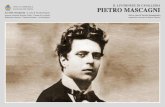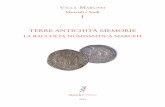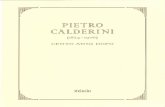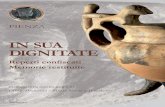Le monete di San Pietro in Cotto
Transcript of Le monete di San Pietro in Cotto
Le monete di San Pietro in Cotto
Elena Baldi
Le campagne di scavo effettuate nel 2008 e 2009 hanno restituito 89 monete, due delle quali sono in argento
ed il resto in lega di rame. La maggior parte dei reperti monetali presentavano incrostazioni superficiali e
strati di corrosione tipici del degrado del rame archeologico.
L’identificazione dei reperti che qui si presentano è stata possibile solo grazie a un paziente lavoro di pulizia
e conservazione1 che ha permesso l’identificazione di molti esemplari, raggiungendo una percentuale di
leggibilità del 50%.
Il range cronologico coperto dei reperti rinvenuti dallo scavo si estende dal 58 a.C., fino al V secolo d.C., in
una distribuzione che evidenzia un vuoto di presenze durante il II e il III secolo (Fig. 1).
Figura 1. Distribuzione cronologica dei reperti numismatici.
Monetazione repubblicana e alto imperiale
Da una prima analisi diacronica dei reperti monetali rinvenuti, si evidenziano attestazioni già a partire dal 58
a.C. con l’esemplare più antico, un denario, coniato dai magistri monetali M. Aemilius Scaurus e P. Plautius
Hypsaeus a Roma nel 58 a.C., in occasione dei giochi edili organizzati da M. Aemilius Scaurus per celebrare
la propria vittoria sul re Aretas III di Nabatea2. Il tondello è stato fortemente tosato in passato e sono stati
rimossi anche piccoli “spicchi” su tutta la circonferenza, forse per imitare i denari serrati o dentellati, la cui
produzione si intensifica tra la fine del II e gli inizi del I secolo a.C.3.
Seguono le emissioni alto-imperiali, a partire da un quadrante di Augusto, coniato a Roma nell’anno 9 a.C.
dal tresviro monetale Lamia4, con due mani giunte che stringono un caduceo, e un asse di Claudio, emesso
dalla zecca di Roma5. La moneta, sul cui diritto si evidenzia una legenda caratterizzata dal titolo P(ater)
P(atriae), si daterebbe, secondo alcuni studiosi tra il 50 ed il 546, mentre per altri risalirebbe all’anno 42/43
7.
1 È stata effettuata una pulizia meccanica delle monete, attraverso l’uso di bisturi con lame affilate che riescono a rimuovere la
corrosione senza lasciare segni sulla superficie della moneta. Data la presenza di cloruri, le monete sono state immerse, dopo la
pulizia, in una soluzione di Benzotriazolo con concentrazione del 5%. Ogni moneta è stata poi inserita in bustine di plastica
contenenti un ritaglio di Polipav, soffice materiale plastico inerte e chiuse, ma perforate, per non creare umidità dentro al sacchettino. 2 M.H. Crawford, Roman Repubblican Coinage, Cambridge 1974, p. n. 422/1b; E.A. Sydenham, The coinage of the Roman
Repubblic, London 1952, p. 152 n. 914. 3 F. Catalli, Numismatica Greca e Romana, Roma 2003, p. 160; S. Balbi De Caro, P. Calabria, A. Pancotti, I denari serrati della
repubblica romana: alcune considerazioni, in Proceedings of the 14. International Numismatic Congress Glasgow 2009, edited by N.
Holmes, Glasgow 2011, pp. 888-892. Tra le ipotesi suggerite per giustificare la dentellatura, Catalli indica che la produzione
dipendeva da una scelta stilistica dettata, forse, per evitare tosature dei bordi monetali. In un’analisi recente Balbi De Caro, Calabria e
Pancotti hanno indicato che la necessità di effettuare la serratura era dovuta alla debole lega di argento di prima coppellazione; la
dentellatura sarebbe dovuta, quindi, all’esigenza di distribuire radialmente le tensioni indotte dalla coniazione. 4 I IIIviri erano magistrati che aspiravano alla carriera senatoriale, assegnati ad una delle attività dei XXviri come atto preliminare alle
elezioni senatorie; il loro compito era quello soprintendere le operazioni di coniazione, implementando la politica monetaria decisa
dai questori, con una certa libertà di scelta sulla tipologia delle emissioni. Diventano IVviri negli anni 5 e 4 a.C., anno dopo il quale
ritornano tre e non compaiono più nelle iscrizioni monetali (The Roman Imperial Coinage, vol. I, From 31 BC to AD 69, a cura di
C.H.V. Sutherland, London 1984, pp. 31-35). 5 H. Mattingly, Coins of the roman empire in the British Museum, vol. 1., Augustus to Vitellius, London 1976, vol. 1, p. clvii 6 C.H.V. Sutherland, The Roman Imperial Coinage, vol. I, From 31 BC to AD 69, London 1984, p. 119.
I a.C. I d.C. II III IV V
1
6
0 0
24
10
Seguendo una scansione diacronica, si registra un dupondio di Nerone che riporta, sul rovescio, l’immagine
del tempio di Giano, che l’imperatore chiuse in occasione della visita di Tiridate, Re dell’Armenia, a Roma
nell'anno 66. Sutherland suggerisce che questo tipo sia stato invece battuto precedentemente, con la maggior
parte delle coniazioni emesse nell’anno 658.
Gli altri quattro esemplari di questo periodo sono databili con precisione rispettivamente al 69, 80/81, 84 e
85, grazie alle legende presenti sulle monete, che indicano l’anno di consolato durante il quale erano state
emesse, identificando produzioni di Vespasiano, Tito e Domiziano. Interessante è il dupondio di
Vespasiano, con un rovescio che ritrae la Pax seduta, una rappresentazione della fine della guerra civile,
segnata dall’ascesa al potere della dinastia dei Flavi9. Nel caso di Domiziano, invece, uno degli esemplari
riporta l’iscrizione SALVTI AVGVSTI sul rovescio, che suona come un auspicio nei confronti
dell’imperatore in rapporto all’altare della pace, costruito con una doppia porta per l’accesso10
per celebrare
le vittorie sulla Britannia e la Germania.
Le produzioni tardo repubblicane e alto imperiali sono quindi rappresentate con un totale di sette reperti, che
costituiscono il 15% della monetazione leggibile, una chiara testimonianza della vivacità di scambi effettuati
nel centro di San Pietro in Cotto. È interessante notare che, ad esclusione del solo quadrante di Augusto, tutte
le altre monete provengono dall’area 2000, una strada con andamento NW-SE. Il rinvenimento di questi
reperti monetali può essere interpretato come il risultato di perdita accidentale nel caso in cui i reperti
provengano da strati di macerie o di abbandono del manto stradale. In alcuni casi, i dati ottenuti dall’oggetto
numismatico, riescono a procurare un termine post quem per chiare fasi di occupazione, quando legati a una
struttura (US 2042, 2074) oppure alla preparazione per il manto stradale (US 2079).
Monetazione di IV secolo
Il quadro cambia a partire dal IV secolo, numericamente il più rappresentato nel nucleo numismatico di San
Pietro in Cotto, con un totale di 24 esemplari, che costituiscono il 54% del materiale leggibile.
12 di queste monete sono attribuibili alla dinastia Costantiniana, a partire da Costantino II, rappresentato da
un’emissione di un Providentiae Caess, coniata forse a Roma, mentre era ancora Cesare, tra il 317 e il 337, e
da una emissione di Virtus Augusti del 337-350.
Sono databili allo stesso periodo, quattro esemplari del tipo Gloria Exercitus con due soldati, stanti frontali,
ognuno con in mano una lancia e scudo e un solo labaro, che identifica le produzioni più tarde del 336-341.
Queste emissioni furono coniate in quantitativi abbondanti, tanto che sono rivenute in tutto il territorio
italiano.
Con l’ascesa di Costante, si registra un cambiamento delle tipologie emesse, tra cui spiccano le emissioni di
Fel Tempo Reparatio, coniate in occasione del 1100esimo anniversario della nascita di Roma11
. Il nominale
prodotto più abbondantemente fu certamente l’AE3-Falling Horseman, nel quale viene rappresentato un
soldato o imperatore mentre trafigge un nemico caduto da cavallo, una emissione datata tra il 348 e il 361.
Sono presenti solo due esemplari di questo tipo, uno attribuibile a Costanzo II, del quale è rinvenuto anche
un Concordia Militum, emesso tra il 351 e il 355.
Non sono invece attribuibili puntualmente una moneta del tipo Victoirae DD AvuggQ•NN, con due Vittorie
l'una di fronte all'altra, ognuna con corona e palma in mano databili al 347-348 e anche un Spes Reipublice,
con Virtus che tiene un globo nella mano destra e lancia nella sinistra, emesso tra il 355 e il 361.
Altri 12 reperti monetali appartengono alla seconda parte del IV secolo; tra questi spiccano le emissioni
attribuibili agli imperatori della dinastia di Valentiniano I, spesso non ascrivibili a un’autorità precisa dato il
cattivo stato di conservazione.
7 H.M. Von Kaenel, Münzprägung und Münzbildnis des Claudius, Berlin 1986, Münztyp 76, pp.29, 298 8 Sutherland C.H.V. (a c.), The Roman Imperial Coinage, vol. I, From 31 BC to AD 69, London 1984, p. 140; Mattingly H., Coins of
the roman empire in the British Museum, vol. 1., Augustus to Vitellius, London 1976, p. clxxiv 9 I.A. Carradice, T.V. Buttrey , The Roman Imperial Coinage volume II –Part I, London 2007, p. 5. 10 I.A. Carradice, T.V. Buttrey , The Roman Imperial Coinage volume II –Part I, London 2007, p. 152. 11 D. Hunt, The successors of Constantine, in The Cambridge ancient history, volume XIII. The Late empire, AD 337-425, edited by
A. Cameron, P. Garnsey, Cambridge 1998, p. 6; J.P.C Kent, The Roman Imperial Coinage, volume X, London 1981, pp. 34-35.
Abbiamo quindi un’emissione di Restitutor Reipublicae, con la figura stante dell’imperatore che trattiene un
labaro e una Vittoria su globo, prodotto tra il 364 e il 378. La stessa datazione è attribuibile ai quattro
esemplari di Securitas Reipublicae, il tipo con la Vittoria che trattiene una corona di alloro uno del tipo
Gloria Romanorum con l’imperatore con labaro mentre trascina un prigioniero. Quest’ultima è ascrivibile a
Valentiniano II, data la legenda parziale e il volto giovanile dell’imperatore.
Infine sono stati rinvenuti un Vota V/X attribuibile alle produzioni di Graziano, Valentiniano II, Teodosio e
Arcadio12
e cinque esemplari delle emissioni di Victoria Avcc con due vittorie frontali ciascuna con una
corona in mano, un tipo coniato durante l’impero di Valentiniano II, Teodosio I e Arcadio tra il 383-395
nelle zecche di Aquileia o Roma. Anche in questo caso, il cattivo stato di conservazione permette di
attribuire un solo esemplare alla zecca di Roma, e un altro alle emissioni di Teodosio I.
Coniato a Roma in grandi quantità sotto gli usurpatori Magno Massimo o Flavio Vittore, un esemplare di
AE4, recante al rovescio l’immagine della porta del castrum, e la legenda Spes Romanorum, emissione
prodotta in occasione della occupazione delle truppe dell’imperatore della Gallia, in marcia contro
Teodosio13
per breve tempo, ma con quantitativi abbondanti. Il tipo è infatti molto diffuso nei rinvenimenti
dell’Italia settentrionale, specialmente nella zona dell’attuale Veneto, Emilia Romagna e Lombardia14
.
Dopo due secoli di assenza monetale, i reperti di IV secolo sembrerebbero indicare un ritorno a un’economia
che necessita di moneta di divisionale minore per lo scambio commerciale sempre più frequente e per le
transazioni quotidiane15
, un utilizzo capillare, che si distribuisce in tutte le regioni dell’Impero Romano,
anche quelle più isolate, come nel caso di San Pietro in Cotto. È importante anche osservare come il dato
numismatico possa provvedere un termine post quem per la datazione del riempimento (US 1113) di alcune fosse di spoliazione della USM 1100 nella fase IV e anche per l’abbandono di un edificio con ambienti pavimentati con esagonette e con impianto di riscaldamento (US 1126) nella fase II.
Monetazione di V secolo
Nonostante il cattivo stato di conservazione dei reperti, almeno 10 esemplari, corrispondenti al 22% del
materiale leggibile, possono essere riconosciuti o confrontabili stilisticamente alle emissioni di questo
periodo.
Sono presenti due monete che riportano la stessa legenda sul rovescio, Gloria Romanorum, ambedue
riferibili alle emissioni di Onorio, una con l’imperatore che schiaccia due vinti, una produzione di Roma,
Aquileia oppure Siscia, un tipo piuttosto comune a Classe16
e nell’Italia nord-orientale; la seconda con
l’imperatore stante, che trattiene uno stendardo e si appoggia su uno scudo, prodotta a Lione.
La stessa legenda e raffigurazione sul rovescio, una Vittoria che trascina un nemico, viene usata per le
emissioni di Salus Reipublicae di Arcadio e Onorio, coniate ad Aquileia tra il 395 e il 402, ma anche di per
Giovanni e Teodosio emesse tra il 423 e il 425.
Tre emissioni di Valentiniano III riconducono alla metà del V secolo, riconoscibili attraverso confronti
stilistici, date le pessime condizioni di conservazione. Abbiamo quindi un esemplare di Victoria Avggg, con
Vittoria che tiene una corona e palma in mano, un Salvs Reipublicae, ambedue con una Vittoria che trascina
un prigioniero e Chi-Rho nel campo e infine un Victoria Avg, che tiene un globo e lancia.
12 Pearce J.W.E. (a c.), The Roman Imperial Coinage vol. IX, Valentinian I – Theodosius I, London 1968, xxxviii. L’uso improprio
del Vota è particolarmente visibile in questa produzione, poiché nell’anno di emissione e celebrazione del quinquennale, l’383, solo
Valentiniano II aveva raggiunto il decennale di regno. Teodosio I, non volendo essere considerato un imperatore subordinato, coniò
monete con lo stesso decennale di Valentiniano II, dando il V/X, che invece gli spettava, al figlio Arcadio. 13 B. Callegher, Trento Teatro Sociale: scavi 1990 – 1992. Le monete repubblicane, imperiali e medievali: analisi critica e catalogo
del complesso numismatico, in E. Cavada, G. Gorini (a c.), Materiali per la storia urbana di Tridentum, II. Ritrovamenti monetali,
(Archeologia delle Alpi, 4), Trento 1998, p. 54 14 G. Gorini, Aspetti monetali, emissione, circolazione e tesaurizzazione, in Il Veneto in età romana, Verona 1987, p. 275; E. Ercolani
Cocchi, 1978, La circolazione monetale fra Tardo Antico ed alto Medioevo: dagli scavi di Villa Clelia, in «Studi Romagnoli»,
XXIX, pp. 367-399; B. Callegher, Trento Teatro Sociale: scavi 1990 – 1992. Le monete repubblicane, imperiali e medievali: analisi
critica e catalogo del complesso numismatico, in E. Cavada, G. Gorini (a c.), Materiali per la storia urbana di Tridentum, II.
Ritrovamenti monetali, (Archeologia delle Alpi, 4), Trento 1998, p. 54. 15 Arslan E.A., Le monete, in G.P. Brogiolo (a c.), S. Giulia di Brescia, gli scavi dal 1980 al 1992. Reperti preromani, romani e
altomedievali, 1999, pp. 347-399. 16 E. Baldi, La documentazione monetale come fonte per la storia di Classe (Ravenna). Gli scavi condotti nell’area portuale (anni
2001-2005) e nell’area della basilica di San Severo (anni 2006-2010), Tesi di dottorato, Università di Bologna, 2013.
Infine, sono state rinvenuta una moneta con monogramma, purtroppo non identificabile e un esemplare con
figura stante, anch’esso non interpretabile puntualmente, ma forse attribuibili alle produzioni di Leone e
Zenone.
I rinvenimenti di San Pietro in Cotto databili al V secolo, anche se numericamente non abbondanti, mostrano
un dato piuttosto importante, il mantenimento di una certa vivacità commerciale che si protrae forse anche
entro il VI secolo, un dato altrimenti riscontrabile con certezza, per questo periodo, solamente a Classe.
CATALOGO DEI REPERTI NUMISMATICI:
1
REPUBBLICA ROMANA
Tresviri monetali: Marcvs Aemilius Scarvs e Publivs Plavtivs
Hypsaes
Zecca: Roma
58 a. C.
Denario, Ag
D/ In alto: M. SCAV/AD CVR; Segno di zecca a sinistra: E/X;
segno di zecca a destra: SC; in basso: REX ARETAS;
Cammello a destra, dinanzi figura inginocchiata (il Re Aretas),
che sorregge con la mano sinistra le redini e con la mano
destra un ramo d'ulivo legato con un nastro; bordo perlinato
R/ P. HVPSAE/AED CVR; segno di zecca in esergo:
CHVPSAE.COS/PREIVE; segno di zecca a destra: CAPTV;
Giove in quadriga a sinistra sorregge con la mano sinistra le
redini e con la destra agita un fulmine; sotto le zampe anteriori
dei cavalli, scorpione; bordo perlinato
Crawford p. 446 n. 422/1b; Sydenham p. 152 nn. 913-914
SP 2009; US 2079.1; g 2,42; ø mm 18,5; direzione 12; In alto:
[M. S]CAVR/[AE]D CVR; Segno di zecca a sinistra: E/X;
segno di zecca a destra: [S]C; in basso: [REX ARETAS]; R/
[P.] HVPS[AE]/AED CVR; segno di zecca in esergo:
[C]HVPSAE.CO[S]/PREIVE; segno di zecca a destra: CAPTV
2
AUGUSTO Tresviro monetale: Lamia Silivs Annivs
Zecca: Roma
9 a.C.
Quadrante, lega di rame
D/ LAMIA SILIVS ANNIVS; Due mani destre che si
stringono, tenendo fra loro un caduceo
R/ III. VIR
. A
.A
.A
. F
.F
., SC nel campo
RIC I, pag. 74 n. 420; CBN 568; BMCRE I, p. 40 n. 200
SP 2009; US 1102.1; g 2,66; ø mm 16; direzione 3; D/
LAMIA SILIVS ANNIVS; R/: III. VIR
. [A
.A
.A
.] F
.F
.; SC
3
CLAUDIO Zecca: Roma
50-54 d.C.(?)
Asse, lega di rame
D/ TI CLAVD CAESAR AVG P M TR P IMP PP; Testa nuda
dell’Imperatore Claudio, a sinistra
R/ C[O]NSTANTIAE AVGVSTI; SC; Constantia, con elmo e
armatura, stante a sinistra, mano destra alzata, la sinistra tiene
lancia; nel campo SC
cfr. RIC I pag. 129 n. 111; BMCRE vol. I, p. 201; Von Kaenel
nn. 1964-1995
SP 2009; US 2056.1; g 8,25; ø mm 22; direzione 6; D/ TI
CLAVD C[AE]SAR [AVG P M TR P] IMP PP; R/:
C[O]NSTANTIAE AVGVS[TI]; SC
4
NERONE
Zecca: Roma
64-68
Dupondio, Lega di rame
D/ IMP NERO CASESAR AVG GERM; Testa laureata a
destra
R/ PACE P R VBIQ PARTA IANVM CLVSIT; SC; Tempio
di Giano con finestra a destra e ghirlanda appesa su porta
doppia a sinistra; nel campo SC
RIC I, pp. 155-157; p. 171 n. 349
SP 2009; US 2062.2; g 10,41; ø mm 26; direzione 6; D/ IMP
NERO CASES[AR AVG G]ERM; R/ PACE P R VBIQ
PARTA IANVM CLVSIT
5
VESPASIANO Zecca: Roma
70
Denario, Ag
D/ IMP CAESAR VESPASIANVS AVG; Testa laureata a
destra
Legenda R/ COS ITER TR POT; Pax seduta a sinistra, tiene
ramo e caduceo
RIC II.i, p. 132 n. 1312
SP 2008; US 2006.1; g 3,23; ø mm 17; direzione 7; D/ [IMP]
CAESAR VESPASIANVS (AVG); R/ (COS ITER) TR POT
6
TITO Zecca: Roma
80-81
Asse, Lega di rame
D/ IMP CAES DIVI VESP F DOMITIAN COS VII; Testa
laureata a destra
R/ Minerva stante a sinistra, tiene fulmine nella mano destra e
lancia nella sinistra, ai suoi piedi uno scudo; nel campo SC
RIC II.i p. 219 n. 347
SP 2009; US 2062.1; g 11,16; ø mm 26,5; direzione 6; D/ IMP
CAES [D]IVI VESP F DOMITIAN COS VII; R/: SC
7
DOMIZIANO Zecca: Roma
84
Asse, lega di rame
D/ IMP CAES DIVI VESP F DOMITIAN AVG GER COS X;
Testa laureata a destra
R/ SALVTI AVGVSTI, SC, Altare
RIC II.I p. 280 n. 209
SP 2008; US 2054.1; g 10,46; ø mm 27,50; direzione 7; D/
IMP CA(ES DIVI) VESP [F] DOMITIAN AVG GER COS X;
R/ SALVTI AVGVST[I], SC
8
85
Asse, lega di rame
D/ IMP CAES DOMIT AVG GERM COS XI CENS POT P P;
Testa laureata a destra
R/ Figura stante
RIC II.i pp. 291 nn. 375-390
SP 2008; Settore 2000 Pulizia Sezione.1; g 8.53; ø mm 31;
direzione 6; D/IMP CAES DO(MIT) AVG GER(M C)OS XI
CENS POT P P; R/ Illeggibile
9
COSTANTINO II
Zecca: Roma ?
317-337
D/ COSTANTINVS IVN NOB C; Busto diademato a destra
PROVIDENTIAE CAESS; Castrum con due torri, stella sopra
cfr. RIC VII p. 212 n. 505; cfr. LRBC p. 14 n. 517
SP 2008; US 1009.1; g 2.72; ø mm 20; direzione 12; D/
COSTANTINVS IVN N(O)B C; R/ PROVIDENTIAE
CAESS; segno di zecca in esergo: *U*
10
Zecca: Roma
337-350
AE3, Lega di rame
D/ VIC CONSTANTINVS AVG; Busto diademato a destra
R/ VIRTVS AVGVSTI; Imperatore stante frontale in abito
militare, testa senza elmo, a destra, tiene lancia nella mano
destra e appoggia la sinistra su scudo
RIC VIII p. 249 n. 4, pl.8 n. 414
SP 2008; US 2012.2; g 1,29; ø mm 14; direzione 5; D/ VIC
[CON]ST[ANTINVS AVG]; R/ [VIRTVS] AVGVSTI; segno
di zecca in esergo: (R) foglia P
11
COSTANTE I Zecca: Siscia
347-340
AE3, Lega di rame
D/ CONSTANS P F AVC; busto diademato a destra
R/ GLORIA EXERCITVS; Due soldati con elmo stanti
frontali con lancia, si appoggiano allo scudo; tra di loro uno
stendardo
cfr. RIC VIII p. 355 n. 86; LRBC I p. 19 n. 756
SP 2008; US 1054.1; g 1,07; ø mm 15; direzione: 12; D/
CONS(TA)NS P F AVC; R/ GLOR[IA AEXERCI]TVS;
segno di zecca in esergo: (A)SIS
12
COSTANTINO I, COSTANTE, COSTANTINO II
Zecca: non identificabile
335-341
AE3, Lega di rame
D/ Iscrizione; busto diademato a destra
R/ GLORIA EXERCITVS; Due soldati con elmo stanti
frontali con lancia, si appoggiano allo scudo; tra di loro uno
stendardo
cfr. LRBCI p. 24 n. 1028
SP 2008; Pulizia Sett. 1000 Angolo NW.1; g 0,7; ø mm 12,5;
D/ illeggibile; R/ illeggibile
13
SP 2008; US 1003.1; g 0,98; ø mm 15,5; direzione 12; D/ […]
AVC; R/ Illeggibile
14
SP 2009; US 2042.1; g 1,44; ø mm 14,5; direzione 6; D/ […]
CONS[…]; R/ illeggibile
15
COSTANZO II
Zecca non identificabile
351-354
AE3, Lega di rame
D/ DN CONSTANTIVS P F AVC; Busto diademato,
drappeggiato e corazzato a destra
R/ FEL TEMP REPARATIO; Soldato con elmo, a sinistra,
scudo nel braccio sinistro, trafigge con la lancia sulla destra un
cavaliere, rivolto verso di lui, con braccio sinistro alzato
cfr. LRBC p. 100 n. 2625
SP 2008; US 1017.1; g 1,97; ø mm 16; direzione 6; D/ DN
CONSTAN(TI)[...] AV(C); R/ FEL (TEMP) REPARATIO
16
Zecca Orientale
351-355
AE2, Lega di rame
D/ DN CONSTANTIVS P F AVC; busto diademato,
drappeggiato e corazzato a destra
R/ CONCORDIA MILITVM; Imperatore diademato e in abito
militare, stante, frontale, testa a sinistra, sopra stella; in ogni
mano tiene uno stendardo con
cfr. LRBC p. 76 n. 1592; cfr. RIC VIII p. 386 n. 21
SP 2008; Sezione Ovest sopra pavimento in cocciopesto.1; g
3,3; ø mm 21; direzione 6; D/ D N CONSTANTIVS P F AVC,
A dietro al busto; R/ [CON]CORD[IA MI]LITVM
17
COSTANTE-COSTANZO II
Zecca: Roma
347-348
AE3, Lega di rame
D/ Iscrizione; busto diademato, drappeggiato e corazzato a
destra
R/ VICTORIAE DD AVCC Q NN; Due Vittorie l'una di
fronte all'altra, tengono ognuna corona di alloro e palma
cfr. RIC VIII p. 253-255 nn. 72-102
SP 2008; US 2007.2; g 0,83; ø mm 14; direzione 12; D/
CON[…]; R/ Illeggibile
18
Zecca: non identificabile
348-361
AE3, Lega di rame
D/ Iscrizione; busto diademato, drappeggiato e corazzato a
destra
R/ FEL TEMP REPARATIO; Soldato con elmo, a sinistra,
scudo nel braccio sinistro, trafigge con la lancia sulla destra un
cavaliere, rivolto verso di lui, con braccio sinistro alzato
cfr. LRBC p. 100 n. 2625
SP 2008; US 1003.2; g 1,36; D/ illeggibile; R/ illeggibile
19
COSTANZO II, GIULIANO Zecca: non identificabile
355-361
AE4, Lega di rame
D/ Iscrizione; Busto diademato a destra
R/ SPES REIPVBLICE; Virtus con elmo a destra, tiene globo
nella mano destra e lancia nella sinistra
cfr. RIC VIII p. 279 n. 318; cfr. LRBC p. p. 97 n. 2504
SP 2008 ; US 1003.3; g 2,06; ø mm 16; direzione 6; D/ […]S P
F AVC; R/ SPES RE[I]PVBLI(CE)
20
COSTANTINIANA Zecca: non identificabile
330-361
AE3, Lega di rame
D/ Iscrizione; Busto diademato a destra
R/ Illeggibile
SP 2008; US 1017.2; g 0,44; D/ CO; R/ illeggibile
21
VALENTE, VALENTINIANO I, GRAZIANO
Zecca: non identificabile
364-378
AE1, Lega di rame
D/ Iscrizione; testa diademata a sinistra
R/ RESTITVTOR REIPVBLICAE; Imperatore stante,
frontale, testa a destra, tiene labaro e Vittoria su globo
cfr. RIC IX pp. 120-121 n. 20a-c (zecca di Roma); cfr. LRBC
p. 56 n. 527
SP 2008; US 2010.1; g 5,66; ø mm 25,5; direzione 6; D/
illeggibile; R/ illeggibile
22
VALENTE, VALENTINIANO I, GRAZIANO, TEODOSIO
Zecca: Non identificabile
364-378
AE3, Lega di rame
D/ Iscrizione; busto diademato, drappeggiato e corazzato a
destra
R/ SECVRITAS REIPVBLICAE; Vittoria a sinistra, tiene in
mano corona di alloro e palma
cfr. RIC IX p. 146 n. 5
SP 2009; US 2074.8; g 1,50; ø mm 17,5; direzione 6; D/
Illeggibile; R/ illeggibile
23
SP 2009; US 2042.3; g 1.53; ø mm 15; direzione 0°; D/
illeggibile; R/ illeggibile
24
SP 2009; US 2074.1; g 0,38; spessore mm 1; D/ illeggibile; R/
illeggibile
25
VALENTE, VALENTINIANO I, GRAZIANO, TEODOSIO,
ARCADIO
Zecca: non identificabile
378-383
AE4, Lega di rame
D/ Iscrizione, busto diademato a destra
R/ VOT/V/MVLT/X; Iscrizione entro corona di alloro
cfr. RIC IX p. 101 n. 36a-d; cfr. LRBC p. 62 n. 794
SP 2008; US 2041.2; g 0,7; ø mm 14; direzione 12; D/
Illeggibile; R/ VOT/V/MVLT/X
26
VALENTINIANO II
Zecca: Roma
383-388
AE3, Lega di rame
D/ D N VALENTINIANVS P F AVC; Busto diademato a
destra
R/ GLORIA ROMANORVM; Imperatore a destra, trascina
nemico con la mano destra e tiene labaro con la sinistra
RIC IX, p. 130 n. 55
SP 2008; US 1012.1; g 1,97; ø mm 17,5; direzione 1; D/ [D N
VALEN]TINIANVS P F AVC; R/ GLORIA ROMANORVM;
Segno di zecca in esergo: - R//RS
27
VALENTINIANO II, TEODOSIO I, ARCADIO
Zecca: Tessalonica, Aquileia, Roma
383-387
AE4, Lega di Rame
D/ Iscrizione; Testa diademata a destra
R/ VICTORIA AVC; due Vittorie rivolte l’una verso l’altra,
tengono ambedue una corona di alloro
RIC IX p. 187 n. 63; LRBC p. 82 n. 1871
SP 2008; US 1048.1; g 1,1; ø mm 14; direzione 12; D/
illeggibile; R/ illeggibile
28
SP 2009; UX 1113.1; g 2,49; ø mm 13; direzione 6; D/
illeggibile; R/ illeggibile
29
SP 2009; US 1126.2; g 1,06; ø mm 12; direzione 12; D/
illeggibile; R/ illeggibile
30
Zecca: Roma
383-387
AE4, Lega di Rame
D/ Iscrizione; Testa diademata a destra
R/ VICTORIA AVC; due Vittorie rivolte l’una verso l’altra,
tengono ambedue una corona di alloro
LRBC p. 62 n. 782-784
SP 2008; Saggio 1 Sezione Ovest.1; g 1,3; ø mm 14; direzione
12; D/ […]S P F AVC; R/ VICTORIA AVCCC; segno di
zecca in esergo: R(P)
31
MAGNO MASSIMO O FLAVIO VITTORE
Zecca: Roma o Aquileia
387-388
AE4, lega di rame
D/ Iscrizione, Busto drappeggiato, diademato, a destra
R/ SPES ROMANORVM; Porta di un castrum sormontata da
due torrette, sopra stella
cfr. RIC IX p. 131 n. 59; cfr. LRBC p. 62 n. 795
SP 2009; US 2074.9; g 0,68; ø mm 15,5; direzione 12; D/
illeggibile; R/ illeggibile
32
TEODOSIO I
Zecca: non identificabile
383-392
AE4, Lega di rame
D/ Iscrizione, busto diademato a destra
R/ VICTORIA AVCCC; Due Vittorie l'una di fronte all'altra,
ognuna con corona e palma in mano.
LRBC p. 82 n. 1868
SP 2008; US 2028.3; g 0,75; ø mm 13; direzione 8; D/
[…]O(DO)SIV[…]; R/ illeggibile
33
ARCADIO, ONORIO
Zecca: Roma, Aquileia
395-402
AE3, Lega di rame
D/ Iscrizione; busto diademato, drappeggiato e corazzato a
destra.
R/ SALVS REIPVBLICAE; Vittoria a sinistra, tiene trofeo su
spalla destra e trascina un prigioniero inginocchiato,
staurogramma nel campo.
cfr. RIC X p. 322 nn. 1237-1238
SP 2008; US 2007.1; g 0,78; direzione 11; D/ illeggibile; R/
Illeggibile
34
SP 2008; US 2028.1; g 1,01; ø mm 13,5; direzione 9; D/
illeggibile; R/ illeggibile
35
ONORIO Zecca Roma, Aquileia, Siscia
410-423
AE3, Lega di rame
D/ D N HONORIVS P F AVG; busto diademato, drappeggiato
e corazzato a destra.
R/ GLORIA ROMANORVM; Imperatore stante, testa a
destra, la sua mano destra sulla testa di un prigioniero
inginocchiato, la sinistra stesa su un prigioniero supplicante
cfr. RIC X p. 338 n. 1355, 1356, 1358; LRBC p. 62 n. 827
SP 2008; US 1096.3; g 0,85; ø mm 12,5; direzione 6; D/
illeggibile; R/ illeggibile
36
Zecca: Lione
423-425
AE4, lega di rame
D/ Iscrizione, Busto diademato a destra
R/ GLORIA ROMANORVM; Imperatore stante, frontale,
testa a destra, tiene stendardo e appoggia la mano sinistra su
scudo
cfr. RIC X, p. 339 n. 1161
SP 2009; US 2074.10; g 0,76; ø mm 14; direzione 12; D/
illeggibile; R/ illeggibile
37
TEODOSIO II-GIOVANNI
Zecca: Roma
423-425
AE4, lega di rame
D/ Iscrizione; busto diademato, drappeggiato e corazzato a
destra
R/ SALVS REIPVBLICE; Vittoria a sinistra, tiene trofeo
sopra la spalla destra e trascina nemico; staurogramma nel
campo a sinistra
cfr. RIC X p. 361 nn. 1914
SP 2008; US 1009. 3; g 0,69; ø mm 12; direzione 12; D/
illeggibile; R/ illeggibile, staurogramma a sinistra
38
SP 2009; US 1126.2; g 1.06; ø mm 12; direzione 12; D/
illeggibile; R/ illeggibile, staurogramma a sinistra.
39
VALENTINIANO III
Zecca: Roma
425-430
AE3, Lega di rame
D/ Busto diademato, drappeggiato e corazzato a destra.
R/ VICTORIA AVCC; Vittoria a sinistra, tiene corona di
alloro e ramo di palma.
cfr. RIC X p. 375 n. 2105
SP 2008; US 2025.1; g 1,79; ø mm 15,5; direzione 12; D/
Illeggibile; R/ illeggibile
40
425-430
AE4, Lega di Rame
D/ Busto diademato, drappeggiato e corazzato a destra.
R/ SALVS REIPVBLICE; Vittoria a sinistra, tiene corona di
alloro e ramo di palma.
RIC X p. 376 nn. 2108-2109
SP 2008; US 1003.4; g 1,17; ø mm 12; direzione 6; D/
Illeggibile; R/ Illeggibile
41
440-455
AE4, Lega di rame
D/ Busto diademato, drappeggiato e corazzato a destra
R/ VICTORIA AVG; Figura stante a sinistra, forse con elmo,
tiene globo e lancia
cfr. RIC X p. 380 n. 2147-2148
SP 2008; Sett. 1000 Sezione Ovest.1; g 0,53, ø mm 10;
direzione 12; D/ illeggibile; R/ illeggibile
42
LEONE I (?)
Zecca: Roma
461-467
AE4, lega di rame
D/ Iscrizione, Testa diademata a destra
R/ VICTORIA AVGG; Vittoria a sinistra, tiene corona di
alloro e palma
RIC X, p. 396 n. 2528
SP 2009; US 2074.3; g 0,84; ø mm 16; direzione 6; D/
illeggibile; R/ illeggibile
43
AUTORITÀ NON IDENTIFICABILE
Zecca: non identificabile
445-498
AE4, Lega di rame
D/ Busto diademato a destra
R/ Monogramma
cfr. RIC X
SP 2008; US 2012.1, g 0,75; ø mm 12; direzione 9; D/
illeggibile; R/ Monogramma illeggibile
PREMESSA AL CATALOGO
Ogni moneta viene registrata nel seguente ordine:
Autorità emittente; Zecca di produzione; Anno di emissione; Nominale e lega di produzione; Descrizione del diritto;
Descrizione del rovescio; Confronto con repertori; Provenienza del reperto; Anno di scavo; US di rinvenimento; Peso in
g; Diametro (max) in mm; Direzione del conio (espresso in ore, 1-12); Descrizione legenda visibile sul diritto;
Descrizione legenda visibile sul rovescio; Segni si zecca (in questo ordine: a sinistra, destra, in esergo)
I dettagli delle abbreviazioni e terminologie utilizzate sono elencati qui di seguito.
Ag = argento
D/ = diritto moneta
R/ = rovescio moneta
g = grammi
ø = diametro
mm = millimetri
/ = segno di divisione della legenda
// = precede segno di zecca in esergo
p., pp. = pagina/e
cfr. confronta
n., nn. = numero/i
[…] [AVC] = lettere mancanti incerte e conosciute
US inv. peso diametro spess desc
1009 2 0,62 10,5 1,5
1009 4 0,78 0 1,5
1013 1 0,38 8,5 1,5
1017 3 0,55 0 1,2
1048 2 0,31 0 2
1048 3 0,32 9 11
1048 4 0,12 0 1,2
1066 1 0,58 0 2
1082 1 0,15 8,5 1
1096 1 0,98 14 1,4
1096 2 0,28 9,5 1,2 Tagliata
1126 1 0,38 8 1,8
2002 2 0,49 9,5 1,5 Tagliata
2002 1 0,28 10,5 1
2002 3 2,12 21,2 1,2
2002 4 0,41 0 1,2
2002 5 0,83 12,5 1,5
2002 6 0,12 0 1
2005 1 0,22 0 1,2 1/2
2007 3 0,33 0 1,2 1/2
2007 4 1,08 14 1,9 Tagliata
2007 5 0,58 0 1,2 Frammento
2009 1 0,06 7,5 1 1/2
2009 2 0,22 8 0,5 Intera
2009 3 0,87 9,5 2,2 Tagliata
2009 5 0,16 0 1
2009 4 0,42 9,5 1,2
2009 6 0,33 0 1
2009 8 0,12 12,5 1
2012 3 0,61 12 1,5
2025 2 0,27 11,5 0,8
2028 2 0,54 8 2
2041 1 0,83 15 1,2
2041 3 0,56 11,2 1,5
2041 4 0,4 10,5 1 Tagliata
2042 2 0,32 9 1,5
2062 3 0,38 12,5 1
2074 2 0,68 15,5 1,5 Tosata
2074 4 0,15 0 1
2074 5 0,62 11,5 1,5
2074 6 0,7 13 1,2
2074 7 0,36 10 1 Tagliata
2074 11 0,68 11 1,5
2074 12 0,12 7 1
Pulizia Settore 2000 1 0,82 10 1,8
Tavola 1. Elenco dei reperti monetali illeggibili.