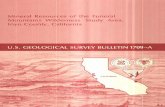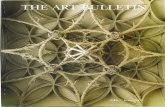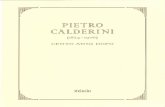Pietro Selvatico theory and praxis Pisani's funeral chapel at Vescovana.
Transcript of Pietro Selvatico theory and praxis Pisani's funeral chapel at Vescovana.
Pietro Selvatico dalla teoria alla pratica. La cappella Pisani a Vescovana PDSan Pietro a Trento 1848-50
Posto davanti ala crisi dell’accademia <<questo vecchio cascame>>, Boito definisce Selvatico come <<un rivoluzionario che studiava il passato per imparare a rompere le catene>>1 con la storia degli stili e della tecnica costruttiva.
La storia dell’arte.
Questo è vero negli scritti giovanili, raccolti poi in Scritti d’arte, 21859 Nella presentazione al lettore [p. VI] difende la raccolta delle sue <<ciarle artistiche>> <<uscite in differenti occasioni e tempi,>> <<c’era se non proprio l’unità dello scopo, almeno quella coerenza di vedute e di intendimenti, che parecchi si ostinano a negarmi con certe malizie spesso un po’ fantastiche.>>3 particolarmente vuole rispondere anche all’accusa <<d’essere travagliato da così ostinata monomania di forestierume>>, ma tanti giovani entusiasti che calano da nord (i Nazareni) sono meglio di tanti sterili locali.Negli scritti degli anni 1840 si nota una certa dipendenza da Cicognara. La scultura senza l’architettura si svuota priva di senso, mentre la pittura è una cosa a sé.Mi vorrei un momento soffermare sul discorso alla Accademia di Belle Arti di Ravenna del 1843.Con quali intendimenti si debba scrivere una storia delle arti del bello visibile specialmente in Italia: <<sin qui non sempre la storia dell’arte scrivemmo, ma quella degli artisti; non il progredimento intellettuale, ma una raccolta di biografie.>>4 La storia della pittura italiana dovrebbe quindi iniziare dai mosaici paleocristiani di Roma e di Ravenna, per poi passare alla miniatura, alla scoperta e rivalutazione dei primitivi. attraverso la nuova estetica del purismo e dei Nazareni.La pubblicazione di nuovi strumenti storico critici permette una nuova visione del medioevo5; la rivalutazione dei primitivi. <<i trecentisti>> lo porta a preferire il giudizio finale dell’Angelico a quello della Sistina. Ma soprattutto a fare della cappella degli 1 C. B0ITO, Il marchese Pietro Selvatico in <<Atti della Reale Accademia e del R. Istituto di Belle Arti in Venezia. Anno 1888>>, Venezia 1889, pp. 5-36.
2 Firenze, Barbèra, Bianchi e compagni 1859, <//archive.org/details/scrittidarte00selv> (maggio 2014)
3 F.BERNABEI, Pietro Selvatico nella critica e nella storia delle arti figurative dell’Ottocento, Neri Pozza, Vicenza 1974, p. 141. Vedi inoltre G. ZUCCONI, L’invenzione del passato. Camillo Boito e l’architettura neomedievale 1855-1890, Marsilio Venezia 1997, pp. 74 e sgg.
4 Ora in P.E.SELVATICO, Scritti d’arte, Firenze, Barbèra, Bianchi e compagni 1859, p.384 <//archive.org/details/ scrittidarte00selv> (maggio 2014). Egli poi scrive:<<E’ anche colpa non lieve di alcuni fra quelli che scrissero dell’arte, il far troppo assegnamento sui mezzi tecnici e curar poco il pensiero artistico; ma sono però molti più quelli che parlano dei mezzi tecnici in modo, da mostrare quanto poco li conoscano.>> p.387. Se la storia dell’arte deve cominciare dall’architettura. Selvatico riconosce il relativismo del bello a seconda dei bisogni e le idee delle civiltà, <<Non Vitruvio e Vignola ma l’architettura del quattrocento è l’architettura italiana degna di assidui studi>>. p.392.
5 Dalla critica a Vasari passa poi alle lodi del commento dei fratelli Milanesi e Carlo Pini in 13 volumi, VASARI, Le vite..., Firenze, Le Monnier 1846-57, del GAYE, Carteggio inedito d’artisti 3 voll, Firenze 1839-41, del GUALANDI, Memorie originali italiane, risguardanti le belle arti, in sei serie Bologna 1840-45; del MILANESI., Documenti per la storia dell’arte senese, 3 voll., Siena 1854-56. l’arte è quindi vista come parte della Kulturgeschikte,
Scrovegni il fulcro monumentale del suo concetto di arte, da difendere e da conservare da ogni tentativo di stacco o di restauro6.
Architettura, fotografia, pittura di storia Quanto al gusto architettonico, la predilezione del moresco, del gotico, del quattrocento, dell’ornamento, dove l’architettura è sintesi delle arti. <<La scultura senza l’architettura si corrompe>>, lo portano ad ammirare il caffè Pedrocchi di Jappelli, a condannare Vitruvio, Vignola, Quarenghi, e a criticare Durand7.
Selvatico è tutt’altro che un nemico del progresso, anzi da liberale cristiano vede nel progresso il segno di Dio, così la fotografia, definita <<la luce costretta a farsi pittrice>> è strumento di verità nella pittura di storia8, ma anche strumento indispensabile per gli architetti che finalmente potranno vedere le giuste proporzioni degli edifici, i loro innumerevoli particolari realisticamente e non perder tempo sui trattati.
Addirittura pare prevedere un mondo collegato “in rete” dalle linee del telegrafo quando scrive:Dio si manifesta nell’altezza dell’ingegno umano; <<si rivela nel pensiero di Stephenson, che perfeziona la locomotiva; in quello di Fulton che applica il vapore alla navigazione>>, nella Trasfigurazione di Raffaello, nel verso di Dante, <<nell’intelletto di Volta che dagli accatastati dischi di volgar metallo trae quel fluido maraviglioso, sulla cui invisibil ala vola rapida come l’idea la parola, a congiungere concetti, sentimenti, bisogni lontani, e a farci tutti una sola famiglia nel nome di quella voce santa che ci dice fratelli.>>9
6 <<Padova ha perduto S.Agostino, la scuola di S. Sebastiano con gli affreschi mantegneschi, i chiostri di S. Giustina e nel 1825 il piccone pareva abbattere pure l’oratorio degli Scrovegni. [....] Si direbbe che la fortuna avesse concesso alla sola Italia per tempo lunghissimo il primato nelle arti della bellezza visibile. quasi a risarcimento delle sciagure storiche e della lunga spartizione, proprio da questa nasce la ricchezza e diversità dell’arte italiana ma nonostante le perdite delle campagne napoleoniche restano ancora moltissime opere d’arte, spesso trascurate, che se fossero in qualche museo straniero sarebbero studiate, restaurate e conservate.>> L’oratorio dell’Annunziata nell’arena di Padova e i freschi di Giotto in esso dipinti. Introduzione. [1836] ora in P.E. SELVATICO, Scritti d’arte, cit., p. 216,
7 <<Bella fu per l’Arabo l’Alhambra che co’ suoi mille meandri, colle bizzarre sue volte, col suo arco chiudentesi in circolo, colle sue gemmate colonne, collo sfolgorare dei colori e dell’oro, gli rammentava la ricca e fiorente immaginazione, e la magnifica prodigalità, la scienza, la grandezza de’ suoi Califfi.>> ID, Come si debba scrivere una storia delle arti...., [1843] ora in ID, Scritti d’arte, cit., p. 391. Critica Durand, Recueil et parallèle des édifices de tout genre, anciens et modernes : remarquables par leur beauté, par leur grandeur, ou par leur singularité, et dessinés sur une même échelle (1800, <<opera pubblicata per cura de’ professori della I. R. Accademia di Belle Arti. Venezia presso Giuseppe Antonelli 1834>> tradotta e ampliata con l’aggiunta di esempi italiani e soprattutto veneziani antichi e moderni e della storia generale dell’architettura di J.G. Legrand) dove si stabiliscono confronti all’interno di tipologie, mentre del Nouveau précis des leçons d'architecture: données à l'École impériale polytechnique (1813) accetta <<Le graticole della composizione>>, la composizione cioè di piante partendo dalla geometria più semplice alla più complessa, ma lo accusa di aver trascurato materiali, usi e costumi.
8 ID, Sui vantaggi che la fotografia può portare all’arte, in ID, Scritti d’arte, cit., pp 335-36, 339, 341. Questi sono i vantaggi:1 Educare il gusto del pubblico ad apprezzare quelle opere che più si avvicinano al vero <<avvivato dall’ideale>>; <<né più crederà che nel molle e nello sfumato si chiuda bellezza e grazia, perché scorgerà come la immagine di ogni vero abbia a mostrarsi decisa e ferma>>. p. 3392 Gli artisti <<s’ accorgeranno allora come un’immagine eliografica, tratta da una movenza istantanea dell’uomo, possa dar lezioni ben altrimenti fruttuose che non sian quelle fornite dalle statue, dalle preparazioni anatomiche, e dalle sudate copie di un modello forzato ad impossibili immobilità. Si accorgeranno che i panni gettati sull’uomo vivo, e riprodotti sulla carta fotografica, offrono ben altra apparenza di verità, che non quelli composti artatamente sopra il fantoccio, i quali non mai possono manifestare gli effetti del moto naturale d’una figura, e velano soltanto le forme di un automa senza vita.>> p.3393 Così gli architetti, meglio giudicando gli effetti delle proporzioni reali degli edifizi, e la spiccatezza dei loro particolari, impareranno a non perdere il tempo sulle arbitrarie regole di un trattato classico.>> p.3394 La fotografia segnerà la fine del vedutismo e ritrattismo di maniera e deteriore. p.341 con l’eliminare tanti produttori di <<vedutine>> p.336.
9 dal 1850 Venezia e Milano sono collegate telegraficamente con Vienna via Verona e Innsbruck. ID., Storia estetico- critica delle arti del disegno : ovvero l'architettura, la pittura e la statuaria considerate nelle correlazioni fra loro e negli svolgimenti storici, estetici e tecnici; lezioni dette nella I. R. Accademia di belle arti in Venezia / da P. Selvatico.Venezia : P. Naratovich, 1852-1856. vol. 2, pp.12-13, < http://books.google.it/books/about/ Storia_estetico_critica_delle_arti_del_d.html?id=KFIWAQAAMAAJ&redir_esc=y> 01-05-2014
La storia dell’architettura e la formazione dell’architetto.Ma tornando alla storia dell’architettura, così il professore inaugura il suo corso veneziano del 1856 con a fianco l’allievo ventenne Camillo Boito:<<Fino adesso la storia dell’architettura ce la esposero come un risultamento dell’indole varia dei popoli, come l’effetto delle loro credenze politiche e religiose, [...]10. Secondo me, uno dei motori più impellenti a diversificare gli stili dell’architettura, fu l’indole stessa dei materiali di cui i differenti popoli furono costretti a valersi.>> [293]Selvatico si contrappone al neoclassicismo come all’eclettismo.
. 1) i materiali definiscono la forma e la costruzione, <<storia delle ragioni costruttive subordinate alla natura dei materiali>> non bisogna anteporre quindi l’estetica alla costruzione
. 2) la storia dei materiali come storia dell’architettura: disegno storico dall’ architettura litica, graniti, porfidi e basalti dell’antico Egitto, i marmi Greci, proconesso, pario,, alla terracotta e al laterizio di Etruschi e Romani, alle malte delle volte e delle cupole, poi rivestite di marmi provenienti da ogni parte dell’impero. Al nord le volte dei boschi, le arenarie delle Ardenne e il grés di Parigi stanno alla base dell’architettura romanica e poi gotica, il legno determina quella degli chalet svizzeri. In Italia Brunelleschi e la sua cupola ogivale, archi su colonne nelle basiliche, l’ornamento. Nel cinquecento invece i trattati di Vitruvio e Vignola soffocano l’architettura. Perciò vanno aboliti i trattati nelle scuole di architettura. Da Falconetto a Scamozzi. Dopo le follie del barocco, delle quali è colpevole Michelangelo, la riscoperta di Ercolano e Pompei e il neoclassicismo come stile della rivoluzione. <<Le graticole della scuola politecnica di Parigi, non disprezzabili se parcamente usate, e le sagome per cornici ed ornamenti predisposte da Percier e Fontaine [...] finirono collo isterilire la povera architettura>> p. 299. Ma da venti anni a questa parte Francesi, Tedeschi, Russi e Inglesi soprattutto si ribellarono e, rotto l’alto sonno della testa, cercarono ispirazione in altri stili del passato, in opere <<brizzolate>> <<d’eclettismo>>, ma tutte <<meglio accomodate, e per distribuzione e per aspetto, alla nostra odierna maniera di vivere>> p.300.
. 3) Solo noi Italiani seguiamo ancora Napoleone e non guardiamo alle nostre basiliche <<latine>> alle <<sicule>> alle combinazioni geometriche di S. Maria del Fiore e del campanile di Giotto, alle leggiadrie degli edifici lombardeschi e bramanteschi. Voi studenti <<dal procedimento storico comprenderete quali elementi del passato s’attaglino a noi, quali si disdicano, quanto sia possibile tentare di nuovo, coi nuovi materiali ch’ora ci fornisce l’industria.>> p.301. La via è stata aperta da Francesco Lazzari in quaranta anni di insegnamento, da Durand e da Hoffstadt <<con lo studio degli stili lombardeschi e archiacuti>>; <<io tenterò di far più chiaro, con l’offerirvi riprodotti da nitide incisioni i monumenti migliori di ogni stile opportuno agli usi odierni.>>11
10ID., Prelezione al corso di storia dell’architettura per laureati ingegneri di Padova all’Accademia di Venezia del 1856 ora in ID., Scritti d’arte , cit., p.289
11 ibid.. p.301. Sul grande Durand tradotto e ampliato con l’aggiunta della storia generale dell’architettura di Legrand e pubblicato dall’Accademia veneziana nel 1834 vedi il mio video <http://www.youtube.com/watch?v=fRDGyXb_UwA>; su Hoffstadt tradotto, ampliato da Lazzari e pubblicato a Venezia nel 1853 vedi il mio video < http://www.youtube.com/ watch?v=2vhfKxHJ4Fk>. Inoltre vedi G. ZUCCONI, L’invenzione del passato..., cit., p. 67.
4) Storia dell’architettura per tipologie e confronti storici come in Durand. A Selvatico la teoria, all’insegnante di disegno la pratica. <<L’ornato architettonico è parola dell’edificio, e come parola deve aver un carattere preciso, limpido>>12.
5) Caratteri costruttivi. di murature e volte in mattoni e pietra da taglio, disegno delle volte senza aiuto del calcolo, capriate in legno. Geometria descrittiva pratica, rilievo dei monumenti. Infine la composizione cominciando dai tipi più semplici
Il tempo per seguire il programma è di soli sette mesi in tutto.In conclusione <<Se l’architettura è ‘parola’ e convenzione il simbolo deve essere ‘conveniente’ e comprensibile>>13 L’ornamento architettonico dal medioevo ai materiali nuovi.Quindi l’ornamento diventa il linguaggio che fa parlare e comunicare l’architettura.14 Selvatico, anticipando Umberto Eco, espone la teoria discutibile dell’orientalista tedesco Jos V. Hammer nel suo Mysterium Baphometis revelatum. Le figure strane delle sculture ornamentali deriverebbero dal culto gnostico diffuso in Siria presso Hassan-Saback, fondatore della setta degli assassini, e, portato in Europa dai Templari, fatto proprio dai liberi muratori. <<Nella celebre loggia fondata da Achen al Cairo verso la fine dell’undecimo secolo si insegnava oltre al culto gnostico la matematica e la geometria, scienze necessarie ai liberi muratori>>15. Per primi i Normanni dalla Terra Santa lo portarono in Europa.Subito però la nega: tutto era regolato dal clero che non permetteva influssi eretici, anzi nel concilio di Nantes si stabiliva espressamente di distruggere le pietre che rappresentavano demoni. Né nelle poche chiese e cappelle dei Templari (La chiesa del Templari a Londra e la sala dei cavalieri a Mont-Saint-Michel) si trovano simili figurazioni. Comunque queste figurazioni di mostri compaiono molto prima della fondazione dell’ordine dei Templari nel 1118. Cervi, pesci, aquile, Orfeo, viti e uva, palme, sirene, nave veleggiante in mare, pavone, simboli degli evangelisti, Agnello mistico sono tutti simboli paleocristiani. Dopo il 726, per reazione all’iconoclastia di Leone Isaurico, artisti greci sono ospitati in Italia, i Longobardi, Ravenna e Roma gli fanno decorare edifici religiosi. Allora artisti greco-bizantini avrebbero portato in occidente motivi. asiatici risalenti alla Persia, alla Fenicia e fatti propri dagli ebrei nel tempio di Salomone.Conclude ribadendo la necessità di fondare un’accademia di archeologia medievale a Roma accanto a quella classica. Gli architetti devono prendere a modelli le prime chiese, <<alzate piuttosto dai popoli che dagli individui>>; le <<semplici disposizioni basilicali>> rispondono meglio del tempio greco al rito cristiano.16 Selvatico tace stranamente sul più grandioso cantiere purista del tempo: la basilica di S. Paolo fuori le mura, modello per Notre-Dame-de-Lorete di Lebas e di St. Vincent-de-Paul a Parigi di Hittorf da lui citate come esempi moderni.La chiesa di Allerheiligen della corte di Monaco (1826-1842) è per Selvatico soprattutto il modello della nuova architettura. Leo von Klenze e Ludovico I unirono all’esterno romanico lombardo, con la facciata a capanna sul modello di S. Michele a Pavia, un interno a quinconce ispirato a S. Marco, mentre le decorazioni mescolano motivi dai 12 ibid. p.303 13 ibid. p. 306
14 ID, Sui simboli e sulle allegorie nelle parti ornamentali delle chiese cristiane del medio evo dall’VIII al XIII secolo. ora in ID, Scritti d’arte , cit., p. 63
15 ibid. p.69. 16 Ibid. p.126
mosaici veneziani con le decorazioni della cappella palatina di Palermo, ammirata durante il viaggio in Italia.L’educazione dell’architetto però non può basarsi solo sulla storia e sulle suggestioni dei “touriste”.
Base di tutto deve essere la geometria descrittiva praticata nelle scuole primarie <<alfabeto della forma>> per <<delineare su qualsiasi coordinata le proiezioni de’ solidi i più complicati, in modo da farli agevolmente eseguire. Nelle scuole superiori (eliminati gli ordini di Vignola e Le fabbriche... di Quarenghi) vanno esaminati monumenti famosi di tutti gli stili possibilmente dal vero: misurandoli e studiandone materiali e costruzione.In Italia si costruisce secondo il Vignola <<monotoni allineamenti di contrade>>. La simmetria è legge, definita da Viollet-Le-Duc la legge degli sciocchi. Nell’ Entretien X scrive che la simmetria non esiste come non esiste l’uguaglianza fra gli uomini.La Londra medievale <<compendio e teatro di snella architettura, alle presenti costumanze convenientissima>> è per Selvatico un modello. Soprattutto Venezia che <<in sé comprende quella varietà pittoresca di linee, e quella gentilezza di ornature che meglio al costruire odierno imporrebbe applicare>> 17.Il mondo contemporaneo richiede ornamenti coerenti con i nuovi materiali per la costruzione.Credo [...] che molto resti da fare per condurre l’ingegno e la mano dell’artista a trovar forme che s’attaglino ai nuovi docilissimi materiali di cui ci gioviamo adesso, come è ad esempio il ferro, il quale, fuso o battuto, chiede una eleganza, se così posso dire, sottile ed agile nelle sue fregiature, che non potrebbe tentarsi nella pietra e nel legno [...] intendo dire al pensiero di comporre gli ornamenti colle pompe sempre dilettevoli della vegetazione.18
Aggiunge poi la sua opinione aperta a un futuro di progresso e di rinnovamento:<<Credo che le nuove industrie, introdotte a profitto e conforto della vita, permettano nuovi simboli ornamentali, ignoti agli antichi.>>19. Perciò la “Industria del bello” va difesa dal positivismo del secolo della scienza e della tecnica. Napoleone fu il patrono delle arti maggiori. Ora Francia e Inghilterra guidano le arti industriali costruendo centinaia di chiese neo gotiche con arredi sacri che sono premiati all’esposizione di Londra del 1851. Eppure la praticità inglese non raggiunge il gusto francese. 20mentre la Germania sta facendo grandi progressi. Lodovico di Baviera ha fatto di Monaco l’Atene d’Europa. Sì al progresso della scienza e dell’industria ma anche a quello delle arti. 21 Ne Sulla necessità che nello insegnamento dell’arte il lavoro sia compagno al’istruzione osserva come <<L’educazione, per quanto egregia, guidi a nulla di utile se non la rafforzi concomitante il lavoro>> basta quindi con la sola teoria senza la pratica, bisogna ritornare alla bottega22.Il purismo e l’arte cristiana.
Modello ideale di pittura e scultura è il purismo e l’arte cristiana dei Nazareni:All’anime che sulla terra, più che le altezze dell’uomo, cercano i palpiti dell’affetto, dovette essere commovente spettacolo, sul cominciare del presente secolo, vedere fra le moli auguste che il Vangelo piantò sulla abbattuta Roma dei Cesari, aggirarsi un drappello di giovanetti tedeschi, poveri sin quasi all’indigenza. E là fra le primitive basiliche ove il cristiano avea deposto, nei secoli della fede, lagrime e gioie, pensieri e
17 ID., L’educazione dell’architetto nel passato e nel presente, ora in ID., Scritti d’arte , cit., p. 331. 18 ID., Sull’importanza dello studio degli ornamenti, ora in ID., Scritti d’arte , cit.. pp.351-352
19 ibid. p.356. Ma quando si passa a proposte concrete i modelli sono forme del mondo vegetale tratte dall’architettura medievale.
20 ID., Il prosperamento delle grandi arti del disegno profitta all’industria manufattrice, ora in ID., Scritti d’arte, cit.. pp. 371-372
21 ibid. p. 375
22 ID. Sulla necessità che nello insegnamento dell’arte il lavoro sia compagno al’istruzione ora in Scritti d’arte, cit. pp. 379-380. Fonda infatti l’ istituto d’arte per operai a Padova nel 1867.
speranze terrene, que’ miti errabondi andar rintracciando le tradizioni dell’arte arcaica, a fine di rinnovare la corrotta arte discesa dai Caracci, che allora faceva il giro del mondo come le devastazioni napoleoniche.23
Sono Vogel, Cornelius, Schadov, Hess, Veit, Steinle, e <<quell’Angelico dei nostri dì>> Federico Owerbeck, Ai nazareni Selvatico associa il faentino Tommaso Minardi e Pietro Tenerani <<luce di tutta la scultura presente>>. L’arte cristiana non deve infatti rappresentare temi religiosi avulsi da ogni naturalismo, <<ella mira invece a dar vita ad ogni argomento sociale in cui la passione sia vinta dai sorrisi dell’affetto24>>.Pittura e scultura devono rappresentare il <<verisimile>> piuttosto che il <<vero>> il deforme non si deve rappresentare come ad esempio nelle decorazioni medievali
Per quanto poi riguarda l’architettura <<L’architetto ha l’obbligo di porre in cima de’ suoi concetti l’uso cui gli edifici son destinati, e di mettere in aperto quest’uso col mezzo di forme tipiche che nettamente lo addimostrino>>25.<<La scultura elemento universale di educazione>> segna la rinascita da Giotto a Masaccio. Dopo la morte di Raffaello nel 1520 <<Michelangelo, ingegno sublime, ma troppo innamorato dello straordinario; anima più gigantesca che grande [...], gettò nell’arte i semi di quell’esagerato che la trascinò, più tardi, ai deliri del barocchismo, e le fece perdere così le pure tradizioni del trecento, come la via diritta su cui ella deve procedere26.>> In reazione lo studio dell’antichità e della bellezza nei marmi greci e romani fece sì che l’arte dimenticò il compito di esprimere la cultura cristiana fino alla caduta di Napoleone. Oggi poi regna incertezza eclettica.
<<L’architettura [è ...] la direttrice, la ragione e il teatro delle altre arti collegate alla civiltà>>27.Modello simbolico il tempio di Salomone. Modelli S. Clemente e S. Saba a Roma. L’autore preferisce le basiliche come ritorno al cristianesimo delle origini, sull’esempio di Brunelleschi. Seppure il gotico appare più severamente religioso e
io amo, più che ogni altro stile, l’archi-acuto, ma il vero innanzitutto, e il vero mi dice che le cattedrali del settentrione, gloria severa e malinconica propria ad un pensiero elevatamente mesto, come quello di popoli nordici, potrebbero essere forse qui da noi piante fuori del loro terreno. Ma se non fuori del loro terreno, certamente fuor del loro tempo ci appariscono invece sì il tempio romano [...] le chiese palladiane, le barocche28.Critica Canina, che nella sua Sull’architettura dei tempii cristiani (Roma 1842) ritiene i colonnati trabeati più antichi e quelli reggenti archi posteriori, ma stranamente tralascia di commentare la ricostruzione di S. Paolo a Roma dopo l’incendio del 1823 e di considerare l’opera di Poletti, il maestro del purismo romano. Di S. Paolo scrive solo a proposito della liceità di far poggiare archi su colonne in nome della verità statica, mentre cita ad esempio le moderne chiese basilicali parigine.L’architettura bizantina fino a Giustiniano deriva direttamente da quella tardo-romana, e man mano allontanandosi da essa si imbarbarisce. L’architettura di Santa Sofia è dovuta 23 ID., Del purismo nella pittura, ora in ID., Scritti d’arte , cit.., pp.136-13724 ID, L’arte dei secoli cristiani, le fondamentali sue basi ed il suo scopo, in Storia estetico-critica, cit., p.14.
25 ibid. p.14. Il deforme è vero ma non verisimile, il Quasimodo di Hugo <<può esserci in natura, ma ne è l’eccezione e le eccezioni non servono mai a spiegare fatti universali.>> p.16.
26 ibid. p.21.
27 ibid. pp. 27-28. Nella metamorfosi da basilica civile a basilica religiosa, avviene l’inversione dal tempio pagano tutto esteriore e rivolto ai profani mentre la divinità è celata; ora i fedeli sono i celebranti del culto, perciò l’importanza dell’interno e dei suoi ornamenti sul modello del tempio di Salomone. Per quanto riguarda la pianta, nelle basiliche romane di S. Pietro e S. Giovanni in Laterano si passa alla pianta a croce, le porte sono a oriente e l’abside a occidente, ma già a Ravenna si ha l’inversione, molto prima dello scisma fra oriente e occidente, come pensa Selvatico.
28ibid. pp. 48-49.
al cerimoniale imposto da Giustiniano intorno allo “jerateion” e da essa nasce il nuovo tipo di chiesa bizantina a quinconce entro un quadrato.A Venezia si trovano affiancati i nuovi modi bizantini (pianta a “quincunx”) ai sistemi costruttivi romani: da s. Giacomo a Rialto e s. Fosca a Torcello (modelli per Scarpagnino e Sansovino a s. Giovanni elemosinario e a s. Geminiano) fino a s. Marco. Dopo il disprezzo per questa architettura da parte degli architetti del tardo rinascimento e del neoclassicismo essa rivive nella sinagoga di Dresda di Semper (distrutta nel 1938) e soprattutto nella chiesa di corte di Monaco. Le forme geometriche collegate a quell’idea sono il quadrato, la sfera e il circolo a dimostrazione dell’importanza della geometria a base della composizione.
Passa poi a fare la storia del romanico occidentale, cioè l’Architettura lombarda dal IX al XIII secolo seguendo Cordèro di S. Quintino: è S. Guglielmo da Volpiano, consigliere dell’abate di Cluny e poi dei duchi normanni, l’ architetto di s. Benigno a Digione29. Concentrato su questa linea genetica piemontese non dà molta importanza ai maestri comacini. Con Hope spiega il passaggio al gotico dopo le crociate e il contatto con l’islam. I capolavori proto romanici che cita in Italia Italia sono il tempietto di Cividale, s. Michele a Pavia, s. Ambrogio a Milano e s. Maria a Tuscania. Sottolinea infine la intima unione fra architettura e ornamento simbolico: i protiri con leoni reggenti colonne di tante cattedrali romaniche sono guardiani a protezione del tempio. Architettura e scultura collaboreranno poi per quasi un millennio fino a Palladio.
Ora per Selvatico occorre non isterilirsi sulle norme neoclassiche o a <<studiare la flora convenzionale dell’Albertolli>>30, bensì rinnovare l’ornamento basandosi sugli stili. Di ciò si gioverebbero le industrie e in particolare l’architettura. Né egli nega la ricerca originale che però non va oltre alla flora stilizzata.
La cappella Pisani a Vescovana
Esempio pratico delle convinzioni di Pietro E. Selvatico su architettura, stile, ornamento sono le poche opere costruite nel segno dell’indissolubile connubio fra architettura e scultura con Antonio Gradenigo, scultore padovano (1806-1884), (oscillante fra il neoclassicismo e il neogotico nel Pedrocchino (1837), il moresco nella serra Torlonia con Jappelli (1838) e di nuovo il neoclassico nei monumenti funerari e infine nella facciata della chiesa dell’Arcella (1869), ricostruita poi nel secolo scorso in forme neogotiche). Dopo la commistione di tardo gotico tedesco e veneziano nella facciata di S. Pietro a Trento 1848-5131 e l’altare maggiore della parrocchiale di Mezzo Lombardo, la cappella funeraria Pisani in stile gotico perpendicolare Tudor, illustrato dalle tavole dello Hoffstadt Lazzari Principi dello stile gotico (1840), Venezia 1853, è l’unica architettura completa della coppia Selvatico Gradenigo, anche se oggi irreparabilmente degradata.
La cappella funeraria di Ermolao Pisani a villa Pisani a Vescovana del 1860 nasce appunto da questa collaborazione, come è dichiarato nella lapide a caratteri gotici posta sulla facciata a lato dell’ingresso. All’esterno il prospetto è diviso in cinque parti declinanti e sfalsate rispetto a quella corrispondente alla navata centrale ornata dal portale; in particolare essa, può accostarsi alla tavola XXXVI dello Hoffstadt Lazzari (figg.1,2). Essa è coronata da una merlatura guelfa tipica dello stile gotico perpendicolare Tudor inquadrata da due snelle guglie laterali ruotate di 45 gradi (di un quarto di cerchio) che sormontano 29ibid . p. 75. 30 ID. Sull’importanza dello studio degli ornamenti, in Scritti d’arte, cit., p. 354.
31 Ci si riferisce qui alle ali laterali della facciata tedesche nel disegno delle finestre e alla ogiva inflessa che orna a bassorilievo la parete centrale sopra il portale fino a reggere la statua del santo tutelare sopra il coronamento traforato. Ringrazio la dr. Maria Elisabetta Piccolo, per la sua tesi L'*eclettismo della "fattoria del doge" ovvero il parco di Villa Pisani a Vescovana / Maria Elisabetta Piccolo ; relatore V. Fontana. - [S.l.] : [s.n.], 2001. - 3 v. ; 30 cm. ((Tesi (Università di Venezia-Facoltà di Lettere e filosofia, a.a. 2000-01). - Consultazione non autorizzata - e per le foto qui pubblicate.
Friedrich Hoffstadt, Gothisches ABC-Buch, 1840, I principi dello stile gotico, tradotti e completati da Francesco Lazzari 1853
con i loro pinnacoli il fregio e mediano il passaggio alle ali laterali che corrispondono alle navate minori coperte a spioventi. Queste ricordano quelle laterali nella facciata di S. Pietro a Trento e sotto la merlatura corre un fregio su cui un tempo era la “dedica” al defunto in lettere gotiche a rilievo in bronzo, oggi in gran parte cadute; più sotto turgide decorazioni vegetali in pietra e in stucco, riprendono le volute che dalle ogive del portale aggettano su uno sfondo di stucco a marmorino innervato da esili e slanciate ogive trilobate, tipiche del gotico inglese. La lunetta entro l’ogiva del portale è partita in due archi acuti trilobati corrispondenti alle ante della porta di quercia ed è sormontata da un angelo reggente lo stemma Pisani. I lati arretrati, testate delle navate laterali, si distinguono per la semplicità della muratura a vista e solo due piedritti con cuspidi di pietra trattengono le diagonali delle falde di copertura. Su un terzo piano arretrato si scorgono i volumi più bassi dei loculi su ambedue i lati tagliati ad angolo smussato suggerendo una visione tridimensionale della cappella; il muro in laterizio qui è coronato da un fregio di pietra massiccio a spezzata a spina di pesce, non certo Tudor (semmai memore del mausoleo di Teodorico a Ravenna) che può aver ispirato Camillo Boito nell’esterno delle cappelle laterali del cimitero di Gallarate.
L’interno, nella devastazione dovuta a incuria e vandalismi, oggi va letto cercando di ricostruirne l’aspetto originale caratterizzato da un calibrato equilibrio fra spazio architettonico e parco ornamento. La contro facciata interna è sormontata da un baldacchino ligneo a pendenti sospeso a mensola sul semplice arco Tudor che sovrasta la porta di ingresso che inquadra l’iscrizione
<<ad honorem/B.M.V. in templo praesentatae / et ad perennandam cinerum familiae memoriam hoc sacellum fieri iussit Hermolaos III Ios. Pisani patr. ven. anno dni 186032>>. La contro soffittatura costituita da una finta volta Tudor, caduta nei primi mesi del 1997, partiva da una cornice ornata a motibid. vegetali alternati a merli guelfi che corre sulla contro facciata (tutta merlata) e sulle pareti. Queste sono divise dalla centrale da pilastri con modanature in stucco mentre le triplici campate di archi Tudor sono evidenziate da mensole aggettati su pendenti che articolano con merli la cornice ritmata da archi capovolti culminanti in fleuron stilizzati in trilobi. Lo stucco a marmorino, innervato da esili e slanciate ogive trilobate, usato nell’esterno sopra il portale, orna i pennacchi delle arcate estendendosi fino alla quota della cornice.Le nervature in stucco del contro soffitto disegnavamo archi Tudor scandendo lo spazio interno secondo le triplici arcate delle navate minori ma poggiavano su mensole nettamente staccate dalla cornice merlata quasi a dimostrare la loro natura non strutturale. Le nervature trasversali intersecavano la longitudinale di colmo con rosoni vegetali inscritti in quadrati tratti dalla tavola XXIV dello Hoffstadt Lazzari (figg.3,4). Un’ orditura di legno e “grisiole” (canne di palude) sosteneva la finta volta appesa alle capriate del tetto.L’altare semplicissimo rivestito di marmorino bianco, che ripete il solito motivo di slanciate ogive trilobate della facciata e dell’interno nei pennacchi degli archi, (oggi completamente depredato e profanato), ha per sfondo il finestrone Tudor a bifora trilobata che illumina tutto l’interno. Danneggiate sono pure le panche di legno in stile neogotico che appaiono accatastate in disordine nel 1999 dopo il crollo del contro soffitto. Nel mezzo della navata a sinistra dell’ingresso un arco Tudor coronato da merli guelfi contiene le lapidi di Ermolao Pisani e della moglie Evelina van Millingen con davanti la statua a tutto tondo e in grandezza naturale di Ermolao in costume storico attribuibile senza dubbio ad Antonio Gradenigo. 32 “In onore della presentazione al Tempio della B.V.M. e per render perenne la memoria delle ceneri di famiglia Hermolao III Pisani patrizio veneto ordinò che si costruisse questo sacello nell’anno del Signore 1860” Naturalmente i caratteri gotici dipinti in rosso seguono il modello di Hoffstadt Lazzari a tav. XXXIII
Nella navata di destra a metà sono le lapidi dei Bentivoglio d’Aragona e Nani Mocenigo, eredi di Pisani, entro un arco identico a quello di fronte.
L’educazione dell’architetto da Selvatico a Boito.Il giovane Camillo Boito esordisce nel 1858 come professore all’Accademia di Venezia facendo tradurre agli allievi le formelle esagonali delle arti liberali e meccaniche del campanile di Giotto e i rivestimenti marmorei dei fianchi di S. Maria del Fiore in terracotta stampata, secondo le indicazioni del maestro e pure nelle sue architetture gli deve molto. Questi esercizi pratici sono corollario alle lezioni teoriche di Selvatico33.I materiali definiscono la forma e la costruzione, <<storia delle ragioni costruttive subordinate alla natura dei materiali>> non bisogna premettere quindi l’estetica alla costruzione. Su essa si basa il disegno storico: dai graniti, porfidi e basalti dell’Egitto ai marmi Greci proconesso e pario, dalla architettura litica alla terracotta e laterizio di Etruschi e Romani, fino alle malte delle volte e delle cupole, poi rivestite di marmi da ogni parte dell’impero. Al nord le volte dei boschi, le arenarie delle Ardenne e il grés di Parigi sono alla base dell’architettura romanica e poi gotica, accanto il legno degli chalet svizzeri. In Italia Brunelleschi affianca la sua cupola ogivale, agli archi su colonne delle sue basiliche usando l’ornamenti classici. Nel cinquecento invece i trattati di Vitruvio e Vignola soffocano l’architettura. Perciò abolire i trattati nelle scuole di architettura: da Falconetto a Scamozzi. Dopo le follie del barocco (colpevole Michelangelo) avviene la riscoperta di Ercolano e Pompei e il neoclassicismo diventa stile della rivoluzione. <<Le graticole della scuola politecnica di Parigi, non disprezzabili se parcamente usate, e le sagome per cornici ed ornamenti predisposte da Percier e Fontaine [...] finirono collo isterilire la povera architettura>>. Ma da venti anni a questa parte Francesi, Tedeschi, Russi e Inglesi soprattutto si ribellarono e, rotto l’alto sonno della testa, cercarono ispirazione in altri stili del passato, in opere <<brizzolate>> <<d’eclettismo>>, ma tutte <<meglio accomodate, e per distribuzione e per aspetto, alla nostra odierna maniera di vivere>>. Solo noi Italiani seguiamo ancora Napoleone e non guardiamo alle nostre basiliche <<latine>> alle <<sicule>> alle combinazioni geometriche di S. Maria del Fiore e del campanile di Giotto, alle leggiadrie degli edifici lombardeschi e bramanteschi. Voi studenti <<dal procedimento storico comprenderete quali elementi del passato s’attaglino a noi, quali si disdicano, quanto sia possibile tentare di nuovo, coi nuovi materiali ch’ora ci fornisce l’industria.>>. La via è stata aperta da Francesco Lazzari in quaranta anni di insegnamento <<con lo studio degli stili lombardeschi e archiacuti [...]. Io tenterò di far più chiaro, con l’offerirvi riprodotti da nitide incisioni i monumenti migliori di ogni stile opportuno agli usi odierni.>>. La storia dell’architettura per tipologie e confronti storici come in Durand non deve tralasciare tecniche e materiali. A Selvatico la teoria, all’insegnante di disegno la pratica. <<L’ornato architettonico è parola dell’edificio, e come parola deve aver un carattere preciso, limpido>>. Ma fondamentali sono i caratteri costruttivi di murature e volte in mattoni e pietra da taglio, il disegno delle volte senza aiuto del calcolo, delle capriate in legno la geometria descrittiva pratica, il rilievo dei monumenti per arrivare infine alla composizione cominciando dai tipi più semplici. Il tempo è di soli sette mesi in tutto34. Boito all’esordio come professore segue le orme del maestro. <<Base di tutto>> aveva scritto Selvatico nelle scuole primarie è la geometria descrittiva pratica <<alfabeto della forma>> per <<delineare su qualsiasi coordinata le proiezioni de’ solidi i più complicati,in modo da farli agevolmente eseguire>>. Nelle scuole superiori (eliminati gli ordini di Vignola
33 Prelezione al corso di storia dell’architettura per laureati ingegneri di Padova all’Accademia di Venezia del 1856 ora in P. Selvatico, Scritti d’arte, cit. p.289. Vedi Inoltre G. ZUCCONI, L’invenzione del passato..., cit., pp. 72 e sgg.
34 Ibid, pp.299-303.
e le fabbriche di Quarenghi) si esaminino i monumenti famosi di tutti gli stili possibilmente dal vero: misurandoli e studiandone materiali e costruzione.In Italia si costruisce secondo il Vignola<<monotoni allineamenti di contrade>>. La simmetria è legge, definita da Viollet-Le-Duc la legge degli sciocchi. Modelli: Londra medievale <<compendio e teatro di snella architettura, alle presenti costumanze convenientissima>>. E soprattutto Venezia che <<in sé comprende quella varietà pittoresca di linee, e quella gentilezza di ornature che meglio al costruire odierno imporrebbe applicare>>35.
E’ su queste basi che Boito a Milano cercherà di rinnovare l’insegnamento dell’architettura all’accademia di Brera gettando un ponte con l’Istituto Tecnico Superiore di Brioschi.Ma il debito non è solo nella didattica ma anche nella progettazione architettonica.In, Sulla condizione attuale del palazzo pubblico di Piacenza e sui modi di ristaurarlo. Relazione, del 186236. Selvatico consiglia la reintegrazione stilistica del prospetto esterno con merli ghibellini, la abolizione del fastigio barocco con le volute e la campana e la ricostruzione delle torrette angolari con quella di sinistra priva dell’orologio. Il balcone barocco dell’arengario deve essere demolito e rifatto in stile gotico. Selvatico propone di appoggiarlo su mensole ma queste seppur originali sporgono alla quota dell’imposta degli archi acuti della loggia terrena e sono quindi troppo basse rispetto al livello della sala. Il problema di quota viene risolto dall’architetto ponendo sulle mensole esili colonnette (come si vedono nella tavola degli Entretiens di Viollet-le-Duc che illustra l’aula romanica). In un modo simile Boito riprenderà questo motivo nel palazzo delle Debite a Padova (figg. 5,6).
Tipi di coperture gotiche inglesi, italiane a carena (come agli Eremitani e a San Fermo a Verona), o contro soffitto a finta volta archiacuta come nella cappella funeraria Pisani sono poi esaminate dall’architetto padovano tenendo ovviamente presente il grandioso esempio della carena ogivale trecentesca di frate Giovanni degli Eremitani nel palazzo della Ragione o della volta a botte ribassata degli Scrovegni. Giuseppe Mengoni invece aveva proposto moderne capriate metalliche a vista.
Nel concorso del 1864 per la facciata di S. Maria del Fiore Camillo Boito attacca violentemente il progetto tricuspidato di Emilio De Fabris, sostenuto da Selvatico, che così aveva progettato la facciata di S. Pietro a Trento. Viene chiesto il parere di Viollet-le-Duc che rileva i limiti del sistema tricuspidale, che del resto Selvatico stesso non aveva usato nella cappella Pisani. Prevale comunque De Fabris con un progetto tricuspidato scelto dalla commissione presieduta da Pietro Selvatico nel 1867 con pochi voti di maggioranza. Questi affida a De Fabris il progetto esecutivo con molti suggerimenti sopratutto per la parte scultorea seguendo temi e simboli scelti dal filosofo Augusto Conti. Selvatico insomma difende fino in fondo il suo concetto neo gotico della facciata concepita come una pala d’altare sull’esempio di Siena e Orvieto, ma dal 1870 la soluzione basilicale con ballatoio appena spiovente nella navata centrale e testate orizzontali per le navate laterali prende definitivamente il sopravvento per accostarsi all’esempio incombente del campanile di Giotto. 35 Ibid. p. 331. Per Selvatico a Padova vedi ora A. AUF DER HEYDE, <<Per l’avvenire dell’arte in Italia>>: Pietro Selvatico e l’estetica applicata alle arti del disegno nel secolo XIX, Pacini, Pisa 2013, pp. 269 e sgg.
36 Pietro Selvatico-Estense, Sulla condizione attuale del palazzo pubblico di Piacenza e sui modi di ristaurarlo. Relazione, Piacenza dalla tipografia di A. Del Majno 1862, ora anche in < http://books.google.es/books/about/ Sulla_condizione_attuale_del_palazzo_pub.html?id=v2xJAAAAYAAJ>.