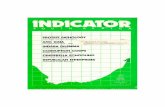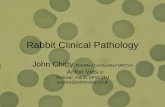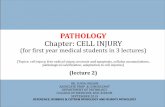Law or Rule of Law? Normality and Pathology in Hart's Concept of Law (in italian)
Transcript of Law or Rule of Law? Normality and Pathology in Hart's Concept of Law (in italian)
Alberto Puppo
Diritto o stato di diritto? Salute e patologia in The Concept of Law di H.L.A. Hart
0. Introduzione
Il libro fondamentale di Hart The Concept of Law rappresenta senza dubbio un
momento tra i più rilevanti della storia della teorizzazione sul fenomeno giuridico, che
va sicuramente al di là della mera tradizione giusfilosofica analitica e positivista.
Se si rispetta fedelmente il titolo del libro, sembra evidente che l’oggetto di studio del
giurista inglese sia stato il concetto di diritto. Tuttavia, esistono varie ragioni per
dubitare del fatto che durante tutto il libro Hart si riferisca al diritto o, il che è
praticamente lo stesso, che si utilizzi lo stesso concetto di diritto.
Un solo esempio è sufficiente per legittimare il dubbio. Da un lato Hart sembra definire
il concetto di diritto come l'unione di norme primarie e secondarie, come un sistema
giuridico con certe caratteristiche, che corrispondono ad altrettante soluzioni ai
problemi che presentavano i diritti primitivi (o i fenomeni giuridici primitivi, se non
vogliamo usare la parola 'diritto'). Da un altro lato, però, Hart, quando analizza il diritto
internazionale, sembra affermare che nonostante non sia un sistema di norme primarie e
secondarie, e soprattutto nonostante la sua natura primitiva, il diritto internazionale è
diritto.
Si potrebbe pensare che il diritto solo può essere definito, wittgensteiniamente, sulla
base di certi casi paradigmatici e di certe somiglianze di famiglia. Il che potrebbe
permettere di affermare, per esempio, che il diritto tedesco del dopoguerra è un esempio
paradigmatico di diritto, mentre il diritto internazionale, pur essendo sempre diritto,
rappresenta un caso marginale. Vi sarebbero, per dirlo con Finnis (NLNR, 278), casi
centrali e casi periferici. Hart, insomma, come lo dice esplicitamente incominciando il
suo capitolo sul diritto internazionale, sta solamente cercando di delucidare il concetto
Alberto Puppo, DOSD, Primo Draft, 29 giugno 2013. Per favore, non citare.
1
di diritto piuttosto che dare una definizione di diritto che stabilisca le regole per il suo
uso (CL, 213).
In altri termini, le oscillazioni di Hart dipenderebbero dalla mutevolezza della realtà e
degli usi che di fatto esistono. La parola ‘diritto’ si userebbe non solo per riferirsi a
sistemi sofisticati in cui chiaramente si possono identificare norme primarie e
secondarie (un caso centrale), ma anche per riferirsi a sistemi primitivi come il diritto
internazionale (i casi periferici). Se si volesse stabilire una scala, sulla quale ordinare i
vari fenomeni che meritano la qualificazione di «diritto», si potrebbe iniziare con
«insieme di norme primarie», «insieme di norme primarie e secondarie», «sistema
giuridico». In quest’ultima categoria, si potrebbe distinguere tra un livello inferiore in
cui starebbero i «sistemi giuridici patologici» e un livello superiore in cui starebbero i
«sistemi giuridici normali», e forse uno ancora superiore in cui si collocherebbero i
sistemi con un'ottima salute1.
Ciò che non risulta chiaro è se un diritto primitivo è ipso facto un sistema patologico2.
Ovviamente la questione è importante, sarebbe come domandarsi se una manichino è
una persona con una grave paralisi, e quindi un caso di «persona patologica». Diremmo
tutti che un manichino non è una persona e quindi non può ammalarsi. Nel caso del
diritto si manifesta l’ambiguità che caratterizza la almeno apparente identificazione
hartiana tra diritto e sistema giuridico. Se sono sinonimi, allora un diritto primitivo è un
sistema giuridico primitivo. Ma se un sistema giuridico è un insieme di norme primarie
2
1 CL, 231-232: "It may well be that any form of legal order is at its healthiest when there is a generally diffused sense that it is morally obligatory to conform to it".
2 Un passaggio del Postscript lascia dubbiosi, e forse può solamente essere capito se si distingue chiaramente tra la funzione e la struttura del sistema giuridico (distinzione che, salvo errore da parte mia, Hart non ha tracciato). Analizzando la questione dell'indeterminazione che può introdurre nella regola di riconoscimento l'incorporazione di criteri morali, Hart constata che "The underlying question here concerns the degree or extent of uncertainty which a legal system can tolerate if it is to make any significant advance from a decentralized regime of custom-type rules in providing generally reliable and determinate guides to conduct identifiable in advance". Questo estratto meriterebbe un ampio approfondimento, ma mi limiterò a sottolineare come possa essere interpretato nel senso in cui il passaggio da un sistema giuridico sofisticato, con una regola di riconoscimento che addirittura include criteri morali, a un mero insieme di norme consuetudinarie, potrebbe essere graduale.
e secondarie e un diritto primitivo è un insieme di sole norme primarie, ci troviamo di
fronte a un caso chiaro di incoerenza nell'uso del linguaggio3.
Può essere d’aiuto analizzare sommariamente gli esempi che offre Hart quando
introduce il tema della patologia. Il caso sudafricano ricostruito da Hart è un chiaro
esempio di patologia che solo può esistere in un sistema giuridico in senso stretto, una
indeterminazione patologica della regola di riconoscimento4. La sospensione del diritto
in caso di invasione, guerra etc. genera qualche dubbio5. Sospensione, in senso stretto,
presuppone un atto di sospensione, in tal caso una sorta di derogazione, il che
implicherebbe almeno un tipo di norma secondaria. Se però la sospensione si intende
come la cessazione della vigenza di certe norme primarie per il semplice fatto, banale,
che tutti, nella città o nello stato, hanno una preoccupazione ben più grave che è, per
esempio, prendere le armi e cacciare il nemico invasore, allora tutto ciò può accadere,
ed essere descritto, per così dire, da un punto di vista esterno, non come sospensione
della validità di certe norme, ma come semplice abbandono di certe pratiche sociali,
ovvero se adottiamo un concetto hartiano di regola, come cambio negli atteggiamenti
del gruppo rispetto a certi modelli che cessano di essere considerati come obbligatori.
Alberto Puppo, DOSD, Primo Draft, 29 giugno 2013. Per favore, non citare.
3
3 Per un'analisi dettagliata della confusione hartiana nel momento in cui fa riferimento al diritto internazionale, che consiste nell'affermare e negare al tempo stesso che il diritto internazionale sia un sistema giuridico, cfr. Beckett, 2008, 57, specialmente la nota 24. E' interessante ricordare che quando Hart approfondisce le varie idee relative al contenuto del diritto internazionale e alla possibilità che esista qualcosa simile a una norma fondamentale, sembra, quando si riferisce alla regola che fornisce forza obbligatoria ai trattati, accettare l'esistenza di una chiara distinzione tra un insieme (set) di standards di condotta (norme primarie), un insieme di regole (che potrebbero essere primarie e secondarie, se si considera che la norma che conferisce obbligatorietà ad altre norme è per definizione secondaria) e un sistema di regole in senso stretto. Per apprezzare la mia osservazione sarà utile comparare i due seguenti passaggi: "In the first place, the rules by which the group lives will not form a system, but will simply be a set of separate standards, without any identifying or common mark, except of course that they are the rules which a particular group of human beings accepts" (CL, 92); the rules which are in fact operative constitute not a system but a set of rules, among which are the rules providing for the binding force of treaties" (CL, 236).
4 Hart introduce l'esempio sudafricano con queste parole: "The unity among officials, the existence of which is normally presupposed when internal statements of law are made within the system, may partly break down" (CL, 122). La patologia che deriva dall'indeterminazione è ovviamente più grave e/o più frequente, quando nella regola di riconoscimento si incorporano criteri morali. Hart (CL, 252) sembra esserne cosciente, anche se non ne deriva conseguenze rilevanti per la sua teoria.
5 CL, 118 ss. Della relazione tra la sospensione del diritto, il concetto di stato di eccezione e l'adozione del punto di vista interno, mi sono occupato in Puppo, 2013.
Nel caso di un sistema primitivo, forse, dovremmo dire, semplicemente, che il diritto è
stato modificato. Ogni patologia, allora, dovrebbe presupporre un funzionamento tale
che esista almeno una norma secondaria, per esempio sulle sanzioni o sulla produzione
o eliminazione di nuove regole.
Se utilizzassimo la metafora basata sull'opposizione tra salute e malattia, potremmo dire
che un diritto primitivo non può ammalarsi. Come un virus, può mutare, ma non può
ammalarsi perché la malattia presuppone la perturbazione, qualunque sia la sua natura,
quantitativa o qualitativa, in una organizzazione relativamente complessa (che negli
umani potrebbe chiamarsi anatomia o, diranno alcuni, fisiologia, e nel caso del diritto
potrebbe chiamarsi sistema giuridico)6.
Sebbene, seguendo Hart, in tutti i citati casi si può parlare di diritto, è legittimo pensare
che tra i due estremi della scala si compia un salto qualitativo, che potrebbe giustificare
l’uso di concetti distinti, per esempio quelli di diritto e stato di diritto. Il concetto di
sistema giuridico, contrariamente a quello che succede con teorie come quella, per non
citarne che una, di Alchourrón e Bulygin, non sembra utilizzato in senso tecnico, e
sarebbe quindi opportuno, per questa ragione, eliminarlo7. Nel caso dei citati autori, per
esempio, è chiara la distinzione, da un lato tra un semplice insieme di norme e un
insieme ordinato di norme; un sistema corrisponde alla seconda ma non alla prima
configurazione. Inoltre è altresì conosciuta la chiara distinzione tra sistema giuridico e
ordine o ordinamento (orden in castigliano) giuridico; il secondo, concetto dinamico, è
4
6 Dico "potrebbe chiamarsi", perché ovviamente è una questione di stipulazioni. Gli autori che considerano sistema giuridico come sinonimo di diritto ovviamente, a meno che non siano positivisti metodologici, non la chiamerebbero così. Preciso, se per caso fosse necessario, che non è qui questione di fare qualche folcloristica analogia tra diritto e biologia. L’uso di una metafora non implica nessuna analogia sostanziale tra i due fenomeni, quello spiegato e quello che fornisce lo spunto per la metafora. Come sosterrò, uno degli obiettivi di questo scritto è smettere di usare metafore connotative, e scegliere piuttosto la soluzione guastiniana, vale a dire distinguere chiaramente.
7 Si tratta di un difetto comune, probabilmente, alla tradizione anglosassone non avvezza alle finezze della dogmatica continentale che, molto prima che i filosofi argentini perfezionassero il concetto di sistema, parlavano già chiaramente del sistema giuridico come frutto dell’opera di sistematizzazione tipica della scienza giuridica. Tali giuristi distinsero chiaramente il sistema della sistematica (artificiale) dai sistemi, per così dire metafisici, di cui parlano autori che pensano che il diritto è «naturalmente» un sistema. E’ inutile ricordare che Bobbio fu un maestro nel delucidare il passaggio dal diritto al sistema. Su questo tema rinvio a Puppo, 2011, 305 ss.
una sequenza di sistemi giuridici. In Hart, invece, risulta chiaro che, da un lato, si usa
'sistema giuridico' come sinonimo di 'diritto', e quindi di 'ordinamento giuridico' e,
dall’altro, si definisce il sistema giuridico (e quindi il diritto) come unione di norme
primarie e secondarie (e non quindi, necessariamente, come un'unione di un certo tipo,
né, sufficientemente, come mero insieme di norme primarie). In alcune occasioni
tuttavia si distingue chiaramente tra un mero insieme, di norme primarie e secondarie, e
un sistema giuridico.
Risulta ugualmente chiaro che non usa, o per lo meno, non usa con particolari finalità
esplicative, il concetto di stato di diritto (rule of law)8. Una ragione è chiara: non era
forse un tema giusfilosofico rilevante. La situazione è diversa oggi: gli studi sul
concetto di stato di diritto sono in crescita, e ogni autore offre la sua versione, la sua
definizione, e ovviamente la sua diagnosi.
A questo proposito è doverosa una premessa: quando mi riferisco allo stato di diritto
non voglio entrare in questioni tipicamente attuali, come il dibattito tra le diverse
concezioni formali e sostanziali. Come risulterà più chiaro in seguito, ogni qualvolta
userò l’espressione ‘stato di diritto’ la userò in senso lato, senza voler prendere
posizione. Il mio atteggiamento si giustifica, credo, nella misura in cui Hart non fa
nessun uso teorico del concetto. Ovviamente ho un'idea ben precisa di come dovrebbe
essere definito un buon concetto di stato di diritto, ma non cercherò di difenderla;
suggerirò solamente quale potrebbe essere la concezione di Hart, ammesso e non
concesso che sviluppi, come sosterrò, una teoria del rule of law.
L’idea o l’intuizione che soggiace a questo scritto è che, senza averne coscienza, Hart
sviluppa due discorsi: un discorso soddisfa l’esigenza metodologica annunciata
dall’inizio, ovvero l’esigenza che impone un lavoro di sociologia descrittiva; l’altro
discorso, a partire dal risultato dell’impresa sociologica, tende a costruire un altro
concetto o a stabilire un modello normativo per il primo: il concetto di diritto descritto
nel secondo discorso potrebbe costituire il modello che si deve seguire, al quale ogni
Alberto Puppo, DOSD, Primo Draft, 29 giugno 2013. Per favore, non citare.
5
8 D'ora in avanti userò le due espressioni come sinonimi.
diritto dovrebbe tendere. Se si vuole evitare l’interpretazione «normativa», allora si
dovrebbero distinguere chiaramente i due discorsi e i due concetti e si dovrebbe parlare
di stato di diritto, in un senso simile a quello di Raz, quando definisce lo stato di diritto
come una virtù che può sfoggiare un diritto, ma senza la quale un diritto, per esempio il
diritto nazista, continua ad essere un diritto.
Di fatto si potrebbero sostenere entrambe le tesi: in primo luogo, si potrebbe sostenere
che accanto al concetto di diritto, Hart costruisce anche un concetto di stato di diritto
(entrambe le imprese potrebbero essere descrittive o concettualmente ricostruttive); in
secondo luogo, si potrebbe affermare che il concetto di stato di diritto può funzionare
come modello al quale deve aspirare la realtà (di fatto: coloro che partecipano in essa)
descritta dal primo concetto. Anche in questo secondo caso, tuttavia, si potrebbe salvare,
e credo che mi stimolerebbe farlo, la posizione di Hart: si potrebbe infatti sostenere che
Hart si limiti a descrivere, sociologicamente, il fatto che coloro che partecipano lo
fanno, spesso, avendo come modello il rule of law. Un’altra possibilità, intermedia,
caldeggiata forse da Waldron, sarebbe forse che il concetto di rule of law è prioritario
rispetto a quello di diritto, ovvero che per sviluppare un concetto di diritto bisogna già
avere un concetto di stato di diritto9; questo significherebbe che Raz si starebbe
sbagliando pensando che il rule of law costituisce una virtù che può avere il diritto,
dando quindi per scontato che il concetto di diritto si possa definire indipendentemente
da quello di stato di diritto.
Penso che tutte queste interpretazioni siano plausibili. Mi concentrerò quindi soprattutto
sulla tesi della duplicità dei discorsi e dei concetti, non sul carattere normativo del
secondo.
6
9 Secondo Waldron, 2009, "our understanding of the Rule of Law and our understanding of the concept of law ought to be much more closely connected than they are in modern jurisprudence" (4), ma soprattutto "we cannot really grasp the concept of law itself without also understanding the values comprised in the Rule of Law" (9-10).
1. Considerazioni preliminari su diritto e stato di diritto
I miei argomenti si basano su due considerazioni o due gruppi di considerazioni, il cui
sottofondo è, si potrebbe dire, un'intuizione banale, che ovviamente può essere
ingannevole.
Sto pensando al fatto che Hart parla dal punto di vista di una tradizione giuridica
particolare, che è la tradizione inglese10. Sebbene si pensi sempre ai suoi maestri
analitici, Austin e Bentham, la mia intuizione è che quando descrive i comportamenti
dei giudici rispetto alla regola di riconoscimento (o alla costituzione), all’adozione del
punto di vista interno, e, soprattutto, quando sostiene che l’adozione del punto di vista
interno non esige un compromesso morale, sta facendo qualcosa di simile a ciò che fece
Dicey nella sua opera fondamentale Introduction to the Study of the Law of the
Constitution11, soprattutto nella parte in cui definisce il concetto di Rule of Law, e nella
parte in cui studia le convenzioni della costituzione.
Ovviamente non ho nessuna pretesa esegetica, rispetto ad Hart e ancora meno rispetto a
Dicey. Sta di fatto, tuttavia, che l’opera di Dicey, da un lato sembra essere una tappa
ineliminabile degli argomenti che autori rilevanti come Dyzenhaus o Waldron utilizzano
Alberto Puppo, DOSD, Primo Draft, 29 giugno 2013. Per favore, non citare.
7
10 Ovviamente ciò sarebbe smentito da Hart, che anche nel Postscript, dopo aver curiosamente – e aggiungo io, onestamente– ammesso che il suo libro sia stato scritto avendo in mente lettori inglesi, ricorda che la sua teoria è generale nel senso che non è legata a una cultura particolare o a un particolare sistema giuridico (CL, 239). Una conseguenza importante della mia intuizione, probabilmente «capitale», è che in tal caso tutta la discussione Hart-Dworkin non avrebbe nessun senso, perché non sarebbero teorie rivali e non solo, come direbbe Hart, per "colpa" della teoria di Dworkin. Quando Hart dice che «di fatto» i giudici usano discrezionalità, sta secondo me dicendo, per esempio, che di fatto i giudici che conosce meglio e che ha osservato, usano discrezionalità, che è impossibile che non lo facciano (come è impossibile che nevichi in Arabia Saudita, credo). Quando Hart critica la tesi dell’unica risposta corretta, quello che sostiene è che se così fosse ciò costituirebbe un male, giacché non dispone di nessun elemento per criticare, sociologicamente, la verità di tale affermazione. In altre parole: Dworkin potrebbe anche avere ragione sul fatto che i giudici megalomani americani pensino di incontrare l’unica risposta corretta, ma ciò indipendentemente dalla plausibilità dell’osservazione empirica sarebbe un male, ovvero costituirebbe un ostacolo nella costruzione di uno stato di diritto, vale a dire non trova spazio nel modello normativo di diritto che ha in mente Hart. Ritornerò sulla relazione tra discrezionalità giudiziale e rule of law, infra, specialmente nella sezione 3.2.2.2.
11 Dicey, 1915.
per formulare o riformulare i concetti di stato di diritto, dall'altro è quasi completamente
ignorata da Hart12.
Fatta questa premessa, posso brevemente passare alle considerazioni preliminari.
1.1. La prima è semplice e si limita a sottolineare che il concetto di stato di diritto
sviluppato da Dicey è, in senso stretto, un concetto di rule of law, così come si
costruisce, a partire dalla realtà inglese; voglio dire con questo che sto deliberatamente
riducendo il mio ambito di studio al concetto di stato di diritto nella versione inglese del
rule of law senza che ciò implichi eliminare altri concetti di stato di diritto che, come gli
studiosi di questa materia hanno da tempo sottolineato, corrispondono (almeno, vale a
dire senza pretese di esaustività, e senza oltrepassare le frontiere della tradizione
giuridico-politica occidentale) al modello tedesco, al modello francese e al modello
statunitense.
La mia riduzione si giustifica facilmente, per due ragioni, una contestuale, una storico-
concettuale.
1.1.1. La contestuale è che se imputo a Hart l’uso di un concetto di stato di diritto, e che
se per di più ammetto che lo faccia in modo incosciente, credo che sia inevitabile
imputargli l’uso di un concetto che gli è familiare. Un concetto, per così dire, che
costituisce per lui una forma di vita, in senso wittgensteiniano, che in un certo senso
rende intelligibili tutte le sue affermazioni «coscienti».
1.1.2. La concettuale è che il concetto inglese tende ad essere quello che meglio riflette
la forma in cui si oppone ad altri concetti, come il concetto di stato d’eccezione. In altre
parole, il concetto di rule of law ha un potere esplicativo, ovviamente secondo la mia
modesta opinione, estremamente grande. Ciò, a sua volta per due ragioni, che danno alla
mia preferenza una dimensione storica: da un lato è un concetto relativamente thin,
facilmente esportabile attraverso il tempo; dall’atro, è un concetto che tende ad essere
8
12 Hart lo cita solo due volte, la prima delle quali a proposito della distinzione tra convenzioni e regole giuridiche in senso stretto: "English constitutional writers since Dicey have usually repeated the statement that the constitutional arrangements of the United Kingdom consist partly of laws strictly so called (statutes, orders in council, and rules embodied in precedents) and partly of conventions which are mere usages, understandings, or customs" (CL, 111).
internazionalizzato in virtù dell’influenza del modello inglese nella costruzione, per
esempio, delle giurisdizioni internazionali, e anche in virtù della sua ovvia presenza nei
grandi stati, come India o Sudafrica, che furono colonie britanniche e le cui Corti
supreme sono protagoniste assolute, nel bene o nel male poco importa, del nostro
secolo.
Per non dare che un esempio: il modello tedesco e il francese tendono a dare molta
importanza ai concetti di legalità e legge, essendo la prima la conformità alla seconda.
Quando il Tribunale penale ad hoc per la ex-Yugoslavia si domandò se era (lo stesso
tribunale) «istituito per legge», come lo esigono i vari strumenti internazionali di
protezione dei diritti umani, interpretò «legge» come «norma giuridica», salto
semantico che gli permise di affermare che la sua creazione mediante una Risoluzione
del Consiglio di Sicurezza della ONU, soddisfaceva perfettamente il requisito «per
legge». Quando lo stesso Tribunale dovette rispondere alla domanda relativa alla
legalità di certe incriminazioni, interpretò legalità come «accessibilità» e
«prevedibilità», citando la Corte europea dei diritti umani.
Ovviamente entrambe le ragioni possono essere criticate o addirittura distrutte. Ciò non
avrebbe tuttavia alcuna conseguenza nella costruzione del mio argomento, perché si
tratta comunque di una stipulazione, e le ragioni che adduco servono solo per capire
perché non penso che si tratti di una stipulazione arbitraria.
2.2. La seconda osservazione è più complessa e per il momento offrirò solo uno spunto
puramente bibliografico. Tra le critiche anti-positiviste è di indubbia rilevanza quella di
Waldron. In un testo in particolare, il cui titolo è in se stesso un argomento (The
Concept and the Rule of Law13), che non è diretto specificatamente a Hart, risulta di
estremo interesse l’intuizione dell’autore. Il concetto di rule of law, se si eliminano tutti
gli elementi tipici delle concezioni thick (democrazia, protezione dei diritti umani, etc.),
può essere pensato come un concetto «robusto» di diritto.
Alberto Puppo, DOSD, Primo Draft, 29 giugno 2013. Per favore, non citare.
9
13 Waldron, 2009.
Tale circostanza bibliografica è molto più di una coincidenza perché permette di
distinguere tre (forse quattro) questioni, che nel caso di Hart rappresentano lo spunto
per altrettanti difetti (ovviamente dal punto di vista dei suoi detrattori), e ai quali
dedicherò le prossime pagine:
1) il suo concetto di diritto è troppo leggero, troppo «casuale», descrive troppe cose e
quindi non serve;
2) il suo concetto di diritto è troppo esigente, soprattutto quando tra i suoi elementi
definitori si introduce l’adozione del punto di vista interno da parte dei giudici, e quindi
non spiega troppe cose, ovvero molti fenomeni giuridici, caratterizzati, per esempio,
dall’assenza (tra i giudici) di una convenzione sociale o di una pratica sociale (non ha
senso in questo contesto entrare nella controversia sulla natura della regola di
riconoscimento) che permette di identificare le norme valide che appartengono a un
sistema;
3) il suo concetto non presenta il difetto segnalato in (2), perché di fatto non è affatto
una pratica o convenzione sociale che permette l’emergenza della regola di
riconoscimento. Si tratta bensì dell’adozione di un compromesso morale (l’adozione del
punto di vista interno) senza il quale è impossibile identificare il diritto. La sua teoria è
buona, ma ovviamente, deve accettare la connessione concettuale tra diritto e morale o,
almeno, solo ha senso se si suppone un fine, un proposito, verso il quale tende il diritto
(se vuole essere chiamato diritto). Detto in altri termini, la concezione positivista di
Kelsen, Ross, Bobbio e probabilmente Hart, secondo la quale il diritto è un meccanismo
neutrale per amministrare l’uso della violenza (versione marxista) o della forza legittima
(versione liberale), cede inesorabilmente di fronte alla constatazione che il diritto
solamente si può identificare (e forse esistere) se si attribuiscono certe ragioni a coloro
che vi partecipano e certi fini al diritto stesso14.
Legata alla precedente si può menzionare un'ulteriore questione:
10
14 Rimando anche alla lettura critica fatta da Waldron, 2011, 896 ss., della teoria di Shapiro, che culmina con la tesi secondo la quale i «piani» di cui parla Shapiro sono necessariamente «piani di un certo tipo» ovvero piani con una certa finalità.
4) il suo concetto di diritto si basa sul concetto di accettazione, su un particolare
atteggiamento che almeno i giudici devono adottare (condizione necessaria per
l’esistenza di un sistema giuridico). Vari autori hanno segnalato frequenti oscillazioni,
nel pensiero o almeno nel vocabolario di Hart, che rendono l’accettazione un fenomeno
impalpabile. Shiner (1992, 160 ss.) o Finnis (2008, p. 20) hanno rilevato che quando
Hart parla di accettazione si riferisce, talvolta a qualcosa molto simile alla mera
obbedienza o acquiescenza passiva, talaltra a un atteggiamento molto più attivo, con un
chiaro componente intenzionale. Data la centralità del concetto di accettazione, tale
incostanza ovviamente tende a distruggere l’intelligibilità della teoria di Hart.
Ovviamente questo difetto è strettamente legato al precedente, per la seguente ragione:
coloro che attribuiscono al punto di vista interno un carattere morale insistono sul fatto
che l’accettazione in senso forte, ovvero l’accettazione, per così dire, intenzionale, non
può non basarsi su ragioni morali o, detto in forma più diretta, che il punto di vista
interno è un punto di vista morale.
Ebbene, la distinzione (in generale, e in particolare quella, assente, nel libro di Hart) tra
diritto e stato di diritto, permette di dissolvere o per lo meno togliere un po’ di gravità,
ai suddetti problemi. La conseguenza della risoluzione di tali problemi ne crea forse uno
molto più grave, al quale ho implicitamente fatto riferimento: Hart non propone nessuna
teoria descrittiva particolarmente nuova sul diritto. Detto altrimenti, le critiche (o alcune
di esse) non colgono nel segno, non per non essere pertinenti, ma semplicemente perché
al posto del bersaglio – un certo concetto sofisticato di diritto – c’è un vuoto, riempito
da un altro concetto, quello di stato di diritto15.
2. Il positivismo casuale: una teoria descrittiva ma poco utile
Che il concetto di diritto elaborato da Hart sia «casuale» o almeno «abbastanza
rilassato», lo ha sostenuto per esempio Waldron16. Ovviamente non è una critica che si
Alberto Puppo, DOSD, Primo Draft, 29 giugno 2013. Per favore, non citare.
11
15 Non è superfluo ricordare che l’assenza del bersaglio non rende le critiche pertinenti.
16 E' lo stesso autore che parla di positivismo casuale per designare la linea che da Bentaham e Austin passa per Hart e continua con i seguaci di quest'ultimo (Waldron, 2009, 14 ss. e specialmente 42)
debba a un particolare autore, è in ultima analisi una critica a una certa concezione
positivista del diritto. La difesa di un concetto di diritto casuale può essere attribuita ad
Hart in generale, per tutto ciò che ha scritto, e in particolare, credo, nel contesto dello
scambio con Fuller. Voglio dire che non è necessariamente casuale la visione che si può
ricavare da una (tra le molte possibili) letture di The Concept of Law. Il fatto stesso che
da questa opera di Hart, e dal famoso Postcript, molti abbiano concluso che Hart fu il
padre del positivismo inclusivo, potrebbe costituire una ragione per dubitare del
carattere eccessivamente rilassato della sua proposta.
Tuttavia è importante ricordare quanto segnalato sopra, ovvero il sospetto che quando
dipinge un quadro «esigente» lo fa avendo in mente come, di fatto, funziona il diritto
costituzionale inglese.
Quando invece parla del diritto nazista, e non esita a consideralo «diritto», ovviamente
sta adottando un visione classica e radicale della tesi delle fonti sociali. Il diritto nazista,
indipendentemente da qualsiasi considerazione che possa sembrare pertinente (di
moralità, o di moralità interna17, alla Fuller), era diritto, perché esisteva come fenomeno
sociale. Il noto argomento di Hart è che se e solamente se si identifica qualcosa come
diritto indipendentemente dal suo valore morale, si può criticarlo alla luce di un criterio
morale. Tutto ciò si può riformulare dicendo che il diritto nazista è ben lontano dal
soddisfare le esigenze di uno stato di diritto, e potremmo criticarlo per questo, ma ciò
non toglie che meriti di essere considerato come qualsiasi altro diritto. Anticipando
12
17 Bisogna sottolineare, en passant, che il tema della moralità interna di Fuller, è diventato quasi un paradigma per coloro che difendono una concezione formal-istituzional-procedurale del rule of law. Ciò che molti autori non seguono della prospettiva di Fuller è la tesi sulla natura necessariamente morale delle caratteristiche che egli definisce e etichetta come "principi della legalità". Detto altrimenti: se la concezione di Fuller è un paradigma per quanto riguarda le caratteristiche che deve avere un diritto per essere uno stato di diritto (o un sistema giuridico, se ci atteniamo alle parole di Fuller), lo stesso non si può dire della sua identificazione tra le suddette caratteristiche e valori necessariamente morali. Ciò implica che si può essere, in un senso, fulleriani, senza rinunciare alla tesi positivista della separazione tra diritto e morale, o perché si concede che lo stato di diritto abbia una natura morale ma si segue affermando la chiara distinzione concettuale tra diritto e stato di diritto (che probabilmente è il caso di MacCormick), o perché si sostiene che lo stato di diritto, sebbene condizioni il diritto, non ha una natura necessariamente morale (che probabilmente, secondo la mia ricostruzione è il caso di Hart).
qualcosa, dirò che tale affermazione, contrariamente alle apparenze, non implica
necessariamente che il concetto di stato di diritto sia di natura morale.
Una teoria che definisca il concetto di diritto in modo casuale ha sicuramente il
vantaggio di poter spiegare molti fenomeni che difficilmente potrebbero essere
considerati come non giuridici. In nessun caso tale spiegazione implica una valutazione
positiva di tali fenomeni. Potremmo dire che si tratta del grande vantaggio teorico del
positivismo: non squalificare certi fenomeni che dal punto di vista socio-politico sono
ovvie manifestazioni giuridiche, ancorché insopportabili dal punto di vista morale,
ovvero orfane di quella virtù che Raz chiama rule of law.
La mia ipotesi, riguardo questo primo punto è che, sebbene sia aperta la questione di
quale sia la concezione sviluppata e difesa da Hart in The Concept of Law, esistono
buoni argomenti per pensare che Hart abbia tendenzialmente difeso una visione
positivista metodologica, distinguendo chiaramente il diritto che è (il diritto nazista per
esempio) dal diritto come deve essere (il rule of law, secondo certe concezioni). Quello
che bisogna domandarsi è se è plausibile attribuire ad Hart un concetto di rule of law
senza che ciò comprometta il suo positivismo metodologico.
3. Plausibilità empirica del positivismo convenzionalista e tradizione giuridica
britannica
Il secondo problema è, in generale, il problema del convenzionalismo. Come ho
premesso, non è necessario entrare nei meandri del dibattito sul convenzionalismo,
esterno o interno, vale a dire, sulla plausibilità della tesi convenzionalista, o accettata la
plausibilità, sulla natura della convenzione che starebbe alla base di ogni sistema
giuridico. Non entrerò neanche nella difficile questione esegetica sulla qualificazione
della regola di riconoscimento di Hart: non importa se si tratta di una convenzione o di
una regola sociale non meglio definita, o di una semplice pratica sociale. Ciò che non si
può negare è che Hart parla chiaramente di una pratica sociale, o di una consuetudine
Alberto Puppo, DOSD, Primo Draft, 29 giugno 2013. Per favore, non citare.
13
giudiziaria, di alcuni soggetti che partecipano nella pratica e così facendo generano una
consuetudine.
Ovviamente, dipendendo da come si caratterizzi la regola di riconoscimento, la proposta
di Hart sarà considerata più o meno stimolante dal punto di vista teorico e/o
empiricamente plausibile. Sia come sia, credo che la proposta del giurista inglese sia
idonea per descrivere sicuramente un diritto (sofisticato, in forma sofisticata), quello
inglese, ma non ogni diritto.
3.1. Che cosa (e come) spiega la teoria sofisticata di Hart?
Come ho suggerito, la teoria di Hart descrive (sicuramente) un diritto ma non ogni
diritto. Dove non si constata tale pratica sociale, diretta dagli alti funzionari ma resa
possibile da tutti i cittadini (che devono almeno obbedire come pecore alle
identificazioni del diritto proporzionate dai giudici, i quali «accettano» la regola di
riconoscimento come modello che tutti, almeno i giudici, devono, e sottolineo
"devono", seguire), Hart dice che non si è di fronte a un sistema giuridico o a un sistema
giuridico sano, sebbene si tratti sempre di diritto: si assiste a una patologia. Si potrebbe
pensare che la sua teoria descriva non solo i diritti sani ma anche i diritti patologici.
Credo che sia presto per valutare tale affermazione, ma non sarà di troppo ricordare che
un acuto lettore come Finnis (2008, 18) ha sottolineato che la teoria della regola di
riconoscimento non è molto illuminante per capire fenomeni come colpi di stato o
rivoluzioni, situazioni in cui è in gioco la continuità del diritto (tema che, se prendiamo
sul serio la critica a Austin, era molto importante per Hart) e non solamente la validità
sistemica delle norme.
Per proseguire con più chiarezza è consigliabile distinguere e formulare varie domande.
a) Hart sostiene che tutti i diritti si caratterizzano per avere una regola di riconoscimento
accettata, etc.? La sua risposta, descrittiva, è «ovviamente no».
14
b) Hart sostiene che alcuni diritti si caratterizzano per avere tale struttura? La risposta è:
probabilmente si, possiamo pensare che almeno (anche se non esclusivamente) il diritto
inglese presenta tale struttura.
c) In che cosa si distingue il diritto inglese da altri diritti, e in particolare dai diritti «non
patologici», ovvero che presentano chiaramente una struttura di norme primarie e
secondarie, una regola di riconoscimento etc.? Tale domanda è complessa e
all'elaborazione di una risposta dedicherò la prossima sezione.
E' necessario formulare un'ultima domanda la cui risposta lascerò per la parte finale, ma
della quale dovrò anticipare, già da ora, qualcosa:
d) Hart sostiene che un diritto che presenta le caratteristiche che definisce a partire
dall’esempio inglese è migliore, più sano, degli altri? Ovvero che un diritto che è anche
un rule of law è da preferire ad un diritto che non lo è?
Questa domanda potrebbe essere riformulata in termini che piacerebbero a Hart: una
teoria del diritto che offre un'adeguata descrizione di un diritto che è anche un rule of
law è migliore di una teoria che non coglie i tratti salienti del rule of law? Se questa
fosse la domanda, ovviamente la risposta sarebbe banale se si compara per esempio
l’imperativismo austiniano con la teoria di Hart. Hart pensa sicuramente che la teoria di
Austin sia insufficiente, e che la sua sia migliore. Tuttavia questa risposta banale non
deve trarre in inganno. La risposta è banale se e solo se la teoria di Austin e quella di
Hart sono rivali. Ma sospetto che Austin non abbia per nulla avuto l’intenzione di
spiegare un fenomeno centrale per Hart: il diritto costituzionale. Relegandolo alla
morale positiva, Austin si è limitato a dire che la teoria del diritto non ha nulla da dire a
riguardo. Nella misura in cui prendiamo sul serio il positivismo soft, ovvero nella
misura in cui accettiamo che la morale positiva sia (possa essere) incorporata nella
regola di riconoscimento, e che la regola di riconoscimento tenda, empiricamente, a
coincidere con, o essere la combinazione di, regole che i costituzionalisti
considererebbero sicuramente parte della loro disciplina, si potrebbe considerare che
l’unico disaccordo teorico tra Hart e Austin (se trascuriamo il disaccordo sulla natura
Alberto Puppo, DOSD, Primo Draft, 29 giugno 2013. Per favore, non citare.
15
delle regole) è molto simile a quello che esiste tra un positivista inclusivo e uno
esclusivo. Per il primo la morale positiva può, attraverso la regola di riconoscimento,
entrare a far parte del sistema giuridico, per il secondo, anche se i giudici possono
applicarla, la morale positiva rimane fuori dal sistema.
Questa lunga digressione non è fine a se stessa. Se è plausibile, permette di sospettare
quello che ho annunciato sin dall’inizio, vale a dire che Hart si distingue da Autin, non
tanto per proporre una determinata teoria del diritto, ma soprattutto per voler spiegare
fenomeni che Austin deliberatamente ha lasciato fuori dalla sua impresa teorica. Per
spiegare come funziona un sistema giuridico con le caratteristiche che gli attribuisce
Hart, abbiamo bisogno di una teoria del rule of law.
3.2. La specificità del diritto inglese (e forse della teoria hartiana)
Tornando alla terza domanda relativa a ciò che distingue il diritto inglese dagli altri
diritti, soprattutto da quelli non patologici, la risposta mi sembra che debba essere la
seguente: si distingue per due cose, per essere un chiaro esempio di rule of law (3.2.1.) e
per avere una costituzione consuetudinaria (3.2.2.)18. La prima risposta va al di là di una
mera questione empirica, dipende ovviamente da come si definisca il concetto di rule of
law, e perciò avrà bisogno di una chiara, anche se breve, giustificazione. La seconda,
anche se dipende da come si concepiscano i concetti di costituzione e consuetudine,
credo che non abbia bisogno di una particolare giustificazione: potremmo quasi pensare
che si tratti di un luogo comune, che nessun costituzionalista contesterebbe e che ha
pertanto solo bisogno di essere sviluppata.
3.2.1. Che il diritto inglese sia un chiaro esempio di rule of law può giustificarsi
analiticamente o sinteticamente.
16
18 Ovviamente non ignoro che il diritto inglese di oggi non è quello di Bentham, né quello di Dicey e neanche quello di Hart, giacché l'integrazione europea (con l'applicazione diretta del diritto comunitario), da un lato, e la protezione sovranazionale dei diritti umani, ha fatto si che il diritto inglese abbia perso parte della sua specificità. Nonostante ciò, credo che dietro al funzionamento superficiale delle istituzioni certi elementi distintivi permangano.
Se ci domandiamo dove nasce il concetto di rule of law, la risposta è: in Inghilterra,
grazie all’elaborazione concettuale di Dicey. Ciò significa che per definizione il diritto
inglese è un caso di rule of law. Se supponessimo che così non fosse, vale a dire che
Dicey, per esempio, avesse elaborato il suo concetto di rule of law a partire
dall’osservazione del diritto francese, potremmo comunque pensare che le
caratteristiche che Dicey identifica come definitorie del rule of law si riscontrano nel
diritto inglese. Ovviamente tale affermazione può essere criticata per essere
empiricamente falsa. Credo che non lo sia ma non mi impegno a difendere tale risposta.
Si può spendere qualche parola invece per analizzare una questione più precisa, centrale
nella seconda risposta.
3.2.2. Che relazione esiste tra il carattere consuetudinario della Costituzione, il concetto
di rule of law e la regola di riconoscimento?
Questo tipo di analisi, se ha successo, mi permetterà di argomentare a favore di due tesi
che sostengo: che Hart abbia costruito il suo concetto robusto di diritto (rule of law) a
partire dalla realtà britannica, la stessa che ha descritto Dicey, ma vari decenni dopo;
che il suo concetto robusto di diritto sia, come in Dicey, un concetto di rule of law.
In questa fase lascio deliberatamente senza risposta la questione relativa al carattere
eventualmente normativo del discorso hartiano. Anzi, presuppongo che si possa
comunque offrire un'interpretazione, per difetto, non normativa, fermo restando che, in
altra sede, la metterò a prova.
Mi concentrerò su due affermazioni di Hart, una relativa a Dicey (3.2.2.2), l’altra
relativa a Kelsen (3.2.2.1.), che mi daranno lo spunto per sostenere, col seguente ordine:
a) che in alcune occasioni, almeno, quello che dice Hart si può solo capire, e approvare
eventualmente, se si riferisce alla realtà britannica;
b) che la caratterizzazione della regola di riconoscimento che offre Hart presenta solide
similitudini con le convenzioni costituzionali così come presentate da Dicey;
Alberto Puppo, DOSD, Primo Draft, 29 giugno 2013. Per favore, non citare.
17
c) che la funzione che espletano le regole secondarie sono analoghe a quelle che espleta
il rule of law, se non nella versione di Dicey, almeno nelle versioni conosciute come
istituzionali e/o procedurali (ovvero né puramente formali, né chiaramente sostanziali);
3.2.2.1. L’affermazione di Hart relativa a Kelsen che voglio sottolineare è quella in cui
Hart critica la norma fondamentale di Kelsen dicendo che tale norma, il cui contenuto
sarebbe il dovere, per i giudici in particolare, di obbedire alla Costituzione, è un inutile
duplicato19. L’argomento di Hart, che senza sorpresa non può evitare di fondarsi sulla
realtà inglese, è che non ha senso obbligare a fare ciò che già si sta facendo. Questa
affermazione solo ha senso se si sta implicitamente facendo riferimento a una
costituzione consuetudinaria, una costituzione che esiste se e solo se è realmente
praticata, ovvero applicata. Il diritto britannico ha una costituzione, in senso materiale,
se e solo se gli alti funzionari e in particolare i giudici, sviluppano una pratica sociale
che genera quella che Hart chiamerà nel Postcript una consuetudine giudiziale, in ultima
analisi la regola di riconoscimento. Nel caso britannico, in effetti, non avrebbe nessun
senso esigere, dal punto di vista teorico – vale a dire con una finalità esplicativa – una
norma che obblighi a rispettare una regola che esiste se e solo se i suoi destinatari la
rispettano (già). Al contrario sarebbe perfettamente sensato immaginare una tale norma
fondamentale nel caso di una Costituzione scritta che potrebbe, come direbbero i
realisti, essere solo un testo, un pezzo di carta senza nessuna vigenza. Potremmo
addirittura andare più lontano: senza una tale norma saremmo completamente disarmati
di fronte alle patologie che consistono nell'eccessiva indeterminazione della regola di
riconoscimento.
3.2.2.2. Per quanto riguarda le convenzioni costituzionali di Dicey, voglio sottolineare
due cose: la prima è che Dicey è drammaticamente assente nel libro di Hart, che gli
18
19 "It seems a needless reduplication to suggest that there is a further rule to the effect that the constitution (or those who 'laid it down') are to be obeyed. This is particularly clear where, as in the United Kingdom, there is no written constitution: here there seems no place for the rule 'that the constitution is to be obeyed' in addition to the rule that certain criteria of validity (e.g. enactment by the Queen in Parliament) are to be used in identifying the law. This is the accepted rule and it is mystifying to speak of a rule that this rule be obeyed" (CL, 293, nota alla p. 100).
dedica qualche linea, nulla più. Lo cita ricordando l’idea di Dicey secondo la quale nel
diritto inglese non solo ci sono Statutes, diritto in senso stretto, ma anche convenzioni.
Hart ricorda che per Dicey le convenzioni non sono vincolanti e quindi la regola di
riconoscimento non può essere ridotta a una convenzione nel senso di Dicey. Senza
dover approfondire troppo, devo ricordare che la posizione di Dicey è tutt’altro che
chiara su questo punto o, almeno, quello che ricostruisce l'autore a proposito della
tradizione costituzionale inglese, è tutt'altro che chiaro. Voglio dire con questo che non
mi interessa sapere quello che pensava Dicey, ma solo sottolineare che nel suo libro si
offre una visione delle convenzioni costituzionali tutt'altro che monolitica, il che
permette di considerare le due linee che le dedica Hart alquanto insufficienti per scartare
la rilevanza del tema.
Eccezionalmente mi permetto di citare un passaggio a mio avviso illuminante:
Still the conventional rules of the constitution, though not laws, are, as it is
constantly asserted, nearly if not quite as binding as laws. They are, or appear to
be, respected quite as much as most statutory enactments, and more than many.
The puzzle is to see what is the force which habitually compels obedience to rules
which have not behind them the coercive power of the Courts20.
Tentando di essere sintetico, mi limiterò ai seguenti brevi commenti: i) in primo luogo
le regole convenzionali della costituzione sono contrapposte alle leggi, laws, che al
plurale designano non il diritto ma le norme scritte, gli statutes. Le convenzioni della
costituzione sono regole, ma non sono leggi. ii) Tali regole sono vincolanti (quasi, se
non completamente) come le leggi. iii) Tali regole sono osservate come lo sono le leggi,
se non di più. iv) Il puzzle, la questione rilevante, è vedere come è possibile che tali
regole siano vincolanti, abbiano forza obbligatoria, senza essere garantite dal potere
coercitivo dei Tribunali. Sebbene questo punto non sia esplicito nel passaggio citato,
bisogna ricordare che per Dicey il diritto in senso stretto, gli Statutes sono obbligatori
Alberto Puppo, DOSD, Primo Draft, 29 giugno 2013. Per favore, non citare.
19
20 Dicey, 1915, 436.
nella misura in cui sono applicati dai Tribunali; è questa, direi, una visione realista; gli
statutes come diritto di carta, solo sono diritto vigente se effettivamente applicati dai
tribunali. Al contrario, le convenzioni sono di fatto vincolanti a prescindere da un
enforcement da parte dei tribunali. Se Hart riformulasse questa idea di Dicey,
utilizzerebbe la critica alla teoria realista. Nella misura in cui sono i giudici (e gli alti
funzionari) che con la loro pratica generano la regola di riconoscimento, non avrebbe
nessun senso affermare che la regola di riconoscimento sia vincolante se e solo se
applicata con un sentimento di obbligatorietà dai tribunali. La regola di riconoscimento
esiste se e solo se applicata dai tribunali, ma se esiste è per ciò stesso obbligatoria. Un
individuo, nella prospettiva realista può fare previsioni su come decideranno i giudici,
in particolare se applicheranno o no una certa legge per esempio. Ma il giudice stesso
non fa previsioni su come lui stesso si comporterà: l'elemento psicologico tipico del
concetto di diritto vigente di Ross è completamente fuori luogo.
Citando un altro passaggio che segue quello appena citato potrò stendere un ponte che
unisce Austin a Hart, e concludere su questo punto.
If a habit or precept which can be set at nought is thereby shown not to be a
portion of constitutional morality, it naturally follows that no true constitutional
rule is ever disobeyed.21
Qui il vocabolario è chiaramente austiniano. Le regole convenzionali della costituzione
di fatto riflettono la moralità costituzionale; dico riflettono perché, secondo me, tutto ciò
che dice Dicey a proposito della moralità costituzionale si riferisce a valori, non a
regole. Ma si potrebbe anche accettare che le convenzioni della costituzione siano di
fatto parte della moralità costituzionale. Che cosa mostra questo passaggio?
Mostra probabilmente che tra la moralità convenzionale, le convenzioni costituzionali e
la regola di riconoscimento l'unica differenza è il modo in cui si definisce il concetto di
20
21 Dicey, 1915, 437.
diritto. Che cosa voglio mostrare? Tutto ciò potrebbe significare che non ha per esempio
senso dire, come fa Austin, che le convenzioni costituzionali non sono diritto se questo
dipende dal suo concetto di diritto. Così come non ha senso dire che la regola di
riconoscimento è diritto perché è funzionale e relazionata alle regole chiaramente
giuridiche, come sembra affermare Hart.
Laddove invece non si sia vittima di una teoria generale, che obbliga a distorcere la
realtà, si può tranquillamente constatare che esiste, da un lato, una chiara relazione, per
quanto riguarda i contenuti normativi, tra la moralità dominante tra gli alti funzionari –
e tra gli organi costituzionali – e la costituzione in senso materiale ovvero la regola di
riconoscimento; dall'altro lato, è plausibile affermare, come fanno forse Dicey e Hart,
che la regola di riconoscimento non si possa violare, che nessuna regola costituzionale
possa essere violata. Di fatto, come qualsiasi regola sociale, può solo essere modificata.
A che cosa serve il concetto di rule of law in questo contesto? L'intuizione alla quale è
legato il concetto è l'esigenza di evitare la arbitrarietà. Se accettiamo che gli alti
funzionari possono con le loro condotte modificare la regola di riconoscimento, che
cosa ci garantisce che tali cambi non siano incessanti e che quindi minaccino la certezza
giuridica alla quale secondo Hart è orientata la regola di riconoscimento22? Che cosa ci
garantisce che la regola di riconoscimento non si trasformi in una regola completamente
indeterminata – situazione che corrisponde per il giurista inglese a una chiara patologia
del sistema giuridico? Che cosa ci garantisce che non si arrivi a una situazione di totale
arbitrarietà – cosa che per Hart costituirebbe un incubo?
Alberto Puppo, DOSD, Primo Draft, 29 giugno 2013. Per favore, non citare.
21
22 Credo che su questo punto non vi siano disaccordi. Al di là della presentazione classica della regola di riconoscimento, è interessante ricordare che nel capitolo dedicato al diritto internazionale, Hart afferma chiaramente che una tra le funzioni tipiche del diritto è introdurre quegli elementi che massimizzano la certezza e la prevedibilità (CL, 229). Questi due valori sono centrali nelle concezioni formali del rule of law (Raz per esempio) così come nella moralità interna di Fuller. Bisogna anche sottolineare che ritornando su tali valori nel Postscript, Hart insiste sul fatto che non sono solamente importanti dal punto di vista della repressione penale: "it is equally crucial for the intelligent exercise of legal powers (e.g. to make wills or contracts) and generally for the intelligent planning of private and public life" (CL, 250). Mi pare difficile non saltare con il pensiero fino a toccare la proposta teorica di Shapiro, che come ho già anticipato, presenta molte delle caratteristiche della teoria hartiana dalla quale si differenzia per essere molto più sofisticata e chiaramente formulata.
La risposta è: il rule of law, inteso come esigenza di non arbitrarietà, esigenza di
giustificazione; in ultima analisi: esigenza di giustificare le decisioni giudiziali23. Il rule
of law, se torniamo a Hart, è ciò che garantisce che la ovvia discrezionalità della quale
fanno uso gli alti funzionari non si trasformi in arbitrarietà. Nella visione
tradizionalmente inglese è ovviamente il diritto consuetudinario che incapsula e limita
la discrezionalità. La distinzione tra moralità positiva, diritto consuetudinario e diritto
naturale non è molto chiara (per esempio le due ultime nozioni tendono a coincidere in
Blackstone). La vera domanda forse è: perché Hart ha cercato una spiegazione
complicata, poco chiara e sicuramente criticabile, a partire dalla nozione di punto di
vista interno, di accettazione eccetera? Perché, si è sostenuto, aveva una naturale
avversione contro il diritto consuetudinario, come Bentham, nella misura in cui
quest'ultimo esprimeva una morale tipicamente conservatrice24.
Prima di passare al terzo e al quarto problema bisogna ricapitolare.
Se distinguiamo chiaramente tra diritto e rule of law, possiamo sostenere:
1) che Hart difende un concetto di diritto minimalista, come insieme di regole primarie,
che si distingue da altri per come caratterizza le regole. Una concezione esigente delle
regole dentro una concezione minimalista del diritto. È un concetto utile perché
permette un passo avanti rilevante per cogliere la natura sociale del diritto. Potremmo
dire che l’originalità di Hart dipende dall’introduzione nella teoria del diritto di una
certa concezione wittgensteiniana del rule-following, come distinto dal semplice e
austiniano (secondo Hart per lo meno) obbedire a degli ordini.
2) che Hart difende un concetto di diritto esigente, robusto, che può chiamarsi concetto
di sistema giuridico o concetto di rule of law. Che quelli di diritto e di sistema giuridico
22
23 E' degno di nota ricordare che in un testo recente Waldron (2012) ha analizzato la relazione tra la regola del precedente e il Rule of Law, sostenendo in particolare che contrariamente a ciò che alcuni potrebbero pensare la regola dello stare decisis non è affatto un problema per lo stato di diritto e che al contrario è una forma di realizzazione dei valori dello stato di diritto, nella misura in cui si esige, affinché una decisione possa essere considerata un precedente, e quindi vincolante, che la stessa decisione sia solidamente giustificata, resa in un contesto in cui esistono forti aspettative, e idonea non solo a soddisfarle ma anche a consolidarle o a crearne di nuove.
24 Per approfondire questo aspetto, rimando a Horwitz, 2008.
non siano concetti coestensivi dovrebbe essere chiarissimo per qualsiasi lettore attento
di Hart, giacché gli elementi testuali di distinzione neutralizzano le purtroppo numerose
volte in cui Hart utilizza diritto e sistema giuridico come sinonimi. Ciò che può essere
messo in dubbio è che il concetto di sistema giuridico e quello di rule of law siano
coestensivi o per lo meno presentino un'analogia maggiore rispetto a quella che
caratterizza la relazione tra il concetto di diritto e il concetto di sistema giuridico. In
altre parole, se condividiamo una visione convenzionale del linguaggio, non esiste
ovviamente nessuna ragione metafisica per chiamare un fenomeno con un certo nome;
tuttavia se pensiamo che eliminare confusioni possa essere una finalità valida, allora si
tratta di dimostrare che cosa si guadagna in termini di chiarezza. La chiarezza dipende
dalla possibilità di spiegare in termini semplici la ricchezza della proposta hartiana, e di
rispondere con gli stessi termini semplici alle due critiche menzionate.
Un concetto minimalista di diritto si spiega (si difende dalle critiche antipositiviste per
esempio) più facilmente se è accompagnato da un concetto, anche lui minimalista, di
stato di diritto. In questo modo gli strumenti concettuali di Hart permettono di
descrivere fenomeni semplici, primitivi o patologici come «diritto», e fenomeni
complessi, sviluppati e sani come «stato di diritto», senza la necessità di perdersi in
metafore biologiche, su diritti sani, sanissimi, patologici, in stato embrionale... ecc.
Il fatto che il concetto di stato di diritto che si può attribuire ad Hart sia minimalista mi
permette, infine, di passare alle altre questioni che tratterò insieme.
4. Sistemi giuridici sofisticati e neutralità morale del rule of law
Se si afferma che il concetto sofisticato elaborato da Hart è un concetto di rule of law,
rispondere alla terza critica significa dimostrare che il concetto di rule of law non
include tra la sue proprietà caratteristiche morali. Esistono due estremi nell’ambito delle
concezioni del rule of law. Una potrebbe essere la kelseniana visione secondo la quale
ogni stato è per definizione uno stato di diritto. Nel dibattito odierno si considererebbe
tuttavia che la prospettiva kelseniana si avvicina a quello che si designa con
Alberto Puppo, DOSD, Primo Draft, 29 giugno 2013. Per favore, non citare.
23
l’espressione rule by law. Il rule by law è compatibile con qualsiasi situazione, per
esempio il diritto nazista, visto che solo si richiede che le decisioni delle autorità siano
fondate su norme giuridiche. Per dirlo in termini grossolani, la commissione di un
genocidio o l’applicazione sistematicamente retroattiva del diritto penale, sono
perfettamente compatibile con il rule by law alla sola condizione che il genocidio, per
esempio, sia eseguito in virtù di una norma giuridica o che la retroattività della legge
penale sia previamente stabilita. Qualsiasi finalità o valore sottostante al diritto è quindi
semplicemente irrilevante. Una versione distinta ma ugualmente formale del rule of law
è quella di Raz, che considera il rule of law una virtù che può entrare in concorrenza
con altre virtù, che corrispondono ad altrettanti valori morali, per esempio la giustizia o
l’uguaglianza, che può sfoggiare, o no, un diritto.
All’altro estremo incontriamo le concezioni materiali o thick, che includono tra le
proprietà definitorie cose come il rispetto dei diritti fondamentali. In tal caso il rule of
law ha una connotazione chiaramente morale. Possiamo pensare a visioni più moderate,
come quella di Fuller che afferma che tutte le caratteristiche che definiscono i principi
della legalità costituiscono la moralità interna del diritto e hanno come fondamento
ultimo la dignità umana, o quella, ancora più minimalista, di Hayek, in cui il valore
ultimo che giustifica l’esigenza del rule of law, è la libertà individuale.
Tra i due estremi si possono inserire concezioni istituzionali, procedurali o
argomentative. Alcune, come quelle di Finnis o Waldron, tendono a giustificare
moralmente il diritto (o un concetto robusto di diritto), ma credo che si possano
proporre versioni moralmente neutrali.
Come Waldron sottolinea nelle prime pagine del testo già citato, la sua tesi è che "our
understanding of the Rule of Law should emphasize not just the value of settled,
determinate rules and the predictability that they make possible, but also the importance
of the procedural and argumentative aspects of legal practice"25.
24
25 Waldron, 2009, 4.
Per quello che ho detto sopra riguardo l'importanza della discrezionalità come antidoto
contro l'arbitrarietà, insisterò sull'aspetto argomentativo. L'idea è che anche quando non
c'è una sola risposta corretta, si può stabilire che una soluzione è migliore di un'altra, a
condizione che si diano certi presupposti. Se supponiamo tribunali relativamente
indipendenti e un diritto non completamente indeterminato, un diritto di accesso
all'informazione, una certa forma di trasparenza (ovvero la possibilità, per i sudditi, di
accettare le norme e non solo di obbedire come pecore), allora è evidente che nella
concezione di Hart26, così come in quella di Waldron, è fondamentale motivare gli atti
degli alti funzionari e in particolare dei tribunali. Se motiviamo sistematicamente le
decisioni, sarà più facile scoprire decisioni arbitrarie. Se si accetta il carattere
inevitabile della discrezionalità, allora si farà ugualmente sentire il peso dell'obbligo di
motivazione27. Questo perché, se i tribunali sanno che tutti sanno che esercitano una
certa libertà, per non perderla faranno gli adeguati sforzi affinché l'uso di suddetta
libertà mai appaia come un abuso, e quindi come arbitrarietà (e non come
discrezionalità). Questo meccanismo sembra molto simile al tipico meccanismo
convenzionale, un meccanismo che ha il vantaggio di includere non solo i giudici ma
anche i destinatari delle loro decisioni. Ovviamente, tale convenzione non sarebbe mai
una condizione necessaria per poter parlare di diritto, ma solo per poter parlare di un
sistema giuridico sofisticato e in buona salute (o, come direbbe Finnis28, in buono stato),
ovvero di un rule of law.
Tutto ciò neanche significa che si stia introducendo un elemento morale. Qualcuno,
come Fuller, potrebbe pensare che questa forma di rispettare i sudditi si basi su una
qualche intuizione morale sulla dignità umana; altri, come Finnis, penseranno che ciò
presupponga un'idea di bene comune, etc. Tuttavia, credo che si può rispolverare la
Alberto Puppo, DOSD, Primo Draft, 29 giugno 2013. Per favore, non citare.
25
26 CL, 253, dove si riferisce esplicitamente alla possibilità, nel contesto della discrezionalità, che si possano difendere certe proposizioni giuridiche con argomenti migliori di altri.
27 CL, 272-273.
28 "The name commonly given to the state of affairs in which a legal system is legally in good shape is ‘the Rule of Law’" (Finnis, 1980, 270).
tipica risposta di Hart: è possibile, ma non necessario. E' sicuramente meglio se gli alti
funzionari hanno un genuino rispetto, moralmente giustificato, verso i sudditi, ma non si
può escludere che tale convenzione, chiamiamola la convenzione della discrezionalità
motivata, sorga e si mantenga per ragioni puramente strategiche. I giudici sanno che
solo così possono mantenere i loro privilegi, i sudditi sanno che solo così possono
mantenere, a lungo termine, un buon grado di prevedibilità per organizzare e finalizzare
i loro "piani" individuali. Nell'ultima pagina del Postscript29 Hart sembra fare
riferimento a tale convenzione quando parla delle "aspettative giustificate" di coloro che
agiscono prendendo in considerazione le prevedibili conseguenze legali dei loro atti.
Tale convenzione ovviamente è messa alla prova nei casi difficili, nei quali è probabile
che si tradiscano aspettative legittime. Tuttavia, aggiungerei, e credo che Hart sarebbe
d'accordo, solamente se si accetta che il dovere di motivare sarà ancora più intenso nei
casi difficili, non è da escludere che una buona motivazione possa generare aspettative
anche nei casi difficili, che cesserebbero probabilmente, poco a poco, di essere
difficili30.
Il diritto è un'attività pianificatrice nella misura in cui, per esempio, il diritto nazista ha
pianificato lo sterminio di popoli interi. Lo stato di diritto, come lo ha sottolineato
Waldron in una sezione critica della sua rassegna su Legality, non sorprendentemente
intitolata Rule of Law, è un'attività pianificatrice di un certo tipo, che si distingue da
quella manageriale o da quella criminale31. Si distingue, probabilmente perché l'autorità
pianificatrice si legittima attraverso la produzione di buoni argomenti e alla pubblicità
degli stessi.
26
29 CL, 276.
30 Cfr. quanto afferma Hart il relazione ai doveri del giudice: "he must not do this arbitrarily: that is he must always have some general reasons justifying his decision and he must act as a conscientious legislator would by deciding according to his own beliefs and values. But if he satisfies these conditions he is entitled to follow standards or reasons for decision whichare not dictated by the law and may differ from those followed by other j udges faced with similar hard cases" (CL, 273; nello stesso senso, cfr. anche 116). Quanto appena detto sembra essere il nucleo della concezione del precedente di Waldron, 2012, non a caso relazionata con il concetto di rule of law.
31 Waldron, 2011, 899.
La discrezionalità motivata è secondo me centrale nell'opera di Hart anche perché
potrebbe perfettamente rappresentare una finalità che perseguono congiuntamente le
norme secondarie meno popolari, vale a dire le regole sull'applicazione giudiziale della
forza, e le regole sull'introduzione di nuove norme.
Quando è vigente la convenzione della discrezionalità i sudditi adottano un punto di
vista interno, ciò che, per Hart, sebbene non sia una condizione necessaria per
l'esistenza di un sistema giuridico, è chiaramente il segno di un sistema giuridico sano32,
il segno, se quanto ho sostenuto è plausibile, che si è in presenza di un autentico rule of
law.
Per tornare alla critica dalla quale siamo partiti, se si sostenesse che tale atteggiamento
da parte di sudditi non può riscontrarsi in assenza di autentiche ragioni morali,
affermare che si tratta di un elemento costitutivo del rule of law permette di sostenere
che se anche i critici di Hart avessero ragione nel sostenere che il punto di vista interno
suppone l'accettazione morale, tale successo sarebbe relativo a un concetto di rule of
law e non a un concetto di diritto. In altre parole, solo si dimostrerebbe che il concetto
di rule of law è inseparabile dalla morale ma non il concetto di diritto, sebbene il prezzo
da pagare per tale separabilità sia la sottoscrizione di un concetto casuale di diritto.
Nessuna dubita che un positivista metodologico pagherebbe questo prezzo senza fiatare.
Riassumendo quanto analizzato finora, si può proporre il seguente insieme di
conclusioni parziali, parziali perché non pregiudicano il punto lasciato in sospeso
all'inizio, ovvero la questione del carattere prescrittivo (o no) della teoria del rule of law
di Hart.
Alberto Puppo, DOSD, Primo Draft, 29 giugno 2013. Per favore, non citare.
27
32 Dopo aver ricordato quali sono le condizioni necessarie e sufficienti per l'esistenza di un sistema giuridico, Hart sottolinea che "The first condition is the only one which private citizens need satisfy: they may obey each 'for his part only' and from any motive whatever; though in a healthy society they will in fact often accept these rules as common standards of behaviour and acknowledge an obligation to obey them, or even trace this obligation to a more general obligation to respect the constitution" (CL, 116-117, corsivo aggiunto).
1. Quando si definisce lo stato di diritto, ovvero quando si costruisce un modello
esplicativo del fenomeno, si può includere o escludere un elemento squisitamente
morale.
2. Tale inclusione o esclusione è interessante per le concezioni intermedie, o miste,
ovvero che non sono né assolutamente formali (Raz) né assolutamente sostanziali
(Ferrajoli).
3. Le concezioni intermedie tendono a definire lo stato di diritto in una forma tale che le
sue proprietà definitorie tendono a coincidere con quelle di un sistema giuridico
(sofistico, vale a dire un sistema giuridico che non coincide con un qualsiasi
ordinamento giuridico, o diritto, ma presenta alcune caratteristiche peculiari).
4. In almeno un caso (Waldron), le caratteristiche del rule of law sono sviluppate come
altrettante proprietà del sistema giuridico.
5. In Hart, esistendo una chiara oscillazione nell'uso dei concetti di diritto, di sistema
giuridico e di sistema giuridico sano, è possibile distinguere tra due discorsi, uno che
tende a sostituirsi al discorso di Austin e che si limita a sostenere la tesi secondo la
quale il diritto è un insieme di regole (caratterizzate dall'aspetto interno, che non
hanno le mere abitudini o gli ordini), l'altro che tende a sviluppare un concetto
sofisticato di diritto (o di sistema giuridico), che si può reinterpretare come concetto
di rule of law, capace di soddisfare le varie esigenze, in primis la certezza e
l'efficacia, che un diritto primitivo (un mero insieme di norme primarie) lascia
inesorabilmente insoddisfatte.
6. Il concetto sofisticato si basa su certi atteggiamenti, come l'adozione del punto di
vista interno da parte, almeno, dei giudici, che aprono una legittima controversia
sulla relazione tra diritto e morale.
7. La complessa relazione tra diritto e morale può essere analizzata, o nel seno del
concetto di rule of law o nella relazione tra diritto e rule of law.
8. L'affiancamento dei due concetti, diritto e rule of law, può sfociare in tre possibili
relazioni: a) i due concetti sono irrelati; b) i due concetti sono relazionati nella
28
misura in cui il primo dipende dal secondo, così come, per esempio le convenzioni
superficiali di Marmor solo possono essere percepite e descritte a partire dalle
convenzioni profonde che le sottendono33; c) i due concetti sono relazionati nella
misura in cui il secondo costituisce un modello al quale deve tendere il primo, che in
tal caso può leggersi come uno stato imperfetto del secondo.
9. Nel caso di Hart, il dubbio è tra la seconda o la terza possibilità.
10. L'uso della metafora che si basa sulla coppia di termini "salute-patologia", data la
chiara connotazione positiva del primo termine e la negativa del secondo, fa sorgere
il sospetto che il sistema giuridico sano costituisca un modello al quale dovrebbe
tendere il sistema giuridico embrionale (o primitivo) o patologico.
5. Hart e l’uso delle metafore mediche: il Rule of Law tra normalità, salute e
normatività
Il sospetto menzionato nell'ultima conclusione può diventare una realtà se si dimostra
che la normalità statistica tende ad essere patologica e che quindi la descrizione del
diritto come sistema sano o è empiricamente falsa o non è affatto una descrizione.
Per valutare la portata empirica del concetto di Hart ci si dovrebbe concentrare non
sullo stato del diritto oggi ma sullo stato del diritto quando Hart ha scritto il suo libro.
Se si può dimostrare che almeno il diritto inglese era un sistema giuridico sano, allora il
libro di Hart può essere considerato una buona descrizione del diritto in generale (come
insieme di regole) e del diritto inglese in particolare (come rule of law). Se non si può
dimostrare che normalmente il diritto è come il diritto inglese, allora il libro di Hart può
forse essere considerato una buona descrizione del diritto in generale (come insieme di
regole), ma non come una realistica descrizione del diritto come rule of law o come
sistema giuridico sano. Si tratta forse di una visione normativa che si proietta su tutti i
diritti del mondo, per aiutarli a compiere le finalità alle quali sono dirette le norme
secondarie, in particolare la certezza e la discrezionalità motivata.
Alberto Puppo, DOSD, Primo Draft, 29 giugno 2013. Per favore, non citare.
29
33 Su questo tema rimando a Puppo, 2011a.
Quest'ultima affermazione solo può essere intesa a partire da un'analisi di concetti come
normale, sano, patologico e normativo.
Ebbene, non può essere ozioso pensare ai padri della sociologia, che non casualmente,
sono anche, almeno in parte, i padri del positivismo (sociologico). Il riferimento è a
Comte. Comte fu l'ispirazione più importante di uno dei più influenti filosofi della
medicina del diciannovesimo secolo, Claude Bernard, al quale si deve una definizione
puramente scientifica, ovvero allo stesso tempo oggettiva e descrittiva, della salute. La
salute corrisponde all'omeostasi. Bernard arrivò a stabilire valori normali, o intervalli
normali, che gli permisero di stabilire biochimicamente se un certo individuo era sano,
ovvero normale, o malato. Tale concezione fu alla base della sanità pubblica così come
la conosciamo oggi, e ne facciamo un'esperienza quotidiana ogni qualvolta, per
esempio, vediamo dei numeri in grassetto su un referto di laboratorio, ed
immediatamente ci diciamo che qualcosa non va. L'ideale scientista e positivista di
Bernard era erigere la fisiologia al livello della fisica e della chimica, stabilire leggi
capaci di prevedere i fenomeni fisiologici come le leggi dell'astronomia permettono di
prevedere i movimenti dei pianeti. Tale concezione è stata criticata brillantemente da un
filosofo della medicina come George Canguilhem, del quale fu allievo Michel Focault,
con argomenti che risulteranno (o risulterebbero) utili per capire la relazione tra
normale e patologico dell'opera di Hart. Canguilhem, che fece in un certo senso l'elogio
dei grandi clinici che si basavano sulla moltiplicazione delle osservazioni dirette o
indirette sui pazienti e elaboravano norme puramente statistiche, affermò che non
esisteva una norma biologica assoluta, che ogni individuo vive secondo la sua norma
biologica, il che significa, in particolare, che un individuo non è anormale se non
corrisponde al modello stabilito in laboratorio. La salute non è la conformità a una
norma, ma normatività rispetto a un certo contesto, è un concetto relazionale che
descrive la capacità per un individuo di non essere costretto ad adattarsi o peggio ancora
di non potere più adattarsi all'ambiente che lo circonda. La salute è, secondo
Canguilhem, normatività, intesa come capacità di imporsi all'ambiente circostante,
30
capacità di modificare le caratteristiche del mondo, comprese, aggiungo io, i
comportamenti di altri individui. E' evidente che tale concetto di salute ha una
dimensione sociale inconfondibile.
Che cosa suggerisce tutto ciò, se lo riferiamo al sospetto di normatività della teoria che
Hart elabora riguardo allo stato di diritto? E' possibile sostenere, a mio avviso, le
seguenti cose:
11. Un diritto normale è un diritto non patologico nella misura in cui soddisfa il modello
di sistema giuridico elaborato in laboratorio da Hart. Il laboratorio di Hart è la
società inglese.
12. Un diritto più o meno patologico è un diritto che si discosta più o meno dal modello
inglese. Le due condizioni necessarie e sufficienti che tutti conosciamo sono per
così dire le condizioni fisiologiche per un corretto funzionamento del diritto34. Una
tipica applicazione giuridica della riflessione di Canguilhem è data dai casi in cui si
pretende di descrivere il funzionamento di altri diritti a partire dai concetti
occidentali, quali appunto rule of law, democrazia etc. Tali diritti sono malati perché
funzionano in un modo diverso o perché non soddisfano certe esigenze. Tuttavia
senza dimostrare che tali "certe esigenze" sono di fatto le loro esigenze, la
conclusione circa la malattia è chiaramente ingiustificata. Le transizioni
democratiche di certi paesi che escono da conflitti (tipiche patologie in Hart)
assomigliano (come gli esperti della giustizia transizionale non esitano a dire) a
delle terapie.
13. Hart non fa nulla di tutto questo. Non giudica altri diritti; si limita a dire,
probabilmente, che date certe esigenze, la migliore forma per soddisfarle è
sviluppare un sistema giuridico come quello che egli concettualizza. Si potrebbe
Alberto Puppo, DOSD, Primo Draft, 29 giugno 2013. Per favore, non citare.
31
34 È ricorrente, soprattutto nel capitolo sui fondamenti del sistema giuridico la metafora che oppone normale o «in salute» e patologico. Paradigmatico è il seguente passaggio: "Yet when we take off the spectacles constituted by this terminology and look at the facts , it becomes apparent that a legal system, like a human being, may at one stage be unborn, at a second not yet wholly independent of its mother, then enj oy a healthy independent existence, later decay and finally die. These half-way stages between birth and normal, independent existence and, again, between that and death, put out of j oint our familiar ways of describing legal phenomena" (CL, 112).
tuttavia ancora sostenere che sebbene abbia la forma di una norma tecnica, si tratta
pur sempre dell'espressione di una norma.
14. Se la salute del sistema giuridico corrisponde all'ideale, allora si potrebbe parlare di
norme ideali, nel senso di Von Wright. Utilizzando le parole di Nietzsche potremmo
dire che Hart dice al diritto "come si diventa ciò che si è".
15. Infine, se si constata che di fatto la maggioranza delle società, allora e forse ancora,
vivono in una situazione patologica, non rimane che dire che il modello salutista di
Hart o non è generale o funziona come modello normativo. Potremmo addirittura
dire che forse la teoria hartiana ha contribuito ad aumentare il numero di casi non
patologici. Se pensiamo al diritto internazionale, per esempio, lo sviluppo di una
pratica giudiziale, inesistente negli anni sessanta, ha forse consolidato una regola di
riconoscimento e quindi diminuito l'incertezza che caratterizzava il diritto primitivo.
Tuttavia, temo, non si tratti di un solido argomento.
16. Infine, per terminare con una citazione di uno dei miei maestri che si pronunciava a
proposito del concetto di sistema giuridico tipico della sistematica continentale, la
constatazione che la realtà non corrisponde al modello è un serio indizio della
precettività del modello35:
Il modello sistematico […] non serve solo al fine conoscitivo di distinguere il
diritto dall’ambiente, ma anche a quello – per certi versi precettivo – di attribuirgli
caratteri come unità, coerenza e completezza: che il modello tenda a presentare
tali caratteri anche quando essi manchino nell’originale è un buon indizio della
sua precettività.
Bibliografia
Barberis, Mauro,1998), L’evoluzione del diritto, Torino, Giappichelli.
32
35 Barberis, 2009, pp. 148-150.
Beckett, J. A., 2008, 'The Hartian Tradition in International Law", The Journal Jurisprudence, 1, pp. 51-83.
Dicey, A.V., 1915, 'Introduction' to the Study of the Law of the Constitution, 8th ed., London, Macmillan & Co.
Finnis, John, 1980, Natural Law and Natural Rights, Oxford, Clarendon.
Finnis, John, 2008, “On Hart’s Ways: Law as Reason and as Fact”, in M.H. Kramer - C. Grant - B. Colburn - A. Hatzistavrou (eds.), The Legacy of H.L.A. Hart. Legal, Political and Moral Philosophy, Oxford, Oxford UP, 2008, pp. 3-27.
Fuller, L., 1958, "Positivism and Fidelity to Law. A Reply to Professor Hart Harvard Law Review", vol. 71, No. 4, pp. 630-672.
Horwitz, M. J., 1997, "Why is Anglo-American Jurisprudence Unhistorical?", Oxford Journal of Legal Studies, vol. 17, 551-586.
Puppo, A., 2011, Acceptation et normativité: la force du devoir dans le discours juridique, Roma, Aracne.
Puppo, A., 2011a, «Fonti della normatività e convenzioni profonde», in Federico Arena - Pierre Brunet (eds.) Cuestiones contemporáneas de Teoría analítica del Derecho (eds.), Madrid, Marcial Pons, 2011, pp. 129-165.
Puppo, A., 2013, "Estado de excepción: algunas consideraciones acerca de héroes garantistas y participantes patológicos", in González de la Vega, R. y Lariguet G. (eds.), Problemas de Filosofía del Derecho. Nuevas Perspectivas, Temis, Colombia (en prensa).
Shiner, R.,1992, Norm and Nature. The Movements of Legal Thought, Oxford, Clarendon.
Waldron, J., 2009, “The Concept and the Rule of Law”, NYU Law School, Public law and Legal Theory Research Paper Series, working paper núm. 08-50, (http://ssrn.com/abstract=1273005),
Waldron, J., 2011, "Planning for Legality", Rassegna di Legality (di Scott Shapiro, Cambridge,Harvard University Press, 2010), Michigan Law Review, 109, pp. 883-902.
Waldron, J., 2012, "Stare Decisis and the Rule of Law: a Layered Approach", Michigan Law Review, 111, pp. 1-31.
Alberto Puppo, DOSD, Primo Draft, 29 giugno 2013. Per favore, non citare.
33