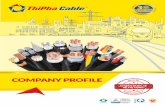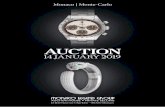L’abito non fa il monaco: il quesito delle confraternitates Sancte Marie Alamannorum
Transcript of L’abito non fa il monaco: il quesito delle confraternitates Sancte Marie Alamannorum
KrisTJAn ToomAspoeG
l’AbiTo non fA il monACo: il QuesiTo delle COnfrATErnITATES SAnCTE MArIE ALAMAnnOruM
il 12 giugno 1553, il notaio lodovico Joannis Vassiero di Valencia com-pilò un atto destinato a don Geronimo Carros, menzionato nel documentoquale preceptor et perpetuus commendator sacre domus Mansionis Theuto-nicorum civitatis Panormi1. Tuttavia, sappiamo che, già dalla fine del XVsecolo, i Teutonici avevano lasciato la città di palermo e certamente, all’epo-ca, il «precettore e commendatore» don Geronimo Carros non era membrodell’ordine. in quegli stessi anni, il patrizio veneziano Andrea lippomanostabiliva che sulla sua tomba figurasse il titolo di Ordinis Theutonici Equeset Prior, benché, in realtà, fosse stato un avversario dell’ordine Teutonico,dal momento che, nel corso del primo quarto del Cinquecento, fu proprio luia mettere le mani sui possedimenti dell’ordine in Veneto2. Così a Cortonatroviamo una fraternitas Sancte Marie Alamannorum, insediatasi nei localidi un antico ospedale teutonico, ma amministrata da cittadini cortonesi, sen-za, in verità, avere mai intessuto rapporti con i frati cavalieri3.
Questi tre esempi, risalenti tutti al XVi secolo, inducono a riflettere, dauna parte, sulla trasmissione della memoria tra i Teutonici e i loro eredi ma-teriali, ovvero coloro che, concretamente, rilevarono ed ebbero il compito diamministrare il loro patrimonio; e, dall’altra, sul ruolo svolto dagli abitantidella penisola italiana nella storia dell’ordine. Anche senza i Teutonici, simantengono le apparenze della loro presenza - «il potere del segno» come le
151
1 A. GiuffridA, Il potere del segno. La transizione della Magione da baliato a commen-da, in I Cavalieri Teutonici tra Sicilia e Mediterraneo. Atti del Convegno Internazionale(Agrigento, 24-25 marzo 2006), a cura di A. GiuffridA, H. Houben e K. ToomAspoeG, Gala-tina 2007 (Acta Theutonica 4), pp. 159-202., qui n. Vii, pp. 184-199.
2 J. rAiner, Zur Geschichte des DO priorates SS. Trinità in Venedig vornemlich im 16.Jahrhundert, in Acht Jahrhunderte Deutscher Orden in Einzeldarstellungen , a cura di K.Wieser, bad Godesberg 1967 (Quellen und studien zur Geschichte des deutschen ordens 1),pp. 357-370, qui p. 367 e u. Arnold, Der Deutsche Orden und Venedig, in Militia Sacra. Gliordini militari tra Europa e Terrasanta, a cura di e. Coli, m. de mArCo e f. TommAsi, pe-rugia 1994, pp. 145-165, qui p. 156.
3 C. perol, Cortona. Pouvoirs et sociétés aux confins de la Toscane (XVe-XVIe siècles),roma 2004 (Collection de l’École française de rome 322), p. 188.
definisce Antonino Giuffrida4 -, il che è indice della solidità e del prestigiodelle tradizioni costruite nel passato.
Tutto ebbe origine con la creazione delle confraternite laiche associateall’ordine Teutonico: si tratta di un processo assai precoce dal momentoche, nelle fonti, i primi confrati dei Teutonici sono documentati già nel 1202(a palermo)5. Gli uomini e le donne che ne facevano parte, in sicilia, veni-vano chiamati «confratelli» o «consorelle», in puglia, «oblati» e, in Veneto,«fratelli conversi»: essi costituivano l’élite del folto gruppo di familiari aservizio dei Teutonici nelle loro commende sparse sulla penisola. la presen-za dei familiari dell’ordine Teutonico, ormai ben documentata sia in ambitotedesco sia italiano6, si spiega con il fatto che i membri veri e propri dell’or-dine, essendo in pochi, avevano dei problemi per l’amministrazione del loroimmenso patrimonio, dovendo così fare ricorso a persone esterne al lorogruppo ristretto per la gestione delle diverse loro attività7.
Kristjan Toomaspoeg
152
4 GiuffridA, Il potere del segno, cit.5 G. mAndAlà, m., mosCone, Tra latini, greci e ‘arabici’: ricerche su scrittura e cultura
a Palermo fra XII e XIII secolo, in «segno e testo. international Journal of manuscripts andText Transmission», 7 (2009), pp. 143-238.
6 per il contesto generale cf. G. müller, Die familiaren des Deutschen Ordens, marburg1980 (Quellen und studien zur Geschichte des deutschen ordens 13), per la sicilia cf. K.ToomAspoeG, “Confratres, procuratores, negociorum gestores et factores eorum...” Storiadei familiares dei Cavalieri Teutonici in Sicilia (1197-1492), in «sacra militia. rivista di sto-ria degli ordini militari», 1 (2000), pp. 151-165; per la puglia cf. m. inTini, I Teutonici e lasocietà pugliese: I laici della commenda teutonica di Barletta, in Mobilità e immobilità nelMedioevo europeo. Atti del 2. Seminario di studio dei Dottorati di ricerca di ambito medie-vistico delle università di Lecce e di Erlangen, roma, Istituto storico germanico, 1-2 aprile2004, a cura di H. Houben e b. VeTere, Galatina 2006 (pubblicazioni del dottorato in storiadei centri delle vie e delle culture dei pellegrinaggi nel medioevo euromediterraneo 3), pp.173-194, eAd., “Offero me et mea”: oblazioni e associazioni di laici alla casa teutonica diSan Leonardo di Siponto, in San Leonardo di Siponto. Cella monastica, canonica, domusTheutonicorum. Atti del Convegno internazionale. Manfredonia, 18-19 marzo 2005, a cura diH. Houben, Galatina 2006 (Acta Theutonica 3), pp. 111-132, eAd., I familiares dell’OrdineTeutonico in Terra di Bari: problemi e prospettive, in L’Ordine Teutonico tra Mediterraneo eBaltico: incontri e scontri tra religioni, popoli e culture, a cura di H. Houben e K. ToomA-spoeG, Galatina 2008 (Acta Theutonica 5), pp. 95-124, eAd., I familiares dell’Ordine Teuto-nico in Capitanata, in federico II e i cavalieri teutonici in Capitanata: recenti ricerche stori-che e archeologiche. Atti del Convegno internazionale, foggia-Lucera-Pietra Montecorvino10-13 giugno 2009, a cura di p. fAViA, H. Houben e K. ToomAspoeG, Galatina 2012 (ActaTheutonica 7), pp. 215-239.
7 per la storia generale dei Teutonici in italia, cf. K. forsTreuTer, Der Deutsche Ordenam Mittelmeer, bonn 1967 (Quellen und studien zur Geschichte des deutschen ordens 2),L’Ordine Teutonico nel Mediterraneo. Atti del Convegno internazionale di studio. Torre Ale-manna (Cerignola)-Mesagne-Lecce 16-18 ottobre 2003, a cura di H. Houben, Galatina 2004(Acta Theutonica 1), K. ToomAspoeG, Die Behauptung des Deutschen Ordens in Italien, inHerrschaft, netzwerke, Brüder des Deutschen Ordens im Mittelalter und neuzeit. Vorträgeder Tagung der Internationalen Historischen Kommission zur Erforschung des Deutschen
A differenza degli altri familiari, tra i quali, in sicilia, troviamo anche nu-merosi ebrei e cristiani ortodossi8, i confrati avevano un legame più profon-do e di tipo spirituale con l’ordine. in realtà, le confraternite dei Teutonicinon possedevano alcun tipo di statuto o altro testo normativo proprio, rifa-cendosi, sostanzialmente, agli statuti dell’ordine Teutonico nella versioneredatta intorno alla metà del Xiii secolo9. in origine, essi abitavano nelle ca-se dell’ordine, ma, in seguito, dal 1250 in poi, tale circostanza venne pro-gressivamente meno. Gli aspetti che li accomunavano erano il fatto di assi-stere alla messa nelle chiese teutoniche e di indossare il mantello dell’ordinecon la raffigurazione della croce tagliata a metà (a forma di ‘tau’)10.
inizialmente, talvolta risulta difficile distinguere tra i membri veri e pro-pri dell’ordine Teutonico e i loro confrati. Ad esempio, quando, nel marzo1229, l’ordine ricevette il patronato di un ospedale nel territorio di Castiglio-ne d’Arezzo (Castiglion fiorentino), i Teutonici si fecero rappresentare daGuido Cacciaconti, esponente della ben nota famiglia ghibellina toscana11, e
L’abito non fa il monaco: il quesito delle confraternitates sancte marie Alamannorum
153
Ordens in Marburg 2010, a cura di K. miliTzer, Weimar 2012 (Quellen und studien zur Ge-schichte des deutschen ordens 72, Veröffentlichungen der internationalen HistorischenKommission zur erforschung des deutschen ordens 12), pp. 133-148, id., The Teutonic Or-der in Italy: An Example of the Diplomatic Ability of the Military Orders, in The Military Or-ders, Volume 5. Politics and Power, a cura di p. W. edbury, burlington-farnham 2012, pp.273-282, per il baliato di puglia cf. i lavori di H. Houben, a cominciare da Zur Geschichteder Deutschordensballei Apulien. Abschriften und regesten verlorener urkunden aus neapelin Graz und Wien, in «mitteilungen des instituts für österreichische Geschichtsforschung»,107, 1-2 (1999), pp. 50-110; per la sicilia K. ToomAspoeG, Les Teutoniques en Sicile (1197-1492), roma 2003 (Collection de l’École française de rome 321), per il baliato di “lombar-dia”, ovvero i possedimenti dell’ordine nell’italia centro-settentrionale, p. CierzniAKoWsKi,L’Ordine Teutonico nell’Italia settentrionale, in L’Ordine Teutonico nel Mediterraneo, cit.,pp. 217-235, K. ToomAspoeG, La fondazione della provincia di “Lombardia” dell’Ordinedei Cavalieri Teutonici (secoli XIII-XIV), in «sacra militia. rivista di storia degli ordini mili-tari», 3 (2003), pp. 111-159; per il lazio cf. J.-e. beuTTel, Der Generalprokurator des Deut-schen Ordens an der römische Kurie. Amt, funktionen, personelles umfeld und finanzie-rung, marburg 1999 (Quellen und studien zur Geschichte des deutschen ordens 55), b.bombi, L’Ordine Teutonico nell’Italia centrale. La casa romana dell’Ordine e l’ufficio delprocuratore generale, in L’Ordine Teutonico nel Mediterraneo, cit., pp. 197-216.
8 Cf. K. ToomAspoeG, L’Ordine Teutonico in Sicilia. una minoranza fra le altre, in«Quellen und forschungen aus italienischen Archiven und bibliotheken», 85 (2005), pp.104-126.
9 m. perlbACH, Die Statuten des Deutschen Ordens nach den ältesten Handschriften,Halle a. s. 1890, regula, 32 e 33.
10 ivi, regula, 32, p. 52: Vestes religiosi colores deferent non cum integra cruce. Questacircostanza fu ribadita nel 1289 dal gran maestro burchard von schwanden (ivi, pp. 138-139). per esempi concreti sull’applicazione di questo diritto, cf. ad esempio inTini, I Teutoni-ci e la società pugliese, cit., pp. 185-186 e ToomAspoeG, Les Teutoniques en Sicile, cit., n.XV, pp. 536-538.
11 ildebrandino di Guido Cacciaconti, probabilmente il figlio di Guido, nel 1231 era a ca-po della nobiltà ghibellina di siena: p. CAmmArosAno, La Toscana nella politica imperiale
da un certo severinus12. non esistono elementi che confermino l’apparte-nenza di questi due uomini all’ordine e, al di fuori di Castiglione, non abbia-mo notizie di altre loro attività; nonostante ciò, essi si presentarono comefratres. peraltro, durante la cerimonia di trasmissione del patronatosull’ospedale, essi si fecero prestare omaggio dai donatori attraverso il baciorituale della croce (dell’ordine Teutonico) che campeggiava sui loro mantel-li13.
nel novembre del 1263, un abitante di barletta, raimondo provinciale,divenne confrate dell’ordine ottenendo il diritto di portare il mantello deiTeutonici con la mezza croce, ma gli fu anche permesso, una volta morta lamoglie, di andare a vivere nella casa dell’ordine, entrare a far parte del «col-legio» dei frati e vestire il mantello con la croce intera14.
in seguito, sino al quarto decennio del Trecento, troviamo nel mezzo-giorno una dozzina di fratres che sottoscrivono documenti dei Teutonici,spesso preti con nomi italiani, tali Giovanni da Gangi15 e Giovanni da napo-li16, ma sui quali non disponiamo di molte altre informazioni. Tuttavia, sap-piamo che alcuni di essi divennero effettivamente Teutonici tramite l’incor-porazione delle loro istituzioni religiose d’appartenenza nell’ordine: basilio,frate in puglia dal 1237, era stato in precedenza a capo della confraternita disanto spirito in Salsula (melfi)17; allo stesso modo, dopo l’incorporazionenell’ordine Teutonico della canonica di san leonardo di siponto, avvenutanel 1260-61, alcuni dei suoi canonici entrarono a far parte dei Teutonici18.
si constata dunque una certa confusione tra il personale dell’ordine e isuoi confrati, confusione che divenne potenzialmente rischiosa nell’epoca
Kristjan Toomaspoeg
154
di federico II, in friedrich II. Tagung des Deutschen Historischen Instituts in rom im Ge-denkjahr 1994, a cura di A. esCH e n. KAmp, Tübingen 1996 (bibliothek des deutschen Hi-storischen instituts in rom 85), pp. 363-380, qui p. 375.
12 G. GHizzi, Storia della Terra di Castiglione fiorentino, Arezzo 1883-1886 (rist. bolo-gna 1972), pp. 149-150.
13 ... et domina Pagana crucem in eorum clamide existentem osculando ...: ivi, p. 150.14 Le pergamene di Barletta del real Archivio di napoli, 1075-1309, a cura di r. filAn-
Gieri di CAndidA, bari 1927 (Codice diplomatico barese 10), nr. 109, s. 157-158, cf. inTini,I Teutonici e la società pugliese, cit., pp. 183-184.
15 ToomAspoeG, Les Teutoniques en Sicile, cit., n. 82, p. 467.16 ivi, n. 110, p. 46917 H. Houben, La presenza dell’Ordine Teutonico a Barletta (secc. XII-XV), in Barletta
crocevia degli Ordini religioso-cavallereschi medioevali. Seminario di studio, Barletta 16Giugno 1996, Taranto 1997 (Gran priorato di napoli e sicilia del sovrano militare ordine dimalta, melitensia 2), pp. 23-50, qui p. 46, id., Zur Geschichte der Deutschordensballei Apu-lien, cit., p. 61.
18 id., San Leonardo di Siponto e l’Ordine Teutonico in Puglia, in San Leonardo di Si-ponto. Cella monastica, cit., pp. 91-110, qui p. 98.
dell’allontanamento dei Teutonici dal mediterraneo. infatti, dopo il 1309,quando il gran maestro siegfried von feuchtwangen scelse come sua nuovaresidenza marienburg, in prussia (in sostituzione di Venezia dove i granmaestri si erano stabiliti dopo la caduta di Acri nel 1291), il controllo suipossedimenti italiani dell’ordine si allentò e, allo stesso tempo, le ricchezzeprodotte nella penisola, sino ad allora utilizzate per la guerra contro i musul-mani, rimasero per lo più in loco. All’epoca, i confrati ebbero facile accessoa queste risorse economiche e la loro gestione del patrimonio teutonico di-venne spesso incontrollabile.
Così quando, nel corso del settimo decennio del XiV secolo, l’ammini-strazione dei baliati italiani fu delegata al Deutschmeister, a capo del ramotedesco dell’ordine Teutonico, una delle sue prime iniziative fu quella di ri-durre drasticamente il ruolo dei confrati negli affari economici delle singolecommende. di conseguenza, essi furono spesso sostituiti da procuratori sala-riati e imprenditori associati19. Ad esempio, nella ricca commenda di poliz-zi, in sicilia, il confrate-gestore manfredi di Amato fu destituito e la mag-gior parte dei possedimenti ceduti in affitto alla comunità ebraica locale20.
Tuttavia, per molti versi questa riforma giunse troppo tardi e non rag-giunse quelle zone dove l’ordine aveva sin dall’inizio affidato la gestionedelle sue attività agli abitanti del posto. Ciò si verificò soprattutto in italiacentrale, nella Val di Chiana toscana, in umbria e nella Tuscia laziale, dove ipossedimenti erano stati acquisiti nell’arco temporale compreso tra la pacedi san Germano (1230) e le spedizioni imperiali in italia di enrico Vii e lu-dovico il bavaro della prima metà del Trecento21. l’ordine Teutonico eser-citò il patronato su di una serie di ospedali-ospizi a Castiglione d’Arezzo,monticchiello22, Asciano23, forse anche a Cortona24, e ne detenne a pieno ti-tolo due altri a montefiascone25 e a Viterbo26.
L’abito non fa il monaco: il quesito delle confraternitates sancte marie Alamannorum
155
19 ToomAspoeG, “Confratres, procuratores”, cit., p. 158.20 Cf. ToomAspoeG, Les Teutoniques en Sicile, cit., n. XVi, pp. 538-540.21 su questo specifico argomento cf. C. e. Woelfle, L’Ordine Teutonico a Cortona e in
Valdichiana, in Studi in onore di Celestino Bruschetti, Cortona 1980 (= «Annuario dell’Ac-cademia etrusca di Cortona», 18, n. s. 11 (1979)), pp. 553-566.
22 rationes Decimarum Italiae nei secoli XII e XIV: Tuscia II, Le decime degli anni 1295-1304, a cura di m. GiusTi e p. Guidi, Città del Vaticano 1942 (studi e testi 98), p. 168.
23 Woelfle, L’Ordine Teutonico a Cortona, cit., p. 561.24 ivi, pp. 563-564.25 forsTreuTer, Der Deutsche Orden am Mittelmeer, cit., pp. 164-165 e beuTTel, Der
Generalprokurator, cit., pp. 482-486.26 T. frAnK, Der Deutsche Orden in Viterbo (13.-15. Jahrhundert), in Vita religiosa im
Mittelalter. festschrift für Kaspar Elm zum 70. Geburtsdag, a cura di f. J. felTen e n. JA-sperT, berlin 1999 (berliner Historische studien 31, ordensstudien 13), berlin 1999, pp.321-343.
Tutti gli ospedali menzionati furono gestiti, senza eccezioni, da laici nonappartenenti all’ordine: così, l’ospedale di Castiglione fu affidato, nel 1229,a un cavaliere di nome napoleone27 e quello di Viterbo, nel 1296, a un pro-curatore, tal enrico de stella28. A montefiascone, l’ospedale teutonico fu sindall’inizio retto da esterni, venendo ceduto in affitto per lunghi periodi e fi-nendo per essere trasformato in locanda29. per quanto riguarda gli ospedalidi monticchiello, Asciano e Cortona, essi compaiono nelle fonti come degliistituti che, sebbene intitolati alla Vergine degli Alemanni o chiamati sempli-cemente ospedali dei Tedeschi, furono sottoposti sia alla curia pontificia, al-la quale pagavano la decima30, sia alle autorità municipali locali, senza tenerconto in alcun modo dei diritti dei Teutonici.
in certi periodi e in particolari località, le confraternite finirono dunqueper sostituire i Teutonici veri e propri. È il caso di Venezia, laddove la com-menda locale dell’ordine, sebbene prestigiosa, rimase sempre di dimensioniridotte e mal equipaggiata a livello di personale, salvo al tempo della presen-za dei gran maestri in città (1291-1309)31. Al contrario, nel corso del Tre eQuattrocento, vi si sviluppò una potente confraternita associata ai Teutonici,molto più consistente rispetto all’esiguo numero di cavalieri. infatti, dopo il1309, sappiamo che non vi furono mai più di due frati di stanza a Venezia eche solitamente la casa veneziana era gestita da un unico Teutonico presen-te, senza dimenticare i frequenti periodi di assenza totale dei frati. la con-fraternita laica giocò un ruolo di primo piano nell’esproprio della casa di Ve-nezia nel 1512, ufficialmente giustificata dall’assenza di un commendatoredopo il decesso di quello precedente, Albert von laumersheim32.
l’interazione tra gli abitanti della penisola e i Teutonici è un fenomenocomplesso e per molti versi originale. per esempio, possiamo osservare unasostanziale differenza con la prassi attuata dai Giovanniti che tendevano agestire i loro possedimenti come dei benefici ecclesiastici, concedendoli asingoli membri dell’ordine. fu così che molti cavalieri dell’ospedale di san
Kristjan Toomaspoeg
156
27 GHizzi, Storia della Terra di Castiglione fiorentino, cit., pp. 149-150.28 frAnK, Der Deutsche Orden in Viterbo, cit., p. 325.29 forsTreuTer, Der Deutsche Orden am Mittelmeer, cit., pp. 164-165.30 rationes Decimarum Italiae nei secoli XII e XIV: Tuscia II, cit., pp. 92, 168 e 297, s.
pieri, notizie sugli “hospitalia”, in «Annali Aretini», 5 (1997), pp. 5-98, qui p. 57.31 Cf. Arnold, Der Deutsche Orden und Venedig, cit.32 forsTreuTer, Der Deutsche Orden am Mittelmeer, cit., p. 155, Protokolle der Kapitel
und Gespräche des Deutschen Ordens im reich (1499-1525), a cura di m. bisKup e i. JA-nosz-bisKupoVA, marburg 1991 (Quellen und studien zur Geschichte des deutschen ordens41, Veröffentlichungen der internationalen Historischen Kommission zur erforschung desdeutschen ordens 3), pp. 83, 103 e 112, Arnold, Der Deutsche Orden und Venedig, cit., pp.155-157.
Giovanni basarono le loro carriere sui redditi ricavati da questi beni tantoche, talvolta, fu difficile operare una distinzione fra il patrimonio di famigliae quello ottenuto in gestione dall’ordine33.
da questo punto di vista, l’ordine Teutonico fu più rigoroso. per evitarele interferenze di esterni nei loro affari e le conseguenti possibili usurpazio-ni, i Teutonici adottarono un sistema di rotazione dei frati, spostando il per-sonale di stanza in italia abbastanza frequentemente da un baliato o unacommenda all’altro/a34. non sempre però questo sistema riuscì a scongiura-re i pericoli: nel 1334 alcuni Teutonici «ribelli» invasero la casa barlettanadell’ordine, approfittando dell’assenza del commendatore provinciale idipuglia, forti del sostegno di alcuni laici, loro «amici e consanguinei»35. Cosìnon è un caso che, dopo questa data, non troviamo più nel baliato pugliesefrati con nomi italiani…
la volontà di evitare i legami di parentela o di amicizia tra i frati e la po-polazione locale spiega dunque la resistenza da parte dell’ordine Teutoniconell’ammettere degli ‘italiani’ tra i Teutonici: qualora un abitante della peni-sola avesse voluto entrare nell’ordine - e gli aspiranti non mancavano -,avrebbe dovuto prestare servizio nei territori di lingua tedesca36. di conse-guenza, i nobili italiani legati ai Teutonici divennero al massimo confrati: èil caso di raimondello del balzo orsini pugliese che partecipò anche ad unaspedizione militare in lituania37.
Tale strategia, che limitava l’adesione o addirittura respingeva i candida-ti, se, da una parte scongiurò il pericolo di usurpazioni e abusi di potere daparte degli stessi Teutonici, dall’altra, non ammettendo nuovi adepti, man-tenne il numero dei frati presenti in situ sempre relativamente basso: il per-
L’abito non fa il monaco: il quesito delle confraternitates sancte marie Alamannorum
157
33 s. fodAle, Scisma ecclesiastico e potere regio in Sicilia, i, Il duca di Montblanc el’episcopato tra roma e Avignone (1392-1396), palermo 1979 (medievalia), p. 108, id., SanGiovanni in Sicilia: l’inchiesta di Gregorio XI sull’ordine gerosolimitano, in Società, istitu-zioni, spiritualità. Studi in onore di Cinzio Violante, spoleto 1994 (Centro italiano di studisull’alto medioevo. Collectanea 1), pp. 361-373, qui p. 364, L’inchiesta pontificia del 1373sugli Ospedalieri di San Giovanni di Gerusalemme nel Mezzogiorno d’Italia, a cura di m.sAlerno e K. ToomAspoeG, bari 2008 (università degli studi della Calabria, Corso di lau-rea in storia e Conservazione dei beni Culturali, itineraria 10), p. 143.
34 ToomAspoeG, Die Behauptung des Deutschen Ordens, cit., p. 143, con degli esempiconcreti.
35 13 settembre 1334, Houben, Zur Geschichte der Deutschordensballei Apulien, cit., n.35, pp. 104-106.
36 Cf. il caso di pedro de luna in Berichte der Generalprokuratoren des Deutschen Or-dens an der Kurie, a cura di K. forsTreuTer e H. Koeppen, iii, Göttingen 1966 (Veröffentli-chungen der niedersächsischen Archivverwaltung , 21), n. 154, pp. 333-336.
37 H. Houben, raimondo del Balzo Orsini e l’Ordine Teutonico, in L’Ordine Teutonicotra Mediterraneo e Baltico, cit., pp. 195-217.
sonale teutonico contava non più di cinquanta individui per tutta la penisola- e in alcuni periodi, anche meno -, tanto che, nel 1492, vi erano solo quattrocavalieri per tutta la sicilia38. Cosicché il ricorso a laici associati all’ordinedivenne necessario e soltanto tramite l’impiego di familiari e confrati si potéassicurare l’amministrazione l’ingente patrimonio accumulato sul territorio.
nonostante ciò, sarebbe riduttivo affrontare l’argomento delle confrater-nite teutoniche solamente dal punto di visto socio economico: infatti, è ne-cessario riflettere anche sul legame spirituale che univa certi laici ai Teutoni-ci. nel Xiii secolo, nel contesto di generale decadenza del monachesimo tra-dizionale nel mezzogiorno, l’ordine Teutonico e gli altri ordini religioso mi-litari rappresentavano una novità, forti della loro spiritualità e della concre-tezza delle loro azioni39.
sarebbe interessante conoscere quale aspetto in particolare della religio-sità dei Teutonici attrasse i loro confrati. oltre alla generica fama sanctitatis,cui si allude nel documento del maggio del 1236 che conferma l’annessionedella confraternita di santo spirito in Salsula all’ordine Teutonico40, dove-vano essere altri i fattori cattivanti, legati sia alle attività dell’ordine in dife-sa della fede cristiana, sia alle iniziative assistenziali a livello locale.
in realtà, poche sono le testimonianze che rivelano essere la guerra inTerra santa la motivazione alla base della decisione dei confrati di aderireall’ordine. esaminando gli atti di donazioni in favore dei Teutonici compilatidai loro confrati o da altri individui a loro associati, notiamo che esisteun’unica donazione, quella del feudo di stigliano (Venezia), fatta da Avanzodi soprovo nel 1282, in cui il donatore trae la sua ispirazione dalle attivitàdell’ordine in Terra santa41. per il resto, la maggior parte dei sottoscrittoridecise di sostenere i Teutonici per le attività caritative e assistenziali da loroportate avanti sul territorio. dunque, alla base della scelta di donatori e con-frati vi furono l’ammirazione per la forma vitae dei frati teutonici, la loro ri-gida osservanza dell’imperativo della carità e, non ultimo, le qualità perso-
Kristjan Toomaspoeg
158
38 Cf. K. ToomAspoeG, ultimi Teutonici di Sicilia (1491-1492), in «sacra militia. rivistadi storia degli ordini militari», 2, (2001), pp. 155-177.
39 Cf., per la decadenza del monachesimo tradizionale, H. Houben, Die Abtei Venosa unddas Mönchtum im normannisch-staufischen Süditalien, Tübingen 1995 (bibliothek des deut-schen Historischen instituts in rom 80), pp. 94-101 e, per la spiritualità degli ordini militari, itesti pubblicati in Die Spiritualität der ritterorden im Mittelalter, a cura di z. H. noWAK, To-ruń 1993 (ordines militares-Colloquia Torunensia Historica 7),
40 Houben, Zur Geschichte der Deutschordensballei Apulien, cit., p. 61.41 Cf. G. CAGnin, La controversa donazione del Castello di Stigliano ai cavalieri teutoni-
ci (Acri, 15 dicembre 1282), in Acri 1291. La fine della presenza degli ordini militari in Ter-rasanta e i nuovi orientamenti nel XIV secolo, a cura di f. TommAsi, perugia 1996 (bibliote-ca di milizia sacra 1), pp. 99-119.
nali dei suoi membri, soprattutto considerando il quadro di progressivo de-cadimento morale della società42.
Altro aspetto interrante e caratterizzante le relazioni esistenti tra gli abi-tanti della penisola e i Teutonici è la loro longevità, dal momento che talunefamiglie rimasero legate all’ordine per diverse generazioni43. Ciò spiega lapersistenza di tradizioni specifiche, come ad esempio la processione di Cor-pus Domini a palermo, che da una parte servirono a consolidare la ‘famiglia’teutonica, dall’altra a farla partecipe della vita pubblica44.
nella penisola italiana, poche decine di cavalieri e preti teutonici furonoaccompagnati da un numero imprecisato di familiari e confrati laici almenodieci volte superiore a loro piccolo gruppo. Questo avvenne in un contestodi forte valenza spirituale e simbolica, in un mondo con propri riferimenticaratteristici, dove molte persone appartenevano praticamente dalla loro na-scita.
Questa particolare situazione spiega come mai la memoria dei Teutonicisia stata conservata e trasmessa ben oltre il momento della loro partenzadall’italia, almeno sino al Cinquecento inoltrato. in seguito, le tracce anda-rono progressivamente perdendosi. in diverse località come Gela in sicilia oCortona in Toscana, si arrivò a trasformare il toponimo di santa maria degliAlemanni in santa maria della manna45; così la Mansio Theutonicorum dipalermo divenne semplicemente la magione, come ancora oggi è ricordata;e nel tempo le origini teutoniche della confraternita di santa maria della sa-lute di Venezia caddero nell’oblio.
sarà compito di noi storici ricostruire questa memoria, iniziando con ilriconsiderare concettualmente la storia dell’ordine Teutonico in italia, trop-po spesso percepita come quella della presenza di un’istituzione ‘straniera’sul nostro territorio. perché la storia dell’ordine non sarebbe mai potuta es-sere tale senza la partecipazione e il contributo - positivo o negativo - degliabitanti della penisola.
L’abito non fa il monaco: il quesito delle confraternitates sancte marie Alamannorum
159
42 sul decadimento, per quanto riguarda il Tre- e Quattrocento, cf. ad esempio p. dAlenA,Dagli Itinera ai percorsi. Viaggiare nel Mezzogiorno medievale, bari 2003, p. 166 e s. fo-dAle, Alunni della perdizione. Chiesa e potere in Sicilia durante il grande scisma (1372-1416), roma 2008 (nuovi studi storici 80), pp. 745-772.
43 Cf. ToomAspoeG, “Confratres, procuratores”, cit., p. 161.44 sulla processione palermitana cf. ToomAspoeG, Les Teutoniques en Sicile, cit., pp. 379-
380 e GiuffridA, Il potere del segno, cit., pp. 165-166.45 Così l’erudito cortonese Girolamo mancini scrisse, nel 1897, «... ignoro perché deno-
minassero degli Alamanni, per corruzione della manna, la chiesa istituita in fondo al borgo,adesso detta di san domenico ...»: G. mAnCini, Cortona nel medioevo, Cortona 1897, pp.108-109. ringrazio il dott. Giovanni lumachi per questa indicazione.
rAsseGnA biblioGrAfiCA(a cura di Kristjan Toomaspoeg)
la tematica degli ordini religioso-militari, compreso quello teutonico,rappresenta ormai uno dei settori di punta della storiografia sul medioevo eil numero di saggi e monografie pubblicati ogni anno su questo argomento ètalmente rilevante da risultare difficile da quantificare. A presente vorrei of-frire un piccolo contributo al lettore, elencando alcune opere di miscellaneapubblicate sulla storia dell’ordine Teutonico nel corso dell’anno 2012. Que-sta rassegna è incompleta e soggettiva, dal momento che essa riguarda soloalcuni fra tanti lavori, mette l’accento sulle vicende dell’ordine nel mediter-raneo e si basa unicamente su volumi pervenuti al nostro Centro interdiparti-mentale di ricerca sull’ordine Teutonico nel mediterraneo (CiroTm).
As Ordens Militares. freires, Guerreiros, Cavaleiros. Actas do VI Encon-tro sobre Ordens Militares. Palmela, 10 a 14 de março de 2010 a cura diisabel Cristina ferreirA fernAndes, palmela, Gabinete de estudios sobre aordem de santiago, 2012, 2 voll., 1118 p., ill., isbn 978-972-8497-56-9.
Tra le più di sessanta comunicazioni del Vi convegno di palmela a pre-sente pubblicate si segnalano i seguenti testi che interessano la storiadell’ordine Teutonico: barbara bombi, The Teutonic Order and the papacy,pp. 455-464, offre una riflessione sulla storiografia esistente sui rapporti in-tercorsi tra l’ordine e il papato nel medioevo, concentrando il suo studio sulXiii secolo e proponendo una serie di argomenti da studiare in futuro; niko-las JAsperT, Military Orders and social history: Some introductory thoughts,pp. 495-518, nel suo testo programmatico sullo stato e sulle prospettive distudi di storia sociale nell’ambito degli ordini militari, si basa ampiamenteanche sulla storiografia dell’ordine Teutonico, buon esempio, tra l’altro,della sistematica pubblicazione delle fonti disponibili; Thomas Krämer,The role of the Military Orders in German and french towns: functionalcomparisons, pp. 519-542, offre un paragone tra le case templari e giovanni-te nel midi francese e il baliato teutonico di franconia, sul piano economicoe sociale; Hubert Houben, A northern Military Order in a mediterraneancontext: the teutonic knights in Southern Italy (13th-15th centuries), pp.591-598, riassume le vicende dell’ordine Teutonico nel mezzogiorno d’ita-
161
lia dove, tra il Xiii e il XV secolo, esistevano due baliati teutonici, Apulia eSicilia, affrontando sia la storia diplomatica che economica e sociale dei ca-valieri; philippe JosserAnd, De l’arrière au front: perspectives croisées,perspectives comparées. regards sur la logistique des ordres militaires aumoyen âge, pp. 683-703, nel suo testo sul legame tra il fronte e le retroviedegli ordini tratta anche l’esempio dei possedimenti teutonici nel regno disicilia e altrove e la questione delle responsiones nell’ordine; Klaus miliT-zer, Administrative organisations of the three main Military Orders in theHoly Land, pp. 705-714, realizza, per la prima volta, una credibile compara-zione tra le strutture del Tempio, dell’ospedale e dell’ordine Teutonico inTerra santa; Kristjan ToomAspoeG, Charles Ier d’Anjou, les ordres militaireset la Terre Sainte, pp. 761-777, tratta anche le attività dei Teutonici a servi-zio di Carlo i, in Terrasanta e nel regno di sicilia; Giulia rossi VAiro, Arteda Ordem Teutónica em Itália (sécs. XII-XV), pp. 1009-1024 presenta i risul-tati sino ad ora raggiunti del progetto Arte e Architettura dell’ordine Teuto-nico in italia (CiroTm), uno studio che, basandosi sull’esame di alcune de-cine di siti sparsi su tutta la penisola, permette ormai delle conclusioni inte-ressanti.
federico II e i cavalieri teutonici in Capitanata. recenti ricerche stori-che e archeologiche. Atti del Convegno internazionale (foggia-Lucera-Pie-tra Montecorvino, 10-13 giugno 2009), a cura di pasquale fAViA, HubertHouben e Kristjan ToomAspoeG, Galatina 2012 (Acta Theutonica 7), 602 p.,ill., isbn 9788880869887.
il convegno del giugno 2009 - del quale questo volume presenta quasitutto il materiale - era frutto della collaborazione tra il Centro di studi nor-manno-svevi dell’università degli studi di bari, il CiroTm, l’istituto sto-rico Germanico di roma e l’università degli studi di foggia. l’idea di basedi questo evento scientifico era di creare un collegamento tra gli studi storicie la ricerca archeologica, cosicché, dopo l’introduzione di Cosimo damianofonseCA, federico II e i Cavalieri teutonici in Capitanata: snodi storiogra-fici e piste di ricerca, pp. 15-28, il volume si articola in due parti tematiche.nella prima si presentano dapprima alcune comunicazioni che riguardano irapporti intercorsi tra l’imperatore federico ii e la Capitanata: Jean-mariemArTin, federico II e la Capitanata, pp. 31-44; Giancarlo AndennA, fede-rico II e le comunità cittadine della Capitanata, pp. 45-60; Georg VoGeler,La comunicazione fra federico II e la Capitanata, pp. 61-74; pasquale Cor-si, foggia al tempo di federico II, pp. 75-103; francesco pAnArelli, fede-rico II e le istituzioni ecclesiastiche della Capitanata, pp. 105-122. Questitesti, scritti da alcuni tra i migliori specialisti della Capitanata e dell’epocafedericiana, rappresentano un utile e aggiornato ‘manuale’ per la storia della
rassegna bibliografica
162
Capitanata non solo per la prima metà del Xiii secolo, ma anche per i perio-di immediatamente precedente e successivo. seguono quattro comunicazionisulla storia degli ordini religioso-militari nella regione che affrontano unacronologia ancora più ampia, dal Xii al XV secolo: Hubert Houben, federi-co II e i cavalieri teutonici a Belvedere (Apricena) e a foggia: scavi archi-vistici (con un appendice documentaria 1220-1417), pp. 123-181, continuacon questo saggio il suo lavoro di ricostruzione degli archivi dei Teutonici inpuglia, scomparsi nel 1943, con l’aiuto di copie e regesti realizzati in epocamoderna (nell’appendice si offrono 56 documenti), arrivando a conclusioniimportanti, ad esempio quando nota la longevità della presenza dell’ordine afoggia, anche dopo l’epoca di federico ii; Kristjan ToomAspoeG, Gli inse-diamenti templari, giovanniti e teutonici nell’economia della Capitanatamedievale, pp. 183-214, ricostruisce le vicende dei tre ordini maggiori inquella regione che era il loro ‘granaio’ nel mediterraneo e serviva a rifornirele attività in Terra santa, notando come la ‘nuova economia’ degli ordini mi-litari si fosse imposta sulla ‘vecchia economia’ monastica e diocesana; ma-riella inTini, I familiares dell’Ordine Teutonico in Capitanata, pp. 215-239aggiunge un altro tassello alla sua ricerca sugli abitanti di puglia legati aiTeutonici, un argomento particolarmente ben documentato che l’autrice dapoco ha affrontato anche nel quadro di una monografia; infine, elena bel-lomo, Tra storia locale e ambizioni internazionali; gli ordini monastico mi-litari di origine iberica in Capitanata (secoli XIII-XIV), pp. 241-259, offreuna ricerca inedita sulla presenza degli ordini di Calatrava e di santiago, in-sediatisi a S. Spiritus de Maitin e a sant’Angelo di orsara nel contesto dellalotta tra il papato e l’impero.
la seconda parte del volume riguarda l’archeologia ed è fortemente mar-cata dal progetto di ricerca dell’istituto storico Germanico di roma, in cor-so di opera a lucera e Tertiveri e qui presentato con l’aiuto di numerose illu-strazioni e appendici dai suoi principali autori, michael mATHeus, allora di-rettore dell’istituto romano e lukas Clemens dell’università di Treviri: Mu-sulmani e Provenzali in Capitanata nel XIII secolo. I primi risultati di unprogetto internazionale e interdisciplinare, pp. 369-404. il resto delle comu-nicazioni sono per la maggior parte delle presentazioni dei risultati di singo-le campagne di scavo nei siti associabili a federico ii o ai Teutonici, cosìpasquale fAViA, Caterina Annese, roberta GiuliAni e Giuliana mAssimo, Loscavo di località Pantano presso foggia: un’indagine archeologica sulladomus di federico II e la masseria svevo-angioina, pp. 263-302; ValentinaCArACuTA e Girolamo fiorenTino, Ambiente e strategie produttive nei sitidi San Lorenzo in Carminiano e Pantano (fg) tra XII e XIV secolo, pp. 317-332; roberta GiuliAni e felice sToiCo, Il complesso di S. Maria di Selvadella rocca a Belvedere: un’analisi archeologica, pp. 333-368; nunzio To-
rassegna bibliografica
163
mAiuoli, Lucera. Il palatium di federico II, da dimora imperiale a castrum,pp. 405-446; nunzia maria mAnGiAlArdi, La fortezza di Lucera: un cantie-re tra Svevi e Angioini, attraverso un sistema integrato di fonti. Il contributoarcheologico delle ‘fonti indirette’, pp. 447-500; pasquale fAViA e robertoGoffredo, Operazioni di diagnostica archeologica a Corleto, sito di unacommenda teutonica, pp. 501-539; Austacio busTo, La domus teutonica diTorre Alemanna (Cerignola). Il contributo delle ultime ricerche archeologi-che (dicembre 2007-gennaio 2008), pp. 541-559. infine, marcello CiminAle,danilo GAllo e mariangela noViello presentano un riassunte delle speri-mentazione condotte a montecorvino e masseria pantano con delle tecnichecome la magnetometria e l’aerofotografia, Indagini non invasive finalizzateallo studio di siti medioevali in Capitanata, pp. 301-315.
le conclusioni del volume sono state affidate a due diversi specialisti,ovvero, per la parte archeologica, a paul ArTHur dell’università del salento(note archeologiche conclusive, pp. 561-566) e per la parte storica a romanCzAJA dell’università di Toruń (Considerazioni conclusive, pp. 567-569).
Herrschaft, netzwerke, Brüder des Deutschen Ordens im Mittelalter undneuzeit. Vorträge der Tagung der Internationalen Historischen Kommissionzur Erforschung des Deutschen Ordens in Marburg 2010, a cura di KlausmiliTzer, Weimar 2012 (Quellen und studien zur Geschichte des deutschenordens 72, Veröffentlichungen der internationalen Historischen Kommis-sion zur erforschung des deutschen ordens 12), 260 p., isbn 978-3-89739-741-5.
l’ultimo volume della collana Quellen und studien zur Geschichte desdeutschen ordens, edita da udo Arnold dal lontano anno 1967, contiene imateriali del convegno della Commissione internazionale degli storicidell’ordine Teutonico tenutosi a marburg an der lahn nell’autunno 2010 ededicato a due concetti abbastanza difficili da tradurre in italiano, ovveroHerrschaft, inteso nel senso weberiano di dominio o autorità su di un territo-rio e netzwerke, ovvero i reti sociali, trattandosi tutto sommato di legami tral’ordine e la società circostante e di sue modalità nell’esercitare il potere.per quanto riguarda il primo concetto, non mancano delle analogie con ilXiV convegno del ciclo di Toruń (Die ritterorden als Träger der Herr-schaft: Territorien, Grundbesitz und Kirche, a cura di roman CzAJA e Jür-gen sArnoWsKy, Toruń 2007), mentre il appena tenuto diciassettesimo con-vegno del ciclo torunense (Die ritterorden in sozialen, politischen und reli-giösen netzwerken in Mittelalter und früher neuzeit) ha affrontato precisa-mente il problema dei netzwerke. nel presente volume, Klaus miliTzer,unterschiede in der Herrschaftsauffassung und Herrschaft und Verwaltungin den Zweigen des Deutschen Ordens, pp. 1-23, presenta uno studio compa-
rassegna bibliografica
164
rativo dei rami dell’ordine Teutonico nel mediterraneo, in prussia, in livo-nia e in Germania, dal punto di vista di storia amministrativa e sociale, in unarco cronologico che va dalla fondazione dell’ordine sino all’epoca dellariforma protestante; shlomo loTAn, Governing the Teutonic Order fromOutremer- The Teutonic Headquarters Competing in the Last Era of the La-tin Kingdom of Jerusalem, pp. 25-38, concentra il suo saggio sul ruolo dellaprima casa madre dei Teutonici ad Acri che mantenne sino al 1291 la suaposizione centrale nelle strutture dell’ordine, nonostante la grande distanzageografica tra la Terra santa e i distaccamenti europei dei frati; Helge WiTT-mAnn, netzwerke und Karrieren von Thüringen im frühen Deutschen Orden,pp. 39-65, presenta la storia del personale del baliato di Turingia (prima Tu-ringia-sassia) nel Xiii secolo; bernhart JäHniG, Herrschaftsverständnis undHerrschaftsverwirklichung beim Deutschen Orden in Preußen, pp. 67-92,esamina la formazione della signoria dei Teutonici in prussia: a questo puntoè utile ricordare la recente e per molti versi simile monografia dello stessoautore sulla livonia (Verfassung und Verwaltung des Deutschen Ordens undseiner Herrschaft in Livland, berlin 2011); Johannes A. mol, Priesterbrü-der in friesland und der Ballei utrecht während des Mittelalters, pp. 93-105, presenta una ricerca prosopografica sui frati preti dell’ordine nei paesibassi. i preti teutonici sono stati nel passato molto meno studiati dei frati ca-valieri ma adesso, grazie ai lavori dei colleghi olandesi come lo stessoJohannes mol e il suo allievo rombert stapel, si dispongono delle informa-zioni molto più esaustivi sull’argomento; libor JAn, Zu den Beziehungenzwischen der Deutschordensballei Böhmen, dem Böhmenkönig und dem Ho-chadel, pp. 107-118, tratta la storia dei possedimenti teutonici in boemia emoravia da un punto di vista sia della storia diplomatica che di quella dei le-gami dei frati con la nobiltà locale; roman CzAJA, Die ritterbrüder desDeutschen Ordens und die städtische Gesellschaft in Preußen bis zur Mittedes 15. Jahrhunderts, pp. 119-132, affronta un argomento molto importanteper capire la storia della prussia medievale, ovvero i legami trasversali tra ledue principali componenti della società, l’ordine Teutonico e le città, notan-do come si sia passato da una iniziale vicinanza tra i cittadini e i Teutoniciad un progressivo allontanamento, visibile a pieno nel XV secolo; KristjanToomAspoeG, Die Behauptung des Deutschen Ordens in Italien, pp. 133-148, descrive la storia dei Teutonici nella penisola italiana, sottolineando glielementi originali del loro ramo italiano, considerato per troppo tempo una‘periferia’ dell’ordine; Juhan Kreem, Wie landfremd war der Deutsche Or-den in Livland? regionale und interregionale Beziehungen des DeutschenOrdens im 16. Jahrhundert, pp. 149-158, affronta uno dei temi cruciali dellastoria medievale dei paesi baltici, ovvero quello dell’integrazione e ruolodell’ordine Teutonico nella società, per rispondere alla domanda, se si trat-
rassegna bibliografica
165
tava di una corporazione di cavalieri e preti estranea al contesto locale o, in-vece, di una delle forze motrici della regione. Tramite lo studio degli aspettisociali della questione, l’a. arriva a sottolineare una serie di elementi di rac-cordo tra i Teutonici e la società locale; udo Arnold, Deutschmeister, Ad-ministrator des Hochmeistertums in Preussen, Hoch- und Deutschmeister,pp. 159-176, descrive i primi passi dell’ordine Teutonico nell’epoca moder-na, quando, dopo la trasformazione della prussia in un ducato laico nel1525, l’amministrazione dell’ordine fu ripresa in mano dai suoi maestri inGermania (Deutschmeistern); Jozef merTens, Adel, ritterorden und Militär-dienst am Beispiel der Ballei Biesen im 16.-18. Jahrhundert, pp. 177-204 eKarl murK, Die ritterbrüder der Ballei Hessen im 18. Jahrhundert -Herkunft, Habitus, Vernetzung, pp. 205-239, presentano studi prosopograficiesaustivi su due baliati dell’ordine, ovvero, rispettivamente, biesen (nell’at-tuale belgio) e Assia, in epoca moderna.
The Military Orders, Volume 5. Politics and Power, a cura di peter W.edbury, burlington-farnham 2012, 493 p., ill., isbn 9781409421009.
l’ultimo volume della serie military orders offre alcune comunicazionidi contenuto generale utili per la storia di tutti gli ordini militari, per sottoli-nearne uno, Karl borCHArdT, The Military-religious Orders: a Medieval‘School for Administrators’?, pp. 3-20, lancia una teoria audace ma almenoin parte condivisibile sul ruolo degli ordini nello sviluppo delle amministra-zioni pubbliche nel medioevo e Karol poleJoWsKi, The Counts of Brienneand the Military Orders in the Thirteenth Century, pp. 285-295, esamina an-che la politica favorevole della famiglia brienne al riguardo dei Teutonici.per quanto riguarda l’ordine Teutonico, si possono elencare i seguenti testi:sven eKdAl, Politics, Diplomacy and the recruitment of Mercenaries befo-re the Battle of Tannenberg, pp. 329-336, tratta le fasi della guerra tra Jagel-lone e i Teutonici prima della decisiva battaglia del 1410, con un’attenzioneparticolare agli aspetti tecnici; Kristjan ToomAspoeG, The Teutonic Order inItaly: An Example of the Diplomatic Ability of the Military Orders, pp. 273-282, studia i rapporti dei Teutonici con i diversi poteri pubblici della peniso-la italiana, tale esempio dell’abilità diplomatica degli ordini religioso-milita-ri (si veda un più ampio analisi in id., Les ordres religieux militaires et la di-plomatie. formes et enjeux, in Les relations diplomatiques au Moyen Âge.formes et enjeux, paris 2011, pp. 227-238); rombert sTApel, Power to theEducated? Priest brethen and their Education, using Data from the utrechtBailiwick of the Teutonic Order (1350-1600), pp. 337-348, presenta qui perla prima volta per il grande pubblico i risultati delle sue ricerche sui fratellipreti del baliato olandese dell’ordine (si veda, per un più ampio sintesi, ilsuo testo nel presente volume); renger e. de bruin, Hidden in the Bushes:
rassegna bibliografica
166
The Teutonic Order of the Bailiwick of utrecht in the 1780-1806 revolutio-nary Period, pp. 349-359 tratta un periodo molto particolare nella storiadell’ordine, ovvero quello delle trasformazioni provocate dalla rivoluzionefrancese, cosicché i Teutonici del baliato di utrecht erano costretti ad elabo-rare una ‘strategia di sopravvivenza.’
La mémoire des origines dans les ordres religieux-militaires au MoyenÂge-Die Erinnerung an die eigenen ursprünge in den geistlichen ritteror-den im Mittelalter, a cura di philippe Josserand e mathieu olivier, berlin2012 (Vita regularis. ordnungen und deutungen religiosen lebens im mit-telalter. Abhandlungen 51), 283 p., isbn 978-3-643-12008-3.
Gli atti del convegno tenutosi nel giugno 2009 presso la missione storicafrancese a Göttingen sulla memoria delle origini negli ordini religioso mili-tari offrono 14 comunicazioni divisi tra tre blocchi tematici: ad un primo cheserve da introduzione generica alla problematica segue un secondo, consa-crato ai testi che narrano le origini dei singoli ordini e un terzo, che riguardale forme, l’utilizzo e il contesto della memorie delle origini. si tratta senzadubbio di un problema molto rilevante che meritava ad essere evidenziato eil convegno - che ha goduto della collaborazione dei specialisti come udoArnold, Alain demurger e Jürgen sarnowsky - non ha mancato di portaredelle riflessioni innovative. il preciso argomento dell’ordine Teutonico futrattato in questa occasione da Jarosław Wenta, specialista delle fonti narra-tive dell’ordine Teutonico, attraverso una comunicazione su diversi testi chenarrano gli inizi dell’ordine e della sua presenza in prussia (Die Berichteüber die Gründung des Deutschen Ordens und seiner preußischen Provinz,pp. 83-94), seguito da un nuovo studio di udo Arnold sulla cronaca narra-tio de primordiis Ordinis Theutonici (Die narratio de primordiis OrdinisTheutonici - Der offizielle Blick des Deutschen Ordens auf seine Anfänge,pp. 95-120). la cronaca è stata redatta almeno un mezzo secolo dopo la fon-dazione dell’ordine - per udo Arnold, l’opera non può essere anterioreall’anno 1252 - e servì a giustificare e glorificare i suoi trascorsi, tale testi-monianza dell’epoca della ‘scoperta di se stessa’ dei Teutonici. Thomas Krä-mer (Der Weg zur Exemption des Deutschen Ordens im Kontext der Erinne-rung an seine ursprünge, pp. 179-197) tratta un argomento che riguardal’utilizzo della memoria delle origini nell’ambito dell’emancipazione deiTeutonici, nel Xiii secolo, con un particolare interesse per l’esonero dell’or-dine dalla giurisdizione dei vescovi diocesani. sylvain Gougenheim offreuna riflessione su uno dei documenti più importanti nella storia dell’ordine,la lettera Etsi neque di onorio iii che conferiva ai Teutonici non meno di 25privilegi e diritti diversi (La bulle etsi neque d’Honorius III (15 décembre1220) au cœur du processus de constitution de l’Ordre Teutonique, pp. 199-
rassegna bibliografica
167
225), trattando il contesto e le ragioni della sua redazione e l’utilizzo che nefu fatto dall’ordine Teutonico. Axel ehlers (Die Bedeutung des Ablasses fürdie spätmittelalterliche Erinnerung an die urpsrünge des Deutschen Ordensund anderer Gemeinschaften, pp. 227-236) parla del legame tra le indulgen-ze e la memoria delle origini, legame che funzionava attraverso le raccolted’indulgenze, redatte dai Teutonici. Annika souhr (“Von jeher fredeschiltder Christenheit”. rückgriffe auf die eigenen ursprünge im auswärtigenSchriftverkehr des Deutschen Ordens in Krisenzeiten, pp. 237-268) analizzal’utilizzo dell’argomentazione storica da parte dei Teutonici nella loro retori-ca politica nel corso delle difficoltà subite dall’ordine nel XV secolo.All’ordine Teutonico sono dunque stati dedicati molti lavori del convegno,il che risulta anche dalle conclusioni scritte da mathieu olivier (Mémoirecommune des origines ou mémoire des origines communes?, pp. 269-282).senza perdersi eccessivamente nelle vie dell’astrazione, il volume illustra ilprocesso della ‘fabbricazione’ della propria storia, intrapresa da tutti gli or-dini religioso militari e l’uso fatto dal passato a servizio del presente. Alcuniaspetti del processo, prima di tutto le falsificazioni dei documenti intrapresidagli ordini militari a difesa dei loro interessi, potevano sicuramente avereun maggior rilievo, ma, tutto sommato, trattasi di un’impresa scientifica ededitoriale molto ben riuscita.
l’anno 2012 è stato ricco di saggi e monografie sulla storia degli ordinimilitari, compresi i Teutonici, che, adesso, non si possono elencare, perchésarebbe inevitabile trascurare alcune opere difficilmente accessibili a benefi-cio delle altre. inciterei gli autori, di qualsiasi regione o lingua siano, di in-viare al nostro centro copie dei loro lavori che saranno prontamente recensi-ti, in questa o altra sede.
due ultime segnalazioni riguardano le pubblicazioni periodiche. per pri-mo, vorrei presentare l’iniziativa lanciata dai colleghi dell’università fede-rale baltica di immanuel Kant di Kaliningrado, nella federazione russa, ov-vero la nuova rivista «studia Teutonica» (Исследования по историинемецкого ордена, isbn 978-5-9971-0211-1, manca ancora il numero is-sn). Questa impresa - che si inserisce a mio avviso perfettamente al proces-so di rinascita dell’antica Albertina - si materializza con un volume interes-sante che contiene una serie di saggi scritti dagli esponenti della nuova sto-riografia russa (evgeny eremin, Anatoly bachtin, Andrey Konoplenko, ma-rina bessudnova, dmitry Weber, Anon Kotov, ilya dementjev, Anna le-bedkina e altri) su problematiche di storia generale dell’ordine Teutonico.Credo che sentiremo ancora parlare di molti degli autori del volume, in ognicaso, la storia dei Teutonici sembra in russia ormai liberata da ogni demo-nizzazione politica.
rassegna bibliografica
168
infine, last but not least, segnalo il cambiamento di forma delle pubblica-zioni regolari dell’università niccolò Copernico di Toruń, «ordines milita-res», che da collana editoriale dedita alla stampa degli atti dei periodici con-vegni sugli ordini religioso-militari tenuti a questa sede dall’anno 1981(«ordines militares. Colloquia Torunensia Historica») sono diventate una ri-vista storica, pubblicata con una cadenza annuale (issn 0867-2008). lanuova rivista accoglie non solo gli atti dei convegni torunensi, ma anche al-tri saggi, su tutte le tematiche riguardanti la storia degli ordini, come si puònotare nell’ultimo volume appena uscito dalle stampe, «ordines militares»XViii (2013), con 14 saggi di qui 11 sono all’origine delle comunicazionilette durante il sedicesimo convegno del ciclo (2011). Grazie a questa inizia-tiva, possediamo per la prima volta, dopo l’esperienza di «sacra militia»,pubblicata da franco Cardini e francesco Tommasi dal 2000 al 2002, una ri-vista internazionale a servizio degli studiosi degli ordini religioso-militari (ilcorrispettivo spagnolo, «revista de las ordenes militares» si è finora limita-to con la penisola iberica).
rassegna bibliografica
169
171
Centro interdipartimentale di ricerca sull’ordine Teutoniconel mediterraneo (CiroTm)
Acta Theutonica
Collana diretta da Hubert Houben
1. l’ordine Teutonico nel mediterraneo. Atti del Convegno internazionale di studio, TorreAlemanna (Cerignola) – mesagne – lecce, 16-18 ottobre 2003, a cura di Hubert Houben,2004.
2. la contabilità delle Case dell’ordine Teutonico in puglia e in sicilia nel Quattrocento, acura di Kristjan Toomaspoeg, 2005.
3. san leonardo di siponto: cella monastica, canonica, domus Theutonicorum. Atti del Con-vegno internazionale di studio, manfredonia, 18-19 marzo 2005, a cura di Hubert Hou-ben, 2006.
4. i Cavalieri teutonici tra sicilia e mediterraneo. Atti del Convegno internazionale di stu-dio, Agrigento, 24-25 marzo 2006, a cura di Antonino Giuffrida, Hubert Houben e Kri-stjan Toomaspoeg, 2007.
5. l’ordine Teutonico tra mediterraneo e baltico: incontri e scontri tra religioni, popoli eculture. der deutsche orden zwischen mittelmeerraum und baltikum. begegnungen undKonfrontationen zwischen religionen, Völkern und Kulturen. Atti del Convegno interna-zionale (bari-lecce-brindisi, 14-16 settembre 2006), a cura di Hubert Houben e KristjanToomaspoeg, 2008.
6. l’inventario dell’archivio di s. leonardo di siponto (ms. brindisi, bibl. de leo b 61):una fonte per la storia dell’ordine Teutonico in puglia, a cura di Hubert Houben e Valen-tina pascazio, 2010.
7. federico ii e i cavalieri teutonici in Capitanata. recenti ricerche storiche e archeologiche.Atti del Convegno internazionale (foggia-lucera-pietramontecorvino, 10-13 giugno2009), a cura di pasquale favia, Hubert Houben e Kristjan Toomaspoeg, 2012.
8. mariella intini, «offero me et mea». oblazioni e associazioni all’ordine Teutonico nelbaliato di puglia fra Xiii e XV secolo, 2012.
9. francesco filotico, le origini del baliato teutonico «nell’Adige e tra i monti», in corso distampa.
10. Analecta Theutonica. studies for the History of the Teutonic order. mélanges pour l’hi-stoire de l’ordre Teutonique. studien zur Geschichte des deutschen ordens. miscellaneadi studi per la storia dell’ordine Teutonico, 1, 2014.