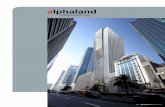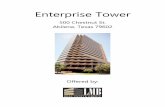La Torre dei d’Adda in Olginate // The D'Adda tower in Olginate
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of La Torre dei d’Adda in Olginate // The D'Adda tower in Olginate
Giovanni Aldeghi - Gianluigi Riva
LA TORRE DEI D’ADDA IN OLGINATE
The d’Adda tower in Olginate
REV. N° 1 – 13/11/2016
Giovanni Aldeghi - Gianluigi Riva
LA TORRE DEI D’ADDA IN OLGINATE
Ancora oggi gli Olginatesi, per indicare la zona di Olginate dove sorge villa Sirtori dicono “a la törr”, a dimostrazione di come questa dimora fortificata, costruita alla metà del XV secolo, sia stata un punto di riferimento ed ha contrassegnato nei secoli la storia del paese. Nata per ospitare una ragguardevole famiglia del paese, quella di Galeazzo Crotti, in seguito divenne anche presidio di difesa e sorveglianza lungo un confine, quello con la Repubblica di Venezia, dal quale venivano i maggiori pericoli alla integrità territoriale del Ducato di Milano. A partire dal XIV secolo, i paesi posti lungo il medio corso dell’Adda conobbero, a causa delle lotte tra Guelfi e Ghibellini, prima, e delle guerre tra il Ducato di Milano e la Repubblica di Venezia poi, una sempre crescente militarizzazione del loro territorio. Si costruirono nuove fortificazioni, mentre quelle già esistenti vennero ampliate e rese più rispondenti alle esigenze dei nuovi strateghi. Dove non intervennero le autorità ducali, furono le famiglie più importanti e facoltose a dotare il territorio di piccole ma capillari opere di difesa, il cui scopo principale era quello, in caso di necessità, di poter mettere in salvo in un luogo sicuro la famiglia e gli averi.1 Sorprende non poco la mancanza in Olginate, dove il letto dell’Adda si restringe in modo tale da rendere facile la messa in opera di ponti di barche tra le due sponde, di fortificazioni ducali come quelle esistenti a Brivio, in modo da impedire e respingere un eventuale attacco da parte nemica, specialmente a partire dall’epoca della conquista veneta della antistante Valle S. Martino. Probabilmente fu una scelta imposta dalla particolare strategia viscontea e poi sforzesca messa in atto su questo tratto dell’Adda che prevedeva, in caso di attacco nemico, l’intervento di una forza locale costituita dalle cosiddette “guardie del fiume” citate da Bernardino Corio nella sua "Historia Patria". Era una specie di forza di pronto intervento formata dagli abitanti dei paesi del Monte di Brianza, ghibellini fedelissimi ai loro signori milanesi. Queste “guardie”, nel marzo del 1418, furono decisive per la vittoria del comandante visconteo Francesco da Bussone detto il Carmagnola contro le milizie comandate da Pandolfo Malatesta che tentavano di attraversare l’Adda davanti ad Olginate. In questo scontro il Malatesta perse circa 400 uomini, fra uccisi e feriti in combattimento ed affogati nell’Adda.2 Durante il periodo sforzesco le “guardie del fiume” vigilarono continuamente la frontiera con Venezia delimitata dall’Adda. Ogni paese, a turno, mandava anziani e ragazzi in posti predisposti sulle colline da dove si poteva osservare ogni movimento nella antistante Val San Martino e, quando veniva loro richiesto, intervenivano in armi a sostegno delle truppe regolari. Ne fa testo una lettera inviata al Duca di Milano il 19 maggio 1482 dal Capitano della Martesana, Giovanni Rolando da Sommo, con cui lo informava che:
“…Et ho dato ordine che dominicha proxima che vene, mi ritrovo nel loco de Merate, Olginate et Uglono, che cadauna loro Plebe, haverà conducto lì la taxa loro de li homini al numero suprascripto, quali anotarò anome per nome. Et che bisognandomi più sono apparegiati ad farlo, dicendo che Vostra Excellentia se ripossa sopra de loro, che intrevengha ciò che voglia, si sentano sufficienti ala defesa, et bisognando, etiam di offendere li inimici di quella …”3
Tuttavia succedeva che in tempo di pace, sentendosi meno minacciati da eventuali invasioni, questi paesi badavano principalmente ai loro interessi e quindi cercavano di risparmiare sulle spese relative a queste vedette, che dovevano essere pagate, mandando a questo scopo ragazzi e “mentecapti”. Di questa situazione si lamentava, all’inizio del 1484, “Rolandus de Summo Capitaneo Martesane”, che utilizzava queste vedette anche per controllare il contrabbando che si faceva attraverso l’Adda:
“…Ulterius la Vostra Signoria sa como per altre mie ho scripto a quela, che le guardie che se fano qua in dreto a Abdua nò si fano con modo cauto ne ancora gli è mandato homini ma puti et mentecapti li quali quando accadesse alcuna cossa o fugirano o vero resteranno como bestie, in modo nò solum saria damno de tali guardie ma ancora poteria sucedere magior a ala Vostra Signoria e ali subditi di quela. La qualcossa considerando io de farli provixione mhe parso fare intender a quella che io vedarò de havere cinquanta homini, presi de questo paexe, et farò che questo Montebrianza li pagaria, li quali farano tute le guardie dreto a
questo fiume de Abdua e saranno homini et nò si poterà dubitar questo paexe, et loro piutosto se aconterano di pagar tali homini che farano quatro o sey milia la sera per far guardia”.4
Tuttavia qualche dubbio sulla necessità di avere una ben protetta fortificazione anche in Olginate rimaneva e periodicamente i Commissari ducali ivi stanziati sollecitavano la Segreteria ducale a provvedere per difendere più concretamente l’abitato temendo che, nel caso il paese fosse caduto in mano veneta, venisse trasformato in una fortezza quasi inespugnabile, perché il terreno si prestava a farlo circondare tutto dal fiume. Questo timore chiaramente lo evidenziava, nel 1470, il Commissario ducale nel Monte di Brianza, Dombello de Ricardis:
“... al apparere mio accadendo che Venetiani pasasseno lì dove feceno altre volte, et pigliasseno quela rocheta et torre, et che butasseno uno ponte lì, che Adda è stricta, et circondasseno quella terra de Olginate, con uno ramo Dada, che se porebe fare, farebeno lì a modo de una citadella, che nò lasserebeno troppo in pressa, me parso per mio debito ricordarlo a Vostra Signoria. Questo importarebe più accadendo che nò farebe Brippio, da laltro canto de Adda gliè Vale de Sanctomartino, gliè solamente Adda in mezo, le terre marchesche sono propinque ad Olginate manco de due balestrate …”5
Le fortificazioni dell’abitato Nel XIV secolo Olginate era un agglomerato urbano piccolo ma molto compatto le cui linee essenziali sono tuttora visibili nella struttura del vecchio nucleo in quanto si può intravedere un impianto a isolati perpendicolari al fiume precedenti alla costruzione della chiesa di Santa Margherita. In questo contesto l’attuale via Barozzi doveva essere quella che collegava il villaggio con la via maestra proveniente da Milano, che correva a monte dell’abitato. Questo schema urbano, tipico dei paesi rivieraschi e di pesca era probabilmente protetto da una linea di fortificazioni, di cui si trovano richiami in alcuni toponimi contenuti in atti notarili che partendo dalla riva dell’Adda seguiva il corso del torrente Aspide arrivando fino alla località di Gambate, situata a metà collina chiamata anticamente “Gambalo seu in Seraliis”, cioè luogo sbarrato, sprangato.6 In un documento del 1383 si cita una di queste fortificazioni nominando un terreno detto "ad fossatum"7; nel
1416 è citata una "portam novam"8, forse un passaggio, ricavato nel terrapieno che difendeva l’accesso alla “bastia”, come era nominata la grande arcata, ora nel giardino di villa Elena e prossima alla diga di regolazione del lago di Como e che, probabilmente, ingloba la testata sinistra dell'antico ponte romano. Documenti di varie epoche fanno riferimento a questo difensivo eretto, probabilmente, dopo la distruzione del ponte, per contrastare e bloccare un eventuale tentativo nemico di attraversare l'Adda. Anche ampie porzioni di terreni circostanti a questa costruzione sono identificati, nel 14839, come “alla Bastia”; alla "Gueia overo Bastia” nel 157710; ed ancora, nel 1914, “alla Bastia”.11
Tutte queste opere difensive erano situate nella zona dell’abitato confinante con il territorio del vicino borgo di Garlate e risalgano, forse, al tempo delle guerre gotiche-bizantine o anche prima e probabilmente servivano a difendere l’importante, a quel tempo, villaggio e l’attraversamento del fiume. A questo proposito esiste una leggenda che vuole che Olginate sia stata fondata da un capitano goto di nome “Olgina” che vi costruì un castello a difesa e guardia del passaggio del fiume.12 Cessata la sua funzione, questa “bastia” ha poi subito, nei secoli, numerosi cambiamenti del suo utilizzo. Inizialmente ha ospitato un mulino da grano a due ruote caduto in disuso già nella prima metà del 1500.13
Poi sulla sua sommità venne ricavato un orto o giardinetto14 che rimarrà tale fino alla metà del 1700, quando sull‘arcata verrà costruita una palazzina panoramica per l’abbellimento del parco del palazzo dei
La pseudo arcata del ponte di epoca romana
signori Testori de Capitani.15 In seguito, verso la metà del 1800, l’arcata venne poi usata come sostegno ad un piccolo filatoio da seta che funzionò fine alla fine del secolo. Oggi, ripulita da tutte le infrastrutture aggiunte nel corso dei secoli, fa bella mostra di sé nel parco di villa Elena ed è considerata dagli storici una “pseudo arcata del ponte di epoca romana”.
Le case-torri
Nell’alto medioevo in Olginate le famiglie più autorevoli vivevano raggruppate in parti differenti dell’abitato. Il casato dei Crotti, a cui apparteneva Galeazzo il costruttore della casa-torre poi passata ai d’Adda, occupava il versante settentrionale del paese, quello probabilmente formante il primo nucleo dell’abitato. I d’Adda occupavano il quartiere attorno alla chiesa di S. Margherita e i Lavelli de Capitani, probabilmente di più recente stanziamento, l’estesa zona a sud del paese, fuori dall’antico nucleo abitativo. A monte, nella zona dove verrà poi costruita la chiesa parrocchiale di San Agnese, avevano la loro casa i Capitani della Beretta probabilmente provenienti dalla bergamasca Valle Beretta o Bretta all’epoca delle cruente dissociazioni tra guelfi e ghibellini. Questa suddivisione in quartieri era tipica delle città e borghi altomedievali. Naturalmente, come in ogni abitato del tempo, ogni casata aveva la sua casa-torre di cui una sola è ancora oggi integra, quella dei d’Adda situata in piazza Garibaldi. Di altre rimangono i resti e la documentazione della loro esistenza. Una di queste casa-torre, situata sul lato nord dell’abitato in fondo all’attuale via Barozzi, identificata come “caminata” per la presenza staanze munite di camino, apparteneva a Stefano Crotti.16 Oggi si presenta troncata e adattata a comune abitazione: solo una pietra angolare che reca incisa la scritta “A.D. 1406” ci ricorda la sua origine. Nell’antica piazza, ora intitolata a Giuseppe Garibaldi, ed un tempo detta del “Porto” e “Santa Margherita”, è
ancora in piedi la torre che faceva parte del complesso altomedioevale appartenuto ai d'Adda, e in seguito, a partire dal secolo XVII, acquisita
dai Lavelli de Capitani: dei quattro piani tuttora esistenti, l'ultimo è stato certamente aggiunto in epoca posteriore, forse nel 1499, insieme alla vicina torre della Comunità. Nella stessa piazza vi era, infatti, la torre della Comunità, la cui costruzione si può anch’essa far risalire all’alto medioevo: posta sulla sponda
dell’Adda veniva a trovarsi proprio dietro l’abside dell’antica chiesa di S. Margherita, per cui in molti documenti viene impropriamente citata come il campanile della stessa. In realtà la chiesa aveva anch’essa la propria campanella collocata su un pilastrello posto sulla facciata. Venne rialzata di circa 2 metri e mezzo nell’aprile del 1499 a spese della Comunità, in vista dell’imminente guerra con i veneti alleati coi francesi (all'epoca gli ingegneri militari non trovarono di meglio, per
contrastare la crescente potenza delle artiglierie, che elevare le mura delle fortificazioni dato che i cannoni
La torre di piazza Garibaldi
Parte della casa di Stefano Crotti in
fondo a via Barozzi
Pietra angolare con la data “1406”
non riuscivano a scagliare le palle di pietra oltre una certa altezza)17. In quell’occasione si decise anche di multare di 4 ducati d’oro le persone che, abusivamente, usavano la campana posta sulla sua sommità per segnalare funerali e altre funzioni tenute nella chiesa conventuale di S. Maria la Vite.18
La torre era dotata di una campana e, a partire dal secolo XVI, valorizzata da un orologio. In epoca antica accanto ad essa si tenevano le assemblee della comunità poiché il luogo era anche detto “alla maiola”.19 Purtroppo, per la sua ubicazione sulla riva del fiume, già nella seconda metà del 1500 veniva periodicamente invasa dalle acque dell’Adda, come succedeva alla
contigua chiesa di S. Margherita, il cui corso col passare dei secoli si era gradatamente spostato verso la riva milanese; diverse case private che le sorgevano accanto, non avendo solide fondamenta, finirono inghiottite dal fiume.20 Malgrado questo increscioso inconveniente venne usata per tutto il 1600 e oltre come torre di avvistamento e di guardia contro le bande dei malviventi che infestavano la zona.21 Questa torre, immagine dell’Olginate medioevale, venne abbattuta nel 1784, assieme alla contigua antica chiesa di S. Margherita, per ricavare una più ampia piazza ad uso dei traffici commerciali che confluivano al vicino traghetto.22 L’orologio pubblico era già stato tolto e collocato, nell’ottobre 1764, sul campanile della chiesa di S. Agnese.23
La “Törr” Ultima, in ordine di costruzione, vi era un’altra e più importante casa-torre, i cui resti sono oggi inglobati nella Villa Sirtori. Situata appena fuori dal limite meridionale dell’antico nucleo abitativo di Olginate, in riva al fiume Adda, laddove quest’ultimo si allarga per formare il lago di Olginate, su di un’area detta “in Quarnario”.24 Questa costruzione, identificata spesso in antichi documenti come “Torre”, “Castello”, oppure "Rocca”, divenne nella seconda metà del 1400 la fortificazione più importante del borgo perchè permetteva di controllare uno dei punti caldi del confine con lo Stato veneto: il "passo” di Olginate e il suo “porto”, ossia il traghetto che dava la possibilità a persone e merci di attraversare comodamente l'Adda. La già citata lettera scritta nel 1470 dal Commissario ducale nel Monte di Brianza, Dombello de Ricardis, accenna all’epoca e alla famiglia che la fece costruire:
“...ancora avviso dago a Vostra Signoria comme sopra Adda in Olginate gliè la rocheta et torre del spectabile domino Galeaz Croto sempre stato et è fidelissimo per experienta a Vostra Signoria ed a questo stato, et persona honorevelle, che luy ha facto hedificare con licentia però aut credo de la bona memoria del signore quondam vostro patre…”25
Questo importante documento ci conferma che questa “Casa-Torre” fu fatta costruire dal mercante Galeazzo Crotti tra il 1454 ed il 1466 con il dovuto permesso del duca Francesco I Sforza e dissolve i vari fantasiosi racconti che a partire dal 1600 descrivono questa fortificazione come la “culla” della stirpe dei d’Adda, scambiandola con quella, ancora oggi esistente, in piazza Garibaldi; la prima e antichissima dimora dei d’Adda. Fra tutti, Antonio M. Venusti che nel suo: “Discorso generale intorno alla generatione, al Nascimento degli huomini”,
Portale di casa in fondo a Via Barozzi
Via Barozzi (in fondo): particolare
stampato a Venezia nel 1562, parlando delle origini della potente famiglia d'Adda, affermava che "la Torre di Olginate antica e forte, posta a cavaliere dell'Adda, può far chiaro l’antichità e la grandezza della famiglia”. Questo equivoco durerà nel tempo anche perché molti documenti parlando della “Torre dei D’Adda” non specificano la sua esatta collocazione nel contesto urbano. È comunque certo che a partire dalla fine del 1400 in Olginate esistevano due case-torri abitate dai d’Adda, quella in piazza Garibaldi e quella chiamata la "Törr”, ora conosciuta come Villa Sirtori.
I Crotti I Crotti furono una delle più importanti e conosciute famiglie mercantili di Olginate tra i secoli XII e XV: nel 1209 un Jacobus Croto figura come debitore verso il nobile Arderico de Vicomercato de Lavello26; nella seconda metà del 1300 un Stefano Crotti è notaio27; alla sua morte, avvenuta alla fine del secolo, il figlio Gotardo gli successe in questa attività.28 Di Stefano, figlio di Gotardo, conosciamo che era fabbricante e mercante di pannilana, tanto è vero che nel febbraio del 1439 questo Stefano paga ai Consoli dei Mercanti della città di Monza le tasse relative ai suoi commerci con quella terra “Pro introytu mercantie et exercitio et fabricatione draporum lane in dicta terra Modoetie”.29 A lui e suoi familiari viene confermata, dal duca Filippo Maria Visconti nel 1440, la cittadinanza comasca concessagli dai Deputati dell'Ufficio di Provvisione di Como.30
Da documenti coevi risulta che nei decenni seguenti i Crotti, a saldo di molti crediti vantati con compaesani e abitanti nei dintorni, aggiunsero alle loro proprietà terreni e case. Ma è con Galeazzo che raggiunsero l’apice della loro potenza economica e politica in paese. Il commercio e il particolare rapporto che aveva con la Corte ducale favorirono certamente la sua ascesa. Nel 1450 gli viene concesso il permesso di tagliare “legname minuto da focho per suo uso” nei boschi che possedeva a Cusago.31 A Cusago vi era il Castello Visconteo, circondato da boschi, costruito dai Visconti e poi utilizzato, fino all’inizio del XVI secolo, dagli Sforza. Nel marzo 1458 viene concesso a Galeazzo Crotti un salvacondotto da parte della Duchessa Bianca Maria Visconti-Sforza per condurre o di far condurre “biade” da Lodi in Olginate.32
Ottimi sono anche i suoi rapporti con il potente segretario ducale Cicco Simonetta, che lo ringrazia per la sua preziosa opera di informazione sulle novità e sui movimenti nemici nella confinante Val San Martino, augurandosi che questa eccellente collaborazione sia continuata anche in futuro, come in effetti avverrà, a beneficio del Ducato:
“Galeaz crotto in olzinate. Gasparro sancto (commissario ducale in Olginate – ndr), quale è venuto da nuy, ne ha avisato et dicto molto largamente della sincera fede, et dispositione toa verso nuy, et quanto sey caldo et fervente in tutte quelle cose che possono retornare a bene del stato nostro et tranquilità et salute de quelle parte. Pertanto rengraciandote de questo bono animo et dispositione toa, quale havimo intesa molto voluntera, ben che non ne sia nova, perché lhavimo intesa et cognosciuta anchora per lo passato, te confortiamo et caricamo che vogli perseverare in essa dispositione, et fare como hay facto fina qui, et como siamo certissimi faray per lavenire in beneficio del stato nostro et de quelle parte. C.”33
A Galeazzo Crotti si ricorre anche in caso di necessità belliche: tra il 1452 ed il 1454 in Valsassina si scontrarono i Ducali milanesi ed i Veneziani, che tentavano di sfondare le linee ducali per raggiungere e controllare il lago. Nonostante le difese, approntate con difficoltà in Valsassina e lungo la Riviera tra Varenna e Bellano, i Veneziani, il 14 dicembre 1452, riuscirono, ma per poco tempo, ad occupare la Muggiasca. II 21 dicembre, da Lecco, il Commissario ducale Giovanni Galeazzo da Ligurni, dopo che il comandante delle truppe venete, il conte Orso, ha raggiunto la Valsassina passando senza opposizione alcuna a monte di Lecco (all’epoca i vari paesi all’esterno del borgo fortificato, il cosiddetto “Lecco estrinseco”,34 erano favorevoli a Venezia), teme che i Veneziani stiano per attaccare la “Riviera del lago” e chiede immediati soccorsi.
Infatti il 23 gennaio 1453 il Ligurni avvisa la Cancelleria milanese che non partirà da Lecco perché ha saputo da Galeazzo Crotti che gli abitanti dei paesi fuori dal borgo di Lecco stanno trattando coi Veneziani e si aspetta un attacco al borgo:
“Insuper aviso la Vostra S. como me saria ritrovato de la su, e cossi me era misso in ordine per andarli, ma hebe notitia como essi inimici hanno lassato, da Balabio in qua, de molti fanti et cavali per guarda del passo, da laltra parte ho havuto aviso da Gasparro Santo comissario in Ulzina. E cossì hanno havuto questi homini da Galeazo crotto da Ulzina como del certo, inimici hanno tractato in questa terra. Il che etiam ne suto refirmato per Antonello de realino, Si che per questi casoni non me sono voluto partire de qui. E sto attentissimo e dì et nocte ad havere la mente per tucto, aciò la non me fosse callata.”.35
L’impossibilità di inviare solleciti rinforzi in Valsassina portarono a una sconfitta delle truppe ducali.36 Nel maggio 1453 Galeazzo de Crotti fa anche da intermediario per far sì che cessino le “froxe” in Olginate a danno dell’erario ducale: è il Capitano della Martesana,Paolo Amiconi, a tenere i contatti con il Duca per aggiornarlo delle trattative da lui avviate con il suo permesso: “Ad questa hora ho recevuto le vostre lettere date a Milano a XVIJ instantis mensis In effectu continentis, che io subito advisa Vostra Excellentia dele compositione ho fato cum quili da Ulzina, et scharischa Vostra Signoria in que termino son romasto cum loro, et prout latius fano mentione epse vostre lettere.” Questo accordo da stipulare era la conseguenza del fatto che “Galeazo Croto voleva componere undexe de quili homini froxatori da Ulzinà cum nuy per ducati XXXIIJ doro (…) Et se voleva luy obligare che più non froxareveno ne cometareveno cossa alchuna contra il stato vostro.” Ma l’Amicone doveva rammaricarsi perchè Galeazzo Crotti, nonostante le promesse, non si era presentato davanti a Giovanni Francesco del Mangano37 per concludere l’accordo, giustificandosi con puerili scusanti come: “li inimici voglieno vargare Adda, quod minime verum erat, modo chel non ha cavalo.” Per metterlo con le spalle al muro, l’Amiconi è disposto ad avvicinarsi ad Olginate, per vedere “sel me poterà venire ad favelare”. Ma questo ambiguo comportamento del Crotti è dettato dal fatto che egli sa dell’opposizione a questo accordo da parte del potente Pagano d’Adda e che “essi froxatori” non vogliono “stare ad la compositione tractata per nuy, salvo se Pagano Dada cum li soy adherenti vegnieno ad compositione. Et che niente se fa sel dicto Pagano cum li suoy non promettano et satisdaghano de più non froxare.” Alla fine, Giovanni Francesco del Mangano e Paolo Amiconi, vedendosi “beffati”, si videro costretti ad emanare “uno comandamento penale al dicto Galeazo Croto, ad laparente Dada, messere Bernardo Dada, Apolonio da Lavelo, ad Georgio da Mandello, et atanti altri che ascendono al numero de dodexe deli meliori del dicto loco da Ulzina quali deliberamo omnino se consegniano da nuy, et ne satisdagheno idonee de non lassare froxare ne contrafare al stato vostro in la dicta terra da Ulzina, et de darme ayuto et favore contra li delinquenti et de lassare fare lofficio in la dicta terra, quod minime facere volunt. Et casu quo non vogliano comparire, como certo sono non comparerano, deliberemo omnino de condenarli, et de mandare le condenatione ad la vostra ducal Camera.” Inoltre Paolo Amiconi, per contrastare le “froxe” e “vivendo loro in tanta deshobedientia et inhonestà como vivono”, decideva di spostare ad Olginate i soldati di Achille et Restorello Corsio “per obviare provedere et meglio punire li froxatori circonstanti et dicti da Ulzina.”38 Questo tentativo di contrastare il contrabbando attraverso un accordo con gli Olginatesi durò a lungo, con promesse di questi ultimi mai mantenute. Le autorità ducali usarono, oltre al “bastone”, anche “la carota” per portare a ragione i capi dei contrabbandieri olginatesi e concludere la vicenda: ma nemmeno le lettere scritte dalla “Illustrissima domina domina Madona nostra et Consorte vostra” ai principali capi “de questi froxatori”, che ad Olginate erano soprattutto i d’Adda,39 affinchè si presentino “denanze al Vostro Magnifico Ducal Conseglio Secreto, qual ha a conferire cum loro,”, ottennero risultato, anzi, “imo se rideno”. Questo sfrontato atteggiamento fa sì che l’indignato Paolo Amiconi si spinga a proporre di “andare ad le loro case et impicharne quatro per terra de li più tristi de questi duy lochi.”40 Alla fine non si fece nulla e il contrabbando continuò: a tutti stava bene così! I servigi alla Corte Ducale di Galeazzo Crotti continuarono anche dopo la “Pace di Lodi” quando, avvalendosi dei buoni rapporti che intratteneva con i mercanti della Valle San Martino e della sua vasta rete commerciale estesa nel Bergamasco, egli riesce ad ottenere notizie di prima mano sui movimenti delle
truppe veneziane nella Valle, facendole pervenire alla segreteria ducale per le decisioni del caso.41 Il prestigio da lui goduto nel Monte di Brianza era grande: ancora nel novembre 1461 Gaspare de Regio, Commissario ducale in Galbiate, si reca ad Olginate per “far honore ad Galeaz Crotto”, in occasione del matrimonio di una sua figlia con un membro della famiglia Lacanale, la più in vista di Civate e del territorio circostante.42
Anche se qualche volta le sue informazioni furono esageratamente allarmistiche, come nel gennaio 1462 quando seminò il panico tra gli abitanti di Lecco con la notizia di un prossimo attacco veneziano al borgo, incassando poi dal segretario ducale Cicco Simonetta una severa reprimenda,43 le autorità ducali tennero sempre in grande considerazione Galeazzo Crotti, passando sopra ad eventuali peccatucci che pur sempre egli aveva, quali la partecipazione al fiorente contrabbando di granaglie con i Veneziani o la propensione per la giustizia fatta in proprio che poteva essere di danno ai precari equilibri diplomatici tra Ducato di Milano e la Repubblica di Venezia. Nell’ottobre del 1450, il Duca Francesco Sforza, piccato, si prese il disturbo di sottoscrivere, di proprio pugno, una lettera a Galeazzo Crotti: “Et per che sì ben chiaro che questa sia la mente et intentione nostra, havimo soctoscripta la presente de nostra propria mano, sichè non gli fare alcuna replicatione ne dimora”. Ma che cosa aveva fatto Galeazzo Crotti di così grave da rendere così adirato il Duca? Qualche giorno prima Galeazzo Crotti aveva “tolta certa robba ad Paulello della Rocha, subdito dela illustra signoria de Venexia,” come pegno per “dela robba vostra diceti esservi stata retenuta in Valle S. Martino”. Non aveva pensato alle conseguenze, il buon Galeazzo: chi si era visto sequestrare la mercanzia, non aveva esitato ad avvisare dell’ingiustizia subita i Rettori di Bergamo che subito avevano contattato il “proveditore miser Iacomo Antonio Marcello” per risolvere la faccenda che poteva trasformarsi in un incidente con più gravi conseguenze. La decisione del Duca non poteva che essere una: costringere Galeazzo a restituire il maltorto e chiedere scusa alle autorità bergamasche per risolvere amichevolmente la vicenda. Infatti a Galeazzo Crotti viene imposto “che, recevuta questa, liberamente debbi restituire ogni cosa aldicto Paulello interamente et senza exceptione ne contradictione alcuna, et non manchi per quanto hai cara la gratia nostra.” In un secondo momento, dopo “che havirai facto tale restitutione, volimo vadi dali rectori de Bergamo, ali quali scrivimo per l’aligata che vi fazano restituire la robba vostra: non dubitamo siandove stato facto iniustitia, che la revocaranno et avisane del recepimento de questa et dela restitutione de dicta robba.”44 Tenendo fede alla promessa, il Duca scrisse ai Rettori di Bergamo, difendendo Galeazzo che si era ritenuto derubato della sua merce: “…haverla facta per rispecto dela robba soa, qual dice essergli stata sostenuta contra rasone in Valle San Martino, tamen è stato facto contra nostra voluntà et saputa”, ma nello stesso tempo conferma che ha “commandato et ordinato al dicto Galeazo che immediate senza alcuna dilatione restituisca dicta robba a Paulello et cossì non dubitamo ch'el faza", ma nello stesso tempo prega i Rettori di Bergamo che provvedano “ch'el dicto rehabia la sua robba et, quando accadesse alcuna simile cosa ve piaza de avisarme” assicurando che così potrà provvedere a “corregere li errori”, in altre parole a tirare le orecchie a chi, con il suo comportamento, poteva mettere a rischio la tranquillità di un confine a cui il Duca teneva tanto.45 La costruzione della sua casa-forte, in tempi in cui solo il favore del Duca poteva permettere simili edificazioni, ci fa comprendere quanto fosse caro e benvoluto dallo Sforza, forse anche per la fedeltà e i servigi da lui forniti durante i difficili anni della conquista del Ducato milanese. Svolse anche la funzione di portavoce degli Olginatesi, il cui zelo e la cui fedeltà al Duca di Milano erano pari al desiderio di prevenire ed evitare l’attacco ed il saccheggio del paese da parte delle truppe veneziane provenienti dalla vicina Valle San Martino. A riprova del reputazione che godeva presso la corte ducale e in Olginate alla morte del Duca Francesco I Sforza, avvenuta nel marzo 1466, Galeazzo è il primo firmatario, dopo il Commissario del Monte di Brianza e precedendo i d’Adda, di una lettera di condoglianze alla vedova Bianca Maria Visconti, nella quale si manifesta la devozione degli olginatesi alla causa sforzesca:
“…Como se sia nuy sempre saremo schiavi et fedeli servitori de la Illustrissima Signoria vostra de li Illustrissimi Soy fioli como siamo stati per il pasato, et quello che possiamo, le persone la vita e la robba la offerissemo alla
Illustrissima Signoria vostra et sempre per quella e per il Stato suo le vogliamo abondantemente exponere ...”46 (vedi doc. 1)
I d’Adda Il casato dei d’Adda lo si trova già citato in Olginate in un atto del 1222: “Zoanardus filius quondam Michaelis de Abdua de loco Ulzinate”. I suoi figli Ugone, Giovanni, Michele, Leone e Salamisio, nel 1281, sono coinvolti in una controversia con Filippo Benaglio riguardante la grande gueglia situata accanto alle rovine dell’antico ponte, di fronte al villaggio bergamasco di Cremellina; questa gueglia sarà poi, per secoli, proprietà della famiglia d’Adda.47
Verso la fine del secolo un Giraldo de Adua è il console del paese. Nel gennaio del 1398 Carlino figlio del fu ser Antonio d’Adda, riceve 9 lire imp. quale rimborso spese per aver comandato e poi pagato i 75 uomini del Monte di Brianza che nell’agosto 1397 parteciparano alla spedizione del duca Gian Galeazzo Visconti contro Mantova.48 Un altro d’Adda, Lanfranco detto Pizeto, è il ghibellino olginatese che muore nello scontro con i guelfi avvenuto nel 1389 al “campo serese”, situato sulla sponda sinistra dell’Adda in comune di Vercurago. Nell’aprile del 1449, i Capitani e Difensori della Repubblica Ambrosiana, avendo capito che le principali famiglie del Monte di Brianza avevano in animo di appoggiarsi a Francesco Sforza, le convocarono a Milano per far giurare loro la fedeltà alla Repubblica: tra di esse si trovava la “parentella illorum de Adda”.49 Il casato dei d’Adda, la “consorteria” come era detta a quel tempo, nella seconda metà del 1400 era molto forte e diffusa in Olginate; da sempre ghibellina in quel periodo era però divisa nettamente in due clan: quello facente capo ad Antonio o Antonino e in seguito a suo figlio Pagano, vero capo indiscusso del contrabbando con il Bergamasco e favorevole al partito di Lodovico Sforza detto “il Moro”, e quello che faceva capo a frate Giovanni, terziario francescano, diretto discendente del “Pizeto” d’Adda morto nello scontro coi guelfi, fedele a quello che consideravano il legittimo duca di Milano, cioè il giovane Gian Galeazzo Maria Sforza. Il ceppo che faceva capo a frate Giovanni, risultato perdente in questa contesa, si estinguerà in Olginate nel 1566 con la morte di Leone d’Adda. Pagano d’Adda era socio non solo d’affari ma anche di malaffare50, con Galeazzo Crotti. Entrambi ottengono una licenza, della quale è informato il Capitano della Martesana, per “de potere condure o fare condure certe sue biade” ad Olginate (40 “some” ciascuno) con la raccomandazione che “fraudi alcuna non segua”.51 Forse la stessa “biada” fatta arrivare ad Olginate dai due fu poi oggetto di una falsa denuncia da parte di Nolo de Lomatio che accusava “Thadeo de Cremona olim capitaneo conducere fecit certa blada ultra abduam habendo inteligentiam cum Gaspare de Regio et partecipando de lucro cum Galeaz de Crotis et Pagano de Abdua” in territorio veneziano, oltre il fiume Adda. Le successive indagini non confermarono la denuncia che cadde nel nulla, ma dimostrava come i giochi su questo confine erano sporchi e nessuno era pulito.52 È in questo stesso periodo di tempo che le Comunità di Olginate e di Galbiate e le famiglie più importanti, quali i Crotti, i d’Adda, i Riva, sono sotto stretta osservazione per il sospetto di contrabbando verso la veneziana Valle S. Martino. Convocate a Milano le principali parentele di Olginate per difendersi da queste accuse,53 queste, a nome della Comunità di Olginate e dopo un colloquio col Duca, promisero di intervenire affinché non si traghettassero più granaglie in Val S. Martino senza la presentazione di una sua speciale licenza.54 Infatti, nell’aprile 1458, un mese dopo, Galeazzo Crotti, Pagano e Jacobino d’Adda ottengono una licenza dalla Duchessa Bianca Maria Visconti-Sforza di condurre o di far condurre “biade” dal Ducato in Olginate.55 Nonostante le promesse e gli impegni presi l’attività di Pagano d’Adda era però sempre poco chiara. Nel 1465 una grave denuncia pervenne direttamente al Duca Francesco Sforza ed alla duchessa Bianca Maria da “Galeaz de Bossis castelanus castri Brippij”. Il Bossi, lamentandosi “che noy potemo morire de famo se la S.V. non ge provederà, che nuy non possemo trovare uno stare de biada per li nostro vivere”, e accusa “Pagano de Adua che la comprata (la biada – ndr) tuta quanta luy ne trova per mandare in bergamasca aly inimici dela S.V. e mette la calastria in dele vostre terre e fa cridare oni omo de famo” e
chiede che “la S. V. che degnia de provede azo che li hominy vostri abiano cassone de potere vive e de non cridare, ancora prego la S. V. che noy povery castelani ve sia recomandati per che nui siamo malle tratate.”56 È vero quello che afferma oppure è solo un modo per portare a conoscenza della Corte Ducale il malcontento che si annidava tra i soldati posti a presidio del confine? Sta di fatto che non vi furono sanzioni contro Pagano d’Adda da parte delle autorità ducali. Da Pagano, figlio di Antonio o Antonino, discenderanno, dal 1500 in poi, i Conti di Sale, i Marchesi di Pandino, i d'Adda Salvaterra, i Borromeo d'Adda, e tanti altri che, pur non abitando più stabilmente in Olginate, tanta parte avranno nella storia di questo paese. Grazie a lui i d’Adda avevano ormai raggiunto e consolidato una posizione di prestigio politico sia nel Monte di Brianza che in Milano presso la Corte Ducale, rendendo più facile, per il casato, l’acquisto del complesso fortificato di Galeazzo Crotti quando i suoi figli lo misero in vendita. Nel 1481 risulta proprietario della “Torre”, come in seguito la casa-torre sarà chiamata, Jacobino d’Adda, succeduto, alla morte del fratello Pagano, nella guida del parentado. Mercante, banchiere, imprenditore ed anche per un certo tempo “caneparo” della pieve civile di Garlate, cioè l’economo che svolgeva funzioni di cassiere e daziere. Era sopranominato “Payno”, dal dialetto brianzolo “pajan” che vuol dire gran mangiatore. Anche i suoi figli erano detti “Spisenetti”, termine anch’esso equivalente a “mangioni” e anche “arraffatori”. 57 Come Pagano non disdegnava di guidare e praticare il contrabbando di granaglie e merci con il Veneziano. Nonostante quest’ultima riprovevole attività, egli era però in buone relazioni con il reggente il ducato milanese, Lodovico Sforza, e con il primo segretario ducale, Bartolomeo Calco. Manteneva anche importanti legami commerciali e di amicizia con i maggiori esponenti della Valle San Martino, come aveva fatto in precedenza Galeazzo Crotti. Relazioni che gli servivano principalmente per i suoi interessi economici ma nello stesso tempo gli permettevano di ottenere riconoscimenti importanti da parte della Cancelleria Ducale per le sue forniture di prodotti rari come il ferro e acciaio proveniente dalle valli bergamasche e bresciane, essenziali per l’industria bellica milanese. Nell’ottobre del 1483, in un periodo in cui le frontiere con Venezia erano chiuse per la guerra, gli riuscì di assicurarsi presso mercanti bergamaschi compiacenti una grossa partita di ferro; era una merce su cui esisteva un embargo totale da parte veneta, specialmente con la guerra in corso. Naturalmente la segreteria ducale si mostrò molto interessata a questa fornitura ordinando al Commissario al porto di Olginate di agevolare e proteggere Jacobino e di:
“daghi licentia de podere andare de là ad levare, cum naveti, tutta quella quantità de ferro e azale li serà conducto”.58 Ma la problema del contrabbando esercitato spudoratamente in Olginate e dintorni era tale che si temeva che Jacobino ne approfittasse per fare un guadagno aggiuntivo scambiando la partita di ferro con fornitura di grano. Ci si premurò quindi di raccomandare al Commissario di controllare che le barche non portassero granaglie da consegnare ai bergamaschi:
“…havendo però bona advertentia che per li dicti naveti non se commetta fraude de biade andandoli tu o mandoli uno di tuoy quando dubiti de froxatione.”59 (vedere doc. 3)
Le sue altolocate amicizie lo difesero sempre dall’invadenza di quelli che, a torto o a ragione, gli volevano togliere il controllo di quella che era diventata la più importante fortificazione di Olginate. In numerose lettere, inviate nel 1483 alla cancelleria milanese da Giò Juliano Degnano, Commissario al porto di Olginate, si denuncia gli ambigui rapporti commerciali intrattenuti da Jacobino con eminenti personaggi della Valle San Martino che avevano libero accesso alla sua casa-torre con il rischio, sottolinea il Commissario, che potessero approfittare di questa amicizia per entrare in possesso della fortificazione con l’inganno e consegnarla ai Veneziani, sostenendo che questo sarebbe di “danno e vergognia nò di poca substantia.”60 Iacobino, pur essendo abile nel commercio e nelle relazioni personali, era per certi versi un uomo controverso ed ambiguo capace di attirarsi l’astio di parte della popolazione olginatese pur di salvaguardare i propri interessi. Ma non mancò, secondo la mentalità del tempo, di acquisire delle benemerenze spirituali, intervenendo
generosamente a sostegno di opere religiose e sociali in paese, mentre a livello personale cercava di vivere una intensa vita religiosa. La sua devozione alla Madonna lo portò a frequentare la chiesa della Madonna del Lavello, in quegli anni sulla bocca di tutti per i fatti miracolosi che vi avvenivano. Risulta, infatti, incluso nell’elenco delle persone guarite dopo avere immerso la mano destra, che era “ingottata”, nell’acqua sgorgata in quel luogo da una antica tomba.61 Contribuisce, inoltre, al restauro della antichissima chiesa olginatese di Santa Maria de Vico o la Vite, dove si fece costruire una cappella nella quale volle essere sepolto e sulle cui pareti si fece ritrarre in atto di preghiera, insieme ai propri familiari.62
Il passaggio di proprietà della “Torre” Dopo la morte di Galeazzo Crotti, avvenuta probabilmente verso il 147563, i suoi figli, Bernardino, Francesco, Zaccaria e Menopaxio o Menapace, decisero di vendere l’avita dimora: la ragione di questa scelta non ci è nota ma probabilmente il loro peso politico non era pari a quello del padre e in Olginate stavano emergendo in tale ruolo i figli di Antonino d’Adda. Solo Bernardino, che ormai abitava stabilmente in Milano, essendo “cives mediolani”, occupa posti importanti alla Corte Ducale: nel 1485 è ducale staffiere, nel 1514 fa parte della Cancelleria segreta come usciere.64 In questo lasso di tempo anche molte altre famiglie della casata dei Crotti abbandonarono il paese per trasferirsi a Genova e, per la maggior parte, a Mantova, dove prosperarono nella loro attività di mercanti in stoffe e broccati.65 Purtroppo il documento che ci informa di questa loro decisione di vendere la casa-forte è mutilo nella parte finale e quindi non ci permette di conoscerne i motivi oltre che la data e lo scrivente. Il documento si può ragionevolmente datare tra il 1475 ed il 1478, e l'estensore, probabilmente, era il Commissario ducale al "porto" di Olginate dell'epoca perché insiste presso il Duca, come altri suoi predecessori, affinché il complesso fortificato non passi a privati ma entri a far parte delle fortificazioni ducali. Egli enumera molte ragioni importanti affinché questo avvenga e indirettamente ci dà informazioni sulla tipologia della costruzione e sul fiorente contrabbando esistente in paese con la nemica Valle S. Martino.66 (vedere doc. 2) La casa-forte dei Crotti posta in vendita era composta da una torre a pianta quadrata collegata da una cortina che correva parallela al fiume ad un torrione circolare posto poco più a sud; il suo punto di forza era un ampio fossato collegato all’Adda, profondo all’incirca “braza XI”, cioè circa 6 metri, che circondava tutta la costruzione di modo che essa si trovava “in mezo duo lacho zoè adda”. In inverno, per la scarsità della portata del fiume, il livello dell’acqua nel fossato era di molto inferiore ma, con opportuni lavori, scrive il Commissario, si poteva ovviare a questo carenza, facendola diventare una “fortezza” più che sicura anche in quella stagione.
Insiste anche sull’importanza strategica che potrebbe avere nel territorio perché: “…al tempo de le guere anze che essa forteza fusse facta, la zente darme de la Signoria de Venizia anno piantato li ponti et sono pasati Adda per quelo passo streto, per la quale cossa per via de essa forteza nò porano più piantare ponti siandoli fato contrasto per quillj che starano et che habitarano in essa forteza (...) anchora questa forteza è guardia et giave de tuto il Monte de Brianza (...) se la Signoria de Venitia piasseno hanche questo locho, lo farebeno fortificare in modo sarebe una altra Crema, et batarevano tuto il payexe de sopra….67
Inoltre fa osservare che chiunque avesse il possesso di questa fortificazione poteva controllare a proprio piacimento non solo l’attività commerciale lecita che si svolgeva lungo il corso dell’Adda e con la Valle S. Martino, ma anche quella, illecita,
I familiari di Jacobino d'Adda effigiati sulla parete
della chiesa di S. Maria la Vitein Olginate
del contrabbando che, eludendo i dazi, diveniva fonte di ricchezza per chi lo praticava, ma soprattutto per coloro che lo dirigevano. Per questo suggerisce al Duca di affidare il complesso, una volta acquistato, a un uomo di provata fede con alle sue dipendenze dei seri soldati che avrebbero navigato il lago ed il fiume su una “gozabieza68 et deli naveti”, che potevano essere, poi, tenuti al riparo in un porto da costruirsi sotto la torre. La costante e puntuale presenza dei soldati avrebbe, sempre secondo il parere dello scrivente, molto indebolito, se non fermato, il contrabbando verso il Bergamasco di “biade”, (definizione sotto cui si comprendevano frumento, segale, miglio, panico, avena e legumi dai quali si potevano ricavare farine per la panificazione) e quello delle spezie che da Venezia entravano nel Milanese, oltre ai tessuti, i drappi, il grasso, il vino, le armi e altri manufatti che invece passavano nel veneziano. Di conseguenza sarebbero aumentate le entrate della Camera Ducale, sia per i maggiori dazi riscossi che per il maggiore interesse per le aste che periodicamente si tenevano per l’aggiudicazione degli appalti per la loro riscossione. Inoltre si poteva favorire l’approvvigionamento della città di Milano, dove sarebbero andati a finire le granaglie ed il pesce che normalmente veniva contrabbandato nel Bergamasco. (All’epoca i mercanti di pesce pagavano per entrare in Milano un dazio di quattro denari per ogni libbra di pesce. ) Alla luce di quanto esposto appaiano poco comprensibile i tentennamenti ducali sull’acquisto della fortificazione: un distaccamento di soldati in questa “fortezza” poteva avere un effetto di deterrenza formidabile per i contrabbandieri.
Forse per tener fede ai molti privilegi concessi alla gente di Olginate, forse per evitare di mettersi in contrasto con gli abitanti del paese, notoriamente restii a soggiacere a qualsiasi tipo di autorità, forse per una diversa visione dello scacchiere politico militare del momento, il Duca, o chi per lui, non ritenne utile entrare in possesso della fortificazione. Con questa decisione ottenne il risultato di mantenersi fedeli, per ogni futura evenienza, gli abitanti di questi luoghi, lasciando al proprietario della “fortezza” il difficile compito di essergli fedele e nello stesso tempo mantenere buoni rapporti con i suoi compaesani. Sfumato l’acquisto da parte del Duca di Milano, furono i d’Adda, ad approfittare dell’occasione offerta loro dai figli di Galeazzo Crotti. Il passaggio del proprietà della “Torre” a Jacobino d’Adda detto “Payno” avvenne il 17 luglio 1478 nell’ambito di un cambio di beni con i fratelli Crotti, dopo una lettera di autorizzazione per questa operazione firmata dal Segretario ducale Bartolomeo Calco.69
La Torre dei d’Adda Ritornando alla “Torre”, i d’Adda la usarono, come già i Crotti in precedenza, soprattutto come luogo sicuro in cui rifugiarsi quando più rilevanti si facevano i pericoli di sfondamento del confine da parte veneziana, come avvenne nel 1483. In quell’anno, come conseguenza della guerra di Ferrara, tutto il territorio brianzolo confinante con l’Adda e la veneziana Valle San Martino, venne messo in allarme per una possibile invasione, anche se poi i veneti al comando di Roberto da Sanseverino, il 15 luglio 1483, riuscirono a passare l'Adda più a valle, mezzo miglio sopra Trezzo, mediante un ponte formato da sei barche difeso da un terrapieno.70 Il ponte fu poi attaccato e distrutto dalle truppe sforzesche il 27 dello stesso mese, mentre nella zona della Valle S. Martino vi furono solo scaramucce di poco conto, che toccarono, in parte, anche Olginate. In questo frangente anche la “torre” venne inserita nelle difese approntate per fronteggiare un eventuale attacco. All’inizio di giugno del 1483, il Segretario ducale Bartolomeo Calco, ordinava quindi al Capitano della Martesana di avvisare “…quelli homini che la torre de Olginate che la faceno ben guardare cossì de dì como de nocte, considerando tu medessimo la provisione te parerano necessarie per la bona guarda dessa, de la quale ne darai notitia alli patroni dessa torre aciò che possendo la mettino in effecto overo che noi siamo avisati de quello li bisognasse per assecura talmente che non altro potessemo dubitare che per quella nò se convene qualche senestro.”71
Un mese dopo, lo stesso Duca Giovanni Galeazzo, scrive al “Castellano Turris olzinate” ordinandogli di accogliere, “per maiore secureza de quella forteza … sey nostri provixionati quali te mandarà Martino da Asola nostro capo de Squadra, et gli daray opportuno loggiamento in essa per modo possano attendere ad bona guardia et conservarla de omne sinistro potesse intervenire in li presenti momenti de linimici.”72 Jacobino non volle però accettare nella sua casa-torre questi sei “provisionanti”, cioè i soldati ducali destinati a difenderla, perché, come scriveva al Duca pochi giorni dopo, gli esigui spazi che si potevano utilizzare al suo interno permettevano di ospitare solo i componenti della sua famiglia, fratelli, parenti, “done e pute da maridare” e servi oltre che la “roba”.73 Ma comunque si dice pronto a difenderla fino alla morte se gli fossero fornite delle armi adeguate:
“... Per una altra mia ha avixato la magnificentia di domino Bartolameo Chalcho vi richiedesse per parte mia per mellio poterme difendere in questa mia forteza, spingarde due, barille due de polvere et casse una di veretoni, li quali pregovi di novo me la voliati fare havere per omnio modo, et poy lasate il pensare a me, se bene vegnesse tucto il campo di la Signoria da Venetia se defenderemo galiardamente fino a lasarge la vitta, per amore di Vostra Signoria la qualle sempre me richomando …”74
In effetti lo stesso giorno, Jacobino d’Adda aveva scritto al Segretario Ducale Bartolomeo Calco chiedendo lo stesso rifornimento di armi:
“…Per chè ala defensione de questa mia forteza qui in Volginate me bexognaria springardelle due, barilli due de polvere et cassa una de veretoni, per chè ne sonto molto malle fornito, dil resto ho fatto quella provixione che posibille sia, per modo che achadendo venire li inimici non me dubito de niente per nò me defenda per batayada mane et sostenire limprexa, fazendome havere le suscripte monitioni; onde prego Vostra Magnificientia vollia provedere con il nostro Illustrissimo Signore habia le suscripte monitione.”75
Passato senza danni per Olginate questo periodo di guerra, all’inizio del 1484 esplosero però drammaticamente le rivalità latenti, commerciali e politiche, tra Jacobino ed i suoi fratelli da una parte, e le altre notabili famiglie di Olginate dall'altra. Già all’inizio di giugno del 1483, Giò Rolando de Sommo, Capitano della Martesana, aveva avvertito il Segretario ducale, Bartolomeo Calco, dei rancori intensi che correvano, in Olginate, tra il proprietario della "Torre" ed un'altra fazione olginatese, sostenendo che:
“... quanto alla torre de Olgina qual che in similiter caso importa assay Vostra Excellentia debe havere inteso le inimicitie, discordie et differentie sono in quello loco, imaximer tra quello che stà in la torre et la più parte della tera, che per certo luna parte et laltra se mandurarobeno voluntera dil fidago per li odij intensi tra loro (…) Vero è che quelli homeni de Olgina al mio intendere sono molto fideli al Stato de Vostra Excellentia ma considerato le risse sono tra loro, per uno disposto se poteria far dil male assay como ogni dì so veder per experienta et in questo è da fare bona guardia perchè quella torre importa assay et quando quella fosse nelle mane de nemici nostri sarebe destructione de tutto questo paese, fariali mò Vostra Signoria quella provision le pare, nò dico chel priva el patrono che viè dicta torre ma … ”76
Ma Jacobino d’Adda, scrivendo al Duca, scaricava la responsabiltà di fomentare queste divisioni sul potente Ambrogino da Longhignana, Capitano Generale dei Provisionanti e Comandante della guarnigione di Porta Giovia a Milano, uomo aduso agli intrighi ducali:77
“… Arichordandovi che quello fa esso domino Ambroxino lo fa apetitione de zerti mey jnimici, homeni banditi et di malla conditione, come altre volte vi ho fatto intendere per chè fine a lora me la voleva tore, et per Vostra Signoria gli fu comisso nò se ne inpagiasse de mandarme gente.”78
È possibile che ad Olginate si siano ripercosse divisioni politiche già esistenti in Milano e nel Ducato a causa delle manovre del reggente Ludovico Maria Sforza, detto il Moro, per spodestare il legittimo Duca, Gian Galeazzo Maria, suo nipote, ed impadronirsi del Ducato, come poi di fatto avvenne. Approfittando di questi momenti difficili, le due fazioni olginatesi si affrontarono apertamente, non solo denunciando vicendevolmente alle autorità ducali le presunte connivenze con i Veneziani degli avversari, ma giungendo fino ad un vero e proprio assalto alla “torre” di Jacobino.79 (vedere doc. 4) Il fattaccio avvenne la mattina del 6 gennaio del 1484 , quando, secondo la descrizione dell’assalto che lo stesso Jacobino fa al Segretario Ducale, cinquanta e più persone, al comando di Giovanni d’Adda, Bernardo Crotti, Pietro d’Adda, Antonio Crotti detto Boda, Silvestro de Testori detto il Matto, Michele
della Beretta e suo figlio Lantelmo cercarono di prendere la sua casa-torre con la forza, armati di: “corazine, tarchoni, tarchete, lanze longe, spedi, partisane e de honio arme”, ma vennero respinti dai difensori, che contarono solo quattro feriti fra di loro, mentre non fa cenno delle perdite avute dagli attaccanti. Il fallimento di questo assalto è forse da imputare al fatto che gli assalitori fossero sprovvisti delle letali armi da fuoco, avevano solo armi bianche, mentre gli assediati poterono valersi, con esito decisivo, di piccoli cannoncini chiamati spingarde, che all'occasione potevano sparare anche fasci di "veretoni”, cioè grosse frecce a forma di “spiedo”, inviate loro dalle autorità ducali già dall’anno precedente, quando si rafforzarono le difese della “Torre” in occasione della già citata guerra. I protagonisti dell’assalto sono chiamati a presentarsi a Milano da Bartolomeo Calco, attraverso il Capitano della Martesana, perché “sotto pretexto de salvaconducto nostro, commetteno de molti desordini et usano male in molti loci le littere nostre.”80 Dopo questo fatto, che metteva a nudo i gravi contrasti tra gli abitanti, si corre ai ripari: questa volta si muove “Jo Rolandus de Summo Capitaneo Martesane” che chiede l’invio di armi per potenziare la difesa della torre:
“Essendo qua a Ulginà trovo la tore de Payno Dada qua esser assay bene in ordene de ogni cossa: la qual tore importa molto, mha trovo che gli bixognia qua haver alcune springarde fornite, aciò possa meglio stare cauto e fermo, sichè prego la Vostra Signoria che si degna di mandare qua quatro springarde con polvere e balote.”81
E’ forse a causa di questo evento e per evitare future zuffe in paese, che Jacobino d’Adda cercò di vendere la “Torre”. Ma a chi, Jacobino, voleva vendere questo prestigioso simbolo di potenza da pochi anni acquistato? Una lettera dell’ottobre 1484 del segretario ducale, Bartolomeo Calco, al Duca Gian Galeazzo Sforza, riporta una supplica, sottoscritta da Ambrogino da Longhignana e da Jacobino d’Adda, perché venga concesso il permesso per la compravendita della casa-torre secondo gli obblighi stabiliti dalle leggi. 82 A sorpresa ritroviamo il Longhignana che già l’anno prima aveva brigato per ottenere la casa-torre.83 Evidentemente con i suoi intrighi era riuscito ad avere significativi appoggi politici per “obbligare” Jacobino d’Adda a vendere ciò che l’anno prima si era rifiutato di fare. Questo Ambrogino da Longhignana, già molte volte presente nel territorio lecchese durante le guerre con Venezia e poi come incaricato di arginare il contrabbando, conosceva benissimo le famiglie più in vista, i loro maneggi e il mondo del contrabbando.
Nell’ottobre del 1451 è a Malgrate con i suoi fanti e lì viene avvisato di non muoversi e di stare all’erta perché “achadendo el bisogno, luy sia aparechiato ad poter andare ad Lecho, o al ponte o altrove, secondo el bisogno richiederà.”84
Nel 1452, sempre a Malgrate, si fa redarguire per aver sequestrato un cavallo e del denaro ad “Angellino Thodesco merchadante et homo delli m.ci Conti dala mirandola, exihibitore presente per lo loco de malgrate, quale conduceva certa quantità de zafrano in allamagna”, con l’ordine di restiture il tutto.85 Nel febbraio 1454 ottiene dallo stesso Francesco Sforza il possesso del “porto” di Brivio per la parte spettante alla Camera Ducale
“Magistris Intratarum ordinariarum et exordinariarum (…) donato et concesso al Strenuo Ambrosino da Longagnana nostro Capo de Squadra de provisionati la intrata del porto de Brivio cioè de quella parte che se aspecta et pertene ala camera nostra, per tanto volemo et ve commettimo che debiate metere dicto Ambrosino, o qualunche altro suo legitimo messo, alla possessione del dicto porto.”86
L’ufficialità della donazione venne ratificata il successivo novembre con apposito decreto sottoscritto dallo stesso Duca.87 Nell’agosto 1456, Ambrogino da Longhignana è ancora nel Monte di Brianza con le sue truppe all’insaputa del Consiglio Segreto e di questo il Consiglio si lamenta presso il Duca:
“Et perchè fanno mentione (alcune lettere di Gaspare de Regio, Commissario del Monte di Brianza – ndr) de lo andare de Ambrosino de Longagnana nel Monte de Briancia cum soi cavalli e fanti, non essendo questo passato per via nostra ce parso de mandare esse littere a la Excellentia Vostra acciò che intendendo quanto el dicto Gaspare scrive gli possa fare respondere como meglio li parirà.”88
Ma questa progettata vendita della casa-torre ad Ambrogino da Longhignana andò in porto? Non lo sappiamo con certezza anche se il Pensa, in un suo articolo, fa capire che l’affare fu portato a termine.89 Ma sappiamo anche che il Longhignana morì l’anno dopo, nel 1485, mentre Jacobino d’Adda si spense alcuni anni dopo, nel 1491 circa, e nel suo testamento non si fa alcun cenno al possesso della casa-torre.90 Sembrerebbe quindi che, dopo la morte del Longhignana, fosse intervenuto un accordo tra Jacobino e la Cancelleria Ducale sulla annosa questione della “Torre di Olginate”, lasciando l’uso della fortificazione ai ducali in tempo di guerra, senza però che lo Stato ne entrasse giuridicamente in possesso. In quegli anni, quindi, il complesso fortificato, pur rimanendo proprietà dei d’Adda, passò però sotto il controllo di un “castellano” di nomina ducale, come risulta da un documento del 1490, dove un Delfino de Porris è citato con questo incarico.91 Nell’agosto del 1499, nell’imminenza della calata delle truppe francesi di Luigi XII, anche Olginate fu messa in allarme, come tutte le località situate sull’infido confine veneto. Solo in questo periodo ritroviamo i d’Adda come proprietari e anche castellani del complesso fortificato. A Palamede d’Adda, figlio di Pagano e nipote di Jacobino, ed agli stessi abitanti, venne affidata la difesa della “torre” e del paese nonchè la sorveglianza dei luoghi guadabili lungo l’Adda, specialmente di fronte alla località del Lavello, dove venne costruito un “bastione”, cioè un terrapieno rinforzato con legname, per contrastare un possibile attraversamento del fiume da parte delle truppe veneziane, alleate ai Francesi, e stanziate nella Valle S. Martino.92 Può essere che in quel frangente anche le case-torri dei d'Adda, cioè "la Törr” e quella più antica posta in piazza Garibaldi, fossero sottoposti a lavori di adattamento alle nuove esigenze militari. Del periodo della dominazione francese, purtroppo, non conosciamo documenti che attestino quanto successo nel territorio olginatese. Sicuramente il complesso fortificato dei d’Adda non venne smantellato dai Francesi, come successe per il castello del Monte Barro e a quello di Vercurago-Somasca, probabilmente perché era di proprietà privata. È tra il 1527 ed il 1532, con l’avvento di Gian Giacomo de Medici detto il Medeghino, rampante signorotto della Brianza e del Lario al servizio di vari padroni, che la “Torre di Olginate” ed i suoi proprietari rientrarono in grande stile nelle vicende guerresche che interessarono il territorio lecchese. Il Medici, dal suo castello di Musso, sul lago di Como, destreggiandosi tra Spagnoli e Francesi che si stavano contendendo il Ducato di Milano, cercava di ritagliarsi un suo proprio dominio, tentando di espandere i suoi possedimenti verso la Brianza. Sconfitto a Carate, nel luglio 1527, dalle truppe imperiali di Carlo V, egli cercò di rifarsi dallo smacco subito tentando di conquistare Lecco ed il territorio circostante. Questo tentativo durò, con alterne vicende ed alleanze, fino al 1532, portando devastazioni e saccheggi in tutti i paesi interessati dalle battaglie tra gli opposti schieramenti. Per ricostruire il primo periodo di questa guerra occorre rifarsi ai lavori di storici coevi agli avvenimenti, non sempre obiettivi nel descriverli poiché portati a schierarsi tra gli opposti contendenti, mentre mancano, a tutt’oggi, molti documenti originali. Anche lo storico don Rinaldo Beretta, nel suo pregevole lavoro “Gian Giacomo de Medici nella Brianza (1527-1531)”, si lamenta di questa situazione e basa la sua ricostruzione dei fatti sulle cronache degli autori cinquecenteschi.93
Nell'ottobre 1527, il Medeghino si accorda con i Veneziani e il duca Francesco II Sforza per strappare Lecco agli Imperiali. Ebbe anche l’appoggio delle più potenti famiglie locali, le quali, fedeli all’ultimo Sforza che nel 1525 era stato defenestrato dall’imperatore Carlo V dal possesso del ducato, gli fornirono tutto l’aiuto possibile. Anche il proprietario del “castello”94 di Olginate, Palamede d'Adda, gli mise a disposizione la fortificazione difesa da Antonio Maria Negro, suo parente, e da un presidio di soldati veneziani. Nel borgo di Lecco il calabrese Lucio Brisighello, comandante del presidio imperiale, era assediato dal Medeghino e attendeva l’invio di rinforzi da parte di Antonio de Leyva, comandante in capo delle truppe imperiali in Milano. All’inizio di marzo del 1528 questi inviò in suo soccorso tremila fanti e quattrocento cavalieri, con quattro cannoni, al comando di valenti condottieri d’arme: Ludovico Barbiano da Belgioioso,
Filippo Tornielli, Cesare Maggi da Napoli e il Mastro di Campo Ibarra con i suoi Spagnoli.95 Sulla strada verso Lecco, la spedizione di soccorso venne continuamente attaccata dai signorotti locali che riuscirono a frenarne la marcia ma non impedire loro di raggiungere Olginate, dove intendevano attraversare l’Adda per arrivare sotto le mura del borgo assediato passando lungo la sponda orientale del lago di Garlate. La conquista di Olginate e lo sfondamento delle difese veneziane non fu, per le truppe imperiali, impresa facile. Una cronaca del tempo descrive succintamente la presa del castello:
“… gionti intorno ad Ulginà piantossi l’Artiglieria, batterno il Castello in faccia all’Essercito Venetiano et per forza lo pigliorno con la morte di quel Capitano del luogo.”96
Un’altra descrizione, più dettagliata, di questo fatto d’armi ci è fornita da Antonio Grumello nella sua “Cronaca”:
“… Antonio da Leva non perdendo tempo per el soccorso di Leccho hebe datto expedicione al conte Ludovicho Belgioioxo, capittano Cexareo, de infanti 3 millia et cavalli 400 che pigliasse il camino di la villa di Olginate sopra il fiume di Abdua, dove in epso locho hera uno torrione fornito de milliti Veneti ala somma de 30. Gionto el Belgioioxo a dicto locho con alquanti pezi di artellaria el soi milliti hebe mandato il tubicine a predicti infanti, se volesseno arrendere a bona guerra; fu risposto per epsi milliti non volersi arrendere, anzi diffensare quella torre con le forze a nome dil Veneto senato. Visto et intexo lo Belgioioxo la risposta de li milliti Veneti di non volersi arrendere subito posta lartellaria a dicta torre battendo quella giorno et nocte di tal sorte che hera per chadere a terra et detti milliti foreno constrecti a rendersi al Belgioioxo a discrezione, quale hautti che li hebe in sue forze li fece tagliare in peze.”.97
Avuto il “castello” grazie all’impiego dei cannoni, a cui non potevano resistere le muraglie del complesso fortificato (l’artiglieria in quei decenni era molto migliorata sia in potenza che in gittata), gli imperiali cercarono di attraversare l’Adda. Messi i quattro cannoni in posizione cominciarono a bombardare le trincee veneziane poste sull’altra sponda, provocando la morte di numerosi soldati, nello stesso tempo costruirono un ponte formato da dieci barche unite assieme. Quindi, approfittando dalla confusione tra le file avversarie e contando sul fatto che le truppe venete erano impegnate a respingere l’attacco di 200 archibugieri che attraversavano il fiume sul ponte appena costruito, uno dei condottieri delle truppe imperiali, il capitano Cesare Maggi, con delle barche cariche di soldati, aggirò le postazioni difensive veneziane, comandate dal capitano Farfarello da Ravenna, condottiero al soldo di Venezia, e attaccò alle spalle i difensori, sbaragliandoli e permettendo il libero attraversamento del fiume alle truppe rimaste ad Olginate. Padroni anche della riva bergamasca, gli Imperiali attaccarono la Chiusa di Vercurago, ultimo ostacolo che si frapponeva tra loro e Lecco. Il Medeghino, furente per la perdita del passo di Olginate, distolse parte delle truppe dall’assedio e le inviò alla Chiusa dove riuscirono, in un primo momento, a respingere gli Imperiali. Questo alternarsi di attacchi e contrattacchi si protrasse fino al 17 marzo del 1528, quando gli imperiali decisero di aggirare la Chiusa, passando a monte della fortificazione, attraverso un passo detto “Pertus”. Intanto, approfittando delle difficoltà incontrate dalle truppe imperiali, Palamede d’Adda si vendicò su coloro che gli avevano tolto il “castello”, ucciso il castellano suo parente, e saccheggiato Olginate: con una veloce barca armata piombò sugli imperiali che stavano sbarcando sulla riva bergamasca davanti alla Chiusa e ne fece strage. Almeno questo è il racconto di Ignazio Cantù, che forse esagera il peso del d’Adda nella vicenda, impegnato com’era ad esaltare tutto quanto richiama la lotta contro gli oppressori dell’Italia.98
Comunque, le truppe imperiali, riuscirono a prendere la Chiusa, costringendo il Medeghino a togliere precipitosamente l’assedio al borgo di Lecco, caricare le artiglierie nelle navi e fuggire verso la sua roccaforte di Musso. In seguito, con il Trattato di Pioltello, firmato il 31 marzo dello stesso anno tra il Leyva ed il Medici, quest’ultimo, dopo aver abbandonata l’alleanza con veneziani e francesi, ottenne il legale possesso di Lecco e del suo territorio, conteso aspramente e sanguinosamente fino a pochi giorni prima. Ma pochi anni dopo la nostra “Torre” fu di nuovo interessata dalle vicende belliche.
Nel 1531 l’imperatore Carlo V rimise in possesso del Ducato di Milano Francesco II Sforza; quest’ultimo cercò di recuperare i territori già appartenenti al Ducato e passati in altre mani. Tra questi vi erano i possedimenti che tre anni prima erano stati concessi dal De Leyva al Medeghino. Fallita ogni trattativa tra le parti per la restituzione dei territori, le truppe ducali iniziarono le ostilità e posero l’assedio a Lecco, in cui si era rinchiuso il Medici.99 Padrone del “castello”, cioè la Torre di Olginate ed interlocutore delle autorità ducali secondo una antica consuetudine, era questa volta Pietro d'Adda, uno dei figli di Palamede, che collaborò fattivamente con i comandanti delle truppe ducali, fornendo informazioni sui movimenti di armati che avvenivano in Lecco e in valle San Martino.100 La fortificazione, dopo l’assedio del 1528, era ridotta assai male ma comunque ancora in grado di dare riparo sicuro ai difensori purchè gli assedianti fossero privi di artiglieria. Mancava però di tutto quanto serviva a una fortezza: armi, munizioni e viveri, come si ricava da una lettera inviata da Gerolamo Crivelli al Conte Lazzaro Stampa il 26 maggio 1531:
“…Forse lo Patron lì à significato essere ben fornita, V. S. sapia che la tardato fin eri a mandar la littera de sua Ex.tia per aver tempo de notarla; li à lassato certi archabuxi malissimi alordene et uno moscetto cum 19 balle de piombo, polver de niuna sorta, dil resto niuna cossa cossi victualie como altro, se par a V. S. chel faza che li homeni li metano un pocho de vino et grano nò se ne moverà salvo a uno bisognio grando. La V. S. sia contenta avisarme quelo serà da fare…”101
Venne quindi nominato castellano del “castello di Olginate” Giovanni Antonio Villanterio che, il 15 giugno 1531, ricevette l’ordine di sorvegliare la navigazione sul fiume per impedire il passaggio di rifornimenti al Medeghino assediato. Ebbe anche istruzioni per effettuare incursioni in Valle S. Martino per catturare i soldati di ventura che, assoldati dal Medeghino, cercavano di arrivare a Lecco:
“…Però vi dicemo et comettemo dobbiati ben advertir et far advertir da quello canto, et capitandolij alcunj fanti sì italiani come spagnoli et lanzichenechi ut supra nò mancarete de prohibirli tal loro andata cò amazarli et far al pegio si pote anchora che se trovassero sopra il paese dell'Ill. Signoria di Venitia, et in questo usareti della vostra solita diligentia, perchè così ricerca el servitio et bisognio nostro.”102
Malgrado le perentorie disposizioni, il 9 luglio, ventidue cavalieri provenienti dal bergamasco riuscirono ad entrare in Lecco rafforzandone le difese. Alla notizie di questo smacco il comandante le forze ducali decise di rafforzare il presidio di Olginate con un contingente di 400 fanti al comando del capitano Sebastiano Picenardo. Queste truppe effettuarono la notte del 18 luglio un’incursione in Valle S. Martino alla ricerca di altri mercenari che intendevano entrare in Lecco ma non ebbero fortuna e riuscirono a catturare solo qualche abitante del luogo, ma si rifecero razziando una trentina di capi di bestiame.103 (vedere doc. 5)
Intanto il Medeghino non stava con le mani in mano. Nella notte tra il 20 ed il 21 settembre 1531, due “navetti” ed una “nave” uscirono da Lecco e si spinsero verso Olginate, dove, approdati sulla riva bergamasca, caricarono vettovaglie portate dagli uomini di Calolzio e quindi rientrarono nel borgo assediato senza che i soldati stanziati ad Olginate potessero impedirlo. Nel frattempo i ducali destinarono il complesso fortificato di Olginate a sede del comando del Luogotenente generale del Duca, il conte Alessandro Bentivoglio, e il 30 settembre vi vennero portati, per essere interrogati, i fanti del Medeghino che difendevano il ponte di Lecco, conquistato dai Ducali: fu il primo successo di questi ultimi dall’inizio delle ostilità. In quei giorni venne anche sistemato un appartamento nel “castello” per ospitare il Duca che intendeva qui incontrare i comandanti del suo esercito. Infatti il 17 ottobre arrivarono a Olginate i suoi famigli, ma poi l’incontro venne annullato. Il ponte di Lecco ritornò dopo pochi mesi nelle mani del Medeghino quando, il 5 dicembre, questi attaccò, a sorpresa, l’accampamento ducale a Malgrate e quello posto a Castello. Tra i ducali si ebbero 150 morti e solo due tra gli attaccanti, che fecero prigioniero anche il colonnello Gonzaga, trovato a letto in ben altre faccende affaccendato. I soldati scampati all’eccidio si dispersero e alcuni fuggirono fino a Monguzzo; altri 250 soldati, con i capitani Lampugnano e Josef Uberto, si ritirarono nel castello di Olginate, da dove l’Uberto mandò un dispaccio al Luogotenente generale per dargli “aviso de la male nove” accadute.
“...Questa serà per dare aviso de la male nove ad Vostra Signoria, como questa notte li nemici sono venuti ad assaltar il campo et l’hanno rotto, et amazzato la magior parte, et è preso il Colonello, et penso tutti li Capitani salvo il Lampugnano et me, quali siamo reduti ad Olginà con fanti 250. Et Vostra Signoria mi darà aviso subito di quanto haveremo a far, et è perso il ponte et ogni cossa, et continuo dreto radunando più fanti che poterò, nò altro ad Vostra Signoria me recomando. Da Olginà alli 5 decembre 1531. D. V. Ill. Signoria vostro servitor Joseph Uberto.”104
Passato il pericolo e riorganizzate le truppe, i Ducali ritornarono al campo di Malgrate, per difenderlo da ulteriori attacchi e riprendere l’assedio a Lecco, lasciando però sguarnita Olginate per mancanza di uomini. Di fatto, dopo la sconfitta subita a Malgrate, rimanevano al Duca solo 580 soldati dei 1.400 iniziali. Intanto il Medeghino, ritornato padrone del ponte di Lecco, poteva con navi da guerra e altre imbarcazioni percorrere il lago ed il fiume, tra Lecco ed Olginate, senza alcun contrasto scorrendo e depredando ed anche approvvigionarsi a proprio piacimento. Di questa possibilità si preoccupava Gerolamo Marinone, Tesoriere della Camera Ducale, che era stato mandato nella zona per pagare, dopo mesi, i soldati ducali e nello stesso tempo reclutarne dei nuovi. Da Olginate egli sollecitò, il 6 dicembre, l’invio di almeno 30 o 40 uomini per difendere il paese, perché se il Medeghino fosse venuto in questi luoghi:
“… se potrà fornire di bona sorte de vino et anchora di grano, visto che in questa notte facio redunar tuta la monicione del campo quallo è bona summa ne la roca, al vino nò se li pò fare altro remedio che lasarlo fora de le boti, pur scorrendo questa notte se farà tutto per redure qua dentro il presidio.”105
Di questa situazione, infatti, ne approfittò con spregiudicatezza il Medeghino. Il 10 dicembre egli uscì da sotto il ponte di Lecco, con le navi più grosse che aveva, e si diresse verso Olginate; il borgo era difeso da una compagnia raccogliticcia di soldati ai quali era stato ordinato, in caso di attacco, di radunarsi nel cortile della “Rocca”. 106 Cosa che essi fecero prontamente quando il Medici ed i suoi soldati sbarcarono sulla riva antistante il paese. Nonostante i ripetuti ordini di passare al contrattacco, i ducali rinchiusi nella fortificazione non uscirono a contrastare l’attacco nemico, “tanto sono tristi gente di natura” e per di più avviliti dalla sconfitta subita a Malgrate, come scrisse al Duca il Marinone.107 I mercenari medicei, trovato libero il campo, razziarono tutto ciò che non era stato ritirato nel “castello”: 160 brente di vino, 10 sacchi di pane e 10 di farina, 40 bestie grosse, 10 cavalli, mentre altri 10 finirono bruciati nell’accampamento ducale messo a ferro e fuoco dagli attaccanti. Particolare curioso: nel bottino vi era anche la mula del Marinone già citato. L’animale venne poi riscattato per 50 scudi. I rinforzi ducali, accortesi in ritardo dell’attacco, giunsero troppo tardi ad Olginate. Cercarono di fermare i nemici appostandosi alla località detta “Gueia”, dove la presenza di una grande gueglia che occupava quasi tutto il letto dell’Adda, rendeva difficoltoso il passaggio alle grandi barche da guerra, ma non osarono assalire la flottiglia nemica limitandosi a sparare alle navi in ritirata, uccidendo tre occupanti e ferendone altri. Poi le vicende della guerra si concentrarono, con alterne fortune, attorno a Lecco, fino alla pace, stipulata nel febbraio 1532, con cui Gian Giacomo de Medici in cambio dei territori avuti nel 1528 ottenne dal Duca il marchesato di Marignano. In quel periodo la Torre dei d’Adda ebbe “l’onore” di ospitare anche il Medeghino. Le cronache del tempo ci informano che questi lasciò Lecco il 13 marzo ma due giorni prima, inaspettatamente, era uscito da Lecco con una scorta di pochi soldati e aveva raggiunto Olginate dove, nella “Torre”, aveva pranzato col Marchese Stampa.108 Questo “amichevole” convivio chiuse un periodo di guerre durato circa un trentennio, in cui gli abitanti di Olginate e del Monte di Brianza, compresa anche la veneta Valle S. Martino, dovettero far fronte all’invasione di diversi eserciti con conseguenti ruberie, saccheggi e uccisioni; oltre ad una grande carestia seguita da una pestilenza chiamata “febbrone” che mieteva numerose vittime, specialmente in Valle S. Martino Per sfuggire alle razzie la popolazione fu costretta a fuggire o quantomeno a cercare di nascondere i suoi
beni più preziosi. Il ritrovamento, avvenuto nel marzo 1905 a Olginate mentre si costruiva una casa nei pressi del monumento a S. Carlo, di un tesoretto in monete d’oro coniate tra la fine del 1400 e l’inizio del 1500 può essere una conferma di quanto avvenne in quel periodo di tempo.109
Anche quanto successe a Galbiate, nel giugno del 1531, è un’ulteriore riprova della mentalità corrente a quei tempi, anche tra i capi degli eserciti. Un drappello di soldati ducali di stanza a Olginate erano arrivati in paese per ritirare del vino richiesto dal Castellano di Olginate, Giò Antonio Vilanterio, ma furono infastiditi dal comportamento dei Consoli della Comunità che tardavano a consegnarlo. Per ritorsione, oltre a requisire 2 brente e mezza di vino, si abbandonarono al saccheggio delle case. I consoli di Galbiate inviarono al Duca Francesco II Sforza una indignata lettera protestando per l’accaduto:
“…feceno como è sorte de i soldati (...) essi andando per diverse caxe per forza cò spezar le porte et ostij et capsoni et capse sachomandando le loro zoè pane formagio biancharie vesti calze dinari anelli et altre cosse diverse como se ditti poveri homini fusseno statti ribelli ...”110
Ma il tutto si risolse con una reprimenda del Duca al Vilanterio, che, rispondendo ad una sua richiesta di dare spiegazioni dell’accaduto, minimizzò il saccheggio, scaricandone la colpa sui galbiatesi che avevano esagerato il fatto commentando che:
“…lo consueto da vilanj se li fu tagliato uno dito, dice nò che lie tagliato uno brazo.”111 In questo non c’è niente di nuovo: coloro che patiscono più di tutti le conseguenze della guerra sono, in qualunque tempo, i miseri e gli indifesi! Dopo queste burrascose vicende, per i secoli a venire il complesso fortificato non fu più interessato da fatti d’arme. Oramai lo stato milanese era saldamente in mano agli spagnoli, il confine col veneziano si era consolidato e non vi era più nessuna necessità di guardarsi da incursioni predatorie da parte dei vicini bergamaschi. Tuttavia, almeno per tutto il secolo XVI, il complesso mantenne il suo assetto difensivo.
Uno schizzo del paese di Olginate visto dalla riva bergamasca, eseguito nel 1588, lo evidenzia munito e minaccioso con la sua quadrata torre ed il robusto torrione circolare.112
Restava pur sempre la dimora avita dei d’Adda, che i discendenti di Antonino d’Adda abiteranno saltuariamente fino agli inizi del 1800, e anche se ormai i componenti il casato si erano diramati in varie parti d’Italia la “Torre dei d’Adda” rimaneva un simbolo rappresentativo della potenza economica e politica
raggiunta dai d’Adda nello Stato milanese. Alla morte di Palamede d’Adda, avvenuta nel 1533, il complesso fortificato e la “pescheria”, cioè la grande gueglia posta alla fine del lago di Garlate, non rimase un bene comune indiviso fra i componenti il casato come era già avvenuto con Jacobino, ma venne diviso fra i suoi membri. Nel 1539 i figli di Palamede cedettero la loro parte di proprietà del complesso di Olginate e di quella del “castro” di Caromano ad Agostino d’Adda loro zio paterno.113
Ancora nel 1575 Pagano, uno dei figli di Palamede d’Adda, cedette i restanti suoi beni di Olginate a suo cugino Erasmo I figlio di Rinaldo, da questi passarono poi a suo figlio Giovanni Paolo, continuando così da padre in figlio per più di un secolo finché la linea diretta si estinse, nel 1685, con la morte di Erasmo III figlio di Gaspare.
1588 - veduta di Olginate.
La freccia indica il "castello" dei d'Adda, con torre e torrione circolare
Durante questo periodo di tempo la “Torre” divenne la sede di un piccolo feudo. Morto nel 1652 il marchese Ambrogio d’Adda senza eredi maschi, i feudi delle due Pievi di Garlate e Oggiono di cui era titolare, tornarono alla Regia Camera che li rimise in vendita. Molti paesi delle due Pievi si disinfeudarono pagando un corrispettivo in denaro. A quel tempo abitava stabilmente nella “Torre” Gaspare d’Adda, discendente da Erasmo I. Questi, unitosi in “consorzio” con alcuni dei suoi parenti milanesi, riuscì a acquistare dalla Regia Camera le località di Olginate, Capiate e Miglianico, formando un piccolo feudo che nell’aprile del 1659 il Questore Provinciale, con una fastosa cerimonia tenuta nel “castello” di Olginate, asservì al detto Gaspare d'Adda.114 Il feudatario aveva l'esercizio del mero e misto imperio, con facoltà di decidere le cause civili e penali, e questo comportava l’istituzione nel palazzo di Olginate di un Pretorio con relative guardie. Il feudatario poteva anche condannare il reo alla prigione che certamente era situata nella torre quadrata del complesso. Prigione che non ospitò, probabilmente, nessun bandito ma solo piccoli debitori e imbroglioni dato che già esisteva in Oggiono il carcere feudale eretto in quella località al tempo della fondazione del feudo di Garlate perché abbastanza lontana dal confine veneto e quindi ritenuta al sicuro da irruzioni di malviventi, specialmente bergamaschi, che imperversano nel territorio lecchese facendo il bello e brutto tempo. Significativa è una supplica, non datata ma collocabile verso il 1670, degli abitanti del territorio di Lecco al Governatore di Milano, in merito a questa situazione, dove tra l’altro si dice che:
“…Testimonio di una verità infalibile contro de sodetti Bergamaschi, et altri aderenti et simili, ne sono li processi che pendono nel Pretorio di Lecco, Olginate e Vimercato per l'estorsioni, concussioni fatte, et altri delitti commessi da simile sorte di gente tanto perniciosa alla quiete de sudditi di questo stato. (…) Con haver usurpato le raggioni di pescare nel lago di Olginate e Brivio con danno notabile de sudditi di V. M.tà con rubare il pesce, retti, dare pasta et pescare di notte tempo, et alle volte anco di giorno publicamente, e piantar passoni (pali – ndr) nella ripa che impediscono la navigatione contro il capitulato (...) facendosi lecito tenere anco barche contro le capitulationi di questo stato, per traghettare banditi, mercanti e quella aglocare in preigiuditio dell'imprese regie. Con usurpare la caccia in questo stato venendo sino al numero de 20 armati e più, e con tittolo di caccia à distruere li polari, et fare mille concussioni come si puotrà informarsi nel territorio d'Olginate, Garlate et Airuno, et loro giurisditione, che però per unico rimedio si riccore à piedi di V. Ecc."115
Questo piccolo feudo ebbe comunque poca durata perché alla morte del figlio di Gaspare, Erasmo III, avvenuta nel 1685, tornò alla Regia Camera. Con Erasmo III si estinse la linea dei d’Adda direttamente residenti a Olginate dato che ebbe dalla moglie, Giulia Testori de Capitani, solo due figlie, Camilla e Isabella, che si fecero monache. I beni di Olginate, tra cui la “Torre”, passarono alla linea dei Conti di Sale nella persona di Costanzo Maria e successivamente al figlio Francesco IV d'Adda. Questi soggiornò saltuariamente in paese: abbiamo notizia solo di una riunione di tutti gli estimati di Olginate tenutasi nella "Torre", presieduta dallo stesso Francesco IV, nel maggio 1750.116
Si può ritenere che i nuovi proprietari, non abitando stabilmente in paese e perdurando nel nostro territorio uno stato di pace che durerà fino ai tempi napoleonici, già nel secolo XVIII trasformarono il complesso
fortificato in un luogo di amena villeggiatura. Quando questo avvenne non si può dire con certezza mancando la documentazione. Nella prima mappa catastale di Olginate del 1721 il complesso appare ancora tutto circondato da un ampio fossato, con una casa colonica posta a occidente. Da una veduta di Olginate, databile al 1750, che mostra al limite meridionale del paese una cinta muraria su cui svettano due alte torri, possiamo dedurre che fino a quegli anni la torre e il torrione fossero rimasti integri, ma è da tener conto che la veduta è molto idealizzata.117
Probabilmente è da collocarsi al tempo del conte Francesco IV d’Adda la troncatura della torre quadrata
Le mappe catastalio del 1721 e del 1858 ci documentano le
modifiche apportate all'antico complesso fortificato
per trasformarla in un panoramico terrazzo sul lago di Olginate. Nel 1780 i beni di Olginate passarono a Maria d'Adda, unica figlia del conte Francesco IV, ancora minorenne e per essa alla tutrice Teresa Litta Visconti Arese, sua madre. Maria d’Adda morì nel 1788 senza eredi estinguendosi con lei la linea primogenita dei Conti di Sale. Tutti i beni passarono quindi all’abate Ferdinando, fratello di Francesco e zio di Maria. Alla sua morte, avvenuta nel 1808, il palazzo e tutti i beni immobili esistenti in Olginate, passarono in proprietà alla “Causa Pia d’Adda” da lui fondata.118 Nel marzo 1809 l’amministrazione della Causa Pia D’Adda diffondeva un avviso d’affitto del palazzo in
Olginate chiamato testualmente “casino civile”. Il tutto era composto da “sei luoghi à piano terreno, otto Stanze à primo piano con una Terrazza, e in cinque Mezzani”. All’esterno vi era “il Giardino, la Corte, la Darsena con Gondola, il comodo di Scuderia e di altri Rustici”. La casa era consegnata ammobiliata, precisando però “non già di rame, e di biancheria”. Gli acquirenti potevano avere ulteriori chiarimenti rivolgendosi in Olginate al fattore della Causa Pia, Antonio Mapelli, oltre che in Milano e in Vimercate.119 La descrizione del “Casino” contenuta nell’
“Avviso” ci conferma che l’antica casa-torre, all’inizio del 1800 aveva già subito drastiche trasformazioni. Successivamente, nel 1852, l’immobile venne ceduto dalla Causa Pia d’Adda a Giovan Battista Crippa, proprietario terriero e industriale della seta. Il Crippa effettuò interventi di ristrutturazione ai piani superiori per renderlo adatto all’attività serica. Probabilmente lo adibì parte a deposito di bozzoli e seta filata e parte ne affittò a privati.120 Nella mappa catastale del 1858 l’edificio appare con la struttura odierna, il fossato è quasi del tutto colmato,
ne rimane solo un tratto a formare una darsena, mentre ancora intatta è la cortina che collegava la torre quadrata col torrione. Nell’ultimo decennio del 1800 una parte del caseggiato, che mai era stato abitato dai Crippa, venne affittata al maestro Domenico Colnaghi che vi trasportò la sede dell’istituto scolastico da lui gestito.121 In seguito tutto il complesso entrò a far parte della dote della figlia di Giovan Battista Crippa, Antonia, quando sposò Antonio
Sirtori. Rimasta vedova con un figlio, decise di andare a abitare nell’antico palazzo, adattandolo alle sue esigenze. Nel 1902-1904 sua nuora, Giuseppina Sirtori, fece allestire nel palazzo una pregevole Cappella privata dedicata alla Sacra Famiglia, su progetto dell’arch. Giulio Amigoni. L’antica casa-torre, ormai trasformata in una signorile villa, venne abitata dalla famiglia Sirtori, da cui prese
Fine 1800: l'antica struttura, trasformata in villa, vista dal lago
La freccia indica la torre quadrata abbassata e trasformata in un "bersò"
Particolare di una veduta di Olginate eseguita nel 1750.
La freccia indica le due torri del “castello” dei d’Adda
anche il nome, fino agli anni Ottanta del 1900.
La leggenda La voce popolare indica questa antica dimora anche con il nome di “Presòn” perché ritenuta sede di una angusta prigione, dove venivano rinchiusi i malfattori del tempo, sottoposti, nel contempo, ad atroci e crudeli supplizi. Come abbiamo visto una prigione legalmente autorizzata vi era effettivamente stata nel corso del 1600, seppure per pochi decenni. Invece le dicerie sull’esistenza di cunicoli sotterranei, che collegavano il complesso con altri punti delle fortificazioni olginatesi, e della cui veridicità era convinto l’ultimo proprietario della villa, Achille Giovan Battista Sirtori, non hanno trovato supporti documentari né archeologici, e tutto rimane nel limbo della leggenda. Oggi rimangono dell’antica casa-torre, che fu dei Crotti e poi dei d’Adda, la torre quadrata, seppur smozzicata e ridotta a terrazzo pergolato, che conserva al suo interno un locale con volta a ombrello e pennacchi cinquecenteschi, e l’atrio angolare a doppia serliana di ingresso, riferibile al secolo XVII, che i restauri hanno, in parte, riportato alla luce.122 Acquistata dal Comune di Olginate e ristrutturata, la villa ospita la Biblioteca comunale e altri servizi tornando ad essere di giovamento, si spera per molti anni ancora ed in modo proficuo, a tutta la comunità olginatese. Pubblicato su “La Voce di Olginate” dal titolo “La “torre” di villa Sirtori nei secoli.” dal Novembre 1989 al Febbraio 1990. Rivisto e ampliato nel febbraio 2013
Legenda: Archivio di Stato di Milano – A.S.M. Biblioteca Ambrosiana - B.A. Archivio Storico Diocesano - A.S. Archivio Comunale Olginate - A.C.Ol. Archivio Parrocchiale Olginate - A.P.Ol. Archivio di Stato di Bergamo - A.S.Bg:
Documenti Doc. 1
1466, 9 martij ex Olginati Illustrissima et excellentissima domina domina nostra singularissima .... premissa dolorosamente cum lacrime de core, havemo inteso il caso doloroso seguito dela morte del nostro Illustrissimo Signore. Elche ne ha tanto disconsolati e datone tanto affanno quanto may dire se possa: per la grande ....... e fede che continuamente havemo portato ad sua Illustre Signoria quale non mancho portiamo alla Excellentia Vostra. Et como quella e .... nuy siamo qui ad questo confine de marcheschi, non sapiamo quello habia ad seguire. Como se sia nuy sempre saremo schiavi et fideli servitori de la Illustre Signoria Vostra de li Illustri Soy fioli como siamo stati per il passato et et quelo che possiamo, le persone, la vita e la robba la offerissemo alla Illustre Signoria Vostra et sempre per quella e per il Stato suo le vogliamo abondantemente exponere. Siche dispone quella de noi como li pare et piace che sempre saremo apperanchiati ad fare quanto la Ill. Signoria Vostra ne concederà. Apreso - perchè in questa terra havemo molte ballestre e nò li havemo veretoni, pregamo Vostra Excellentia se degni
mandarne una cassa. Non altra ...... diamo sempre alla Illustre Signoria Vostra quale pregamo vogli consolarse de tal doloroso caso e havere paseda di quello è piazuto a Dio onnipotente. Non altra ................. sempre alla prefata Ill. Signoria Vostra Datum Olginati die 9 martij 1466 Vester fidelissimi servitores Conradus Vigurre Comissarius Montis Briantia nec non Galeaz Crottus, Paganus de Abdua et fratrer Johannes de Abdua. Indirizzata a : Bianca Maria Visconti [in manibus domini Andriotti Maynis, cito cito] A.S.M.: Fondo Militare p.a., cart. 365, Piazzeforti Comuni
Doc. 2 Senza data Illustrissime princeps. Si fato intendere a Vostra Signoria che havendo quella forteza de li fiolli del quondam Domino Galeazo Crotto vostri fidelissimi servitori lì in Olzinà, se pò fare talle provixione che la Vostra Signoria ne cavarà honia anno dinari asay et tuti li homini del duchato de Millano se trovaranj bene contenti de talle cossa. Avisando la Vostra Signoria credo che la più parte de essi fiolli sarano contenti de dare in venzeda essa forteza a dicta Vostra Signoria facendo essi fiolli cossa agrata ha Vostra Signoria et per fare intendere più giaramente li reparj se pò fare et la utillitate de la Ducalle Camera ulterius nò fu may fato cossa più agrata et utille ali hominj del dicto duchato prima. Haverà di bisognio che Vostra Signoria faza provixione bona ad essi fiolli poseno vivere per chè dagando questa forteza ha dita Vostra Signoria sarebeno hodiati per questi talli che fano li dicti mancamenti, in modo haverano di bisognio che se absenteno da esso locho. Anchora questa forteza he de grande importanza al Stato de Vostra Signoria al tempo de le guere anze che essa forteza fusse facta, la zente darme de la Signoria de Venizia anno piantato li ponti et sono pasati Adda per quello passo streto, per la qualle cossa per la via de essa forteza nò porano più piantare ponti siandoli fato contrasto per quillj che starano et che habitarano in essa forteza. Anchora finalmente al dito tempo de guera ala invernata la zente darme de essa Signoria de Venizia pono guazare Adda longe da questa forteza mezo milio, como per li tempi pasati anno fato più volte, anze fusse fato dicta forteza, ma farino di bisognio che li fazano cappo ha questa volta dove he questa forteza et facendoli contrasto per la via de essa forteza harebero faticha ha passare. Anchora finelmente al dito tempo de guera per la via de essa forteza se potarebe dare sicorso a Lecho et al ponte da Lecho et Brippio, tute forteze de Vostra Signoria et il simile torne del dito secorso quando facesse di bisognio a dispeto dil campo. Anchora questa forteza è guardia et giave de tuto il Monte de Brianza et al dito tempo de guerra tuto esso Monte de Brianza pò stare et dormire siguramente siando fato bona guarda ha dicta forteza non pò acadere niente che nò vedano ho vero oldire li inimici et dicti inimici nò posano fare niente che nò sieno discoperti, facendo bona guarda como ho dito de sopra. Anchora questa forteza he di grande pericollo se la Signoria de Venitia piasseno hanche questo locho, lo farebeno fortificare in modo sarebe una altra Crema, et batareneno tuto il payexe de sopra questo locho siè ali confini de Vostra Signoria et de la Signoria de Venitia et al tempo de la estade questa forteza vene quasi a essere in mezo duo laco, zoè Adda, et li va Adda atorno, al tempo de lastade dove el le più abaso he alto al mancho braza XI et ala invernata li ha anchora Adda atorno ma non tanto alto, et quando Vostra Signoria volesse li potarebe anchora dare laqua più alta cossì dastade como da inverno zoè a rato per rato et havendo Vostra Signoria essa forteza li provederà che stareno siguramente et li vostri fidelissimi servitori del Monte de Brianza sarano ben contenti. Anchora havendo dicta Vostra Signoria essa forteza et metendo dentro uno homo che sia ato in talle cossa se farà tali ripparo che biade nessune non andarano in froxa ne in sinestro fora dil dominio de Vostra Signoria facendo uno mollo sotto questa forteza da giavare le nave, che honio anno li ne va amilliare de some et non posendo andare dicte biade in sinestro ne in froxa sarà forza che queste biade rimagnieno in lo dominio de dicta Vostra Signoria et quelli vorano vendere biade haverà di bisognio condurli a Millano, et vignando questa biada a Millano Vostra Signoria ne caverà li datij et la ma... che relevarene grande somma de dinari ala Ducale Camera et alterius in fra pocho tempo farà abondante il vostro Ducato de Millano che credo chel valerà più il sacho che il grano zoè che li anni sieno commij recoltj et facendo cossì li huomini de Vostra Signoria non aveno may meliore novelle. Anchora haverà di bisognio questo Comissario ho Castelano ho Offitiale che starà in essa forteza tenire una gozabiesa cum alchunij compagni et deli naveti per stracorere tuti li lachi zoè Adda, ma non sollamente ripararano alle biade, ma etiam li passa de le spiziarie et altre merchanzie asay, che paseno per le terre de la Signoria de Venezia in zà che suno froxate per sgniare li datij et in spizialitade per sgniare il datio Cremonexe quale intendo pageno de grandi datij, per la quale cossa credo che quando li dicti datierj non fusseno ingannati incantarebeno li
datij asay più quantitade. Anchora ripararano che nesuno altra merchantia non se froxarà li datij anze pagarano li consueti datij et non froxerano honio datio, et a questo modo li datij de Vostra Signoria se incantarano più et cum grande utilitade. Anchora rippararano che de honio cossa zoè lane, drapi, grasso, vino, stramno et de honio simille cossa si froxata et vano fora del dominio de dicta Vostra Signoria et va in le terre Venetiane et tute le predicte cosse pagarebeno datio ha Vostra Signoria. Anchora rippararano, havendo essa forteza, va grande quantitade de pesso che si froxato in le terre de la Signoria de Venizia che nò li andarà et che paga ha dicta Vostra Signoria ha intrare in Millano dinarij IIIJ per honio lipra, ultra che tignaranno Millano abondante de pesso. Lo prezio che domanderia de duchati imp. 980..... (manca il proseguo della lettera). A.S.M.: Fondo Comuni cart.62, senza data
Doc. 3 1483, 7 ottobre - Milano Officiali portus Olginate Me ha facto intendere Payno Dada havere inteligentia cum alcuni de la Valle San Martino de condure sin suso la rippa Dada del ferro del azale. Cum questo che non voleno venire lì al porto perchè dicono seriano discoperti et fariano male li facti loro, ma che sia mandato ad levare suso la rippa de là dove loro condurano. Et perchè questo non pò cadere salvo che ad utilità nostra e di subditi nostri volemo e te commettiamo che intendendo tu da esso Payno chi sono costoro, ad ogni soa richesta li daghi licentia de podere andare de là ad levare, cum naveti, tutta quella quantità de ferro e azale li serà conducto. Et quelli li condurano volemo siano salvi per le persone e robbe dali nostri, et così non li lassaray dare impazo, havendo però bona advertentia che per li dicti naveti non se commetta fraude de biade andandoli tu o mandoli uno di tuoy quando dubiti de froxatione. B. C. A.S.M.: Registri Sforzeschi, cart.158 – 1483, 7 ottobre
Doc. 4 1484, 6 gennaio - Olginate llustrissime et excellentissime signore. Avixo Vostra Signoria como sia Johannes Dada, Bernardo Crotto, et Petro Dada, Antonio dicto Bolda de Crotti, Micheli de la Beretta, Lantelmo de la Beretta suo fiollo, cum più de homini zinquanta armati de corazine, tarchoni, tarchete, lanze longe, spedi, partisane et de honio arme, ogi zircha a hore XVIIJ me sono venuto asaltare a questa mia forteza et hano feriti quatro miei de la guarda de la forteza, unde se nò fusse stato che io sempre li tengo bona guarda et grande adiuto credo me voleseno tore dicta forteza per darla ala Signoria de Venezia, perchè sono altre volte banditi da Vostra Signoria et anchora stano ....... per la grande unione che mantegneno continuamento. Anchora honio dì dano aviso ala Signoria de Venezia contro Vostra Signoria, etiam li arano dato adiuto in questa guerra dagandoge de le corazine, coramo de fare barde li anno dato, etiam più de pezzi quatrocento, et vano et praticheno a Bergamo como facimo nuy a Millano, sichè ...... Vostra Signoria che se degnia ha prendere a questo subito perchè siamo reduti qui in questa forteza circha homini vinti, et nò posano usire de dicta forteza dubitandomi che dicti bandezati nò me tolgeno apeze, ho vero nò me fazeno uno altro asalto a dicta forteza. (…) nò altro me richomando a Vostra Signoria et intendo che he arivato a Bergamo quatro millia persone per dargli adiuto a quisti bandezati. Ex Olzinate die VI januarij 1484. Servitor vestre Jacobino de Abdua cum richomandatione. Segue una postilla: «Silvestro dicto el matto di Testori» A.S.M.: Fondo Sforzesco - Carteggio Interno, cart.1126 - 1484, 6 gennaio
Doc. 5 1531, 19 luglio - Olginate Molto Ill.mo et ex.te Signor mio osservantissime. In questa hora son ritornato insieme cò il signor Colonello, siamo stati in compagnia a Olginà dove ho mandato la nocte passata il Capitanio Bastian Pizinardo cò la sua compagnia et di altre compagnie fin al numero dj 400 fanti passati di là, habiamo aspectato a Olginà fin al ritorno suo che erano già gionti alaqua per pasare riva però nò hano exequito quelo speravamo che dovesseno fare, hano conducto in qua fin a 25 o trenta bestie et alchuni presoni, però speravamo devesseno far magiore effecto.
Capitan Bastiano nò è ancor gionto al gionger suo se intendarà et V. S. sarà dil tuto avisato. …. Ex.tia dil signor Duca supplico V. S. sia contenta farle le mie ricomandationi. Anday ancora eri a Malgra et vidi bene tuto quelli siti. In Chivà adj 19 jullio 1531 Di V. S. Ill. hobedientissimo servitore Johanne Antonio Tanze. Indirizzata: Al molto Ill.mo et Ex.mo signor Alessandro Bentivoglio ducal Locotenente in Chomo A.S.M.: Fondo Sforzesco - Carteggio interno, cart. 1412 – 1531, 19 luglio
Doc. 6 1484, 22 ottobre – Vigevano Dux Mediolani etc. Intellecta supplicatione nobis exhibita nomine egregij et strenui Ambrosini de Longhignana peditum nostrorum praefecti generalis nobis dilectissimi: ac Jacobini dicti Payni de Abdua tenoris inferius annotati videlicet: Ill.me princeps: Superioribus annis Joannes Franciscus, Joannes Zacharias et Menopaxius de Crottis quondam Galeaz parte una: et Jacobinus de Abdua dictum Paynus ex altera: fecerunt quoddam instrumentum cambij cum beneficio litterarum Ex.tie V. Datum Mediolani primo julij 1478 signatum Bartholomeus Chalcus, et inter caetera dicti fratres de Crottis dederunt suprascripto Jacobino loco caeterorum aliorum bonorum Turrim unam plodatam et sollariatam cum domo una plodatam et sollariatam: rizeto: curte: et pecia una terrae prativae omnibus simile tenendo: iacentibus in loco de Olginate plebe Garlate: Ducatus vestri Mediolani: ubi dicitur in Quarnario: quibus choeret ab una parte lacus: ab alia heredi quondam d. Stephani de Crottis: ab alia Bernardini de Crottis: et ab alia strata: quae omnia sunt pertice tres vel circa etc. Et cum alijs clausulis: et solemnitatibus debitis prout in eo instrumento cambij continetur rogato per Silvestrum de Rocchis notarium Mediolani die 17 julij 1478. nunc vero ipse Jacobinus dictus Paynus vult vendere dictam Turrim et bona de quibus supra: devotissimo D. V. Servitori Ambrosino de Longhignana Capitaneo generali provisionatorum Ex. Vestrae pro precio prout sunt, seu erunt de accordo: et cum clausulis et promissionibus debitis: sed videntur obstare certa decreta Ex. V. quae disponunt Fortalicia et turrim obligari nec alienari posse … : prout in eis continetur: Ex quibus supplicantes ipsi coguntur D.V. presidium implorare: supplicando eidem humillime ut premissis attentis dignetur prefata D.V. per sua litteras patente edicere: decernere et mandare qui dictus Jacobinus dictus Paynus possit et valeat dictam turrim et bona de quibus supra: vendere et alienare predicto supplicanti et p.tus supplicans possit emere cum clausulis et solemnitatibus debitis: et talem alienationem factam valere et tenere: et contraveniri non posse: et heac omnia tute libere et impune dictis decretis et aliquibus alijs legibus: statutis: decretis: ordinibus: provisionibus: et decreto edito de anno 1423, quod incipit Providere volentes: et quibuscunque alijs in contrarium facientibus: quibus omnibus et ex certa scientia: et de V. potestatis plenitudine etiam absolvere derogare dignemini aliter rc. Annuentes itaque honestis supplicationibus memorati Ambrosini cuius commodum merito prospicimus: suis fide: integritate: et benemeritis erga nos et statum nostrum sic exposcentibus. Declarantes insuper memorato Jacobino dicto Payno licere dictam Turrim et bona in ipsa supplicatione nominata vendere alienare et de ipsis ad eius libitum et voluntate disponere ut ad dictam venditionem: et emptionem legitime deveniri possit. Tenore presentium ex certa scientia ac de nostre potestatis plenitudine etiam absolute dicto Ambrosino emendi: acquirendi: et acceptandi: memorato vero Jacobino dicto Payno vendendi: alienandi: transferendi: et cedendi libere et impune dictam Turrim: ac omnia et singula in dicta supplicatione mentionata et descripta pro eo precio et sub ijs pactis et condicionibus quibus partes ipse nivicem concordes fuerint plenam et liberam licentiam et facultatem damus, concedimus et impartimur. Aliquibus legibus, decretis, ordinibusque et praesertim Decreto edito de anno 1423 quod incipit Providere volentes rc.. et alijs quibusuis in contrarium quomodolibet disponendi non attentis quibus omnibus in hac parte ex certa scientia: ac nostre potestatis plenitudine etiam absolute derogamus ac derogatum esse volumus et jubemus: volentes dictas Venditionem et emptionem postquam factae fuerint et celebrate: perpetuum sortiri effectum: omnibus praedictis et alijs quibuscunque non obstantibus utsupra. Mandantes denuo omnibus et singulis officialibus nostris et subditis: ut has nostras licentiae et concessionis litteras firmiter observent: et faciant inviolabiliter observari. Ita tamen qui propter has nostras litteras juri alicuis tercij non intendi…. derogare. Datum Viglevani die xxij octobris 1484 B. Ch. A.S.M.: Registri Ducali, n. 117
Note:
1 - Sull’argomento del controllo del confine si confronti soprattutto per la parte riguardante il confine dell’Adda ad Olginate, lo studio di L. Zenobi, Guerra, stato e poteri locali sul medio corso dell’Adda alla metà del quattrocento. Organizzazione militare e difeasa dei confini, in Società e storia, n. 149, 2015. Alcune affermazioni contenute in questo articolo dovrebbero essere rilette alla luce di quanto evidenziato in questa revisione del precedente nostro articolo.
2 - B. Corio: Mediolanensis patria historia, 1503: “…In questi giorni (siamo nel giugno del 1418 – ndr) Pandolpho Malatesta intendendose con Thomo Campo Fregoso Duce di genua: venne per passare il fiume de Ladda ad Olginato e damnificare la Martesana. E puoi che furono passati alquanto de suoi per le guardie dil fiume fu commisso il facto darme: onde piu de cccc ne perirono tra ne la pugna e ne lacqua volendo fugire….”. D. Brivio, Pandolfo Malatesta signore di Lecco, 1982, pag. 16
3 - A.S.M.: Fondo Sforzesco - Carteggio interno, cart.1074 - 1482, 19 maggio 4 - A.S.M.: Fondo Sforzesco – Carteggio interno, cart.1126 - 1484, 28 gennaio 5 - A.S.M.: Fondo Sforzesco - Carteggio interno, cart. 897 - 1470, 22 febbraio
6 - A.P.Ol.: P-BF/X, cart.1, n. 1915: 1496 – 1501 Fascicolo con atti del processo tenuto in Milano riguardante il mancato pagamento di un fitto livellario dovuto da Pietro d'Adda e dai suoi eredi alla prepositura di Garlate e del livello posto su di un terreno in Olginate detto in “Gambalo o Seralis”. Anche in A.S., Fondo Pergamene di Olginate - 1487, 15 febbraio: Il sacerdote Giovanni Bassi, prevosto della chiesa dei Ss. Stefano e Agnese di Garlate, confessa e dichiara di aver ricevuto la somma di 24 lire e otto soldi imperiali moneta di Milano, da Francesco d’Adda figlio ed erede del fu Aluisio, abitante a Olginate, a saldo dell’affitto livellario di un terreno a ronco sito nel territorio di Olginate detto “in Gambalo”.
7 - A.S., Fondo Pergamene di Olginate - 1383, 20 giugno 8 - A.S. , Fondo Pergamene di Olginate - 1416, 6 novembre: “Actum in soprascripto loco Olzinate ubi dicitur ad portam /novam apud hostium domus hastenoris
habitationis domini Pasino de Ferarijs…” 9 - 1483, 25 febbraio: Il Prevosto di Garlate Giovanni Bassi attesta di aver ricevuto da “messer” Giovanni d’Adda del fu Martino, frate del terzo
ordine di S. Francesco, lire 32 imp. per il fitto di due anni di un terreno “ortivo”, appartenente alla chiesa di Garlate e posto in Olginate, dove si dice “alla bastita”. (A.S.M.: Fondo Notarile, Rocchi Silvestro , cart. 3227)
10 - A.S.: Sez. X, Vol. 1, q. 3 – 1577, 19 ottobre - “Notta delli beni imobili et livelli della prepositura de Santa Agnese de Olginate altre volte de Garlate”: “Item una peza di terra de campo dove si dice ala Gueia overo alla Bastia coverentia da due parte strada da laltra il lago et da laltra parte messer Jsaco Maldura. Pertiche 2 tavole 3”. Tre anni prima, la descrizione dello stesso terreno era diversa: “Una peza di terra campo ove si dice ala Gueia overo alla Bastia coherentia da una parte il lago, da l’altra strada, et da l’altra Gio: Antonio Testore – pertiche 2”; - A.P.Ol.: P-BF/I, cart. 1, n.1637, 1574 circa: “Nota delli Beni imobili della prepositura de S.ta Agnese de Olginate altre volte de Garlate fatta da me prete Gio Antonio Maria Vimercato prevosto de detta chiesa”; A metà del 1600 troviamo ancora lo stesso terreno: “Petia terre campive ubi dicitur alla Bastia cui coheret a duabus strata a mane lacus a monte Antonij de Testoribus perticae 2-6”, A.P.Ol.: P-BF/I, cart.3, n. 1648 – (Elenco dei beni e diritti del Beneficio Prepositurale di S. Agnese di Olginate, compilato dal Prevosto Giovanni Battista Ferrario. Con correzioni ed aggiunte del Prevosto Innocenzo Tartari)
11 - A.C.Ol.: Cart. 43, Cat. V, cls.I, fasc. 8, anni 1914-16 12 - A.S.M.: Fondo Acque p.a., cart. 310 - Il primo accenno su questa leggenda è riportato in uno scritto del 1750 riguardante una disputa per la
pesca fra il sig. Giovan Battista Testori e il Consorzio Arrigoni-Dugnani a quel tempo padroni della pesca nel lago di Olginate: “Se poi ho d’accordagli questo Ponte ovunque il Sig. Robbecco lo voglia, e che anche la Torre comunale di Olginate servisse qual Velletta da spiarne li vicini Laghi, io gli chieggo in cortesia come hanno potuto quei Quartieri assistenti al Ponte ed alla Specola, e quella Popolazione tutta rimanersene per tanti secoli anonima, se Olginate trasse la sua denominazione dal valoroso OLGINA ADDA 600 e più anni dopo il nascimento del Redentore”. Una nota a questo documento rimanda a Fanusio Campano (uno dei tanti pseudonimo di Alfonso Ceccarelli, vissuto tra il 1532 ed il 1583) che scrisse, fra l’altro, il “De familiis illustribus Italiae ac de earum origine” in 5 libri nel quale, nel IV libro, vengono descritte le origini della famiglia d’Adda. Fanusio e Raffaele Fagnani (autore di “Nobilium familiarum mediolanensium Commenta”) vengo citati, quasi tre secoli dopo, anche da Ignazio Cantù, ne “Le vicende della Brianza e de' paesi circonvicini”, sempre per descrivere le origini della famiglia d’Adda: “Tanto almeno è detto da Raffaele Fagnani e da Fanuzio. Questi due poi asseriscono, senza addurre argomenti, che questa famiglia trae il suo nome da Olgina eroe famoso presso i Goti e nobilissimo, che dopo molte guerre combattute presso l’Adda costrusse una torre, che poi fu chiamata di Olginate; e i suoi discendenti ottennero molti privilegi e furono chiamati d’Adda per la vicinanza di Olginate a questo fiume.” Questa leggenda, per ora senza fondamenti storici, fu ripresa da tutta la letteratura ottocentesca quando si doveva parlare delle origini di Olginate.
13 - A.S.M.: Fondo Finanza p.a., cart. 872: “…altre volte per secoli intieri passati vi era fabricato (sopra l’arco – ndr) su la ripa del detto fiume Adda un molino terraneo da due ruote, et che sino dell’anno 1518 era rovinato et inhabile al macinare, come dalla fede estratta da libri Camerali (…) perché sino dell’anno 1518 cessò l’obligo di pagare l’Annata, perché essendo il molino rovinato, cessava l’uso dell’acqua, per il quale solamente trattandosi di acqua Regale correva l’obligo del pagamento dell’Annata…”
14 - A.S.M.: Fondo Finanza p.a., cart. 872: “Ne giova al Notificante quella circostanza che deduce da alcuni pilastri o sij piloni, che con grande apparato ha dimostrato nel suo dissegno, vi sijno nell’altra ripa bergamasca, chiamandoli Vestigij del preteso Ponte o sij Porto, a quali corrisponda l’Arco o sij Ponte sopra il quale vi è il Giardinetto controverso…”.
15 - A.S.M.: Fondo Acque p.a., cart. 310 e Biblioteca Angelo Maj di Bergamo: Muraglioni lungo l’Adda, anno 1750 16 - A.S.M.: Fondo Notarile, cart. 5897 - notaio Gabriele d'Adda: 1499, 4 febbraio - Testamento di Stefano Crotti 17 - A.S.M.: Fondo Notarile, cart. 5897 - notaio Gabriele d'Adda: 1499, 2 aprile 18 - A.S.M.: Fondo Notarile, cart. 5897 - notaio Gabriele d'Adda - ibidem 19 - A.S.M.: Fondo Acque p.a., cart.309 - 1662, 8 agosto. Il termine probabilmente deriva da “maiolam”, uno strumento a percussione, detto poi
“magliola”, usato per convocare le assemblee degli abitanti di un paese. In antico veniva detto “mallo”. 20 - A.S.M.: Fondo Finanza p.a., cart. 872 21 - Nel 1608, il governatore di Milano emise una “grida” con cui ordinava a tutte le Comunità del Ducato interessate dal passaggio dei corrieri
diplomatici di Roma e Venezia, di provvedere alla loro protezione dagli assalti dei banditi mentre transitavano sul rispettivo territorio comunale. Venne quindi istituito un corpo di guardie armate di archibugi a ruota pronto ad intervenire in caso d’allarme dato da vedette che
stazionavano giorno e notte sulla torre della comunità Questa “grida” venne riconfermata diverse volte nei decenni successivi cosicché le varie Comunità del territorio, specialmente quelle che gestivano i traghetto sull’Adda come Brivio ed Olginate, dovettero sobbarcarsi altre gravose spese per mantenere in efficienza questo sistema di sorveglianza.
22 - "Dal Regio Ducal Magistrato si è ordinato la demolizione della vecchia chiesa di S. Margherita con la vicina torre, posta vicino al lago in fondo alla Contrada di mezzo di questo luogo di Olginate, per servirsi dei materiali di questi distrutti edifici per fare la nova strada Anzana longo il lago, per comodo di condur le barche con facilità sopra il corrente dell'Adda, dirimpetto ad Olginate. Questa demolizione della chiesa si è cominciata il giorno 11 febbraio ..." (A.P.Ol.: VM-BF/III)
23 - La maggiore parte della spesa venne sostenuta dalla Comunità. (A.P.Ol.: VM-BF/III) 24 - "Turrim unam plodatam et sollariatam cum domo una plodatam et sollariatam: rizeto: curte: et pecia una terrae prativae omnibus simile tenendo: iacentibus in loco de
Olginate plebe Garlate: Ducatus vestri Mediolani: ubi dicitur in Quarnario: quibus choeret ab una parte lacus: ab alia heredi quondam d. Stephani de Crottis: ab alia Bernardini de Crottis: et ab alia strata: quae omnia sunt pertice tres vel circa etc." (A.S.M.: Registri Ducali, n. 117 – 1484, 22 ottobre)
25 - A.S.M.: Fondo Sforzesco - Carteggio interno, cart. 897 - 1470, 22 febbraio 26 - A.S.M.: Archivio Diplomatico, cart. 476, n° 18 27 - Biblioteca Universitaria di Halle van der Salle: Fondo Morbio e in Marcora: L'Abbazia Benedettina di Civate, BPL, 1985 28 - A.S.D.: Fondo Pergamene di Olginate - 1383, 20 giugno 29 - B.A.: AMB.H.VII.32, n° 3451 - 1439, 13 febbraio 30- B.A.: AMB.H.VII.32, n° 863bis - 1440, 7 settembre: Decreto di cittadinanza di Como, concessa a Stefano de Crottis e figli dai “sapientes
provisionis cumarum" Luchino "de Laporta", Abondio "del ponte", Paolino de Clericis, Petrolo de Rezonico, Paganolo de Marinis, Antonio de Mangiacabalis detto Fiorentino, Primo de Retegnio, Anrigolo de Soldino, e Giovannolo de Campatiis, non che dal referendario Giovanni de Castiliono, e dal podestà Giovanni Bellono.- B.A.: AMB.H.VII.32, n° 863 - 1440, 17 settembre: Il duca Filippo Maria Visconti conferma il decreto di cittadinanza comasca rilasciato a Stefano de Crotis o Crottis e suoi figli concessa dai Deputati dell'Ufficio di Provvisione di Como.
31 - A.S.M.: Registri Ducali Sforzeschi – Registro Missive, n. 3 – 1450, 18 dicembre 32 - A.S.M.: Registri Ducali, n. 54 – 1458, 15 marzo: “Ducissa Mediolani etcaetera. Galeaz de Crottis de Olginate presentium ostende conducerij seu conduci faciendi
ex ducatu nostro mediolani vel districtu nostro Laudensis ad dictum locum Olginate salmas quatuor bladi semel in ebdomoda pro suo et massariorum suorum usu, tute libere impune ac omni inhibitione remota. Harum tenore liberam licentiam concedimus et impartimur Mandantes quibuscunque offitialis et subditis nostris quatenus has nostras litteras hinc ad callende maij proxime futuru valituris observent et fatiant observare et attento scribentis computum de dicto blado teneant advertanique ne obinde maior quantitas conducatur et fraus ulla conmittatur. Mediolani die xv martij 1458”.
33 - A.S.M.: Registri ducali, n. 190 – 1453, 19 gennaio 34 - P. Pensa: “Francesco Morone in Lecco avventuriero o patriota?” 35 - A.S.M.: Fondo Sforzesco, cart. 663 – 1453, 23 gennaio 36 - V. Adami: “Episodi della guerra tra Milanesi e Veneziani in Valsassina 1452 -1454”, in “Archivio Storico Lombardo” - 1926, Anno LIII, Fasc. X-XII 37 - E’ il Vicario Generale del Duca 38 - A.S.M.: Fondo Sforzesco – Carteggio interno, cart. 663 – 1453, 17 maggio 39 - Sono “Stefano et Cavallino fratelli Dada et fratelli de Pagano Dada habitatori de Ulzinate, quali ancora loro fanno il simile secondo ma informato Galeazo Croto”.
In questa lettera si parla anche di altri capi del contrabbando di Galbiate: Bazono da Riva, Galeazono da Riva, Lancialoto et Marsilio da Riva. 40 - A.S.M.: Fondo Sforzesco – Carteggio interno, cart. 663 – 1453, 17 luglio 41 - A.S.M.: Fondo Sforzesco – Carteggio interno, cart.886 - 1468, 9 ottobre: “Quando Donibello mio fratello, se partite de qua, ordinò con un fedelissimo
servitore, de Vostra Excellentia giamato domino Galeaz de Crotto habitatore de Olginà confinante de la Vale Sancto Martino, che intendendo luy cossa alcuna dal canto di là, me ne avisasse fidelmente aciò che jo ne puotesse subito dare aviso a Vostra Signoria”.
42 - A.S.M.: Fondo Sforzesco - Carteggio interno, cart. 671 - 1461, 9 novembre 43 - A.S.M.: Fondo Missive ducali, cart. 53 - 1462, 27 gennaio - "Galeaz de Crottis, ... crediamo tu abia facto ad ben fine tu hay tamen usata una gran legereza et
simplicità in mettere ad terore queli nostri homini da Lecho sotto falso romore che la gente dela Illustre Signoria da Venetia devevano venire ad quela tera nostra de Lecho. … Ben te dicemo che ad stare attento et ...... per ogni caso che potesse occorre è ben facto, ma è stata molto mal facto lacto che tu hay usato el quale ne è molto despiaciuto como ò dicto. Mediolani XXIJ januarij 1462"
44 - A.S.M.: Registri Ducali Sforzeschi - Registri Missive, n. 3 – 1450, 5 ottobre 45 - A.S.M.: Registri Ducali Sforzeschi - Registri Missive, n. 3 – 1450, 5 ottobre 46 - A.S.M.: Fondo Militare p.a., cart. 365, Piazzeforti Comuni 47 - A.S.Bg.: Fondo Notarile, notaio Viviano Gatti, 2a, I, 21
48 - A.S.M.: Fondo Notarile, cart. 19, notaio Zanolo Cafferario - 1398, gennaio 29: Carlino fq. ser Antonio de Abdua, ab. Olginate, pieve di Garlate, comitato di Milano, "ex ilis hominibus LXXV" che nei mesi di giugno, luglio e agosto servirono il duca [Gian Galeazzo Visconti] nella spedizione contro Mantova, riceve, a nome di quelli di Galbiate, Olginate, Garlate, Civate e del territorio Cernuschese, dai fratelli Andriolo e Petrino fq. dm. Belo de Schachabarozis, ab. Garlate, pieve di Garlate, comitato di Milano, 9 lire di imperiali per le spese e per lo stipendio di detti uomini.
49 - A.S.M.: Registri ducali, n. 146 – 1449, 20 aprile: “Sia fatta Crida per parte deli illustrissimi S.ri Capitanei et caetera Che ciaschuna persona de le infrascripte parentele che habitano nel Monte de Brianza vegna qua davanti ad li prefati S.ri infra tre dì proximi da venire a farne in le loro
mane o …. deli suoi signori, il debito iuramento de fidilictade, sotto pena de rellassione et de confiscatione de tutti soi benni, nela qual pena incoreranno inremissibilmente se sarano negligenti o retignenti ad obedire ale presenti grida o vero mandano qua doe persone per cadauna parentela con pieno mandato per fare la dicta fidelità ut supra. Nomina quorum parentele sunt hec videlicet:
- parentella illorum de Ripa - parentella illorum de la Canalis - parentella illorum de Adda - parentella illorum de Isacchis - parentella illorum de Dalphinonum - parentella illorum de Molgola - parentella illorum de Ayroldis de Robiate imbersago
- parentella illorum de Renditoribus de perego - parentella illorum de Contri …” 50 - Nel maggio il Segretario Ducale, Cicco Simonetta, ordinava al Capitano della Martesana di catturare Pagano d’Adda, abitante di Olginate, il
“quale era in presone qua in le mano de messer Galeotto, nostro capitaneo de iustitia, se n’è fugito et desideramo rehaverlo, ve comittiamo et volimo servati ogni modo et via per prehenderlo …” (A.S.M.: Registri Ducali Sforzeschi - Registri Missive, n. 4 – 1451, 6 maggio)
51 - A.S.M.: Fondo Sforzesco - Carteggio interno, cart 673 – 1462, 23 luglio 52 - A.S.M. : Fondo Sforzesco – Carteggio interno, cart.673 – 1462, 22 dicembre 53 - A.S.M.: Registri ducali, n. 190 - 1453, 16 febbraio: “Capitaneo Martesane. Volimo che recevuta la presente mandi mandi per Galeaz croto, Johanne altramente
dicto lapparenzo da Adda, polonio da lavello et paghano da adda, et gli comandi per nostra parte che subito senza condictione ne dimora alchuna vegnano qui, et se presentino da zorzo aliprando nostro officiale sopra le cavallari. Datum ut supra (da Milano 16 febbraio 1453 - ndr) Mar…. C.”.
54 - A.S.M.: Fondo Sforzesco – Carteggio interno, cart. 664 - 1454, 25 settembre: “Magnifice et potens domine mi colendissime. Respondendo ad una vostra de dì XXV instantis. Dicho essere vero che Galeazo Crotto ha promesso al meyo offitio uno cum li altri da Olzinà de non froxare biade ne contrafare ad li ordeni ducali. Et cussì sono cauto do esso et in vero certo sono che esso non cometterà frude alchuna, perchè lè valenthomo et anche servitore del Illustrissime Signore nostro. Ex Vicomercato die XXV septembris 1454. E. d. V. Fidelissimo servitor Paulus Amiconus”
Indirizzata: “Magnifico et potenti viro domino Cicho de Callabria ducali secretario domino suo colendissimo”. Sul contrabbando tra le due sponde del fiume aAdda, davanti ad Olginate, si rimanda all’artcolo: G. Aldeghi – G. Riva: “Adda fiume di confine:
contrabbando e spionaggio tra Olginate e la Valle San Martino nella seconda metà del quattrocento” in “Archivi di Lecco", Anno XVII - N. 4/1994 oppure al link: https://www.academia.edu/11015232/ADDA_FIUME_DI_CONFINE_CONTRABBANDO_E_SPIONAGGIO_TRA_OLGINATE_E_LA_VALLE_S._MARTINO_NELLA_SECONDA_MET%C3%80_DEL_QUATTROCENTO_Adda_border_river_smuggling_and_spying
_between_Olginate_and_the_Valley_of_Saint_Martino_in_the_second_half_of_the_XV_century. In questo saggio si tratta approfonditamente si è arrivati alla promessa tra il Duca e la Comunità di Olginate per evitare le “froxe”. 55 - A.S.M.: Registri Ducali, n. 54 – 1458, 26 aprile: “Ducissa Mediolani etcaetera. Pagano et Jacobino fratribus de abdua presentium ostendi conducendi seu conduri
faciendi ex ducatu nostro mediolani vel districtu nostri laudensis ad terram nostram olginatem montis briancie salmas tres bladi cuiuslibet generis in ebdomada pro usu suo et massariorum suorum. Tute libere et impune ac omni inhibitione remota. Harum tenore liberam licentiam concedimus et impertimur Mandantes Capitaneo nostris devetus ceterisque offitialis et subditis nostris quatenus has nostras licentie litteras hinc ad callende jullij proxime futuru valituris observent et fatiant observare et attento scribentis computum de dicto blado teneant advertanique ne obinde maior quantitas conducatur et fraus ulla conmittatur. Mediolani die xxvj aprilis 1458.
Refirmatus die v julij per unum mensem”. 56 - A.S.M.: Fondo Sforzesco – Carteggio interno, cart. 676- 1465, 9 agosto 57 - A. Cherubini, Vocabolario Milanese–Italiano: Saggio d’osservazione su l’idioma brianzuolo, vol.V, Milano, 1856 58 - A.S.M.: Registri Sforzeschi, cart.158 – 1483, 7 ottobre 59 - A.S.M.: Registri Sforzeschi, cart.158 – 1483, 7 ottobre 60 - A.S.M.: Fondo Sforzesco - Carteggio interno, cart.1074 - 1483, 28 ottobre 61 - A.S.M.: Fondo Religione p.a., cart. 2887 62 - A.S.M.: Pergamene per Fondi – Fondo di Religione, cart. 335; Si veda anche: G. Aldeghi – G. Riva: “Le vicende della chiesa e del convento di Santa
Maria la Vite in Olginate nella seconda metà del 1400” in “Archivi di Lecco”, Anno XX - N. 4/1997 oppure al link: https://www.academia.edu/10829354/LE_VICENDE_DELLA_CHIESA_E_DEL_CONVENTO_DI_SANTA_MARIA_LA_VITE_IN_OLGINATE_NELLA_SECONDA_META_DEL_1400_THE_EVENTS_OF_THE_CHURCH_AND_THE_CONVENT_OF_SANTA_MARIA_LA_VITE_IN_OLGINATE_IN_THE_SECOND_HALF_OF_1400
63 - L’ultimo documento in cui si parla di Galeazzo Crotti è del 9 ottobre 1470 (A.S.M.: Fondo Sforzesco – Carteggio interno, cart. 897). Dopo
questa data, allo stato attuale delle ricerche, non viene più citato o non si è trovato alcun documento da lui sottoscritto oa lui riferito. Il 16 ottobre 1476, in un atto notarile, Bernardino de Crotti figura come “figlio del fu” Galeazzo (A.S.M.: Fondo Notarile, Rocchi Silvestro, cart. 3227)
64 - A.S.M.: Registri Sforzeschi, cart. 216, p. 113 65 - A.S.M.: Fondo Notarile, cart. 2346, notaio Oliviero Corti 66 - A.S.M.: Fondo Comuni, cart. 62, senza data 67 - A.S.M.: Fondo Comuni, cart.62, senza data 68 - La “corrobiessa” o “gozabiessa” era una grossa imbarcazione con più di venti remi, rostrata e armata con spingarde; poteva trasportare circa 60
uomini 69 - A.S.M.: Registri Ducali, n. 117 – 1484, 22 ottobre 70 - A.S.M.: Fondo Sforzesco - Carteggio interno, cart. 1074 - 1483, 15 luglio 71 - A.S.M.: Registri Sforzeschi, cart. 158 -1483, 2 giugno 72 - A.S.M.: Registi Ducali, n. 115 – 1483, 14 luglio 73 - A.S.M.: Fondo Sforzesco - Carteggio interno, cart. 1074 - 1483, 18 luglio 74 - A.S.M.: Fondo Sforzesco - Carteggio interno, cart. 1074 - 1483, 18 luglio 75 - A.S.M.: Fondo Sforzesco - Carteggio interno, cart. 1074 - 1483, 18 luglio 76 - A.S.M.: Fondo Sforzesco - Carteggio interno, cart.1074 - 1483, 4 giugno 77 - Tra l’altro era uomo di fiducia di Ludovico il Moro, prendendo anche parte all’arresto di Cicco Simonetta (Archivio Storico Lombardo, 1988) 78 - A.S.M.: Fondo Sforzesco - Carteggio interno, cart. 1074 - 1483, 18 luglio 79 - A.S.M.: Fondo Sforzesco - Carteggio Interno, cart.1126 - 1484, 6 gennaio 80 - A.S.M.: Registri Sforzeschi, cart.162 - 1484, 8 maggio 81 - A.S.M.: Fondo Sforzesco - Carteggio Interno, cart. 1126 - 1484, 28 gennaio 82 - A.S.M.: Registri Ducali, n. 117 – 1484, 22 ottobre 83 - A.S.M.: Fondo Sforzesco - Carteggio interno, cart. 1074 - 1483, 18 luglio
84 - A.S.M.: Registri Ducali Sforzeschi – Registri Missive, n. 5 – 1451, 29 ottobre 85 - A.S.M.: Registri ducali, n. 190 – 1452, 4 gennaio 86 - A.S.M.: Registri Ducali, n. 51 – 1454, 23 febbraio 87 - A.S.M.: Registri Ducali, n. 51 – 1454, 1 novembre 88 - A.S.M.: Fondo Sforzesco – Carteggio interno, cart. 666 – 1456, 31 agosto 89 - P. Pensa: “Francesco Morone in Lecco avventuriero o patriota?” - “Lancillotto Visconti provvedeva a porre in condizioni di difesa la terra di Olginate, facendo
guardare la torre di quella località da Palamede d'Adda, subentrato ad Ambrosino da Longhignana.” (Fonte: ASM, Reg. miss. 211, c. 274, a Lancillotto Visconti, 31-7-1499 e 4-8-1499)
90 - A.S.M.: Pergamene per Fondi – Fondo di Religione, cart. 355 – 1491, 11 gennaio 91 - A.S.M.: Fondo Sforzesco - Carteggio interno, cart.1126 - 1490, 7 maggio 92 - A.S.M.: Frammenti Registri Ducali, cart. 10, fasc. 211 - 1499, 8 agosto 93 - R. Beretta, Gian Giacomo de Medici nella Brianza (1527-1531) 94 - Come viene chiamato, nelle cronache del tempo, il complesso fortificato 95 - Luca Contile, "La historia de fatti de Cesare Maggi da Napoli ecc. ", Pavia, 1564 96 - Luca Contile, "La historia de fatti de Cesare Maggi da Napoli ecc. ", Pavia, 1564 ed anche in C. Marcora, La Pieve di Lecco ecc., pag. 10 97 - A. Grumello, “Cronaca”, Milano, 1856 98 - I. Cantù, "Le vicende della Brianza, ecc", pag. 97 99 - Salvo diversa indicazione, per l'assedio al Medeghino in Lecco, ci si è basati su: P. Pensa: L'assedio del Medeghino in Lecco, Ed. E. Bartolozzi, Lecco
1960 100 - A.S.M.: Fondo Sforzesco - Carteggio interno, cart. 1412 –1531, 23 maggio – 1531, 8 giugno 101 - A.S.M.: Fondo Sforzesco - Carteggio interno, cart. 1412 – 1531, 26 maggio 102 - A.S.M.: Fondo Sforzesco - Carteggio interno, cart. 1412 – 1531, 15 giugno 103 - A.S.M.: Fondo Sforzesco - Carteggio interno, cart. 1412 – 1531, 19 luglio 104 - A.S.M.: Fondo Sforzesco - Carteggio interno, cart. 1413 105 - A.S.M.: Fondo Sforzesco - Carteggio interno, cart. 1413 106 - Anche con questo nome si indicava la "Torre di Olginate" 107 - A.S.M.: Fondo Sforzesco - Carteggio interno, cart.1412 – 1531, 6 dicembre 108 - I. Coppelli, La guerra del Medeghino contro Francesco II Sforza, Archivio Storico Lombardo, 1930, fasc 1-2 serie 6 109 - "Scavando le fondamenta per una casa sita sui fondi di proprietà dei figli della ved. Sirtori Giuseppina, verso Garlate, denominati già di Casa Vitali, (e anche "alla
Bastia") alla profondità di centimetri 60 circa, da un manovale si rinvennero circa 70 monete d'oro, cioè zecchini coniati circa 4 secoli sono, in diverse città d'Italia, come Genova, Venezia, Roma, parecchi sono coll'effigie di Papa Leone X (1513-1521) e di Alessandro VI (1492-1503). Furono esaminate da un numismatico e furono calcolate circa L. 12,50 l'una. La proprietaria si comportò come richiede il codice". A.P.Ol.: Liber Cronicus, anno 1905 - Societa Storica per la Provincia e antica Diocesi di Como
110 - A.S.M.: Fondo Sforzesco – Carteggio interno, cart.1412 111 - A.S.M.: Fondo Sforzesco – Carteggio interno, cart.1412 112 - A.S.M.: Fondo Confini p.a., cart. 239 113 - A.S.M.: Fondo Notarile, cart. 5863 – notaio Pietro Maggi 114 - A.S.M.: Fondo Acque p.a., cart. 310 115 - A.S.M.: Fondo Confini p.a., cart. 258 116 - A.S.M.: Fondo Acque p.a., cart. 310 117 - A.S.Co.: Catasto - Mappe Teresiane 118- Questa fondazione doveva assistere i poveri di diversi comuni lombardi, fra i quali Olginate, Capiate e Villa San Carlo, assicurando loro
assistenza sanitaria ed economica, favorendo l'alfabetizzazione dei fanciulli attraverso la gestione di scuole private. L'abate nominò amministratore della fondazione il conte Febo Borromeo d'Adda, consigliere di Stato – vedi: M. Mattarozzo, La carezza della beneficenza, Milano, 2008
119 - M. Mattarozzo, La carezza della beneficenza, Milano, 2008, pag. 56 120 - A. Villa, Ristrutturazione e risanamento di Villa Sirtori 121 - A. P. Ol.: ME-ST/I, cart.1, Memorie A. Sirtori 122 - A. Villa, Ristrutturazione e risanamento di Villa Sirtori