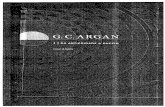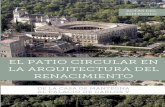Leer lo ilegible: Los casos de Mirtha Dermisache y León Ferrari
La psicotecnica in Giulio Cesare Ferrari: dall’esperienza manicomiale al contesto internazionale
Transcript of La psicotecnica in Giulio Cesare Ferrari: dall’esperienza manicomiale al contesto internazionale
DirettoreGiordano Pierlorenzi
Direttore Poliarte di Ancona
Comitato scientifico
Per l’ergonomia
Francesco Marcolin
Università di Udine
Melchiorre Masali
Università di Torino
Per l’antropometria
Emanuela Gualdi
Università di Ferrara
Elisabetta Marini
Università di Cagliari
Margherita Micheletti Cremasco
Università di Torino
Mila Tommaseo Ponzetta
Università di Bari
Per la psicologia del lavoro
Enzo Spaltro
Università delle Persone di Bologna
Referente per l’estero
Irene Schlac
Università di Berlino
Comitato di redazione Poliarte
Andrea Montesi
per l’ergonomia e l’antropometria
Maria Papacosta
per la psicologia generale
William Sbacco
per la psicologia del lavoro
Chiara Sgreccia
per la cultura del design e filosofiadel progetto
A MISURA D’UOMO
SEZIONE DIPSICOLOGIA DEL LAVORO
Omnia in mensura et numero et pondere
Le esigenze dell’uomo contemporaneo sono così evolute e amplificate da richie-dere alle moderne scienze e tecnologie soluzioni sempre più avanzate. La masscustomization s’impone nella nostra epoca consentendo all’uomo di personalizzareun prodotto industriale adattandolo a sé. L’uso flessibile del cam (Computer AidedManufacturing) gli consente infatti di soddisfare il proprio desiderio di distinguersidagli altri consumatori. È il ritorno all’oggetto su misura, in cui, tuttavia, la tradi-zione artigiana del capolavoro deve dialogare con la produzione industriale in serie,attuando la cultura postindustriale e oltrepassando la postmodernità. Così, l’unico eil molteplice, l’originale e lo standard, il singolare e il plurale superano la bipolaritànella coincidentia oppositorum: artigianato–industria, arte–design. La misura ritornadunque la cifra delle relazioni spaziali con gli oggetti e con gli uomini, il criterioper conoscere e progettare, lo strumento per conseguire la qualità della vita e ilbenessere personale e sociale. Il merito di questa rivalutazione del “su misura” spettacertamente a discipline come il design e l’ergonomia, che incentrandosi sull’uomolo riaccreditano “misura di tutte le cose”, fattore primario nel rapporto con glioggetti, le macchine e l’ambiente, dando nuovo valore alle concezioni di Vitruvio,Leonardo e Le Corbusier.
La collana presenterà risultati di studi, ricerche e sperimentazioni antropome-triche, prossemiche, ergonomiche e della psicologia sociale, facendo riferimentoall’ambiente in tutte le sue declinazioni, in particolare quello di lavoro, maggior-mente condizionante per l’uomo. Una collana con la finalità di divulgare la culturadel benessere, ammiccando al bellessere. Una cultura che consenta di migliorare leproprie condizioni di vita passando da uno stato in cui possa aVermare «Sto benequi, ora» a quello in cui possa aggiungere «Mi piace star bene qui, ora». Una culturache promuova l’educazione emotiva a fianco di quella razionale, per un umanesimointegrale di maritainiana memoria.
Il bellessere è una realtà aumentata, il passare da una situazione di carenza a una diabbondanza, come sostiene Enzo Spaltro. È vivere in pienezza, in quella condizionefavorevole che sant’Agostino descrive icasticamente con l’aforisma: «La misuradell’amore è amare senza misura», a distinguere il contingente dal trascendente.
La collana è strutturata in due sezioni, una dedicata all’antropometria e all’ergo-nomia, l’altra alla psicologia del lavoro, in un unicum sottile e immateriale semprepresente, rappresentato dall’idea di progetto.
Questo volume è stato realizzato dal Centro interdipartimentale Aspi –Archivio storico della psicologia italiana con il contributo del Dipartimentodi psicologia dell’Università degli studi di Milano-Bicocca, in collaborazionecon Fondazione Isec e Fondazione Pirelli.
Psicologi in fabbrica
Storie e fonti
a cura di
Mauro Antonelli, Paola Zocchi
Contributi diMauro Antonelli
Paola BianchiMartina De Petris
Roberta GarruccioGiuseppe Lupo
Marina ManottaIlaria Montanari
Stefano MussoRoberta Passione
Paola Zocchi
Copyright © MMXIIIARACNE editrice S.r.l.
via RaVaele Garofalo, 133/A–B00173 Roma(06) 93781065
isbn 978-88-548-xxxx-x
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.
Non sono assolutamente consentite le fotocopiesenza il permesso scritto dell’Editore.
I edizione: dicembre 2013
!
9
Indice 11 Introduzione Mauro Antonelli e Paola Zocchi 21 L’uomo al lavoro: un capitolo di storia del positivismo Roberta Passione 45 Il lavoro di fabbrica tra organizzazione scientifica e re-
lazioni sociali Stefano Musso 69 La psicotecnica in Giulio Cesare Ferrari: dall’esperien-
za manicomiale al contesto internazionale Paola Zocchi 109 L’esame ai conducenti di autoveicoli negli archivi di
Ugo Pizzoli e Vito Massarotti Paola Bianchi 129 Agostino Gemelli e la psicotecnica nel secondo dopo-
guerra. Ricerca, applicazione, divulgazione nelle carte del Fondo Gemelli-Scolari
Ilaria Montanari 155 Psicotecnica e orientamento professionale in Cesare
Musatti Marina Manotta
Indice
!
10!
177 Francesco Novara e la psicologia del lavoro in Olivetti nello snodo degli anni Sessanta
Roberta Garruccio 191 Il Laboratorio di psicotecnica della Pirelli Martina De Petris 203 Psicotecnica e letteratura in Ottiero Ottieri Giuseppe Lupo 215 Indice dei nomi
69
La psicotecnica in Giulio Cesare Ferrari
Dall’esperienza manicomiale al contesto internazionale
Paola Zocchi*
1. Premessa L’opera e il profilo scientifico dello psichiatra e psicologo
emiliano Giulio Cesare Ferrari (1867-1932)1 sono stati più volte oggetto di indagine da parte degli storici della psicologia italia-na. Particolarmente studiati sono stati da un lato il suo ruolo nella nascita e nella promozione della disciplina in Italia (so-prattutto attraverso la Rivista di psicologia, da lui fondata nel 1905), dall’altro i suoi contributi nel campo della psicopedago-gia (riabilitazione dei frenastenici e dei giovani criminali) e del-la psicologia applicata all’attività manicomiale2. Solo negli ul-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
* Centro interdipartimentale di ricerca Aspi - Archivio storico della psico-logia italiana, Università degli studi di Milano-Bicocca, [email protected].
1 Giulio Cesare Ferrari è noto soprattutto per aver tradotto e diffuso in Ita-lia le opere di William James all’inizio del Novecento e per aver fondato nel 1905 la Rivista di psicologia, il primo periodico italiano dedicato a questa di-sciplina. Fu direttore del Manicomio di Imola dal 1907 al 1924 e dell’Ospe-dale psichiatrico Roncati di Bologna dal 1924 al 1932. Si occupò a lungo di assistenza ai minori, dirigendo dal 1903 al 1907 l’Istituto medico-pedagogico di Bertalìa e fondando Castelguelfo (Imola) nel 1910 la Colonia libera per de-ficienti gravi e giovani criminali, la cui esperienza terminò allo scoppio della prima guerra mondiale.
2 Cfr. Babini (1996); Guarnieri (1996); Lazzari (1998); Lazzari & Quaran-ta (1998); Mucciarelli (1984); Quaranta (1984; 2006).
Zocchi
!!
70
timi anni l’attenzione degli storici ha cominciato a volgersi an-che all’impegno profuso da Ferrari nel campo della psicologia del lavoro3.
A questo proposito, il recente riordino del suo fondo archivi-stico e librario, conservato all’Università degli studi di Milano-Bicocca, presso il centro di ricerca Aspi - Archivio storico della psicologia italiana4, fornisce ulteriori informazioni e consente di tracciare un quadro più completo del ruolo giocato da Ferrari nello sviluppo della psicotecnica e delle sue applicazioni, sia in ambito nazionale, sia e soprattutto nel più vasto contesto inter-nazionale.
2. Le prime esperienze Ferrari arrivò ad occuparsi di psicotecnica attraverso la psi-
cologia sperimentale e le sue applicazioni in campo psichiatri-co. Le sue prime esperienze in questo senso furono effettuate a Parigi nel 1895-96 presso il Laboratorio di psicologia fisiologi-ca diretto da Alfred Binet, dove imparò ad utilizzare i «mental tests» e gli strumenti di misurazione. Al modello di tale labora-torio si ispirò quando, al rientro in Italia, decise di ampliare e attrezzare, in collaborazione con Giuseppe Guicciardi, il Labo-ratorio di psicologia sperimentale dell’Istituto psichiatrico San Lazzaro di Reggio Emilia, già impostato in nuce anni prima da
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3 Cfr. Bongiorno (2009); Passione (2012). Un primo spunto per questi
studi si trova già in Pogliano (1986). 4 Il Fondo Ferrari (d’ora in poi FF) è stato donato al centro Aspi nel 2006
dall’Istituto Ferrari di Padova, a cui gli eredi lo avevano affidato. L’archivio, conservato dalla figlia Nora dopo la morte di Ferrari, raccoglie lettere, mano-scritti e dattiloscritti, casi clinici e perizie psichiatriche, appunti e fotografie. Il nutrito carteggio, in parte ancora inesplorato, annovera circa 700 corrispon-denti diversi, per un totale di circa 2.700 lettere. Il lavoro di riordino e inven-tariazione archivistica è attualmente in fase di chiusura e il materiale sarà pre-sto consultabile in formato digitale sul portale www.aspi.unimib.it. Il fondo comprende anche una raccolta libraria, composta di volumi, opuscoli e riviste, già catalogati e consultabili nell’opac della Biblioteca di ateneo.
La psicotecnica in Giulio Cesare Ferrari
!
71
Gabriele Buccola (Ferrari, G. C., 1984, p. 249; Babini, 1996; Zocchi, 2013).!
Nel 1898 usciva l’articolo “Ricerche ergografiche nella don-na” (Ferrari, 1898), in cui Ferrari dava conto degli esperimenti effettuati con l’ergografo di Mosso su alcune malate e infermie-re del manicomio:
A quel tempo, eccettuate la Kulmpke-Déjérine5 a Parigi, la
Joteyko6 e la Kipiani7, non era facile incontrare in Europa delle donne nei laboratori, né averne come soggetti di studio. Ma siccome a Reggio ero medico in una sezione femminile di cui il padiglione era attiguo al laboratorio di psicologia, potevo di-sporre di preferenza, come soggetti, delle donne, malate o in-fermiere. Con l’aiuto dell’ergografo di Mosso, notai subito che in generale la donna, anche se non è mancina nella vita e al di-namometro, presenta una curva ergografica del braccio sinistro assai superiore per il numero (ma non per altezza) delle fles-sioni a quella del braccio destro, di cui la curva è analoga alla curva degli uomini (Ferrari, G. C., 1984, p. 250). Il tema del lavoro, che in quegli anni cominciava ad essere
argomento molto dibattuto in Italia, anche in ambito scientifico e più precisamente fisiologico, faceva così il suo ingresso in manicomio, introdotto da uno strumento rivoluzionario per lo studio della fatica: l’ergografo, che si stava diffondendo in tutti i laboratori.
Non si trattava però ancora di una psicologia del lavoro vera e propria, quanto, presumibilmente, di una prima applicazione delle ricerche ergografiche al campo della tecnica manicomiale; !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 L’americana Augusta Klumpke (1859-1927), il primo medico donna as-sunta in un ospedale di Parigi, allieva e moglie del neurologo francese Joseph Jules Déjérine (1849-1917), nota per i suoi studi sulla neuroanatomia.
6 La fisiologa e psicologa polacca Józefa Franciszka Joteyko (1866-1928), che all’epoca del soggiorno di Ferrari presso Binet si trovava a Parigi e che si trasferì poco dopo a Bruxelles, dove diresse l’Istituto di psicologia universita-rio e fondò la Revue psychologique. Morì a Varsavia, dove dirigeva l’Istituto pedagogico.
7 Varia Kipiani, collaboratrice della Joteyko e autrice nel 1912 di uno stu-dio sperimentale sull’ambidestrismo (Kipiani, 1912).
Zocchi
!!
72
con ogni probabilità, infatti, Ferrari indagava la resistenza mu-scolare delle ricoverate al San Lazzaro in vista delle indicazioni ergoterapiche che se ne sarebbero potute trarre.
Psichiatra attento a ciò che accadeva fuori dalle mura del manicomio, egli coglieva la portata e l’importanza del dibattito sul lavoro che iniziava a muovere anche la cultura medica ita-liana di fine secolo. Così, riagganciandosi esplicitamente al «pre-sente momento dell’evoluzione della nostra società, in cui gene-rali ed insistenti sono le domande di tutti i lavoratori per ottene-re più elevati compensi al loro lavoro», nel 1902 Ferrari pubbli-cò l’articolo “L’istruzione tecnica professionale per gli infer-mieri” (Ferrari, G. C., 1902, p. 729), sollecitando l’istituzione di corsi professionalizzanti per il personale infermieristico ma-nicomiale, al quale, molto più che al medico, erano affidati quo-tidianamente gli ammalati psichiatrici. Se infatti – scriveva Fer-rari – si richiedeva «un alunnato più o meno lungo prima di con-fidare ad un individuo la più semplice macchina industriale», per diventare infermiere di manicomio ed avere quindi «affida-ta alla propria intelligenza la mente vacillante di un disgrazia-to», era sufficiente che un contadino, o un calzolaio, disponesse di «certi requisiti fisici», avesse «buon nome» e fosse «ben rac-comandato da persone influenti» (Ferrari, G. C., 1902, p. 729).
Di fronte alle giuste rivendicazioni di tipo sindacale, occor-reva dunque secondo Ferrari che vi fosse anche un corrispettivo nel servizio svolto dagli infermieri, tasselli importantissimi nel-l’opera di cura complessiva del malato psichiatrico. Il maggiore benessere lavorativo degli infermieri avrebbe dovuto essere in-fatti finalizzato a una migliore assistenza al paziente, come av-veniva ad esempio nel Manicomio di Meerenberg in Olanda, dove il direttore Jacob Van Deventer (1848-1916) – in collabo-razione con la moglie – aveva riorganizzato completamente il servizio infermieristico, puntando soprattutto sull’istruzione me-dica e deontologica del personale e sulla premiazione del merito (Ferrari, G. C., 1902, p. 730).
Il tema del lavoro risultava peraltro legato all’ambito mani-comiale anche per quanto riguardava l’utilizzo dei test. Quelli elaborati da Ferrari e Guicciardi, inizialmente applicati allo stu-
La psicotecnica in Giulio Cesare Ferrari
!
73
dio individuale dell’alienato, erano infatti utilizzabili anche co-me mezzo di esame delle attitudini professionali. Non a caso, proprio presso il laboratorio di Ferrari si era formato Ugo Piz-zoli, pioniere in Italia della cosiddetta «pedagogia scientifica», che mirava ad applicare i metodi della psicologia individuale, con fine professionale, anche ai bambini normali (Passione, 2012, pp. 124-125, 135).
I maggiori contributi di Ferrari negli anni prima della Gran-de guerra furono del resto dedicati proprio all’aspetto psicope-dagogico del lavoro, in particolare nell’ambito della rieducazio-ne dei minori delinquenti. Egli indicava infatti nel lavoro e nel-lo studio psicologico individuale gli strumenti fondamentali per il recupero dei piccoli criminali e per il loro reinserimento nella società. Più specificamente, concepiva il metodo del lavoro li-bero, ossia liberamente scelto, non solo e non tanto come ausi-lio rieducativo-normativo, quanto piuttosto come un vero e pro-prio strumento diagnostico ai fini di un esame attitudinale, non-ché come strumento terapeutico fondamentale per incanalare le energie dei giovani verso un’attività gratificante, che consentis-se loro di appagare il «bisogno di distinguersi», di «non essere un numero nella collettività» (Francia, 1911, p. 13; Passione, 2012, pp. 163-166).
Ferrari aveva maturato queste idee già negli anni 1903-1907, quando era stato direttore dell’Istituto medico-pedagogico di Bertalìa (Babini, 1998), ma le riprese in modo più organico tra il 1910 e il 1915, nel corso dell’esperienza effettuata con la maestra Gabriella Francia nella Colonia libera per deficienti gravi e giovani criminali, da lui fondata a Castelguelfo (Imola)8.
Con lo scoppio della prima guerra mondiale, l’accelerazione dello sviluppo industriale, la prima diffusione in Italia del taylo-rismo e del fordismo, ma soprattutto l’avvio delle ricerche sulle prestazioni psicofisiche dei soldati contribuirono, com’è noto, a dare un ruolo fondamentale alla psicotecnica e all’attività dello psicologo quale interlocutore privilegiato dei governi e delle
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8 La Colonia fu poi trasferita nella villa Palazzi di Imola e chiusa nel 1915 a
causa della guerra (cfr. Lazzari, 1998, pp. 82-84; Passione, 2012, pp. 164-166).
Zocchi
!!
74
industrie in tema di selezione e orientamento dei militari e dei lavoratori. L’organizzazione della macchina bellica costituì un primo esempio di quelle forme di razionalizzazione del lavoro che Oltreoceano si erano già affermate con l’opera di Taylor (Passione, pp. 173-174) e la Rivista di psicologia di Ferrari non mancò infatti di ospitare numerosi articoli, tra il 1915 e il 1919, dedicati espressamente alla psicologia di guerra.
3. Gli anni Venti e le conferenze internazionali di psicotecnica Se dunque il tema del lavoro, comune a molti altri esponenti
della cultura medico-pedagogica italiana fra Otto e Novecento, fu presente sin dall’inizio nell’opera di Ferrari, fu soprattutto nel periodo postbellico che la sua ricerca – ma anche il suo im-pegno istituzionale e organizzativo – si rivolse maggiormente alla psicotecnica.
Nel 1919 egli recensì sulla Rivista di psicologia il volume di Hugo Münsterberg Psychology and industrial efficiency (Mün-sterberg, 1913), sottolineandone da un lato la novità assoluta in tema di psicotecnica e condannandone dall’altro la rigidità effi-cientistica, a suo dire tipicamente tedesca (Ferrari, 1919). Inter-ventista della prima ora, poi convinto sostenitore di Mussolini, Ferrari aveva accolto con entusiasmo lo scoppio della guerra e non aveva mai nascosto la sua fiera antipatia per la Germania. Il libro di Münsterberg, pur «interessante soprattutto come ‘messa a fuoco’ del problema dei servizi che la psicotecnica dei labora-tori può rendere alla pratica industriale», gli appariva comple-tamente «pervaso da questo senso della ferrea necessità di as-servire gli uomini alla necessità dell’organizzazione» e come «un avant-gout del mondo come sarebbe risultato dalla conqui-sta della Germania». Gli sembrava quasi che Münsterberg, «te-desco, ma professore in America, preved[esse] un compito com-binato fra la Germania maestra (?)9 di organizzazione e l’Ame-rica dalle favolose possibilità» (Ferrari, G. C., 1919, p. 76). !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Così nel testo.
La psicotecnica in Giulio Cesare Ferrari
!
75
Ferrari contestava dunque le eccessive concessioni di Mün-sterberg al sistema tayloristico e all’approccio efficientista tipi-co della scuola americana, indicando piuttosto il bisogno di se-guire nella psicologia del lavoro una strada tutta italiana, fina-lizzata all’orientamento scolastico e professionale piuttosto che alla semplice selezione della manodopera. In questa direzione, come molti degli psicologi italiani impegnati sul fronte di un avvicinamento tra scuola e mondo del lavoro, egli fu tra coloro che, nell’immediato dopoguerra, ribadirono la necessità di non rinunciare ad alcuni temi fondamentali maturati nell’ambito della pedagogia scientifica, come la realizzazione individuale, il ri-spetto delle spinte motivazionali e il diritto alla felicità dei gio-vani in quanto futuri lavoratori (Passione, 2012, p. 200).
Datava al 1920 il suo primo articolo espressamente dedicato all’“orientamento professionale dei lavoratori” (Ferrari, G. C., 1920b), che si apriva con la constatazione che «le grandi tra-sformazioni politiche e sociali determinate dalla guerra» aveva-no «rese necessarie delle trasformazioni egualmente importanti in molti aspetti del grande problema del lavoro». Risultava ur-gente trovare un modo per evitare una diminuzione della produ-zione, «pur diminuendo la durata e la fatica» del lavoro stesso, il quale avrebbe dovuto diventare quindi «più redditizio e più facile ad un tempo» (Ferrari, G. C., 1920, p. 327).
Dopo un breve excursus storico sulle prime indagini effet-tuate in America da Taylor e dallo stesso Münsterberg, Ferrari sottolineava l’influenza che esse avevano avuto su altri studiosi, soprattutto tedeschi, come William Louis Stern e Otto Lipmann, i quali, se durante la guerra avevano contribuito alla selezione dei soldati in base alle attitudini psicofisiche, con la sconfitta militare si erano rivolti «con lena ammirevolmente rinnovata» a studi analoghi nel campo industriale, finalizzati «a guadagnar tempo nell’opera di ricostruzione della Germania» (Ferrari, G. C., 1920b, p. 328). Tra i pionieri italiani della psicotecnica, egli indicava invece, oltre a se stesso – e alle proprie ricerche «fatte su piani analoghi a quelle dello Stern e con le medesime diretti-ve, ma applicate soprattutto agli anormali del carattere» – il col-lega Sante De Sanctis, che nel 1918 aveva tenuto a Milano, al
Zocchi
!!
76
cospetto delle autorità governative e comunali, una «magnifica conferenza» su “L’utilizzazione dell’uomo”, facendola seguire nel 1919 da trenta lezioni a Roma sulla psicologia delle attitu-dini e da un articolo sulla Rivista di psicologia dedicato alla “psicologia della vocazione”10 (Ferrari, G. C., 1920b, p. 329). Ma l’opera di De Sanctis, aggiungeva Ferrari,
ebbe l’effetto tipicamente italiano, che quando si trattò di or-ganizzare le ricerche psicologiche per l’esercito in campo e fu-rono istituiti laboratori specialmente di psicofisica e psicofisio-logia per lo studio degli aviatori, nessuno si ricordò dell’opera dell’iniziatore per certi riguardi e del propagandista fra noi di queste ricerche, le quali furono perciò eseguite spesso senza unità di indirizzo e quindi con un rendimento problematico per l’insieme di un esercito in lotta (Ferrari, G. C., 1920b, p. 330). Nella situazione drammatica del dopoguerra appariva ormai
urgente «mostrare il problema agli industriali, agli uffici del la-voro, eventualmente anche alle Camere del lavoro, alle Coope-rative ed ai giornali che dei problemi del lavoro si interessano e si occupano» (Ferrari, 1920b, p. 330). Ferrari citava a questo proposito le iniziative avviate in Svizzera dall’Association suisse des conseils de apprentissage et de la protection des apprentis11, che aveva incaricato l’Institut des sciences de l’éducation “Jean-Jacques Rousseau” di Ginevra, diretto da Edouard Claparède e Pierre Bovet, di organizzare una serie di conferenze sull’aspetto scientifico dell’orientamento e delle attitudini professionali, ri-volte appunto agli industriali e ai vari enti che si occupavano di apprendistato. Era anche l’occasione, per Ferrari, di annunciare la propria partecipazione – unico italiano insieme a De Sanctis – alla prima Conferenza internazionale di psicotecnica organiz-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!10 De Sanctis (1919). Sulla psicotecnica in De Sanctis cfr. Lombardo,
Pompili, & Mammarella (2002), pp. 78-80; Cimino, & Lombardo (2004), pp. 185-191.
11 Nata nel 1902 come Fédération suisse des patronats d’apprentissage, aveva mutato il suo nome nel 1916, divenendo successivamente nel 1932 As-sociation suisse pour l’orientation scolaire et professionnelle.
La psicotecnica in Giulio Cesare Ferrari
!
77
zata dall’Institut Rousseau a Ginevra nel settembre di quello stesso 1920:
Il convegno, importante anche per essere il primo approc-
cio in terra neutrale fra uomini di scienza di paesi già nemici, acquista un interesse anche maggiore pel momento storico del tutto nuovo in cui si trovano certi paesi, come p[er] es[empio] la Germania, dove la questione del maggior rendimento delle industrie è la necessità più vitale del momento, o come la Rus-sia, dove tutto è da rifare e dove sembra che si stia cercando di tutto instaurare ex novo (Ferrari, G. C., 1920b, pp. 330-331). Se dunque era importante ripristinare il dialogo scientifico
nei difficili anni del dopoguerra, un accordo internazionale era necessario, secondo Ferrari, anche per stabilire criteri di indagi-ne uniformi che permettessero di ottenere dati comparabili sul rendimento dei lavoratori nei vari paesi e di «correggere le con-dizioni meccaniche e psico-fisiologiche del lavoro, adattandole alle disposizioni fondamentali dei diversi popoli»:
Per noi che conosciamo l’ingegnosità e la meravigliosa ca-
pacità di adattamento degli operai italiani per le più fantastiche condizioni di lavoro […] appare inconcepibile che i nostri ope-rai possano, in vista di un più alto salario, meccanizzare i loro movimenti al punto che i metodi del Taylor presuppongono. […] Per l’operaio nostro, almeno, come pel francese, la perso-nalità non scompare mai. Egli si identifica sempre col suo la-voro, che personifica sempre un po’ (Ferrari, G. C., 1920b, pp. 331-332). Riprendendo la Differentielle Psychologie di Stern (1911),
Ferrari sottolineava l’esistenza di «una moltitudine di varietà individuali per ciascuna delle nostre attività psichiche» e riba-diva l’importanza di studiare le disposizioni individuali come qualcosa di potenziale che andava favorito e sviluppato fin dall’infanzia, quindi prima della scelta del mestiere in età adul-ta. Tornavano qui – rielaborati in base alle nuove istanze utilita-ristiche emerse con maggiore evidenza nell’immediato dopo-
Zocchi
!!
78
guerra – i temi già cari a De Sanctis e alla scuola psicopedago-gica italiana del primo Novecento, che vedevano nell’orienta-mento professionale una valida alternativa alla selezione dei la-voratori (Passione, 2012, p. 204). Occorreva dunque «studiare gli individui prima che sce[gliesser]o il loro mestiere e, ricono-sciuta in essi l’esistenza di determinate attitudini, cercare di svi-lupparle per renderle più altamente redditizie che sia possibile» (Ferrari, G. C., 1920b, p. 333). Certo bisognava anche «analiz-zare quali elementi psichici dell’operaio integr[asser]o meglio l’opera bruta degli strumenti di lavoro», ma senza manifestare intenti coercitivi:
[…] per togliere a tutto questo quel quid di apparentemente
illiberale, di coattivo che potrebbe stimolare il sentimento anar-chico che cova in fondo all’anima dei lavoratori più intelligen-ti, si dovrebbe iniziare questa condottazione degli apprendisti verso determinate specie di lavori fin dalle scuole elementari superiori, e, meglio ancora, nelle scuole complementari e pro-fessionali (Ferrari, G. C., 1920b, pp. 333-334). Nel 1920 iniziò anche il carteggio di Ferrari con uno dei
maggiori rappresentanti della psicotecnica francese, Jean-Mau-rice Lahy (1872-1943)12, docente di psicologia applicata all’Ecole pratique di Parigi e poi segretario dell’Associazione internazionale di psicotecnica (AIP). Lo scambio epistolare, che proseguì sostanzialmente fino alla morte di Ferrari, riguardò l’organizzazione delle conferenze internazionali di psicotecni-ca, che si tennero in vari paesi a partire proprio dal 192013. Da tale carteggio emerge il ruolo poco noto ma centrale dello psi-cologo emiliano come organizzatore e portavoce dell’Italia a li-vello internazionale.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!12 Il FF conserva 9 lettere di Lahy a Ferrari (la prima del 18 dicembre
1920, l’ultima del 2 aprile 1931), e 3 minute di risposte di Ferrari a Lahy. 13 La prima Conferenza internazionale di psicotecnica si tenne a Ginevra
nel 1920, la seconda a Barcellona nel 1921, la terza a Milano nel 1922, la quarta a Parigi nel 1927, la quinta a Utrecht nel 1928, la sesta a Barcellona nel 1930, la settima a Mosca nel 1931, l’ottava a Praga nel 1934.
La psicotecnica in Giulio Cesare Ferrari
!
79
Fin dal dicembre 1920, infatti, essendo stato incaricato di stendere un resoconto sulla prima Conferenza tenutasi a Gine-vra14, a cui lo stesso Ferrari aveva partecipato, Lahy si rivolse a lui per sapere quanto fosse stato fatto in Italia nel campo della psicotecnica e dell’orientamento professionale15.
Organizzata dall’Institut Rousseau e dal Laboratorio di psi-cologia sperimentale dell’Università di Ginevra grazie all’ini-ziativa congiunta di Claparède e Bovet, questa prima conferen-za – in realtà più che altro una riunione tra specialisti – aveva visto la partecipazione di circa 60 studiosi provenienti da quasi tutti i paesi europei, tranne l’Inghilterra e la Germania. Tra i partecipanti figuravano molti dei corrispondenti dello stesso Ferrari, come il belga Ovide Decroly16, lo svizzero Claparède17, i francesi Lahy, Édouard Toulouse18, Henri Piéron19. In occasio-ne della conferenza era stata istituita l’Associazione internazio-nale di psicotecnica, con sede a Parigi, fortemente voluta anche dalla Lega francese di igiene mentale (fondata da Toulouse). Presidente e segretario della nuova associazione erano stati no-minati rispettivamente Piéron e Lahy (Gundlach, 1998, I, 18, 32; Turbiaux, 2006, 220).
La dimestichezza con il mondo scientifico francese, come già accennato, risaliva agli anni della formazione di Ferrari e al-la sua frequentazione del laboratorio parigino di Binet, dove
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!14 Lahy, 1922a. 15 FF, Carteggio, Lettere a Ferrari, fasc. Lahy, 18 dicembre 1920. 16 Nel FF sono presenti 4 lettere e cartoline dello psicologo e pedagogista
Ovide Decroly (1871-1932), professore all’Institut d’enseignement spécial di Bruxelles, risalenti agli anni 1904-1923.
17 Con Edouard Claparède (1874-1940) Ferrari aveva una frequentazione amichevole e familiare che risaliva alla fine del 1904, quando erano comincia-ti i loro scambi epistolari. Il FF conserva infatti 16 lettere di Claparède a Fer-rari degli anni 1904-1929. I primi contatti riguardarono lo scambio di riviste, essendo Ferrari fondatore e direttore della Rivista di psicologia e Claparède degli Archives de psychologie.
18 Nel FF sono presenti 11 lettere e cartoline di Edouard Toulouse (1865-1947) a Ferrari, risalenti agli anni 1898-1932.
19 Il FF conserva 4 lettere e cartoline dello psicologo Henri Piéron (1881-1964) a Ferrari, del periodo 1905-1915.
Zocchi
!!
80
aveva stretto amicizia con Nicholas Vaschide (1873-1907), lo psicologo rumeno con il quale Lahy aveva pubblicato i suoi primi lavori all’Istituto di Villejuif diretto da Toulouse (Tur-biaux, 2006, 218).
Durante la conferenza di Ginevra, Ferrari aveva peraltro al-lacciato nuovi rapporti anche con gli ambienti scientifici spa-gnoli, in particolare con Emilio Mira y López (1896-1964) e Jo-sé Ruiz Castella, dell’Istituto di orientamento professionale di Barcellona20. E fu proprio Ruiz Castella a scrivergli il 23 agosto 1921 proponendogli di agire come delegato italiano del Comita-to organizzativo della seconda Conferenza internazionale di psi-cotecnica applicata all’orientamento professionale e all’orga-nizzazione del lavoro, che si sarebbe tenuta a Barcellona il me-se successivo21.
Ferrari, che teneva molto al riconoscimento del proprio ruo-lo internazionale, chiese al deputato Gino Baglioni di intercede-re presso il ministro del lavoro Alberto Beneduce per ufficializ-zare la nomina22. La Rivista di psicologia diede inoltre pubblici-tà all’evento, sia nella rubrica «Notizie», sia in una breve intro-duzione di Ferrari all’articolo del collega milanese Giuseppe Corberi, dedicato non a caso alla «ricerca delle attitudini pro-fessionali» (Ferrari, G. C., 1921b).
Promossa dall’Istituto diretto da Ruiz Castella, la seconda Conferenza di Barcellona diede a Ferrari – come si diceva – l’occasione di stringere legami di collaborazione duraturi con i colleghi catalani, in particolare con il direttore del Laboratorio di psicofisiologia Emilio Mira e con Juan Alzina y Melis23, uno
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!20 L’Institut d’orientació professional, già “Secretariat d’aprenentatge” del
Museo social di Barcellona, a partire dal 1914 fu diretto da José Ruiz Castel-la, inizialmente segretario del Museo. Nel 1919 Emilio Mira fu incaricato di dirigere la Sezione psicometrica dell’istituto e nel 1926 ne divenne direttore al posto di Ruiz Castella.
21 FF, Carteggio, Lettere a Ferrari, fasc. Ruiz Castella, 23 agosto 1921. 22 FF, Lettere a Ferrari, fasc. Baglioni, 16 settembre 1921. 23 Nel FF sono presenti 10 lettere e cartoline di Alzina a Ferrari, in italia-
no, degli anni 1921-1924.
La psicotecnica in Giulio Cesare Ferrari
!
81
psichiatra che si era laureato a Bologna, fondatore nel 1917 del-la Scuola per deficienti di Villajoana.
Durante il soggiorno a Barcellona, nel settembre 1921, Fer-rari fu coinvolto dai colleghi spagnoli in diverse iniziative: su loro richiesta tenne infatti una conferenza sulla riforma del Co-dice penale italiano24 e alcune lezioni di psicotecnica per i mae-stri della Scuola di Villajoana, promuovendo inoltre la fonda-zione di colonie libere per giovani criminali, sul modello di quelle italiane che egli stesso aveva impiantato a Castelguelfo e a Imola.
L’ambiente barcellonese era del resto particolarmente vivace in quel periodo: lo stesso Ferrari ricordava infatti in un articolo sulla Rivista di psicologia, che ad esempio a Sarrià, nei sobbor-ghi della città, viveva «onorata e stimata da tutti, in un volonta-rio esilio che la patria lamenta», Maria Montessori25, il cui ce-lebre “metodo” era stato importato a Barcellona proprio da Juan Alzina (Ferrari, G. C., 1921, p. 360).
Intanto in Italia l’interesse per la psicotecnica del lavoro cre-sceva, di pari passo con il ruolo organizzativo di Ferrari. In una lettera del 22 settembre 1921, il fondatore dell’Istituto italiano di igiene, Ettore Levi, dopo aver letto le comunicazioni com-parse sulla Rivista di psicologia, pregava infatti Ferrari di met-terlo in contatto con gli altri italiani che si interessavano di orientamento educativo e professionale, di inviargli gli atti della Conferenza ancora in corso a Barcellona e di dargli notizie sul progetto del Laboratorio di psicotecnica “Francesco Menafo-glio” della Scuola “Fermo Corni” di Modena26 e sull’attività degli altri istituti aperti da Pizzoli e Corberi27.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!24 Ferrari faceva parte della Commissione reale per la riforma del Codice
penale italiano. 25 Sulla Montessori cfr. Babini & Lama, 2000. 26 Sul laboratorio cfr. Ferrari (1923). 27 FF, Carteggio, Lettere a Ferrari, fasc. Levi, 22 settembre 1921. Ferrari
aveva annunciato infatti nella Rivista: «per mio invito la Società Umanitaria di Milano […] ha fin dal settembre dello scorso anno messo a disposizione del dottor Corberi la propria influenza e mezzi materiali di cui il Corberi va facendo il miglior pro […]. I lettori sanno pure che un secondo nucleo di stu-
Zocchi
!!
82
Terminata la Conferenza di Barcellona, che vide la parteci-pazione di un numero maggiore di paesi rispetto alla prima e in cui prevalsero le discussioni metodologiche e quelle sul rendi-mento dei diversi test proposti, cominciarono a fervere i prepa-rativi per la terza, in occasione della quale il ruolo di Ferrari si fece più attivo. Come delegato per l’Italia nella Commissione internazionale permanente, infatti, fu incaricato di organizzare l’evento, che si sarebbe tenuto nel 1922 a Milano, presso la So-cietà Umanitaria.
Il rapporto di Ferrari con l’Umanitaria era cominciato molti anni prima, almeno nel 1904, quando aveva tenuto diverse le-zioni di ortofrenia e pedagogia emendatrice all’Istituto di Pizzo-li, appena trasferito a Milano proprio grazie all’appoggio dei di-rigenti dell’Umanitaria, i coniugi Luigi ed Ersilia Majno (Pas-sione, 2012, p. 140). Più tardi, nel 1914, il segretario generale Augusto Osimo gli aveva affidato un corso di frenologia e psi-cologia infantile rivolto alle allieve della Scuola magistrale per le educatrici dell’infanzia, istituita su richiesta di Maria Mon-tessori28. Nel settembre 1921 lo stesso Ferrari aveva invitato Osimo a Barcellona in occasione della seconda conferenza in-ternazionale di psicotecnica, ma il segretario aveva declinato l’invito per ragioni di salute, chiedendogli di rappresentare uffi-cialmente l’Umanitaria poiché, anche a causa della grave disoc-cupazione e dei problemi economici che angustiavano le opere pie, non poteva inviare Corberi a sostituirlo29. Ed era stato an-cora una volta Ferrari a suggerire all’Umanitaria, nel settembre 1920, di mettere a disposizione di Corberi – allora responsabile del Laboratorio di psicologia dell’Ospedale psichiatrico di Mi-lano in Mombello – «la propria influenza e mezzi materiali» per
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!diosi italiani lavora a Modena nell’Istituto blackfordista a cui il Menafoglio ha dato vita e che il valoroso Pizzoli sta organizzando (Ferrari, 1921b, p. 269).
28 I corsi si tennero nel 1914 e 1915, cfr. FF, Carteggio, Lettere a Ferrari, fasc. Osimo, 27 ottobre 1914, 5 novembre 1914 e 14 ottobre 1915. Cfr. anche ibid., fasc. Montessori, 5 novembre 1914. Cfr. Babini, & Lama (2000), pp. 272-288.
29 FF, Carteggio, Lettere a Ferrari, fasc. Osimo, 7 settembre 1921. Sull’attività dell’Umanitaria cfr. Decleva (1985); Colombo (2008).
La psicotecnica in Giulio Cesare Ferrari
!
83
allestire un Gabinetto di psicotecnica che fu poi collocato prov-visoriamente presso la Clinica del lavoro (Ferrari, G. C., 1921b, p. 269). Qui Corberi iniziò con Vittorio Favini quelle “Osserva-zioni sui conduttori di tram” di cui presentò i risultati alla Con-ferenza internazionale di Milano nell’ottobre 1922 (Società uma-nitaria, 1923, pp. 116-137 e 240) e che posero le basi per la successiva inaugurazione, nel 1926, del Laboratorio di psico-tecnica dell’Azienda tranviaria municipale (ATM)30.
Per organizzare la terza conferenza milanese, Ferrari lavorò in pieno accordo e collaborazione con il segretario Lahy, il qua-le gli scriveva il 22 giugno 1922:
Je suis tout à fait d’accord avec vous pour garder à cette
Conférence un caractère d’intimité et de cordialité qui donne tout leur charme à nos rencontres.
Organisation de la Conférence. Tout [ce] que vous me dites sur ce point me parait excellent et le programme des dis-tractions tout à fait remarquable. Je vous demanderai d’annon-cer aux vôtres dans la convocation par que les personnes que j’ai déjà sollicitées comprennent qu’il s’agit de la même confé-rence; comme secrétaire général de ces réunions cela sera fa-cile. Je suis donc à l’Angleterre, où j’ai vu Myers qui m’a promis fermement de venir à Milan. Il désire avoir une contro-verse avec Gilbreth au sujet du rôle du psychologue dans la sé-lection des travailleurs. J’ai un ami Wilsace [sic]31 qui dirige le «industrial fatigues Research Buward» [sic]32 de Londre. Il vous enverra un représentant officiel33. Lahy insisteva dunque sull’importanza della presenza degli
inglesi alla conferenza, approvava i temi generali proposti da Ferrari («Analisi psicologica del lavoro», «L’orientamento pro-fessionale basato sulla conoscenza delle attitudini») e ne propo-neva un terzo, che intendeva trattare in prima persona: «Che
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!30 Cfr. Corberi (1926). 31 D.R. Wilson, segretario dell’Industrial Fatigue Research Board di Londra. 32 Industrial Fatigue Research Board. 33 FF, Carteggio, Lettere a Ferrari, fasc. Lahy, 22 giugno 1922.
Zocchi
!!
84
cos’è un’attitudine professionale». Nella stessa lettera comuni-cava inoltre che avrebbe presentato a nome della Lega d’igiene mentale un intervento su “La fiche de contre indications médi-cales”, che avrebbe potuto costituire l’oggetto di un’interessan-te discussione sulla messa a punto di una scheda internazionale di esame medico dei soggetti sottoposti ai test di orientamento professionale34. La scheda35 era stata presentata poche settima-ne prima da Lahy al Congresso internazionale di igiene mentale di Parigi, al termine del quale si era auspicato che l’orienta-mento professionale fosse organizzato tenendo conto non sol-tanto delle condizioni del mercato del lavoro, della situazione economica delle famiglie e dei gusti dei giovani, ma anche delle controindicazioni mediche rilevate appunto mediante la scheda in oggetto e i metodi della psicologia sperimentale (Turbiaux, 2006, p. 222).
Nella stessa lettera, Lahy chiedeva infine a Ferrari di poter proiettare un film di orientamento professionale sul mestiere del tornitore36, poiché nell’ambito delle sue ricerche di psicologia pedagogica egli aveva intrapreso diversi studi sulla cinemato-grafia come tecnica di insegnamento. Il filmato che poi effetti-vamente presentò alla Conferenza di Milano, realizzato dal re-gista Abel Gance (1889-1981), riguardava il mestiere del torni-tore-attrezzista nelle fabbriche dell’azienda Voisin (Turbiaux, 2006, p. 224)37.
Se dunque la collaborazione con i francesi e con l’Umani-taria fu attiva e improntata alla cordialità dei rapporti, nel clima ancora teso del dopoguerra qualche problema venne invece dai colleghi tedeschi, rappresentati da Otto Lipmann. Quest’ultimo, in una lettera del 16 agosto 1922 indirizzata non solo a Ferrari, ma anche a Lahy e alla Società Umanitaria, si lamentava del ri-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!34 Ibid. 35 Cfr. Lahy, 1922b, 1923a, 1923b. 36 FF, Carteggio, Lettere a Ferrari, fasc. Lahy, 22 giugno 1922. 37 Lahy predispose in quel periodo, con l’aiuto della società cinematogra-
fica Triomphe, una serie di film sul lavoro industriale nelle fabbriche e nelle officine.
La psicotecnica in Giulio Cesare Ferrari
!
85
tardo nell’invio delle circolari di invito, dell’insufficienza delle agevolazioni economiche per i partecipanti, e del fatto che la Germania non fosse rappresentata nel Comitato internazionale, nonostante egli stesso ne avesse fatto esplicita richiesta, soprat-tutto dopo uno «spiacevole contrattempo» verificatosi alla con-ferenza precedente tra il francese Marcel Frois e il tedesco Wal-ter Moede, il quale aveva minacciato di andarsene. Lipmann fa-ceva inoltre notare di non aver mai approvato la relazione sul-l’analisi psicologica del lavoro che gli era stata assegnata (e che presentò poi alla conferenza), sostenendo di non avere il tempo di prepararla38. Con la mediazione di Ferrari, tuttavia, i problemi furono alla fine risolti e lo stesso Lipmann gli scrisse in seguito per ringraziarlo di aver reso possibile la sua parteci-pazione39.
Se Ferrari si occupava dell’organizzazione generale della conferenza e di mantenere i rapporti a livello internazionale, il comitato milanese era composto dai rappresentanti dei tre istitu-ti più direttamente coinvolti: Osimo e il segretario Riccardo Bauer per l’Umanitaria; il direttore Giuseppe Antonini con i se-gretari Giuseppe Corberi e Piero Gonzales per il Manicomio di Mombello; il direttore Luigi Devoto per la Clinica del lavoro.
Tra le visite previste nel corso dell’evento congressuale fi-guravano, oltre a quelle agli istituti citati, anche le seguenti: al Laboratorio municipale di pedagogia e psicologia sperimentale, diretto da Casimiro Doniselli, che illustrò ai congressisti i nuovi apparecchi da lui stesso realizzati; al Laboratorio di psicotecni-ca “Menafoglio” di Modena, dove gli stranieri, accompagnati dal fondatore, dovettero constatare che erano «in uso da vent’an-ni degli strumenti e degli apparati dovuti alla genialità inventiva del Pizzoli, che a Berlino e altrove vengono man mano risco-perti» (Ferrari, G. C., 1922b, p. 187); e al moderno impianto in-dustriale del cappellificio Valera & Ricci di Monza, nel quale i convenuti ebbero modo di osservare la «razionale applicazione dei più perfetti sistemi di prevenzione degli infortuni e di difesa
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!38 FF, Carteggio, Lettere a Ferrari, fasc. Lipmann, 16 agosto 1922. 39 Ibid., 21 ottobre 1922.
Zocchi
!!
86
igienica dei lavoratori» (Ferrari, G. C., 1922b, p. 187; Società umanitaria, 1923, p. 246).
Nonostante il successo dell’evento, durante il quale si con-venne che la quarta Conferenza internazionale di psicotecnica si sarebbe tenuta a Bruxelles due anni dopo, nel gennaio 1924 Lahy comunicava a Ferrari che i colleghi belgi, a causa della si-tuazione politica, non si sentivano di organizzarla; gli chiedeva quindi un parere sulla sede di Praga, dove aveva già contattato il direttore dell’Istituto di fisiologia industriale40. Ma tutti gli accordi risultarono vani e fu necessario aspettare fino al 1927 prima che gli incontri internazionali di psicotecnica riprendes-sero.
4. La collaborazione con l’Enios e con il figlio ingegnere Intanto Ferrari, che teneva un corso di psicologia sperimen-
tale all’Università di Bologna, aveva destinato una sala del La-boratorio di psicologia del Manicomio di Imola, da lui diretto, agli esperimenti in materia di orientamento professionale e psi-cologia vocazionale, nei quali lo assistevano come volontari tre allievi del corso stesso41.
A partire dal 1927, con la pubblicazione della Carta del la-voro e l’avvio del corporativismo, anche l’attività di Ferrari – come quella della maggior parte degli psicologi italiani – di-venne sempre più funzionale alle politiche economiche del fa-scismo. Se infatti i principi dell’organizzazione scientifica del lavoro avevano già lentamente cominciato a diffondersi nelle imprese italiane negli anni precedenti, a partire da quell’anno le esigenze di razionalizzazione produttiva vennero sempre più ad interagire con il corporativismo e con le politiche statali di re-golazione economica (Padovan, 2007, p. 697).
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!40 FF, Carteggio, Lettere a Ferrari, fasc. Lahy, 21 gennaio 1924. 41 Cfr. la minuta di lettera di Ferrari al direttore generale dell’istruzione
primaria Giuseppe Lombardo Radice del 3 marzo 1923 (FF, Carteggio, Lette-re di Ferrari, fasc. Lombardo Radice).
La psicotecnica in Giulio Cesare Ferrari
!
87
Nel settembre 1927, a Roma, il terzo Congresso internazio-nale di organizzazione scientifica del lavoro fu chiuso da Mus-solini in persona (Pogliano, 1986, p. 278). Ferrari vi presentò, senza tuttavia leggerla, una relazione su “Psicologia e tecnopsi-cologia”, che ripropose poi alla quarta Conferenza internaziona-le di psicotecnica che si tenne a Parigi il mese successivo. Il te-sto, pubblicato nella Rivista di psicologia (Ferrari, G. C., 1927), conteneva alcuni interessanti spunti critici. Partendo dalla con-siderazione che nonostante la propaganda, nonostante i con-gressi internazionali, nonostante le numerose pubblicazioni e «l’evidenza dei fatti» l’organizzazione scientifica del lavoro stentava «a divenire popolare nei paesi non americani», egli analizzava la situazione italiana sulla base dei colloqui avuti con gli industriali:
Il sospetto che l’organizzazione celi un bluff (e in parte lo
sia), nasce dall’improntitudine con cui certi organizzatori im-provvisati mostrano di credere che la parte materiale di essa, cioè la cronometria e le esperienze – più o meno giustificate – in genere, siano tutta l’organizzazione scientifica (Ferrari, G. C., 1927, p. 117). A suo modo di vedere, coloro che si erano «improvvisati or-
ganizzatori senza preparazione» avevano danneggiato l’imma-gine della «vera psicologia», la quale poteva avere invece un’importanza strategica per gli industriali. Le «geniali intui-zioni» di Taylor erano nate in un contesto in cui si pensava che le macchine industriali non fossero ulteriormente perfezionabili e dunque – secondo Ferrari – era sembrato necessario concen-trarsi sull’incremento e il perfezionamento del rendimento dell’uomo al lavoro. Nel campo della psicotecnica si era verifi-cato lo stesso fenomeno che in passato aveva coinvolto la psi-cologia sperimentale, ovvero un appiattimento delle ricerche e degli esperimenti intorno alle funzioni elementari della vita psi-chica (sensazioni, percezioni, memoria, associazioni), mentre si sarebbe dovuto invece insistere «sui fenomeni superiori del pensiero, del raziocinio, della volontà, sull’affettività superiore
Zocchi
!!
88
ecc.». Allo stesso modo la psicotecnica aveva trascurato l’orga-nizzazione scientifica e pratica del lavoro, limitando i suoi in-terventi allo studio del «meccanismo materiale del lavoro indu-striale», al solo scopo di cercare di migliorare la produzione del «lavoratore manuale medio». Si era quindi trascurato l’aspetto più importante, il fattore umano, perché il lavoro «è espressione del criterio» e del «giudizio» del lavoratore, il quale deve «cer-care e trovare – spesso rapidissimamente – adattamenti nuovi» e «risolvere d’intuito» i problemi che gli si presentano (Ferrari, G. C., 1927, p. 118).
Il compito della psicotecnica doveva essere quello di tentare di organizzare scientificamente e praticamente questo lavoro, aiutando l’industria ad applicare i principi della psicologia e a sviluppare nei lavoratori le «tendenze istintive individuali o del-la razza». Si doveva puntare innanzitutto sull’imitazione, poiché «la psicologia moderna insegna che c’è un solo maestro: l’espe-rienza». L’industriale avrebbe dovuto quindi aver cura di «porre sott’occhi al nuovo impiegato gli esempi migliori», senza di-menticare però che «l’imitazione è tale forza che agisce tanto se è seguita volontariamente, quanto se agisce sull’uomo senza che egli se ne avveda» (Ferrari, G. C., 1927, pp. 119-120).
Vi erano poi altri due fattori su cui puntare: l’allenamento e il subcosciente. Citando i risultati ottenuti dallo psicologo ame-ricano Walter Dill Scott, Ferrari ricordava le sue «interessanti ricerche grafiche sullo sforzo di cui erano capaci degli atleti che pure assicuravano di essere del tutto esausti». Ne derivava un insegnamento che avrebbe dovuto essere sempre inculcato ai giovani: «che se ognuno si arresta al primo segno di stanchezza non arriverà mai a conoscere quale sorgente inesauribile di energia esista nel più profondo di noi stessi» (Ferrari, G. C., 1927, p. 121).
Gli studi condotti da Ferrari in quel periodo nel campo della psicologia del lavoro (e protratti fino alla morte nel 1932) furo-no incentrati sempre più esplicitamente su quella «grande mi-niera di ogni nostra virtù, di ogni nostra energia potenziale, di ogni nostra forza attuale, che è il subcosciente», un tema che in-teressava in quel periodo anche altri psicologi italiani, come
La psicotecnica in Giulio Cesare Ferrari
!
89
Sante De Sanctis (Cimino, & Lombardo, 2004, pp. 29-32). Par-tendo dall’assunto della «esperienza come sola generatrice di sapienza», Ferrari scriveva:
Quell’accomodamento dei nostri muscoli che noi tentiamo
per imitare e poi per cercare di superare il campione di tennis che ammiriamo, non si esaurisce, ma lascia una sua inimmagi-nabile traccia sul nostro organismo più remoto e più insonne, che chiamiamo il nostro subcosciente, che la conserva per ri-presentarcela identica o perfezionata appena ne abbiamo biso-gno e ne richiamiamo il ricordo muscolare. A questo si riferi-sce il proverbio che «s’impara a nuotare d’inverno e a pattinare d’estate». […] L’addestramento progressivo agli sports, il maggior rendimento del lavoro professionale è tutto frutto, ap-punto, di questa «cerebrazione incosciente». […] Per questo il subcosciente è giustamente considerato dagli psicologi come il serbatoio senza fondo di tutte le possibilità (Ferrari, G. C., 1927, pp. 122-123). Era dunque fondamentale che il lavoratore si rendesse conto
di avere nel subcosciente il suo migliore alleato, in modo da ac-quisire una maggiore sicurezza di sé e un entusiasmo per il pro-prio lavoro in grado di fargli superare gli inevitabili momenti di sfiducia tipici di qualunque allenamento.
Al rientro dalla Conferenza internazionale di Parigi del 1927, Ferrari ricevette una lettera dall’Enios, il neocostituito Ente nazionale italiano per l’organizzazione scientifica del la-voro, che gli chiedeva di entrare a far parte della nuova Com-missione di studio sulla fatica industriale, presieduta dal mate-matico Paolo Medolaghi, direttore della Cassa nazionale di pre-videnza per l’invalidità e la vecchiaia degli operai42. Accettato il nuovo incarico, dichiarò che si sarebbe avvalso della collabo-razione del figlio ingegnere Carlo Alberto (1902-1987)43. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42 Si vedano, nel FF, la lettera dell’Enios in data 13 ottobre 1927 (Carteg-gio, Lettere a Ferrari) e la minuta della risposta di Ferrari del 17 ottobre 1927 (Carteggio, Lettere di Ferrari).
43 FF, Carteggio, Lettere di Ferrari, fasc. Commendatore, 4 novembre 1927. Il FF conserva solo pochi documenti di Carlo Alberto Ferrari.
Zocchi
!!
90
Pochi giorni dopo, il 7 novembre 1927, inaugurò a Bologna il sesto Congresso della Società italiana di psicologia, da lui stesso organizzato. Carlo Alberto fu presente con una relazione (che non ebbe però il tempo di leggere) sugli “Elementi genetici e dati rivalutatori della fatica nel lavoro industriale”, mentre sempre alla psicotecnica fu dedicata anche una relazione di Cor-beri dal titolo “Concordanze e contrasti fra orientamento e sele-zione professionali”. Ferrari condusse inoltre i congressisti a vi-sitare l’Ospedale psichiatrico Roncati, nel quale stava sperimen-tando – a suo dire con ottimi risultati – l’applicazione «con ve-dute nuove e geniali» delle «ammalate agitate a lavori industria-li ad esse adattati» (Cronache scientifiche, 1927, pp. 229-230)44.
Secondo i dettami della psichiatria ottocentesca, com’è noto, il lavoro era da tempo considerato uno degli strumenti fonda-mentali per la cura e la rieducazione dei malati psichiatrici. Ne-gli istituti manicomiali di Imola e di Bologna, Ferrari utilizzò sempre le attività lavorative a scopo terapeutico, seguendo l’in-segnamento di Andrea Verga per cui «il lavoro è il miglior ri-medio per la pazzia sanabile, il miglior palliativo per quella in-sanabile» (Ferrari, G. C., 1932a, p. 3). Tuttavia egli ammetteva che il lavoro degli alienati si era ormai trasformato in un «affare di ordinaria amministrazione», che «fa passare il tempo ai ma-lati un poco peggio, ma non si crede che li aiuti molto a guari-re» (Ferrari, G. C., 1932a, p. 3). Contro questa concezione me-ramente palliativa dell’ergoterapia, Ferrari sosteneva la necessi-tà di utilizzare il lavoro come vero e proprio strumento terapeu-tico, tanto che a partire dal 1927 organizzò presso il manicomio di Bologna un laboratorio modello di sartoria gestito da malate agitate. Si trattava di un’idea che aveva cercato di realizzare più volte, ma senza successo, finché proprio una paziente gli aveva dato «la chiave del mistero»:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!44 Ferrari pubblicò tuttavia i risultati di questa esperienza solo alcuni anni
dopo, nel 1932, con il titolo di Psicologia del lavoro. Un metodo originale di applicazione delle malate agitate al lavoro metodico ma attivo (Ferrari, 1932), dopo averne presentato una relazione a Washington nel maggio 1930, al primo Congresso internazionale di igiene mentale.
La psicotecnica in Giulio Cesare Ferrari
!
91
Un bel giorno una maniaca subeccitata, molto intelligente e lavoratrice, la quale aveva forse ampiamente contribuito a mandare a male i miei tentativi, mi diede la chiave del mistero, osservando che «solo le agitate intelligenti avrebbero potuto lavorare bene, ma esse non lo avrebbero fatto finché fossero adibite ai lavori indegni di loro». La parola indegni mi colpì (forse perché illuminava certi aspetti della fatica che assieme a mio figlio stavo studiando nel Laboratorio di psicologia) per cui pensai di fare pernio su di essa (Ferrari, G. C., 1932a, p. 4). Ferrari fece allora «decorare con eleganza» alcuni locali
vuoti vicini al reparto delle agitate e si fece consegnare dall’eco-nomo tutta la tela nuova che acquistava per l’istituto. Diede poi l’incarico alla paziente citata di cercare tra le compagne un gruppo di lavoranti in grado di confezionare lenzuola, federe e asciugamani, attrezzando il laboratorio con tutti gli strumenti necessari, anche quelli potenzialmente pericolosi, che in genere venivano tenuti lontani dai malati agitati.
Accompagnando tale attività con una serie di premi, di elogi e di punteggi di valutazione del lavoro svolto, finalizzati a pub-blicizzare all’interno e all’esterno del manicomio il valore di queste malate (che avevano diritto per esempio ad assistere a spettacoli e feste pubbliche in posti d’onore, a incontrare gli studenti del corso universitario di psicologia sperimentale45 e via dicendo), Ferrari riuscì a ottenere «la rinascita» del loro «senso della dignità». Anche per questo motivo tali malate – a differenza degli altri ricoverati adibiti al lavoro – rifiutavano di essere pagate:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!45 Sappiamo da una lettera del 1930 al preside della Facoltà medica
dell’Università di Bologna che il corso di Ferrari prevedeva, tra le altre, 12 ore di lezione dedicate alla psicotecnica e corredate da esercitazioni in labora-torio, suddivise in una parte generale («Condizioni fisiologiche ed effetti psi-chici del lavoro», «La fatica», «Lo studio dello sforzo e del rendimento») e in una parte speciale («Lo studio dei reattivi mentali dei lavoratori», «L’organiz-zazione del lavoro», «Adattamento degli operai agli strumenti e alle macchi-ne», «Razionalizzazione», «Selezione professionale», «Orientamento profes-sionale» (FF, Carteggio, Lettere di Ferrari, fasc. Martinotti, Minuta di lettera a Leonardo Martinotti, 14 novembre 1930).
Zocchi
!!
92
Questo relativo dispregio di un utile materiale immediato deriva da ciò che le malate si sono immedesimate nella massi-ma che qui il lavoro è proprio una cura, per cui sarebbe strano che in un ospedale un malato fosse compensato per le medicine che prende (Ferrari, G. C., 1932a, pp. 6-7). In sostanza, spiegava Ferrari, «buona parte del merito del-
l’andamento così regolare di questo esperimento spetta alla sua organizzazione psicologica, e al fatto di non trascurare alcun elemento di essa» (Ferrari, G. C., 1932a, p. 7). Alla base di tutto vi era comunque il lavoro, «ma non il lavoro comune che impe-gna solo le mani e non la mente», bensì «un lavoro che attesti la confidenza che si ha nei malati, che impegni la buona volontà e l’intelligenza, dia loro delle responsabilità, faccia sorgere dal loro sub-cosciente delle inibizioni e delle suggestioni utili». In sostanza, non un lavoro automatico e fine a se stesso: «se il la-voro automatizza anziché individuare e caratterizzare i loro movimenti», «i malati più deboli lavorando corrono il rischio [...] d’indebolirsi sempre di più» (Ferrari, G. C., 1932a, p. 14). Dunque la critica all’automatismo del lavoro non era applicabi-le solo al mondo della fabbrica, ma riguardava il lavoro in gene-rale, anche quello «curativo» applicato ai pazienti psichiatrici.
L’esperienza maturata in seno alla Commissione dell’Enios per lo studio della fatica industriale consentì a Ferrari, grazie al-la collaborazione con il figlio ingegnere (all’epoca «consulente per i problemi del lavoro» in diverse grandi aziende italiane), di produrre una serie di ricerche mirate a «stabilire ex novo in labo-ratorio ed officina, correlativamente, il problema del senso della fatica, del senso dello sforzo e della stanchezza», partendo da una verifica degli studi già esistenti, soprattutto di Buyse46 e Bloch47 (Ferrari, G. C., 1930a, p. 174). Dopo aver studiato infatti gli ele-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!46 Il pedagogista belga Omer Buyse, già autore di lavori sulle scuole tec-
niche tedesche e inglesi, poi direttore dell’Université du travail di Charleroi, aveva pubblicato nel 1908 il volume Méthodes américaines d’éducation gé-nérale et technique (Buyse, 1908).
47 Il fisiologo francese Adolphe Moïse Bloch, autore nel 1903 della En-quête sur la fatigue musculaire professionnel (Bloch, 1903).
La psicotecnica in Giulio Cesare Ferrari
!
93
menti che favorivano l’insorgere del senso della fatica, i due Ferrari cercarono di «determinare, in officina, il giuoco degli imponderabili che possono avere influenza sul tempo e sul mo-do di manifestarsi del senso della fatica stessa» (Ferrari, G. C., 1930a, p. 174). Tornava dunque il tema del subcosciente, indaga-to grazie a tre nuovi test volti a studiare l’attenzione, le resistenze interne (suggestibilità) e la capacità di sforzo dell’individuo. Ferrari (padre) li presentò al settimo Convegno nazionale di psi-cologia e psicotecnica tenutosi a Torino nel novembre 1929, in una relazione dal titolo “Gli elementi subcoscienti della fatica in-dustriale” (Ferrari, G. C., 1930a, p. 175; Ponzo, 1929, p. 273)48.
Ma se le ricerche di laboratorio erano parte dell’attività quo-tidiana dello psicologo, il rapporto con l’industria presentava invece qualche problema. Persino le Ferrovie dello Stato, nel gennaio 1929, rifiutarono di aprire le porte a Ferrari e di con-sentirgli un «diretto e personale controllo sul funzionamento delle officine». Egli fu invitato a mandare degli appositi questio-nari all’amministrazione, che avrebbe poi provveduto a inviar-gli le risposte tramite i propri funzionari e il personale dell’Uf-ficio sanitario49.
Probabilmente l’accesso al mondo dell’industria si rivelava più facile per un ingegnere come Carlo Alberto Ferrari, figura che meriterebbe indubbiamente uno studio più approfondito. Nel dicembre 1929, su interessamento del padre e di Agostino Gemelli (membro del Consiglio superiore della pubblica istru-zione) egli ottenne all’Università di Roma la prima libera do-cenza italiana in psicotecnica del lavoro, grazie a una serie di articoli di propaganda dedicati all’organizzazione del lavoro e
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!48 Nel 1931 il testo fu rivisto e pubblicato sulla Rivista di psicologia con il
medesimo titolo (Ferrari, G. C., 1931). Ferrari dichiarava di aver voluto, nelle sue ricerche, «escludere i soliti metodi sperimentali psicofisiologici» – e tanto più quelli puramente fisiologici o fisiopatologici – per concentrarsi su indagi-ni dirette al subcosciente del lavoratore, in grado di rivelare anche «i tentativi di inganno» dei soggetti esaminati.
49 Cfr. la lettera del capo del Servizio materiale e trazione delle Ferrovie dello Stato all’Enios, 23 gennaio 1929 (FF, Carteggio, Lettere di altri ad altri, fasc. Capo del Servizio materiale e trazione delle Ferrovie dello Stato).
Zocchi
!!
94
ai principi di Henry Ford50, in cui illustrava la propria duplice attività, in laboratorio e nelle aziende (Ferrari, C. A., 1930a, p. 175). Pubblicò inoltre per l’Enios il volume Aspetti moderni dell’organizzazione del lavoro, con particolare riferimento al fattore umano, introdotto da una prefazione dell’ingegnere e deputato Francesco Mauro (Ferrari, C. A., 1929b, p. 175).
Il giovane Ferrari incarnava dunque la fusione delle due pro-fessionalità coinvolte negli studi psicotecnici: quella dello psi-cologo, formatasi grazie alla stretta collaborazione con il padre, e quella dell’ingegnere. Insieme, i due Ferrari scrissero e opera-rono nel campo della psicologia del lavoro per diversi anni, al punto che in archivio si conservano alcuni documenti di diffici-le attribuzione all’uno o all’altro.
Carlo Alberto era stato abituato dal padre fin dall’infanzia a viaggiare e a conoscere il contesto internazionale. Dopo l’av-vento del fascismo, era stato per molto tempo «all’estero a far l’operaio, nonostante fosse già ingegnere chimico industriale»51 e nel 1928 aveva trascorso un periodo di studio negli Stati Uniti presso i coniugi Gilbreth52. Questo elemento – oltre natural-mente al fatto di essere figlio di Ferrari – dovette certamente favorire anche la sua carriera in Italia e il superamento dell’esa-me per la libera docenza: nonostante infatti la commissione fos-se composta da psicologi (Sante De Sanctis, Cesare Colucci e Mario Ponzo), l’incarico fu assegnato a lui, un ingegnere53.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!50 Cfr. Ferrari, C. A. (1926; 1927; 1928; 1929a). 51 FF, Carteggio, Lettere di Ferrari, fasc. Fiorentini, [1929]. 52 Cfr. la lettera di Lillian M. Gilbreth a Ferrari del 28 maggio 1928, in
FF, Carteggio, Lettere a Ferrari, fasc. Gilbreth. 53 Cfr. a questo proposito la relazione della Commissione giudicatrice per
l’abilitazione di Carlo Alberto Ferrari (FF, Documenti, Congressi, commis-sioni e concorsi, fasc. Commissione per la libera docenza in psicotecnica del lavoro, 6 dicembre 1929). In realtà l’anno prima, nel 1928, il medesimo esa-me era stato sostenuto, con esito negativo, dal maestro faentino Leone Cimatti (1899-1960), sponsorizzato da padre Gemelli. In quell’occasione Giulio Cesa-re Ferrari, che figurava tra i commissari, aveva emesso un giudizio di notevo-le incompetenza scientifica (cfr., nello stesso fascicolo d’archivio, i verbali delle due sedute della Commissione giudicatrice del 2 e 20 dicembre 1928).
La psicotecnica in Giulio Cesare Ferrari
!
95
5. In Russia nel 1931 A causa dei numerosi impegni e delle condizioni di salute in
via di peggioramento, Giulio Cesare Ferrari non partecipò alle conferenze internazionali di psicotecnica che si tennero a Utre-cht nel 1928 e a Parigi nel 193054. Si recò però a Mosca nel set-tembre 1931 per assistere all’ottava conferenza, l’ultima a cui partecipò prima di morire nell’ottobre 1932.
Si trattava di uno dei primi congressi di psicologia organiz-zati nell’URSS dopo la Rivoluzione del 1917 e sembrava segnare un ritorno della psicologia russa sulla scena internazionale. Ma quelli erano anche gli anni dell’ascesa di Stalin, del primo piano quinquennale (1928-1933), della centralizzazione burocratica dello Stato sovietico e della riorganizzazione generale dell’atti-vità scientifica, sempre più soggetta al diretto controllo statale e posta al servizio delle sue politiche economiche e industriali. Anche la psicologia stava vivendo profondi e sostanziali muta-menti, con le pesanti critiche rivolte alla scuola riflessologica di Betcherev e alla reattologia di Kornilov, accusate di non tenere sufficientemente conto del ruolo dell’ambiente sociale nel con-dizionamento dei processi psicologici (Mecacci, 1976, pp. 30-31). La psicotecnica, in questo contesto, se da un lato poteva essere un valido alleato della politica staliniana, grazie ai suoi contributi in materia di orientamento professionale e di selezio-ne dei lavoratori, era costretta dall’altro a sacrificare molto del proprio originale mandato e della propria potenzialità innovati-va alle necessità del regime, volte a omogeneizzare e centraliz-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Cimatti ottenne comunque la libera docenza nel 1929, poco dopo Carlo Alber-to Ferrari (FF, Carteggio, Lettere di Ferrari, fasc. Fiorentini, [1929]).
54 Cfr. le due minute di lettere inviate da Ferrari a Lahy il 29 marzo 1928 e il 3 aprile 1930: nella prima si scusava, adducendo problemi di salute, e co-municava che a Utrecht non vi sarebbero stati rappresentanti italiani poiché il 15 settembre era fissata a Torino la riunione della Società italiana per il pro-gresso delle scienze, «alla quale occorre partecipare dato il ritardo dell’Italia nel campo della psicotecnica»; nella seconda avvisava che non sarebbe andato a Parigi perché doveva recarsi a Washington, al Congresso d’igiene mentale, dal 5 al 10 maggio (FF, Lettere di Ferrari, fasc. Lahy).
Zocchi
!!
96
zare sempre più i settori dell’istruzione e del lavoro (Mecacci, 1976, p. 32; Krementsov, 1997, cap. 2; Gouarné, 2012, p. 277).
Accompagnato dal figlio Carlo Alberto (in quel periodo consulente presso le Acciaierie Terni) e dai coniugi Claparède, Ferrari e i colleghi degli altri paesi si preparavano dunque al viaggio in Russia proprio nel periodo in cui lo stesso presidente della Conferenza internazionale, Isaak Naftulovich Spielrein (1891-1937)55, uno dei maggiori animatori della psicotecnica sovietica negli anni Venti, cominciava a essere oggetto di criti-che e di pesanti attacchi per essersi dichiarato, pur essendo mar-xista, discepolo dello psicologo tedesco William Stern (Gouar-né, 2012, p. 277). Anche per questo, Spielrein organizzò la con-ferenza internazionale con molto impegno, sostenuto dal segre-tario Lahy, che in quanto socialista e massone non nascondeva le proprie simpatie filosovietiche. Era stato proprio Lahy, infat-ti, ad insistere perché la Russia aderisse all’AIP e partecipasse per la prima volta alla conferenza di Parigi del 1927, dove si era recata un’importante delegazione di studiosi sovietici, compo-sta, tra gli altri, dallo stesso Spielrein, da Solomon G. Heller-stein, da Nikolaj Dmitrievič Levitov e da Grigorii Ivanovich Rossolimo56 (Gouarné, 2012, p. 278).
In una lettera scritta a Spielrein poco prima della partenza, Ferrari si diceva «bien heureux de vous revoir et de visiter quelque chose de l’intéressant nouveau monde en devenir qui est votre pays»57. Un «nuovo mondo in divenire», dunque, era in procinto di svelarsi ai due Ferrari, padre e figlio, che avreb-bero presentato alla Conferenza internazionale di Mosca, rispet-tivamente, due relazioni sugli “elementi subcoscienti della fati-ca industriale e mezzi per rilevarli” e sulle “esperienze della vi-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!55 Su Spielrein cfr. Etkind (1992); Gouarné (2012). 56 Ferrari si era già messo in contatto con Rossolimo nel 1922, quando lo
aveva invitato alla Conferenza internazionale di Milano, alla quale lo studioso non aveva potuto partecipare perché, gli scrisse, «noi qui siamo troppo poveri e un tal lungo viaggio costa molto» (FF, Carteggio, Lettere a Ferrari, fasc. Rossolimo, Mosca, 1° settembre 1922).
57 FF, Carteggio, Lettere di Ferrari, fasc. Spielrein, 8 agosto 1931.
La psicotecnica in Giulio Cesare Ferrari
!
97
ta operaia fatte da un ingegnere” (FF, Carteggio, Lettere di Fer-rari, fasc. Spielrein, Bologna, 8 agosto 1931).
Già al Congresso internazionale di igiene mentale tenutosi a Washington nell’agosto 1930, Ferrari aveva ascoltato con gran-de interesse le relazioni presentate dal direttore dell’Istituto scientifico di neuropsichiatria di Mosca, Leo Rosenstein, e dal professor Salkind, docente di pedagogia in quella università, ri-guardanti l’igiene mentale nella Russia sovietica, relazioni che avevano suscitato un vivace dibattito e molte domande tra il pubblico (Ferrari, G. C., 1930b). In particolare – scriveva Ferra-ri dandone notizia sulla Rivista di psicologia – nell’URSS stali-niana «un operaio può ottenere un passaporto sanitario con l’esame psicologico, il quale ne favorisce l’adattamento alle in-dustrie più opportune e dà all’industriale la garanzia delle spe-ciali abilità o deficienze dell’individuo» (Ferrari, G. C., 1930b, p. 185). Nelle grandi città sovietiche venivano studiate «la pato-logia del lavoro, la fatica industriale, le qualità speciali, la vo-cazione, ecc.», per ottenere «il migliore adattamento degli indi-vidui alla vita». I russi, convinti che «non è il lavoro che este-nua, ma le condizioni in cui esso viene eseguito», considerava-no fondamentali la razionalizzazione, l’«eliminazione del fatto-re emotivo, la selezione vocazionale, l’esame medico, compresa l’indagine psichica della personalità, e l’organizzazione degli operai in piccoli gruppi» per assicurare appunto «il migliore adattamento di ciascuno al proprio lavoro e alla vita» (Ferrari, G. C., 1930b, pp. 185-186).
Inoltre – proseguiva Ferrari introducendo un tema che gli stava molto a cuore e che lo riportava alle proprie esperienze psicopedagogiche –, dal momento che i test vocazionali erano ritenuti in Russia «troppo meccanici» e finalizzati a una «stan-dardizzazione non logica», il bambino veniva «studiato nel suo insieme», in modo da capire quali fossero i suoi reali interessi e «dargli poi tutte le opportunità di scegliere liberamente una pro-fessione lungo le linee che lo interessano di più» (Ferrari, G. C., 1930b, pp. 189)58. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
58 Ferrari si era già occupato dell’argomento nel 1920, quando aveva pub-
Zocchi
!!
98
Il viaggio in Russia nel settembre 1931 fu dunque anche un’occasione per verificare di persona le novità provenienti da quel paese lontano e ancora poco conosciuto, di cui si avevano solo notizie di seconda mano e spesso frammentarie.
Per quanto riguardava la psicotecnica, tuttavia, si trattava di una scienza ancora troppo giovane perché il congresso interna-zionale di Mosca fornisse indicazioni risolutive ai molti pro-blemi dell’organizzazione industriale e dell’orientamento pro-fessionale. La recensione che comparve sulla Rivista di psico-logia, affidata da Ferrari al figlio Carlo Alberto, si apriva infatti con questa constatazione:
Quando convengono a congresso i cultori di una scienza
giovane, in via di formazione quasi più che di evoluzione, i lo-ro programmi, e più il succo ed il frutto delle loro adunate arri-va bene spesso ad avere un valore di informazione quasi nor-mativo. [...] Questa osservazione, tanto ovvia da sembrare ba-nale, ha avuto una conferma che le circostanze hanno reso clamorosa in occasione delle recentissima riunione dei psico-tecnici a Mosca [...], la capitale del più interessante paese del mondo di oggi (Ferrari, C. A., 1932a, p. 216). In effetti, Spielrein aveva concentrato la discussione dei te-
mi più importanti emersi dalle passate conferenze nei due giorni precedenti l’apertura dei lavori, affidandola a cinque commis-sioni dedicate rispettivamente all’unificazione del vocabolario, allo studio psicologico degli infortuni, allo studio dello sforzo nel lavoro, a quello dell’influenza dell’ambiente e alla centra-lizzazione dei test. Per quest’ultima attività, sottolineava il gio-vane Ferrari, la Commissione aveva rilevato «l’eccellente esem-pio dato in Italia dal Ponzo» e dalla Rivista di psicologia (Ferra-ri, C. A., 1932a, p. 216).
La conferenza vera e propria, invece, prevedeva oltre a tre simposi generali dedicati rispettivamente ai «Fondamenti teori-ci della psicotecnica», alla «Professiografia» e alle «Valutazioni !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!blicato sulla Rivista di psicologia un articolo che analizzava “La riforma pe-dagogica dei bolsceviki” (Ferrari, G. C., 1920a).
La psicotecnica in Giulio Cesare Ferrari
!
99
matematiche dei dati della psicotecnica», anche 50 comunica-zioni speciali. Di queste, 11 «si riferivano ad argomenti di psi-cologia generale ed avevano legami assai lassi con la psicotec-nica», 19 erano «di ordine filosofico-politico» – ma tendevano per la maggior parte «a dimostrare la esclusività del modo di vedere e di pensare comunista» – e solo 21 erano «propriamente psicotecniche». Anche fra queste ultime, secondo Carlo Alberto Ferrari, erano «purtroppo rare quelle che si potevano riferire a problemi pratici dell’industria» (Ferrari, C. A., 1932a, p. 217).
Pur riconoscendo l’importanza delle relazioni degli studiosi più accreditati nel panorama internazionale (Baumgarten, Lahy, Lipmann, Piéron, Stern e così via), l’intervento che più colpì i due Ferrari fu quello del direttore dell’Istituto del lavoro di Mo-sca, Gartew, che si era formato come operaio in una fabbrica di automobili di Parigi. Egli rifiutava le direttive fondamentali se-guite dalla psicotecnica nel resto del mondo, basate sull’orien-tamento e sulla selezione dei lavoratori, ritenendo che dovesse essere il «bisogno sociale dell’uno o dell’altro genere di lavoro» a stabilire quando e in che misura formare ed assumere perso-nale. Secondo Gartew, ogni operaio avrebbe dovuto sapersi adattare a qualunque genere di lavoro, poiché «in qualunque la-voro complesso esistono 3 momenti»:
1) preparazione, 2) esecuzione e 3) controllo, che esigono
qualità differenti per parte di chi vi è addetto. Egli analizza perciò gli operai per studiare per quale dei tre momenti debbo-no essere particolarmente destinati. […] Il secondo principio di Gartew è quello della «liberazione delle energie nascoste», che i comunisti ottengono con mezzi incentivi solo possibili, se-condo lui, nel mondo socialista (Ferrari, C. A., 1932a, p. 218). Infine, Carlo Alberto Ferrari sottolineava uno dei punti criti-
ci che in Italia, ma anche in Europa, non era ancora stato pie-namente affrontato e che ostacolava notevolmente il lavoro de-gli psicotecnici, ovvero il rapporto tra scienza e industria:
Il Gartew, da tecnico intelligente, ritiene – e per fortuna
non è il solo – che se la psicologia industriale vuole essere o
Zocchi
!!
100
divenire utile deve avvicinarsi anche ai problemi reali della vi-ta di officina. Essere quindi scienza praticamente applicabile e non restare isolata sul suo piedestallo di teorie (Ferrari, C. A., 1932a, p. 218). Qualche mese dopo essere rientrato dal viaggio in Russia,
Giulio Cesare Ferrari scrisse una interessante relazione all’am-basciatore italiano a Mosca, Bernardo Attolico, per informarlo sullo svolgimento della conferenza. Nonostante il notevole af-flusso di studiosi, spiegava Ferrari, «tutti sapevano, anche pri-ma di venire a Mosca, che i frutti di questa settima conferenza sarebbero stati scarsi»; tutte le relazioni di carattere più genera-le, infatti, erano pervenute alla seguente conclusione:
Fuori del socialismo e del materialismo dialettico di Hegel
non c’è speranza di salute per la vera scienza e tanto meno per la psicotecnica, la quale lontano dalla Russia sovietica è al ser-vizio degli interessi capitalistici59. Nonostante gli accenti polemici nei confronti del comuni-
smo, Ferrari – che del resto non aveva mai nascosto le proprie simpatie per Mussolini e per la politica fascista60 – era molto in-teressato alla situazione scientifica, politica e sociale dell’Unio-ne sovietica61, tanto che al ritorno mantenne i contatti con Spielrein, chiedendogli costantemente informazioni sull’istru-zione professionale e sull’organizzazione del lavoro in Russia. Nel rispondere alle sue domande, in una lettera del 19 maggio 1932, il collega gli forniva numerose spiegazioni in merito al lavoro dei giovani (che in URSS potevano entrare nel mondo dell’industria a 16 anni, ma solo a 18 nelle «industrie dannose» e ricevevano un’istruzione professionale in apposite «scuole !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
59 FF, Carteggio, Lettere di Ferrari, fasc. Attolico, 25 settembre 1931. 60 Cfr. Ferrari (1922a). 61 Oltre all’articolo del 1920, Ferrari aveva ospitato nel 1925, nella Rivista
di psicologia, una memoria sulla rivoluzione russa tratta dai ricordi di un pro-fugo (R[ubasceff], 1925) che si era firmato solo con le iniziali “E.R.”. Si trat-tava in realtà di una donna, Elisabetta Rubasceff, autrice, qualche anno più tardi, del volume La Russia tra due regimi (Rubasceff, 1929).
La psicotecnica in Giulio Cesare Ferrari
!
101
d’officina», dove si tenevano corsi teorici ed esercitazioni prati-che in laboratorio), ai provvedimenti assicurativi per i lavoratori ammalati e per i disoccupati, al lavoro e all’istruzione delle don-ne, alla remunerazione dei lavoratori e alla nazionalizzazione delle proprietà62: tutte informazioni che Ferrari utilizzò poi – insieme agli appunti personali di viaggio – per la stesura della sua ultima pubblicazione, La URSS vista da uno psicologo, uscita in quattro puntate sulla Rivista di psicologia nel 1932 (Ferrari, G. C., 1932b).
Anche in questo scritto, che pure aveva le caratteristiche ti-piche del diario di viaggio, con impressioni generali di carattere storico, politico, sociale e culturale, non mancavano i riferimen-ti al lavoro e all’incremento della produzione industriale sovie-tica, che nonostante le sue contraddizioni continuava ad affa-scinare e a preoccupare allo stesso tempo il mondo occidentale:
Nelle nuove città create apposta per l’industria, come Sta-
lingrad, quasi tutte le officine sono di tipo americano, col lavo-ro a catena e continuo. Cosicché, benché la giornata sia di 6 ore e i giorni lavorativi 4 su 5, si calcolava che dalla fine del 1931 sarebbero state in grado di mettere sul mercato 180.000 trattori all’anno. Però, la naturale indolenza dei russi, aggravata dal troppo rapido passaggio ad una civiltà industriale affanno-sa, non sorretta da condizioni di nutrizione e di comfort suffi-cienti, era poco adatta alla produzione intensiva moderna. Fu-rono perciò adottate la perequazione del salario al genere, alla qualità e alla quantità delle produzione, i cottimi ecc. (con ele-mentari riguardi ai sacri principi di Marx) (Ferrari, G. C., 1932b, p. 145). Per ovviare alle «difficoltà dovute alle caratteristiche etni-
che, aggravate dalla lontananza da Mosca», spiegava Ferrari, a Stalingrado i russi avevano preso a modello «il buon effetto che sullo spirito delle truppe combattenti avevano avuto le nostre compagnie di assalto, le brigades de choc francesi», applicando il medesimo principio al campo industriale:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!62 FF, Carteggio, Lettere a Ferrari, fasc. Spielrein, 19 maggio 1932.
Zocchi
!!
102
[…] dapprima vennero scelti e segnalati come esempio ai compagni gli operai che lavoravano meglio, di più e con la co-scienza di un compito, gli oudarniks, gli «attivisti»; poi si or-ganizzò una larga réclame di essi mettendone in luce nei modi più vari la più ricca produzione; infine furono create delle squadre con questi operai più intelligenti e più attivi, di diverse arti, inviandoli nelle varie officine a mostrare come si potesse lavorare più efficacemente senza maggior fatica grazie all’armonia, al sincronismo, all’economia dei movimenti ecc. (Ferrari, G. C., 1932b, p. 146). Si trattava di quel principio dell’imitazione che Ferrari ave-
va sempre considerato fondamentale per le sue applicazioni, sia nel campo educativo che in quello della psicotecnica.
Bibliografia
BABINI, V. P. (1996). La questione dei frenastenici. Alle origini della psicologia scientifica in Italia (1870-1910). Milano: FrancoAngeli.
BABINI, V. P., & LAMA, L. (2000). Una «donna nuova». Il femmi-nismo scientifico di Maria Montessori. Milano: FrancoAngeli.
BLOCH, A. M. (1903). Enquête sur la fatigue musculaire profession-nel. Bulletin de la Société de biologie, 66, 548.
BONGIORNO, V. (2009). La psicotecnica in Italia: il contributo di G. C. Ferrari. In H. GUNDLACH, E. LAFUENTE, M. SINATRA, M. M. SOKAL, & G. TANUCCI (a cura di), Psicotecnica: ieri! oggi? domani?? Atti del I Congresso internazionale. Bari, 14-16 marzo 2007 (vol. 1, pp. 21-33). Roma: Aracne.
BUYSE, O. (1908). Méthodes américaines d’éducation générale et technique. Paris: H. Dunod.
CIMINO, G., & DAZZI, N. (a cura di). (1998). La psicologia in Italia. I protagonisti e i problemi scientifici, filosofici e istituzionali (1870-1945). Milano: LED.
CIMINO, G., & LOMBARDO, G. P. (2004). Sante De Sanctis tra psicologia generale e psicologia applicata. Milano: FrancoAngeli.
COLOMBO C. A. (2008). “Sapere, fare e saper fare”. La Società Umanitaria, un modello laico per la formazione e l’orientamento al lavoro. In A. BOVO, P. NIMIS, M. PALMARO, V. PARISI, M. H. POLIDORO, & A. SANTUCCI (a cura di), L’alchimia del lavoro. I
La psicotecnica in Giulio Cesare Ferrari
!
103
generosi che primi in Milano fecondarono le arti e le scienze (pp. 93-145). Milano: Raccolto Edizioni.
C[OLUCCI] C. (1928). Congresso di psicotecnica di Utrecht, settembre 1928. Rivista di psicologia, 24, 243-244.
CORBERI, G. (1921). Appunti sulla ricerca delle attitudini profes-sionali. Rivista di psicologia, 17, 269-276.
——— (1926). Un laboratorio di psicotecnica inaugurato a Milano. Rivista di psicologia, 22, 33-37.
Cronache scientifiche (1927). 6° Congresso della Società italiana di psicologia (Bologna, 7-8-9 novembre 1927). Rivista di psicologia, 23, 228-230.
DECLEVA, E. (1985). Etica del lavoro, socialismo, cultura popolare: Augusto Osimo e la Società Umanitaria. Milano: FrancoAngeli.
DE SANCTIS, S. (1919). Psicologia della vocazione. Critica, contributi, linee generali. Rivista di psicologia, 15, 30-69.
ETKIND, A. (1992). L’essor et l’échec du mouvement “Paidologique”. De la psychanalyse au “Nouvel homme de masse”. Cahiers du Monde russe et soviétique, 33(4), 387-418.
FERRARI, C. A. (1926). L’abitudine nell’organizzazione razionale del lavoro (danni e vantaggi). Rivista di psicologia, 22, 183-190.
——— (1927). La scienza del lavoro e i principi di Enrico Ford. Rivista di psicologia, 23, 90-101.
——— (1928). Fatica individuale e fatica collettiva. Rivista di psi-cologia, 24, 43-46.
——— (1929a). Deux expériences d’organisation rationnelle du tra-vail en usine. Revue du science du travail, 1(2), 265-271.
——— (1929b). Aspetti moderni dell’organizzazione del lavoro con particolare riferimento al fattore umano. Roma: Enios.
——— (1932a). La VIIma Conferenza internazionale di psicotecnica, Mosca, (6-13 settembre 1931). Rivista di psicologia, 28, 216-218.
——— (1932b). La psicotecnica applicata alla prevenzione degli in-fortuni stradali. Rivista di psicologia, 28, 152-155.
FERRARI, G. C. (1898). Ricerche ergografiche nella donna. Rivista sperimentale di freniatria, 24, 61-86.
——— (1902). L’istruzione tecnica professionale per gli infermieri. Rivista sperimentale di freniatria, 28(4), 729-734.
——— (1919). Recensione a H. MÜNSTERBERG, Psychology and in-dustrial Efficiency. Rivista di psicologia, 15, 76-77.
——— (1920a). La grande riforma pedagogica dei Bolsceviki. Rivista di psicologia, 16, 319-326.
Zocchi
!!
104
——— (1920b). Per l’orientamento professionale dei lavoratori. Rivi-sta di psicologia, 16, 327-334.
——— (1921a). A Barcellona: la 2a Conferenza internazionale di psi-cotecnica. Lezioni per gli insegnanti di anormali. Il progetto del nuovo Codice penale italiano. Rivista di psicologia, 17, 356-361.
——— (1921b). Introduzione all’articolo di G. CORBERI, Appunti sulla ricerca delle attitudini professionali. Rivista di psicologia, 17, 269.
——— (1922a). La psicologia della Rivoluzione fascista. Rivista di psicologia, 18, 145-160.
——— (1922b). Il III Convegno internazionale di psicotecnica, Mila-no (2-3-4 ottobre 1922). Rivista di psicologia, 18, 181-187.
——— (1923). La Scuola professionale “Fermo Corni” e il La-boratorio di psicotecnica “Francesco Menafoglio”. Rivista di psi-cologia, 19, 97-99.
——— (1925). Commento all’articolo di E. R[UBASCEFF], La Ri-voluzione russa nei ricordi di un profugo. Rivista di psicologia, 21, 103-105.
——— (1927). Psicologia e tecnopsicologia. Rivista di psicologia, 23, 117-124.
——— (1930a). Il laboratorio bolognese di psicologia e la psicotecni-ca. Archivio italiano di psicologia, 8(3), 174-176.
——— (1930b). L’igiene mentale nella Russia di oggi. Rivista di psi-cologia, 26, 184-192.
——— (1931). Gli elementi subcoscienti nella fatica industriale. Rivi-sta di psicologia, 27, 153-160.
——— (1932a). Psicologia del lavoro. Un metodo originale di appli-cazione delle malate agitate al lavoro metodico ma attivo. Bolo-gna: Stabilimenti poligrafici riuniti. [Ristampa dalla Rassegna di studi psichiatrici (1930), 19, 834-846].
——— (1932b). La URSS vista da uno psicologo. Rivista di psicolo-gia, 28, 46-57, 136-147, 228-238, 314-322.
——— (1984). Autobiografia, a cura di M. QUARANTA. In G. MUC-CIARELLI (a cura di), Giulio Cesare Ferrari nella storia della psi-cologia italiana (pp. 235-268). Bologna: Pitagora [Pubblicazione originale in inglese: FERRARI, G. C. (1932). Autobiography. In C. MURCHISON (a cura di), A history of psychology in autobiography (vol. 2, pp. 63-88). Worcester: Clark University Press].
GOUARNÉ, I. (2012). Isaak N. Spielrein. VIIe Conférence internatio-nale de psychotechnique. Moscou, 8-13 septembre 1931. Présenta-tion. Bulletin de psychologie, 3, 277-281.
La psicotecnica in Giulio Cesare Ferrari
!
105
GUARNIERI, P. (1996). Ferrari Giulio Cesare. In Dizionario biografico degli italiani (vol. XLVI, pp. 605-609). Roma: Treccani.
GUNDLACH, H. (a cura di). (1998). Applied Psychology. The first-Thirteenth Congress Proceedings of the International Association of Applied Psychology. Vols. 1-13. London-New York: Routledge.
KIPIANI, V. (1912). Ambidextrie. Étude expérimentale et critique. La Revue psychologique, 5, 151-248.
KIRCHNER COLOM, M. (1979). Historia de la psicologia aplicada en Barcelona (1916-1936). Anuario de psicología, 20, 3-22.
KREMENTSOV, N. (1997). Stalinist Science. Princeton: Princeton Uni-versity Press.
LAHY, J.-M. (1922a). La conférence de psychotechnique de Genève. Journal de psychologie normale et pathologique, 1, 65-79.
——— (1922b). La fiche médicale de contre-indications, Le Con-cours médical, 28, 2305-2310.
——— (1923a). La fiche médicale de contre-indications. In Atti della III conferenza internazionale di psicotecnica applicata all’orien-tamento professionale (pp. 74-78). Milano: Società Umanitaria.
——— (1923b). La fiche médicale de contre-indication et l’orienta-tion professionnelle. Bulletin mensuel de la Ligue d’hygiène men-tale, 1-2, 5-8.
LAZZARI, S. (1998). Giulio Cesare Ferrari psicologo e psichiatra tra Otto e Novecento, con le inedite Lezioni di ortofrenia. Padova: Edizioni Sapere.
LAZZARI, S., & QUARANTA, M. (1998). Giulio Cesare Ferrari. In G. CIMINO, & N. DAZZI (a cura di), La psicologia in Italia. I prota-gonisti e i problemi scientifici, filosofici e istituzionali (1870-1945) (pp. 225-254). Milano: LED.
LOMBARDO, G. P., POMPILI, A., & MAMMARELLA V. (2002). Psicolo-gia applicata e del lavoro in Italia. Studi storici. Milano: Fran-coAngeli.
MECACCI, L. (1976). La psicologia sovietica 1917-1936. Roma: Edi-tori Riuniti.
MUCCIARELLI, G. (a cura di). (1984). Giulio Cesare Ferrari nella storia della psicologia italiana. Bologna: Pitagora.
MÜNSTERBERG, H. (1913). Psychology and industrial Efficiency. Bos-ton: Houghton Mifflin.
PADOVAN, D. (2007). Organicismo sociologico, pianificazione e cor-porativismo in Italia durante il fascismo. Rassegna italiana di so-ciologia, 4, 681-718.
Zocchi
!!
106
PASSIONE, R. (2012). Le origini della psicologia del lavoro in Italia. Nascita e declino di un’utopia liberale. Milano: FrancoAngeli.
POGLIANO, C. (1986). Il “fattore umano”. Psicologia e scienza del la-voro (1890-1940). In V. CASTRONOVO (a cura di), La cassetta degli strumenti (pp. 267-305). Milano: FrancoAngeli.
PONZO, M. (1929). Il VII Convegno nazionale di psicologia e psico-tecnica a Torino. Rivista di psicologia, 25, 271-279.
QUARANTA, M. (2006). I mondi di Giulio Cesare Ferrari. Psicologia, psichiatria, filosofia. Padova: Edizioni Sapere.
R[UBASCEFF], E. (1925). La Rivoluzione russa nei ricordi di un pro-fugo. Rivista di psicologia, 21, 96-103.
RUBASCEFF, E. (1929). La Russia tra due regimi. Milano: Alpes. SAPELLI, G. (1978). Organizzazione lavoro e innovazione industriale
nell’Italia tra le due guerre. Torino: Rosemberg & Sellier. SOCIETÀ UMANITARIA (a cura di). (1923). Atti della III Conferenza in-
ternazionale di psicotecnica applicata all’orientamento profes-sionale, Milano, 2-3-4 ottobre 1922. Milano: Cooperativa grafica degli operai.
TURBIAUX, M. (2006). J.-M. Lahy (1872-1943) et l’orientation pro-fessionnelle. Bulletin de psychologie, 2, 217-235.
ZOCCHI, P. (2012). Giulio Cesare Ferrari e Alfred Binet. Il rapporto allievo/maestro nei documenti del Fondo Ferrari. Teorie & Model-li, 17(1), 81-106.
Fonti d’archivio Fondo Ferrari (FF), Aspi - Archivio storico della psicologia italiana, Università di Milano-Bicocca: − Carteggio, Lettere a Ferrari, fascicoli: Alzina Juan; Baglioni Gi-
no; Binet Alfred; Claparède Edouard; Decroly Ovide; Enios; Gil-breth Lillian, Lahy Jean-Maurice; Levi Ettore; Lipmann Otto; Montessori Maria; Osimo Augusto; Piéron Henri; Rossolimo Grigorii Ivanovich; Ruiz Castella José; Spielrein Isaak Naftulo-vich; Toulouse Edouard.
− Carteggio, Lettere di Ferrari, fascicoli: Attolico Bernardo; Com-mendatore; Direttore dell’Ufficio internazionale per l’istruzione professionale; Enios; Fiorentini; Lombardo Radice Giuseppe; Martinotti Leonardo; Spielrein Isaak Naftulovich.
La psicotecnica in Giulio Cesare Ferrari
!
107
− Carteggio, Lettere di altri ad altri, fascicolo: Capo del Servizio materiale e trazione delle Ferrovie dello Stato.
− Documenti, Scritti scientifici, Psicotecnica e psicologia del lavo-ro, passim.
− Documenti, Congressi, commissioni e concorsi, passim. − Documenti, Scritti politici e letterari, fascicoli:! Memorie dal
viaggio in Russia; «Verso il Bolscevismo».