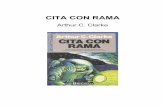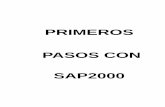LA PROMESSA CON FUNZIONE DI GARANZIA
Transcript of LA PROMESSA CON FUNZIONE DI GARANZIA
INDICE SOMMARIO
Introduzione..........................................7
CAPITOLO PRIMO
IL CONTRATTO DI GARANZIA NEL SISTEMA DEL CODICECIVILE
1. Polimorfismo del concetto di garanzia.Insufficienza della “nozione tecnica” di garanziaai fini dell’inquadramento delle varie figureutilizzate nei rapporti civili e commerciali.........152. I contratti di garanzia nel sistema delineatodal codice civile. Cenni.............................243. Personalità del vincolo fideiussorio: lafunzione di garanzia della fideiussione sispecifica nella “duplicazione” soggettiva delvincolo obbligatorio.................................324. Parti del contratto. La fideiussione rilasciatadal garante all’insaputa del debitore garantito......355. Segue: la fideiussione rilasciata su incaricodel debitore garantito...............................376. Le affinità strutturali e funzionali tra lafideiussione e l’assunzione cumulativa del debitoaltrui impongono la ricerca di sicuri criteridistintivi degl’istituti, poiché la relativadisciplina, soprattutto riguardo al regime delleeccezioni opponibili, è decisamente differente.......44
1
7. Segue: Sia la fideiussione che l’assunzionecumulativa del debito hanno per effetto unrafforzamento della posizione del creditore, ma loscopo tipico di garantire il credito ricorre nelsolo negozio fideiussorio. L’eterogeneitàfunzionale dei due schemi comporta una diversaincidenza del peso del debito........................488. Carattere solidale dell’obbligazionefideiussoria com’effetto naturale dellafideiussione.........................................529. La causa di garanzia del negozio e laconseguente accessorietà genetica e funzionaledell’obbligazione fideiussoria.......................6010. Segue: le eccezioni opponibili dal fideiussore(art. 1945 cod. civ.): un’ulteriore estrinsecazionedel principio di accessorietà........................6911. La problematica concernente gli effettiriflessi del giudicato formatosi nella lite tracreditore e debitore.................................7212. Il contenuto dell’obbligazione fideiussoria. Ilconcetto di fungibilità della prestazione............8613. Segue: la fideiussione può essere prestata pergarantire l’adempimento di obbligazioni, nonpecuniarie, di dare o fare fungibili.................9014. Segue: è possibile prestare una “fideiussione”a garanzia dell’adempimento di obbligazioni aventiad oggetto prestazioni infungibili? La strutturasolidale dell’obbligazione fideiussoria chiariscela modalità attraverso cui il fideiussore“garantisce l’adempimento dell’altruiobbligazione”........................................9415. La c.d. fideiussio indemnitatis: fattispecie digaranzia la cui funzione è succedanea, ma anche
2
autonoma rispetto all’obbligo primario diprestazione, in quanto preordinata ad “assicurare”il risarcimento del danno dovuto dal debitore perl’inadempimento del debito principale................9816. Segue: la promessa del fatto del terzo comepossibile garanzia dell’obbligazione a contenutoinfungibile.........................................10217. Conclusioni del capitolo primo..................104
CAPITOLO SECONDO
LA PROMESSA DEL FATTO DEL TERZO
1. La fattispecie denominata “promessa del fattodel terzo” (art. 1381 cod. civ.) va ricondotta alprincipio d’inefficacia del contratto rispetto aiterzi...............................................1102. Contrattualità della promessa....................1133. Segue: promessa come frammento di fattispecie....1154. Segue: promessa come contratto autonomo..........1205. Dalla previsione dell’art. 1129 dell’abrogatocodice alla formulazione attuale (art. 1381)........1226. I problemi posti dalla natura dell’obbligazioneassunta dal promittente. Le soluzioni proposte indottrina e in giurisprudenza........................1267. Segue: la tesi secondo cui il promittente assumeun obbligo di facere, nell’accezione di adoperarsiaffinché il terzo esegua il fatto promesso..........1278. Segue: l’opinione secondo cui il promittenteassume l’obbligo di procurare l’esecuzione delfatto altrui........................................130
3
9. Segue: l’insegnamento secondo cui il promittenteassume l’obbligo di pagare l’indennità,sospensivamente condizionato al rifiuto del terzo...13610. Segue: il promittente assume una obbligazionedi garanzia?........................................14011. Critiche verso la natura di garanziadell’obbligazione che il promittente assume.........15012.Segue: critiche alla possibilità di configurarela promessa come contratto con causa di garanzia....15513. Segue: critica alla configurazione di uncontratto con causa generica costante e causaspecifica variabile.................................15914. Rigetto della nozione di causa – funzione digaranzia applicabile alla promessa e individuazionedel suo fondamento causale, per il caso che essanon s’innesti in un più ampio regolamentonegoziale...........................................16215. Orientamento della Cassazione: dupliceobbligazione a carico di chi promette il fatto delterzo...............................................16716. Natura dell’obbligo del pagamentodell’indennizzo: tra autonomia ed equivalenza conil risarcimento.....................................17117. Questioni in tema d’indennizzo..................17818. L’obbligo del pagamento dell’indennizzo nonesclude che il promittente debba rispondere perillecito contrattuale e sia tenuto al risarcimentodel danno...........................................19519. Segue: prova del danno..........................19820. Considerazioni sul significato del rischioassunto dal promittente.............................200
4
21. Analisi della funzione restitutoria delpagamento dell’indennizzo...........................20422. Gratuità e onerosità della promessa. Promessadel fatto del terzo e accordo di cortesia...........21123. Forma della promessa............................21524. Conclusioni del capitolo secondo................216
CAPITOLO TERZO
LA GARANZIA AUTONOMA
1.Premessa..........................................2212 La teorizzazione dei c.d. contratti autonomi digaranzia............................................2223. Dalla teorizzazione del Garantieverträge, allatipizzazione della garanzia autonoma nella prassidel commercio internazionale........................2314. Iniziale disinteresse della dottrina italianaall’argomento della garanzia autonoma; la suadiffusione a livello interno -come garanziabancaria attiva- e a livello internazionale -comegaranzia bancaria passiva- impongono unarimeditazione sul tema..............................2385. La varietà tipologica: garanzie interne edinternazionali; passive ed attive; bid bond,perfomance bond, maintenance bond, repayment bond edaltre garanzie autonome.............................2436. Segue: Nozione e descrizione dell’operazione:garanzie autonome dirette e indirette...............2497. Riconduzione della categoria “contratto digaranzia autonoma” allo schema della promessa del
5
fatto del terzo (art. 1381 cod. civ.)...............2538. Segue: critiche alla riconduzione tout court delcontratto autonomo di garanzia alla fattispeciedella promessa del fatto del terzo..................2589. La nozione di autonomia utilizzata perdescrivere la categoria di contratti personali digaranzia in cui non trova applicazione il principiodell’accessorietà fideiussoria......................26510. La causa della garanzia consistentenell’obbligazione preesistente garantita............27711. Segue: la causa della garanzia autonoma, intesacome causalità dell’assunzione dell’obbligo digaranzia............................................28112. La Cassazione a Sezioni Unite si pronunciasulle differenze sul piano morfologico funzionaleed interpretativo tra la fideiussione ed ilcontratto autonomo di garanzia, in particolareaffrontando la problematica della qualificazionegiuridica delle polizze fideiussorie. Una sentenzastorica. Sintesi della controversia portata aconoscenza della S.C................................29413. Segue: la Corte di Cassazione sembra inquadrarein maniera unitaria le diverse ipotesi di “garanziaautonoma”...........................................29714. Segue: gli aspetti peculiari del contrattoautonomo di garanzia, sotto il profilo morfologicoe funzionale, nella ricostruzione operata dallasentenza in esame. Limiti all’autonomia delcontratto autonomo di garanzia e proponibilità ditalune eccezioni fondate sul rapporto base..........29915. Segue: profili valutativi dell’incidenza sulcontratto autonomo di garanzia della nullità delcontratto illecito..................................305
6
16. Segue: La causa del contratto autonomo digaranzia nella ricostruzione delle Sez. Unite.......30917. Segue: le Sezioni Unite qualificano le polizzefideiussorie stipulate a garanzia delleobbligazioni di un appaltatore come garanziaatipica e non fideiussoria, e pervengono ad unimportante cambiamento di rotta sulla rilevanzadelle <<clausole a prima richiesta>> e <<senzaeccezioni>>, inserite nel testo del contratto, aifini della sua qualificazione come contrattoautonomo di garanzia................................31218. Spunti sistematici forniti dalla sentenza dellaCassazione ora citata...............................32119. Una comprensione più approfondita delfunzionamento e dell’inquadramento giuridico dellediverse tipologie contrattuali che si usa ascriverealla categoria della garanzia autonoma, richiedeche si distingua innanzitutto tra garanzia <<senzaeccezioni>>, come assunzione di rischi atipici, egaranzie <<a prima domanda>>, in cui l’interessedel beneficiario è quello di poter escutere senzaritardo la garanzia.................................32620. La garanzia autonoma come assunzione di rischiatipici. Cenni alla fattispecie dell’indemnity, chenell’area di common law assolve alla stessafunzione svolta dal Garantieverträge nell’ordinamentotedesco. L’obbligazione di garanzia può essereautonoma in senso assoluto solo se il contrattoavente ad oggetto la prestazione di garanzia abbiauna giustificazione causale autonoma. In tal casoandranno distinti nettamente due pianidell’analisi: a) l’oggetto del contratto, ossia laprestazione della garanzia; b) la causa dellostesso, che andrà individuata nelle comuni ragioni
7
giustificatrici di un negozio. Le uniche eccezioniopponibili dal garante al beneficiario sarannoquelle derivanti dal contratto di garanziamedesimo............................................33221. La garanzia autonoma <<a prima domanda>>. Lariconduzione di tali figure contrattuali allagaranzia autonoma costituisce un errore diprospettiva?........................................34222. Segue: la qualificazione della Bankgarantiefondata sulla circostanza che l’obbligazione delgarante è contratta all’interno di un procedimentotipologicamente riconducibile a quello delegatorio.La causa della garanzia bancaria passiva ècostituita dall’obbligazione adempiuta eseguendol’incarico del cliente..............................35123. Segue: La qualificazione delle polizzefideiussorie come contratto a favore di terzi concausa di scambio, per essere il debitore garantitotenuto a pagare una somma alla compagnia diassicurazioni.......................................36524. Autonomia ed accessorietà della garanzia eregime delle eccezioni. Le eccezioni relative alcontratto ed al rapporto di garanzia (rinvio).Riesame della problematica alla luce della propostaricostruzione delle garanzie bancarie passive edelle polizze fideiussorie: le eccezioni relativealla causa della promessa con funzione di garanziaautonoma............................................36925. Segue: Il problema dell’opponibilità albeneficiario delle eccezioni derivanti dalcontratto e dal rapporto principale. Laproponibilità dell’exceptio doli in caso di escussionefraudolenta o abusiva del creditore può costituireuno strumento per prevenire possibili abusi?........379
8
26. Riepilogo.......................................384
CONCLUSIONI
SEZIONE PRIMA: LA PROMESSA DEL FATTO DEL TERZO ALLO"STATO DELL'ARTE INTERPRETATIVO".1. Gli effetti obbligatori della promessa del fattodel terzo...........................................3882. Funzione dell’indennizzo e determinazione delsuo ammontare.......................................394
SEZIONE SECONDA: PROMESSA DEL FATTO EL TERZO EGARANZIA DEL CREDITO.1. Configurabilità di una promessa dell’altruiadempimento. Un’ipotesi accettabile?................3992. La promessa del fatto del terzo come possibilestrumento per garantire il creditore contro irischi atipici del contratto?.......................407
Indice degli autori......................................413
Indice delle sentenze....................................419
Allegato1
9
INTRODUZIONE
Il presente studio si propone di analizzare le
possibili accezioni funzionali del negozio
attraverso cui s’intende garantire un diritto
di credito. Una nozione risalente, sulla base
di un’analisi sistematica avente ad oggetto i
contratti di garanzia specificamente
contemplati dal codice civile, ravvisava
nell’obbligazione di garanzia uno strumento per
rafforzare le ragioni del creditore, con l’accrescerne le
probabilità di soddisfazione. L’osservazione attenta
della prassi economica e commerciale evidenzia,
tuttavia, che le varie figure contrattuali che
perseguono una funzione di garanzia non si lasciano
inquadrare dal citato concetto. Alla luce di
siffatta considerazione si è proposta un’idea
più moderna di garanzia, che le assegna
10
piuttosto finalità di controllo e riduzione del rischio di
mancato soddisfacimento, per questa via
privilegiando un’indole in cui prevalgono scopi
indennitari.
L’inquadramento della promessa del fatto del
terzo come contratto di garanzia ha fondamento
dogmatico in tale visione funzionale
dell’istituto.
La materia è distribuita in tre capitoli. Nel
primo si espongono i caratteri peculiari dei
contratti di garanzia accolti nel sistema del
codice, con particolare riguardo alla
fideiussione, figura negoziale che rappresenta
tanto nella prassi, quanto nella teoria del
diritto, una delle più antiche forme di tutela
delle ragioni creditorie, nonché l’exemplum da
cui originano le più recenti manifestazioni
11
atipiche di garanzia (contratto autonomo,
polizze fideiussorie e lettere di patronage).
L’indagine condotta sulle diverse forme
negoziali di garanzia accolte nel sistema
codicistico evidenzia una loro
caratterizzazione omogenea, consistente nel
generare diritti (di garanzia) accessori al
credito. Sebbene il legislatore in nessuna
norma enunci l’attributo dell’“accessorietà”, è
opinione costante che esso sia intrinseco nel
fondamento causale di garanzia dei contratti in
questione, che, in quanto preordinati alla
tutela di un credito preesistente, implicano un
collegamento genetico e funzionale del rapporto
di garanzia con quello principale.
Il capitolo secondo ha per oggetto l’analisi
concernente l’operazione negoziale denominata
12
“promessa del fatto del terzo”, figura
contrattuale che (a dispetto del nome) potrà
inserirsi in un più ampio regolamento
d’interessi, o anche presentarsi come autonoma
negoziazione. Il coacervo di opinioni
dottrinali e giurisprudenziali in ordine alla
natura dell’obbligazione assunta dal
promittente rende necessario un esame delle
diverse tesi proposte circa la natura
dell’obbligazione assunta dal promittente, da
cui si evince che l’evoluzione dialettica delle
considerazioni sul tema conduce alla
descrizione dell’impegno assunto dal
promittente come obbligazione di garanzia.
Secondo tal insegnamento, con la conclusione
della promessa il promittente assume il rischio
del mancato compimento del fatto del terzo,
indipendentemente da ciò che farà per indurre
13
il terzo a compiere il fatto. Il promissario ha
la certezza di contare su un’utilità
sostitutiva rispetto al fatto del terzo
promesso: il pagamento dell’indennizzo. Il
concetto di garanzia assunto a fondamento del
citato orientamento interpretativo descrive
l’assunzione, da parte del garante, dell’onere
economico del rischio che il terzo non compia
quanto promesso dal promittente.
Un precedente storico della riconduzione della
promessa ex art. 1381 cod. civ. a tale nozione
di garanzia si deve alla dottrina tedesca, che
ha accomunato nella categoria dei cc. dd.
Garantieverträge tutti quei contratti ignorati dal
BGB, ma diffusi nella prassi, caratterizzati da
una “funzione di garanzia consistente nel fornire sicurezza
contro il verificarsi di un evento temuto”.
14
Si tratta di contratti non accessori ad un
debito preesistente - e quindi differenti sotto
questo aspetto dalle garanzie personali tipiche
- ma che hanno una funzione di garanzia, “poiché
un contraente assicura all’altro un’indennità, per il caso che
quest’ultimo subisca un danno, o non veda soddisfatto un suo
interesse”.
L’individuazione della “funzione di garanzia”
del contratto attraverso cui si promette il
fatto del terzo lascia tuttavia aperto il
problema della giustificazione causale del
negozio. Apparirà a tal fine illuminante
l’orientamento dottrinale secondo cui il
termine garanzia oltre ad indicare la causa
negoziale, può essere utilizzato per esprimere
la natura, la funzione della prestazione
dovuta, la quale può contribuire a realizzare
15
svariati schemi causali. In quest’ottica,
parlando di promessa di garanzia, si farà
riferimento non alla causa della promessa, ma
alla natura (di garanzia) dell’effetto.
Rilevanti interrogativi solleva il tema del
quantum debitum, per il caso che il fatto del
terzo non si verifichi. Una risposta alla
questione dipenderà dalla concezione che si
accolga circa la funzione esplicata dalla
promessa del fatto del terzo.
Il terzo capitolo è dedicato, infine, alla c.d.
garanzia autonoma, le cui origini teoriche sono
rintracciabili nella figura del Garantieverträge,
categoria cui la dottrina moderna e la
giurisprudenza riconducono soprattutto una
serie di garanzie “a prima domanda” utilizzate
nella prassi commerciale. L’operazione è però
16
compiuta trascurando le peculiarità causali del
tipo negoziale originario e richiamandone il
solo effetto dell’autonomia dell’obbligazione
di garanzia, che diventa idoneo, forse senza i
necessari approfondimenti, ad inquadrare una
serie non omogenea di fattispecie negoziali.
L’analisi separata delle diverse fattispecie
condurrà ad individuare un gruppo di contratti
con funzione di garanzia che possono
addirittura prescindere dalla stessa esistenza
del negozio principale, o attraverso cui il
garante può assumere i c.d. rischi atipici del
contratto, concernenti l’evenienza
dell’invalidità o della risoluzione del negozio
principale. Il risultato del <<distacco>>
dell’operatività della garanzia rispetto alle
vicende del negozio “garantito” costituisce per
17
siffatta forma contrattuale un effetto del suo
fondamento causale autonomo.
La locuzione “contratto di garanzia” starà qui
ad indicare non la causa del negozio (causa
cavendi), bensì la funzione della prestazione
posta in essere dal garante, volta alla
protezione dell’interesse del beneficiario a
non subire detrimento per la conclusione di un
certo affare.
Gli studi dedicati a siffatta forma
contrattuale conducono ad importanti risultati
sistematici circa l’inquadramento della
promessa del fatto del terzo tra i contratti di
garanzia.
18
SOMMARIO: 1. Polimorfismo del concetto di garanzia. Insufficienza della
“nozione tecnica” di garanzia ai fini dell’inquadramento delle varie figure
utilizzate nei rapporti civili e commerciali. - 2. I contratti di garanzia nel
sistema delineato dal codice civile. Cenni. - 3. Personalità del vincolo
fideiussorio: la funzione di garanzia della fideiussione si specifica nella
“duplicazione” soggettiva del vincolo obbligatorio. - 4. Parti del contratto.
La fideiussione rilasciata dal garante all’insaputa del debitore garantito. -
5. Segue: la fideiussione rilasciata su incarico del debitore garantito. - 6.
Le affinità strutturali e funzionali tra la fideiussione e l’assunzione
cumulativa del debito altrui impongono la ricerca di sicuri criteri distintivi
degl’istituti, poiché la relativa disciplina, soprattutto riguardo al regime
delle eccezioni opponibili, è decisamente differente. - 7. Segue: Sia la
fideiussione che l’assunzione cumulativa del debito hanno per effetto un
rafforzamento della posizione del creditore, ma lo scopo tipico di
garantire il credito ricorre nel solo negozio fideiussorio. L’eterogeneità
funzionale dei due schemi comporta una diversa incidenza del peso del
debito. - 8. Carattere solidale dell’obbligazione fideiussoria com’effetto
naturale della fideiussione. - 9. La causa di garanzia del negozio e la
conseguente accessorietà genetica e funzionale dell’obbligazione
fideiussoria. - 10. Segue: le eccezioni opponibili dal fideiussore (art. 1945
cod. civ.): un’ulteriore estrinsecazione del principio di accessorietà. - 11. La
problematica concernente gli effetti riflessi del giudicato formatosi nella
lite tra creditore e debitore. - 12. Il contenuto dell’obbligazione
fideiussoria. Il concetto di fungibilità della prestazione. - 13. Segue: la
fideiussione può essere prestata per garantire l’adempimento di
obbligazioni, non pecuniarie, di dare o fare fungibili. - 14. Segue: è
possibile prestare una “fideiussione” a garanzia dell’adempimento di
20
obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni infungibili? La struttura
solidale dell’obbligazione fideiussoria chiarisce la modalità attraverso cui
il fideiussore “garantisce l’adempimento dell’altrui obbligazione”. - 15. La
c.d. fideiussio indemnitatis: fattispecie di garanzia la cui funzione è
succedanea, ma anche autonoma rispetto all’obbligo primario di
prestazione, in quanto preordinata ad “assicurare” il risarcimento del
danno dovuto dal debitore per l’inadempimento del debito principale. -
16. Segue: la promessa del fatto del terzo come possibile garanzia
dell’obbligazione a contenuto infungibile. - 17. Conclusioni del capitolo
primo.
1. Polimorfismo del concetto di garanzia. Insufficienza della
“nozione tecnica” di garanzia ai fini dell’inquadramento
delle varie figure utilizzate nei rapporti civili e commerciali.
Il concetto di garanzia rinvia necessariamente
ad un quid a cui s’intende fornire una
protezione; esso ha un’impronta marcatamente
funzionale, in quanto, da un punto di vista
logico e strutturale, è necessariamente
associato ad una situazione soggettiva o ad un
interesse, che s’intende proteggere o
21
realizzare1. In ambito giuridico la pluralità
d’interessi della persona umana suscettibili di
essere presidiati fornisce una spiegazione
all’uso dello stesso termine “garanzia” in
diversi settori dell’ordinamento, in cui esso
assume un’accezione differente in relazione ai
diversi istituti per cui viene impiegato
(garanzie processuali, garanzie costituzionali,
garanzie del credito garanzie internazionali),
pur conservando la medesima rilevanza
concettuale d’individuare quegli strumenti che
hanno la funzione di proteggere, rafforzare una
data situazione soggettiva2.
Nel settore del diritto privato la locuzione
garanzia viene impiegata per descrive tanto i1 L. PIAZZA, Garanzia I) Diritto civile, in Enc. giur. Treccani, XIV, Roma,
1989, pag 1.2 S. GALEOTTI, La garanzia costituzionale (presupposti e concetto), Milano, 1950;
M. FRAGALI, Garanzia, in Enc. del dir., XVIII, Milano, 1969, p. 449
ss.
22
mezzi che l’ordinamento appresta per assicurare
l’adempimento dell’obbligazione, quanto gli
strumenti offerti al titolare di una situazione
giuridica attiva, per assicurargliene il
godimento3. Ne risulta un concetto di garanzia
che individua <<ogni mezzo apprestato
dall’ordinamento per assicurare il godimento di
un diritto o l’adempimento di
un’obbligazione>>4.
3 E. BRIGANTI, Fideiussione e promessa del fatto del terzo, Napoli, 1981, p.
12. Esempi dell’utilizzo del termine garanzia in tale ultima
accezione possono rinvenirsi in varie norme del codice civile:
art. 1476 n. 3 cod. civ. (in cui si fa riferimento all’obbligo del
venditore di garantire il compratore dall’evizione e dai vizi
della cosa); art. 1585 cod. civ. (in cui è statuito l’obbligo del
locatore di garantire il conduttore dalle molestie che
diminuiscono l’uso o il godimento della cosa, arrecate da terzi
che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima); art. 1266
cod. civ. (in cui si prevede l’obbligo di colui che cede un
credito di garantire l’esistenza del credito al tempo della
cessione, laddove questa sia a titolo oneroso).4 E. BRIGANTI, op. loc. cit.; G. BO, Garanzia, in Noviss. dig. it., VI,
Torino, 1938, p. 192.
23
La dottrina precisa, però, che i due distinti
fenomeni (garanzia dell’adempimento – garanzia
del godimento di un diritto) hanno in comune la
sola circostanza di operare, nei casi di
<<deviazione del rapporto dal suo iter
fisiologico e cioè al verificarsi di certi
eventi negativi>>5 (vizi della cosa venduta o
evizione, molestie arrecate al conduttore della
cosa locata, invalidità del credito ceduto,
inadempimento), come strumenti ripristinatori
della fisiologia dei rapporti. Ad un’analisi
più approfondita emerge che le c.d. garanzie di
godimento non sono altro che obbligazioni che
la legge impone al titolare di una situazione
soggettiva passiva (o che le parti stesse
pattuiscono: es. garanzia della solvenza di cui
all’art. 1267 cod. civ.), che comportano
5 L. PIAZZA, op. loc. cit.
24
un’assunzione di responsabilità funzionale al
perseguimento degli scopi tipici del negozio
concluso, dovendo, chi trasmette un diritto,
assicurarne l’esistenza ed il pacifico
godimento. In quest’ottica, l’obbligo del locatore di
garantire il conduttore dalle molestie che
diminuiscono l’uso o il godimento della cosa6
altro non è che una specificazione dell’obbligo
di assicurare (garantire secondo l’art. 1575 n.
3 cod. civ.) al conduttore il pacifico
godimento del bene; parimenti, gli obblighi “di
garanzia” imposti al venditore (art. 1476 n.3
cod. civ.), a colui che cede un credito (art.
art. 1266 cod. civ.), o un contratto (art.
1410, comma 1, cod. civ.) assicurano il
contenuto del diritto attribuito al creditore.
Come si è giustamente osservato, tali obblighi
6 Art. 1585 cod. civ.
25
c.d. “di garanzia” <<avrebbero potuto essere
ugualmente desunti dai principi generali, anche
se in termini diversi e con un certo sforzo,
ove la legge non li avesse previsti
espressamente, (…) perché non v’è obbligazione
che non “garantisca” il suo adempimento>>7. In
altri termini, dette garanzie costituiscono una
specificazione dei doveri contrattuali che
gravano sulle parti del negozio, e descrivono
pertanto un’assunzione di responsabilità,
piuttosto che di garanzia (nel senso avanti
precisato)8.
Quanto alle garanzie di adempimento
dell’obbligazione, si è tentato9 d’individuare
“il contenuto legittimo del concetto di garanzia”, precisando
7 M. FRAGALI, op. loc.. cit.8 D. BARBERO, Sistema del diritto privato italiano, II, Torino, 1965, p. 123
ss.9 M. FRAGALI, Garanzia, cit., p. 449 ss.
26
che: a) la garanzia di un’obbligazione non può
consistere nell’assunzione di una nuova
obbligazione da parte del debitore, perché per
tal verso non viene rafforzata sotto alcun
profilo l’aspettativa creditoria10; b) né la
garanzia di un’obbligazione può realizzarsi
attraverso l’assunzione di un’obbligazione, il
cui peso economico si riversi definitivamente
sul patrimonio del garante, perché elemento
essenziale della garanzia è l’incidenza del
peso definitivo del debito su di un patrimonio
diverso da quello dell’obbligato in via
accessoria (garante)11; c) né la garanzia può
attuare una mera assunzione di rischio da parte
del garante, anche per il caso che il peso
definitivo del debito non incida
definitivamente sul patrimonio di costui,10 RUBINO, La compravendita, Milano, 1962, p. 634.11 M. FRAGALI, op. loc. ult. cit.
27
poiché elemento essenziale della garanzia è il
rafforzamento delle possibilità satisfattorie
dell’aspettativa creditoria, mentre nel caso di
specie si realizzerebbe la sola conservazione
dell’integrità patrimoniale della sfera del
creditore12.
Si perviene, attraverso siffatta delimitazione
del concetto, ad un’accezione di garanzia
descrittiva della funzione di rafforzamento
dell’aspettativa di attuazione di un’altra obbligazione13.
L’obbligazione di garanzia sarebbe quella (e
solo quella) che rafforza le ragioni del
creditore, nel senso di un potenziamento delle
probabilità satisfattive del suo diritto di
credito14.12 M. FRAGALI, op. cit., p. 450.13 M. FRAGALI, op. cit., p. 454 ss.14 Una maggiore sicurezza circa la realizzazione dell’aspettativa
del creditore può realizzarsi, stando al sistema predisposto dal
legislatore, attraverso una misura reale che migliori l’efficacia
28
Posizioni più recenti hanno criticato questa
definizione, perché insufficiente sotto il
profilo dell’inquadramento delle varie figure
negoziali che la pratica conosce. La prassi dei
rapporti economici e commerciali mostra,
infatti, che attraverso l’autonomia privata si
fa ricorso ad una serie di strumenti attraverso
cui, più che rafforzare le probabilità di
soddisfazione di un credito, si persegue il
fine di evitare che la posizione giuridica di
un soggetto sia pregiudicata da fatti estranei
alla propria sfera di dominabilità. Sulla base
di tal osservazione, si propone l’accoglimento
di una nozione di “garanzia” che non descriva
dell’azione esecutiva (in termini di tempo e certezza del
risultato), oppure attraverso una garanzia c.d. personale, che
veda obbligato un terzo ad eseguire “la medesima” prestazione cui
è tenuto il debitore principale, ed il cui inadempimento permetta
di aggredire anche il suo patrimonio, oltre quello dell’obbligato
principale.
29
il solo fenomeno del rafforzamento del credito,
ma la più ampia funzione negoziale, consistente
nel controllo e riduzione del rischio del mancato
soddisfacimento di un interesse, mediante l’assunzione, da
parte del “garante” dell’onere economico del danno temuto15.
La diversità di prospettiva si evidenzia in
ciò: la garanzia, nell’accezione “tecnica”
(come rafforzamento delle probabilità di
15 Tra gli altri, F. NAPPI, op. cit., p. 58; E. BRIGANTI, op. cit., p.
145 ss.; L. PONTIROLI, Le garanzie autonome ed il rischio del creditore, un
contributo alla lettura del sistema, Padova 1992, p. 176; L. PIAZZA, op. cit.,
p. 3, il quale sottolinea che il nostro sistema codicistico è
prevalentemente orientato verso un complesso sistema di
<<sicurezza del credito>>, la cui ricomposizione sarebbe utile a
fornire un’accezione più precisa del concetto civilistico di
garanzia, che si estrinseca nella sicurezza fornita al creditore
circa il soddisfacimento del proprio interesse. L’A. rileva che,
essendo decisamente scarsi gli strumenti predisposti dal
legislatore al fine specifico del <<rafforzamento del diritto di
credito>>, una nozione di garanzia fondata su tal aspetto
funzionale, se da un lascerebbe in un << limbo paragiuridico>>
inaccettabile una serie di strumenti tipici e atipici, dall’altro
non sarebbe utile alla comprensione del nucleo funzionale del
fenomeno della garanzia, consistente appunto nella sicurezza, in
senso lato, apprestata al beneficiario.
30
soddisfacimento del credito), costituisce uno
strumento che attribuisce nuove utilità al beneficiario,
soddisfacendo quello stesso interesse
creditorio dedotto in un rapporto principale
(garanzia satisfattiva); in questa “nuova”
accezione rappresenta uno strumento funzionale
ad evitare che il beneficiario subisca un detrimento
patrimoniale, preservando pertanto le utilità
esistenti nel suo patrimonio (garanzia
indennitaria). Si è giustamente segnalato16 che
quest’elaborazione del concetto di garanzia
rappresenta <<il retroterra dogmatico di una
concezione della garanzia con finalità sempre meno
satisfattorie - quelle avute presenti dal
legislatore nell’approntare degli strumenti
tipici di garanzia – e sempre più indennitarie – alle
quali mira invece l’autonomia privata col
16 F. ROCCHIO, La promessa con funzione di garanzia, Napoli, 2009, p. 22.
31
ricorso a strumenti che presentano molti punti
di contatto con la funzione assicurativa ->>17.
Da un punto di vista strutturale, l’interesse
che attraverso quest’accezione di garanzia
riceve tutela non necessariamente è contemplato
in un diverso rapporto obbligatorio (c.d. base,
o principale), ma può essere elevato ad oggetto
di protezione esclusivamente nel negozio di
garanzia18, o comunque, pur accedendo
quest’ultimo ad un rapporto principale, è
possibile che il garante si impegni sulla base
di una causa negoziale “autonoma”, diversa
dalla preesistenza del rapporto garantito, con
l’effetto che ne risulterà spezzato il tipico
nesso di accessorietà che lega l’obbligazione
17 A. e op. ult. cit., p. 22. Il corsivo è nostro.18 Che è quanto accade per la promessa del fatto del terzo. F.
NAPPI, op. loc. ult. cit.
32
di garanzia (fideiussoria) all’obbligazione
principale19.
L’inquadramento della promessa del fatto del
terzo tra i negozi di garanzia ha fondamento in
quest’accezione del concetto di garanzia20, nel
cui ambito, volendo citare solo alcune delle
fattispecie più diffuse nella prassi, la
dottrina riconduce anche il contratto autonomo
19 Tal evenienza potrà individuarsi sia per la promessa del fatto
del terzo, ammettendo che siffatto contratto possa essere
stipulato per assicurare il fatto dell’adempimento di un terzo,
sia per la garanzia autonoma intesa come assunzione dei rischi
atipici.20 SCALFI, La promessa del fatto altrui, Milano – Varese, 1955, p. 48; F.
NAPPI, op. cit., p. 59.
33
di garanzia nelle sue varie articolazioni21 e le
lettere di patronage22.
S’individuano, pertanto, accanto ai negozi di
garanzia previsti dal codice civile, contratti “con
funzione di garanzia”, caratterizzati da un triplice
ordine di peculiarità rispetto al tipico
negozio di garanzia personale (la
fideiussione): a) hanno una diversa funzione,
consistente nel controllo e riduzione del
rischio del mancato soddisfacimento di un
interesse, mediante l’assunzione, da parte del
“garante”, dell’onere economico del danno
temuto.21 Vedremo al capitolo terzo che in realtà occorrerebbe
distinguere le varie ipotesi che si suole ascrivere alla
categoria; talune infatti sono propriamente riconducibili alla
nozione di garanzia da ultimo descritta, mentre altre rimangono
ancorate al principio di accessorietà dell’obbligazione di
garanzia, seppur temperato dall’iniziale inopponibilità delle
eccezioni relative al rapporto principale. V. cap. terzo, par. 19
ss.22 A. MAZZONI, Le lettere di patronage, cit., p. 114 ss.
34
b) Il profilo funzionale investe quello
strutturale, in quanto la circostanza per cui v’è
tutela di un interesse e non di un credito si
riflette sul nesso esistente tra il rapporto
principale e quello di garanzia, connotandolo
di una più accentuata autonomia, rispetto alla
relazione esistente tra l’obbligazione del
fideiussore e quella del debitore principale
(che è tradizionalmente descritta attraverso il
concetto di accessorietà).
c) Infine, dal punto di vista della giustificazione
causale, la mancanza di un riverbero delle
vicende del rapporto principale sul rapporto di
garanzia comporterà, com’è logicamente ovvio,
la necessità d’individuare un fondamento
causale diverso da quello che assiste i c.d.
contratti accessori di garanzia, che
35
s’individua nella preesistenza del rapporto
garantito.
Questi profili che caratterizzano i contratti
che assolvono la funzione di garanzia in senso
lato, che si è testé descritta, saranno meglio
esplicitati nel secondo e terzo capitolo del
presente studio, quando si tratterà
specificamente della promessa del fatto del
terzo (art. 1381 cod. civ.) e della garanzia
autonoma. Dovranno esaminarsi, invece, in
questo capitolo, i tratti caratteristici della
garanzia fideiussoria, che rappresenterà, nella
nostra analisi, il punto di riferimento per
stabilire le differenze strutturali, funzionali
e causali del contratto con cui un promittente
“garantisca” ad un promissario il compimento di
un certo fatto da parte di un terzo.
36
2. I contratti di garanzia nel sistema delineato dal codice
civile. Cenni.
I diritti di garanzia derivano da specifici
titoli legali o negoziali, a differenza della
garanzia patrimoniale (ex art. 2740 cod. civ.),
che presidia la soddisfazione di tutti i
crediti23 In via di premessa va precisato che le
figure di garanzia contemplate dal nostro
codice civile hanno un’indiscutibile
caratterizzazione omogenea, consistente nel
generare diritti soggettivi accessori. Discende
da ciò un intenso collegamento tra il diritto
credito, di cui s’intende assicurare
l’adempimento, ed il diritto di garanzia
preordinato a tale scopo.
23 Non è il caso di addentrarsi, in questa sede, nel dibattito che
vede da un lato coloro che assegnano anche alla garanzia
patrimoniale generica una funzione di garanzia, e coloro che
negano questa funzione con riferimento all’art. 2740 cod. civ. Si
rinvia per l’argomento a M. FRAGALI, op. cit., p. 451 e 461.
37
Secondo una tradizionale distinzione le
garanzie si distinguono in reali (o garanzie
sui beni) e personali. Garanzie reali tipiche
sono il pegno e l’ipoteca. Il diritto di pegno
si costituisce mediante un contratto reale: non
basterà pertanto il consenso degli interessati,
essendo necessario il trasferimento della cosa
al creditore (art. 2786 cod. civ.). Per quanto
concerne l’ipoteca, la legge distingue tra
ipoteca legale (art. 2817 cod. civ.),
giudiziale (art. 2818 cod. civ.) e volontaria
(art. 2821 ss. cod. civ.24).
Entrambe le garanzie, vincolando determinati
beni al soddisfacimento del creditore (c.d.
24 L’ipoteca volontaria è regolarmente concessa per contratto, ma
l’art. 2821 cod. civ. ne consente la concessione anche per
dichiarazione unilaterale. Questo è uno dei casi in cui la legge
riconosce effetti vincolanti alla dichiarazione unilaterale di
volontà (art. 1987 cod.civ.). Non ne è ammessa la costituzione per
testamento.
38
diritto di seguito) e, attribuendo al
beneficiario un diritto di prelazione sul
ricavato della vendita del bene su cui grava la
garanzia, tendono a migliorare il risultato
dell’azione esecutiva25.
Al pegno ed all’ipoteca il legislatore
affianca, come cause legittime di prelazione, i
privilegi (art. 2741 cod. civ.), che tuttavia,
pur svolgendo una funzione di garanzia del
credito, nel senso di determinare un vincolo di
destinazione o di soggezione esecutiva
preferenziale26, non nascono da una convenzione
negoziale, bensì sono titoli di prelazione
accordati dalla legge, in considerazione della
causa del credito (art. 2745 cod. civ.).
25 Cfr. M. FRAGALI, Garanzia, cit., p. 462.26 A. e op. ult. cit., p 457.
39
Le garanzie personali o semplici conferiscono
al titolare di un diritto di credito un pari
diritto verso un soggetto terzo, estraneo al
rapporto principale (garantito), il cui
adempimento permette al beneficiario di
conseguire la medesima prestazione oggetto
dell’obbligazione principale27. Tipico negozio
costitutivo di garanzia personale è la
fideiussione (art. 1936 ss.)28.
Il nostro codice civile contempla altre due
forme contrattuali che esplicano una funzione
di garanzia: l’anticresi (art. 1960 ss., cod.
civ.) ed il mandato di credito (art. 1958 –
1959, cod. civ.). Come vedremo, tuttavia, non è
27 C. M. BIANCA, op. cit., p. 465 ss.28 Pur essendo discussa la circostanza che la fideiussione
rappresenti l’unico paradigma codicistico di garanzia personale
(così L. PIAZZA, op. cit., p. 4), è certo che tale contratto
rappresenta quello, tra le garanzie personali, cui il legislatore
dedica una più particolareggiata disciplina.
40
corretto qualificare quest’ultimo come tipo
autonomo di contratto di garanzia.
A) Quanto alla prima, essa costituisce figura
sostanzialmente desueta nella moderna economia.
Alla stregua dell’art. 1960 cod. civ.
l’anticresi (semplice o estintiva) si configura
come il contratto con il quale il debitore o un
terzo si obbliga a consegnare un immobile al
creditore a garanzia del credito, affinché il
creditore ne percepisca i frutti, imputandoli
agl’interessi, se dovuti, e quindi al capitale.
La dottrina prevalente29 individua, sulla base
dell’art. 1964 cod. civ., una seconda specie di
anticresi (c.d. compensativa), in cui è
convenzionalmente attribuito al creditore il
diritto di percepire i frutti dell’immobile29Cfr. V. TEDESCHI, Anticresi, in Noviss. dig. it., Torino, 1968, I, p.
658; M. SCARLATA FAZIO, Il contratto di anticresi, in Studi in memoria di
Antonino Giuffrè, II, Milano, 1967, p. 815.
41
consegnatogli a compensazione dei soli
interessi, fermo restando il debito. In tal
caso il debitore potrà in ogni tempo estinguere
il debito, così rientrando nel possesso
dell’immobile. Secondo siffatta prospettazione
le due fattispecie dovrebbero distinguersi in
funzione della diversa destinazione dei frutti
percepiti dal creditore30, con la conseguenza di
una differente disciplina riguardo all’obbligo
di rendiconto a carico del creditore
(insussistente nell’anticresi compensativa31).
30 Nell’ipotesi contemplata dall’art. 1964 cod. civ. i frutti sono
destinati integralmente e forfettariamente – ossia
indipendentemente dalla loro concreta venuta ad esistenza ed
effettiva entità- ad estinguere in tutto o in parte il debito
d’interessi e, soltanto se convenuto, anche l’obbligazione
relativa al capitale (nel qual caso, rimanendo una parte dei
frutti a disposizione del capitale, l’anticresi sarà riconducibile
allo schema previsto dall’art. 1960 cod. civ., che postula,
appunto, la ripartizione dei frutti tra interessi e capitale).31 M. FRAGALI, L’anticresi, in Comm. cod. civ. Scialoja e Branca, Bologna-
Roma, 1974, p. 202.
42
Sennonché si è osservato32 che una corretta
individuazione del tipo negoziale presuppone
che si tengano presenti le due ipotesi di
anticresi, in quanto il legislatore,
predisponendo l’art. 1964, non ha avuto
intenzione di prevedere una figura autonoma, ma
una clausola particolare, che non modifica la
struttura tipica del negozio anticretico. In
tale prospettiva l’anticresi può definirsi come
il contratto con cui il debitore (o un terzo)
consegna al creditore un immobile, affinché ne
percepisca i frutti imputandoli al suo credito,
salvo che sia stata convenuta la compensazione,
in tutto o in parte, di questi con
gl’interessi33.
32 G. ZUDDAS, Anticresi, in Enc. giur. Treccani, I, Roma, 1988, p. 1.33 M. FRAGALI, L’anticresi, cit., p. 7.
43
Tralaticio in giurisprudenza34 ed in dottrina35
è il riferimento alla funzione di garanzia del
negozio anticretico. Bisogna però specificare
che l’anticresi svolge la suddetta funzione
solo in senso lato, ed in modo diverso dal
pegno e dall’ipoteca, per essere assente il
collegamento dell’operatività della garanzia
con l’inadempimento e con la conseguente azione
esecutiva, che invece è elemento caratteristico
dei menzionati diritti reali di garanzia. La
funzione di garanzia esplicata da tale negozio
andrà quindi ravvisata nel soddisfacimento
diretto del creditore, tramite l’attuazione del
godimento concessogli36.
34 Cass., 27 novembre 1951, n. 2696, in Foro it. 1952, I, c. 11; App.
Lecce 22 giugno 1953, in Rep. giust. civ., 1955, Locazione di cose, n. 7;
Ap.. Trieste, 11 gennaio 1957, in giust. civ., 1957, I, p. 1428.35 V. TEDESCHI, Anticresi, cit., p. 656; C. M. BIANCA, Il divieto del patto
commissorio, Milano, 1957, passim. 36 V. TEDESCHI, op. loc. cit.
44
Quel che preme qui sottolineare, rinviando
l’approfondimento complessivo della figura agli
studi ad essa specificamente dedicati37, è
l’accessorietà del rapporto anticretico
rispetto a quello principale che dev’essere
estinto. La validità e l’efficacia
dell’anticresi è legata, infatti, a quella del
negozio principale da cui è sorto il credito.
Tale nesso di accessorietà, che lega il
rapporto di garanzia a quello garantito, come
si è anticipato, accomuna le diverse figure di
garanzia previste dal codice civile. Le vicende
attinenti al rapporto principale si
riverbereranno, pertanto, sul diritto
anticretico. L’art. 1962 cod. civ. statuisce,
infatti, che l’anticresi dura finché il
37 M. FRAGALI, L’anticresi, cit. p. 1 ss.; V. TEDESCHI, Anticresi, cit., p.
654 ss.; G. PERSICO; Anticresi (Diritto civile), in Enc. dir., II, Milano,
1958, p. 529 ss.; G. ZUDDAS, Anticresi, cit., p. 1 ss.
45
creditore sia stato interamente soddisfatto del
suo credito, anche se l’immobile dato in
anticresi sia divisibile38. Il legislatore
prevede, attraverso la norma citata, solo una
delle cause di estinzione del diritto
anticretico; pari efficacia estintiva avranno
pertanto i fatti e gli atti idonei a produrre
l’estinzione totale del credito cui l’anticresi
accede (a titolo esemplificativo: remissione
del debito, prescrizione, compensazione,
accertamento, etc.)39.
B) Quanto al mandato di credito (art. 1958 –
1959, cod. civ.), esso è quel contratto
mediante il quale una parte assume l’incarico38 È questo il c.d. principio d’indivisibilità, previsto anche in
tema di pegno dall’art. 2799, cod. civ. Si è segnalata però (M.
D’AMELIO, Dell’anticresi, in Comm. cod. civ. D’Amelio e Finzi, Libro delle
obbligazioni, II, Firenze, 1949, p. 446) la prevedibilità di una
liberazione progressiva del bene oggetto del contratto, ovviamente
sul presupposto che lo stesso sia divisibile.39 Amplius, M. FRAGALI, L’anticresi, cit., p. 158 e 164.
46
di fare credito ad un terzo, ossia di stipulare
con costui un contratto di finanziamento (ad
esempio un mutuo, o un’apertura di credito), in
nome e nell’interesse proprio40. Differentemente
dal regime stabilito per il mandato dall’art.
1719 cod. civ., che prevede l’obbligo del
mandante di somministrare al mandatario i mezzi
necessari per l’esecuzione del contratto,
l’art. 1958 cod. civ. statuisce che la persona
che ha dato l’incarico risponde come
fideiussore (del mandatario) per un debito
futuro. Dal contratto de quo la legge fa
pertanto nascere un’obbligazione fideiussoria
in capo al “mandante” dell’operazione di
finanziamento; trattasi di un’ipotesi di
40 E non del mandante, circostanza che vale a distinguere il
negozio de quo dallo schema del mandato (art. 1703 cod. civ.)
47
fideiussione legale, che prescinde dalla
volontà delle parti41.
Lo schema contrattuale in esame determina un
duplice ordine di rapporti tra i medesimi
soggetti dell’operazione negoziale: tra il
mandante ed il mandatario corre sia un rapporto
di mandato42, che di garanzia (il mandante
risponde come fideiussore di un debito futuro).
Conseguentemente, il rapporto mandante-
mandatario sarà regolato dalle norme sul
mandato, fatta salva l’integrazione con quelle
dettate appositamente in relazione alla41 C. M. BIANCA, Diritto civile, V, La responsabilità, cit., p. 505.42 Non pare opportuno in questa sede addentrarsi nella
problematica dell’inquadramento sistematico del negozio de quo
nello schema del mandato, piuttosto che del contratto a favore di
terzo. Pertanto non resta che rinviare l’approfondimento della
tematica a C. M. BIANCA, op. ult. cit., p. 507; SIMONETTO, Mandato di
credito, in Noviss. dig. it., X, p. 149 (di opinione concorde col primo
Autore citato, nell’escludere la riconduzione del negozio allo
schema del mandato); ABADESSA, Obbligo di far credito, in Enc. dir., XXIX,
p. 534 ss.
48
finalità creditizia dell’incarico: a) la norma
che costituisce il mandante come fideiussore
del mandatario (art. 1958 comma 1, cod. civ.);
b) quella che autorizza il mandante a revocare
il mandato in ogni caso (tranne quando il
mandato è stato già eseguito con una
concessione di credito irrevocabile),
risarcendo però il danno al mandatario (art.
1958 comma 2, cod. civ.)43; c) la norma secondo
cui il mandatario è esonerato dall’esecuzione
dell’incarico, qualora le condizioni
patrimoniali del mandante o del terzo siano
divenute tali da rendere molto più difficile il
soddisfacimento del suo credito (art. 1959
comma 1, cod. civ.). Quest’ultima disposizione,
si badi, non estingue necessariamente il
mandato; il mandatario, infatti, può comunque43 Cfr. la diversa regola statuita in relazione al contratto di
mandato dall’art. 1723 comma 2, cod. civ.
49
dargli esecuzione ed in ogni caso, per
l’estinzione del contratto, è necessario un
recesso proprio del mandatario44.
Quanto al rapporto di garanzia (fideiussoria),
questo sarà regolato dalle norme sue proprie. A
rigore, pertanto, non si potrà qualificare il
contratto de quo come un negozio di garanzia a
sé stante; si dovrà ritenere, piuttosto, che
l’obbligo di garanzia45 che la legge impone a
colui che dà l’incarico di finanziamento, sia
strumentale alla concessione del credito ed
assuma di conseguenza un ruolo solo secondario
nell’economia complessiva del negozio. La
collocazione sistematica del contratto in esame
tra quelli a contenuto di garanzia si spiega
44 A. e op. ult. cit., p. 506.45 In dottrina, valorizzando il disposto dell’art. 1958 <<
risponde come fideiussore>>, si parla di fideiussione indiretta
(L. PIAZZA, Garanzia, cit., p. 4.).
50
perché, pur non riducendosi la posizione del
mandante a quella di fideiussore, costui
risponde come tale46.
3. Personalità del vincolo fideiussorio: la funzione di
garanzia della fideiussione si specifica nella “duplicazione”
soggettiva del vincolo obbligatorio.
Occorre ora procedere ad un’analisi puntuale
della fideiussione, tipico negozio di garanzia
personale (art. 1936 ss., cod. civ.), sulla cui
base il garante s’impegna alla realizzazione
dell’interesse creditorio dedotto in una
diversa obbligazione principale.
L’esame particolareggiato di tale figura
negoziale consentirà l’acquisizione degli
46 Cfr. M. FRAGALI, Garanzia, cit., p. 456; l’A. precisa che la
distanza che corre tra la funzione del contratto in esame e la
fideiussione è tangibile, se si pensa all’immediato rilievo
dell’assenza in quest’ultimo di un obbligo del garantito di far
credito ad un soggetto terzo.
51
strumenti cognitivi, utili alla comprensione
delle differenze che corrono, quanto a
struttura, contenuto, funzione e causa
negoziali, tra questa forma di garanzia
personale, il contratto di promessa del fatto
del terzo (cui parte della dottrina riconosce
una funzione di garanzia personale), ed i
contratti di garanzia caratterizzati dalla c.d.
autonomia dell’obbligazione del garante
rispetto all’obbligazione principale.
La fideiussione affonda le proprie radici
nell’ordinamento giuridico romano, in cui la
fideiussio si affianca alle più antiche forme
della sponsio e della fidepromissio, com’assunzione
di un’obbligazione solidale47. 47 Per un approfondimento della tematica concernente le garanzie
personali dell’obbligazione nell’ordinamento giuridico romano, ed
in particolare l’origine storica ed i caratteri della fideiussio, si
rinvia a M. TALAMANCA, Fideiussione, in Enc. dir. (parte storica), XVII,
Milano, 1968, p. 322 – 345.
52
Fin dall’antichità emerge, quale caratteristica
propria del contratto di fideiussione, la
costituzione di un rapporto obbligatorio (che
vede nel garante il soggetto passivo)
funzionalmente connesso a quello principale, il
cui debitore è soggetto terzo rispetto alla
garanzia48.
L’elemento della personalità del vincolo
fideiussorio appare tutt’oggi dalla lettera
dell’art. 1936 cod. civ., secondo cui è
fideiussore colui che obbligandosi personalmente
verso il creditore, garantisce l’adempimento di
un’obbligazione altrui; siffatto dato vale a
distinguere il negozio de quo da quelle forme di
garanzia (nell’antichità assunte da vades e
praedes) in cui il garante risponde sic et simpliciter
per un debito altrui e non perché autonomamente
48 M. TALAMANCA, op. ult. cit., p. 330.
53
investito di un’obbligazione che grava su di
lui (es.: terzo datore d’ipoteca). Il
fideiussore assume un’obbligazione di garanzia
autonoma rispetto a quella principale e
garantisce l’adempimento della medesima con
tutti i suoi beni presenti e futuri; il
creditore pertanto, nell’eventualità che il
primo non adempia l’obbligazione, potrà
esperire l’azione esecutiva, oltre che sul
patrimonio del debitore principale, anche su
quello del fideiussore.
In dottrina49 si è evidenziato che la funzione
di garanzia consistente nel rafforzamento
dell’aspettativa creditoria, propria anche di
altre fattispecie negoziali, si realizza nella
fideiussione mediante un’aggiunta alla
preesistente obbligazione garantita di un altro
49 BARBIERA, Garanzia del credito e autonomia privata, Napoli, 1971, p. 33.
54
rapporto obbligatorio, accessorio al primo; si
verifica, in tal modo, un allargamento del potere di
aggressione del creditore per la soddisfazione del
suo diritto50. Il fine tipico di garantire
l’adempimento si realizza quindi, nel nostro
contratto, attraverso la duplicazione soggettiva del
vincolo obbligatorio51, con il risultato di aumentare
le probabilità di ottenere l’estinzione satisfattoria
dell’obbligazione garantita52, per poter il
creditore pretendere dal fideiussore
l’adempimento dell’obbligazione di garanzia,
avente il medesimo oggetto di quella
principale.
50 RAVAZZONI, La fideiussione, Milano, 1973, p. 109.51 DI SABATO, L’assuntore del concordato fallimentare, Napoli, 1960, p.4652 BARBIERA, op. loc. cit.
55
4. Parti del contratto. La fideiussione rilasciata dal garante
all’insaputa del debitore garantito.
Parti del contratto di fideiussione sono il
fideiussore ed il creditore: il fideiussore,
alla stregua dell’art. 1936 comma 1, cod. civ.,
garantisce, infatti, l’adempimento di
un’obbligazione altrui, ossia di un soggetto terzo
rispetto al contratto di fideiussione; d’altro
canto il debitore garantito potrebbe essere
addirittura all’oscuro della stipula del
negozio fideiussorio, giacché il contratto
anche ora è ugualmente efficace (art. 1936
comma 2, cod. civ.)53.
La norma contenuta nell’articolo da ultimo
citato è espressione di un principio generale,
secondo cui non è necessario che il debitore
53 M. FRAGALI, Fideiussione, (dir. priv.), in Enc. dir., XVII, Milano, 1968,
p. 348.
56
presti il suo consenso alla conclusione del
negozio tra terzo e creditore, che ha l’effetto
di rafforzare l’aspettativa creditoria di
quest’ultimo nei confronti dell’obbligato
principale. Una disposizione analoga opera, ad
esempio, in materia di espromissione (art. 1372
cod. civ.), fattispecie in cui la promessa di
adempimento di un terzo (espromittente)
rafforza la posizione del creditore,
determinando la nascita di un’obbligazione
solidale passiva a carico del debitore
principale e dell’assuntore del debito altrui,
qualora l’espromissione sia cumulativa, ossia
il creditore non dichiari espressamente di
liberare l’obbligato principale.
L’effetto favorevole a favore del creditore è
agevolato in quanto il legislatore non richiede
57
per il suo operare il necessario coinvolgimento
del terzo. Anzi in dottrina54 è diffusa
l’opinione secondo cui il negozio “di garanzia”
può essere stipulato non solo qualora il
debitore garantito ne sia ignaro, ma anche se
si opponga alla sua conclusione.
È pur vero infatti che alcune norme
dell’ordinamento (ad esempio quella contenuta
nell’art. 1180 cod. civ.) proteggono
l’interesse del debitore ad adempiere
personalmente, ma suddetta tutela non si spinge
fino al punto d’impedire radicalmente
l’adempimento del terzo55. L’articolo citato, ad
esempio, prevede che se ricorre l’opposizione
del debitore al pagamento del terzo, il
54 In argomento, in tal senso A. RAVAZZONI, La fideiussione, Milano,
1957, p. 145.55 Cfr. R. NICOLO’, L’adempimento dell’obbligo altrui, in Scritti, II,
Milano, 1980, p. 973 ss.
58
creditore sia autorizzato, ma non obbligato, a
rifiutarlo. L’ordinamento valuta pertanto come
preminente e meritevole di protezione
l’interesse creditorio all’ottenimento di
quanto gli è dovuto, piuttosto che quello del
debitore all’estromissione del terzo dai suoi
affari.
5. Segue: la fideiussione rilasciata su incarico del debitore
garantito.
Normalmente l’assunzione dell’obbligazione
fideiussoria avviene in virtù di un accordo tra
garante e debitore principale, per essere
costui <<il primo interessato>>56 alla
conclusione del negozio fideiussorio tra il
garante ed il creditore, che avrà l’effetto di
rafforzare la posizione di quest’ultimo, ma nel
contempo consentirà al debitore di ottenere un
56 Così C. M. BIANCA, op. ult. cit., p. 473.
59
vantaggio, consistente, ad esempio, nella
concessione di un credito57. In tal caso la
stipula del nostro contratto (di cui ricordiamo
sono parti il fideiussore ed il creditore) sarà
condizione di un beneficio concesso al debitore
principale. Si pensi ad un mutuo, il cui
rilascio sia sospensivamente condizionato al
“rilascio” di una garanzia fideiussoria.
È poi immaginabile che il contraente si sia
impegnato verso il creditore a rilasciargli una
fideiussione e assuma, pertanto, l’obbligo di
presentare a quest’ultimo, in qualità di
fideiussore, una persona capace, che possieda
beni sufficienti a garantirne l’obbligazione e
che abbia o elegga domicilio nella
giurisdizione della Corte d’appello in cui la
fideiussione si deve prestare (art. 1943 cod.
57 L’esempio è prospettato da C. M. BIANCA, op. loc. ult. cit.
60
civ.). Volendo riproporre l’esempio poc’anzi
fornito, si può immaginare un contratto di
mutuo in cui si pattuisca che il mutuatario
procurerà al creditore un’idonea garanzia.
Ancora, è possibile che l’interessamento del
debitore alla stipula di una fideiussione nasca
dalla prospettiva di ottenerne vantaggi,
perché, ad esempio, il creditore si è impegnato
a concedere tassi d’interesse più bassi o altre
agevolazioni, se il debitore gli procuri una
garanzia fideiussoria.
In tutti questi casi, il fideiussore si obbliga
verso il creditore in conseguenza dell’incarico
ricevuto dal debitore principale, che, per
essere conferito nell’interesse di un terzo (il
creditore) oltre che del mandante, integrerà un
mandato irrevocabile, ai sensi dell’art. 1723
61
comma 2, cod. civ. Si è giustamente osservato58
che la presenza nella fattispecie
dell’interesse del terzo - il creditore
garantito - con conseguente irrevocabilità del
mandato conferito dal debitore al fideiussore,
<<emerge significativamente ogniqualvolta nel
rapporto principale si preveda il rilascio
della garanzia>>59. La qualificazione del
mandato come irrevocabile discende dal
vantaggio arrecato al creditore attraverso la
fideiussione, che rafforza l’aspettativa
satisfattoria di costui; il debitore
principale, vista la rilevanza dell’interesse
creditorio, non potrebbe revocare il mandato,
restando il soggetto che accetta l’incarico
obbligato a stipulare il contratto di garanzia,
58 L. RUGGERI, La fideiussione, in Trattato di diritto civile del consiglio nazionale
del notariato, diretto da P. PERLINGIERI, Napoli, 2005, p. 9.59 A. e op. loc. ult. cit.
62
a prescindere dalle mutate intenzioni del
mandante (il debitore principale)60.
Nei casi da ultimo prospettati distingueremo,
allora, da un lato, il negozio fideiussorio,
intervenuto tra fideiussore e creditore,
dall’altro, il contratto concluso tra
fideiussore e debitore principale, in base al
quale il primo si obbliga a prestare la
garanzia al creditore61.
La presenza di un incarico conferito dal
debitore al fideiussore ha indotto parte della
60 Si impone una precisazione. Si è detto che attraverso la
fideiussione il garante assume un’obbligazione personale. Il
mandato rileva come causa dell’impegno assunto attraverso il
negozio fideiussorio. Una volta che sia stata stipulata la
fideiussione, il titolo della responsabilità del garante sarà da
rinvenire proprio in tale contratto di garanzia. Pertanto il
problema della revocabilità del mandato dovrebbe porsi, a ben
vedere, solo in una fase intermedia tra il cofermento
dell’incarico e la stipula del negozio fideiussorio.61 C. M. BIANCA, op. cit., p. 474.
63
dottrina62 a ravvisare per tale caso un negozio
plurilaterale di fideiussione.
Secondo altra prospettazione63, invece, la
compresenza del rapporto di mandato e di
fideiussione determinerebbe un’ipotesi di
rapporti tra loro collegati; in quest’ottica,
l’incarico s’inserisce in un’operazione
economica complessa, la cui realizzazione
postula una pluralità di negozi tra loro
connessi64. Più dettagliatamente, tra rapporto
principale, incarico e fideiussione
62 In tal senso A. RAVAZZONI, op. ult. cit., p. 148, che richiama F.
MESSINEO, Il negozio giuridico plurilaterale, in Studi di diritto delle società,
Milano, 1949, p. 15 ss., individuando l’esistenza di negozi
giuridici plurilaterali, ogniqualvolta si possa ravvisare
l’esistenza di dichiarazioni di volontà autonome e operanti in
direzioni e per interessi diversi.63 C.M. BIANCA, op. loc. cit.; M. LOBUONO, Contratto e attività economica nelle
garanzie personali, Napoli, 2002, p. 33; 64 P. PERLINGIERI, Nuovi profili del contratto, in Rass. dir. civ., 2000, p.
554: l’A. rileva che spesso il raggiungimento di una determinato
fine economico implica il superamento dell’adozione di un’unica
struttura.
64
sussisterebbe, in primo luogo, un collegamento
genetico: il mandato è conferito a seguito di un
accordo con il creditore principale, oppure al
fine di ottenere, in virtù della maggiore
sicurezza del credito realizzata attraverso la
garanzia, una modulazione del programma
contrattuale più favorevole (ad esempio: minore
tasso d’interesse, termine maggiore, etc.); la
conclusione del negozio fideiussorio è a sua
volta la conseguenza dell’impegno assunto dal
garante accettando l’incarico65. Inoltre, sotto
il profilo del rapporto che corre tra
l’obbligazione fideiussoria e quella
65 Occorre precisare che il negozio intervenuto tra fideiussore e
debitore principale, in base al quale il primo si obbliga a
prestare la garanzia, non deve essere necessariamente un mandato.
È possibile ad esempio che il garante (banca) abbia concluso con
il proprio cliente un contratto di apertura di credito di firma,
in base al quale il primo s’impegna ad un facere, consistente
nell’assumere o nel garantire un’obbligazione del secondo. Per
l’analisi dell’istituto si rinvia al par. 11, lettera B, del
capitolo terzo del presente studio.
65
principale, si evidenzia un collegamento
funzionale66, per essere la prima preordinata allo
stesso risultato di quella principale.
Infine, ai sensi di un’ulteriore tesi
proposta67, la relazione sussistente tra il
rapporto debitore – fideiussore e quello
garante – creditore potrebbe spiegarsi
richiamando lo schema del contratto a favore di
terzo (art. 1411 ss. cod. civ.). Si afferma68,
per tal verso, che il debitore è parte del
negozio fideiussorio, quando la garanzia è
oggetto di un contratto da lui concluso con il
fideiussore a favore del creditore. Per tal
eventualità la fideiussione troverebbe fonte in
un contratto a favore di terzo (in cui
66 Cfr. Cass., 31 agosto 1984, n. 4738, in Banca borsa tit. cred., 1985,
II, p. 11.67 M. FRAGALI, Fideiussione, cit., p. 348.68 A. e op. loc. ult. cit.
66
promittente sarebbe il fideiussore,
beneficiario il creditore, stipulante il
debitore) diventando irrevocabile nel momento
in cui il terzo dichiari di volerne profittare,
secondo quanto statuisce l’art. 1411, comma 2,
cod. civ.
Contro tale impostazione si è obiettata
l’incompatibilità di essa con il disposto
dell’art. 1936 comma 1, cod. civ., che, nel
definire il fideiussore come colui che obbligandosi
personalmente verso il creditore garantisce
l’adempimento di un’obbligazione altrui,
farebbe riferimento al negozio che corre tra il
garante ed il beneficiario della garanzia69.
Inoltre indici normativi contenuti negli
articoli che il legislatore dedica alla
69 L. RUGGERI, op. cit., p. 11.
67
disciplina dell’istituto70 prospetterebbero una
partecipazione del creditore alla
determinazione del contenuto del rapporto
fideiussorio71.
La questione più preoccupante che concerne la
possibilità di configurare un contratto
fideiussorio a favore del terzo sembra, a mio
sommesso parere, essere la seguente. L’art.
1413 cod. civ., relativo al regime delle
eccezioni opponibili dal promittente, statuisce
che costui può opporre al terzo <<le eccezioni
fondate sul contratto dal quale il terzo deriva
il suo diritto>>, ossia le c.d. eccezioni
causali, afferenti il contratto a favore di
terzo stipulato dallo stipulante e dal
promittente. Applicando lo schema del contratto
70 Si veda ad esempio il comma 2 dell’art. 1944. 71 A. e op. loc. ult. cit.
68
a favore di terzo alla fideiussione, il
creditore beneficiario resterebbe così esposto
al rischio che l’escussione della garanzia sia
paralizzata dalle summenzionate eccezioni, per
essere, ad esempio, invalido il contratto tra
stipulante e promittente (alias debitore e
fideiussore), oppure, ipotesi limite, per non
aver il debitore adempiuto, nei confronti del
fideiussore, l’obbligo di pagare il prezzo del
rilascio della fideiussione.
In buona sostanza, ammettendo la configurazione
di un contratto fideiussorio che nasca secondo
lo schema del contratto a favore di terzo, il
regime delle eccezioni opponibili dal
fideiussore imporrebbe al creditore un onere di
accertamento relativo alla validità ed
efficacia del negozio da cui deriva il suo
69
diritto (il contratto a suo favore), che
riterrei non essere ammissibile alla luce della
funzione essenziale che il contratto di
fideiussione è preordinato a realizzare: il
rafforzare l’esigenza di sicurezza del credito.
6. Le affinità strutturali e funzionali tra la fideiussione e
l’assunzione cumulativa del debito altrui impongono la
ricerca di sicuri criteri distintivi degl’istituti, poiché la
relativa disciplina, soprattutto riguardo al regime delle
eccezioni opponibili, è decisamente differente.
Si è visto che ai sensi dell’art. 1936 cod.
civ. la fideiussione dà vita ad un obbligo
personale di garanzia in capo al fideiussore.
Si aggiunga, ora, che il nostro contratto dà
luogo ad un vincolo di solidarietà passiva tra
garante e debitore, espressamente previsto
dall’art. 1944 comma 1, cod. civ.
70
La nascita di un obbligo personale, che grava
su un soggetto terzo rispetto al rapporto
principale e il regime di solidarietà passiva
dei vincoli non sono tratti esclusivi del
contratto di garanzia in esame. Anche i negozi
di assunzione del debito altrui (art. 1268 ss.
cod. civ.) determinano un’obbligazione
personale a carico del terzo e, salvo diversa
specificazione negoziale72, comportano che il
debitore originario e l’assuntore siano
obbligati in solido per l’adempimento
dell’obbligazione, precisando l’art. 1268 cod.
civ., con riguardo al negozio di delegazione
cumulativa, che il creditore che ha accettato
72 La disciplina dettata per la delegazione, l’espromissione e
l’accollo (art. 1268, 1272 e 1273 cod. civ.) statuisce che la
liberazione del debitore originario si verifica se il creditore
dichiari espressamente di liberarlo; quanto all’accollo l’art.
1273, comma 2, cod. civ. prevede che il debitore sia liberato,
oltre che nell’ipotesi summenzionata, anche se ciò costituisce
condizione espressa della stipulazione.
71
l’obbligazione del terzo non può rivolgersi al
delegante, se prima non ha richiesto al
delegato l’adempimento.
Giacché il legislatore ha soppresso il
beneficio di escussione a favore del
fideiussore com’effetto naturale del negozio73,
il terzo viene a trovarsi pertanto in una
situazione analoga a quella del fideiussore,
per essere nelle diverse ipotesi di assunzione
del debito obbligato in solido con il debitore
principale, <<sia pure con modalità diverse>>74.
73 Previsto invece dall’art. 1907 cod. civ. del 1865, secondo cui
il regime di solidarietà delle obbligazioni fideiussoria e
principale dovesse essere espressamente pattuito, essendo effetto
naturale del contratto il beneficium excussionis.74 La precisazione è di E. BRIGANTI, Fideiussione e promessa del fatto del
terzo, cit., p. 24, che al riguardo puntualizza che <<anche se
nella delegazione cumulativa (art. 1268, comma 2, cod. civ.) è
previsto l’onere del creditore di chiedere preventivamente
l’adempimento ad uno degli obbligati (delegato) si tratta di un
tipo di sussidiarietà che non contrasta con i principi generali
della solidarietà e può inquadrarsi nell’ambito delle diverse
modalità del vincolo solidale espressamente previste da una norma
72
Ma v’è di più. Le analogie tra fideiussione e
negozi di assunzione del debito non si limitano
al regime di solidarietà tra l’obbligazione
originaria e quella che si costituisce in capo
al garante o all’assuntore, ma riguardano sia
le dinamiche negoziali che danno vita al
“nuovo” rapporto obbligatorio, che l’assetto
d’interessi che le operazioni (di assunzione o
di garanzia) sono idonee a realizzare.
Quanto a quest’ultimo punto si è giustamente
osservato75, con riguardo specifico all’accollo,
che l’esame degl’interessi che inducono a
siffatto negozio rivela che l’effetto di
rafforzare l’aspettativa di soddisfazione del
credito può realizzarsi, oltre che attraverso
di legge (l’art. 1293 cod. civ.)>>. L’articolo citato dispone
infatti che la solidarietà non sia esclusa dal fatto che i singoli
debitori siano tenuti ciascuno con modalità diverse.75 E. BRIGANTI, op. cit., p. 22.
73
la fideiussione, anche mediante la semplice
assunzione (cumulativa) del debito. Anche la
stipulazione dei negozi di assunzione, infatti,
può produrre un effetto di garanzia,
consistente nella duplicazione soggettiva del
vincolo obbligatorio76, che, rafforzando il
potere di aggressione del creditore, aumenta le
probabilità di ottenere l’estinzione
satisfattiva dell’obbligazione.
Quanto alla dinamica negoziale che conduce alla
stipulazione di una fideiussione, si è visto77
che essa di regola presuppone un incarico del
debitore, ma nel contempo la disciplina
codicistica (art. 1936, comma 2) consente che
il contratto possa essere stipulato senza detto
76 Così DI SABATO, op. loc. cit.77 Vedi retro, par. 5.
74
incarico e addirittura senza che il debitore ne
abbia conoscenza.
La struttura della fideiussione richiama così
quella dei negozi di assunzione del debito e
precisamente lo schema della delegazione, se il
debitore dà mandato al fideiussore di assumere
il debito, e la figura dell’espromissione,
qualora il debito sia assunto dal fideiussore
senz’alcun incarico del debitore.
Laddove poi si aderisca a quell’opinione
dottrinale78 che prospetta la configurabilità di
un negozio fideiussorio a favore di terzo (il
creditore), quest’accordo è strutturalmente
affine allo schema dell’accollo (art. 1273
comma 1, cod. civ.).
78 M. FRAGALI, Fideiussione, cit., p. 348.
75
Fungono da contraltare alle analogie
summenzionate tra la fideiussione e
l’assunzione cumulativa del debito altrui le
rilevanti differenze di disciplina previste dal
legislatore, specialmente sotto il profilo del
regime delle eccezioni, da cui l’esigenza
dell’individuazione di criteri distintivi tra
le figure.
Intatti, mentre l’art. 1945 cod. civ. prevede
che il fideiussore possa opporre al creditore
tutte le eccezioni che spettano al debitore
principale, salvo quella dell’incapacità, per
il caso della delegazione astratta dal rapporto
di valuta il delegato non può opporre al
delegatario le eccezioni relative al rapporto
di quest’ultimo con il delegante (art. 1271,
comma 3, cod. civ.); l’espromittente, invece,
76
non può contrastare l’azione di adempimento del
creditore attraverso le eccezioni personali al
debitore principale, quelle che derivano da
fatti successivi all’espromissione, né infine
eccependo la compensazione <<che avrebbe potuto
opporre il debitorio originario, quantunque si
sia verificata prima dell’espromissione>> (art.
1272, comma 2, cod. civ.).
L’accollante invece può <<opporre al creditore
le eccezioni fondate sul contratto in base al
quale l’assunzione è avvenuta>> (art. 1273,
comma 4, cod. civ.), divergendo tale regime,
sia per eccesso, che per difetto, rispetto a
quello previsto per la fideiussione.
77
7. Segue: Sia la fideiussione che l’assunzione cumulativa del
debito hanno per effetto un rafforzamento della posizione
del creditore, ma lo scopo tipico di garantire il credito
ricorre nel solo negozio fideiussorio. L’eterogeneità
funzionale dei due schemi comporta una diversa incidenza
del peso del debito.
Una prima diversità concettuale tra la
fideiussione e l’assunzione cumulativa del
debito si fonda sul diverso elemento casuale
che regge i due schemi negoziali, in quanto,
pur essendo entrambi idonei a rinsaldare
l’aspettativa creditoria d’ottenere
l’estinzione satisfattoria del diritto, solo la
fideiussione è tipicamente preordinata a tale
scopo79, per essere un negozio causale di
garanzia80. Il rilievo attribuito alla funzione
79 Cfr. DI SABATO, Fideiussione e negozi di assunzione del debito altrui: criteri
d’interpretazione, in Riv. dir. civ., 1961, II, p. 490 ss.80 Così C. M. BIANCA, op. cit., p. 474.
78
di garanzia del negozio intercorso tra terzo e
creditore sarà pertanto indice favorevole alla
sua qualificazione come fideiussione81.
Quanto agl’interessi tipicamente sottesi alla
fideiussione e all’assunzione cumulativa, si è
evidenziato che un indice di qualificazione del
negozio va rinvenuto nella presenza, o meno, di
un interesse proprio del terzo all’intervento
nel rapporto obbligatorio82: si avrà la
conclusione di un contratto di fideiussione o
un’assunzione cumulativa di debito secondo che,
81 Così E. BRIGANTI, op. cit., p. 31, il quale richiama l’opinione
precedentemente espressa in tal senso da RODOTA’, Espromissione, in
Enc. dir., XV, Milano, 1966, p. 788, in riferimento
all’espromissione cumulativa.82 DI SABATO, L’assuntore del concordato fallimentare, cit., p. 51, nota, 72;
l’A. osserva che <<in concreto si può essere indotti
all’assunzione pur senza avere un interesse proprio, o invece alla
fideiussione avendo un personale interesse, ma ciò non esclude che
in astratto ciascuno dei due schemi possa essere tipicamente
preordinato per l’ipotesi che, rispettivamente, vi sia un
interesse proprio del terzo>>.
79
rispettivamente, il terzo si obblighi per
realizzare un interesse del debitore originario
(ad esempio per permettergli di ottenere la
concessione di un credito), oppure un interesse
proprio (come avviene ad esempio nel caso
dell’assuntore del concordato fallimentare).
Sulla falsariga di tal impostazione si è
giustamente osservato83 che <<se fideiussione e
assunzione del debito possono essere utilizzate
per realizzare la stessa funzione pratica,
bisogna innanzitutto distinguere secondo che lo
scopo di garanzia risulti o meno dal contratto
tra terzo e creditore>>. In caso positivo il
contratto dovrebbe qualificarsi come
fideiussione.
Al diverso interesse che anima l’iniziativa del
fideiussore e dell’assuntore del debito83 E. BRIGANTI, op. cit., p. 32.
80
corrisponde, sul piano della disciplina, la
previsione dell’azione di regresso (art. 1950 cod.
civ.) a favore del solo fideiussore, una volta
che costui abbia pagato. Il meccanismo previsto
dall’art. 1950 cod. civ., a tutela della
posizione patrimoniale del fideiussore, non è
contemplato dalla disciplina dell’assunzione
“pura”, dove al terzo può anche spettare
un’azione di rivalsa verso il debitore
principale, ma siffatta azione ha fondamento
sui rapporti interni tra assuntore e debitore,
piuttosto che sul meccanismo negoziale
dell’assunzione, e, conseguentemente, non è
caratterizzante ai fini della qualificazione
del negozio, configurandosi come azione
generale di arricchimento o come ripetizione
d’indebito84. In quest’ottica, un elemento84 Sull’argomento, in questi termini E. BRIGANTI, Fideiussione e
promessa del fatto del terzo, cit., p. 34. L’autore richiama il pensiero
81
distintivo della fideiussione rispetto
all’assunzione emergerebbe dal riferimento, nel
rapporto esterno assuntore – creditore, alla
previsione dell’azione di regresso a favore del
fideiussore85.
La funzione di garanzia del negozio
fideiussorio comporta, pertanto, che non si
realizzi uno spostamento patrimoniale del peso
del debito originario, perché, pur essendo il
fideiussore tenuto ad adempiere l’obbligo di
garanzia, l’azione di regresso gli consentirà
di recuperare quanto prestato86.
Nell’assunzione, invece, secondo lo schema
legale tipico, il sacrificio patrimonialedi DI SABATO, L’assuntore del concordato fallimentare, cit., p. 45 ss., 55 e
57, nota 80. All’ultimo A. citato si deve la distinzione tra
fideiussione e assunzione del debito fondata essenzialmente sulla
disciplina del regresso, nonché il diverso fondamento della
rivalsa dell’assuntore rispetto al regresso fideiussorio.85 In questi termini E. BRIGANTI, op. ult. cit., p. 33.86 Cfr. E. BRIGANTI, op. cit., p. 34.
82
dell’assuntore resterà definitivamente ancorato
al suo patrimonio, realizzandosi un mutamento
del soggetto che dovrà sostenere il peso finale
del debito87.
In conclusione, l’autonomia concettuale e
funzionale delle ipotesi di assunzione del
debito rispetto alla fideiussione trova
conferma nella diversa efficienza operativa dei
due schemi negoziali, realizzando le prime la
sostituzione o l’aggiunta di un nuovo debitore
87 Cfr. R. CICALA, Saggi sull’obbligazione e le sue vicende, Napoli, 2001, p.
134 ss. L’autorevole A. ha evidenziato però che vi sono ipotesi in
cui all’assunzione del peso del debito nei confronti del creditore
non fa riscontro un’assunzione anche nel rapporto interno. Il
sincronismo tra assunzione esterna ed interna, se è tipico
dell’accollo cumulativo, non trova riscontro nella delegazione e
nell’espromissione. Resta però il rilievo concettuale che assume
la previsione dell’azione di regresso a favore del solo
fideiussore (art. 1950 cod. civ.), da cui si potrebbe desumere
che, in ogni caso, la rivalsa eventuale dell’assuntore è elemento
non caratterizzante i negozi di assunzione, ma che rinvia alla
disciplina del rapporto interno assuntore - debitore originario.
83
all’originario, la seconda il semplice
rafforzamento del vincolo obbligatorio88.
8. Carattere solidale dell’obbligazione fideiussoria
com’effetto naturale della fideiussione.
In base all’art. 1944 cod. civ. <<Il
fideiussore è obbligato in solido col debitore
principale al pagamento del debito. Le parti
possono però convenire che il fideiussore non
sia tenuto a pagare prima dell’escussione del
debitore principale>>. A differenza di quanto
previsto nel codice civile abrogato89, sotto
88 In questi termini G. F. CAMPOBASSO, Coobbligazione cambiaria e
solidarietà diseguale, Napoli, 1974, p. 273.89 Il codice civile del 1865 prevedeva che il fideiussore non era
obbligato in solido con il debitore principale, occorrendo a tal
fine che la solidarietà fosse stata espressamente prevista nel
negozio fideiussorio (art. 1907). Il codice del commercio
prevedeva, all’inverso, una presunzione di solidarietà di pari
grado a carico del fideiussore, al quale, conseguentemente, non
spettava il beneficium excussionis, salvo diversa pattuizione. Il
Codice Civile del 1942, unificando il diritto civile e quello
commerciale, uniformò la disciplina dei rapporti, nella direzione
tuttora vigente (art. 1944 cod. civ.).
84
quello vigente la fideiussione dà luogo ad un
vincolo di solidarietà passiva tra garante e
debitore, perché il beneficio d’escussione
preventiva del debitore principale è
pattuizione solo eventuale. Ne consegue che il
creditore potrà rivolgersi direttamente al
fideiussore, salvo che sia stato convenuto
l’onere del creditore di escutere
preventivamente il debitore principale90, onere90 In questo senso RAVAZZONI, La fideiussione, cit., p. 181 ss.;
SALVESTRONI, La solidarietà fideiussoria , Padova, 1977, p. 106 ss; E.
BRIGANTI, op. cit., p. 19, nota 21; TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile,
XXXVIII ed., Padova, 1998, p. 619.
Secondo diversa opinione dottrinale a vantaggio del fideiussore
sarebbe previsto un beneficium ordinis, nel senso che, anche quanto
non sia previsto l’onere di preventiva escussione, il creditore
dovrebbe comunque chiedere l’adempimento al debitore principale,
prima di rivolgersi al fideiussore (M. FRAGALI, Fideiussione – mandato
di credito, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja e Branca, Libro quarto,
Delle obbligazioni, art. 1936 – 1959, Bologna – Roma, 1968, p. 74
ss.). La tesi si scontra, tuttavia, con il dato letterale
dell’art. 1944 cod. civ., che impone di ritenere sussistente il
regime di solidarietà passiva. Si è inoltre giustamente osservato
(E. BRIGANTI, op. loc. ult. cit.) che la scelta inequivocabile del
legislatore a favore del regime di solidarietà trova conferma
nella Relazione al codice civile, n. 765, in cui si legge <<il creditore
85
che esalta, nella dinamica del negozio, la
funzione sussidiaria dell’obbligazione del
garante.
Il fideiussore è quindi soggetto tenuto alla
medesima prestazione cui è tenuto il debitore
principale, stabilendo del resto il legislatore
(art. 1941 cod. civ.), che la fideiussione non
può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né
può essere prestata a condizioni più onerose,
confermando così che il contenuto
dell’obbligazione fideiussoria è desumibile da
quella principale91.
In dottrina si è però definita la solidarietà
fideiussoria come anomala, o imperfetta92,
prospettando una forma speciale di solidarietà,
può sempre rivolgersi al fideiussore piuttosto che al debitore, se
non esista un dovere contrattuale d’escussione del debitore>>.91 In tal senso E. BRIGANTI, op. cit., p. 19 ss.92 Così M. FRAGALI, Fideiussione, cit., p. 360.
86
c.d. fideiussoria, il cui tratto saliente
sarebbe rappresentato dall’assenza della
comunione d’interessi: il vincolo solidale
nascerebbe nell’interesse esclusivo del
debitore garantito, giustificando
l’applicazione di una disciplina diversa
rispetto a quella operante per la solidarietà
(art. 1292 ss.).
Si è precisato, in tal senso, che
nell’obbligazione solidale la mancanza di una
comunione d’interessi è solo eventuale e,
comunque, in tal ipotesi, pur se è stata
assunta l’obbligazione per realizzare un affare
d’interesse esclusivo di uno dei coobbligati,
essa non appare all’esterno, laddove è palese
che l’adempimento del fideiussore viene a
gravare in definitiva sul debitore principale,
87
data l’eterogeneità d’interessi che la
solidarietà realizza. Il debitore principale
s’impegna infatti per il vantaggio proprio; il
fideiussore per quello altrui, <<anche se ha
interesse a procurare quel vantaggio, e sia
pure, quando la fideiussione è remunerata, con
il contemporaneo vantaggio proprio>>93.
Più precisamente, secondo la citata tesi,
l’obbligazione fideiussoria si caratterizza per
la sua natura accessoria, ossia per la sua
dipendenza dall’obbligazione garantita, mentre
l’obbligazione solidale passiva è
essenzialmente principale e oggetto di un
vincolo a sé stante; da ciò deriverebbe <<la
direzione unilaterale della solidarietà
fideiussoria>>94, poiché, mentre il regime
93 A. e op. loc. ult. cit.94 A. e op. loc. ult. cit.,
88
solidale denota, in genere, un modo di essere
comune a più obbligazioni, nel caso della
fideiussione, solidale è l’obbligazione del
fideiussore, non quella del debitore.
Una riprova della distanza che corre tra il
regime della coobbligazione solidale e quello
della solidarietà fideiussoria si è rinvenuta
nelle seguenti peculiarità della disciplina
dettata per la fideiussione95: a) sulla base
dell’art. 1297 cod. civ. ciascun debitore in
solido non può opporre al creditore le
eccezioni personali agli altri condebitori,
mentre il fideiussore può eccepire al creditore
tutti quei fatti estintivi o modificativi del
suo diritto o impeditivi della sua
azionabilità, che lo stesso debitore principale
potrebbe opporgli per paralizzare la domanda di
95 M. FRAGALI, op. ult. cit., p. 361.
89
adempimento, salvo l’incapacità (art. 1945 cod.
civ.); b) il debitore in solido, che ha pagato
l’intero debito, può ripetere dai condebitori
soltanto la parte di ciascuno di essi (at. 1299
cod. civ.), salvo che l’obbligazione sia stata
contratta nell’interesse esclusivo di alcuno di
essi (art. 1298 cod. civ.), mentre il regresso
del fideiussore che ha pagato è sempre per
l’intero (art. 1950 cod. civ.); c) il
condebitore convenuto in giudizio dal creditore
non può agire in rilievo contro gli altri
coobbligati, affinché costoro gli procurino la
liberazione o, in mancanza, prestino le
garanzie necessarie per assicurargli il
soddisfacimento delle eventuali ragioni di
regresso, azione questa consentita invece al
fideiussore contro il debitore principale (art.
1953 cod. civ.); d) il fideiussore è liberato
90
se per fatto del creditore non potrà aver luogo
la surrogazione (art. 1955 cod. civ.), mentre
il condebitore in solido, alla stregua
dell’articolo 1299 cod. civ., rimane obbligato
nonostante l’insolvenza degli altri obbligati,
pur quando il creditore ne avrebbe potuto
evitare gli effetti.
Alla luce delle differenze suelencate la
solidarietà fideiussoria, pur appartenendo al
ceppo della coobbligazione solidale, costituirebbe un
sottotipo della solidarietà obbligatoria, con
la conseguenza che <<le disposizioni sulla
coobbligazione solidale governano la
solidarietà fideiussoria nei limiti consentiti
dalle caratteristiche che sono proprie di
questa, soprattutto avendo presente l’indole
91
sussidiaria e dipendente che ha l’obbligazione
fideiussoria>>96
Corretto il rilievo circa le peculiarità
disciplinari della fideiussione rispetto al
regime stabilito in via generale per le
obbligazioni solidali, si è però osservato che
esse non contraddicono la fondamentale nozione
di solidarietà passiva, che descrive il vincolo
obbligatorio di più debitori, tutti tenuti per
una medesima prestazione, tale che ciascuno può
essere costretto all’adempimento dell’intero e
l’adempimento dell’uno libera anche gli altri97.
96 A. e op. loc. ult. cit.; in senso analogo G. F. CAMPOBASSO,
Coobbligazione cambiaria e solidarietà diseguale, cit., p. 354, secondo cui
le norme sulla fideiussione sarebbero fondate su di una ratio di
favore del fideiussore, mentre il semplice condebitore in solido
sarebbe un obbligato in via autonoma.97 La precisazione è di C. M. BIANCA, op. cit., p. 468.
92
Come precisato da un attento Autore98, la
solidarietà è istituto idoneo a ricomprendere
al suo interno una pluralità di fattispecie
eterogenee; di tale potenzialità v’è traccia
anche nella disciplina che il codice civile
dedica alle obbligazioni in solido: dall’art.
1298 cod. civ. si desume, infatti, che
l’obbligazione solidale può essere stata
contratta per un interesse comune ai
condebitori, oppure nell’interesse esclusivo di
uno di essi. Il codice detta una nozione
unitaria della solidarietà, il cui fulcro è la
complessità soggettiva dell’obbligazione
(<<l’obbligazione è in solido quando più debitori
sono obbligati tutti per la medesima prestazione>> )99, ma
ricomprende nell’istituto obbligazioni tra loro
98 F. D. BUSNELLI, L’obbligazione soggettivamente complessa: profili sistematici,
Milano, 1974, p. 53 ss.99 Incipit dell’art. 1292 cod. civ.
93
distinte, seppur funzionalmente o
economicamente connesse100.
Secondo tale diversa prospettazione la
solidarietà fideiussoria non integra una
diversa forma di solidarietà, poiché condivide
con il “meccanismo” previsto dal legislatore
negli art.1292 ss. la natura di “strumento di
rafforzamento del credito”101, impiegabile tanto
in relazione ad obbligazioni assunte
nell’interesse di uno dei condebitori, quanto
per quelle sorte sulla base di una comunione
d’interessi. Quest’ultimo profilo si riverbera
unicamente sulla disciplina del regresso,
perché il legislatore ha previsto che, laddove
100 G. BISCONTINI, Solidarietà fideiussoria e “decadenza”, Napoli, 1980, p.
39, secondo cui la fideiussione senza beneficio d’escussione
produce un’obbligazione autonoma, ma funzionalmente collegata a
quella principale, per la soddisfazione del medesimo interesse
creditorio.101 Così L. RUGGERI, op. cit., p. 127.
94
l’obbligazione sia stata contratta
nell’interesse esclusivo di uno dei
condebitori, il peso definitivo del debito
ricada per l’intero su quest’ultimo soggetto
(arg. ex art. 1950 e 1298 - 1299 cod. civ.).
Per nulla diverge, pertanto, rispetto alle
regole generali, la disciplina dettata dal
legislatore in relazione al diritto di regresso
del fideiussore.
In conclusione, la solidarietà fideiussoria si
caratterizza in relazione alla causa di garanzia
che costituisce il fondamento del contratto da
cui nasce l’obbligazione del fideiussore,
laddove le varie obbligazioni in solido possono
reggersi sulle più svariate cause negoziali,
afferenti i contratti da cui nascono. D’altro
canto, in tanto è possibile affermare
95
l’esistenza di un’obbligazione in solido (tra
garante e debitore) in quanto il legislatore ha
esplicitamente previsto tale regime. Va infatti
ricordato che, secondo un’attenta opinione
dottrinale102, per operare la presunzione di
solidarietà, stabilita dall’art. 1294 cod.
civ., è necessario che l’obbligazione nasca da
un medesimo titolo. Si comprende allora che,
nascendo l’obbligazione del debitore principale
e quella del fideiussore da titoli diversi,
soltanto l’intervento legislativo ha potuto
rendere solidale l’obbligazione del garante103.
102 P. PERLINGIERI, Profili istituzionali del diritto civile, Napoli, 1979, p.
234; G. BISCONTINI, op. cit., p. 69 ss.103 In argomento L. RUGGERI, op. cit., p. 128.
96
9. La causa di garanzia del negozio e la conseguente
accessorietà genetica e funzionale dell’obbligazione
fideiussoria.
Per opinione concorde104 si usa indicare la
giustificazione casuale della fideiussione
nella garanzia dell’adempimento
dell’obbligazione altrui. La causa del negozio
in esame denota la sua funzione di rafforzare
la tutela dell’interesse del creditore
all’attuazione di un suo credito verso un
terzo, attraverso il mezzo tecnico
dell’obbligazione personale del fideiussore,
che si aggiunge a quella dell’obbligato
principale105.
104 Tra gli altri M. FRAGALI, op. cit., p. 354; C. M. BIANCA, op.
cit., p. 476; C. F. MASSIDDA, Fideiussione, in Enc. giur. Treccani, XIV,
Roma, 1988, p. 4.105 Così M. FRAGALI, op. cit. p. 355.
97
L’obbligazione del fideiussore si fonda
pertanto sullo scopo di garantire il debito
altrui (art. 1936 cod. civ.) e ad esso resta
asservita l’obbligazione che il garante assume,
in quanto le vicende originarie e successive,
che inficiano il diritto che il creditore vanta
nei confronti del debitore, si riverberano
direttamente sull’obbligo di garanzia.
Il concetto stesso di garanzia, come visto nel
par. 1 del presente capitolo, rinvia ad un quid
di esterno cui s’intende prestare una
protezione, postulando, pertanto, da un punto
di vista logico, prima che giuridico, un
collegamento tra il diritto “di garanzia” e
quello “principale”, cui il primo assicura
tutela. Il c.d. principio di accessorietà
descrive il collegamento (genetico e\o
98
funzionale) che sussiste tra il rapporto
principale, e quello di garanzia,
teleologicamente preordinato all’estinzione
satisfattoria del primo.
Da un punto di vista genetico il rapporto
accessorio presuppone un rapporto principale
esistente e valido; sotto il profilo funzionale
esso risente di tutte le vicende che incidono
sul rapporto principale, con l’effetto che
tutte le eccezioni fondate su quest’ultimo
possono essere opposte nel rapporto
(accessorio) di garanzia. La ratio di tale
regime è conseguenza immediata ed evidente
della causa di garanzia del contratto da cui
nasce siffatto ultimo rapporto.
99
Seppure in termini non assoluti106, la
fideiussione codicistica è tipicamente
caratterizzata dall’operatività del citato
principio di accessorietà, espresso attraverso quattro
106 Attraverso gli articoli 1939, 1945 e 1950, cod. civ., il
legislatore disciplina la fideiussione per un’obbligazione assunta
da un incapace, statuendo che: a) è valida la fideiussione
nonostante l’invalidità del rapporto garantito (art. 1939 cod.
civ.); b) il fideiussore non può eccepire al creditore
l’invalidità del rapporto garantito (art. 1945 cod. civ.); c)
l’esercizio del diritto di regresso è limitato a quanto sia stato
rivolto a beneficio dell’incapace garantito (art. 1950, comma 4,
cod. civ.). Questa disciplina ha sollevato numerosi problemi di
compatibilità sistematica con il principio di accessorietà, tant’è
che secondo taluni autori (vedi A. RAVAZZONI, La fideiussione, cit.,
p. 283) il contratto di fideiussione stipulato per garantire
l’adempimento del debito dell’incapace costituirebbe un’ipotesi
atipica, causalmente connotata dalla funzione di assicurare il
credito. La tesi sembrerebbe da rigettare sulla base della
semplice osservazione che l’atipicità presuppone che la
fattispecie non sia esplicitamente contemplata dalla legge,
circostanza questa che non si verifica nel caso di specie. Altri
autori individuano la ratio della normativa in esame nell’esigenza
di evitare che il fideiussore si avvantaggi di una tutela che ha
riguardo esclusivo allo stato personale del debitore principale
(in tal senso C. M. BIANCA, op. cit., p. 478; Cfr. L. RUGGERI, op.
cit., p. 18.).
100
articoli del codice civile (artt. 1939, 1941,
1942, 1945 cod. civ.). Procediamo con ordine.
A) Innanzitutto, l’art. 1939 cod. civ.
prescrive che la fideiussione non è valida se
non è valida l’obbligazione principale: la
norma sanziona un difetto ab origine della causa
negoziale. Si è prospettata107 l’applicabilità
della disposizione anche quando l’obbligazione
principale sia simulata, sia stata dichiarata
prescritta o sia di carattere naturale. Nei tre
casi esposti, non essendovi un credito
“principale” da garantire, verrebbe meno la
causa del contratto di garanzia (come
nell’ipotesi descritta dall’articolo citato).
Va precisato che l’annullabilità del contratto
da cui ha origine il rapporto garantito,
comportando un’efficacia potenzialmente107 M. FRAGALI, op. cit., p. 356.
101
eliminabile attraverso l’azione di
annullamento, non esclude la possibilità di
prestare una valida garanzia fideiussoria108; il
fideiussore, tuttavia, può eccepire il vizio
che causa l’invalidità del contratto – base,
per sottrarsi all’escussione della garanzia.
B) L’art. 1941 cod. civ. dispone che la
fideiussione non può eccedere quanto dovuto dal
debitore, né può essere prestata a condizioni
più onerose. A conferma del carattere
imperativo109 ed inderogabile110 del principio,
108 Sull’argomento G. BOZZI, La fideiussione, le figure affini e l’anticresi, in
Tratt. dir. priv. Rescigno, 13, Torino, 1085, p. 287 ss.109 A. RAVAZZONI, Fideiussione, cit., p. 280; l’A. precisa che la
riduzione della fideiussione eccessiva può anche avvenire ad opera
del giudice ex officio.110 L’inderogabilità va intesa nel senso che non è ammissibile la
fideiussione a condizioni più gravose, non quella in leviorem causam
(art. 1941, comma 2, cod. civ.). Cfr. M. FRAGALI, Fideiussione, cit.,
p. 359. L’A. precisa che l’eccedenza della fideiussione rispetto a
quanto dovuto dal debitore principale va verificata in concreto,
in modo da chiarire se essa sia apparente, come per il caso che le
parti abbiano inteso considerare il sovrappiù come oggetto di
102
il terzo comma del medesimo articolo statuisce
che l’obbligazione fideiussoria eccedente il
debito, o contratta a condizioni più onerose, è
valida nei limiti dell’obbligazione principale.
La norma è posta a salvaguardia
dell’accessorietà fideiussoria e risponde ad un
criterio di ragionevolezza: il valore causale
che nella fideiussione assume il nesso tra
l’obbligazione del garante e quella
dell’obbligato principale impone che
l’esposizione debitoria di quest’ultimo non
possa eccedere quella del debitore “primario”.
È interessante notare che ove la fideiussione
ecceda quanto dovuto dal debitore o sia
prestata a condizioni più onerose, il
obbligazione a causa diversa, o quale corrispettivo di un
vantaggio concesso al fideiussore. Quanto alla fideiussione
concessa a condizioni più gravose, la maggiore gravosità potrebbe
essere condizione, loco, modo, die.
103
legislatore non commina la nullità del negozio
di garanzia, ma la “riduzione” dello stesso,
attraverso una tecnica normativa che fa
applicazione del principio di conservazione del
contratto e dei suoi effetti111. La fideiussione
che obbliga il fideiussore in duriorem causam non
è un atto valido, ma il legislatore ne
salvaguardia l’efficacia, previa riduzione del
programma negoziale iniziale, sulla scorta
dell’obbligazione garantita. Si è osservato in
tal senso che la disposizione <<appare come il
frutto di una sapiente combinazione dei due
rimedi (incisione sul regolamento negoziale e
salvaguardia della sua efficacia), attraverso i
quali si realizza il valore rappresentato dalla
conservazione del contratto: il mantenimento
della regola privata meritevole di tutela e
111 Cfr. L. RUGGERI, op. cit., p. 54.
104
l’adeguamento della regola difforme alla
realizzazione degl’interessi privilegiati
dall’ordinamento>>112
Il comma 2 dell’art. 1941 cod. civ. statuisce
poi che <<la fideiussione può prestarsi per una
parte soltanto del debito o a condizioni meno
onerose>>. Tale disposizione, prescrivendo la
validità della fideiussione in leviorem causam,
ammette che l’obbligato principale e quello
fideiussorio non siano tenuti per una medesima
prestazione o alle stesse condizioni.
Se la fideiussione preveda condizioni più
vantaggiose per il garante, rispetto al
debitore, il regime di solidarietà passiva
potrà ritenersi salvo alla stregua dell’art.
1293 cod. civ., secondo cui la <<la solidarietà
non è esclusa dal fatto che i singoli debitori112 A. e op. ult. cit., p. 55.
105
siano tenuti ciascuno con modalità diverse>>.
Qualora però la fideiussione sia prestata per
una parte soltanto del debito, l’obbligazione
fideiussoria non sarà esattamente identica a
quella del debitore principale, con ciò venendo
meno il presupposto oggettivo dell’esistenza di
un’obbligazione in solido113. La previsione di
cui all’art. 1941, comma 2, cod. civ., ha un
importante rilievo sistematico, poiché apre il varco
a fideiussioni che, per caratteristiche
strutturali, non possono dar luogo ad
un’obbligazione in solido.
È possibile una riflessione ulteriore. La
norma, consentendo la prestazione di
fideiussioni non identiche all’obbligazione
principale (garanzia prestata per una parte113 L’art. 1293 cod. civ. prescrive in fatti che <<l’obbligazione è
in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima
prestazione (…)>>.
106
soltanto del debito), tempera il principio di
accessorietà, ammettendo che il contenuto
dell’obbligo del fideiussore possa modellarsi
in senso parzialmente autonomo rispetto a
quello dell’obbligo principale. Ne risulta una
conferma di quell’opinione dottrinale che aveva
predicato l’ammissibilità di una fideiussione
per obbligazione di fare e dare fungibili114.
C) La strutturale accessorietà dell’obbligo del
fideiussore trova ulteriore specificazione
nell’art. 1942 cod. civ., che statuisce il
principio di estensione della fideiussione.
Alla luce del citato articolo la garanzia
prestata dal fideiussore non si limita a
coprire il debito principale, ma si estende a
tutti gli accessori di esso, nonché alle spese
per la denunzia al fideiussore della causa
114 In tal senso Cfr. E. BRIGANTI, op. cit., p. 47 ss.
107
promossa contro il debitore principale e alle
spese successive.
La disposizione trova applicazione soprattutto
in relazione a fideiussioni prestate a garanzia
di debiti pecuniari. Problematica risulta,
tuttavia l’individuazione delle categorie
d’interessi suscettibili di determinare
l’estensione dell’esposizione debitoria del
fideiussore. La giurisprudenza ritiene che la
prestazione cui il garante è tenuto vada
determinata per relationem, in misura
corrispondente a quella del debitore
principale. Ad esempio si è stabilito che il
fideiussore sia obbligato a pagare gl’interessi
ultralegali praticati dalla banca al debitore
108
garantito, ogniqualvolta quest’ultimo non abbia contestato
l’estratto conto che liquida tali interessi115.
La soluzione non ha mancato di sollevare
critiche116. Evidentemente, infatti, per
l’ipotesi menzionata, il fideiussore <<rimane
in balia del debitore principale>>117, in quanto
l’inerzia di quest’ultimo aggrava la posizione
del garante, senza che questi abbia la
possibilità di procedere ad un controllo circa
le pretese della banca creditrice. D’altro
canto, l’art. 1284, comma 3, cod. civ.,
statuisce la forma scritta ad substantiam per la
determinazione d’interessi superiori alla
misura legale. Il garante, quindi, risulterebbe
obbligato al pagamento degl’interessi
115 Cass., 8 agosto 1988, n. 4871, in Banca borsa tit. cred., 1989, II,
p. 576.116 L. RUGGERI, op. cit., p. 178.117 A. e op. loc. ult. cit.
109
ultralegali senza che nessuna pattuizione
scritta abbia sancito tal obbligo nei suoi
confronti, e senza poter neppure contestare
l’estratto conto che liquida gl’interessi in
misura extralegale.118.
Dovrebbe pertanto ritenersi contrario ai
principi di buona fede nell’interpretazione ed
esecuzione del contratto che il comportamento
negligente del debitore, il quale ometta di
contestare gli addebiti sul proprio conto
corrente, possa condurre alla suddetta
estensione del debito fideiussorio.
A nulla varrebbe obiettare che in conseguenza
dell’esperimento dell’azione di regresso il
peso definitivo del debito non grava sul
garante, ma sul debitore principale. È chiaro
infatti che alto è il rischio del fideiussore118 In questi termini A. e op. ult. cit., p. 179.
110
di non poter soddisfare le proprie ragioni,
data l’incapienza del patrimonio del debitore
garantito.
La giurisprudenza di merito119 ha poi ritenuto
estensibile per relationem l’esposizione
debitoria del fideiussore agl’interessi
moratori dovuti dal debitore, secondo la misura
pattuita da quest’ultimo col creditore,
piuttosto che secondo quella legale. Anche ora
sembrerebbe che la soluzione tuteli
eccessivamente il creditore e per nulla il
fideiussore120.
119 In tal senso App. Firenze, 29 settembre 1980, in Banca borsa tit.
cred., 1981, II, p. 445.120 Ma vedi Cass., 16 gennaio 1985, n. 103, in Banca borsa tit. cred.,
1986, II, p. 144, che ha cassato la sentenza prima menzionata,
proponendo una lettura restrittiva dell’art. 1942 cod. civ.,
salvaguardando la posizione del fideiussore, che, soprattutto in
ipotesi di fissazione di un tetto massimo del debito garantito,
non può vedersi addossati gl’interessi moratori pattuiti dal
debitore col creditore.
111
10. Segue: le eccezioni opponibili dal fideiussore (art. 1945
cod. civ.): un’ulteriore estrinsecazione del principio di
accessorietà.
L’art. 1945 cod. civ. statuisce:<<il
fideiussore può opporre contro il creditore
tutte le eccezioni che spettano al debitore
principale, salva quella derivante
dall’incapacità>>.
La norma, che costituisce un’ulteriore
estrinsecazione del principio di accessorietà
dell'obbligazione fideiussoria, va letta
coordinatamente all'art. 1939 cod. civ., perché
permette al garante (la possibilità) di
sollevare, tra le altre, le eccezioni legate
all'invalidità del rapporto principale,
richiamando esplicitamente la limitazione
112
legata all'incapacità del debitore garantito,
già prevista dall’articolo citato.
La ragione del descritto regime va rinvenuta
nella giustificazione causale di garanzia del
contratto in esame, giusta l’osservazione
secondo cui la ragione per cui il fideiussore
può opporre le stesse eccezioni spettanti al
debitore si spiega in quanto l’obbligazione
garantita è il presupposto di quella di
garanzia121.
In altri termini, la posizione del fideiussore
nei confronti del creditore è identica a quella
del debitore garantito, <<come se egli stesso
fosse questo debitore>>122. In dottrina123 si
sottolinea però che il fideiussore vanta un
diritto proprio a far valere quelle eccezioni,121 Così M. FRAGALI, fideiussione, cit., p. 368.122 A. e op. loc. ult. cit.123 C. F. MASSIDA, op. cit., p. 9; M. FRAGALI, op. loc. ult. cit.
113
con la conseguenza che il comportamento tenuto
dal debitore, che, ad esempio abbia
riconosciuto il debito, convalidato un negozio
annullabile, oppure rinunziato alle eccezioni,
non potrà pregiudicare il diritto attribuito al
fideiussore dall’art. 1945 cod. civ.124, in cui
la locuzione <<eccezioni che spettano al
debitore principale>> va interpretata secondo
un criterio di spettanza “astratta”125.
Si deve ora chiarire che in tanto il garante
potrà opporre tutte le eccezioni che spettano
al debitore principale, in quanto ne sia a
conoscenza. Per favorire detta cognizione il
legislatore pone a carico del fideiussore
l’onere di dare avviso al debitore del suo
124 Cfr. B. GRASSO, L’interesse del fideiussore tutelato dall’art. 1945 cod. civ., in
Rass.dir. civ., 1980, p. 362.125 In tal senso M. FRAGALI, op. loc. ult. cit.
114
proposito di pagare126, di modo che costui potrà
comunicargli la situazione di validità ed
attuabilità del rapporto che lo lega al
creditore127.
Conseguenza del mancato avviso sarà
l’opponibilità al fideiussore che ha pagato, e
che agisca in via di regresso (art. 1950 cod.
civ.) verso il debitore, delle eccezioni che
costui avrebbe potuto opporre al creditore. In
tal caso è fatta salva al fideiussore l’azione
di ripetizione d’indebito verso il creditore.
Il problema è se il legislatore, attraverso
l’art. 1952, comma 2, cod. civ. abbia inteso
porre a carico del fideiussore un obbligo di
opporre le eccezioni desumibili dal rapporto
garantito128. In altri termini il fideiussore126 Arg. ex art. 1952 cod. civ.127 Così m. FRAGALI, op. loc. ult. cit.128 In senso affermativo M. FRAGALI, op. cit., p. 369.
115
che adempia l’obbligo di garanzia, pur essendo
stato informato dal debitore dell’esistenza di
eccezioni relative al contratto o al rapporto
base, potrà esperire con successo il regresso
verso quest’ultimo? Oppure dovrà ritenersi che
il debitore possa opporgli quelle eccezioni che
avrebbe potuto far valere verso il creditore?
Una risposta alla domanda che voglia
valorizzare la ratio dell’art. 1952 cod. civ.
dovrebbe essere nel senso che non possa
ritenersi onerato dell’azione di ripetizione il
debitore, a causa della negligenza del
fideiussore.
Ricapitolando, il fideiussore potrà opporre nei
confronti del creditore tutte le eccezioni
fondate sul rapporto principale, quali la
prescrizione dell’obbligazione principale,
116
l’invalidità, la rescissione e la risoluzione
del contratto da cui ha origine il debito
principale, la simulazione etc.
Non potrà opporre invece l’eccezione relativa
all’annullabilità del negozio base dovuta
all’incapacità del contraente (deroga
espressamente prevista dall’art. 1945 cod.
civ.), quelle di carattere personalissimo al
debitore, nonché le eccezioni afferenti il
rapporto con il debitore principale (ad esempio
quelle che riguardano il rapporto di mandato in
base al quale il fideiussore è stato indotto
alla conclusione del contratto di garanzia).
A fini di completezza espositiva va aggiunto
che saranno ovviamente opponibili tutte le
eccezioni relative al contratto o al rapporto
117
di garanzia, come ad esempio il beneficio di
escussione.
11. La problematica concernente gli effetti riflessi del
giudicato formatosi nella lite tra creditore e debitore.
Rilevanti interrogativi solleva la questione
concernente la possibilità del creditore di
escutere la garanzia sulla base di una sentenza
di condanna pronunciata nei confronti del
debitore principale. Va tenuta presente la
seguente dinamica: se si tratta di fideiussione con
beneficio d’escussione il creditore non ha scelta, dovrà
rivolgere la propria istanza al debitore
principale, perseguendo, nel contraddittorio
delle parti, il buon esito della propria
domanda giudiziale. Può accadere che il
fideiussore, la cui obbligazione è dipendente
da quella principale, rimanga estraneo al
118
processo129, salvo che intervenga spontaneamente
(art. 105 cod. proc. civ.), o sia chiamato in
causa su istanza di parte (art. 106 cod. proc.
civ., verosimilmente dal creditore) o del
giudice (art. 107 cod. proc. civ.).
Il processo si chiuderà con una sentenza di
condanna del debitore, oppure, in senso
contrario, con il rigetto della domanda.
A) Consideriamo l’ipotesi per prima
prospettata. L’art. 2909 cod. civ. statuisce
che <<l’accertamento contenuto nella sentenza
passata in giudicato fa stato ad ogni effetto
tra le parti, i loro eredi, o aventi causa>>.
Da un punto di vista processuale si è affermato
129 Sulla base dell’attuale disciplina (art. 102 cod. proc. civ.)
non è rinvenibile un litisconsorzio necessario tra debitore
principale e fideiussore. Resterà di conseguenza rimessa alla
decisione delle parti o del giudice la scelta in ordine alla
chiamata in causa (art. 106 e 107 cod. proc. civ.) o
all’intervento (art. 105 cod. proc. civ.) del fideiussore.
119
pertanto che il giudicato formatosi nella lite
tra creditore e debitore non è idoneo a “fare
stato” nei confronti del fideiussore130, il
quale non è né parte del processo, né avente
causa del debitore. Alla stregua di detta
conclusione, il creditore che intenda agire in
executivis contro il fideiussore131, non solo non
avrà un titolo esecutivo nei confronti di detto
soggetto, ma dovrà sobbarcarsi ad un nuovo
processo, ora nei confronti del fideiussore,
che “formalmente” non è per nulla influenzato dal
primo132. Il creditore dovrà così ripercorre
interamente l’iter delle prove, e il nuovo
130 Nel senso proposto M. FRAGALI, Fideiussione, cit., p. 369.131 Perché ad esempio ritenga inutile esperire l’azione esecutiva
nei confronti del debitore, data l’assenza nel suo patrimonio di
adeguate utilità.132 Cass., 12 aprile 1984, n. 2369, in Foro it., 1985, I, c. 2383
ss., ha ritenuto che il giudice, nel processo promosso contro il
fideiussore, può liberamente valutare il giudicato di condanna
formatosi avverso il debitore principale.
120
convenuto potrà liberamente opporgli qualsiasi
eccezione che gli competa, riguardante
l’obbligazione garantita, sicché il nuovo
processo potrà avere anche esito diverso dal
primo. Non si produrrà però, per il caso
ipotizzato, un contrasto “pratico” di
giudicati, perché i due processi avranno avuto
ad oggetto rapporti collegati, ma autonomi.
Il problema dell’inopponibilità al fideiussore
del giudicato formatosi nella lite tra debitore
e creditore è tuttavia controverso.
Si è prospettata in dottrina la necessità di
accogliere un’interpretazione estensiva della nozione di avente
causa, per includervi tutti coloro <<la cui
situazione giuridica è strettamente dipendente
da un’altra situazione, facente capo alla parte
della situazione decisa col giudicato, in modo
121
da ritenere che l’esistenza, l’inesistenza o le particolari
caratteristiche di questa siano il presupposto (…) dell’esistenza,
inesistenza o delle particolari caratteristiche di quella. Anche
il soggetto che si trova in una siffatta
relazione giuridica con l’altro soggetto può
considerarsi un avente causa perché (…) deriva
da lui (…) la ragione o una parte della ragione
che potrà far valere verso altri>>133.
Il citato A. afferma che nell’ipotesi in cui
fra creditore e debitore principale si sia
giudicato che la relativa obbligazione esiste,
è valida e non si è estinta, <<quel giudicato
tra creditore e debitore principale (…)
escluderebbe ogni ulteriore questione
sull’esistenza e validità dell’obbligazione
garantita e renderebbe infondate obiezioni ed
133 G. PUGLIESE, Giudicato civile, in Enc. dir., XVIII, Milano, 1969, p.
884.
122
eccezioni al riguardo da parte del
fideiussore>>134. La dipendenza della
fideiussione dall’obbligazione principale
dovrebbe ritenersi <<idonea a giustificare
l’opponibilità al fideiussore del giudicato
sfavorevole>> e, aggiunge l’A., il cui pensiero
qui si riporta, <<solo ragioni pratiche (…)
spiegano l’orientamento di quella parte della
dottrina e della giurisprudenza che nega nella
specie l’autorità del giudicato. Infatti le
ragioni giuridiche (…) appaiono inconsistenti o
assai discutibili>>135.
Da un punto di vista più generale, si è
osservato che <<l’efficacia del giudicato nei
confronti dei terzi si spiega in virtù del
collegamento giuridico intercorrente tra il
134 A. e op. loc. ult. cit.135 A. e op. loc. ult. cit. V. nota 439 a pag. 892.
123
rapporto deciso e quello di cui è soggetto il
terzo: collegamento che può sostanziarsi in un
nesso di dipendenza del secondo rispetto al
primo (…)>>136. <<Carattere identificatore della
efficacia “consequenziale” è (…) il suo normale
atteggiarsi come normale manifestazione della
generale ripercussione della vicenda del
rapporto deciso – nella veste di rapporto
pregiudiziale – sul rapporto dipendente di cui
è soggetto il terzo>>137. L’efficacia
consequenziale sarebbe operante ogniqualvolta
il rapporto di cui il terzo è soggetto sia
giuridicamente collegato al rapporto deciso e,
quindi, anche in mancanza di esplicita
disposizione in tal senso. Anzi, una norma
espressa sarebbe necessaria solo per sancire
136 F. B. BUSNELLI, Della tutela dei diritti, in Commentario del codice civile,
Libro VI, Tomo IV, Torino 1964, p. 226.137 A. e op. ult. cit., p. 227.
124
eventuali deroghe o limiti al normale
verificarsi di quest’efficacia138.
Ancora si è puntualizzato che <<se il processo
si è svolto senza l’intervento del fideiussore
e si è giunti ad una sentenza passata in
giudicato, non è più possibile a questi fare
nulla contro l’estensione di codesto giudicato
nei suoi confronti>>139, in quanto, alla stregua
dell’art. 1945 cod. civ., dovranno ritenersi
opponibili da parte del fideiussore soltanto le
eccezioni concretamente proponibili: il
giudicato di condanna del debitore garantito
escluderebbe dal novero delle eccezioni
opponibili le questioni sulle quali è
intervenuto il giudicato.
138 Così, testualmente, A. e op. ult. cit., p. 228.139 A. RAVAZZONI, La fideiussione, Milano 1973, p. 35.
125
I riferiti discorsi presuppongono l’elasticità
della nozione di “avente causa”, tale cioè da
“(…) permettere l’inclusione in essa di
soggetti, che senza aver partecipato al
processo in cui si formò il giudicato, debbano
però risentirne l’autorità”140.
Come sopra anticipato vi è chi dissente
dall’opinione surriportata. Nella prospettiva
di assicurare al fideiussore il giusto diritto
di difesa (art. 24, comma 2, Cost.) si afferma
che <<la dipendenza dell’obbligazione
fideiussoria da quella principale, che, secondo
alcuni, giustificherebbe una regola di
riflessione del giudicato, non può spingersi
fino ad opporre al fideiussore una vicenda,
come quella conclusasi in modo sfavorevole per
il debitore, il cui svolgimento è stato
140 G. PUGLIESE, op. cit., p. 882.
126
determinato unicamente dal potere dispositivo
dello stesso, ma potrebbe formare soltanto
oggetto di apprezzamento del giudice nel quadro
complessivo delle deduzioni prospettate dal
fideiussore e delle prove acquisite nel
processo>>141.
A mio avviso sembra essere questa l’equa
soluzione da dare alla questione dell’efficacia
riflessa del giudicato.
In base al principio di “economia” sembrerebbe
che la sentenza resa tra creditore e debitore
sia opponibile al fideiussore. Diversamente il
giudizio promosso dal creditore contro il
debitore si rivelerebbe in gran parte inutile.
Considerazione, questa, rafforzata dalla
pacifica non ricorrenza di litisconsorzio
necessario nella specie. E potrebbe addirittura141 M. FRAGALI, Fideiussione, cit., p. 368 ss.
127
ritenersi che il debitore non chiami in causa
il fideiussore, proprio per l’inopponibilità a
costui della sentenza.
È lecito però osservare, d’altro canto, che
l’iniziativa della chiamata in causa del
fideiussore può essere presa dal creditore e
nella pratica è inverosimile che ciò non
avvenga, in quanto l’avvocato “diligente” del creditore
assumerà certamente l’iniziativa della chiamata in causa del
fideiussore, al fine di rendergli opponibile il giudicato. In
secondo luogo va ricordato che, secondo la
dottrina maggioritaria, il rimedio
dell’opposizione di terzo ordinaria ex art.
404, comma 1, cod. proc. civ., è esperibile dal
terzo titolare di un diritto autonomo ed
indipendente142. Il fideiussore, pertanto, in
142 A. PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 2006, p.
541.
128
quanto non è titolare di un diritto “autonomo
ed indipendente”, ma “dipendente” da quello
delle parti del rapporto principale, non
potrebbe tutelarsi impugnando la sentenza ai
sensi dell’art. 404, comma 1, cod. proc. civ.,
ma solo attraverso l’opposizione di terzo
revocatoria (art. 404, comma 2, cod. proc.
civ.), assoggetta a ristretti limiti temprali,
nonché all’eventualità che la sentenza sia
l’effetto di dolo o collusione a danno del
terzo. Sembra ragionevole concludere che si
verifichi una compressione forse eccessiva del
diritto di difesa del fideiussore, a cui
sarebbe opponibile il giudicato, senza che
abbia alcuno strumento per contrastarne
l’efficacia, a meno che la sentenza sia
l’effetto di dolo o collusione a suo danno.
129
In linee più generali, sulla problematica
dell’efficacia riflessa del giudicato formatosi
sul rapporto pregiudiziale143 si può notare che
l’adesione alle posizioni che prospettano il
riverbero sul rapporto dipendente
dell’efficacia della sentenza resa sul rapporto
pregiudiziale (tesi dell’efficacia riflessa generalizzata),
piuttosto che a quelle restrittive (secondo cui
l’ordinamento positivo non offre dati per
ritenere che il fenomeno dei collegamenti
giuridici tra rapporti c.d. di pregiudizialità
– dipendenza debba dare luogo a quello,
diverso, dell’efficacia riflessa della
143 Sul tema dei limiti soggettivi del giudicato ed in particolare
sulla problematica dell’efficacia riflessa del giudicato in
relazione ai rapporti legati da un nesso di pregiudizialità-
dipendenza cfr. PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli
2006, p. 365 ss.; G. VERDE Profili del processo civile, 2 Processo di cognizione,
Napoli 2006, p. 325 ss. e 349 ss.;
130
sentenza), dipenderà dall’adesione ad una
particolare opzione ideologica144.
Quel che è certo è che: a) in talune ipotesi il
legislatore stabilisce che la sentenza
144 Per quanto concerne la dottrina processual - civilistica si
possono al riguardo richiamare le osservazioni antitetiche di due
autorevoli Studiosi: G. VERDE, op. cit., p. 349 afferma: <<(…) la nostra
opinione è contraria ad immaginare che il giudicato possa estendere i suoi effetti nei
confronti dei terzi. L’economia processuale e la coerenza fra le decisioni, che sono le
ragioni che militano a favore dell’estensione, devono cedere di fronte ad altri valori a
nostro avviso prevalenti, quali la necessità che la pronuncia sia coordinata alla domanda
dei privati e sia l’esito di un processo nel quale tutti i destinatari del provvedimento
giudiziale abbiano avuto piena possibilità di difesa>>. Viceversa PROTO PISANI,
op. cit., p. 369, sostiene che escludere l’efficacia riflessa della
sentenza resa sul rapporto pregiudiziale, al fine di privilegiare
la garanzia del diritto di difesa dei terzi, significa
pretermettere del tutto “la considerazione che, quanto meno nel settore degli
status e della circolazione dei beni, specie se immobili, l’esigenza di certezza (esigenza
che subirebbe un irrimediabile attentato dalla, più o meno larga, possibilità di un
differente accertamento del rapporto pregiudiziale) costituisce un <<valore pratico>> che
lo stesso legislatore fa assurgere a dimensione giuridica (si consideri la disciplina dei
registri dello stato civile e della trascrizione) e con il quale, pertanto, l’interprete non può
non fare i conti”. “(…) la soluzione dell’efficacia riflessa generalizzata della sentenza
non sarebbe necessariamente in contrasto con l’art. 24, comma 2, Cost., sol che l’istituto
dell’intervento coatto per ordine del giudice ex art. 107 c. p. c., conformemente alle
indicazioni di gran parte della dottrina, fosse più sapientemente utilizzato dai giudici a
tutela del diritto di difesa dei terzi titolari di rapporti dipendenti, e soprattutto che l’art.
404, comma 2, fosse interpretato nel senso di allargare gl’indici del dolo e della
collusione ricollegandoli a tutti i comportamenti , anche omissivi, espressione della
131
pronunciata tra le parti del rapporto
pregiudiziale abbia effetto sul rapporto
dipendente (es. art. 1595 cod. civ. in tema di
nullità o risoluzione del contratto di
locazione). b) Vi sono ipotesi in cui il
legislatore, partendo dalla consapevolezza che
la sentenza non possa pregiudicare il terzo che
non sia messo in condizione di partecipare al
processo (es. art. 1485 cod. civ.), ha previsto
che il terzo (nell’esempio proposto il
venditore) possa opporsi alla sentenza posta a
base della pretesa della parte originaria (il
compratore) nei suoi confronti, provando che
esistevano ragioni sufficienti per un diverso
accertamento del rapporto pregiudiziale in cui
è coinvolto (il venditore dovrà provare cheviolazione in danno del terzo dell’obbligo di lealtà e probità ex art. 88 c. p. c. e di ritenere
che il terzo debba provare unicamente la sussistenza di tali indici (…), ma non anche i
comportamenti necessariamente positivi, o addirittura direttamente il dolo o la
collusione” (Proto Pisani, op. cit., p. 370).
132
esistevano ragioni sufficienti per il
respingimento della domanda del terzo che ha
vittoriosamente evitto il compratore). c) In
tutte le ipotesi in cui il fenomeno della
pregiudizialità – dipendenza si accoppia al
fenomeno della solidarietà, l’art. 1306 cod.
civ. esclude che la sentenza resa sul rapporto
pregiudiziale possa avere efficacia contro il
terzo coobbligato solidale soggetto passivo del
rapporto giuridicamente dipendente. Qui il
terzo non è neppure incentivato ad effettuare
un interveto (adesivo dipendente) nel processo,
in quanto può trovare ragionevole “restare alla
finestra”145, poiché soltanto il risultato
positivo potrà avere un qualche effetto nei
suoi confronti.
145 L’espressione è di G. VERDE, Profili del processo civile, 1 parte generale,
Napoli, 2002, p. 247.
133
La soluzione contenuta nell’art. 1306 sembra
tra l’altro applicabile anche al di fuori del
collegamento solidale tra rapporti, in ragione
della logica ad essa sottesa. La norma
salvaguardia il diritto al contradditorio del
soggetto terzo, evitando che a costui si
estendano gli effetti di un processo svoltosi
in sua assenza e senza che si siano potuti
esercitare i poteri dispositivi al fine di
orientare la decisione del giudice. Nel
contempo il legislatore da rilievo al nesso di
solidarietà, consentendo al condebitore, terzo
rispetto al processo, di opporre al creditore
la sentenza a costui sfavorevole, a meno che
non sia fondata su ragioni personali al
condebitore, parte del processo de quo.
134
Nella fideiussione il nesso di accessorietà che
lega il rapporto fideiussorio a quello
principale giustifica un’analoga parziale
influenza del giudicato sul rapporto
dipendente, limitata al diritto potestativo del
fideiussore di eccepire l’intervenuta
decisione, al fine di paralizzare un’abusiva
escussione della garanzia da parte del
creditore146.
B) Pertanto, ove il processo tra debitore e
creditore si chiuda con il rigetto della
domanda di quest’ultimo, dovrebbe ritenersi che
il fideiussore possa comunque invocare la146 Per il caso che sia stabilito il beneficio di escussione
potrebbe obbiettarsi che, non essendo l’obbligazione del
fideiussore solidale, non possa applicarsi analogicamente la norma
contenuta nell’art. 1306 cod. civ., dettata in tema di
obbligazioni solidali. Tuttavia la soluzione non terrebbe conto
del fatto che pur non essendo il fideiussore obbligato in solido,
la sua posizione debitoria sarebbe comunque modellata su quella
del debitore principale, verificandosi pertanto quell’identità del
debito che ritroviamo nelle obbligazioni solidali passive.
135
sentenza per paralizzare la domanda del
creditore che si fondi su una questione già
decisa dal giudice de quo147. La natura solidale
(o comunque accessoria) dell’obbligazione
fideiussoria consente infatti di applicare
all’ipotesi dell’escussione pretestuosa della garanzia
la norma prevista dall’art. 1306, comma 2, cod.
civ.148. L’articolo citato, seppur confermativo
dell’inopponibilità del giudicato nei confronti
dei condebitori rimasti estranei al processo,
consente a questi ultimi di avvalersene, al
fine di paralizzare la domanda del creditore.
La ratio legis è duplice: da un canto, il
legislatore salvaguardia il diritto al
contraddittorio, escludendo (in linea con
l’art. 2909 cod. civ.) che la sentenza
147 Sull’argomento L. RUGGERI, op. cit., p. 142.148 Sull’importanza sistematica della disposizione in esame G.
PUGLIESE, Giudicato civile (dir. vig.), cit., p. 886.
136
pronunziata verso uno dei condebitori possa
avere effetto nei confronti di chi, per non
essere stato parte di quel processo, non abbia
avuto la possibilità di far valere le proprie
ragioni; d’altro canto, il riconoscimento al
“condebitore in solido” del diritto potestativo
di eccepire l’intervenuta decisione al fine di
paralizzare la domanda del creditore, sembra
finalizzata ad un obiettivo processuale di
economia degli atti149, evitando che il
creditore, attraverso pretese già respinte da
una decisione passata in giudicato, si avvalga
della terzietà del condebitore per instaurare
un nuovo processo e “darsi una seconda chance di
uscirne vittorioso”.
In conclusione, sulla base di tale opzione
interpretativa il garante risulterà certamente
149 In tal senso L. RUGGERI, op. cit., p. 143.
137
avvantaggiato, poiché potrà utilizzare il
giudicato favorevole, in via di eccezione, per
paralizzare la richiesta del creditore; in caso
di sentenza favorevole al creditore, invece, il
relativo giudicato non “farà stato” nei suoi
confronti, potendo il fideiussore proporre
tutte le eccezioni relative al rapporto
principale, anche quelle già proposte dal
debitore principale nel precedente giudizio. Il
“nuovo processo” potrà pertanto avere un esito
divergente rispetto al primo, con il possibile esito di
giudicati logicamente contraddittori ove mai vi siano
due accertamenti contrastanti del rapporto
pregiudiziale debitore – creditore (ad es. è
ipotizzabile che il primo giudice accolga la
domanda del creditore contro il debitore
principale ed il secondo giudice respinga
quella proposta contro il fideiussore, per
138
accogliere le eccezioni relative al rapporto
principale, già sollevate dal debitore nel
primo processo e tuttavia respinte in quella
sede).
Allo stato, non configurandosi un’ipotesi di
litisconsorzio necessario in relazione a
rapporti autonomi seppur collegati150, l’unico
rimedio per evitare il risultato sopra
ipotizzato, “ingiusto” per il creditore, sarà
la condotta diligente dell’avvocato del
creditore che chiamerà in causa il fideiussore
(ex art. 106 cod. proc. civ.), o comunque
l’utilizzo sapiente, da parte del giudice,
dell’istituto dell’intervento coatto iussu iudicis,150 La giurisprudenza esclude la necessità del litisconsorzio anche
per il caso che siano in discussione aspetti essenziali del
rapporto principale (ad es. la validità del titolo da cui nasce il
debito), propendendo per la configurabilità del litisconsorzio
facoltativo in causa considerate scindibili (Cfr. Cass., 17 luglio
2002, n. 10400, in Rep. Giur. it., 2002, Obbligazioni e contratti, c. 3466,
n. 557 e c. 3469, n. 577).
139
previsto dall’art. 107 cod. proc. civ., qui
utilizzato a tutela del diritto di difesa dei
terzi titolari di rapporti giuridicamente
dipendenti.
12. Il contenuto dell’obbligazione fideiussoria. Il concetto di
fungibilità della prestazione.
Occorre ora soffermarsi sulla tematica del
rapporto tra lo scopo e il contenuto
dell’obbligazione fideiussoria151. Ne risulterà
chiarita, sotto quest’aspetto, la specificità
“oggettuale” del negozio fideiussorio, rispetto
alle diverse forme del “garantire”, che pur
avendo funzione di garanzia, ed essendo per
quest’aspetto assimilabili alla fideiussione,
ne divergono per la diversità del contenuto
dell’obbligazione assunta dal garante.
151 Sull’argomento E. BRIGANTI, op. cit., p. 37 ss.; ma v. anche M.
FRAGALI, Fideiussione, cit., p. 355.
140
In via di premessa va detto che l’art. 1936,
comma 1, cod., civ., affermando che <<è
fideiussore colui che (…) garantisce
l’adempimento dell’obbligazione altrui>> ha
modificato il precedente art. 1898 cod. civ.,
che riteneva il fideiussore debitore della
stessa obbligazione principale; non è dato
desumere dal primo articolo citato, tuttavia,
se con la fideiussione si abbia un unico debito
o, invece, due debiti e, quindi, se la
prestazione del fideiussore sia o meno identica
a quella dell’obbligato principale152. In altri
termini il problema è stabilire in che modo il
fideiussore garantisca l’adempimento
dell’obbligazione altrui.
152 Pone in tali termini il problema del contenuto
dell’obbligazione fideiussoria E. BRIGANTI, op. cit., p. 38.
141
Per risolvere siffatto interrogativo, va
innanzitutto precisato che, sulla base dei
risultati cui è pervenuta la teoria generale
delle obbligazioni153, per contenuto
dell’obbligazione s’intende la prestazione
teleologicamente preordinata al conseguimento
di quel bene, l’oggetto della prestazione, che
consente il soddisfacimento dell’interesse
creditorio.
Ciò che realizza l’interesse creditorio è
dunque il conseguimento dell’oggetto della
prestazione e non l’attività necessaria al suo
conseguimento, ossia la prestazione. Si deduce
che la soddisfazione del diritto del creditore
può avvenire anche senza la prestazione del
debitore, ma di un terzo, che, attraverso la
153 CICALA, concetto di divisibilità ed indivisibilità delle obbligazioni, Napoli, 1953,
p. 58 ss.
142
propria prestazione, faccia conseguire al
creditore il bene a cui questi ha interesse154.
Il fideiussore deve “adempiere” l’obbligazione di un terzo. Il
contenuto del suo obbligo dovrà pertanto essere
modellato su quello del debito principale.
Affermare che tra i due obblighi esista
un’identità assoluta sarebbe tuttavia errato.
Si è già detto che l’art. 1941, comma 2, cod.
civ., nell’affermare che può prestarsi
fideiussione per una parte soltanto del debito,
ammette che fideiussore e debitore principale
siano tenuti ad eseguire una prestazione
parzialmente diversa.
Il problema del contenuto dell’obbligazione
fideiussoria si è presentato in passato in
relazione all’ammissibilità della fideiussione
154 E. BRIGANTI, op. cit., p. 40.
143
a garanzia di debiti non pecuniari, sul
presupposto che, dovendo essere identica
l’obbligazione del fideiussore a quella del
debitore principale, la fideiussione dovesse
ritenersi ammissibile in relazione alle sole
obbligazioni pecuniarie, le uniche ritenute
fungibili155.
Contro tale tesi si è però evidenziato156, in
primo luogo, che l’assunto non può trovare
conferma nella lettera della legge, ossia nel
fatto che il legislatore si riferisca
all’adempimento dell’obbligazione fideiussoria
155 In tal senso, sotto la vigenza del codice civile abrogato:
REDENTI, Fideiussione, in Dizionario pratico del diritto privato, diretto da
Scialoja, De Ruggiero e Bonfante, III, Milano, 1923, p. 120 ss.;
BO, Fideiussione (dir. civ.), in Nuovo dig. it., V, Torino, 1938, p.
1114;vigente l’attuale codice civile: ARU, Della fideiussione, in
Comm. cod. civ. diretto da d’Amelio e Finzi, Libro delle obbligazioni, II,
2, Firenze, 1948, p. 337; BARBERO, Sistema istituzionale del diritto privato
italiano, II, Torino, 1949, p. 605.156 E. BRIGANTI, op. cit., p. 48 ss.
144
attraverso la locuzione pagamento del debito157 (ad
esempio nell’art. 1944 cod. civ.158), in quanto
il termine viene impiegato nell’accezione di
attività solutoria del debitore che adempie
l’obbligo; conferma siffatta prospettazione
l’uso promiscuo che il legislatore fa dei
termini adempimento e pagamento nell’ambito
della disciplina della solidarietà159.
Quanto poi al concetto di fungibilità,
riferendosi la nozione ai rapporti obbligatori
e non alle qualità naturali delle cose, meglio
è sembrato160 fondare il suo significato in157 Argomento, questo, ritenuto rilevante al fine di limitare la
fideiussione ai soli debiti di denaro da ARU, op. loc. ult. cit.158 Cfr. E. BRIGANTI, op. cit., p. 60. L’A. afferma che il
legislatore, statuendo che il fideiussore è obbligato in solido
con il debitore al pagamento del debito, ha semplicemente inteso
riferirsi all’ipotesi di esposizione debitoria più frequente nella
realtà sociale: le obbligazioni pecuniarie.159 Cfr. art. 1292 cod. civ., con gli art. 1296, 1299, 1310 comma 2
e 1312 cod. civ.160 ZARRELLI, Fungibilità ed infungibilità nell’obbligazione, Napoli, 1969, p.
36, p. 57; PERLINGIERI, Introduzione alla problematica della proprietà,
145
relazione alla funzione di soddisfacimento
dell’interesse del creditore, che la cosa
svolge nel rapporto obbligatorio. La res
andrebbe considerata fungibile o meno, secondo
che sia o meno equivalente ad altra ai fini del
soddisfacimento del diritto del creditore161.
Dunque anche cose oggettivamente infungibili
possono essere fungibili in un determinato
rapporto; è chiaro che si tratterà di un
problema, in alcuni casi non facile,
d’interpretazione della volontà negoziale;
occorrerà stabilire, in altri termini, se nel
concreto rapporto l’interesse del creditore
debba essere soddisfatto attraverso
l’attribuzione di uno specifico bene, oppure se
ai fini del soddisfacimento dell’interesse del
Camerino – Napoli, 1970, p.139; E. BRIGANTI, op. cit., p. 52.161 In tal senso A. e op. ult. cit., p. 53.
146
creditore vi siano più beni funzionalmente
equivalenti.
Questa distinzione tra prestazioni fungibili ed
infungibili, fondata non su elementi intrinseci
delle cose ma sull’elemento teleologico della
soddisfazione del creditore, si adatta anche
alle prestazioni di fare162, che sono
generalmente considerate in dottrina
infungibili, dato il carattere personale della
prestazione del debitore. Anche in relazione
alle prestazioni di fare, tuttavia,
l’individuazione delle prestazioni fungibili
non può che basarsi sulla considerazione
dell’interesse del creditore: se dev’essere
soddisfatto dall’oggetto della prestazione di
un determinato soggetto l’obbligazione è
162 ZARRELLI, Fungibilità ed infungibilità, cit. p. 91ss.
147
infungibile, viceversa la prestazione sarà
fungibile.
13. Segue: la fideiussione può essere prestata per garantire
l’adempimento di obbligazioni, non pecuniarie, di dare o
fare fungibili.
La tesi163 che ammette la fideiussione a
garanzia delle sole obbligazioni pecuniarie si
fonda sul seguente sillogismo: la fungibilità è
possibile soltanto tra obbligazioni pecuniarie;
l’obbligazione del fideiussore è fungibile
rispetto a quella del debitore principale, per
essere il primo tenuto alla medesima
prestazione del debitore principale; è
possibile stipulare una fideiussione solo a
garanzia di obbligazioni pecuniarie.
Si è visto, però, nel paragrafo precedente, che
la fungibilità dell’oggetto della prestazione163 Retro, nota bibliografica 141.
148
non è limitata ai debiti in denaro, per cui,
venendo meno la premessa maggiore
dell’argomentazione, non vi dovrebbe essere
ragione per escludere la possibilità di
stipulare una fideiussione a garanzia di
obbligazioni non pecuniarie164
A ben vedere, la limitazione del contenuto
dell’obbligazione fideiussoria a quello
pecuniario non risulta espressamente dalla
lettera della legge. Il legislatore nel
definire la nozione di fideiussore stabilisce,
all’art. 1936 cod. civ., che tale è <<colui che
obbligandosi personalmente verso il creditore
garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui>>,
senza specificare quindi di che natura debba
essere la prestazione a carico del garante165.164 MATTEUCCI, Solidarietà del fideiussore, cit., p. 1363 ss; RAVAZZONI, La
fideiussione, cit., p. 135. E. BRIGANTI, op. cit., p. 58.165 In tal senso E. BRIGANTI, op. cit., p. 59.
149
Per risolvere la questione circa il tipo di
prestazione cui può essere tenuto il
fideiussore sembra essere utile ragionare in
tal senso: la struttura dell’obbligazione
fideiussoria ricalca quella delle obbligazioni
in solido, talché si può applicare alla prima
la medesima disciplina prevista per la
solidarietà passiva166. Diventa allora decisivo
osservare che nelle obbligazioni in solido non
è necessario che l’esposizione debitoria dei
condebitori sia relativa ad un’obbligazione
pecuniaria, ma è sufficiente che si tratti di
obbligazione fungibile, di modo che si possa
dire che tutti gli obbligati siano tenuti alla
medesima prestazione167.
166 MATTEUCCI, op. cit., p. 1348. 167 MATTEUCCI, op. cit., p. 1343 ss; SALVESTRONI, La solidarietà
fideiussoria, Padova, 1977, p. 70 ss.; E. BRIGANTI, op. cit., p. 61.
150
La fungibilità può riscontrarsi, come si è
visto168, anche nelle obbligazioni di dare cose
fungibili (ad esempio beni diffusi nel settore
merceologico d’interesse), o di fare
“fungibile”, tenendo conto dall’attitudine
dell’interesse creditorio ad essere soddisfatto
dall’uno piuttosto che dall’altro oggetto della
prestazione; se ne deduce che l’obbligazione
fideiussoria, pur nascendo per lo più a
garanzia di debiti di denaro, potrà tuttavia
avere contenuto di dare o fare, purché
fungibili.
Per il caso che il fideiussore non adempia il
proprio obbligo, di contenuto “identico” a quello
principale, sarà, ai sensi dell’art. 2740 cod.
civ., tenuto a rispondere dell’inadempimento
con tutto il suo patrimonio, trasformandosi ora
168 V. retro, par. 11.
151
la sua obbligazione in risarcitoria. Si spiega
così perché l’art. 1943 cod. civ. prescriva che
il debitore, obbligato a dare un fideiussore,
debba presentare una persona che abbia beni
sufficienti a garantire l’adempimento
dell’obbligazione. Il legislatore si riferisce
qui alle conseguenze dell’inadempimento del
fideiussore che, ex art 2740 cod. civ.,
ricadranno sul suo patrimonio, secondo il
principio della responsabilità patrimoniale.
Nei paragrafi precedenti169 si è visto che la
funzione di garanzia propria della fideiussione
si realizza attraverso una duplicazione
soggettiva del vincolo obbligatorio170, ossia
mediante l’aggiunta alla preesistente
obbligazione di un altro rapporto obbligatorio,
169 V. retro, in particolare par. 3.170 DI SABATO, L’assuntore del concordato fallimentare, cit., p.46
152
che rafforza l’aspettativa creditoria di
ottenere l’estinzione satisfattoria della prima.
Possiamo ora aggiungere che identica funzione
esplicherà la fideiussione prestata a garanzia
dell’adempimento dell’obbligazione avente ad
oggetto una prestazione di dare o fare
fungibili. Anche per tal caso, il creditore,
che non abbia interesse a che il debitore
esegua personalmente l’obbligazione (art. 1180
cod. civ.), potrà conseguire quanto gli è
dovuto dall’uno o dall’altro coobbligato,
realizzandosi, pertanto, la funzione tipica
della fideiussione di garantire l’altrui
adempimento.
153
14. Segue: è possibile prestare una “fideiussione” a
garanzia dell’adempimento di obbligazioni aventi ad
oggetto prestazioni infungibili? La struttura solidale
dell’obbligazione fideiussoria chiarisce la modalità
attraverso cui il fideiussore “garantisce l’adempimento
dell’altrui obbligazione”.
Occorre ora considerare se sia possibile
rilasciare una fideiussione a garanzia
dell’adempimento di un’obbligazione altrui,
avente ad oggetto una prestazione (di dare o
fare) infungibile.
Taluni autori171, alla luce della lettera
dell’art. 1936 cod. civ. - che si riferisce in
maniera molto generica alla garanzia
dell’adempimento dell’obbligazione altrui - ,
rispondono affermativamente al quesito,
171 Tra gli altri, M. FRAGALI, op. cit., p. 357; BARBERO, Sistema
istituzionale, II, cit., p. 658.
154
sostenendo che in siffatta ipotesi
<<l’obbligazione infungibile verrebbe garantita
mediante la prestazione di quell’id quod interest
che è ugualmente dovuto dal debitore>>172: il
risarcimento del danno. In altri termini,
quando la prestazione dovuta sia infungibile,
la fideiussione produrrebbe, in capo al
fideiussore, un’assunzione di responsabilità
per un debito altrui, cui si affianca, in
previsione dell’inadempimento, un debito
sussidiario di risarcimento. Così ragionando,
tuttavia, si esclude che il debitore principale
ed il fideiussore siano obbligati in solido, e
pertanto tenuti all’adempimento della medesima
prestazione (ex art. 1292 cod. civ.).
È agevole notare, di contro, che l’art. 1944
cod. civ. prevede il regime di solidarietà
172 L’espressione è di M. FRAGALI, op. loc. ult. cit.
155
passiva tra l’obbligazione fideiussoria e
quella del debitore principale; la natura
solidale dell’obbligo che grava sul fideiussore
chiarisce, così, la modalità attraverso cui
questi “garantisce l’adempimento
dell’obbligazione altrui”: costui si obbliga ad
adempiere un debito “identico” a quello cui è tenuto
il debitore principale, o, detto altrimenti, un
debito il cui contenuto è determinato per
relationem a quello principale.
La generica funzione di garanzia della
fideiussione si specifica, pertanto, attraverso
il riferimento al contenuto dell’obbligazione
assunta dal fideiussore: costui, essendo
obbligato in solido con il debitore principale,
è tenuto ad eseguire la “medesima” prestazione
del debitore principale e non a riparare le
156
conseguenze dell’inadempimento. In altri
termini il fideiussore garantisce,
conformemente a quanto prescrive l’art. 1936
cod. civ., <<l’adempimento dell’altrui
obbligazione>>, non la riparazione delle
conseguenze dell’inadempimento173.
Al fine di consentire il rilascio di una
fideiussione a garanzia dell’adempimento di una
prestazione infungibile, si è sostenuto,
richiamando l’art. 1938 cod. civ., che, per
siffatta ipotesi, il fideiussore garantisce
l’adempimento dell’obbligazione futura ed
eventuale del debitore principale, avente ad
oggetto il risarcimento dei danni da
173 Cfr. E. BRIGANTI, op. cit., p. 66 ss. L’ordinamento tedesco, a
differenza di quello italiano, riconosce alla fideiussione la
funzione di garantire il risarcimento del danno da inadempimento;
in tal contesto normativo la fideiussione genera una
responsabilità per debito altrui: v. F. NAPPI, La garanzia autonoma,
profili sistematici, Napoli, 1992, p. 25 e 29.
157
inadempimento174. L’obbligo del fideiussore
sarebbe, pertanto, sospensivamente condizionato
all’inadempimento di quello principale.
Verificatosi detto evento, il creditore
potrebbe pretendere l’adempimento
dell’obbligazione pecuniaria di risarcimento
sia dal debitore che dal fideiussore,
risultandone rafforzata l’aspettativa
creditoria di soddisfazione del suo diritto al
risarcimento dei danni. In sostanza la
fideiussione esplicherebbe ora la funzione di
garantire l’adempimento dell’obbligazione
risarcitoria.
Che una forma atipica di garanzia personale,
possa esplicare la funzione da ultimo descritta
174 M. FRAGALI, Fideiussione – Mandato di credito, cit., p. 71, 79 e 98;
ARU, Della fideiussione, cit., p. 386; BO, Fideiussione, cit., p. 1114.
158
è fuor di dubbio175. La questione da chiarire,
tuttavia, è se siffatta finalità risarcitoria
possa essere perseguita anche attraverso la
fideiussione. Al riguardo possono prospettarsi
due ordini di considerazioni: a) la
fideiussione, prestata per l’obbligazione
avente ad oggetto una prestazione infungibile,
non comporta maggiore sicurezza circa il
soddisfacimento dell’interesse creditorio
dedotto nell’obbligazione principale, in quanto
quest’ultimo può essere soddisfatto soltanto
attraverso l’esecuzione della prestazione
(infungibile) da parte del debitore principale,
per cui il fideiussore non potrebbe “garantire
l’adempimento” dell’altrui obbligazione; b) il
meccanismo della solidarietà, che normalmente
175 Vedremo nei capitoli successivi che talune figure contrattuali
tipiche (promessa del fatto del terzo) ed atipiche di garanzia
esplicano proprio tal funzione “successiva indennitaria”.
159
consegue alla conclusione di un contratto di
fideiussione, quando cioè non sia stato
espressamente pattuito il beneficio di
escussione del debitore principale, dovrebbe
comportare che il creditore, dal momento in cui
il credito è esigibile, possa esigere,
indifferentemente, l’adempimento della
prestazione dal debitore o dal fideiussore;
siffatta possibilità resta necessariamente
esclusa quando la prestazione oggetto
dell’obbligazione principale è infungibile176.
Sulla base di tali considerazioni, per il caso
della garanzia prestata per obbligazioni aventi
ad oggetto prestazioni infungibili, si è
prospettata177 la configurazione di una figura176 Cfr. sull’argomento E. BRIGANTI, op. cit., p. 71 ss.177 RAVAZZONI, La fideiussione, cit., p. 133, secondo cui si
tratterebbe di una figura di garanzia ravvicinabile, per taluni
aspetti, alla fideiussione, per altri, al contratto
d’assicurazione; la prospettazione è ad oggi seguita dalla
160
atipica di garanzia, la cui funzione è
succedanea, secondaria ed autonoma rispetto
all’obbligo primario del debitore principale di
eseguire la prestazione infungibile.
15. La c.d. fideiussio indemnitatis: fattispecie di
garanzia la cui funzione è succedanea, ma anche autonoma
rispetto all’obbligo primario di prestazione, in quanto
preordinata ad “assicurare” il risarcimento del danno
dovuto dal debitore per l’inadempimento del debito
principale.
Si è visto che con l’assunzione
dell’obbligazione il fideiussore garantisce,
personalmente, l’adempimento dell’obbligazione
del debitore principale, diventando anch’egli
obbligato ad eseguire un obbligo, che, quanto
dottrina e giurisprudenza maggioritarie: in dottrina, tra gli
altri,. E. BRIGANTI, op. cit., p. 72 ss.; in giurisprudenza v. la
recentissima Cass., Sez. Unite, 18 febbraio 2010, n. 3947, in
allegato al presente studio, p. 56 ss.
161
al contenuto, ricalca quello principale.
L’insostituibilità della prestazione del
debitore, ossia la sua infungibilità, comporta,
invece, che per il suo inadempimento il
creditore potrà pretendere dal garante solo una
prestazione (necessariamente) diversa da quella del
debitore principale, consistente in una somma
di denaro a titolo d’indennizzo satisfattivo178.
Si richiama al riguardo la fattispecie della
c.d. fideiussio indemnitatis179, figura già nota al
diritto romano, storicamente nata dalla
necessità di porre il creditore al riparo
dall’efficacia estintiva dell’obbligazione che
178 Cfr. Cass. 24 gennaio 1986, n. 466, in Dir. fall., 1986, II, p.
546, secondo cui la fideiussione prestata a garanzia del debito
dell’appaltatore si traduce nell’obbligo di far fronte al
risarcimento del danno e alla restituzione della controprestazione
già pagata.179 Sull’argomento BO, Contributo alla dottrina dell’obbligazione fideiussoria,
Milano, 1934, p. 77 ss.; RAVAZZONI, La fideiussione, cit., p. 192 ss.;
FRAGALI, Fideiussione – Mandato di credito, cit., p. 99.
162
aveva la litis contestatio nel diritto romano
classico, talché, convenuto in giudizio il
debitore, si estingueva l’obbligazione
principale e, pertanto, restava liberato anche
il fideiussor180.
La locuzione fideiussio indemnitatis individua il
contratto attraverso cui il fideiussore
s’impegna a pagare, dopo l’escussione automatica del
debitore principale, la somma ancora dovuta a saldo
dal debitore, oppure l’integrale indennizzo per
l’inadempienza di esso181. Il garante assume,180 Il rilievo storico è di E. BRIGANTI, op. cit., p. 73. Cfr. BO, op.
loc. ult. cit.181 Così E. BRIGANTI, op. cit., p. 72. Si è discusso in dottrina se
la fattispecie negoziale di garanzia dovesse essere riferita ad
ambedue le ipotesi riportate nel testo. Propende per tale tesi BO,
Contributo, cit., p. 84 ss.; contra RAVAZZONI, La fideiussione, cit., p.
194, secondo cui la fideiussio indemnitatis andrebbe riferita solo
all’ipotesi in cui il garante s’impegni a pagare l’integrale
indennizzo per l’inadempimento dell’obbligo principale; per il
caso che il garante s’impegni a pagare solo la somma ancora dovuta
a saldo dal debitore, a seguito dell’infruttuosa escussione,
dovrebbe parlarsi di fideiussione con beneficio automatico di
escussione. L’assunto sembra tuttavia da rigettare, poiché nel
163
pertanto, nei confronti del creditore
beneficiario, l’obbligo di tenerlo indenne,
mediante pagamento di un determinato importo,
dalle conseguenze derivanti dall’inadempimento
della prestazione a lui dovuta dal fideiuvato.
La fideiussio indemnitatis si distingue
dall’ordinaria tipica fideiussione in quanto
oggetto dell’obbligazione principale è una
prestazione infungibile (spesso la garanzia è
assunta, a presidio dell’esatta esecuzione
della prestazione dell’appaltatore, nella forma
della polizza fideiussoria182).
nostro ordinamento il beneficio di escussione dovrebbe operare
solo se espressamente pattuito.182 In tal senso Cass., Sez. Unite, 18 febbraio 2010, n. 3947, cit.,
p. 57 ss. Rileva la S. C., confermando un consolidato indirizzo
interpretativo, che si discorre di fideiussio indemnitatis con
riferimento a fattispecie di garanzia la cui funzione è
succedanea, ma anche autonoma rispetto all’obbligo primario di
prestazione, in quanto preordinata ad “assicurare” il risarcimento
del danno dovuto dal debitore per l’inadempimento del debito
principale. L’adempimento garantito, per tal verso, non è quello
dell’obbligazione cui è originariamente tenuto il debitore
164
L’insostituibilità della prestazione del
debitore comporta che, in caso di suo
inadempimento, il creditore possa pretendere
dal garante solo una prestazione
(necessariamente) diversa da quella del
debitore principale, consistente in una somma
di denaro a titolo d’indennizzo satisfattivo.
Tale garanzia ha, rispetto alla fideiussione
tipica, carattere indefettibilmente sussidiario,
presupponendo la preventiva, infruttuosa
escussione del debitore principale, che non
dovrà essere chiesta dal fideiussore e limitata
principale (ad esempio l’esecuzione dei lavori dell’appaltatore),
bensì quello dell’obbligazione futura ed eventuale del
risarcimento del danno, con la conseguenza che l’obbligazione del
garante diviene attuale solo a seguito dell’inadempimento
dell’obbligazione principale. La descritta funzione reintegratoria
della garanzia, aggiunge la S. C., pregiudica <<quel meccanismo
della solidarietà, che attribuisce al creditore la libera electio,
cioè la possibilità di chiedere l’adempimento così al debitore,
come al fideiussore>>, con conseguente espunzione della garanzia
de quo <<dall’orbita della garanzia fideiussoria>>, che ha la
diversa funzione di garantire preventivamente l’adempimento.
165
ai beni da questo indicati, ma è presupposto
dell’escussione del fideiussore e deve
riguardare tutto il patrimonio del debitore183.
Da quanto esposto si evidenzia che la generica
funzione di garanzia si specifica, nella figura
di cui si discorre, attraverso l’esecuzione, da
parte del garante, di una prestazione di tipo
indennitario, che “assicura” al beneficiario di
essere “manlevato” dalle conseguenze
dell’inadempimento del debitore principale. Ne
consegue che la fideiussio indemnitatis è estranea
all'area delle garanzie di tipo satisfattorio
prestate a presidio dell’adempimento di
prestazioni fungibili, caratterizzate dall'identità
della prestazione, dal vincolo della solidarietà e
dall'accessorietà, e riconducibile invece all'area
delle garanzie di tipo indennitario, nelle quali il183 Così, testualmente, M. FRAGALI, Fideiussione – Mandato di credito,
cit., p. 99.
166
garante non è tenuto ad eseguire la prestazione
mancata, bensì ad indennizzare il creditore
insoddisfatto.
16. Segue: la promessa del fatto del terzo come possibile
garanzia dell’obbligazione a contenuto infungibile.
Si è visto nel paragrafo precedente che, se sia
prestata una fideiussio indemnitatis, l’obbligazione
del garante è sospensivamente condizionata
all’infruttuosa escussione del patrimonio del
debitore principale.
Un Autore184 ha sagacemente osservato che tale
forma di garanzia non coincide perfettamente
con la garanzia dell’obbligazione a contenuto
infungibile185, perché il fideiussor indemnitatis non
è direttamente obbligato a risarcire, in solido184 E. BRIGANTI, op. cit., p. 74.185 Così, testualmente, A. e op. loc. ult. cit.
167
con il debitore principale, il danno da
inadempimento della prestazione infungibile, ma
è obbligato sub condicione inutilis excussionis.
In altri termini, secondo il citato Autore,
bisognerebbe distinguere tra: a) garanzia
dell’obbligazione a contenuto infungibile, in
cui il fideiussore è obbligato direttamente al
risarcimento del danno, data la natura
infungibile della prestazione, e b) fideiussio
indemnitatis, sulla cui base il garante non è
obbligato ab initio al risarcimento del danno, ma
solo in conseguenza dell’infruttuosa escussione
del patrimonio del debitore principale, che non
consenta al garante, in tutto o in parte, di
ricevere soddisfazione del proprio credito.
Ricostruendo la fattispecie della promessa del
fatto del terzo (art. 1381 cod. civ.) in una
168
prospettiva diversa da quella proposta dalla
dottrina e giurisprudenza maggioritarie186, l’A.
in parola ravvisa nella menzionata fattispecie
negoziale lo strumento possibile di una
garanzia indennitaria187.
La promessa del fatto del terzo svolgerebbe
anch’essa una funzione di garanzia, consistente
nella riparazione successiva del danno188.
186 Prescindendo dalle opinioni secondo cui il promittente assume
un obbligo di fare, di procurare il fatto altrui, o di pagare
l’indennità (su cui vedi par. 6, 7, 8, del capitolo secondo del
presente studio), anche quegli autori che hanno ravvisato nella
promessa l’assunzione di un obbligo di garanzia, hanno
sottolineato, poi, che la fattispecie negoziale in parola non
presuppone l’esistenza di un’obbligazione principale da garantire
(così, testualmente, SCALFI, La promessa del fatto del terzo, Milano –
Varese, 1955, p. 100; in senso analogo STASI, Promessa
dell’obbligazione o del fatto del terzo, in Nss. dig. it., XIV, 1967, p. 73), con
la conseguenza che l’obbligo assunto dal promittente (di garanzia
solo in senso lato) deve considerarsi strutturalmente autonomo,
ossia non accessorio ad altra obbligazione principale di cui si
voglia garantire l’adempimento.187 E. BRIGANTI, op. cit., p. 192 ss.188 A. e op. ult. cit., p. 193.
169
Ove la prestazione sia infungibile, infatti, il
creditore non potrà garantirsi l’adempimento,
chiedendo il rilascio di una fideiussione, dato
che la prestazione dovrà essere necessariamente
eseguita dal debitore principale; in siffatta
ipotesi, però, al creditore potrà essere
“assicurato” il risarcimento del danno, per
l’eventualità dell’inadempimento dell’obbligo
principale189. In ciò consisterebbe la funzione
di garanzia della promessa del fatto del terzo.
In questa sede non resta che rinviare al
capitolo successivo del presente lavoro per
un’analisi approfondita della fattispecie qui
richiamata.
17. Conclusioni del capitolo primo.
Le figure di garanzia contemplate dal nostro
codice civile hanno un’indiscutibile189 E. BRIGANTI, op. cit., p. 195.
170
caratterizzazione omogenea, consistente nel
generare diritti soggettivi accessori al
credito (garantito). Discende da ciò un intenso
collegamento tra il diritto di credito, di cui
s’intende assicurare l’adempimento, ed il
diritto di garanzia preordinato a tale scopo.
Tra gli strumenti apprestati dall’ordinamento a
garanzia della soddisfazione del credito, il
legislatore contempla e disciplina puntualmente
l’istituto della fideiussione, che costituisce,
tanto nella prassi quanto nella teoria del
diritto, una delle più antiche forme di tutela
delle ragioni creditorie, nonché l’exemplum da
cui originano le più recenti manifestazioni
atipiche di garanzia (contratto autonomo,
polizze fideiussorie e lettere di patronage).
171
Il contratto di fideiussione dà luogo ad un
vincolo di solidarietà passiva tra il debitore
principale ed il fideiussore, espressamente
previsto dall’art. 1944 cod. civ., con la
conseguenza che il creditore potrà rivolgersi
direttamente al fideiussore per esigere la
prestazione dovuta, salvo che sia stato
convenuto l’onere del creditore di escutere
preventivamente il debitore principale.
La conclusione, com’è noto, è discussa, in
quanto si ritiene che al debitore principale,
proprio per essere tale, va domandato per primo
l’adempimento; o, se anche si volesse escludere
il beneficium ordinis a favore del fideiussore, per
costui vi sarebbe pur sempre una semplice
“sussidiarietà”190. Perciò garante e garantito190Cfr. B. GRASSO, Saggi, Napoli 2001, spec. p. 205; G. CAMPOBASSO,
Coobbligazione cambiaria e solidarietà diseguale, p. 306 s., 309, secondo cui
l’obbligato solidale in veste di garante è obbligato sussidiario,
nel senso che potrà essere costretto all’adempimento solo in
172
non stanno sullo stesso piano – con la
conseguenza della libera electio del creditore – ma
su piani diversi. Il debitore originario è
principale, il fideiussore risponde se costui
non adempie e solo per quest’ipotesi, onde la
non uguaglianza dei due verso il creditore,
tenuto ad “agire” comunque prima verso il
debitore principale, giacché il garante “sta dietro a
costui” ove mai si verifichi l’inadempimento del
primo (quale che sia poi la qualificazione che
s’intenda riconoscere a tale “star dietro” del
fideiussore rispetto al debitore principale).
seguito al rifiuto dell’obbligato principale; F. D. BUSNELLI,
L’obbligazione soggettivamente complessa, Milano 1974, osserva che per
aversi solidarietà pura occorre un “vincolo di comunione”
d’interessi che nella fideiussione non v’è (nota 68, p. 39); che
il 1294 “non allude genericamente a tutti i possibili collegamenti
fra più debitori tenuti in solido anche se non per la stessa
causa” (p. 90); nella fideiussione v’è soltanto un “vincolo tra
più obbligazioni semplicemente connesse” (p. 124).
173
La natura solidale dell’obbligazione
fideiussoria chiarisce la modalità attraverso
cui si esplica la funzione di garanzia propria
del negozio fideiussorio: il fideiussore è
tenuto ad eseguire una prestazione fungibile
rispetto a quella principale, con l’effetto di
aumentare le possibilità di estinzione
satisfattiva del diritto di credito.
Poiché il fideiussore garantisce “l’adempimento
dell’altrui obbligazione” (art. 1936 cod.
civ.), il contratto di garanzia dovrà fondarsi
su di un valido ed efficace rapporto
obbligatorio, costituendo pertanto attributo
costante del negozio in parola la sua
accessorietà genetica e funzionale al rapporto
principale.
Il fideiussore che abbia pagato avrà diritto
sempre all’azione di regresso verso il debitore
174
principale, istituto questo che assicura che il
peso economico del debito transiti dalla sfera
patrimoniale del garante, per andarsi a
radicare su quello del debitore principale.
Accessorietà, solidarietà del vincolo
fideiussorio e circolarità dell’attribuzione
patrimoniale, assicurata tramite l’esercizio
del diritto di regresso riconosciuto al
fideiussore che abbia pagato, sono i tratti
caratteristici della fideiussione, che può
essere definita come garanzia preventiva – satisfattoria
del credito. Tale definizione descrive la funzione
del negozio di rafforzare l’aspettativa di
soddisfazione del credito, attraverso la
duplicazione dei soggetti tenuti
all’adempimento dell’obbligo.
175
SOMMARIO: 1. La fattispecie denominata “promessa del fatto del terzo”
(art. 1381 cod. civ.) va ricondotta al principio d’inefficacia del contratto
rispetto ai terzi. - 2. Contrattualità della promessa. - 3. Segue: promessa
come frammento di fattispecie. - 4. Segue: promessa come contratto
autonomo. - 5. Dalla previsione dell’art. 1129 dell’abrogato codice alla
formulazione attuale (art. 1381). - 6. I problemi posti dalla natura
dell’obbligazione assunta dal promittente. Le soluzioni proposte in
dottrina e in giurisprudenza. - 7.Segue: la tesi secondo cui il promittente
assume un obbligo di facere, nell’accezione di adoperarsi affinché il terzo
esegua il fatto promesso. - 8. Segue: l’opinione secondo cui il promittente
assume l’obbligo di procurare l’esecuzione del fatto altrui. - 9. Segue:
l’insegnamento secondo cui il promittente assume l’obbligo di pagare
l’indennità, sospensivamente condizionato al rifiuto del terzo. - 10. Segue:
il promittente assume una obbligazione di garanzia? - 11. Critiche verso la
natura di garanzia dell’obbligazione che il promittente assume. -
12.Segue: critiche alla possibilità di configurare la promessa come
contratto con causa di garanzia. - 13. Segue: critica alla configurazione di
un contratto con causa generica costante e causa specifica variabile. - 14.
Rigetto della nozione di causa – funzione di garanzia applicabile alla
promessa e individuazione del profilo causale della promessa nel casi in
cui essa non s’innesti in un più ampio regolamento negoziale. - 15.
Orientamento della Cassazione: duplice obbligazione a carico di chi
promette il fatto del terzo. - 16. Natura dell’obbligo del pagamento
dell’indennizzo: tra autonomia ed equivalenza con il risarcimento. - 17.
Questioni in tema d’indennizzo. - 18. L’obbligo del pagamento
dell’indennizzo non esclude che il promittente debba rispondere per
illecito contrattuale e sia tenuto al risarcimento del danno. - 19. Segue:
177
prova del danno. - 20. Considerazioni sul significato del rischio assunto
dal promittente. - 21. Analisi della funzione restitutoria del pagamento
dell’indennizzo. - 22. Gratuità e onerosità della promessa. Promessa del
fatto del terzo e accordo di cortesia. - 23. Forma della promessa. - 24.
Conclusioni del capitolo secondo.
178
1. La fattispecie denominata “promessa del fatto del terzo”
(art. 1381 cod. civ.) va ricondotta al principio d’inefficacia
del contratto rispetto ai terzi.
L’art. 1381 cod. civ. dispone: <<colui che ha
promesso l’obbligazione o il fatto del terzo è
tenuto ad indennizzare l’altro contraente, se
il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il
fatto promesso>>. La norma citata contempla la
fattispecie secondo cui un soggetto
(promittente) promette ad un altro
(promissario) l’assunzione di un’obbligazione o
il compimento di un fatto da parte di un terzo;
se costui rifiuta di obbligarsi o non compie il
fatto promesso, il promittente è tenuto ad
indennizzare il promissario.
In dottrina e in giurisprudenza sono state
prospettate soluzioni interpretative diverse
179
quanto alla natura dell’operazione negoziale e
dell’obbligazione assunta dal promittente.
L’inserimento della norma nel codice civile del
1942 (e prima ancora in quello del 1865) ha
permesso di superare de iure condito le perplessità
sulla validità ed efficacia della promessa191,
fondate sull’impossibilità di questa di
vincolare il terzo, poiché costui è soggetto
estraneo alla conclusione della “promessa”. In
dottrina si era però rilevato che essa è atto
di disposizione di un interesse del
promittente, il quale ultimo soltanto
vincola192. In ogni caso con la riproposizione
della norma il legislatore del 1942 ha
191 STOLFI, La promessa del fatto di un terzo, in Riv. dir. comm., 1927, I, p.
203 ss.192 SCALFI, La promessa del fatto del terzo, Milano - Varese, 1955, p. 31
ss.
180
definitivamente sancito la validità della
figura193.
La promessa del fatto del terzo non deroga al
principio degli effetti contrattuali limitati
alle parti194, consacrato nell’art. 1372, comma
2, secondo cui <<il contratto non produce
effetti rispetto ai terzi, che nei casi
previsti dalla legge>>. Nessun effetto discende
infatti per il terzo dalla promessa, la sua
sfera giuridica non è colpita da una situazione
passiva attraverso un atto unilaterale di
volontà del promittente. L’obbligazione
nascente dalla promessa è vincolante solo per
costui, su cui grava l’onere d’indennizzare il
contraente se il terzo non faccia quanto da lui
193 F. ALCARO, Promessa del fatto del terzo, in Enc. dir. XXXVII, s.d., ma
Milano 1988, p. 70.194 E. BRIGANTI, Fideiussione e promessa del fatto del terzo, Napoli 1981, p.
84.
181
promesso. In dottrina si parla di “contratto
indifferente rispetto al terzo”195.
Del resto è da considerare che la fattispecie
della promessa del fatto del terzo non può
ricondursi alla deroga del principio della
relatività degli effetti contrattuali,
contemplata nella parte finale del secondo
comma dell’art. 1372. Il principio
dell’inefficacia del contratto rispetto ai
terzi riguarda, come insegnato da autorevole
dottrina196, quei contratti che producono
effetti sfavorevoli o non solamente favorevoli
per il terzo. L’eccezione si riferisce quindi
ai casi in cui il legislatore consente, in via
straordinaria, che un contratto produca effetti
195 CARRESI, Corso di diritto civile sul contratto, Bologna, 1961, p. 399.196 DONISI, Il problema dei negozi giuridici unilaterali, Napoli, 1972, p. 68
ss., p. 86 ss., p. 96 ss.; CICALA, L’adempimento indiretto del debito
altrui, cit. p. 184, nota 223.
182
non favorevoli a carico di chi non ne è parte.
Orbene la fattispecie della promessa del fatto
del terzo non può ricondursi all’alveo di tale
deroga, proprio perché essa non tocca in alcun
modo la sfera giuridica del terzo estraneo alla
promessa.
Esclusa, quindi, qualsiasi interferenza tra il
rapporto promittente - promissario e la
posizione del terzo, rimangono una serie
d’interrogativi circa l’inquadramento giuridico
della fattispecie, nodi che ruotano intorno
all’individuazione del collegamento che
s’instaura tra la promessa del promittente, il
fatto del terzo che si è promesso e l’obbligo
eventuale del promittente di pagare
l’indennizzo.
183
Prima di analizzare singolarmente le singole
questioni, si affronta il tema della
contrattualità del negozio promissorio, che
costituisce un prius logico rispetto alle
rilevanti problematiche sollevate dall’istituto
in esame: a) quale fatto del terzo si può
promettere; b) che natura ha l’obbligazione
assunta dal promittente; c) quali sono i
requisiti del contratto de quo, ossia la sua
causa, oggetto e forma; d) qual è la funzione
assolta dal pagamento dell’indennizzo.
2. Contrattualità della promessa.
Nonostante il legislatore parli di “promessa”,
dottrina e giurisprudenza sono concordi nel
qualificare come contratto quello che
intercorre tra promittente e promissario, per
cui l’obbligo del promittente nasce
184
dall’accettazione del promissario, secondo la
norma generale (art. 1326 cod. civ.). In taluni
casi, come vedremo, la promessa si presenta
come un frammento di altra fattispecie
contrattuale.
A riprova della natura contrattuale della
fattispecie in esame vi è un duplice dato:
l’art. 1381 cod. civ., che disciplina la nostra
figura, è inserito nel capo quinto del titolo
secondo del libro quarto, dedicato agli effetti
del contratto; la lettera stessa dell’articolo
fa riferimento all’obbligo del promittente di
indennizzare “l’altro contraente”.
Ne consegue, contrariamente a quanto ritenuto
da datata dottrina, che la promessa del fatto
del terzo non potrà farsi per testamento197,
perché la fattispecie tipica prevista dall’art.197 SCALFI, Promessa del fatto del terzo, cit., p. 81.
185
1381 non è così congegnata. Una tale promessa
si configurerebbe alla stregua di una promessa
unilaterale di una prestazione, ponendosi di
conseguenza il problema dell’efficacia
obbligatoria della stessa, sulla base della
regola enunciata nell’art. 1987 cod. civ.
Inoltre qualora il terzo rifiutasse,
l’indennizzo dovrebbe essere pagato dall’erede,
con alterazione conseguente del meccanismo
tipico previsto dall’art. 1381, e non sembra
che un tal effetto possa configurarsi in
assenza di una specifica previsione di legge.
Si è anche sostenuto in dottrina198, però, che
diversa è l’ipotesi in cui il promittente dopo
aver fatto la promessa muore; se il fatto non
si verifica, l’erede deve pagare l’indennizzo.
198 F. ALCARO, Promessa del fatto del terzo, in Enc. dir., XXXVII, s.d., ma
Milano 1988, p. 78.
186
Secondo l’insegnamento in parola l’elemento che
differenzia le due ipotesi è l’elemento
genetico della promessa, la quale è valida ed
efficace, in questo caso, perché nata ex contractu
e non ex testamento.
Chiarita la natura contrattuale, è da
aggiungere che la promessa del fatto del terzo
potrà presentarsi nella concreta realtà sia
come contratto autonomo, che come un “frammento
di fattispecie” di un più ampio regolamento
d’interessi che intercorre tra le parti
medesime. Per cogliere le differenze tra queste
ipotesi è necessario procedere ad un esame dei
casi che si sono presentati all’attenzione
della giurisprudenza.
187
3. Segue: promessa come frammento di fattispecie.
Com’è stato rilevato in dottrina199, le ragioni
di fatto per cui un soggetto promette il fatto
di un terzo sono sostanzialmente due:
a) La prima consiste in ciò, che “il
promittente si trova in una situazione di
potere, di controllo giuridico o di fatto,
rispetto al terzo di cui promette il fatto o
l’obbligazione”, o ancora ricorre semplicemente
un rapporto giuridico o di fatto tra
promittente e terzo”. Esempi di tale rapporto
si sono posti all’attenzione della
giurisprudenza. Si ricordino in primo luogo
alcune ipotesi di patronage c. d. forte, dove
tra il promittente e il terzo esiste un
rapporto di società controllante e controllata.199 SACCO, Il contratto, in Trattato di diritto civile italiano, diretto da
Vassalli, VI, t. 2°, Torino, 1975, I, 500 ss.; M.R. MARELLA,
Promessa del fatto del terzo, in Dig. disc. priv, XV, Torino, 1997, p. 384.
188
Ma si rinvia questo argomento al capitolo
terzo. Altri esempi sono il caso
dell’associazione di coltivatori che promette
ad un proprio affiliato l’offerta di un posto
di lavoro da parte di un’organizzazione o un
ente da essa stessa controllati200, o ancora il
caso della finanziaria che promette ad una rete
televisiva la raccolta di un certo numero di
contratti pubblicitari ad opera della
concessionaria di pubblicità da essa
controllata201.
b) La seconda ragione per cui il promittente
promette il fatto del terzo è quella d’indurre
il contraente ad una stipulazione. La promessa
serve in tal ipotesi a far apparire più
interessante al contraente promissario un certo
200 Cass., sez. lav., 21 giugno 1991, n. 6984, in Rep Foro it., 1991. 201 Trib. Monza, 6 febbraio 1989, in Rep. Foro it., 1989, primo, 3219.
189
affare economico. Valga l’esempio classico del
venditore di un appartamento che promette al
compratore la cessione della terrazza attigua
da parte del legittimo proprietario202, o ancora
il caso in cui il contraente induce la
controparte a cedere tutte le azioni di una
società costruttrice che detiene, in cambio
della promessa che la società medesima gli
cederà 20 appartamenti203.
Nelle ipotesi in cui la promessa ha la funzione
d’indurre il contraente alla conclusione di un
certo affare emerge la sua natura di “frammento
di fattispecie”, in quanto essa afferisce ad un
più ampio regolamento d’interessi. Qui la
promessa s’inserisce in un più vasto programma
202 Trib. Urbino, 3 marzo 1952, in Rep. Foro it., 1953, primo, p. 722.203 Trib. Venezia, 8 luglio 1991, in Foro it., 1992.
190
negoziale e si pone come corrispettivo della
prestazione dovuta dal promissario.
In dottrina si parla, per tal caso, di
contratto misto o collegato, avendo tuttavia i
due termini una diversa funzione descrittiva,
per riferirsi, il primo, alla natura della
controprestazione cui è tenuto il promissario,
il secondo, alla relazione funzionale che
sussiste tra la promessa e la
controprestazione. Il contratto misto ricorre quando
la promessa viene fatta verso una
controprestazione, che è elemento di altra
fattispecie contrattuale204. Tale
controprestazione potrà consistere in un dare,
in un fare o non fare, così come potrà
consistere in un’altra promessa del fatto del
terzo. Un esempio di detta ultima ipotesi è il
204 SCALFI, op. cit., p. 81. STASI, op. cit., p. 71
191
caso in cui le parti si promettano
reciprocamente l’obbligazione di terzi di
vendere beni, di cui essi terzi sono
proprietari205.
Per quanto riguarda la promessa collegata ad altro
contratto, una parte della dottrina ne ravvisa
l’esistenza anche quando “il contratto di promessa
costituisca il corrispettivo della conclusione di
altro contratto” 206 e si fa l’esempio di Tizio che
loca a Caio un immobile urbano e Caio gli
promette che Sempronio gli alienerà un muro di
confine del giardino.
La seconda ipotesi (certa) di promessa collegata ad altra
fattispecie negoziale si ha quando essa non
costituisca il corrispettivo di una diversa
prestazione contrattuale, ma influenzi il contenuto
205 STASI, op. cit. p. 71, con un riferimento ad un caso
giurisprudenziale.206 SCALFI, op. cit., p. 82.
192
del contratto a cui si collega; si fa l’esempio
di Tizio che vende a Caio un immobile ad un
prezzo superiore al valore di mercato, previa
promessa che Sempronio gli venderà anche il
proprio appezzamento di terreno confinante,
acquisendo così l’immobile oggetto del
contratto un valore maggiore207.
Secondo una diversa prospettazione208 l’ipotesi
della promessa collegata ad altra fattispecie
non ricorre quando essa costituisca il
corrispettivo per la stipulazione di un diverso
contratto (come accade invece nel primo esempio
riferito). Si afferma che quando la promessa si
atteggia come controprestazione si rientra nell’ipotesi del
contratto misto, ossia un “contratto unitario
anche se strutturalmente complesso”, in quanto
ciascuna prestazione trova la propria207 A. e op. loc. ult. cit.208 STASI, op. cit., p. 71 ss.
193
giustificazione nella controprestazione
dell’altro contraente.
L’ipotesi del contratto collegato, secondo la
dottrina in parola, ricorrerà solo quando la
promessa si collega ad altro contratto
influenzandone il contenuto, senza però porsi
in rapporto di corrispettività rispetto alla
prestazione dell’altro contraente. (E’ ciò che
accade nel secondo esempio ricordato, oppure
nel caso in cui Tizio aliena a Caio un immobile
e promette che un terzo gli venderà una
terrazza contigua. L’immobile acquisterà agli
occhi di Caio un valore maggiore e questi sarà
disposto a pagare di più).
Lungi dall’essere questione di “pura dottrina”,
come a prima vista potrebbe sembrare, il
ritenere che ricorra un’ipotesi di contratto
194
misto, piuttosto che collegato, avrà rilevanti
conseguenze quanto all’applicabilità
dell’istituto della risoluzione del contratto per
inadempimento. I principi di questo potranno
infatti trovare applicazione per il solo caso
che la promessa si configuri come contratto
sinallagmatico, ma non nei casi di promesse
collegate ad altro contratto, promesse cioè che
non rientrano nel sinallagma contrattuale, ma
che hanno costituito un semplice incentivo alla
conclusione del contratto. Sembra opportuno,
per ora, tralasciare la problematica del
momento in cui si verifica l’inadempimento
della promessa. Le opinioni al riguardo sono
differenti: per taluni autori esso si avvera
con il mancato compimento del fatto da parte
del terzo, per altri a seguito della mancata
corresponsione dell’indennizzo. L’argomento
195
coinvolge il problema della natura giuridica
dell’obbligazione assunta dal promittente e
potrà pertanto trattarsi solo dopo che si sia
affrontato tale tema209.
4. Segue: promessa come contratto autonomo.
Fuori dei casi in cui la promessa è parte di un
più ampio programma contrattuale, essa si
presenterà come contratto autonomo.
In primo luogo la promessa può farsi verso un
corrispettivo, così come può essere prestata
una fideiussione verso il pagamento di un
compenso210, salvo poi dovere specificare che
tipo di prestazione il promittente assuma
l’obbligo di compiere.
209 Su cui infra par. 6 ss.210 SCALFI, op. cit., p. 94; ALCARO, op. cit., p. 79; e. BRIGANTI, op.
cit., p. 115.
196
Quando il contratto di promessa non preveda
invece obbligazioni a carico del promissario
sembrerebbe che si ricada nell’ipotesi del
contratto unilaterale prevista dall’art. 1333
cod. civ. Si è osservato in dottrina, infatti,
che la promessa ha una sua giustificazione come
contratto unilaterale, costituendo
l’obbligazione del promittente “il dato che ne
conforma la struttura e ne esaurisce la
funzione tipica” 211.
Da un punto di vista logico – giuridico deve
osservarsi innanzitutto che, per le ragioni
sopra esposte212, non può essere messa in
discussione la natura contrattuale della
promessa. Orbene se la figura in esame non è
parte di un più ampio contratto, non è
211 F. ALCARO, op. cit., p. 78 ss.212 Vedi retro par. 2.
197
stipulata verso un corrispettivo, ma comporta
un’obbligazione del solo promittente, nulla
prestando il promissario, ricadremo
necessariamente nell’ipotesi del contratto con
obbligazioni del solo proponente, contemplato
dall’art. 1333 cod. civ.
La giustificazione causale di una tale
promessa, come contratto unilaterale, andrà
evidentemente ricercata nell’interesse del
promittente, così come avviene nell’ipotesi in
cui una società controllante ha interesse a che
la società controllata riceva un mutuo da una
banca. In dottrina si afferma infatti che
“quando la promessa non è parte di un più ampio
programma negoziale e non è sostenuta dalla
corrispettività, può stare in piedi come
promessa interessata”213 e si aggiunge che la
213 M.R. MARELLA, op. cit., p. 385.
198
promessa, proprio perché sorretta da un
interesse serio del promittente, è in grado di
creare un affidamento ragionevole nel soggetto
cui è diretta, anche se questi non è tenuto al
pagamento di un corrispettivo.
Il mancato compimento del fatto del terzo
determinerà quindi la lesione dell’affidamento
del promissario, ossia un pregiudizio da
riparare. La sequenza logica che dalla promessa
conduce all’obbligo del promittente di pagare
l’indennizzo viene descritta dalla dottrina in
parola in questi termini: interesse del promittente –
affidamento ragionevole del promissario – danno per il caso
della frustrazione della promessa.
Prima di affrontare le questioni attinenti ai
profili strutturali del contratto dianzi
menzionato (causa, oggetto e forma), sembra
199
opportuno procedere ad esporre la problematica
della natura dell’obbligazione assunta dal
promittente.
5. Dalla previsione dell’art. 1129 dell’abrogato codice alla
formulazione attuale (art. 1381).
Come già chiarito dalla promessa ex art. 1381
nascono effetti obbligatori per il solo
promittente. In dottrina ed in giurisprudenza
vi sono però opinioni diverse circa il
fondamento della responsabilità del promittente
e sulla natura dell’obbligazione a suo carico.
Può essere un utile punto di partenza, per le
riflessioni differenziali che consente di fare
rispetto all’attuale formulazione, un
riferimento alla disciplina della promessa
contenuta nel codice del 1865. L’art. 1129
statuiva : <<Può taluno obbligarsi per un altro
200
promettendo il fatto di una terza persona. Tale promessa da
“soltanto” diritto ad una indennità verso colui che si è obbligato
o che ha promesso la ratifica del terzo se questi rifiuta di
adempiere l’obbligazione>>.
Com’è agevole notare l’articolo contemplava due
distinte ipotesi di promessa: quella fatta dal
promittente “in nome proprio” (colui che si è
obbligato …) e quella fatta “in nome del terzo” (…
o che ha promesso la ratifica del terzo), come
suo rappresentante senza mandato214. In questo
secondo caso il promittente si faceva garante
della ratifica da parte del terzo e rispondeva
dei danni conseguenti alla mancanza di essa,
ferma restando la libertà del terzo di decidere
l’opportunità della ratifica del contratto
214 PACCHIONI, La promessa del fatto di un terzo, in Riv. dir. comm. 1911, II,
p. 549 ss; GIOVENE, Il negozio giuridico rispetto ai terzi, Torino, 1917, p.
210.
201
concluso dal promittente, come suo
rappresentante senza poteri215.
In dottrina si propose, da un illustre
autore216, una sorta di reductio ad unitatem delle
due ipotesi di promessa contemplate dall’art.
1129, perché ambedue costituivano “promesse in
nome proprio di un fatto altrui”, essendo anche
la promessa di ratifica promessa del fatto
altrui. Dalla promessa, si diceva, nasce
un’obbligazione per il solo promittente, mentre
solo la ratifica facoltativa avrebbe comportato
la nascita dell’obbligo del terzo.
Il dato messo in evidenza dalla dottrina del
tempo, secondo cui la fattispecie in esame è
quella della “promessa in nome proprio di un
fatto altrui”, è utile per escludere dalla215 PACCHIONI, op. cit., p. 553.216 STOLFI, La promessa del fatto di un terzo, cit., p. 212 ss.; concorde
SCALFI, La promessa del fatto altrui, cit., p. 15 ss.
202
riconduzione alla figura alcuni casi che
apparentemente sembrano rientrarvi. Come si è
chiarito negli studi sul tema, sotto il codice
vigente217 non possono ricondursi alla
fattispecie prevista dall’art. 1381 cod. civ.
le figure della promessa di convincere il terzo
a compiere un certo fatto e della promessa in
nome del terzo. Nel primo caso trattasi infatti
di promessa di un fatto proprio e non di un
fatto altrui, per cui il promittente assume un
obbligo di fare diligentemente quanto in suo
potere per convincere il terzo. Quanto al
secondo, la promessa è fatta in nome del terzo
sulla base “di un potere di rappresentanza
effettivo o putativo”. Questa fattispecie
rientra nell’ambito della disciplina dettata in
tema di rappresentanza, da cui rimane regolata.217 A. CHECCHINI, Indennizzo e risarcimento nella promessa del fatto altrui, in
Riv. dir. civ., 1999, I, p. 560.
203
È da considerare, tuttavia, che sulla scorta
dell’ipotesi espressamente prevista dal codice
del 1865, il falso rappresentante potrebbe
promettere la ratifica da parte del falso
rappresentato.
L’attuale formulazione dell’art. 1381 cod. civ.
riprende sostanzialmente la precedente, con
alcune variazioni che, come messo in evidenza
in dottrina218, possono fornire spunti
interpretativi.
In primo luogo scompare il riferimento
“all’obbligarsi per un altro”, per cui occorre
chiedersi se possa individuarsi un
comportamento specifico cui il promittente è
tenuto in adempimento di un suo obbligo. È da
notare del resto che, come si avrà modo di
chiarire, la stessa dottrina che parla di218 A. CHECCHINI, op. ult. cit., p. 565 ss.
204
obbligazione di garanzia in capo al promittente
si divide tra chi sostiene sic et simpliciterer che
il promittente “coopera sopportando il
rischio”219 e chi invece individua una rilevanza
dell’obbligo di fare del promittente, che se
non adempiuto darà luogo al risarcimento
danni220.
In secondo luogo va evidenziato che mentre
nell’abrogato codice civile si leggeva “(…) tale
promessa da soltanto diritto all’indennità (…)”, tal
indicazione scompare nella formulazione
adottata dal codice odierno. Questa esclusione
potrebbe lasciar pensare che dalla promessa
possano derivare effetti diversi dall’obbligo
di pagare l’indennizzo, effetti che sarebbero
219 SCALFI, op. cit., p. 68 ss.220 M.C. CHERUBINI, op. cit., p 27 ss.
205
da individuare sulla base dei principi generali
dell’ordinamento.
Infine nella formulazione dell’art. 1381 viene
corretta un’inesattezza prevista nell’art. 1129
del codice abrogato, dove si stabiliva la
nascita del diritto all’indennità “se il terzo
ricusasse di adempiere l’obbligazione”. Invero il
legislatore non avrebbe potuto parlare di
rifiuto di adempiere, non avendo il terzo
assunto l’obbligazione. L’inesattezza è stata
corretta nel senso che il diritto
all’indennizzo nasce dal rifiuto “di compiere
il fatto” o “di assumere l’obbligazione”.
206
6. I problemi posti dalla natura dell’obbligazione assunta
dal promittente. Le soluzioni proposte in dottrina e in
giurisprudenza.
Le incertezze circa la natura dell’obbligazione
assunta dal promittente che già si erano poste
sotto il codice abrogato, si ripropongono anche
in relazione all’attuale art. 1381. L’articolo
sembra descrivere gli effetti della fattispecie
alla stregua di una consequenzialità meccanica:
promessa – mancato compimento del fatto –
obbligo di pagare l’indennizzo, il che pone
nell’interprete due quesiti fondamentali: dalla
promessa del fatto del terzo nasce
un’obbligazione per il promittente? Se si, di
che tipo di obbligazione si tratta? Alla luce
della lettera dell’articolo infatti non è
chiaro quale sia la prestazione che il
207
promittente deve compiere221, dato che il fatto
promesso è un fatto altrui, che evidentemente
non può essere oggetto della prestazione del
promittente, nella misura in cui il suo
compimento dipende da una libera scelta del
terzo.
L’interprete dovrà chiedersi altresì quale sia
il fondamento della responsabilità del
promittente e, conseguentemente, la natura
dell’indennizzo che sarà tenuto a pagare in
caso di frustrazione della promessa.
Procediamo dunque con ordine, attraverso
l’esame degli orientamenti dottrinali e
giurisprudenziali circa la natura
dell’obbligazione assunta dal promittente, sino
agli indirizzi espressi dalla giurisprudenza
più recente.221 E. BRIGANTI, op. cit., p. 92.
208
7. Segue: la tesi secondo cui il promittente assume un
obbligo di facere, nell’accezione di adoperarsi affinché il
terzo esegua il fatto promesso.
La dottrina più antica e la giurisprudenza
anche in tempi non remoti222 hanno sostenuto che
il promittente assume con la promessa un
obbligo di fare consistente nell’adoperarsi
affinché il terzo compia il fatto dovuto.
La configurazione di un tal obbligo del
promittente dovrebbe però comportare che, in
base ai principi generali enunciati negli
articoli 1176 e 1218 cod. civ., il promittente,
se sia stato diligente nell’adempimento del suo
obbligo di convincere il terzo a compiere il222 MESSINEO, il contratto in genere, in Trattato di diritto covile e commerciale,
diretto da CICU e MESSINEO, XXI, t. 2., Milano, 1972, p. 97;
BARASSI, La teoria generale delle obbligazioni, II, Milano, 1946, 449.;
Cass.18 novembre 1987, n. 8483, in Giuri. it., 1988, I, 1, c. 1361;
Cass., 20 febbraio 1982, n. 1081, in Mass. giust. civ., 1982; Cass., 27
febbraio 1980, n. 1379, in Mass. giust. civ., 1980; Cass. 13 novembre
1974, n. 3601, in Giust. civ., 1975, I, p. 1206.
209
fatto, senza peraltro riuscirvi, non dovrebbe
essere tenuto al pagamento dell’indennizzo.
Nell’anzidetta ipotesi dovrebbe concludersi che
il promittente ha adempiuto esattamente
all’obbligazione a suo carico e quindi non
dev’essere considerato responsabile della
mancata soddisfazione dell’interesse del
promissario.
La stessa giurisprudenza che ha sostenuto la
configurazione di un obbligo di fare,
nell’ipotesi in cui il terzo non avesse
compiuto il fatto promesso, o si fosse
rifiutato di assumere l’obbligazione, ha
considerato il promittente inadempiente per il
fatto obiettivo del mancato adempimento del
terzo, ritenendo non raggiunta la prova
liberatoria a favore del promittente
210
“diligente”. Una parte della giurisprudenza
giustificava la condanna del promittente al
pagamento dell’indennizzo ritenendo che la
frustrazione della promessa fosse dipesa da un
comportamento non diligente del promittente. Si
negava quindi la prova liberatoria dell’aver
agito con diligenza.
In verità, com’è sembrato ai commentatori,
questo ragionamento ha coperto un più semplice
meccanismo di giudizio “oggettivizzante”223, ossia la
consequenzialità meccanica: promessa del fatto
del terzo – frustrazione della stessa – obbligo
del promittente di pagare l’indennizzo.
Si è allora prospettata in dottrina l’idea che
la tesi citata fosse insostenibile alla luce
della lettera dell’art. 1381224, che non223 M.R. MARELLA, op. cit., p. 387.224 SCALFI, La promessa del fatto altrui, cit., p. 40 ss.; ALCARO, op. cit.,
p. 73; E. BRIGANTI, op. cit., p. 94 ss.; STASI, op. cit., p. 72 ss.;
211
contiene alcun riferimento alla pretesa
obbligazione di adoperarsi da parte del
promittente e non contempla la prova
liberatoria per il caso del comportamento
diligente di quest’ultimo. Il promittente è
senz’altro tenuto ad indennizzare l’altro
contraente se il terzo non compie il fatto
promesso o rifiuta di obbligarsi.
8. Segue: l’opinione secondo cui il promittente assume
l’obbligo di procurare l’esecuzione del fatto altrui.
Meglio è sembrato adattarsi alla formulazione
dell’art. 1381 l’orientamento secondo cui il
promittente assume l’obbligo di procurare il
fatto altrui (cura cum effectu) e dovrà
conseguentemente pagare l’indennizzo se il
fatto del terzo non viene compiuto225.
M.R. MARELLA, op. cit., p. 387.225 ALLARA, Natura giuridica dell’obbligazione del fatto altrui, in Riv. dir. comm.,
1929, I, p. 410 ss.; SACCO, Il contratto, cit., VI, 2, 1975, p. 501.
212
Se il terzo non compie il fatto o non assume
l’obbligazione, l’obbligo del promittente dovrà
considerarsi inadempiuto, pure se questi
dimostri di aver fatto tutto il possibile per
convincere il terzo. In altri termini il
promittente non sarebbe solo tenuto ad un
comportamento diligente, ma ad ottenere il
fatto del terzo (c. d. cura cum effectu226).
Pur configurando l’obbligazione del promittente
come volta al risultato del compimento del
fatto promesso, facendo applicazione dei
principi generali dell’ordinamento, e
segnatamente dell’art. 1218 cod. civ., si dovrà
tuttavia dire che il promittente non risponde
dell’inadempimento della sua obbligazione, se
questo è dipeso da impossibilità della
prestazione derivante da causa a lui non
226 ALLARA, op. cit., p. 423.
213
imputabile. Gli autori che sostengono questa
tesi227 sono divisi nell’identificare le
evenienze in cui si verifichi l’impossibilità
sopravvenuta della prestazione. I casi che si
prospettano sono due: a) il fatto del terzo non
si verifica per un rifiuto di questi a
compierlo; b) il mancato compimento del fatto o
la mancata assunzione dell’obbligazione
dipendono da una causa diversa dal mero rifiuto
del terzo (es. è perita la res che questi
avrebbe dovuto consegnare).
Secondo alcuni degli autori che propongono la
tesi ora riassunta228, il promittente non
avrebbe alcuna responsabilità anche nel caso di
rifiuto da parte del terzo. In altri termini227 ALLARA, op. cit., p. 410 ss.; OSTI, Contratto, in Noviss. dig. it., IV,
Torino, 1959, p. 526; BARBERO, Sistema istituzionale del diritto privato italiano,
II, Torino, 1962, pag. 475; SACCO, Il contratto, cit., p. 500 ss.; ALCARO,
op. cit., p. 67 ss.228 ALLARA, op. cit., p. 425 ss.
214
pure in questa ipotesi si configurerebbe
l’estinzione dell’obbligo del promittente, per
impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Si è obiettato229, però, che in quanto si
configura la volontà del terzo come oggetto
mediato dell’obbligo, non può sostenersi
l’impossibilità sopravvenuta della prestazione
per il caso del rifiuto del terzo. Mutatis
mutandis sarebbe come dire che non v’è
responsabilità in relazione a ciò che il
promittente è pur tenuto a provocare (il
compimento del fatto).
Del resto si fa presente 230 che, secondo
l’insegnamento tradizionale, per causare
l’estinzione dell’obbligazione l’impossibilità
della prestazione deve avere il carattere
229 SACCO, Il contratto, cit., p. 500 ss.230 SACCO, op. cit., p. 501.
215
dell’assolutezza. Se il terzo rifiuta questa
non sussiste, perché il terzo, se volesse,
potrebbe certamente realizzare il risultato
voluto.
Il promittente, secondo i sostenitori di tale
tesi, potrebbe essere liberato solo per
impossibilità sopravvenuta della prestazione ex
art. 1256, ossia quando il mancato compimento
del fatto o il rifiuto di assumere
l’obbligazione non dipendono da un atto di
volontà del terzo (rifiuto), ma siano divenuti
oggettivamente impossibili231 (esempio la res che
il terzo avrebbe dovuto alienare è andata
distrutta).
Avverso l’anzidetta conclusione sono state
avanzate critiche riguardanti da un lato il231 ALLARA, Natura giuridica, cit., p. 427, nota 1; STOLFI, La promessa del
fatto di un terzo, cit., p. 215; SCALFI, La promessa del fatto altrui, cit.,
p. 125.
216
merito e dall’altro la distinzione che la tesi
presuppone tra obbligazioni di mezzo e di
risultato, obbligazioni cioè che hanno ad
oggetto una determinata attività a prescindere
dal risultato e obbligazioni in cui ciò che
soddisfa l’aspettativa del creditore è il
compimento di un’opera o di un servizio, ossia
un determinato risultato232 (es. obbligo
dell’appaltatore).
Il principio della diligenza nell’adempimento
ex art. 1176 opererebbe con riferimento alle
sole obbligazioni di mezzi, mentre le
obbligazioni di risultato sarebbero
assoggettate alla più rigida regola della
232 MENGONI, Obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi (studio critico), I,
L’oggetto dell’obbligazione nelle due categorie di rapporti, in Riv. dir, comm.,
1954, I, p. 185 ss.; CICALA, Concetto di divisibilità ed indivisibilità, cit.,
p. 216, nota 490, p. 82 ss.
217
responsabilità oggettiva qualora non si
verifichi il risultato.
La dottrina è diffidente verso la distinzione
da ultimo prospettata, perché essa è poco utile
sotto il profilo applicativo ed è
sostanzialmente arbitraria nella scelta del
criterio distintivo, “data la relatività e
l’approssimazione dei concetti di mezzi e
risultato”233.
Si è notato che la predetta distinzione non
tiene conto della relatività dei concetti di
mezzo e risultato234, in quanto “l’attività
vista come mezzo può rappresentare già un
risultato quando sia considerata in se
stessa”235. Si fa l’esempio della prestazione
medica, che rappresenta un mezzo in relazione233 ALCARO, op. cit., p. 74.234 MENGONI, Obbligazioni di risultato, cit., p. 188.235 E. BRIGANTI, op .cit., p. 101.
218
al fine di essere guarito, ma è un risultato se
vista in relazione all’essere curato. La
dottrina in parola fa presente che nel nostro
ordinamento non esistono obbligazioni che non
tendano ad un determinato risultato, visto come
momento conclusivo della prestazione, e non
abbiano ad aggetto l’impiego di determinati
mezzi necessari alla realizzazione del
risultato236. In altri termini tutte le
obbligazioni sarebbero nel contempo
obbligazioni di mezzo e di risultato.
Nel merito poi si è rilevato che nella
fattispecie prevista dall’art. 1381 è
inconcepibile la configurazione di una
obbligazione di fare, perché essa avrebbe ad
oggetto, seppure mediato, il compimento del
236 RESCIGNO, Obbligazioni (diritto privato) A) Nozioni generali, in Enc. dir. XXIV,
Milano, 1979, pp. 190 – 192.
219
fatto da parte del terzo; l’adempimento di una
tal obbligazione, che si verifica con il
compimento del fatto da parte del terzo, non
rientra nel potere del debitore237. Si
prometterebbe dunque qualcosa che non rientra
nelle possibilità del promittente di
determinare238. Il fatto del terzo è un atto
giuridicamente autonomo, nel senso che il
promittente non può esercitare un’influenza
giuridica al fine di coartarne il compimento.
Da un punto di vista logico – giuridico si è
osservato che “nessuno può promettere (…) ciò
che non dipende da lui”239. Il fatto altrui non
può considerarsi un risultato dovuto immediato
o mediato, in quanto il compimento del fatto da
parte del terzo non è adempimento del237 SCALFI, op. cit., p. 36.238 BRIGANTI, op. cit., p. 102 ss; MAZZONI, op. cit., p. 355.239 E. BRIGANTI, op. cit., p. 103.
220
promittente, così come il mancato compimento
non è inadempimento del promittente, ma solo
presupposto del pagamento dell’indennizzo240.
Da questa osservazione trae origine l’opinione
dottrinale che si discosta dalla configurazione
di un’obbligazione di fare nel senso di
“adoperarsi per convincere il terzo” o di
“procurare il fatto del terzo”, per configurare
l’obbligazione del promittente come
obbligazione di garanzia: “il promittente (…)
garantisce l’assunzione dell’obbligo o il compimento del fatto
da parte del terzo e s’impegna ad indennizzare il contraente
per il caso del mancato verificarsi di tali eventi
indipendentemente da ciò che ha fatto per convincere il
terzo”241.
240G. SCALFI, op. cit., p. 36.241 E. BRIGANTI, op. cit., p. 103.
221
9. Segue: l’insegnamento secondo cui il promittente assume
l’obbligo di pagare l’indennità, sospensivamente
condizionato al rifiuto del terzo.
In dottrina 242 e in giurisprudenza243 si è in
passato individuato un obbligo di garanzia del
promittente, inteso, in questa prima accezione,
come obbligazione di dare condizionata alla
frustrazione della promessa del fatto del
terzo.
L’obbligo primario del promittente
consisterebbe secondo tale ricostruzione nel
pagamento dell’indennità al promissario, se il
terzo non compia il fatto o non assuma
l’obbligazione.
Alla stregua della riferita dottrina dovrebbe
però dirsi che, consistendo l’obbligazione242 CARNELUTTI, Diritto e processo nella teoria delle obbligazioni, in Studi in onore
di G. Chiovenda, cit., n. 46, p. 835.243 App. Napoli, 28 marzo 1962, in Dir. giur., 1963, p. 559.
222
primaria del promittente nel pagamento
dell’indennità, l’interesse primario del
promissario sia quello al pagamento
dell’indennità stessa, talché tal interesse
sarà soddisfatto quando in ragione della
frustrazione della promessa il promittente
debba pagare l’indennizzo.
Si è allora facilmente replicato244 che la
ricostruzione in esame non descrive in modo
appropriato gl’interessi sottesi alla stipula
della promessa, in quanto l’interesse primario
del promissario concerne il compimento da parte
del terzo del fatto promesso; lo stesso
promittente, del resto, ha interesse a vedere
compiuto quel fatto, al fine di sottrarsi al
pagamento dell’indennizzo.
244 SCALFI, op. cit., p. 54 ss.
223
La configurazione del pagamento dell’indennizzo
come obbligazione primaria del promittente
comporterà che se il fatto è dal terzo compiuto
o se questi si obbliga, la promessa non è da
considerarsi adempiuta. A tale conclusione si
perviene attraverso la constatazione che, non
verificandosi il fatto (il mancato compimento
di questo da parte del terzo, o la mancata
assunzione dell’obbligazione) cui l’obbligo
primario è sospensivamente condizionato, il
promittente non adempirà al suo obbligo di
pagare l’indennizzo. Nell’ipotesi in cui la
promessa sia stata fatta verso il pagamento di
un corrispettivo oppure si ponga in rapporto
sinallagmatico ad altra prestazione, il
promissario avrebbe a suo favore i rimedi
predisposti dall’ordinamento per
l’inadempimento di una obbligazione, potrebbe
224
cioè ripetere quanto prestato qualora abbia già
pagato o eccepire l’inadempimento per sottrarsi
al pagamento.
La tesi sopra esposta, secondo cui il
promittente assume l’obbligo di pagare
l’indennità qualora il terzo non compia il
fatto promesso, attinge le proprie radici dagli
studi sul contratto di assicurazione e
precisamente da quella dottrina245 che individua
l’obbligo primario dell’assicuratore nel
pagamento dell’indennità all’assicurato, per il
caso in cui si verifichi l’evento assicurato.
Dal punto di vista del sinallagma contrattuale,
è stato rilevato tuttavia che stante il
rapporto obbligo di pagare i premi – obbligo di
pagare l’indennità, l’assicurato dovrebbe poter
ripetere i premi pagati, nel caso in cui
245 E. BRIGANTI, op. cit., p. 104, nota 267.
225
l’evento non si verifichi. L’assurdo logico
giuridico viene temperato da tale dottrina
ricorrendo alla distinzione tra “il sinallagma
genetico e quello funzionale”, per cui il
rapporto nascerebbe con le promesse reciproche
di pagare i premi e di pagare l’indennità, non
rilevando poi che nella vita del rapporto
giuridico il fatto da cui dipende il pagamento
dell’indennità non si verifichi246.
Come dianzi anticipato questa costruzione dell’obbligo
del promittente sembra trascurare la corretta descrizione
degl’interessi sottesi alla promessa, in quanto con il
compimento del fatto o l’assunzione
dell’obbligazione del terzo il promissario vede
soddisfatto l’interesse in ragione del quale il
negozio è stato stipulato. Se quel fatto invece
246 DONATI, Trattato del diritto delle assicurazioni private, II, Milano, 1954, p.
36.
226
non è compiuto, il promissario farà affidamento
sulla soddisfazione dell’interesse alla
sicurezza, rappresentando quindi l’indennità
una “utilità essenzialmente vicaria”, che
soddisfa un interesse secondario247.
Rilevando tale forzatura un altro Autore248 ha
sostenuto che per comprendere la natura
dell’obbligazione assunta dall’assicuratore
bisogna scostarsi dall’inquadramento
dell’oggetto dell’obbligo nel contegno del
debitore, ossia in un dare o fare, riconoscendo
che la prestazione possa consistere “nella cura”,
“nell’assunzione di tutela” di un interesse altrui. In tal
senso il soggetto obbligato garantisce il
contraente, per l’eventualità di un pregiudizio247 E. BRIGANTI, op. cit., p. 106248 V. SALANDRA, Assicurazione, Comm. al cod. civ. a cura di Scialoja e
Branca, p. 228, Roma – Bologna, 1948; Cfr. BUTTARO, L’interesse
nell’assicurazione, Milano, 1954, p. 154 ss. Impostazione accolta dallo
SCALFI, in La promessa del fatto del terzo, cit., passim.
227
ad un interesse di quest’ultimo, mediante
l’assunzione dell’onere economico del rischio,
che si tradurrà nel pagamento dell’indennità o
nel risarcimento del danno, ove si verifichi
l’evento temuto.
Secondo uno studio249 che ha ricevuto larghi
consensi nelle ricerche successive sul tema,
questo concetto di obbligazione di garanzia,
che si rinviene nell’obbligo assunto
dall’assicuratore, bene descrive l’obbligo che
assume colui che promette il fatto del terzo.
249 SCALFI, op. cit., p. 45.
228
10. Segue: il promittente assume una obbligazione di
garanzia?
Un orientamento dottrinale250, che non ha
suscitato molti consensi in giurisprudenza,
prospetta che dalla promessa nasca
un’obbligazione di garanzia in capo al
promittente. Secondo tal insegnamento con la
conclusione della promessa il promittente
assume il rischio del mancato compimento del
fatto del terzo, indipendentemente da ciò che
farà per indurre il terzo a compiere il fatto.
Si tratterebbe quindi di una prestazione di
sicurezza a favore del promissario, circa il
conseguimento dell’utilità che si attende
250 G. SCALFI, op. cit., p. 60 ss.; E. BRIGANTI, Fideiussione e promessa del
fatto del terzo, cit.; p. 107 ss. A. MAZZONI, lettere di patronage, mandato di
credito e promessa del fatto del terzo, in Banca borsa e tit. cred., 1984, I, p.
334 ss; MASTROPAOLO, Promessa del fatto altrui, garanzie personali e sindacati di
voto, in Riv. Dir. Comm., 1992, I, p. 695 ss; M.C. CHERUBINI, La
promessa del fatto del terzo, Milano, 1992, p. 45 ss.
229
dall’esecuzione del fatto o dall’assunzione
dell’obbligazione da parte del terzo251.
Una giustificazione all’idea che la promessa
dia luogo ad una obbligazione di garanzia in
capo al promittente si ritrova in quella
dottrina, che prospetta l’esistenza della
categoria delle obbligazioni c.d. di
garanzia252, già note ai giuristi romani253 come
obbligazioni di praestare (stare garante). Il
contenuto di tali obbligazioni sarebbe
caratterizzato da una prestazione di garanzia,
ossia dall’assunzione dell’onere economico di
un danno eventuale.
251 BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, cit., p. 563 ss; SCALFI, La
promessa del fatto del terzo, cit., p. 60 ss; E. BRIGANTI, op. cit., p. 107
ss.252 E. BETTI, Teoria gen. delle obbligazioni, I, Milano, 1953.253 F. PASTORI, Profilo dogmatico e storico dell’obbl. romana, Milano, 1951,
p. 147 ss.
230
Un precedente storico della riconduzione della
promessa del fatto altrui a tale categoria di
obbligazioni di garanzia si deve alla dottrina
tedesca, che ha accomunato nella categoria dei
cc. dd. Garantieverträge tutti quei contratti
ignorati dal BGB, ma diffusi nella prassi,
caratterizzati da una “funzione di garanzia
consistente nel fornire sicurezza contro il
verificarsi di un evento temuto”254. Si tratta
di contratti non accessori ad un debito
preesistente - e che quindi si differenziano
sotto questo aspetto dalle garanzie personali
tipiche -, ma che hanno una funzione di
garanzia, “poiché un contraente assicura
all’altro un’indennità nel caso questi subisca
254 E, BRIGANTI, op. cit., p. 109.
231
un danno, o non veda soddisfatto un suo
interesse”255.
In tale prospettiva la risposta alla domanda
circa il contenuto dell’obbligazione del
promittente è che “il promittente presta una
garanzia”256, prestazione che si concreta
nell’assunzione dell’onere economico del
rischio da parte del promittente. L’utilità che
tale prestazione arreca al promissario andrebbe
individuata nella sicurezza che il peso
economico del danno, che subirebbe in caso di
mancato compimento del fatto promesso, sarà
sostenuto dal promittente. La promessa, quindi,
anche prescindendo dal pagamento dell’indennità
eventuale, soddisferebbe un interesse specifico
del promissario.255 STAMMLER, Der garantievertrage, in Arch. Civ. priv. Prax 69, 1886, 1; G.
STOLFI, La promessa del fatto di un terzo, in Riv. dir.comm., 1927, p. 219.256 SCALFI, op. cit., p. 49.
232
Secondo tale veduta l’obbligo di garanzia che
il promittente assume si articola in due
momenti: uno, che precede l’evento temuto;
l’altro, che lo segue. Con la conclusione del
contratto il promittente si assume ab initio
l’onere economico del danno della mancata
esecuzione del fatto, rischio che viene
trasferito dal promissario in capo al
promittente; se poi il terzo non compie il
fatto, la garanzia si converte in un debito di
risarcimento, l’obbligo di pagare
l’indennizzo257. Entrambi i momenti in cui in
astratto sembra scindibile la promessa (la
promessa e il pagamento dell’indennizzo) sono
elementi della prestazione di garanzia.
257 In tal senso SCALFI, op. cit., p. 74.
233
Si parla al riguardo di cooperazione258 del garante,
nel senso che il promittente soddisfa
l’interesse del promissario a che il mancato
ottenimento di un’utilità o la lesione di un
proprio interesse sia risarcito. Assumendo
l’onere economico della frustrazione della
promessa il garante coopera con il promissario,
e questa cooperazione soddisfa l’interesse
della controparte alla certezza di ottenere
un’utilità sostitutiva rispetto al compimento
del fatto o all’assunzione dell’obbligazione259.
La cooperazione del promittente ora descritta
va già inquadrata nel rapporto che nasce dalla
promessa, come prestazione patrimoniale che
precede il pagamento dell’indennità. Si
afferma260, infatti, che “il rapporto di garanzia opera
258 SCALFI, op. cit., p. 66.259 SCALFI, op. cit., p . 68.260 SCALFI, op. cit., p. 67.
234
due risultati”, sicurezza patrimoniale del
garantito (risultato certo) e pagamento
dell’indennità (risultato eventuale). La
prestazione di garanzia del promittente, ossia
l’assunzione del rischio, è già adempimento
dell’obbligo di garanzia. L’obbligazione del
promittente soddisfa infatti l’interesse del
promissario alla sicurezza, “prima e
indipendentemente dal pagamento dell’indennità,
attraverso l’assunzione della sopportazione del
rischio altrui”261.
Sulla base della distinzione tra debito e
responsabilità262 la dottrina in parola263
riconosce nella promessa del fatto altrui
261 BRIGANTI, op. cit., 109 ss.262 BETTI, Il concetto della obbligazione costruito dal punto di vista dell’azione,
Pavia, 1920, p. 99 ss; ID., Teoria generale delle obbligazioni, cit., p. 82,
89 e 90; CARNELUTTI, Lezioni di diritto processuale civile. Processo di esecuzione,
Padova, 1929, I, p. 82 ss.263 SCALFI, op. cit., p. 61 ss.
235
un’ipotesi di “responsabilità senza debito, o
meglio di responsabilità attuale, connessa ad
un debito eventuale e futuro, l’indennizzo”264.
Secondo questa costruzione responsabilità e
debito del promittente hanno due distinti
momenti genetici: la responsabilità del
promittente nasce in relazione al negozio della
promessa e ha la funzione di sopportazione del
rischio che il terzo non compia il fatto
promesso o rifiuti di obbligarsi. Il debito
consistente nel pagamento dell’indennità nasce
invece nell’ipotesi che si verifichi l’evento
temuto. La responsabilità del garante sussiste ancora prima
del verificarsi del mancato compimento del fatto ed è legata
264 SCALFI, La promessa del fatto altrui, cit., p. 61 ss, che sviluppa il
pensiero di Betti.
Di contro MESSINEO, Il contratto in genere, cit., p. 100, il quale
sostiene che è inammissibile parlare di responsabilità senza
debito, perché se non fosse obbligato il promittente potrebbe
dirsi che non è obbligato nessuno.
236
alla sopportazione del rischio, alla sicurezza offerta al
garantito; quando poi si verifichi l’evento dannoso, la
responsabilità si converte nel debito di pagare l’indennizzo265.
Nell’ottica dell’individuazione dell’utilità
che il promissario riceve dalla promessa sin
dalla sua stipula, essa va posta in relazione a
ciò, che la promessa del fatto del terzo genera
nel promissario un affidamento, che giustifica
il pagamento dell’indennità per il caso della
delusione dell’aspettativa del promissario.
In relazione al percorso dottrinale e
giurisprudenziale compiuto per l’inquadramento
dell’obbligazione del promittente, si può
rilevare che quando la dottrina e la
giurisprudenza hanno posto l’attenzione sul
solo aspetto del promettere, si è pervenuti
alla conclusione che dalla promessa nascesse265 SCALFI, op. cit., p. 70.
237
l’obbligazione di fare, o di procurare il fatto
altrui. Quando invece si è posta l’attenzione
sul solo pagamento dell’indennità, si è parlato
di obbligazione condizionata del promittente di
pagare l’indennità. Se, invece, si guardasse al
fenomeno in una prospettiva unitaria e si
ponesse attenzione sul fatto che il pagamento è
conseguenza dell’affidamento creato dal
promettere, rileverebbe l’utilità conferita al
promissario con la promessa: l’assunzione da parte
del promittente dell’onere economico di un rischio.
Il rischio del mancato compimento del fatto o
della mancata assunzione dell’obbligazione,
com’evento possibile produttivo di un danno,
genera nel promissario l’interesse economico di
riversare tale rischio sul contraente.
Conseguentemente l’assunzione del rischio da
238
parte del promittente, in quanto satisfattoria
di tal interesse del promissario, costituisce
prestazione suscettibile di valutazione
economica ai sensi dell’art. 1174. Si comprende
quindi sotto tale profilo l’ammissibilità della
categoria della prestazione di garanzia, come
prestazione suscettibile di valutazione
economica.
Secondo gli autori che aderiscono a tal
inquadramento giuridico dell’obbligazione del
promittente, la funzione di garanzia della
promessa emerge dalla lettera dell’art. 1381,
che, non attribuendo alcun rilievo alla
condotta del promittente, pone a carico dello
stesso l’obbligo di pagare l’indennità per il
caso che il terzo non compia il fatto o non
assuma l’obbligazione. Sembra quindi emergere
239
uno scostamento rispetto alla concezione
classica dell’obbligazione come dovere di
condotta del soggetto obbligato e la
configurazione di un concetto di prestazione
diverso, cui si è fatto riferimento come
assunzione di rischio che può tradursi in obbligo del
pagamento dell’indennizzo. Il promissario sulla base
di tale indennizzo ha la certezza di contare su
un’utilità sostitutiva rispetto al fatto del
terzo promesso. Il pagamento dell’indennità
rappresenta l’utilità vicaria cui il
promissario ha diritto in attuazione
dell’obbligo di garanzia. Se pure tale obbligo
di pagamento non nasce, perché il terzo compie
quanto promesso, comunque con la promessa sarà
stata trasferita al promissario un’utilità, che
consisterà nella sicurezza di ricevere detta
utilità vicaria per il caso della frustrazione della promessa.
240
Tale sicurezza viene realizzata mediante la
prestazione dell’assunzione dell’onere
economico del rischio che il terzo non compia
quanto promesso dal promittente. Per questa
ragione, nel caso di promessa prestata verso un
corrispettivo, il promissario – se il terzo
compie il fatto- non potrà ripetere quanto
pagato al promittente. Costui, infatti, avrà
eseguito comunque una prestazione che
giustifica sotto il profilo causale la
corresponsione patrimoniale.
La ratio della norma andrebbe quindi ricercata
nella necessità di tutelare l’affidamento del
promissario, su cui poggia l’obbligatorietà
della promessa e la natura (di garanzia)
dell’obbligazione che nasce in capo al
promittente.
241
Non avrebbe senso secondo la dottrina in parola
parlare di un’obbligazione di fare, neppure nel
senso di procurare il fatto altrui o garantire
il risultato, in relazione ad una fattispecie
in cui se pure il promittente abbia fatto tutto
il possibile per indurre il terzo a compiere
quanto da lui promesso, sia comunque tenuto ad
indennizzare il promissario. Si comprende,
infatti, che “la posizione giuridica del
promittente è assorbita dalla obbligazione di
garanzia”266 In questa prospettiva si nota come
ponendo l’attenzione sul concetto di
prestazione di garanzia si possa trovare un
raccordo con la lettera dell’art. 1381, che non
contiene alcun riferimento esplicito
all’obbligazione di adoperarsi del promittente.
Sebbene sia interesse di quest’ultimo
266 SCALFI, op. cit., p 76.
242
convincere il terzo a compiere il fatto
promesso al fine di sottrarsi al pagamento
dell’indennizzo, l’obbligazione che assume si
configura come obbligazione di garanzia, in
relazione alla sicurezza che il promittente
presta al contraente di essere tutelato contro
il rischio che il fatto del terzo non venga
compiuto. Sembra allora, come è stato messo in
evidenza da un Autore267, che la norma legittima
una concezione del rapporto obbligatorio in cui
“l’obbligazione è concepibile come assunzione
di rischio […] e in definitiva come strumento
di tutela dell’affidamento del promissario”,
secondo una prospettiva in cui assume rilievo
la protezione dell’affidamento del contraente,
piuttosto che il comportamento dell’obbligato.
La disposizione sembra in tal modo atteggiarsi267 M.R. MARELLA, Promessa del fatto del terzo, in Dig. disc. priv., XXV,
Torino, 1997, p. 388.
243
a “norma di chiusura del sistema”, che
legittima la configurazione di una nozione
della prestazione che si allontana dal
comportamento dovuto da parte dell’obbligato.
Per inciso si deve qui ricordare che in
dottrina268 si è enucleato un concetto di causa
– funzione di garanzia, che, oltre che nel caso
delle garanzie codificate, può rinvenirsi
“tutte le volte che un soggetto che attende la
soddisfazione di un proprio interesse in via
primaria da un terzo vede accresciuta la
possibilità della realizzazione di tale
interesse attraverso l’obbligazione del
garante”. L’inquadramento della figura della
promessa del fatto del terzo, secondo questa
visione, presuppone l’utilizzazione del
descritto concetto di garanzia, che non è
268 MAZZONI, op. cit., p. 359.
244
pensato sulla base delle figure di garanzia
codificate. Questo argomento sarà ripreso nel
capitolo terzo del presente lavoro, quando si
avrà modo di parlare dell’inquadramento
giuridico che è stato tentato in relazione ad
alcune forme di garanzie atipiche.
Per l’importanza sistematica che riveste ai
fini del presente lavoro, ci sembra opportuno
dedicare un paragrafo a parte alle critiche
mosse verso tale configurazione dell’obbligo
che nasce dalla promessa.
11. Critiche verso la natura di garanzia dell’obbligazione
che il promittente assume.
La costruzione della promessa come fonte di una
obbligazione di garanzia ha sollevato
perplessità di ordine metodologico e
sostanziale. Le critiche si sono concentrate
245
sostanzialmente su tre motivi: tale
configurazione non permetterebbe di comprendere
il reale assetto d’interessi sotteso alla
promessa; non sembrerebbe ammissibile la
configurazione di un’obbligazione di garanzia;
non sarebbe configurabile un contratto con
causa - funzione di garanzia. Procediamo con
ordine.
Si è sostenuto, da parte degli autori che
configurano l’obbligazione del promittente come
obbligazione di garanzia, che l’utilità
attribuita al promissario attraverso la
promessa è la possibilità di fare affidamento
sulla sopportazione del rischio del mancato
compimento del fatto del terzo da parte del
promittente. Questa utilità, nell’ottica
dell’assetto d’interessi che la promessa
246
realizza, risulta essere logicamente secondaria
rispetto all’utilità primaria che il
promissario si attende e cioè il compimento del
fatto da parte del terzo. È stato evidenziato,
infatti, che “dire che la promessa comporta la
nascita di una obbligazione di garanzia,
significa concentrare l’attenzione su un dato
essenziale della figura, ma logicamente
successivo e posteriore rispetto al contenuto
proprio di essa”269. Bisognerebbe rilevare che
nella formulazione della norma l’obbligo del
pagamento dell’indennizzo si pone in
conseguenza di una promessa del fatto altrui,
che diviene punto di riferimento di un
interesse che deve trovare tutela nell’ambito
di una struttura giuridica obbligatoria;
all’interesse primario del promissario dovrebbe
269 ALCARO, op. cit., p 76.
247
cioè far riscontro un’obbligazione volta a
soddisfare tale interesse. Quando si afferma
che “la promessa genera un affidamento del
promissario che fa nascere nel promittente una
responsabilità che la norma esplicita
nell’obbligo del pagamento dell’indennizzo”,
bisognerebbe pur dire a che fa riferimento
quell’affidamento. Si rileverà allora il
rimando al compimento del fatto o
all’assunzione dell’obbligazione da parte del
terzo270. Se così è, risulterà logico
evidenziare nella struttura della fattispecie
un’obbligazione del promittente volta a
procurare quel fatto del terzo promesso, che
soddisfi l’interesse primario del promissario.
Secondo la dottrina in parola, l’inquadramento
dell’obbligazione che nasce dalla promessa sic et
270 A. e op. loc. ult. cit.
248
simpliciter come obbligazione di garanzia non
soddisfa rispetto alla delineazione della
struttura della fattispecie che appare
dall’art. 1381. La prestazione di garanzia
segue il mancato compimento del fatto e allora
come può dirsi, da un lato, che il promissario
ha interesse primario al compimento del fatto
da parte del terzo e, dall’altro, che
l’obbligazione primaria del promittente è
quella dell’assunzione di un’obbligazione di
garanzia?
Bisognerà allora riconoscere che, da un lato,
se l’irrilevanza della diligenza impiegata dal
promittente per ottenere il fatto del terzo e
la valorizzazione da parte della legge del
fatto oggettivo del compimento dello stesso
inducono l’interprete verso l’inquadramento
249
dell’obbligazione del promittente come
obbligazione di garanzia, dall’altro,
l’interesse primario del promissario ad
ottenere il fatto deve avere un riscontro nella
struttura della fattispecie, nei termini
dell’individuazione di un obbligo del
promittente atto a soddisfarlo.
Nella fattispecie della promessa l’interesse
del promissario alla “sicurezza” è succedaneo
rispetto all’interesse all’esecuzione del fatto
del terzo. In realtà si potrebbe dire che in
qualsiasi altro rapporto di garanzia v’è un
interesse primario all’esecuzione del debito
principale. La caratteristica della fattispecie
ex art. 1381 è che mentre nel caso delle
garanzie codificate l’interesse primario e
quello alla garanzia ricevono tutela sulla base
250
di due distinti negozi giuridici, qui
l’interesse primario è contemplato e riceve
tutela sulla base del medesimo negozio che da
vita all’obbligazione di garanzia.
Per cogliere la struttura caratteristica della
promessa bisogna porre l’attenzione sul fatto
che, sebbene l’interesse del promissario deve
essere soddisfatto “in via esterna” dal terzo
(che non è tenuto al comportamento), tale fatto
del terzo viene comunque preso in
considerazione come atto a soddisfare
l’interesse primario del promissario. Non
bisogna allora incorrere nell’errore di
effettuare una “posposizione logica dei termini della
fattispecie”271, che sono il promettere il fatto
del terzo e il garantirlo. Se si costruisce
l’obbligazione del promittente come
271 ALCARO, op. cit., p. 77.
251
obbligazione di garanzia, non si pone più la
giusta attenzione sull’obbligo primario assunto
dal promittente, atto a soddisfare l’interesse
primario del promissario al compimento del
fatto del terzo.
La formulazione della norma (che fa discendere
l’obbligo del pagamento dell’indennizzo
dall’obiettività del mancato compimento del
fatto o della mancata assunzione
dell’obbligazione, senza contemplare l’azione
del promittente) sembra la causa di questa
visione secondo cui il fatto del terzo è il
presupposto dell’obbligazione di garanzia del
promittente e non l’elemento centrale della
promessa. Il legislatore non enuncia che tipo
di collegamento esiste tra la promessa e il
fatto del terzo. Secondo gli autori che
252
accolgono tale ricostruzione questo dato
tuttavia non dovrebbe essere interpretato nel
senso di un’assenza di collegamento o peggio di
un’“inconcepibilità logica” di tale
collegamento, sol perché il compimento del
fatto del terzo non rientra nel potere del
promittente obbligato. Sembra, allora, che
l’individuazione della natura dell’obbligo del
promittente vada condotta nel solco della
relazione logico – giuridica che sussiste tra
l’interesse principale del promissario al
compimento del fatto da parte del terzo e il
contenuto dell’obbligo del promittente atto a
soddisfarlo.
In quest’ottica talune opinioni dottrinali272,
pur aderendo alla tesi dell’obbligazione di
272 M.C. CHERUBINI, op. cit., p. 30 ss.; F. MASTROPAOLO, Promessa,
cit., p. 709, p. 716 ss., p. 737.
253
garanzia, hanno riconosciuto rilevanza al
comportamento del debitore, sostenendo che la
promessa faccia nascere obblighi di
comportamento prima di tramutarsi nell’obbligo
del pagamento dell’indennizzo. Esclusa la
possibilità di configurare l’obbligo del
promittente come obbligo di procurare il fatto
altrui, perché l’attività del terzo si sottrae
al controllo da parte del promittente, il
contegno dovuto viene individuato in quello
atto ad influire in direzione dell’evento
atteso. In altri termini il promittente sarebbe
tenuto ad un’opera di persuasione, nei limiti
della correttezza e della tutela dell’interesse
del terzo a non subire ingerenze nella propria
sfera di autodeterminazione. In relazione al
rapporto che corra tra promittente e terzo
quest’attività del promittente potrà
254
estrinsecarsi nei modi più vari, dalla semplice
prospettazione dell’affare al terzo,
all’utilizzo di mezzi di pressione leciti
consentiti dalla relazione che corra tra
promittente e terzo (es. un soggetto promette
l’assunzione di un’obbligazione da parte di una
società di cui è socio di maggioranza).
12.Segue: critiche alla possibilità di configurare la
promessa come contratto con causa di garanzia.
Un orientamento dottrinale273, su cui dovremo
più ampiamente ritornare, ha messo in
discussione che l’obbligazione del promittente
possa descriversi nei termini di
un’obbligazione di garanzia afferente ad un
contratto con causa – funzione di garanzia. Si
è evidenziato che la possibilità d’individuare
una prestazione di garanzia del promittente,
273 F. NAPPI, La garanzia autonoma, Profili sistematici, Napoli 1992
255
nei termini di “cooperazione del debitore”
all’interno del rapporto obbligatorio e
assunzione del rischio della frustrazione della
promessa, non significa implicitamente fare
riferimento alla funzione negoziale che
mediante la prestazione s’intende realizzare.
In altri termini dire che un soggetto pone in
essere una prestazione di garanzia non implica
l’individuazione della causa del negozio274.
Una funzione di garanzia nei termini che si
sono descritti può infatti ravvisarsi sia in
relazione alla prestazione del fideiussore, che
in relazione alla prestazione
dell’assicuratore, sebbene la causa dei
relativi negozi sia diversa. Nel caso del
contratto di assicurazione la causa del negozio
è la eliminazione del rischio, laddove la causa
274 F. NAPPI, op. cit., p 149.
256
della fideiussione è il rafforzamento della
possibilità della soddisfazione dell’interesse
creditorio
Emerge quindi la necessità di tenere distinti
due piani dell’analisi:
1)La prestazione di garanzia, come
cooperazione del garante all’interno del
rapporto obbligatorio, che comporta una
prestazione diversa dall’azione o
omissione.
2)La funzione negoziale (causa del
contratto) in cui è inserita la
prestazione stessa.
Parlare quindi della promessa nei termini di
“garanzia dell’ assunzione del rischio
concernente la frustrazione di un rapporto
obbligatorio” non significa fornire una
257
descrizione della causa della promessa. La
giustificazione causale della promessa potrà
infatti ravvisarsi in schemi causali che non
hanno attinenza con la causa di garanzia, quale
si riscontra nelle forme tipiche e atipiche di
garanzie reali e personali.
Come già la dottrina che descrive la promessa
come fonte di un’obbligazione di garanzia aveva
correttamente evidenziato, la promessa “potrà
inserirsi in un contratto di mandato, di
commissione, di spedizione, di mediazione, in
cui il mandatario, il commissionario, lo
spedizioniere, il mediatore, invece di
assumere, i primi, le più gravose obbligazione
dello star del credere (art. 1715 e 1736),
l’ultimo quella di fideiussore (art. 1763),
promettono soltanto il consenso del terzo alla
258
conclusione del contratto che essi (nel caso
della mediazione, l’interessato)
stipuleranno”275.
La promessa potrà inserirsi in un altro
contratto come controprestazione o anche come
prestazione complementare ad altra, così come
accade nei casi esaminati in cui la promessa è
complementare al pagamento del canone (che
proprio in ragione della promessa fatta al
locatore sia stabilito in misura più bassa
rispetto al prezzo di mercato), oppure se essa
è fatta contestualmente alla vendita del
terreno (che in ragione della promessa della
vendita di un pezzo di terreno adiacente
acquista un valore di mercato maggiore).
275 SCALFI, La promessa del fatto altrui, cit., p. 107, che ritiene essere
questo l’unico caso in cui la promessa è patto o clausola di altro
contratto.
259
La dottrina che configura l’obbligazione del
promittente come obbligazione di garanzia
afferente ad un contratto di garanzia ha
sostenuto che <<la causa del contratto con cui
una parte promette all’altra che un terzo le
venderà un immobile, lo assumerà come impiegato
o rinunzierà ad un servitù è quella di garantire
la controparte dal rischio che il terzo non venda
l’immobile, non lo assuma come impiegato o non
rinunzi alla servitù>>276.
In verità analizzando i casi concreti in cui si
configura una promessa del fatto del terzo
risulterà che il promittente che “si accolla il
rischio del mancato compimento del fatto”
compensa questo sacrificio patrimoniale con
276 Così G. SCALFI, La promessa del fatto altrui, cit., p. 89, che ne
discorre come “nozione astratta di causa”. Sul punto M.C.
CHERUBINI, op. cit., p. 67 ss., nel senso confermativo della
dottrina dominante
260
un’utilità che gli viene attribuita dalla
controparte. Si è infatti correttamente
evidenziato che “in alcuni dei casi descritti
il promittente riceve come conseguenza della
promessa un vantaggio patrimoniale, che trova
rispondenza nel sacrificio patrimoniale
subito277”.
Se allora la promessa s’inserisce in un
regolamento d’interessi più ampio, sarà giusto
individuare la causa della promessa in
relazione alla giustificazione causale di quel
negozio in cui la promessa s’inquadra. Il
regolamento d’interessi che include la promessa
dovrà in altri termini necessariamente
integrare la causa di quest’ultima, qualora
essa non si presenti in via autonoma. Si
perviene in tal modo alla conclusione che gli
277 SCALFI, Promessa del fatto altrui, cit., p. 87.
261
schemi causali da riconoscere a fondamento
della promessa possono essere diversi e
risulterà quindi essere una forzatura
l’individuazione di una sua generica e costante
causa di garanzia278.
13. Segue: critica alla configurazione di un contratto con
causa generica costante e causa specifica variabile.
La medesima problematica della giustificazione
causale del contratto si ritrova in altri
istituti disciplinati dalla legge, la cessione
del credito e la cessione del contratto.
L’affinità tra la promessa e i detti contratti
sotto il profilo della giustificazione causale
ha indotto talvolta la giurisprudenza279 ad
applicare alla promessa del fatto del terzo la
costruzione di contratto con “causa generica”,278 F. NAPPI, op. cit., p. 153.279 Pret. Messina, 22 luglio 1961, in Rep. Foro it., 1962, voce
obbligazioni e contratti, c. 1923ss., nn. 236 – 237.
262
elaborata per la descrizione della causa del
contratto di cessione. Tale causa, come
sostengono i fautori di detta tesi,
ricorrerebbe quando <<un interesse, che di per
sé preso in considerazione non è idoneo a dare
un contenuto sufficiente al contratto ed è in
grado di fornire, se mai, soltanto parte di uno
schema contrattuale, onde deve essere integrato
in uno schema più ampio e in un più ampio
sistema d’interessi, può in concreto assumere
un rilevante grado di autonomia agli occhi del
legislatore così da meritare una disciplina
autonoma>>280. L’interesse in questione nel caso
della cessione del contratto o del credito
sarebbe il generico interesse al trasferimento
(causa generica), distinto dall’interesse
specifico variabile ad una attribuzione280 PANUCCIO, La cessione volontaria dei crediti nella teoria del trasferimento, cit.,
p. 27.
263
gratuita o onerosa” (causa specifica); nel caso
della promessa la causa generica sarebbe
costituita dall’assunzione della garanzia.
La possibilità d’individuare un generico
interesse al trasferimento, senza che si faccia
riferimento al fine di liberalità o di lucro
per cui il trasferimento è fatto, è stata
criticata281; similmente si critica la
configurazione della esistenza di una doppia
causa, generica e specifica, nel contratto di
promessa del fatto del terzo282. Il riferimento
alla superata impostazione dottrinale serve
però per comprendere la necessità di
evidenziare che così come l’intento di
trasferire il credito non costituisce causa
sufficiente del contratto, dovendo farsi
281 CICALA, Il negozio di cessione del contratto, Napoli, 1962, p. 127 ss.282 Tra gli altri E. BRIGANTI, op. cit., p. 119 ss.
264
necessariamente riferimento a quegli schemi
causali che giustificano il trasferimento del
credito (vendita, cessione d’azienda, permuta),
così la promessa alla controparte che “un terzo
le venderà un immobile, lo assumerà come
impiegato o rinunzierà ad un servitù” non può
fondarsi su una generica causa di garanzia del
contratto, ma su una causa che giustifichi il
complessivo assetto d’interessi che il
contratto realizza”.
Del resto negli stessi contratti tipici in cui
è contenuta una prestazione di garanzia, questa
non trova in sé la propria giustificazione
causale. Nella fideiussione per esempio
l’obbligazione di garanzia del fideiussore
rinviene la propria giustificazione causale
265
nell’esigenza di rafforzamento del rapporto
obbligatorio principale.
Per la promessa del fatto del terzo quindi la
semplice prestazione di garanzia non è idonea a
fornire una adeguata giustificazione causale.
Appare fondato, sotto questo aspetto,
l’orientamento dottrinale283 secondo cui per
avere comprensione del fenomeno complessivo si
deve partire dal dato che il termine garanzia
oltre ad indicare la causa negoziale, può
essere utilizzato per esprimere la natura, la
funzione della prestazione dovuta, la quale può
contribuire a realizzare svariati schemi
causali.
Questo fenomeno di un’obbligazione di garanzia,
che può essere sorretta da svariati fondamenti
283 F. NAPPI, op. cit., p. 156; C. CASTIGLIA, Promesse unilaterali atipiche, in
Riv. dir. comm., 1983, p. 392 ss.,
266
causali, ha una sua tipica manifestazione nella
promessa del fatto altrui ex art. 1381. La
possibilità d’individuare nella prestazione del
promittente una prestazione di garanzia non
comporta di per sé la possibilità di fondare la
promessa su di una causa di garanzia.
14. Rigetto della nozione di causa – funzione di garanzia
applicabile alla promessa e individuazione del suo
fondamento causale, per il caso che essa non s’innesti in un
più ampio regolamento negoziale.
Anticipando un argomento su cui si tornerà
ampiamente nel terzo capitolo del presente
lavoro, occorre qui fare riferimento alla
critica a quella opinione dottrinale secondo
cui la promessa del fatto del terzo costituisce
il modello tipico attraverso il quale si presta
una garanzia autonoma, una garanzia cioè che
267
non presenta i caratteri dell’accessorietà
propri delle garanzia personali.
Nell’ambito di uno studio sulle lettere di
patronage284 si è evidenziato che quando si parla
di causa di garanzia, intendendo i vari modi di
prestare una garanzia, emerge che <<la causa
funzione di garanzia consiste nel far sì che il
creditore garantito, che si attende in via
primaria da un terzo la soddisfazione di un
proprio interesse, veda accresciuta la
possibilità di realizzare tal interesse
attraverso l’obbligazione del garante. Tutte le
volte che un soggetto s’impegna verso un altro a proteggere
l’interesse che quest’ultimo si attende venga soddisfatto dal
terzo, si può dire che c’è causa di garanzia>>285.
284 ; A. MAZZONI, Lettere di patronage, mandato di credito e promessa del fatto del
terzo, in Banca borsa e tit. cred., 1984, I, p. 334 ss;285 A. MAZZONI, o. u. c., p. 359.
268
Prosegue la dottrina in esame dicendo che
intendendo in tal modo la nozione causale di
garanzia, dal suo ambito rimane esclusa
l’obbligazione che comporta assunzione di un
mero rischio, perché in tal ipotesi il
creditore non si attende la soddisfazione di un
proprio interesse dal terzo; vi rientra invece
l’impegno del garante posto in relazione ad un
interesse che non poggia su una preesistente
obbligazione del terzo verso il beneficiario,
proprio perché l’obbligazione del garante si
pone in relazione alla soddisfazione di un
“interesse” che il garantito si attende sia
soddisfatto in via primaria da un terzo, e non
di un credito. La promessa del fatto del terzo
rientrerebbe, com’è evidente, nell’alveo dei
contratti che presentano tale causa - funzione
di garanzia in senso lato, essendo per tale
269
profilo assimilabile a quei contratti tipici e
atipici “di garanzia”.
Si è obiettato286 che il ricondurre ad una
categoria unitaria (negozi di garanzia) figure
diverse, fideiussione, garanzie autonome,
promessa del fatto del terzo, comporta un errore
di metodo, ossia l’eliminazione delle
peculiarità strutturali e quindi di
funzionamento della fideiussione e in genere di
quegl’istituti che presuppongono un rapporto
giuridico principale. La promessa del fatto del
terzo non potrà fondarsi sullo schema di
funzionamento di quegl’istituti.
Applicando lo schema della causa cavendi dovrebbe
dirsi che il fondamento della promessa sia
nella protezione dell’interesse del promissario
che, se pure non creditorio, è idoneo a286 A. CHECCHINI, op. cit., p. 597 ss.
270
giustificare la promessa. L’interesse del
promissario dovrebbe costituire giusta causa
dell’attribuzione del garante, pur non essendo
rivestito dei caratteri del diritto soggettivo;
se l’interesse però non integra un diritto
soggettivo non ha dall’ordinamento quel
riconoscimento che gli permette di costituire
giusta causa dell’attribuzione in un diverso
rapporto (di garanzia).
L’accessorietà della fideiussione comporta una
circolarità di attribuzioni patrimoniali per
cui il peso definitivo del debito è destinato
normalmente a gravare sul debitore principale,
perché il fideiussore che paga può avvalersi
della surrogazione e del regresso verso lo
stesso287. Così si spiega perché per la
fideiussione non si ponga il problema della287 E. BRIGANTI, op. cit., p. 30 ss.
271
giusta causa dello spostamento patrimoniale e
si possa parlare di causa cavendi
dell’obbligazione fideiussoria.
In realtà nella fideiussione nessuno si
arricchisce senza causa, esiste un debito, se
il fideiussore paga può rivalersi sul debitore.
La disciplina complessiva della fideiussione è
ispirata a questo meccanismo della circolarità
degli spostamenti patrimoniali (la fideiussione
non obbliga in duriorem causam, art. 1941, se non
può avere effetto la surrogazione per fatto del
creditore il fideiussore è liberato, art. 1956,
se è messo in pericolo il regresso vi sono
strumenti di protezione del fideiussore, art.
1953, né obbliga per una obbligazione invalida,
art. 1939, salvo che per incapacità).
272
La causa di garanzia nella fideiussione è
intimamente collegata all’accessorietà
dell’obbligazione di garanzia rispetto al
rapporto principale (accessorietà che comporta
spostamenti patrimoniali circolari). Tale
accessorietà non può certo ravvisarsi nella
promessa del fatto del terzo e non ha senso
parlare di “un’accessorietà dell’obbligo del
promittente rispetto ad un mero interesse del
promissario, se non si spiega perché tale
interesse giustifica uno spostamento
patrimoniale”288. Dunque lascia perplessi
l’affermazione che la garanzia prestata dal
promittente accede ad un interesse (che non
integra un diritto soggettivo) e trae da tale
legame la sua giustificazione causale, allo288 F. NAPPI, op. cit., p. 86 ss, p. 92, p. 156, p. 197, critico
verso quanto sostengono MAZZONI, Lettere di patronage mandato di credito,
cit., p. 361 e DE SANNA, op. cit., p. 41 ss, 61 ss, 78 e
MASTRROPAOLO, Promessa, cit., p. 747.
273
stesso modo in cui la fideiussione accede
all’interesse creditorio garantito.
Quando la promessa non s’innesta in un
regolamento d’interessi più ampio che ne
fornisca il supporto causale, i suoi effetti
possono essere spiegati abbandonando lo schema
causale (sia pure allargato) della garanzia: la
promessa si giustificherà sulla base di un
interesse specifico del promittente, o forse
anche del suo animus donandi289.
Parlando di promessa di garanzia si farà
riferimento non alla causa della promessa, ma
alla natura (di garanzia) dell’effetto. In
altri termini “un fondamento alla garanzia
autonoma (quale può ritenersi la promessa) può
essere rinvenuto nelle comuni ragioni
giustificatrici di un negozio (un289 G. CASTIGLIA, Promesse unilaterali atipiche, cit., p. 391 ss
274
corrispettivo, lo spirito di liberalità …),
piuttosto che costringendo la garanzia autonoma
entro lo schema causale della causa cavendi (o
uno schema ad esso ispirato).
15. Orientamento della Cassazione: duplice obbligazione a
carico di chi promette il fatto del terzo.
Sulla base di un orientamento interpretativo
ormai ultradecennale avuto inizio nel 1995290,
la Cassazione ritiene che con la promessa del
fatto del terzo il promittente assume una prima
obbligazione di facere consistente
nell’adoperarsi affinché il terzo tenga il
comportamento promesso, per soddisfare
l’interesse primario del promissario
all’ottenimento del fatto stesso. Qualora
290 Cass., 20 dicembre 1995, n. 12973, in Foro it., 1996, I, c. 1731
ss.; Cass., 24 gennaio 2003, n. 1137, in Contratti 2003, con nota di
C. Leo, La promessa del fatto del terzo tra indennizzo e risarcimento, p. 977 ss.;
Cass., 15 luglio 2004, n. 13105.
275
nonostante il promittente si sia adoperato, il
terzo rifiuti d’impegnarsi, nasce una seconda
obbligazione di « dare », cioè di corrispondere
l’indennizzo.
La tesi si pone in maniera evidente come un
compromesso tra le teorie formulate in merito
all’inquadramento dell’obbligo nascente dalla
promessa. Tale ricostruzione dell’obbligo
assunto dal promittente costituisce, infatti,
un tentativo di superamento dei limiti che si
sono imputati alla teoria secondo cui dalla
promessa nasce un obbligo di fare, e a quella
secondo cui dalla promessa nasce
un’obbligazione di garanzia. Come esposto nei
paragrafi precedenti, contro quest’ultima si è
detto che l’attenzione riposta nella garanzia
del compimento del fatto del terzo non
276
metterebbe bene in evidenza che, essendo
l’interesse primario del promissario quello di
ottenere il compimento del fatto da parte del
terzo, il promittente non potrebbe non assumere
un obbligo di attivarsi perché l’evento sperato
si verifichi; l’idea secondo cui il promittente
assumerebbe l’obbligo di fare, di adoperarsi
affinché il terzo compia il fatto, è stata
invece criticata sotto il profilo opposto, cioè
perché trascurerebbe l’operatività dell’obbligo
di pagare l’indennizzo, a prescindere dalla
diligenza impiegata dall’obbligato nel
convincere il terzo.
La nascita del doppio obbligo comporta, invece,
che qualora l’obbligazione di facere non venga
adempiuta e l’inesecuzione sia imputabile al
promittente ovvero venga eseguita in violazione
277
dei doveri di correttezza e buona fede, il
promissario avrà a disposizione gli ordinari
rimedi contro l’inadempimento, quali la
risoluzione del contratto, l’eccezione
d’inadempimento, l’azione di adempimento. Gli
spetterà inoltre il risarcimento del danno
qualora a seguito di tale inadempimento subisca
un pregiudizio economicamente valutabile e
sussista il nesso di causalità fra
inadempimento ed evento dannoso.
Qualora, invece, il promittente abbia adempiuto
a tale obbligazione di facere, ma ciononostante
il promissario non ottenga il risultato sperato
a causa del rifiuto del terzo, diverrà attuale
l’altra obbligazione di «dare», in virtù della
quale il promittente sarà tenuto a
corrispondere l’indennizzo.
278
Nel caso in cui si prometta un fatto per cui
non esiste, per la natura del fatto promesso,
un potere del promittente d’indurre il terzo ad
adempiere, sarà logico ritenere che l’unico
obbligo eventuale per il promittente sarà
quello di pagare l’indennizzo per il caso in
cui il terzo non compia il fatto promesso
(esempio: fattispecie relativa a promessa del
fatto della pubblica amministrazione,
consistente nell’adozione di uno «strumento
urbanistico» idoneo a ricondurre il complesso
immobiliare promesso in vendita, composto da
alloggi di servizio dell’ente telefonico,
nell’ambito delle civili abitazioni, pienamente
commerciabili dal promissario acquirente – caso
deciso da Cassazione, 15 luglio 2004, n. 13105
-).
279
Merita di essere ricordato che nella citata
sentenza del 2004, la Cassazione ha avuto modo
di ribadire il principio secondo cui
l’interpretazione dei contratti da parte del
giudice di merito é censurabile in sede di
legittimità per vizi di motivazione e per
violazione delle regole legali di ermeneutica
contrattuale. La parte che denuncia la
violazione di tali regole ha l’onere di
dimostrare specificamente il modo in cui il
ragionamento seguito dal giudice di merito
abbia deviato dalle regole stesse, non potendo
invece limitarsi a prospettare una
interpretazione contrattuale diversa da quella
adottata nella decisione impugnata (nella
specie, nella sentenza di merito, l’accordo
contrattuale riguardante una promessa del fatto
del terzo era stata ricostruita in termini
280
derogatori rispetto al modello legale di cui
all’art. 138l c.c., attraverso la limitazione
della responsabilità del promittente, in caso
d’insuccesso dell’iniziativa condotta presso il
terzo - pubblica amministrazione, alla sola
restituzione della somma data a titolo di
caparra, oltre interessi, senza l’obbligo del
pagamento dell’indennizzo).
16. Natura dell’obbligo del pagamento dell’indennizzo: tra
autonomia ed equivalenza con il risarcimento.
L’art. 1381 pone al carico del promittente
l’obbligo di pagare un indennizzo al
promissario per il caso in cui il terzo non
compia il fatto o assuma l’obbligazione.
L’impiego del termine indennizzo ha dato luogo
ad una ampia disputa circa la natura da
281
attribuirgli e quanto alla determinazione in
concreto del quantum debetur.
È da considerare in via di premessa che
l’individuazione della natura dell’indennizzo e
la determinazione dell’ammontare da
corrispondere sono speculari all’idea che si
abbia circa la natura giuridica
dell’obbligazione del promittente.
La configurazione dell’obbligo del promittente
come obbligo di fare comporta che si ravvisi
nel mancato compimento del fatto del terzo
l’inadempimento del promittente, che sarà
conseguentemente obbligato al risarcimento del
danno da inadempimento. L’indennizzo in
quest’ottica avrà funzione risarcitoria e i
parametri di determinazione del suo ammontare
282
saranno quelli che presiedono alla
determinazione del danno da risarcire.
Coloro che sostengono la tesi dell’assunzione
da parte del promittente di una obbligazione di
garanzia per il compimento del fatto da parte
del terzo, individuando l’oggetto della
garanzia direttamente nel fatto del terzo,
ritengono che l’indennizzo rappresenti
l’equivalente economico del fatto promesso291.
Anche secondo tale orientamento si ridimensiona
radicalmente la differenza tra indennizzo e
risarcimento, riducendosi in sostanza ad una
peculiarità di genesi dei due istituti, ma
senza conseguenze pratiche in ordine alla
determinazione del quantum debetur: l’indennizzo,291 Cass., 5 maggio 1993, n. 5216, in Riv. dir. sport., 1993, p. 471;
Cass. 16 novembre 1981, n. 6071, in Arch. civ., 1982, p. 476 ss.;
SCALFI, op. cit., p. 134; F., ALCARO, op. cit., p .81; A. MAZZONI, Le
lettere, op. cit., p. 306; M.C. CHERUBINI, op. cit., p. 37, 50 ss.; M.R.
MARELLA, op. cit., p. 390.
283
a differenza del risarcimento, non è la
conseguenza di un inadempimento (art. 1218) o
di un atto illecito (art. 2043),
conseguentemente non sarebbe volto al ristoro
di un danno antigiuridico. Mancherebbe però di
fatto una differenza di disciplina
significativa tra il risarcimento e
l’indennizzo che induca ad attribuire
all’indennizzo un significato diverso da quello
di equivalente economico del fatto promesso292.
La citata dottrina sostiene che la differenza
tra risarcimento e indennizzo nasce da una
concezione sanzionatoria della responsabilità civile, che ha
il fulcro sull’elemento della colpa e
dell’antigiuridicità del fatto, piuttosto che
sulla riparazione del danno cagionato. Secondo
tale visione il risarcimento sarebbe legato al
292 E. BRIGANTI, op. cit., p. 188.
284
contegno antigiuridico del responsabile e
avrebbe una funzione sanzionatoria, mentre
l’indennizzo prescinderebbe dal contegno
illecito e dalla colpa e avrebbe funzione
reintegratoria, risolvendosi nell’obbligo di
versare un corrispettivo di entità pari al
valore del bene colpito, quindi diverso e
certamente inferiore rispetto al
risarcimento293.
Gli autori che rigettano la tesi della
diversificazione dell’indennizzo dal
risarcimento, evidenziano che in relazione alla
funzione della responsabilità civile
bisognerebbe porre in primo piano la lesione
cagionata e commisurare conseguentemente la
responsabilità all’entità del danno, piuttosto che alla gravità
293 RUBINI, La responsabilità patrimoniale, Torino, 1956, p. 6.; BARBERO,
Sistema istituzionale del diritto privato italiano, II, cit., p. 123 ss.
285
della colpa294. Si promuove in tal senso uno
“spostamento di prospettiva dall’agente alla
vittima”, o anche una “obiettivizzazione del
dato in rapporto al quale va pronunciato il
giudizio di responsabilità”. In quest’ottica
non sussisterebbe una differenza di funzione
tra risarcimento ed indennizzo295. Tale tesi
sembrerebbe avvalorata dal rilievo che nella
pratica i criteri di determinazione del danno
da indennizzare coincidono con quelli
utilizzati per la determinazione del danno da
risarcire296.
294 RODOTA’, Il problema della responsabilità civile, Milano, 1964, p. 58 ss.;
TRIMARCHI, Rischio e responsabilità oggettiva, Milano, 1961; SCOGNAMIGLIO,
Responsabilità civile, cit., p. 638 ss.; COMPORTI, Esposizione al pericolo e
responsabilità civ., Napoli, 1965, p. 9 ss.295 SCALFI, La promessa del fatto altrui, cit., p. 134 ss; RASCIO,
Giurisprudenza e dottrina su varie questioni relative ad un caso di promessa del fatto del
terzo, cit., p. 563; E. BRIGANTI, op. cit., p 188 ss.296 Tra le altre: Cass., 15 novembre 1973, n. 3036, in Rep. Foro It.,
1974, voce Contratto in genere, c. 515, n. 221; SCALFI, op. cit. p.
134 ss.; F. ALCARO, op. cit., p 80 ss; E. BRIGANTI, op. cit., p 187.
286
Questa pretesa equivalenza funzionale tra
indennizzo e risarcimento contrasta però, a ben
vedere, con il rilievo che sembra avere nella coscienza
sociale il contegno tenuto dal debitore in
relazione alla produzione di un pregiudizio
economico, rilevando sotto questo aspetto se il
danno derivi da un atto lecito o piuttosto da
un inadempimento o da un atto illecito. La
Cassazione, ormai per tradizione
ultradecennale, ha accolto la differenza tra
l’indennizzo contemplato dall’art. 1381 e il
risarcimento del danno297.
Sulla base di tali considerazioni un A. ha
sostenuto che <<l’indennizzo ha la funzione di eliminare il
pregiudizio subito dall’oblato per avere affrontato un
297 Cass. 11 novembre 1992, n. 12118, in Giust. civ., 1993, primo, p.
2179; Cass. 20 dicembre 1995, n. 12973, in Foro it., 1996, primo, c.
1731 ss; Cass. 5 settembre. 1997, n. 8614, in Studium iuris, 1998, p.
190; Cass., 24 gennaio 2003, n. 1137, cit., p. 977 ss.
287
determinato sacrificio economico nell’interesse del
promittente>>298. Se il terzo non compie il fatto
promesso il promissario non avrebbe diritto al
ristoro, per equivalente economico,
dell’interesse all’ottenimento di quella
specifica utilità rappresentata dal compimento
del fatto, perché il promissario non ha diritto
al fatto del terzo e il promittente non ha
colpa del rifiuto del terzo. La funzione
dell’indennizzo sarebbe allora quella di
riparare il pregiudizio subito dal promissario
per l’iniziativa intrapresa. In un normale
rapporto obbligatorio il rischio
dell’inadempimento della prestazione resta a
carico del contraente; nel caso della promessa,
invece, il compimento del fatto è garantito dal
promittente, nel senso che sarà quest’ultimo298 A. CHECCHINI, Indennizzo e risarcimento nella promessa del fatto del terzo,
cit., p. 563 ss.
288
che ne subirà le conseguenze, dovendo
restituire al promissario ciò di cui costui si
sia impoverito nell’interesse (anche non
patrimoniale) del promittente. Il fondamento di
tal indennizzo sembra allora rinvenirsi proprio
nel fatto che il promittente ha un qualche
interesse alla stipula della promessa, da cui
riceve un vantaggio e in virtù di tale
interesse si assume consapevolmente il rischio
della frustrazione della promessa.
Sulla base di tale ragionamento dovrebbe
sostenersi che se alla promessa non consegue
una qualche prestazione da parte del
promissario, oppure l’assunzione di un rischio
di un pregiudizio economico, o ancora un
comportamento attivo del promissario che ha
riflessi patrimonialmente valutabili (il
289
promissario ad esempio fa acquisti nella
prospettiva del compimento del fatto da parte
del terzo), non ci sia alcuno spazio per la
configurazione di un indennizzo299. La bontà di
una tale conclusione è tuttavia tutta da
dimostrare, perché ipotizzando una promessa
disinteressata da parte del promittente, che
sia mosso da puro spirito di liberalità,
sarebbe da dimostrare che in caso di mancato
compimento del fatto del terzo al promissario
non spetti un indennizzo. La lettera dell’art.
1381 non sembra contemplare una tale eccezione.
Allora, se appare ragionevole la configurazione
di una funzione reintegratoria dell’indennizzo,
volto a ristorare il promissario del
pregiudizio economicamente valutabile che ha
subito per aver confidato nel buon esito della299 A. CHECCHINI, La promessa del fatto del terzo, in Trattato di diritto privato a
cura di Mario Bessone, volume tredicesimo, Torino, 2002, p. 396.
290
promessa, non sembra altrettanto sicuro che si
possa escludere tout court la possibilità del
pagamento dell’indennizzo quando il promissario
non abbia subito un pregiudizio economico.
Tuttavia, la questione circa la possibilità di
porre in essere una valida promessa del fatto
del terzo, con obbligazione del solo
promittente e senza che il promissario faccia o
subisca alcunché per l’ottenimento della
promessa, sembra avere rilevanza più teorica
che pratica. Tale asserzione muove dall’analisi
del Repertorio giurisprudenziale: ad oggi
sembra infatti che mai all’attenzione della
giurisprudenza sia pervenuto un caso in cui il
promissario avesse fatto affidamento nella
promessa e nel conseguente obbligo del
promittente di tenerlo indenne per il caso in
291
cui il terzo si rifiutasse di compiere il fatto
promesso, senza che tale affidamento si
radicasse nella sopportazione di un qualche
peso economico, in relazione ad un regolamento
d’interessi tra quest’ultimo e il promittente.
Per quanto riguarda la determinazione del
quantum debetur, la giurisprudenza in alcuni casi
assume a fondamento delle proprie decisioni il
principio del ragguaglio dell’indennizzo al
valore della prestazione attesa, ma applica poi
di fatto il criterio del pregiudizio economico
subito dal promissario, ispirandosi per esempio
al costo della prestazione eseguita dal
promissario300. Sembra allora che la possibilità
di configurare l’indennizzo com’equivalente
economico del fatto promesso sia puramente
300 Trib. Ancona, 11 novembre 1994, in Giust. civ., 1995, primo, p.
1657.
292
accidentale, cioè legata all’eventualità che il
promissario abbia eseguito nell’interesse del
promittente una prestazione, o subito altra
forma di detrimento patrimoniale, di entità
pari al valore economico della prestazione
attesa dal terzo.
Se è vero il ragionamento effettuato, la
giustificazione del pagamento dell’indennizzo
sembra doversi ravvisare nello scambio tra la
promessa e la prestazione del promissario,
ossia nella reciprocità di sacrifici economici.
La garanzia prestata dal promittente in
quest’ottica si configura come garanzia di
riequilibrio economico, che elimina il
pregiudizio subito dal promissario che ha fatto
affidamento sul buon esito della promessa. In
questo senso si parla di una funzione restitutoria
293
dell’indennizzo301, volto a ristorare il promissario
del pregiudizio economico che ha subito in
relazione al mancato compimento del fatto del
terzo.
17. Questioni in tema d’indennizzo.
A) Misura dell’indennizzo
Il legislatore, nella laconica formulazione
dell’art. 1381, non chiarisce a quali parametri
ancorare la determinazione dell’indennizzo;
conseguentemente l’interpretazione che si
accolga circa la natura e la funzione del
pagamento di esso influenzerà la determinazione
in concreto del quantum debetur. Al riguardo in
giurisprudenza ed in dottrina si sono affermati
diversi orientamenti.
301 A. CHECCHINI, La promessa del fatto del terzo, cit., p. 398.
294
a) Secondo un primo orientamento302,
assolutamente maggioritario in dottrina,
l’indennità dovuta dal promittente dovrebbe
essere ragguagliata al valore dell’utilità non
conseguita dal promissario, rappresentando il
pagamento dell’indennizzo la soddisfazione in
via succedanea dell’interesse del promissario
al fatto oggetto della promessa. Se essa sia
stata fatta verso un corrispettivo, nella
determinazione dell’indennità si dovrebbe
tenere conto della diminuzione patrimoniale che
il promissario ha subito, perché questa
rapprenderebbe l’aspettativa di profitto
nutrita dal promissario, così come quantificata
dalle parti. Laddove non sia stato pattuito un
controvalore, la misura dell’indennizzo da
302 SCALFI, op. cit., p. 134 ss.; STASI, op. cit., p. 76; E. BRIGANTI,
op. cit., p. 186 ss; F. ALCARO, op. cit., p. 81; M.C. CHERUBINI, op.
cit., p. 50 ss.; M. R. MARELLA, op. cit., p. 390.
295
corrispondere al promissario si dovrebbe
determinare sulla base del valore di mercato
del bene o della prestazione promessa; quando
invece la prestazione promessa non abbia un
valore di mercato, il giudice dovrebbe
stabilire equitativamente la misura
dell’indennizzo (in un caso la Cassazione ha
determinato la misura predetta sulla base di
una penale precedentemente stabilita dalle
parti303).
Sebbene l’indennizzo non rappresenti il
contenuto di una responsabilità per
inadempimento, per la determinazione della
somma da corrispondere al promissario sarebbero
applicabili in via analogica i criteri che
presiedono alla determinazione del danno da
303 Cass., 21 giugno 1991, n. 6984, in Foro it., 1992, I, c. 1249, con
nota di Ponzanelli.
296
inadempimento (art. 1223 ss., cod. civ.). Alla
stregua del citato articolo il promissario
dovrebbe essere ristorato della perdita che ha
subito, ma anche del mancato guadagno, in
quanto ne siano conseguenza immediata e
diretta. La somma da corrispondere a titolo di
risarcimento del danno da lucro cessante
andrebbe stabilita dal giudice con equo
apprezzamento delle circostanze del caso, ai
sensi dell’art. 2056, 2° comma., cod. civ.
Riguardo quest’ultima questione un A.304 ha
sostenuto che l’obbligo del pagamento
dell’indennizzo si pone al di fuori della
responsabilità per inadempimento (applicandosi
solo in via analogica le relative norme), ma
anche della responsabilità ex art. 2043 ss;
sicché, ritiene l’A., sembrerebbe più giusto
304 M.C. CHERUBINI, op cit., p. 51.
297
applicare l’art. 1226 cod. civ., secondo cui il
giudice liquida il danno con valutazione
equitativa solo se quest’ultimo non può essere
provato nel suo preciso ammontare. Seguendo
tale impostazione, se è possibile stabilire con
certezza la misura del mancato guadagno, non si
applicherà la regola della valutazione
equitativa stabilità dall’art. 2056, comma 2°,
cod. civ.
Infine si è sostenuta305 l’applicabilità del
secondo comma dell’art. 1227 cod. civ., alla
luce del quale il risarcimento non è dovuto per
i danni che il creditore avrebbe potuto evitare
usando l’ordinaria diligenza. Alla stregua
dell’art. 1223 cod. civ., il danno risarcibile
dev’essere conseguenza immediata e diretta del
mancato compimento del fatto del terzo, sicché
305 M.C. CHERUBINI, op. cit., p. 52.
298
la negligenza del promissario interromperebbe
il nesso eziologico tra fatto dannoso ed
effetto; il danno sarà allora conseguenza
mediata del fatto dannoso e come tale non
risarcibile alla stregua dell’art. 1223 cod.
civ.
Quanto all’applicabilità della norma posta dal
1° comma dell’art. 1227 cod. civ., occorrerebbe
distinguere. Il comma citato riguarda l’ipotesi
in cui il creditore concorra con il debitore
nella provocazione dell’evento produttivo del
danno. Ne consegue la diminuzione del
risarcimento secondo la gravità della colpa del
creditore e l’entità delle conseguenze che ne
sono derivate. La limitazione dell’entità del
risarcimento sarebbe possibile solo nei casi in
cui si configuri la responsabilità del
299
promittente per la mancata o inesatta
esecuzione del fatto del terzo, oppure per il
mancato adempimento dell’obbligo di
corrispondere l’indennizzo. L’impossibilità di
applicare la norma, per limitare l’entità
dell’indennizzo, deriva dalla costatazione che
il contegno colpevole del promissario non
potrebbe influenzare la determinazione di
volontà del terzo e non potrebbe concorrere a
cagionare il danno rappresentato dal mancato
compimento del fatto del terzo.
In sostanza, secondo tale orientamento, la
differenza dogmatica che esiste tra indennizzo e risarcimento
non avrebbe alcuna rilevanza riguardo alla determinazione in
concreto dell’indennità dovuta. In particolare si è
sostenuto306 che non essendo la responsabilità
indennitaria responsabilità da inadempimento in
306 M.R. MARELLA, op. cit., p. 390.
300
senso tecnico, ma piuttosto l’oggetto di
un’obbligazione di garanzia, il legislatore ha
scelto il termine indennizzo e non quello di
risarcimento, perché servirebbe a chiarire che
non si tratta di una sanzione per un
inadempimento. Il che però non precluderebbe in
concreto la possibilità di fare ricorso ai
medesimi parametri per la determinazione
dell’ammontare da corrispondere.
b) Un tentativo di soluzione delle perplessità
che sono state espresse in dottrina circa la
possibilità di distinguere tra risarcimento e
indennizzo, quando si tratti di determinare
l’ammontare di quest’ultimo, è stato effettuato
dall’Autore citato307 che ha sostenuto la tesi
secondo cui l’indennizzo avrebbe la funzione di eliminare il
307 A. CHECCHINI, Indennizzo e risarcimento nella promessa del fatto del terzo,
cit., p. 563 ss.
301
pregiudizio subito dal promissario per avere affrontato un
determinato sacrificio economico nell’interesse del
promittente. Secondo tal opinione, il
corrispettivo pagato per la stipula della
promessa circoscriverebbe il pregiudizio
indennizzabile subito dal promissario, salva la
prova di un maggior danno subito da costui,
rispetto alla prestazione eseguita, a causa
delle occasioni perdute308.
Qualora invece la promessa acceda ad
un’operazione economica tra le parti, la
determinazione dell’indennizzo passa attraverso
la stima del “minor valore che il promissario
308 A. CHECCHINI, La promessa del fatto del terzo, cit., p. 422.
Quest’ultima affermazione sembra aprire una falla nella tesi
dell’autore, costituendo, a mio parere, una apertura verso la tesi
secondo cui l’indennizzo ha una funzione satisfattoria
dell’interesse al fatto promesso. L’aderenza ad una funzione
“meramente restitutoria” dell’indennizzo comporterebbe che il
promittente si limiti a “restituire” quanto pagato dal promissario
302
ha ottenuto nel negozio garantito”309, rispetto
al sacrificio che ha affrontato, non
contemplandosi nel calcolo dell’indennizzo
dovuto il mancato guadagno del promissario
(esempio: il promissario acquista un immobile
senza la licenza che la pubblica
amministrazione non ha concesso)310.
Infine nel caso in cui l’iniziativa del
promissario non consenta una valutazione
economica oggettiva del sacrificio da lui
affrontato, il giudice dovrebbe procedere ad
309 A. CHECCHINI. La promessa del fatto del terzo, cit., p. 422.310 Non si comprende, a mio parere, perché nel caso in cui la
promessa sia stata fatta verso un corrispettivo bisognerebbe
calcolare nell’indennizzo le occasioni perdute dal promissario che
ha fatto affidamento sulla promessa, ed invece nel caso in cui la
promessa acceda ad una operazione economica tra le parti non si
debba tener conto del mancato guadagno che il promissario avrebbe
potuto conseguire (ad esempio Tizio promette a Caio che Sempronio
rinuncerà ad una determinata servitù sul suo fondo. Mevio è
interessato all’acquisto del fondo, ma solo a condizioni che non
ci sia alcuna servitù. Se Sempronio non rinuncia alla servitù sul
fondo di Caio, costui non potrà vendere il fondo a Mevio).
303
una valutazione secondo equità (esempio: il
promissario ha accettato sulla base della
promessa di concludere un negozio con il terzo,
che altrimenti non avrebbe concluso).
c) Le indicazioni giurisprudenziali circa la
determinazione dell’indennizzo da corrispondere
al promissario sono contrastanti. Secondo un
primo orientamento311, sussisterebbe un’equivalenza
funzionale tra risarcimento ed indennizzo, per cui
l’unica differenza di rilievo tra i due rimedi
starebbe nell’impossibilità di ottenere una
reintegrazione in forma specifica, in
alternativa al pagamento dell’indennizzo; per
la determinazione in concreto di questo,
sarebbero invece applicabili gli stessi criteri
311 Cass., 10 febbraio 1984, n. 1024, in Giust. civ., 1984, I, p.
3383; Cass., 16 novembre 1981, n. 6071, in Arch. civ., 1982, p. 476.
304
che presiedono alla determinazione del danno da
risarcire.
Un secondo orientamento, maggioritario in
giurisprudenza, evidenzia la differenza che sussiste tra
i due rimedi sotto il profilo genetico e funzionale. Il
risarcimento è sanzione da atto illecito o da
inadempimento e mira a ricostruire la
situazione patrimoniale del danneggiato;
l’indennizzo prescinde dalla colpa e
dall’inadempimento e ha la funzione di
compensare la lesione di un interesse altrui312.
Da questa distinzione le citate sentenze fanno
anche derivare una conseguenza di ordine
processuale, per cui sarebbe inammissibile,
sulla base del divieto di proporre domande
nuove in appello (art. 345 cod. proc. civ.),312 Cass., 9 settembre, 1997, n. 8164, in Studium iuris, 1998, p. 190;
Cass., 27 settembre 1996, n. 8522, in Mass. giust. civ., 1996; Cass.,
21 giugno 1991, n. 6984, in Foro it., 1992, I, p. 1248.
305
richiedere per la prima volta in grado di
appello l’indennizzo, se in primo grado sia
stato richiesto il risarcimento del danno. Le
conseguenze pratiche in tema di determinazione
dell’indennizzo sono però meno chiare delle
premesse. Talvolta viene escluso dal quantum
dell’indennizzo il calcolo del lucro
cessante313; in altri casi si è ritenuto che il
giudice dovesse valutare equitativamente
l’ammontare dell’indennizzo, essendo ogni altro
criterio di liquidazione ritenuto non
applicabile alla determinazione dell’indennizzo
ex art. 1381 cod. civ.314
B) Presupposti della corresponsione
dell’indennizzo: impossibilità sopravvenuta del
fatto altrui.
313 App. Napoli, 28 marzo 1962, cit.314 Cass., 21 giugno 1994, n. 6984, cit.
306
L’art. 1381 cod. civ. pone a carico del
promittente l’obbligo di corrispondere al
promissario un indennizzo, per il caso che il
terzo non compia il fatto promesso o rifiuti di
assumere l’obbligazione promessa. Il pagamento
dell’indennizzo costituisce elemento
caratterizzante la fattispecie tipizzata
nell’articolo citato. Qualora le parti
decidessero di escludere l’obbligo del
pagamento dell’indennizzo per il caso di
frustrazione del promessa, non si avrebbe
tuttavia nullità dell’accordo, ma semplicemente
si ricadrebbe in una fattispecie diversa da
quella della promessa del fatto altrui, e cioè
nell’impegno di adoprarsi in maniera diligente,
in modo da sollecitare il comportamento
promesso del terzo.
307
Accertato che il promittente è tenuto a
corrispondere l’indennizzo per il caso in cui
il terzo non compia il fatto promesso, resta da
chiarire se tale obbligo sorge in relazione ad
ogni caso in cui non si verifichi il fatto
promesso, oppure nelle sole ipotesi che il
terzo si rifiuti, esplicitamente o
implicitamente, di tenere un comportamento
conforme alla promessa.
La questione dei presupposti in base ai quali
il promittente è tenuto al pagamento
dell’indennizzo è uno dei nodi più dibattuti
circa la figura che stiamo analizzando. La
lettera dell’articolo 1381 stabilisce che
l’indennizzo è dovuto <<se il terzo rifiuta di
obbligarsi o non compie il fatto promesso>>.
Volendo applicare la norma alla lettera
308
dovrebbe dirsi che il legislatore pone due
presupposti differenti in base ai quali nasce
l’obbligo della corresponsione dell’indennizzo,
secondo che si sia promesso il fatto del terzo,
oppure l’assunzione di una determinata
obbligazione da parte del terzo. Nella prima
ipotesi il promittente sarebbe tenuto al
pagamento dell’indennizzo qualora per qualsiasi
ragione il terzo non abbia compiuto il fatto
promesso; nella seconda ipotesi l’obbligo della
corresponsione dell’indennizzo sarebbe
condizionato al rifiuto del terzo di assumere
l’obbligazione, non costituendo quindi ragione
dell’esborso indennitario tutti quei casi in
cui il promittente non assume l’obbligazione
per cause estranee alla sua volontà
(impossibilità della prestazione, perimento
309
dell’oggetto della prestazione, morte del
terzo).
Secondo un primo orientamento maggioritario in
dottrina315, il promittente sopporta il rischio
di dover pagare l’indennizzo limitatamente al
caso che il terzo si rifiuti di compiere quanto
promesso dal primo. In altri termini, se è vero
che con la promessa il promittente si accolla
il rischio del rifiuto del terzo, dovendo per
tal ipotesi provvedere ad indennizzare il
promissario, non sarebbe altrettanto possibile
addossare al promittente il rischio delle cause
impeditive del fatto promesso, che non
dipendono da una mancanza di volontà del terzo.
La garanzia del pagamento dell’indennizzo
opererebbe in relazione al solo rifiuto del
315 SCALFI, op cit., p. 122 e 125; ALCARO, op. cit., p. 81; M.C.
CHERUBINI, op. cit., p. 40; M.C. STASI, op. cit., p. 75, nota n. 6.
310
terzo. Costituirebbe del resto una conferma
ermeneutica di tale assunto la previsione
espressa nell’art. 1120 del code Napoleon e
nell’art. 1129 del codice civile abrogato, (che
costituiscono gli antecedenti storici
dell’attuale art. 1381 cod. civ.), che
l’obbligo del pagamento dell’indennizzo nasce a
causa del “rifiuto del terzo”, senza fare
distinzioni in base alla natura del fatto
promesso. Sostengono gli autori citati che al
verificarsi di tali cause impeditive del fatto
del terzo, il promittente sarà liberato
dall’obbligo del pagamento dell’indennizzo.
Adottando lo stesso criterio di delimitazione
del rischio assunto dal promittente, si è anche
sostenuto316 che costui è liberato dall’obbligo
del pagamento dell’indennizzo nel caso di
316 SCALFI, op. cit., p. 127 ss.
311
sopraggiunta incapacità, oppure di sopraggiunto
fallimento del terzo, che non potrebbe per ciò
disporre dei suoi beni. Il mancato compimento
del fatto è ora imputabile ad una causa diversa
dalla mancanza di volontà del terzo;
conseguentemente nulla dovrà il promittente al
promissario. Tuttavia bisogna considerare che
nell’ipotesi dell’inabilitazione, in cui si
configura un potere di disposizione del
soggetto incapace seppure limitato, il rifiuto
del terzo inabilitato comporterà l’obbligo del
promittente d’indennizzare il contraente, così
come nel caso in cui il fatto promesso abbia
natura tale da poter essere compiuto senza
disporre dei beni incamerati nella massa
fallimentare.317
317 Per una interessante disamina delle conseguenze del fallimento
del promittente e del promissario, v. SCALFI, op. cit., p. 128 ss.
312
Secondo un altro orientamento318 l’indennizzo
spetterebbe al promissario non solo nei casi di
rifiuto del terzo, ma anche quando il fatto di
costui diviene impossibile o comunque
ineseguibile per ragioni differenti dal suo
rifiuto. Tale assunto si ritrova, in primis, in
quegli autori che ritengono che dalla promessa
nasca una obbligazione di garanzia meramente
indennitaria319, per cui non verificandosi il
fatto del terzo e prescindendo dalle ragioni di
tale evenienza, il promittente sarebbe tenuto
ad indennizzare il promissario.
Si è visto che tale configurazione dogmatica
della promessa incontra ostacoli di ordine
logico e giuridico, che sconsigliano di
318 M. SEGNI, La lettre de patronage come garanzia personale impropria, in Riv.
dir. civ., 1975, I, p. 168 ss.; A. MAZZONI, op. cit., p. 363, nota 98;
A. CHECCHINI, La promessa del fatto del terzo, cit., p. 424 ss.319 Tesi citata sub paragrafo 9.
313
percorrere la via dell’obbligazione
indennitaria; per inquadrare l’obbligo del
promittente meglio è sembrato fare riferimento
al concetto di garanzia, inteso alla stregua
dell’assunzione di un rischio da parte del
promittente. Com’è noto, però, il concetto di
assunzione di un rischio è suscettibile di una
pluralità di significati. Può infatti dirsi che
il promittente assume il rischio che il
promissario non ottenga quella specifica
utilità rappresentata dal fatto del terzo (in
questa ipotesi l’indennizzo rappresenterà
l’equivalente economico del fatto promesso); ma
può ritenersi anche che il promittente assuma
un rischio più limitato rappresentato
dall’obbligo di ristorare il promissario del
pregiudizio subito per avere intrapreso
un’iniziativa economica, facendo affidamento
314
sul buon esito della promessa (in quest’ottica
l’indennizzo varrà a riequilibrare gl’interessi
economici sottesi alla stipula del contratto,
valendo in altri termini a restituire al
promissario ciò che ha perduto concludendo il
contratto). Partendo da tale significato
dell’assunzione del rischio320, si è detto che
l’obbligo di pagare l’indennizzo sussiste non
solo nel caso di rifiuto del terzo, ma anche se
il fatto del terzo non si verifica per cause
diverse dal rifiuto, perché identica è la
funzione che l’indennizzo deve svolgere:
<<garantire l’equilibrio patrimoniale fra le
prestazioni che formano oggetto del contratto
al quale è collegata la promessa>>.
In altri termini accedere all’idea della
garanzia significherebbe dire che, avendo il
320 A. CHECCHINI, La promessa del fatto del terzo, cit., p. 426.
315
promissario accettato i termini del contratto
in vista del compimento del fatto del terzo,
garantito dal promittente, costui dovrà
<<riequilibrare i termini dello scambio
attraverso l’indennizzo>>, in ogni caso che il
fatto del terzo non venga compiuto. La tesi
sembra tenere in debito conto l’interesse del
promissario, che ha sostenuto dei costi per
concludere il contratto cui la promessa accede,
a non dover subire il pregiudizio della
frustrazione della promessa.
A mio sommesso parere se si volesse aderire
alla tesi secondo cui se il fatto del terzo
diventa impossibile, oppure non viene compiuto
per altra causa indipendente dal rifiuto del
terzo, il promittente è liberato dall’obbligo
del pagamento dell’indennizzo, dovrebbe
316
comunque ritenersi che il promittente è tenuto
a restituire ciò che ha ricevuto in relazione
alla stipula della promessa, verificandosi una
causa di risoluzione del contratto per
impossibilità sopravvenuta della prestazione
(di facere del promittente). In altri termini,
salvo che non ricorra un’espressa volontà delle
parti in tal senso, non mi sembrerebbe
ragionevole far ricadere sul promissario il
rischio dell’impossibilità sopravvenuta della
prestazione, o quello di altre cause impeditive
del compimento del fatto o dell’assunzione
dell’obbligazione da parte del terzo,
indipendenti dalla sua volontà. Se per esempio
un soggetto accetta di acquistare un immobile
sulla base di una promessa che il proprietario
dell’immobile confinante venderà il bene di sua
proprietà; il promissario, sulla base
317
dell’aspettativa della vendita dell’immobile
confinante, è indotto pagare un prezzo
superiore al valore di mercato del bene oggetto
del contratto di compravendita. Non mi
sembrerebbe corretto sostenere che nel caso in
cui l’immobile, che il terzo avrebbe dovuto
vendere, vada distrutto a causa di un incendio,
il promissario debba impoverirsi del maggior
valore corrisposto al promittente.
C) Previsione di una penale
In dottrina ed in giurisprudenza è stata talora
prospettata (ed accolta) la possibilità per i
contraenti di pattuire una penale,
contestualmente alla stipula della promessa,
per il caso che il fatto del terzo non si
verifichi321. In giurisprudenza in relazione ad
321 M.C. CHERUBINI, op. cit., p. 54 (è da precisare che secondo l’A.
la predeterminazione di un indennità, per il caso in cui il fatto
318
una tal evenienza si ritiene che, ai fini della
determinazione della somma che il promittente
deve al promissario, il giudice non possa
ridurre la penale eccessiva, facendo
applicazione analogica dell’art. 1384 cod.
civ., data la natura eccezionale della norma322.
Si è notato tuttavia323 come tale assunto appare
paradossale alla luce della considerazione che
il legislatore ammette la riduzione della penale
manifestamente eccessiva in relazione
all’inadempimento dell’obbligato; ne consegue
del terzo non si verifichi, non costituisce vera e propria
clausola penale, perché non si riferisce ad un inadempimento o ad
una violazione di un dovere giuridico, che costituiscono i
presupposti dell’operatività della clausola); Cass., 30 dicembre
1997, n. 13120, in Giust. civ. mass., 1997, p. 2454.
322 App. Roma, 30 novembre 1993, n. 3184, in Rass. dir. civ., 1996, p.
193 ss, con nota di A. Morace Pinelli; in tema di caparra
confirmatoria:.Cass., 23 maggio 1995, n. 5644, in Giust. civ. Mass.,
1995, p. 1050.323 M.C. CHERUBINI, op. cit., p. 54, A. CHECCHINI, Promessa del fatto del
terzo, cit., p. 427, nota 149.
319
che, a maggior ragione, la riduzione della
penale dovrebbe essere possibile a favore del
promittente, che non è inadempiente.
Prescindendo da tali considerazioni,
occorrerebbe a mio avviso sottolineare che
l’art. 1381 cod. civ. contempla una fattispecie
tipica, ossia la promessa del compimento di un
certo fatto da parte di un soggetto terzo324, e
ne disciplina le conseguenze. Rimane estraneo
alla fattispecie il caso in cui un soggetto
prometta il pagamento di una certa somma, per
il caso in cui un terzo non compia un
determinato fatto (si ricade infatti nella c.
d. promessa del fatto proprio).
In quest’ottica la previsione di una penale,
per il caso che il terzo non compia il fatto
promesso, sembra inquadrarsi in una promessa del324 A. CHECCHINI, op. ult. cit., p. 428.
320
fatto proprio, come promessa del pagamento di una
certa somma. Se il ragionamento è esatto, non
vi sarebbe ragione di porsi il problema della
commisurazione dell’indennizzo alla penale,
perché si tratterebbe di fattispecie diversa
dalla “semplice” promessa del fatto del terzo,
per cui non sussisterebbe l’esigenza di
stabilire a quanto ammonta l’indennizzo ex art.
1381 cod. civ.
Tuttavia, la previsione di una clausola penale,
o anche la prestazione di una caparra,
relativamente ad un contratto che è collegato
alla stipula della promessa, più che
rappresentare la misura dell’indennizzo,
potrebbero acquistare il rilievo d’indici cui
ancorare la determinazione dell’indennizzo
secondo equità. È di questo avviso la
321
giurisprudenza, che in alcuni casi ha
quantificato l’indennizzo sulla base di una
penale precedentemente stabilita dalle parti325,
ma non fissata propriamente per l’eventualità
dell’inadempimento della promessa, quanto
piuttosto per l’inadempimento di un contratto
che regolava il regolamento d’interessi più
ampio in cui la penale s’inseriva.
18. L’obbligo del pagamento dell’indennizzo non esclude
che il promittente debba rispondere per illecito
contrattuale e sia tenuto al risarcimento del danno.
Si è messo in evidenza326 che la possibilità di
configurare un obbligo del promittente di fare,
nel senso di procurare il fatto altrui, oppure
nel senso di convincere il terzo a compiere il
fatto, incontra ostacoli di ordine logico e325 Cass., 21 giugno 1991, n. 6984., cit; Cass., 7 gennaio 1975, n.
19., in Arch. civ, 1975, p. 513.326 Vedi retro, par. 7 – 8 di questo capitolo.
322
giuridico. Pur prescindendo dalla tesi della
Cassazione sul doppio obbligo assunto dal
promittente, la difficoltà d’inquadrare
l’obbligo che il promittente assume nell’alveo
delle obbligazioni di fare non esclude che
sulla base delle regole d’interpretazione del
contratto possa individuarsi un impegno di
attivarsi del promittente. Quando risulti che
la conclusione della promessa sia avvenuta sul
presupposto di un potere del promittente di
adoperarsi per ottenere il fatto del terzo, la
regola d’interpretazione del contratto di buona
fede porterà al risultato di ritenere esistente
un tal obbligo in capo al promittente.
Quanto al caso ora prospettato, il ridurre
l’obbligazione, che il promittente assume, ad
una mera assunzione di rischio, rendendo
323
irrilevante l’impegno di attivarsi cui le parti
hanno fatto riferimento nella stipula della
promessa, significherà svilire le circostanze
che hanno portato alla conclusione del
contratto, le ragioni che hanno indotto il
promissario alla conclusione della promessa,
legate al “potere di fatto del promittente di
adoperarsi”; sarà in tal modo infranta ogni
buona norma d’interpretazione e di esecuzione
del contratto (articoli 1366-1375 cod. civ.).
Il contenuto di tal obbligo di fare del
promittente dovrebbe essere individuato, nel
caso concreto, sulla base delle reali
possibilità di adoperarsi del promittente, che
siano state contemplate all’atto della stipula
della promessa. Anche se il compimento del
fatto da parte del terzo dipenderà sempre da
324
circostanze estranee al potere del promittente,
data l’alterità soggettiva di chi deve compiere
il fatto o assumere l’obbligazione, tuttavia è
plausibile pretendere che il promittente tenga
quel comportamento idoneo, quanto meno, a
rendere possibile il fatto stesso del terzo.
È da precisare, tuttavia, che la possibilità di
adoperarsi del promittente non rappresenta un
requisito di validità della promessa, la quale
può essere fatta anche nel caso che il
promittente non abbia alcun potere di procurare
il fatto del terzo (es. si promette il fatto
della pubblica amministrazione). In tale caso
l’unico effetto che nascerà dalla promessa sarà
l’onere di riequilibrare i sacrifici economici
sopportati per la stipulazione del negozio
oneroso in cui la promessa è inserita.
325
La formulazione dell’art. 1381 evidenzia - come
conseguenza tipica del mancato compimento del
fatto o della mancata assunzione
dell’obbligazione - l’obbligo di pagare
l’indennizzo al promissario; ciò non preclude,
tuttavia, la possibilità che ricorra l’obbligo
di risarcire il danno: il promittente
risponderà a titolo d’illecito contrattuale
quando con dolo o colpa ometta di fare quanto è
necessario e a cui si è impegnato, sia pure
implicitamente, per rendere possibile il
compimento del fatto da parte del terzo.
Un esempio macroscopico della ricorrenza di un
illecito contrattuale può individuarsi
nell’esempio giurisprudenziale, in cui il
promittente dopo aver promesso al contraente la
vendita da parte di un terzo di un certo bene
326
lo abbia acquistato in proprio327. Volendo fare
un esempio di fantasia si può immaginare che il
promittente prometta il rilascio di una licenza
da parte della pubblica amministrazione e poi
non si dia cura di presentare neppure la
documentazione necessaria.
19. Segue: prova del danno.
Secondo le regole generali (art. 2697 cod.
civ.) la prova del pregiudizio subito spetterà
al promissario. L’oggetto della prova dovrà
però essere differente, secondo che l’attore
intenda ottenere il pagamento dell’indennizzo o
del risarcimento.
a) Quanto al primo caso, l’idea che si abbia
circa la natura e la funzione dell’indennizzo
influenzerà la scelta dei parametri cui
ancorare la determinazione della misura327 Cass. 20 dicembre 1995, n. 12973, in Foro it., 1996, c. 1731 ss.
327
dell’indennizzo. Qualora si volesse far valere
l’assunto secondo cui l’indennizzo rappresenta
l’equivalente economico del fatto promesso,
dovrà darsi la prova del valore economico del fatto
del terzo che non è stato compiuto. Se si aderisce
invece all’idea secondo cui l’indennizzo ha
funzione di riparare il pregiudizio sofferto
dal promissario nel concludere un certo affare,
sulla base della promessa del compimento del
fatto del terzo, bisognerà dimostrare l’entità
del pregiudizio sofferto, considerando
principalmente l’onere economico affrontato dal
promissario a favore del promittente e non compensato
dal verificarsi dell’evento atteso.
b) Quanto al secondo caso, il promissario dovrà
invece provare che il promittente, non facendo
quanto era in suo potere per ottenere il
328
compimento del fatto del terzo, ne ha causato
il mancato verificarsi. Il promittente, in tale
caso, non essendosi avvalso dei poteri di fatto
o di diritto che avrebbe potuto impiegare, non
ha procurato le condizioni per il compimento
del fatto del terzo. L’attore dovrà fornire la prova di
tutti gli elementi che costituiscono l’illecito contrattuale: la
condotta negligente o il dolo dell’obbligato,
la lesione patrimoniale che è derivata
dall’inadempimento, la sussistenza del nesso di
causalità328. Il promittente potrà invece
resistere alla domanda di risarcimento del
danno, provando di aver fatto quanto era in suo
potere per indurre il terzo a compiere il fatto
(in altri termini la sua diligenza
nell’adempimento), oppure l’assenza di un nesso
328 M.C. CHERUBINI, op. cit., p. 36.; Cass., 20 dicembre 1995, n.
12973, cit., c. 1743.
329
di causalità tra il suo agire e il mancato
compimento del fatto del terzo.
Le regole sulla prova suesposte inducono a
ritenere che sarà certamente più agevole per il
promissario ottenere il pagamento
dell’indennizzo, dovendo ora dimostrare solo
che non si è verificato il fatto promesso,
senza dover fornire la prova della condotta
dolosa o colposa del promittente e del nesso di
causalità. L’esame della prassi
giurisprudenziale conferma del resto che, nei
casi di frustrazione della promessa, il
promissario domanda con frequenza sicuramente
maggiore il pagamento dell’indennizzo,
piuttosto che il risarcimento del danno.
Giova in questa sede ricordare che la
giurisprudenza329 ha ritenuto costituire domanda329 Cass., 9 settembre, 1997, n. 8164, cit., p. 190.
330
nuova, inammissibile, quella dell’indennizzo
proposta per la prima volta in appello, laddove
in primo grado si era domandato il risarcimento
del danno. Quindi sarebbe rimedio utile per il
promissario quello di domandare in primo grado
la condanna al risarcimento del danno da
inadempimento ed in subordine la condanna al
pagamento dell’indennizzo, ottenendo in tal
modo che il giudice si pronunci sulla domanda
d’indennizzo, laddove ritenga di rigettare la
prima.
20. Considerazioni sul significato del rischio assunto dal
promittente.
In dottrina si è individuata una funzione di
garanzia della promessa del fatto del terzo e
si è precisato che con la promessa il
promittente si assume il rischio del mancato
331
compimento del fatto del terzo. La funzione
dell’indennizzo sarebbe quella di attribuire al
promissario un’utilità vicaria rispetto al
fatto del terzo. In sostanza l’indennizzo
rappresenterebbe un equivalente economico del
fatto promesso. Secondo quest’orientamento la
promessa genera un affidamento nell’ottenimento
di un’utilità specifica da parte di un terzo,
con la conseguenza che il promittente sarà
tenuto a soddisfare per equivalente economico
tale aspettativa, per il caso in cui il terzo,
libero nel suo operato, decida di non compiere
il fatto o non assumere un’obbligazione. In
sostanza secondo tal orientamento la sequenza
logica generata dall’affidamento sarebbe la
seguente: promessa del fatto del terzo –
nascita dell’aspettativa del promissario al
compimento di un certo fatto da parte di un
332
terzo – obbligo di pagare l’equivalente
economico del fatto promesso, per il caso in
cui il fatto promesso non venga compiuto.
Il rischio che il promittente assume e i parametri cui ancorare
la determinazione del quantum dell’indennizzo sono tuttavia
suscettibili di una diversa individuazione. Se si
attribuisce all’indennizzo la funzione di
riequilibrio degl’interessi economici coinvolti
nel contratto in cui s’inserisce la promessa,
può attribuirsi un significato specifico alla
funzione di garanzia dell’obbligazione del
promittente. Il rischio che costui si assume
andrebbe individuato in relazione al sacrificio
economico sopportato dal promissario, avendo
egli concluso un certo negozio sul presupposto
del buon fine della promessa del fatto del
terzo; qualora tale fatto non sia compiuto,
333
l’indennizzo avrà la funzione di tenere indenne
il promissario dal pregiudizio subito.
In sostanza secondo tal opinione330 l’effetto
della promessa del fatto del terzo è quello di
far nascere un obbligo negoziale di protezione
a favore del promissario, al quale viene
garantito che non subirà pregiudizio per ciò che è indotto
a rischiare, stipulando un determinato negozio su
sollecitazione del promittente. Il legislatore
pone l’obbligo del pagamento dell’indennizzo a
presidio del riequilibrio delle posizioni
economiche dei contraenti.
Se il promittente ha la possibilità
d’influenzare materialmente o giuridicamente il
compimento del fatto da parte del terzo, le
regole d’interpretazione ed esecuzione del
contratto in buona fede imporranno che il330 A. CHECCHINI, La promessa del fatto del terzo, cit., p 404.
334
promittente sia in via preliminare obbligato a
creare i presupposti per la soddisfazione
dell’interesse del promissario. In concreto,
quanto il promittente debba compiere dipenderà
dal rapporto che sussiste con il terzo:
l’obbligo di fare potrà consistere soltanto nel
prospettare l’affare economico al terzo, oppure
nel caso che il promittente, socio di
maggioranza di una società, abbia promesso la
conclusione di un certo affare da parte della
stessa, dovrà esplicare i propri poteri
decisionali nella relativa deliberazione
dell’assemblea. L’inadempimento di un tal
obbligo di adoperarsi rappresenterà un illecito
contrattuale, perché si lederà l’interesse
protetto del promissario.
335
Se invece il fatto del terzo si sottrae al
controllo giuridico o materiale del promittente
(caso in cui si promette il fatto della
pubblica amministrazione), l’unico effetto che
nascerà dalla promessa sarà quello di tenere
indenne il promissario per il caso che il fatto
del terzo non sia compiuto. Tal indennizzo
rappresenta il riequilibrio degl’interessi economici dei
contraenti.
In altri termini, inquadrando la promessa del
fatto del terzo nell’ambito di un più ampio
regolamento d’interessi, sarà possibile
identificare un sacrificio economico del
promissario che corrisponde ad un interesse del
promittente. Tale sacrificio apparirà
giustificato quando il fatto del terzo si
verifichi; in caso contrario detto sacrificio
336
rappresenterà un impoverimento ingiustificato
e, conseguentemente, attraverso l’indennizzo,
il promissario sarà reintegrato della perdita
subita.
21. Analisi della funzione restitutoria del pagamento
dell’indennizzo.
Cercheremo in questo paragrafo di verificare,
attraverso l’esame della prassi,
l’ammissibilità di una funzione restitutoria
del pagamento dell’indennizzo.
a) Occorre innanzitutto trattare il caso che la
promessa garantisce l’equilibrio dello scambio:
la promessa è accessoria rispetto ad un negozio
oneroso che il promissario stipula in vista del
compimento del fatto del terzo. Ad esempio: un
soggetto si decide ad acquistare un immobile
solo con la promessa del venditore che la
337
pubblica amministrazione rilascerà la licenza
di abitabilità331. Qui il promittente riceve con
la promessa un vantaggio rappresentato dalla
stipula del negozio, che non sarebbe stato
concluso senza la promessa del fatto del terzo.
Se quest’ultimo non compie il fatto si verifica
uno squilibrio degl’interessi economici delle
parti, proprio perché il fatto del terzo,
nell’ottica del promissario, aveva la valenza
di rendere equilibrato lo scambio tra
prestazione (vendita dell’immobile) e
controprestazione (acquisto dello stesso). Il
rischio che il promittente assume con la
promessa sarà da ravvisare proprio nella
possibilità che l’affare economico sollecitato
dal promittente o comunque concluso anche nel
suo interesse sia fonte di danno per il
331 Cass. 17 dicembre 1993, n. 12507, in Giust. civ., 1994, I, p. 1565
338
promissario; l’obbligo del pagamento
dell’indennizzo varrà ad eliminare gli effetti
di tale pregiudizio, garantendo al promissario
di non risentire alcun pregiudizio economico
dalla conclusione del contratto oneroso.
b) Può accadere che la promessa si presenti
come contratto unilaterale (lettera di patronage
in cui la società controllante, per indurre la
banca a stipulare un mutuo con la società
controllata, assicura la solidità della società
e promette in ogni caso la restituzione della
somma da parte di quest’ultima). Per la
fattispecie ora descritta, sebbene la promessa
non acceda ad un negozio oneroso
contestualmente concluso tra il promittente e
il promissario, la funzione della promessa è la
medesima svolta nel caso sopra esposto. Il
339
promittente, società controllante, ha interesse
a che il promissario stipuli un certo negozio
con la società controllata. Quest’interesse è
la ragione che spinge la società controllante a
promettere che il terzo restituirà la somma
mutuata. Il rischio che il promittente assume
con la promessa sarà egualmente da ravvisare
nella possibilità che l’affare economico
sollecitato dal promittente sia fonte di danno
per il promissario. L’obbligo del pagamento
dell’indennizzo varrà a riequilibrare gl’interessi economici
sottesi alla operazione complessiva.
c) La promessa è accessoria ad un contratto in
cui il promittente s’impegna ad adoperarsi per
procurare il compimento del fatto del terzo
verso corrispettivo. Ora ricorrerebbe una
promessa del fatto altrui che accede ad un
340
obbligo di fare atipico del debitore. Tal
obbligo sarà adempiuto se questi si è
diligentemente adoperato, ma essendo stato
promesso il fatto del terzo, la diligenza con
cui il debitore ha cercato d’indurre il terzo a
compiere il fatto non sarà sufficiente ad
esimerlo dal pagamento dell’indennizzo,
eliminando in tal modo il pregiudizio che il
promissario avrà subito stipulando il contratto
oneroso.
In verità occorrerebbe distinguere secondo che
il mancato compimento del fatto sia dipeso
dalla volontà del terzo oppure da un’azione o
omissione del promittente, che, ad esempio, non
si sia attivato per creare le condizioni del
compimento del fatto, o peggio, abbia
acquistato in proprio il bene del terzo di cui
341
aveva promesso la vendita.. Nel primo caso
dalla frustrazione della promessa discenderà
l’effetto tipico stabilito dall’art. 1381,
ossia l’obbligo del pagamento dell’indennizzo.
Nel secondo invece il promittente dovrà
rispondere per l’inadempimento.
In altri termini, può ravvisarsi nella promessa
che accede ad un contratto atipico di facere, la
garanzia della soddisfazione dell’interesse del
creditore al compimento del fatto da parte del
terzo. L’operatività della promessa comporterà
che se senza colpa del debitore il terzo non
compia il fatto, il promittente dovrà
restituire ciò di cui si è arricchito in
conseguenza del negozio oneroso. La funzione di
una tale promessa del fatto del terzo potrebbe
in altri termini essere equivalente alla
342
funzione di una clausola <<soddisfatti o
rimborsati>>332.
d) Si è presentato all’attenzione della
giurisprudenza la controversia in cui una
promessa del fatto del terzo venga fatta in
cambio di una prestazione del promissario333,
senza che la promessa risulti inserita in più
ampio programma contrattuale. In questa ipotesi
per meglio inquadrare gli effetti nascenti
dalla promessa, sembra doversi distinguere due
possibilità alternative: il promittente ha il
potere d’influire sul compimento del fatto
altrui, ferma restando l’autonomia del terzo;
oppure il fatto del terzo è del tutto immune da
influenze esterne (se mi dai cento ti prometto
332 A. CHECCHINI, La promessa del fatto del terzo, cit., p. 408.333 Cass. 3 maggio 1955, n. 1236, in Giust. civ., 1955, p. 444; Cass19
novembre 1963, n. 2995, in Giur. it., 1964, primo, 1, c. 757; App,
Napoli, 28 marzo 1962, n. 521, in Dir. giur., 1963, p. 559 ss.
343
che la pubblica amministrazione ti assumerà
come dirigente; che il giudice ti assolverà;
che il parlamento emanerà una certa legge
etc.).
1) Se il promittente promette il fatto del
terzo verso un corrispettivo e ha il potere
d’influenzare in senso positivo il compimento
del fatto stesso, in base alle regole
d’interpretazione del contratto potrà
individuarsi un impegno del promittente di
adoperarsi affinché il terzo compia il fatto e
l’assunzione di una garanzia, nel senso che il
promittente s’impegna a tenere indenne il
promissario del costo del contratto oneroso
qualora il fatto non venga compiuto. In altri
termini, l’impegno di protezione del
promissario si esplicita attraverso l’obbligo
344
di fare ciò che è necessario per indurre il
terzo a compiere il fatto promesso, salvo
indennizzare il promissario se nonostante gli
sforzi profusi in tal senso il fatto del terzo
non sia stato compiuto.
2) Se il fatto del terzo è estraneo a qualsiasi
potere del promittente d’influenzarne il
compimento, la promessa del fatto del terzo
prestata verso un corrispettivo assume il
significato di una scommessa334.
La possibilità di adoperarsi del promittente
non costituisce in generale condizione di
validità della promessa. Ove la promessa sia
accessoria ad altro negozio oneroso (esempio:
viene acquistato un immobile sulla base della
promessa del rilascio della licenza di
abitabilità), la promessa avrà la funzione334 SCALFI, op. cit., p. 98
345
d’indurre il promissario alla stipula del
contratto di compravendita, con la
consapevolezza che in caso di mancato rilascio
della licenza, il promittente dovrà tenerlo
indenne dal pregiudizio economico subito. Il
fondamento causale del pagamento del prezzo da
parte del promissario sarà comunque da
ravvisare nella vendita del bene, rilevando la
promessa del fatto della pubblica
amministrazione al livello dei motivi che lo
inducono a stipulare il negozio.
Se la promessa del fatto del terzo è fatta sic et
simpliciter verso il pagamento di un
corrispettivo, si deve poter presupporre
necessariamente una possibilità del promittente
di adoperarsi, perché tale attività “costituirà
necessariamente il corrispettivo nel contratto
346
di scambio cui la promessa accede”. In altri
termini, se il terzo non può essere sollecitato
al compimento del fatto, il corrispettivo che
il promissario paga per la promessa non avrà
una giustificazione causale, salvo considerare
come controprestazione l’assunzione del rischio
che il terzo non compia il fatto promesso. Lo
schema della scommessa meglio sembra descrivere
quest’ipotesi335.
La giurisprudenza in passato336 ha ravvisato un
nesso sinallagmatico tra il corrispettivo
pagato dal promissario e il fatto altrui che si
è promesso. Sembrerebbe invece che quando si
prometta il fatto di un terzo verso un qualche
corrispettivo, si possa ravvisare un vincolo di
335 A CHECCHINI, op. ult. cit., p. 410.336 Cass. 3 maggio 1955, n. 1236, in Giust. civ., 1955, p. 444; Cass19
novembre 1963, n. 2995, in Giur. it., 1964, primo, 1, c. 757; App,
Napoli, 28 marzo 1962, n. 521, in Dir. giur., 1963, p. 559 ss.
347
corrispettività tra l’obbligo di adoperarsi del
promittente e la prestazione del promissario. È
da precisare tuttavia che tale vincolo
sinallagmatico non si riflette sulla funzione
di garanzia della promessa, perché ciò
significherebbe affermare che il promittente,
se ha fatto tutto il possibile per indurre il
terzo a compiere il fatto, non debba alcun
indennizzo al promissario, neppure ove mai il
fatto non sia compiuto. Il nesso di
sinallagmaticità si riflette invece sul
contratto d’opera, in cui l’obbligo di fare del
promittente è in rapporto di scambio con
l’obbligo del pagamento del corrispettivo o di
altro sacrificio economico da parte del
promissario337. Conseguentemente il promissario,
che provi che il promittente non ha fatto
337 A CHECCHINI, op. ult. cit., p. 410.
348
quanto era in suo potere per indurre il terzo a
compiere il fatto, potrà ottenere la
risoluzione del contratto per inadempimento e
il risarcimento dei danni338, oltre che eccepire
l’inadempimento per sottrarsi al pagamento del
corrispettivo. Altra conseguenza del rapporto
sinallagmatico tra obbligo di adoperarsi e
pagamento del corrispettivo sarà che il
contratto si risolverà per impossibilità
sopravvenuta della prestazione339, se il fatto
del terzo dovesse divenire impossibile prima
che il promittente adempia al suo obbligo di
fare.
338 Cass., 20 dicembre 1995, n. 12973, cit.339 Cass., 29 maggio 1998, n. 5347, in Mass. giust. civ., 1998, c. 1174,
(era stato promesso ad un lavoratore l’assunzione da parte di una
centrale nucleare, che non ha potuto procedere all’assunzione per
l’intervento del referendum che ha interrotto l’attività delle
centrali nucleari).
349
22. Gratuità e onerosità della promessa. Promessa del fatto
del terzo e accordo di cortesia.
L’analisi della realtà economico - sociale
mostra come la promessa del fatto altrui
s’inquadri spesso in un più ampio regolamento
d’interessi, in cui il promissario acconsente
alla conclusione di un certo contratto, o di un
certo affare economico, se gli sia assicurato
il fatto del terzo con le conseguenze tipiche
previste dall’art. 1381. Attraverso il
meccanismo della promessa si crea, in altri
termini, uno scambio tra la prestazione (o più
in generale il comportamento del promissario) e
l’assunzione del rischio che l’affare
intrapreso comporta per il promittente.
In quest’ottica si può affermare che la
promessa si collega ad un comportamento del
350
promissario o, per meglio dire, ad un
contrattato comportamento del promissario
nell’interesse del promittente, che risulterà
essere in rapporto di reciprocità con la
prestazione della garanzia. Se questo è vero,
il vincolo creato dalla promessa troverà
fondamento proprio nell’esplicita o implicita
contrattazione della modifica del comportamento
del promissario e nel rischio di un pregiudizio
economico che ne potrebbe derivare. 340
Si discute in dottrina se oltre questa
ricostruzione dell’operatività della promessa
del fatto del terzo vi sia uno spazio per
configurare una valida obbligazione del
promittente, che si assuma il rischio del
mancato compimento del fatto del terzo, con le
conseguenze stabilite dall’art. 1381. Occorre
340 A. CHECCHINI, op. ult. cit., p. 412.
351
domandarsi, in altri termini, se sia
ammissibile una promessa autonoma, non legata
ad alcun interesse del promittente, né ad alcun
comportamento del promissario.
Si è sostenuto341 che se non è dato ravvisare
una reciprocità tra la promessa e il
comportamento del promissario che soddisfi un
interesse del promittente, la promessa non
assume quel significato tipico che è dato
rinvenire nella fattispecie di cui all’art.
1381; si configurerebbe in quest’ipotesi una
“promessa di esercitare buoni uffici”, che non farebbe
nascere alcun obbligo giuridico.
Conseguentemente non sarebbe dovuto alcun
indennizzo per il caso del mancato compimento
del fatto del terzo.
341 A. CHECCHINI, op. ult. cit., p. 413.
352
L’opinione evidentemente coinvolge la tematica
della struttura della promessa, nel senso che
non sarebbe ammissibile una promessa gratuita,
senza che si faccia alcunché da parte del
promissario, seppure il promittente avesse un
interesse a che si stipuli il “negozio
garantito” (terzo – promissario). In
particolare un Autore 342 ha sostenuto che la
struttura di contratto bilaterale della
promessa deriva dall’enunciata funzione
restitutoria dell’indennizzo. Se non sussiste
la prestazione del promissario, ossia il
sacrificio da lui affrontato per soddisfare un
interesse del promittente, non si potrebbe
determinare il pregiudizio da lui subito. In
altri termini, se si afferma che la funzione
dell’indennizzo è quella di riequilibrare
342 A. CHECCHINI, op. ult. cit., p. 429.
353
gl’interessi economici delle parti, avendo il
promissario concluso un certo affare nella
prospettiva della garanzia del fatto del terzo,
è implicito che non si ammetta una promessa
gratuita, perché per tale caso il pagamento
dell’indennizzo non potrebbe svolgere alcuna
funzione restitutoria.
Tuttavia, l’inammissibilità di una promessa
gratuita non è affatto pacifica. V’è in
dottrina chi sostiene che se è vero che la
promessa si presenta normalmente inserita in un
regolamento negoziale più ampio, essa però si
delinea quale schema contrattuale in sé
compiuto343, costituendo l’obbligo del
promittente il dato che caratterizza la
struttura della promessa. Non sarebbe dunque
343 M.C. CHERUBINI, op. cit., p. 67; SCALFI, op. cit., pp. 81 e 92 ss.;
ALCARO, op. cit., p. 79.
354
impossibile che una promessa, sebbene gratuita,
generi gli effetti tipici previsti dall’art.
1381 e non vada quindi qualificata alla stregua
di un impegno che rileva sul piano puramente
sociale, ossia come impegno di esercitare buoni
uffici.
L’elemento che distingue la promessa ex art.
1381 dagli accordi c. d. di cortesia è da
cogliersi, infatti, nell’intento delle parti,
ossia nella volontà di escludere o meno il
vincolo giuridico. Tal intento potrà essere
esplicito oppure potrà desumersi dal
comportamento dei soggetti tra cui si svolge un
dato rapporto, tenuto conto delle circostanze
specifiche in relazione alle quali la promessa
venga fatta.
355
Sotto tale profilo potrà rilevare la differenza
tra la gratuità o la onerosità della promessa.
La promessa, se s’inserisce nel contesto di
relazioni economiche tra promittente o
promissario, oppure se è stipulata in vista di
un certo negozio da concludersi tra gli stessi
soggetti, o tra promissario e terzo, sarà
indice della volontà d’impegnarsi
giuridicamente. Viceversa, se la promessa
risulterà avulsa da qualsiasi regolamento
d’interessi tra le parti e non è sorretta da un
specifico interesse del promittente, si potrà
pervenire alla soluzione opposta. Secondo tal
orientamento344 si tratterebbe di una soluzione
interpretativa che non esclude la
configurabilità di una promessa gratuita, con
gli effetti previsti dall’art. 1381, per cui
344 M.C. CHERUBINI, op. cit., p. 79 ss.
356
sotto il nome di promessa del fatto del terzo
si ricomprenderebbero sia ipotesi di contratti
con prestazioni corrispettive, sia contratti
con obbligazioni del solo promittente.
23. Forma della promessa.
L’istituto esaminato non deroga al principio di
libertà della forma, purché risulti in maniera
esplicita e non equivoca la volontà di
obbligarsi345. La promessa del fatto del terzo
non richiede alcuna forma particolare, neppure
per il principio dell’attrazione, così come
accade in tema di forma della procura o di
contratto preliminare.
Nel caso specifico in cui la promessa sia una
clausola di un contratto formale essa dovrà
assumere invece la forma richiesta per questo.
345 F. ALCARO; op. cit., p. 79; SCALFI, op. cit., p. 90; per riferimenti
giurisprudenziali vedi: M.C. CHERUBINI, op. cit., p. 101 ss.
357
Come già ricordato nel corso della presente
trattazione, è opinione costante che neppure ai
fini della prova sussista l’obbligo della forma
scritta, con conseguente inoperatività dei
limiti probatori ex art. 2725 cod. civ.
24. Conclusioni del capitolo secondo.
L’istituto analizzato è certamente uno dei più
controversi nell’ambito del diritto civile.
Come dimostrato dalla varietà d’interpretazioni
circa la natura dell’obbligo assunto dal
promittente e circa la funzione del pagamento
dell’indennizzo, la promessa si è prestata ad
una pluralità d’inquadramenti sistematici, fino
alla tesi della Cassazione che appiana in una
certa misura i contrasti interpretativi,
ravvisando in capo al promittente un doppio
obbligo, di fare (adoperarsi affinché il terzo
358
compia il fatto promesso) e di dare (pagamento
eventuale dell’indennizzo), con riconoscimento
di spazi di operatività sia per il risarcimento
del danno, che per l’indennizzo propriamente
detto.
Qualunque sia l’idea che si abbia circa la
natura dell’obbligo nascente dalla promessa,
sarà tuttavia comunque ragionevole ravvisare
nell’istituto l’esplicazione di una funzione di
garanzia. Salvo specificare a quale parametro
debba essere rapportata la determinazione del
quantum debetur, è certo che se il promittente fa
una promessa, creando un affidamento nel
promissario, non potrà liberarsi dagli effetti
obbligatori con la semplice prova di aver fatto
tutto il possibile per indurre il terzo ad
adempiere. Il promittente dovrà ponderare le
359
conseguenze della propria promessa, perché
promettendo il fatto del terzo ha garantito un
risultato, in mancanza del quale sarà tenuto
quanto meno ad indennizzare il contraente.
360
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La teorizzazione dei c.d. contratti autonomi
di garanzia. - 3. Dalla teorizzazione del Garantieverträge, alla
tipizzazione della garanzia autonoma nella prassi del commercio
internazionale. - 4. Iniziale disinteresse della dottrina italiana
all’argomento della garanzia autonoma; la sua diffusione a livello interno
-come garanzia bancaria attiva- e a livello internazionale -come garanzia
bancaria passiva- impongono una rimeditazione sul tema. - 5. La varietà
tipologica: garanzie interne ed internazionali; passive ed attive; bid
bond, perfomance bond, maintenance bond, repayment bond
ed altre garanzie autonome. - 6. Segue: Nozione e descrizione
dell’operazione: garanzie autonome dirette e indirette. - 7. Riconduzione
della categoria “contratto di garanzia autonoma” allo schema della
promessa del fatto del terzo (art. 1381 cod. civ.).- 8. Segue: critiche alla
riconduzione tout court del contratto autonomo di garanzia alla
fattispecie della promessa del fatto del terzo. - 9. La nozione di autonomia
utilizzata per descrivere la categoria di contratti personali di garanzia in
cui non trova applicazione il principio dell’accessorietà fideiussoria. - 10.
La causa della garanzia consistente nell’obbligazione preesistente
garantita. - 11. Segue: la causa della garanzia autonoma, intesa come
causalità dell’assunzione dell’obbligo di garanzia. - 12. La Cassazione a
Sezioni Unite si pronuncia sulle differenze sul piano morfologico
funzionale ed interpretativo tra la fideiussione ed il contratto autonomo di
garanzia, in particolare affrontando la problematica della qualificazione
giuridica delle polizze fideiussorie. Una sentenza storica. Sintesi della
controversia portata a conoscenza della S.C. - 13. Segue: la Corte di
Cassazione sembra inquadrare in maniera unitaria le diverse ipotesi di
“garanzia autonoma”-. - 14. Segue: gli aspetti peculiari del contratto
362
autonomo di garanzia, sotto il profilo morfologico e funzionale, nella
ricostruzione operata dalla sentenza in esame. Limiti all’autonomia del
contratto autonomo di garanzia e proponibilità di talune eccezioni
fondate sul rapporto - base. - 15. Segue: profili valutativi dell’incidenza sul
contratto autonomo di garanzia della nullità del contratto illecito. - 16.
Segue: La causa del contratto autonomo di garanzia nella ricostruzione
delle Sez. unite. - 17. Segue: le Sezioni Unite qualificano le polizze
fideiussorie stipulate a garanzia delle obbligazioni di un appaltatore come
garanzia atipica e non fideiussoria, e pervengono ad un importante
cambiamento di rotta sulla rilevanza delle <<clausole a prima richiesta>>
e <<senza eccezioni>>, inserite nel testo del contratto, ai fini della sua
qualificazione come contratto autonomo di garanzia. - 18. Spunti
sistematici forniti dalla sentenza della Cassazione ora citata. - 19. Una
comprensione più approfondita del funzionamento e dell’inquadramento
giuridico delle diverse tipologie contrattuali che si usa ascrivere alla
categoria della garanzia autonoma, richiede che si distingua innanzitutto
tra garanzia <<senza eccezioni>>, come assunzione di rischi atipici, e
garanzie <<a prima domanda>>, in cui l’interesse del beneficiario è quello
di poter escutere senza ritardo la garanzia. - 20. La garanzia autonoma
come assunzione di rischi atipici. Cenni alla fattispecie dell’indemnity,
che nell’area di common law assolve alla funzione svolta dal
Garantieverträge nell’ordinamento tedesco. L’obbligazione di
garanzia può essere autonoma in senso assoluto solo se il contratto
avente ad oggetto la prestazione di garanzia abbia una giustificazione
causale autonoma. In tal caso andranno distinti nettamente due piani
dell’analisi: a) l’oggetto del contratto, ossia la prestazione della garanzia;
b) la causa dello stesso, che andrà individuata nelle comuni ragioni
363
giustificatrici di un negozio. Le uniche eccezioni opponibili dal garante al
beneficiario saranno quelle derivanti dal contratto di garanzia medesimo.
- 21. La garanzia autonoma <<a prima domanda>>. La riconduzione di
tali figure contrattuali alla garanzia autonoma costituisce un errore di
prospettiva? - 22. Segue: la qualificazione della Bankgarantie fondata
sulla circostanza che l’obbligazione del garante è contratta all’interno di
un procedimento tipologicamente riconducibile a quello delegatorio. La
causa della garanzia bancaria passiva è costituita dall’obbligazione
adempiuta eseguendo l’incarico del cliente. - 23. Segue: La qualificazione
delle polizze fideiussorie come contratto a favore di terzi con causa di
scambio, essendo il debitore garantito tenuto a pagare una somma alla
compagnia di assicurazioni. - 24. Autonomia ed accessorietà della
garanzia e regime delle eccezioni. Le eccezioni relative al contratto ed al
rapporto di garanzia (rinvio). Riesame della problematica alla luce della
proposta ricostruzione delle garanzie bancarie passive e delle polizze
fideiussorie: le eccezioni relative alla causa della promessa con funzione di
garanzia autonoma. - 25. Segue: Il problema dell’opponibilità al
beneficiario delle eccezioni derivanti dal contratto e dal rapporto
principale. La proponibilità dell’exceptio doli in caso di escussione
fraudolenta o abusiva del creditore può costituire uno strumento per
prevenire possibili abusi? - 26. Riepilogo.
364
1.Premessa.
Nella prassi dei rapporti commerciali tra
imprese, ma anche tra quest’ultime ed i
committenti pubblici, si è assistito ad una
progressiva diffusione di contratti di garanzia
svincolati dal connotato dell’accessorietà
fideiussoria. Dette forme di garanzia c.d.
autonoma nascono dall’esigenza di attenuare se
non eliminare il rapporto di dipendenza ed
accessorietà che corre tra l’obbligazione del
garante e quella del debitore principale.
La trattazione di tali figure di garanzia
nell’ambito del presente lavoro si spiega in
relazione alla duplice necessità di tracciare i
tratti differenziali dei c. d. contratti
autonomi di garanzia rispetto ai contratti di
garanzia caratterizzati dal connotato
365
dell’accessorietà al rapporto principale (il
cui prototipo è rappresentato dalla
fideiussione), nonché di rendere conto del
tentativo d’inquadramento sistematico degli
stessi che fa leva sulla loro riconduzione allo
schema della promessa del fatto del terzo. La
prima prospettazione di siffatta riconduzione
sistematica è ormai risalente nel tempo346 e si
fonda su una doppia affinità tra l’istituto
della promessa del fatto del terzo ed il
contratto autonomo di garanzia: entrambi
sarebbero fonte di un’obbligazione autonoma del
garante – promittente; entrambi farebbero
nascere un’obbligazione indennitaria a carico
del garante. La tesi in parola, di cui più
diffusamente si darà conto nel prosieguo del
capitolo, ha tuttavia subito vivaci critiche,
346 G. STOLFI, La promessa del fatto di un terzo, cit., p. 216 ss.
366
in particolare in relazione all’univoca
individuazione dell’obbligazione del garante
autonomo com’indennitaria347.
Per una comprensione adeguata del fenomeno
sembra opportuno procedere alla ricostruzione
dell’emersione pratica e concettuale della
categoria negoziale, per poi affrontare la
problematica dell’inquadramento delle diverse
forme contrattuali, argomento, questo, che si
lega al regime delle eccezioni opponibili dal
garante al creditore garantito ed alla tematica
della tutela dell’ordinante (cioè del debitore
originario).
2 La teorizzazione dei c.d. contratti autonomi di garanzia.
La teorizzazione del contratto autonomo di
garanzia, come contratto a sé stante, che si
347 R. CICALA, Saggi sull’obbligazione e le sue vicende, Napoli, 2001, p.
107.
367
distingue dalla fideiussione per l’attributo
dell’accessorietà che contraddistingue
quest’ultima, risale alla fine del 1800 ed è
dovuta a R. Stammler348. L’Autore, soprattutto
con l’obiettivo di fornire un’adeguata
collocazione sistematica alle promesse di dare
con funzione di garanzia, ossia alle forme di
promissio indemnitatis diffuse nella prassi del
tempo, distingueva per la prima volta i
contratti di garanzia in due categorie: quelli
che accedono ad un’obbligazione principale
(fideiussione e mandato di credito) e quelli
che trovano la loro fonte in un atto di
autonomia privata (i c.d. Garantieverträge),
prescindendo dal rapporto con altra
348 Si deve a R. STAMMLER, Der Garantievertrag. Eine civilistische Abhandlung,
in Archiv für die civilistische Praxis, 1886; per la comprensione del
pensiero dell’Autore tedesco si è fatto riferimento alla
dettagliata ricostruzione di F. NAPPI, La garanzia autonoma, profili
sistematici, Napoli 1992, p. 22 ss.
368
obbligazione, e generando pertanto
un’obbligazione autonoma del promittente349.
Lo Stammler affermava, più precisamente, che si
ha contratto di garanzia quando <<una parte,
per sorreggere o promuovere un’iniziativa già
intrapresa o da iniziarsi dalla controparte,
assume contrattualmente e ordinariamente senza
corrispettivo il rischio collegato all’impresa
stessa, alla cui realizzazione il promittente è
in qualche modo interessato>>350. La copertura
del rischio poteva essere delimitata entro una
determinata somma, o anche in rifermento al
solo danno emergente o lucro cessante,
eventualmente predeterminati entro un certo
ammontare. Il fondamento giustificativo del349 G.B. PORTALE, Fideiussione e Garantieverträge nella prassi bancaria, in AA.
VV., Nuovi tipi contrattuali e tecniche di redazione nella pratica commerciale, Profili
comparatistici, a cura di P.Verrucoli, Milano, 1978, p. 12.350 La citazione del passo dello STAMMLER è riportata da G.B.
PORTALE, op. loc. ult. cit.
369
negozio veniva identificato nell’interesse del
garante allo svolgimento dell’attività
garantita.
Si è osservato351 che nell’originaria
impostazione della dottrina dei Garantieverträge
“l’interesse di animazione” del garante
costituiva l’elemento caratterizzante la figura
negoziale, che ne stabiliva la peculiarità
rispetto alla fideiussione. L’assunto diviene
palese ove si pensi che nella prassi dell’epoca
il garante “ordinariamente” non percepiva
alcuna controprestazione. Più precisamente lo
Stammler individuava nell’Animierungsinteresse,
ossia nell’interesse personale che il garante
ha nello stimolare un’iniziativa economica
dell’oblato, la causa sufficiente del
contratto; quest’interesse poteva essere di
351 F. NAPPI, o u. c., p. 23.
370
qualsiasi natura, quindi economico, sociale o
anche puramente ideale. Lo Stammler in
particolare aveva a mente soprattutto casi di
promesse pubbliche con funzione di garanzia
(es.: la promessa con cui lo Stato garantisce
ai sottoscrittori di azioni emesse da una
società ferroviaria un rendimento minimo).
L’affermazione secondo cui la causa del
Garantieverträge è costituita dall’“interesse di
animazione” del garante sembra volere dire, in
altri termini, che tali contratti si reggono su
di uno scambio tra la prestazione cui è tenuto
il creditore garantito ed il sacrificio cui il
garante si espone prestando la garanzia. In
questa sede rileva notare che tale
configurazione della causa del contratto
autonomo di garanzia, così come ricostruita
371
dallo Stammler, richiama alla mente il discorso
svolto nel capitolo precedente circa la
configurazione della causa dell’attribuzione
patrimoniale del promittente, per il caso della
stipula della promessa del fatto del terzo. In
quella sede352 si è infatti visto che,
costituendo la promessa per lo più un frammento
di un più ampio regolamento d’interessi, tale
figura può trovare giustificazione proprio in
un interesse del promittente, il quale per
indurre il contraente – promissario al
compimento di un certo fatto o alla conclusione
di un certo negozio, promette il fatto di una
terza persona. Più precisamente si è visto che
la causa dell’impegno del promittente d’indurre
il terzo a compiere il fatto promesso, e
dell’obbligo d’indennizzare il promissario per
352 V. retro, par. 3 e 4, capitolo II.
372
l’eventualità che il terzo non compia il fatto,
è da ravvisarsi nel pregiudizio subito dal
promissario, per avere compiuto un certo fatto,
facendo affidamento sulla promessa prestata dal
promittente. Anche in tal caso è possibile
ravvisare uno scambio tra la prestazione del
promissario e il sacrificio cui il promittente
si espone concludendo la promessa.
Come meglio si vedrà nel corso di questo
capitolo, tal interesse del garante è di regola
assente nelle odierne forme di garanzia
autonoma, o almeno, volendo essere più precisi,
lo è per quei casi in cui la garanzia è assunta
sulla base di un incarico ricevuto dal debitore
garantito, il quale ha preventivamente promesso
al creditore la prestazione di una garanzia.
373
Tralasciando l’importanza dell’Animierungsinteresse
come possibile riferimento causale dei
contratti in questione, sin dall’antica
dottrina tedesca353 la collocazione sistematica
dei c.d. contratti autonomi di garanzia fa leva
sulla loro autonomia, poiché essi sono
stipulati per la copertura di un rischio, come
i contratti accessori di garanzia, ma a
differenza di quest’ultimi non rinvengono la
propria causa in un preesistente e valido
rapporto obbligatorio. E’ ricorrente infatti
l’assunto secondo cui nel tipico contratto per
l’assunzione di una garanzia personale, la
fideiussione, la responsabilità del garante
deriva dalla responsabilità del debitore
principale ed in ciò consiste la c.d.
accessorietà dell’obbligazione del fideiussore;
353 Per riferimenti ,vedi F. NAPPI, op. cit., p. 24, nota 25.
374
la responsabilità del garante “autonomo” nasce
invece in relazione ad un autonomo atto
negoziale e comporta l’assunzione del rischio
del verificarsi o del non verificarsi di un
fatto, cui il creditore ha interesse, senza che
di tali eventi sia chiamato a rispondere anche
un debitore principale354.
354 G. STOLFI, La promessa del fatto di un terzo, cit., p. 219. Sul punto v.
i rilievi di F. NAPPI, op. cit., p. 29 ss., il quale sostiene che
questa delimitazione del rischio produce un’indebita restrizione
del rischio che può assumersi mediante una garanzia autonoma, che
dovrebbe potersi identificare anche in un fatto o un’omissione di
cui il terzo sia chiamato a rispondere. L’evento garantito
attraverso la garanzia autonoma potrebbe in altri termini essere
oggetto di una prestazione cui il terzo sia tenuto nei confronti
del promissario e, più in generale, dovrebbe ritenersi possibile
garantire attraverso una garanzia autonoma (e non solo attraverso
una garanzia accessoria) un evento, anche quando sia possibile
imputare al terzo la responsabilità per il mancato verificarsi
dello stesso. Il carattere autonomo dell’obbligazione del garante
non sarebbe quindi incompatibile con un’obbligazione di natura
contrattuale o extracontrattuale del garantito verso il creditore,
ma comporterebbe solamente l’indipendenza dell’obbligazione del
garante rispetto a quella (eventuale) del debitore garantito.
375
In dottrina355 si è evidenziato che la corrente
definizione della garanzia autonoma, fondata
sull’autonomia dell’obbligazione assunta, pone
in ombra la ragione del “distacco”
dell’obbligazione di garanzia da quella
garantita: la diversità dei rischi
<<assicurati>>. In altri termini, il rilievo
dato all’autonomia dell’obbligazione di
garanzia, mettendo in risalto la differenza di
effetti prodotti dalle garanzie autonome,
porrebbe in ombra la ragione stessa della
diversità effettuale. Nell’ottica di un’analisi
di tipo economico – descrittiva si è infatti
notato356 che la realizzazione dell’interesse
del creditore è sottoposta ad una pluralità di
rischi, per alcuni dei quali (l’inadempimento
355 A titolo esemplificativo: F. NAPPI, op. cit., p. 26; L. RUGGERI –
S. MONTICELLI, Garanzie personali, Napoli, 2005, p. 205.356 F. NAPPI, op. cit., p. 26.
376
del debitore) il creditore può essere garantito
con la fideiussione; per altri (ad esempio
l’impossibilità sopravvenuta della prestazione)
diventa insufficiente la fideiussione e
necessario il Garantieverträge. Riflettendo
sull’esempio prospettato, la ragione per cui
l’impossibilità sopravvenuta della prestazione
non si ripercuote sull’obbligazione “autonoma”
del garante, rendendola inesigibile, sarebbe da
ravvisare proprio nella peculiarità del rischio
assunto dal garante (il rischio
dell’impossibilità sopravvenuta della
prestazione), che rende l’obbligazione di
garanzia immune dalle vicende di quella
principale. In altri termini, il fatto che
l’invalidità del contratto da cui nasce il
rapporto principale non si riverberi sul
rapporto di garanzia, o ancora che vicende
377
estintive del rapporto obbligatorio principale
non abbiano effetto sull’escussione della
garanzia, deriverebbe proprio dalla peculiarità
di rischi che attraverso il contratto si
coprono; in questo senso sembra dover essere
interpretata l’affermazione riferita alla
fideiussione, così come modificata dalla
normativa convenzionale, ma estendibile ai
contratti di garanzia autonomi che coprono
rischi atipici, secondo cui <<la fideiussione
si è trasformata da forma di garanzia
dell’adempimento, così com’è previsto nel
sistema del codice, in garanzia contro il
rischio dell’inadempimento>>357.
In conclusione del presente paragrafo merita
d’essere ricordata l’utilità pratica e
357 E. BRIGANTI, Contratti di garanzia ed esercizio del credito nella prassi bancaria
italiana, in Vita not., 1980, p. 18 (dell’estratto).
378
concettuale che ha avuto la distinzione
dogmatica tra contratti di garanzia accessori e
autonomi. La distinzione dello Stammler, accolta
nei Motive del BGB, è stata utilizzata dalla
dottrina e dalla giurisprudenza tedesche per
dare una soluzione a tre ordini di questioni,
non risolvibili alla luce della disciplina
codicistica: a) per catalogare i negozi in cui
una parte assumeva la garanzia di un certo
successo o di un certo risultato, negozi non
assimilabili né al contratto di assicurazione,
né a quello di fideiussione (es. garanzia
dell’utile minimo a favore di chi avesse
acquistato una partecipazione sociale); b) per
ritenere obbligato il promittente, laddove la
nullità del negozio principale si riverberava
sulla validità dell’obbligazione del
fideiussore; c) per dare una collocazione
379
sistematica a quei contratti in cui il
fideiussore rinunciava a far valere le
eccezioni spettanti al debitore principale
(contratti evidentemente non riconducibili alla
fideiussione).
Riguardo alla funzione del contratto autonomo
di garanzia enunciata sub b, occorre ricordare
che la medesima operazione di ritenere
obbligato il garante nonostante l’invalidità
della fideiussione è stata compiuta in Italia
richiamando la figura della promessa del fatto
del terzo358. L’Autore riteneva che convertendo
la fideiussione nulla in una valida promessa
del fatto del terzo si ottenesse la doppia
utilità di ritenere obbligato il debitore, che
aveva contrattato per obbligarsi e non per dare
358 STOLFI, La promessa del fatto del terzo, in Riv. dir. comm., 1927, I, p.
221.
380
vita ad un negozio nullo, e di tutelare la
legittima aspettativa del creditore a
pretendere la prestazione pattuita359. La
ricostruita operatività della promessa del
fatto del terzo ha però suscitato le critiche
di quegli autori che hanno notato come, in
realtà, pure convertendo la fideiussione nulla
in una valida promessa del fatto del terzo, mai
potrebbe avere soddisfazione l’aspettativa
creditoria all’ottenimento della prestazione
pattuita (cioè quella cui è tenuto il debitore
principale). Sulla base della disciplina
enunciata dall’art. 1381 cod. civ., il
promittente è infatti tenuto ad eseguire una
prestazione indennitaria nei confronti del
promissario, quindi non è tenuto ad eseguire la
medesima prestazione cui è tenuto il debitore
359 G. STOLFI, op. loc. cit.
381
principale; ne consegue che pur considerando il
fideiussore obbligato sulla base di una valida
promessa del fatto del terzo (promittente),
costui non potrà essere chiamato a soddisfare
l’aspettativa creditoria all’ottenimento della
prestazione pattuita360.
3. Dalla teorizzazione del Garantieverträge, alla
tipizzazione della garanzia autonoma nella prassi del
commercio internazionale.
Il Garantieverträge assume una rilevante
diffusione nella prassi dopo la seconda guerra
mondiale, in relazione al proliferare dei
rapporti commerciali internazionali. Stante la360 F .NAPPI, op. cit., p. 27, nota 34; Analoghe considerazioni svolge
B. GRASSO, Saggi di diritto civile, Napoli, 1989, p. 124, in tema di
diversa funzionalità della fideiussione rispetto al contratto
autonomo di garanzia: quest’ultimo obbliga il garante ad eseguire
una prestazione di tipo indennitario, a differenza della
fideiussione che obbliga il fideiussore ad eseguire la medesima
prestazione cui è tenuto il debitore principale, quindi non
consente di soddisfare l’aspettativa creditoria all’ottenimento
della prestazione pattuita.
382
natura accessoria del negozio fideiussorio, gli
operatori commerciali transnazionali prendono
atto dell’inidoneità di tale negozio a
garantire il creditore contro i rischi di misure
valutarie restrittive, di confisca dei crediti stranieri da
parte dello Stato di appartenenza del debitore
e per l’eventualità della nullità del negozio principale,
perché in contrasto con una norma imperativa o
un principio di ordine pubblico dello Stato di
appartenenza del contraente361, non conosciuto
al momento della conclusione del contratto. Il
carattere autonomo del Garantieverträge rende
invece inopponibili le eccezioni fondate sul
rapporto principale e, staccando l’obbligazione
dell’obbligazione di garanzia da quella
principale, esclude che la nullità del
contratto da cui quest’ultima nasce si
361 G.B. PORTALE, op. cit., p. 13.
383
riverberi sulla validità della garanzia, e
dunque ostacoli l’escussione della stessa.
Il contratto autonomo di garanzia,
affrancandosi dall’accezione teorizzata dallo
Stammler (il cui nucleo centrale era costituito
dall’interesse del garante nell’incentivare
l’iniziativa garantita), diventa lo strumento
utilizzato da banche e compagnie di
assicurazioni per garantire una prestazione
<<auf jedem Fall>>. Lo strumento tradizionale
impiegato per premunirsi contro i c.d. rischi
atipici del commercio internazionale era
rappresentato dal deposito cauzionale; la
garanzia autonoma viene ora utilizzata in
alternativa a questo, in quanto, pur
perseguendo la stessa funzione del deposito
384
cauzionale, evita inutili immobilizzi di
denaro362.
Nella dottrina di lingua tedesca si afferma una
definizione della Bankgarantie363 secondo cui essa
è <<quel contratto obbligatorio unilaterale che
di regola serve a garantire la prestazione di
un terzo a favore del creditore beneficiario,
in maniera da assicurare a quest’ultimo che
egli riceverà in ogni caso la prestazione o la
somma di danaro contrattualmente stabilita, e
questo non solo in ipotesi d’inadempimento del
terzo, ma anche nel caso che l’obbligazione del
debitore principale non sia venuta ad
esistenza, oppure sia divenuta successivamente362 F. NAPPI, op. cit., p. 207; Cass., 31 luglio 2002, n. 11368, in
Banca, borsa, tit. cred., 2003, II, 251, con nota di C. FRIGENI, Alcune
nuove pronunce sul contratto autonomo di garanzia, che parla di strumento
alternativo al deposito cauzionale. 363 In questa fase del suo sviluppo la garanzia autonoma viene
presa in considerazione come Bankgarantie, piuttosto che come
Garantieverträge.
385
impossibile>>364. Tale definizione è incentrata
sull’elemento del potere del creditore di
conseguire una prestazione <<auf jeden Fall>>,
ossia <<in ogni caso>> (inadempimento del
terzo; obbligazione del debitore nulla; oppure
divenuta successivamente impossibile).
La differenza fondamentale tra il Garantieverträge
teorizzato dallo Stammler e la Bankgarantie di
successiva emersione consiste in ciò, che
mentre la causa del primo contratto va
individuata nell’Animierungsinteresse del garante,
che si pone in rapporto di scambio con
l’impegno assunto dall’oblato, la causa del
secondo va ravvisata nell’obbligazione assunta
dalla banca con l’accettare l’incarico ricevuto
dal debitore, per adempiere la quale la banca364 Traduzione corrente nella dottrina italiana. Per la dottrina di
lingua tedesca v. E. SCHINNERER – P. AVANCINI, Bankverträge, III,
Wien, 1976, p. 291
386
si è impegnata nei confronti del
beneficiario365. La conseguenza di tale
differente supporto causale è che nel caso
della Bankgarantie il peso economico
dell’operazione ricadrà sul debitore
principale, per effetto della rivalsa che la
banca eserciterà nei confronti del debitore -
cliente, una volta che sia stata escussa la
garanzia (c.d. conteggio); nel Garantieverträge,
invece, il peso definitivo dell’operazione
rimane in capo al garante che ha pagato,
proprio perché il suo interesse di animazione
giustifica lo spostamento patrimoniale in
favore del beneficiario della garanzia366.
Il contratto autonomo di garanzia, così come
descritto, non soddisfaceva però un’altra
365 F. NAPPI, op. cit., p. 47 ss.366 P. CORRIAS, Garanzia pura e contratti di rischio, Milano, 2006, p. 439.
387
esigenza che si poneva nella prassi
commerciale: la necessità di una tutela del
creditore contro il rischio di contestazioni
circa la ricorrenza del presupposto
dell’obbligazione del garante (mancato
adempimento dell’obbligazione primaria da parte
del debitore principale), contestazioni che
avrebbero potuto ritardare notevolmente la
riscossione della prestazione da parte del
creditore. Nella prassi del commercio estero
viene allora tipizzata una nuova clausola: la
<<clausola di pagamento a prima richiesta e
senza eccezioni>>. La sua funzione non è solo
quella di staccare l’obbligazione del garante
dal rapporto principale (funzione già assolta
dalle clausole di deroga all’accessorietà
dell’obbligazione di garanzia fideiussoria, che
impediscono il ripercuotersi dell’invalidità
388
del contratto da cui nasce il rapporto
principale sull’obbligazione del fideiussore, o
che comportano la rinuncia a far valere le
eccezioni fondate sul rapporto principale), ma
anche quella di neutralizzare il rischio di
contestazioni circa l’esistenza dei presupposti
che legittimano l’escussione della garanzia da
parte del creditore. In base alla clausola <<a
prima richiesta>> il creditore ha diritto di
ottenere immediatamente la prestazione del
garante, con la semplice affermazione che si è
verificato l’inadempimento da parte del
debitore367. Le parti peraltro possono stabilire
diverse condizioni cui la domanda di pagamento
deve uniformarsi, come previsto dall’art. 2
nelle norme uniformi emesse dalla Camera di367 È da segnalare sin d’ora che la corrente nozione di garanzia
autonoma fa riferimento a due ipotesi, che “occorrerebbe tenere
ben distinte, esaminare separatamente nelle loro problematiche e
diversamente riqualificare, v. R. CICALA, op. cit., p. 195 ss.
389
Commercio Internazionale nel 1991 (Uniform Rules
for Demand Guarantees): il pagamento può avvenire
a semplice richiesta; a richiesta accompagnata
dalla generica affermazione che l’ordinante è
inadempiente, o accompagnata dall’indicazione
specifica dell’inadempimento; a richiesta
accompagnata dalla descrizione
dell’inadempimento e dai documenti indicati
nella garanzia; a richiesta accompagnata da una
sentenza o da un lodo arbitrale di condanna
dell’ordinante per inadempimento. È da notare
che in quest’ultima ipotesi la garanzia sembra
assumere i connotati tipici dell’accessorietà,
in quanto il creditore deve dimostrare con i
documenti suindicati l’inadempimento del
debitore.
390
Il garante conteggerà la prestazione al
debitore garantito, a cui carico v’è ogni onere
probatorio per il caso che ritenga che il
creditore abbia escusso indebitamente la
garanzia (es.: il debitore aveva già adempiuto
la sua obbligazione). A ben vedere la clausola
produce un’inversione dell’onere della prova,
poiché non sarà il creditore a dover dimostrare
al garante l’inadempimento dell’obbligazione
principale, presupposto per l’escussione della
garanzia, ma sarà il debitore, cui il garante
conteggia la prestazione effettuata, a dover
dimostrare, in sede di azione di ripetizione,
l’assenza dei presupposti che legittimavano il
creditore ad ottenere la prestazione della
garanzia.
391
Il successo della clausola si spiega alla luce
del fatto che se da un lato consente indubbi
vantaggi in termini di sicurezza e rapidità per
il beneficiario, assicurando una soddisfazione
del creditore assimilabile a quella realizzata
da un deposito cauzionale, dall’altro consente
di evitare improduttive immobilizzazioni
finanziarie (come già si è accennato).
La garanzia autonoma diventa strumento di
elezione dei traffici commerciali, specie
internazionali, presentando vantaggi economici
e giuridici per i soggetti coinvolti
nell’operazione.
Più precisamente, l’ordinante che intende
svolgere traffici commerciali all’estero non
immobilizza liquidità (conseguenza necessaria
dei depositi cauzionali) ed affronta un costo
392
minore rispetto a quello che dovrebbe sostenere
stipulando una garanzia fideiussoria. La banca
garante non dovrà entrare nel merito del
rapporto di valuta e delle controversie tra
debitore e creditore: le minori indagini che la
banca dovrà compiere in sede di escussione
della garanzia spiegano il costo minore della
garanzia autonoma rispetto alla fideiussione.
Infine il beneficiario potrà escutere con
semplicità la garanzia, la quale, per giunta,
potrà coprire anche i rischi atipici (risultato
non conseguibile con le garanzie fideiussorie).
393
4. Iniziale disinteresse della dottrina italiana all’argomento
della garanzia autonoma; la sua diffusione a livello interno
-come garanzia bancaria attiva- e a livello internazionale -
come garanzia bancaria passiva- impongono una
rimeditazione sul tema.
Un’iniziale riflessione della dottrina italiana
sul tema della garanzia autonoma, nella forma
del Garantieverträge, risale ad uno studio sulla
promessa del fatto del terzo368. In tale
monografia l’A. qualifica come negozio di
garanzia la figura prevista dall’art. 1129
dell’abrogato codice civile del 1865
(sostanzialmente corrispondente a quella oggi
prevista dall’art. 1381 cod. civ.) e afferma
che la differenza tra l’obbligazione del
fideiussore e l’obbligazione di chi promette il
fatto del terzo risiede nella circostanza che
368 G. STOLFI, La promessa del fatto di un terzo, cit.
394
mentre il primo contrae un’obbligazione
accessoria e sussidiaria dell’obbligazione
principale del debitore, il secondo è obbligato
invece egli stesso in via principale,
indipendentemente dal vincolo che possa sorgere
tra lo stipulante ed il terzo (nel qual caso,
riteneva erroneamente l’A., il promittente si
libera), ed è obbligato fin dal momento in cui
v’è stato accordo delle volontà col
promissario369. Individuata nel binomio
accessorietà – autonomia la differenza tra
l’obbligazione di garanzia del fideiussore e
quella del promittente, si richiama la dottrina
del Garantieverträge, che distingue i contratti di
garanzia in due classi, quelli che accedono ad
un’obbligazione principale e quelli che trovano
nella volontà delle parti il loro fondamento, a
369 Così G. STOLFI, op. cit., p. 217.
395
prescindere da ogni altra obbligazione370. Dalla
comparazione della figura della promessa con la
categoria di elaborazione tedesca l’A. giunge
alla conclusione che tra il contratto di
garanzia di cui parla la dottrina tedesca e la
promessa del fatto del terzo non vi sia una
differenza concettuale371.
In questa chiusura verso l’individuazione di
autonomi spazi di operatività della categoria
del Garantieverträge si annidava un equivoco circa
le potenzialità esplicative della stessa,
potendo il Garantieverträge trovare applicazione
in ipotesi non riconducibili alla promessa del
fatto di un terzo: garanzia del rendimento di
un titolo, garanzia del successo di una lite,
costituendo l’oggetto della garanzia un evento
370 G. STOLFI, op. cit., p. 218.371 G. STOLFI, op. cit., p. 220.
396
che prescinde dal comportamento di un terzo
soggetto372. Inoltre ponendo l’accento
sull’autonomia dell’obbligazione assunta, l’A.
non teneva conto dell’altro elemento
individuato dallo Stammler come fattore
descrittivo della categoria, l’interesse di
animazione del garante, idoneo ad offrire un
supporto giustificativo al negozio. Del resto
lo stesso Stammler aveva già identificato le
differenze tra Garantieverträge e Promissio facti alieni:
mentre il primo è fornito di una propria
giustificazione causale, per la seconda si pone
l’esigenza di specificare la giustificazione
causale, in relazione alla fattispecie
negoziale in cui s’inserisce373. Pertanto
<<mentre il Garantieverträge nasceva come promessa
372 F. NAPPI, op. cit., p. 33.373 STAMMLER, Der Garantieverträge, cit., p. 43; la tesi dello STAMMLER
è riportata in F. NAPPI, op. cit., p. 34.
397
di dare causata, là dove la causa sufficiente
era rappresentata dallo scambio>>374, la
promessa del fatto del terzo rappresenta una
fattispecie muta rispetto alla causa, <<una
frazione di fattispecie negoziale che dovrà
essere giustificata di volta in volta in forza
di un “autonoma” causa>>375.
Dopo questo primo intervento, che di fatto
risolveva il tema delle garanzie autonome
attraverso l’inquadramento della categoria
nello schema della promessa del fatto del
terzo, la dottrina italiana trascurò in buona
sostanza di occuparsi del primo argomento; la
necessità di uno studio più approfondito è
stata avvertita, invece, in seguito alla
massiccia diffusione a livello interno -come
374 F. ROCCHIO, La promessa con funzione di garanzia, Napoli 2009, p. 85.375 G. CASTIGLIA, op. cit., p. 397.
398
garanzia bancaria attiva- ed internazionale -
come garanzia bancaria passiva- di nuove forme
di garanzia personali, in cui era attenuato se
non eliminato il tipico nesso di accessorietà
con il rapporto principale, che connota la
fideiussione.
In Italia, nei formulari bancari predisposti
dall’ABI per il rilascio di fideiussione a
favore delle banche (c.d. fideiussioni
attive)376 si ricorre a due clausole “che
comportano il distacco dell’obbligazione del
garante da quella del debitore garantito”377:
a) <<il fideiussore è tenuto a pagare
immediatamente alla banca a semplice richiesta
376 In Banca borsa e tit. cred., 1964, I, p. 460 ss., hanno ricevuto una
prima pubblicazione le <<Condizioni generali uniformi relative
alle fideiussioni senza limite massimo a garanzia di qualunque
operazione>> predisposte dall’ABI.377 F. NAPPI, op. cit., p. 37.
399
scritta, anche in caso di opposizione del
debitore, quanto dovutole per capitale,
interessi, spese, tasse ed ogni altro
accessorio>>;
b) <<in deroga all’art. 1939 la fideiussione
mantiene i suoi effetti anche se l’obbligazione
principale sia dichiarata invalida>>.378
Nel contempo i bandi degli appalti
internazionali prevedevano quasi regolarmente,
come condizione di partecipazione ed
alternativamente al rilascio di una cauzione,
l’assunzione di garanzie (esempi: bid bond,
performance bond, repayment bond) da parte di una
banca o di una compagnia di assicurazione, in
via autonoma rispetto all’obbligazione
principale e su incarico del debitore (in tal
378 Tra gli altri le clausole sono riportate in G.B. PORTALE,
Fideiussione e Garantieverträge nella prassi bancaria, cit., p. 5.
400
caso la banca o la compagnia assicurativa sono
in veste di garante e non di creditori
garantiti). Elemento caratteristico delle
garanzie che si diffondono nel commercio
internazionale è che “il contratto di garanzia
è la fase terminale di un’operazione
triangolare che ha i suoi punti di riferimento
nel contratto garantito e nel mandato oneroso
(spesso richiamato nel contratto di garanzia)
in base al quale il garante (banca o compagnia
assicurativa) assume la garanzia, con
l’autorizzazione a conteggiare al mandante le
somme pretese da quest’ultimo”379.
In queste garanzie non è più possibile
rinvenire quello che Stammler individuava come
il fondamento giustificativo del Garantieverträge
e cioè l’interesse del garante a promuovere
379 F. NAPPI, op. cit., p. 47.
401
l’attività del beneficiario della garanzia,
senza ricevere alcun corrispettivo per
l’assunzione della stessa. In tali contratti di
garanzia appaiono clausole che riproducono
sostanzialmente il tenore di quelle
summenzionate contenute nei moduli per il
rilascio di fideiussioni bancarie attive380: a)
clausole che impongono il pagamento a prima
richiesta e senza eccezioni; b) clausole che
distaccano la validità dell’obbligazione di
garanzia da quella principale, per cui la
garanzia resta ferma, anche in caso
d’invalidità dell’obbligazione principale.
380 G.B. PORTALE, cit., p. 6- 7.
402
5. La varietà tipologica: garanzie interne ed internazionali;
passive ed attive; bid bond, perfomance bond,
maintenance bond, repayment bond ed altre garanzie
autonome.
È opportuno procedere ad una disamina circa la
varietà tipologica delle garanzie c.d. autonome
che la prassi conosce. Questi chiarimenti
costituiranno un utile strumento d’indagine per
comprendere se la categoria della garanzia
autonoma costituisce un’organica e unitaria
categoria concettuale, o piuttosto un
contenitore di figure contrattuali molto
diverse tra loro, che meritano una trattazione
ed un inquadramento differenziato381.
381 Tra gli altri, espongono analiticamente le varie specie di
garanzie autonome,: F. NAPPI, op. cit., p. 210 ss.; L. RUGGERI – S.
MONTICELLI, op. cit., p. 210 ss.; R. DE NICTOLIS, Nuove garanzie personali
e reali, Padova, 1998, p. 26 ss.
403
In ordine ai soggetti coinvolti nell’operazione
è possibile distinguere tra garanzie interne ed
internazionali. Queste ultime ricorrono quando
le parti del rapporto base hanno il domicilio o
la sede in Stati diversi. È opportuno
sottolineare che i rapporti commerciali
internazionali sono il campo in cui le garanzie
autonome si sono affermate e sviluppate382.
Quanto al contenuto della garanzia nella prassi
del commercio nazionale ed internazionale viene
adoperata una variegata tipologia di garanzie
autonome, delineata, fin dal 1978, dalla Camera
di Commercio Internazionale che pubblicava le
<<Norme uniformi per le garanzie contrattuali>>.
Si distinguono anzitutto tre ipotesi: la
garanzia di mantenimento dell’offerta; la
garanzia di buona esecuzione; la garanzia di382 V. retro par. 2 del presente capitolo.
404
rimborso (detta anche garanzia di restituzione
degli acconti). Dato che spesso accomuna tali
forme di garanzie è il contratto da cui nasce
il rapporto principale, per lo più un appalto,
ma può anche trattarsi di un contratto di
somministrazione o di vendita funzionale a
procurare beni o servizi alla pubblica
amministrazione o ad altre imprese. Elemento
differenziale è che mentre la prima opera nella
fase antecedente alla stipulazione del
contratto base, le altre due forme di garanzia
operano con riferimento alla fase dello
svolgimento del rapporto.
a) Come anticipato, la garanzia di mantenimento
dell’offerta (o bid bond, o tender bond) opera
nella fase antecedente alla stipulazione del
contratto ed è un “impegno rilasciato da una
405
banca, da una compagnia di assicurazioni o da
un altro soggetto (garante) su richiesta di chi
ha presentato l’offerta (l’ordinante) alla
parte che ha invitato all’offerta (il
beneficiario); in virtù di tale garanzia il
garante s’impegna a pagare al beneficiario una
somma predeterminata, qualora l’ordinante non
ottemperi agli obblighi che derivano dalla
presentazione dell’offerta”383. La garanzia
trova applicazione soprattutto in riferimento
ai contratti di appalto e copre il rischio (del
committente) che il vincitore della gara
d’appalto rifiuti di stipulare il contratto, o
comunque di stipularlo alle condizioni previste
nel bando. In tal caso, sulla base della
semplice richiesta del beneficiario, il garante
si obbliga a pagare allo stesso una somma
383 F. NAPPI, op. cit., p. 210.
406
prefissata, calcolata in percentuale rispetto
al valore del contratto base (normalmente la
somma oscilla tra l’1% e il 10% del valore di
esso). La garanzia cessa di operare quando
l’impresa (o la pubblica amministrazione)
committente dà comunicazione al garante che
l’impresa che partecipa alla gara non si è
aggiudicata l’appalto, o nella diversa ipotesi
della conclusione del contratto384.
b) La garanzia di buona esecuzione (anche
conosciuta come performance bond) “è un impegno
rilasciato da una banca, da una compagnia di
assicurazioni o da altro soggetto (il garante),384 L. RUGGERI – S. MONTICELLI, op. cit., p. 207; F. NAPPI, op. cit., p.
210 ss., individua la funzione della garanzia dell’offerta nella
“copertura del rischio che l’esportatore non esegua le
obbligazioni derivanti dall’offerta e consistenti principalmente
nella sottoscrizione del contratto”. Come già chiarito, tali
garanzie appaiono idonee ad essere prestate in relazione a diverse
forme di contratto “garantito”, con la conseguenza che il rischio
“assicurato” sarà diverso, secondo il contratto base che le parti
abbiano stipulato.
407
su richiesta di un fornitore di beni o servizi
o di un altro contraente (l’ordinante), ad un
compratore, un committente, o altro contraente
(il beneficiario)”385 ed ha la funzione di
garantire quest’ultimo contro il rischio
dell’inadempimento totale o parziale degli
obblighi che nascono dal contratto principale,
o del ritardo nell’esecuzione degli stessi. Il
garante s’impegna a pagare al creditore
garantito una somma predeterminata, stabilita
in valore percentuale rispetto al valore delle
opere da realizzare, o dei servizi o forniture
da rendere. Il garante sarà tenuto a pagare
sulla base della semplice dichiarazione che si
è verificato l’inadempimento del contratto
principale (performance bond on demand)386.385 F. NAPPI, op. cit., p. 211.386 Quando l’escussione della garanzia è subordinata
all’accertamento, in via definitiva, dell’inadempimento del
debitore del contratto base, ricorre il performance bond on default (o
408
c) Analoga configurazione ha la garanzia c.d.
di manutenzione (maintenance bond): essa mira a
garantire il buon funzionamento di quanto
fornito o costruito, eliminando difetti o
anomalie387. Attraverso tale garanzia è
assicurata al beneficiario (committente,
compratore, o altro soggetto avente diritto ad
una determinata prestazione da parte del
debitore principale) l’attribuzione di una
somma nell’ipotesi in cui il debitore del
rapporto principale (appaltatore, venditore o
altro contraente) non provveda ad eliminare le
anomalie funzionali emerse dopo che siano stati
effettuati i lavori o le forniture.
d)La garanzia di restituzione degli acconti (o
garanzia di rimborso, repayment bond) è “un
conditional): G. BOZZI, Le garanzie atipiche, vol. I, Garanzie personali,
Milano 1999, p. 40.387 L. RUGGERI – s. MONTICELLI, op. cit., p. 208.
409
impegno rilasciato da una banca o una compagnia
di assicurazioni o altro soggetto (garante) a
richiesta di un fornitore di beni o servizi o
di altro contraente (ordinante) ad un
compratore oppure ad un committente
(beneficiario), in virtù del quale il garante
s’impegna -nel caso di mancato rimborso da
parte dell’ordinante di qualsiasi somma
anticipata dal beneficiario allo stesso- ad
effettuare un pagamento al beneficiario nei
limiti di una somma di denaro prestabilita”388.
Anche questa garanzia trova precipua
applicazione nei contratti di appaltatore;
copre il rischio che costui non restituisca al
committente il pagamento degli anticipi
ricevuti in conseguenza dell’affidamento dei
lavori, e che si era obbligato a restituire nel
388 F. NAPPI, op. cit., p. 212- 213.
410
caso di mancata esecuzione degli stessi. Rileva
notare che in questo caso, a differenza di
quelli esaminati in precedenza, la garanzia
tutela un credito pecuniario e l’ammontare del
credito di garanzia è pari a quello del credito
garantito. In altri termini il garante non è
tenuto ad un’obbligazione indennitaria, ma ad
eseguire la medesima prestazione cui è tenuto
il debitore principale. La precisazione, come
si avrà modo di notare nel prosieguo della
trattazione, è di fondamentale importanza in
relazione a quella tendenza di ravvisare uno
dei principali tratti di affinità tra le
garanzie autonome e la promessa del fatto del
terzo proprio nel carattere indennitario della
prestazione cui è tenuto il
garante/promittente.
411
e) La garanzia di pagamento (payment guarantee)
costituisce il reciproco della garanzia di
buona esecuzione, giacché mira a garantire il
pagamento dei beni o servizi resi. Più
precisamente “essa tende ad assicurare il
pagamento del prezzo nell’ipotesi in cui
quest’ultimo non sia stato anticipato”389, cioè
allorché l’esportatore, l’appaltatore, (etc.)
abbiano eseguito la propria prestazione senza
preventivamente ricevere il pagamento. Anche
per tale garanzia il garante non è tenuto ad
una prestazione indennitaria nei confronti
dell’oblato, ma ad eseguire la stessa
prestazione cui è tenuto il debitore
principale.
f) Nel commercio internazionale sono diffuse
anche le garanzie per la ritenuta -retention money
389 F. NAPPI, op .cit., p. 213.
412
bonds- mediante le quali si garantisce al
beneficiario (committente o acquirente) la
restituzione di una quota del prezzo pagato,
qualora la merce o l’opera non abbiano le
caratteristiche stabilite.
g) Infine bisogna menzionare il customs bond che
garantisce il pagamento dei dazi doganali,
qualora siano stati importati temporaneamente
dei macchinari per l’esecuzione di un’opera, ma
questi non siano poi più stati riesportati;
garanzia, questa, satisfattoria e non indennitaria.
6. Segue: Nozione e descrizione dell’operazione: garanzie
autonome dirette e indirette.
Dalla prassi contrattuale si rileva l’esistenza
di due tipi di garanzie autonome, che si
differenziano sotto il profilo strutturale:
413
quelle dirette (o triangolari), quelle
indirette (o quadrangolari).
A) Nelle garanzie dirette sono individuabili
tre distinti rapporti.
a) V’è un rapporto principale (o rapporto base,
o rapporto di valuta) che intercorre tra
l’ordinante la garanzia ed il beneficiario. In
pratica il contratto che darà vita a questo
rapporto potrà essere una compravendita, una
somministrazione, un appalto, o altro tipo di
contratto diffuso nella pratica commerciale.
b) V’è un contratto di mandato (o rapporto di
provvista) che intercorre tra il debitore nel
rapporto di valuta (ordinante la garanzia) ed
il garante, che di norma sarà una banca o una
società di assicurazioni. L’ordinante dà
incarico alla banca di stipulare un contratto
414
di garanzia autonoma con colui che è creditore
nel rapporto di valuta e che è beneficiario
della garanzia. In astratto si potrebbe anche
ipotizzare un’assunzione spontanea della
garanzia da parte del garante (banca o società
di assicurazione); in tal caso i rapporti tra
garante e debitore principale potrebbero essere
regolati dalle norme in tema di gestione
d’affari e di arricchimento senza giusta
causa390.
c) Infine v’è un contratto di garanzia tra il
garante e il beneficiario, creditore nel
rapporto di valuta. Tale terzo rapporto, non
avendo vita da un contratto sinallagmatico, è
riconducibile alla fattispecie di cui all’art.
1333 cod. civ., (contratto con obbligazioni del
390 F. MASTROPAOLO, I contratti autonomi di garanzia, Torino, 1995, p. 224.
415
solo proponente), che si perfeziona con il
mancato rifiuto dell’oblato.
B) Passando ad enunciare la struttura delle
garanzia autonome indirette, va detto che esse
sono frequenti quando gli operatori economici
del rapporto principale hanno sede in Stati
diversi. Più precisamente è necessario
ricorrere a tali garanzie quando la legge del
Paese del beneficiario impone che le garanzie
possano essere emesse soltanto da banche
locali. Per questo caso la banca dell’ordinante
assume non un impegno diretto nei confronti del
beneficiario, bensì nei confronti della banca
del Paese del beneficiario. Il debitore dà
incarico ad una banca del suo Paese (prima
banca o banca contro garante) d’incaricare una
banca del Paese del beneficiario (seconda banca
416
o banca garante), di rilasciare la garanzia
autonoma al creditore. In tal caso la struttura
della garanzia sarà quadrangolare:
a) v’è un rapporto base, tra ordinante e
beneficiario;
b) v’è un rapporto di mandato tra l’ordinante e
la prima banca.
c) Per quanto riguarda il rapporto sussistente
tra la prima banca (banca contro garante) e la
seconda (banca garante), secondo una prima
ricostruzione391 si tratterebbe di un rapporto
di sostituzione nel mandato (art. 1117 cod.
civ.). Per altra tesi, il rapporto tra la prima
e la seconda banca ha natura di autonomo sub
mandato, perché la seconda banca non interviene
per eseguire un’obbligazione della prima banca,
391 MASTROPAOLO, op. cit., p. 395.
417
ma per adempierne una propria, derivante da
autonomo mandato della prima banca392.
d) V’è un rapporto di garanzia autonoma tra la
seconda banca ed il beneficiario (creditore nel
rapporto di valuta).
e) Infine sussiste un rapporto di
controgaranzia tra la banca garante e la prima
banca, in forza del quale la seconda banca, che
ha pagato, potrà rivalersi verso la prima.
Va precisato, al fine di una migliore
comprensione della descritta struttura dei due
tipi di garanzia autonoma, che pur essendo di
solito il garante una banca o una società di
assicurazioni, è possibile in astratto pensare
che il contratto di garanzia autonoma
392 G. B. PORTALE, Le garanzie bancarie internazionali, (questioni), in Banca
borsa tit. cred., 1988, I, p. 29.
418
intercorra tra un diverso soggetto (garante) ed
il beneficiario.
Avendo descritto i rapporti che sono coinvolti
nella garanzia autonoma, si può pervenire ad
una definizione della stessa di tipo
strutturale. Si dirà che il Garantieverträge è il
contratto mediante il quale un soggetto, detto
garante, su incarico di un altro soggetto,
detto ordinante, ovvero controgarante (nelle
garanzie indirette), si obbliga nei confronti
di un terzo soggetto (beneficiario) ad eseguire
una determinata prestazione in suo favore, nel
caso d’inadempimento dell’ordinante quanto al
rapporto di valuta; la prestazione sarà
eseguita su semplice richiesta avanzata dal
beneficiario nelle forme pattuite, senz’onere
per quest’ultimo di provare l’inadempimento del
419
debitore, e senza possibilità per il garante di
opporre eccezioni relative al rapporto di
valuta o di provvista (salve le precisazioni
che dovranno farsi su quest’ultimo punto).
7. Riconduzione della categoria “contratto di garanzia
autonoma” allo schema della promessa del fatto del terzo
(art. 1381 cod. civ.).
Uno degli utilizzi più rilevanti sotto il
profilo sistematico della fattispecie
contemplata dall’art. 1381 del codice civile
(promessa del fatto del terzo), è stato quello
d’individuarvi un supporto normativo per
l’inquadramento delle garanzie affermatisi
nella prassi commerciale nazionale ed
internazionale, caratterizzate dalla carenza
dell’accessorietà dell’obbligazione del garante
rispetto a quella del debitore principale (dato
420
che connota la garanzia di tipo fideiussorio di
cui agli art. 1936 ss. cod. civ).
Come sopra già ricordato393 risale ad un Autore
non recente l’affermazione secondo cui una
fideiussione invalida per nullità del contratto
principale si converte sempre in una valida
promessa del fatto del terzo ex art. 1381 cod.
civ., e che se le parti discorrono di
fideiussione, pur sapendo che il contratto
principale è nullo, deve ritenersi che essi
vogliano stipulare una promessa del fatto del
terzo394. In merito a tal opinione, se è chiara
la comprensione del pensiero dell’A., sembra
intanto agevole rilevare che la seconda
proposizione sembra una mera ripetizione della
prima, perché ammettendo che il contratto di
393 V. Par. 2 del presente capitolo.394 G. STOLFI, op. cit., p. 203 ss.
421
fideiussione invalido per nullità del contratto
principale si converta sempre in una valida
promessa del fatto del terzo, inevitabilmente
la conversione avverrà a prescindere dalla
conoscenza che le parti abbiano della nullità
del contratto principale.
Più di recente si è sostenuto che l’art. 1381
cod. civ. <<si presenta come il prototipo, nel
sistema, delle varie possibili forme di
garanzie autonome; di quelle garanzie, cioè,
mediante le quali un soggetto (promittente)
induce un altro (promissario) a intraprendere
alcunché che può causargli un pregiudizio (ed
in particolare, ad instaurare o mantenere un
rapporto con un terzo che comporti obblighi,
spese, prestazioni, modifiche organizzative
interne etc.), creando l’affidamento che
422
l’eventuale perdita dovuta all’insuccesso
dell’iniziativa indotta (mancata prestazione
del terzo, quale che ne sia la causa) sarà
sopportata non dal promissario su cui
ricadrebbe in primo luogo, ma da lui
(promittente), in quanto egli ne assume il
rischio.>>395. L’A. citato afferma inoltre che
bisognerà ricorrere al principio dell’autonomia
contrattuale per spiegare perché il promittente
sia libero di dare sicurezza al creditore
garantito mediante l’assunzione di un obbligo
autonomo di garanzia, (ma si può aggiungere
anche mediante l’assunzione di un obbligo di
garanzia fideiussorio); attraverso il principio
della giusta causa dell’attribuzione si
spiegherebbe invece perché il promissario può
trattenere l’attribuzione patrimoniale fatta
395 A. MAZZONI, Lettere di patronage, Milano 1986, p. 306.
423
dal promittente. Afferma l’A. <<è lecito nel
sistema il patto di trasferimento di rischi o
perdite non imputabile a colpa delle parti; e
di ciò appunto l’art. 1381 costituisce il
riconoscimento legislativo forse più
cospicuo>>396.
Sempre nell’ottica di rinvenire nell’art. 1381
cod. civ. uno schema legale tipico attraverso
il quale può essere assunta dal contraente una
garanzia personale priva dell’attributo
dell’accessorietà (tipico della fideiussione)
ad un obbligo che il debitore abbia verso il
creditore, si è detto che <<per inquadrare gli
impegni assunti per ragione di garanzia, ma
scissi dalle vicende iniziali e successive del
rapporto garantito, occorrerebbe valorizzare lo
spunto secondo il quale in tutte queste nuove
396 A. e op. ult. cit., p. 308.
424
forme negoziali, v’è un interesse specialmente
qualificato e normalmente economico, del
garante>>397. Piuttosto che di un impegno di
adempiere l’obbligo altrui, <<lo schema
sembrerebbe essere quello della promessa del
fatto del terzo, nella variante particolare
della promessa del fatto materiale del
pagamento>>398. Per quanto riguarda la
giustificazione causale del negozio, essa viene
individuata nell’interesse patrimoniale del
garante, <<giacché questi impegni vengono
assunti allo scopo di agevolare gli affari di
un soggetto alla cui attività il promittente è
direttamente interessato, o, all’inverso, sono
resi da una banca in esecuzione dell’accordo
stipulato dietro corrispettivo con il
397 G. CASTIGLIA, Promesse unilaterali atipiche, in Riv. dir. comm., 1983, I,
p. 396.398 G. CASTIGLIA, o.u.c., p. 397.
425
debitore>>399. Il fondamento della vincolatività
dell’impegno non sarebbe pertanto da ravvisare
nella semplice causa cavendi (ripetendo il
ragionamento che è lecito effettuare per la
fideiussione), ma “nell’interesse non liberale
del promittente”.
La tesi richiama alla mente la costruzione
classica del Garantieverträge, caratterizzato
dall’interesse di animazione del garante, ossia
da un qualsiasi interesse del garante che lo
induce a sollecitare l’attività del soggetto
garantito, per cui la giustificazione causale
del negozio si regge su di uno scambio tra la
prestazione cui è tenuto il creditore garantito
e il sacrificio cui il garante si espone
prestando la garanzia. Tuttavia sembra
necessario un chiarimento sul punto.
399 G. CASTICLIA, o.u.c., p. 398.
426
Innanzitutto va premesso che con il termine
contratto autonomo di garanzia non s’individua
un’unitaria categoria negoziale, bensì una
frammentazione d’ipotesi negoziali. Del resto, già da
un punto di vista descrittivo, un indizio della
non uniformità della categoria si può rinvenire
nella varietà tipologica di figure che si usa
ascrivere alla categoria della garanzia
autonoma400. Sul punto si tornerà diffusamente
in seguito, quando si cercherà di rinvenire un
inquadramento sistematico delle diverse figure
più aderente ai profili strutturali che le
caratterizzano. Per ora sembra opportuno
sottolineare che l’assunto secondo cui
l’interesse del garante può costituire la
giustificazione causale di alcune tipologie di
contratti autonomi di garanzia (ad esempio
400 F. NAPPI, op. cit., p. 102.
427
delle lettere di patronage “forte”, in cui il
patronnant ha interesse a che la società
patrocinata riceva un certo finanziamento), non
sembra potersi estendere a quelle garanzie che
sono prestate sulla base di un incarico
ricevuto dal debitore garantito. In tal caso la
giusta causa del negozio con funzione di
garanzia che la banca (la compagnia di
assicurazioni o altro garante) conclude con il
creditore beneficiario, più che essere
rinvenuta nell’interesse patrimoniale della
banca, va ravvisata nell’incarico stesso, che
permetterà al garante di conteggiare il
pagamento della garanzia al debitore
principale. In altri termini, come meglio si
dirà, queste garanzie possono essere ricondotte
al meccanismo della delegazione.
428
8. Segue: critiche alla riconduzione tout court del
contratto autonomo di garanzia alla fattispecie della
promessa del fatto del terzo.
In sostanza le tesi che riconducono la
categoria del contratto autonomo di garanzia
alla fattispecie della promessa del fatto del
terzo individuano nell’autonomia
dell’obbligazione assunta dal promittente-
garante rispetto a quella che corre tra il
promissario ed il terzo401 e nella valenza401 Superato l’orientamento per cui intanto il promittente può
ritenersi obbligato in quanto nessun rapporto corra tra terzo e
promissario (nel qual caso il promittente sarebbe liberato) resta
il fatto che, a ben vedere, l’indipendenza del rapporto di
garanzia rispetto a quello garantito ha un diverso significato nei
due istituti. Nella promessa del fatto del terzo l’autonomia
dell’obbligazione del promittente sta ad individuare la
circostanza per cui il promittente “assicura” il compimento di un
certo fatto da parte del terzo, indipendentemente dall’obbligo che
questi abbia nei confronti del promissario; nel contratto autonomo
di garanzia l’autonomia indica uno scollamento (definitivo o
provvisorio) del rapporto di garanzia rispetto alle vicende del
rapporto garantito. Quindi il medesimo concetto, se nel caso della
promessa sembra indicare la possibilità dell’assunzione di
un’obbligazione di garanzia indipendentemente dall’esistenza di un
429
indennitaria dell’obbligazione assunta dal
promittente-garante qualora il terzo non compia
il fatto, gli elementi che consentono una
reductio ad unitatem dei due istituti. In altri
termini la promessa del fatto del terzo e la
garanzia autonoma avrebbero in comune la funzione
di proteggere il beneficiario dal rischio della mancata
esecuzione del rapporto di valuta (che nel caso della
promessa può non esistere, a meno di non
individuarlo nel mero rapporto d’interesse che
il promissario abbia al compimento del fatto
del terzo), attraverso una prestazione di tipo
indennitario.
obbligo derivante da un rapporto principale, utilizzato in
relazione al contratto autonomo di garanzia sembra descrivere un
carattere afferente alla realizzazione della garanzia,
prescindendo l’escussione della stessa dall’eventuale esistenza di
vizi del contratto da cui nasce il rapporto principale, o dalla
possibilità di opporre eccezioni che attengono al rapporto
principale.
430
Nonostante il fascino che può esercitare la
riconduzione tout court delle garanzie autonome
nell’alveo dello schema ex art 1381 cod. civ.,
sulla base dei citati caratteri che i due
istituti hanno in comune, bisogna tuttavia
convenire sulla circostanza che tale
collocazione sistematica presenta notevoli
limiti, soprattutto nella misura in cui essa si
prospetta come soluzione d’inquadramento totale
di tutte le diverse forme di garanzia autonoma,
senz’alcuna distinzione. Cerchiamo allora di
analizzare puntualmente quali sono gli ostacoli
alla riconduzione sistematica delle garanzie in
discorso allo schema legale di cui all’art.
1381 cod. civ.
A) Come un autorevole Studioso ha sostenuto402,
bisognerebbe innanzitutto prendere atto che le
402 R. CICALA, Saggi, cit., p. 195 ss.
431
diverse fattispecie negoziali riconducibili
alla garanzia autonoma, piuttosto che porsi
come un insieme omogeneo, si prestano ad essere
distinte sotto tre profili: 1) diversità del
rischio che s’intende coprire, 2) diverso
oggetto della prestazione del garante, 3)
richiamo o meno nel contratto di garanzia, del
mandato debitore – garante.
Tralasciando per ora di analizzare il terzo
profilo citato, riguardo al primo profilo
bisognerebbe distinguere tra a) quelle garanzie
attraverso le quali <<s’intenda solo evitare
che la soddisfazione del creditore subisca
ritardi per contestazioni sollevate dal garante
o dal debitore, nel qual caso il creditore
soddisfatto dal garante nonostante
l’inesistenza, la nullità etc. del debito,
432
resta esposto alla ripetizione da parte del
debitore, a cui il garante conteggiò il suo
pagamento>>; b) quelle ipotesi di garanzia che
hanno la funzione di coprire a favore del
creditore <<il rischio atipico correlativo alla
nullità, annullabilità, o frustrazione in
genere del contratto di valuta, (…) qui
l’attribuzione del garante è in ogni caso
definitiva, cioè irripetibile e dal garante e
dal debitore>>. Ebbene, se è agevole affermare
la compatibilità di questo secondo gruppo di
garanzie che coprono rischi atipici con lo
schema della promessa del fatto del terzo, è
senz’altro preclusa la possibilità di
ricondurre le garanzie c.d. a prima domanda
allo schema citato, in quanto l’obbligazione
indennitaria a carico del promittente comporta
433
un’acquisizione definitiva in capo al
beneficiario.
Riguardo l’oggetto della prestazione del
garante, l’A. citato giustamente osserva che
nell’ambito della categoria contrattuale in
esame è possibile che a) il garante “autonomo”
sia tenuto ad una prestazione indennitaria,
<<cioè di riparazione del danno da
inadempimento o da frustrazione del rapporto,
preventivamente liquidata in una somma di
danaro>>403; ora (si pensi ad esempio alla c.d.
garanzia dell’offerta, o ancora alla garanzia
di buona esecuzione404) il garante sarà tenuto
ad una prestazione diversa (indennitaria)
rispetto a quella cui è tenuto il debitore
principale. b) In talune tipologie di garanzie
403 R. CICALA, o.u.c., p. 197.404 Vedi sopra, p. 4.
434
autonome invece il garante è tenuto ad una
prestazione identica a quella del debitore
principale, il che è possibile solo se
quest’ultima sia fungibile405. Esempi di tale
seconda tipologia di garanzie autonome sono la
garanzia di pagamento e la garanzia di
restituzione degli acconti, nelle quali il
garante è tenuto ad effettuare la medesima
prestazione cui è tenuto il debitore
principale. Emerge pertanto, data la natura
indennitaria della prestazione cui è tenuto il
promittente ex art. 1381 del codice civile, che
tali tipi di garanzie non sono riconducibili
allo schema della promessa del fatto del terzo,
divergendone sotto il profilo dell’oggetto
della prestazione del garante.
405 R. CICALA, o.u.c., p. 197.
435
B) Una seconda obiezione alla riconduzione tout
court delle garanzie autonome allo schema della
promessa fa leva sulla circostanza che,
richiamando lo schema di cui all’art. 1381 cod.
civ., secondo cui il promittente è tenuto ad
indennizzare il promissario se il terzo non
compie il fatto promesso, il garante dovrebbe
rispondere dell’inadempimento solo nell’ipotesi
in cui il debitore (terzo secondo lo schema
della promessa) non abbia adempiuto
l’obbligazione principale406. Questa
ricostruzione non consente però di offrire un
inquadramento alle garanzie in cui è inserita
la clausola <<a prima domanda e senza
eccezioni>>, in cui il garante è senz’altro
tenuto al pagamento, non rilevando in sede di
escussione della garanzia l’avvenuto
406 L. RUGGERI . S. MONTICELLI, op. cit., p. 230.
436
adempimento del debitore principale, giacché
detta circostanza emerge in sede di azione di
ripetizione, salvo che si ritenga percorribile
la via dell’exceptio doli, soluzione tutt’altro
che pacifica.
C) Dal punto di vista delle obbligazioni che
nascono dalla stipula delle due diverse figure
negoziali, si è poi osservato che mentre dalla
promessa, secondo la ricostruzione accolta
dalla corte di Cassazione407, nascono una prima
obbligazione di fare in capo al promittente, ed
una seconda obbligazione eventuale di pagare
l’indennizzo, ove il promittente si sia
impegnato a procurare il fatto promesso ed il
terzo non lo abbia compiuto, è evidente che
solo la seconda obbligazione nascerebbe in capo
407 Cass., 20 dicembre 1995, n. 12973, in Giur. it., 1997, I, 1, p.
89.
437
al garante in seguito alla stipulazione di un
contratto autonomo di garanzia408.
D) Ancora, riguardo all’operatività della
promessa, si è evidenziato che l’art. 1381 cod.
civ. non contempla una fattispecie contrattuale
autonoma, ma un frammento di fattispecie, che
s’inserisce in un più ampio regolamento
d’interessi. Sebbene la formulazione
dell’articolo 1381 cod. civ. non escluda in
astratto che possa configurarsi un promessa
autonoma, intesa come contratto con
obbligazioni del solo proponente, la realtà
mostra che la promessa <<s’inserisce sempre in
un più ampio regolamento d’interessi che ne
integra il profilo causale, proprio perché non
realizza di per sé un autonomo schema causale.
Insomma questa tipica prestazione di garanzia,
408 L. RUGGERI – S. MONTICELLI, o.u.c., p. 231.
438
che è la promessa del fatto del terzo può, come
accade in linea di principio per qualsiasi
promessa, essere sorretta da svariati profili
causali (mandato, commissione, locazione,
vendita, ecc.) anche eventualmente atipici>>409.
Giuste le considerazioni riportate, la
differenza tra la promessa e il contratto
autonomo di garanzia risiederebbe nella diversa
natura delle due fattispecie negoziali, l’una
costituendo un frammento di fattispecie
negoziale non dotato di autonoma
giustificazione causale, l’altro un contratto
con funzione di garanzia, con la precisazione
che anche per il contratto autonomo di garanzia
si pone la necessità di specificarne il profilo
causale, non potendo questo essere individuato
nella causa cavendi, se attraverso la prestazione
409 F. NAPPI, op. cit., p. 74.
439
del garante s’intenda garantire una prestazione
<<auf jedem Fall>> e quindi anche nei casi
d’invalidità del rapporto principale. Lo schema
della causa di garanzia comporterebbe infatti
che dovendo il garante “assicurare”
l’adempimento dell’obbligazione principale, la
garanzia non potrebbe essere escussa nei casi
d’invalidità del negozio da cui nasce il
rapporto principale, riproponendosi in sostanza
il meccanismo del riverbero dell’invalidità del
negozio principale sulla negozio di garanzia
(meccanismo che opera nella fideiussione ex
art. 1939 cod. civ., il cui disposto esplicita
il requisito dell’accessorietà genetica,
subordinando la validità della fideiussione
alla validità dell’obbligazione principale).
440
Le considerazioni formulate inducono a
rimeditare la possibilità di un inquadramento
totalizzante delle diverse forme di garanzia
autonoma, inducendo a considerare invece la
necessità di una trattazione differenziata
delle diverse ipotesi cui fa riferimento la
corrente nozione di garanzia autonoma.
9. La nozione di autonomia utilizzata per descrivere la
categoria di contratti personali di garanzia in cui non trova
applicazione il principio dell’accessorietà fideiussoria.
Secondo un iter che si è cercato di ricostruire
nei paragrafi precedenti, la pratica degli
affari e l’evoluzione della tecnica creditizia
hanno prodotto una duplice conseguenza:
1)con la normativa convenzionale v’è stato
un mutamento sulla struttura giuridica
delle figure generali di garanzia,
441
specialmente della fideiussione, nei
termini di un distacco dell’obbligazione
di garanzia da quella garantita;
2)v’è stato il ricorso a nuove forme di
garanzia personale sempre più svincolate
dalla rigida accessorietà dell’obbligo
fideiussorio.
Affianco all’obbligazione accessoria di
garanzia, il sistema conosce pertanto quelle
obbligazioni di garanzia che sono autonome
rispetto al rapporto principale, nel senso che
le vicende del rapporto di garanzia sono
indipendenti da quelle del rapporto garantito.
Il dato che unifica queste garanzie è proprio
la carenza dell’accessorietà che connota la
garanzia di tipo fideiussorio, di cui agli art.
1936 ss cod. civ. In particolare tale risultato
442
è ottenuto attraverso l’inserimento nel
contratto di clausole la cui operatività
comporta che a) l’invalidità dell’obbligazione
principale non si riverberi sulla validità
dell’obbligazione di garanzia; b) il garante
non può sottrarsi al pagamento opponendo
eccezioni attinenti al rapporto principale; c)
il garante deve pagare sulla base della sola
richiesta del beneficiario, ancorché vi sia
l’opposizione del debitore principale. La
funzione di tali clausole è diversa: le prime
due recidono il nesso di accessorietà genetica
e funzionale della garanzia rispetto al
rapporto – base, per cui le vicende iniziali e
successive del rapporto-base non si
ripercuotono sul rapporto di garanzia; l’ultima
clausola ha la funzione di evitare ritardi nel
pagamento della garanzia, sulla base di
443
eventuali contestazioni circa la sussistenza
dei presupposti che legittimano il creditore
all’escussione della garanzia (avvenuto
adempimento da parte del debitore principale).
Negli studi sul tema della garanzia c.d.
autonoma è diffusa l’opinione secondo cui
autonomia ed accessorietà dell’obbligazione di
garanzia siano descrittive di due specie
diverse <<nell’ambito di un concetto di
garanzia per altri versi unitario410>>, che
differiscono in relazione al diverso
collegamento che sussiste tra rapporto
garantito e rapporto di garanzia. La garanzia
autonoma darebbe luogo ad una più accentuata
indipendenza del rapporto di garanzia dal410 Espressione utilizzata da F. NAPPI, op. cit., p. 56; L’A. è
critico verso la possibilità di <<identificare nell’autonomia un
carattere peculiare delle garanzie autonome, che consenta di
collocarle accanto a quelle accessorie, nell’ambito del genus
delle garanzie personali>>.
444
rapporto garantito. Procediamo ad una rapida
rassegna della dottrina in materia.
Una conferma della possibilità sistematica di
considerare l’autonomia e l’accessorietà
dell’obbligazione come attributi di due specie
di garanzia, che a pieno titolo si riconducono
all’unitario genus delle garanzie personali,
può rinvenirsi negli studi sulle garanzie
cambiarie. Com’è noto, sulla base dell’art. 7
della legge cambiaria ogni obbligato cambiario
assume un’obbligazione indipendente da quella
degli altri firmatari, per cui traenti e
giranti sono obbligati indipendentemente
dall’esistenza attuale o futura
dell’obbligazione principale; in particolare
anche per l’avallo (garanzia cambiaria
attraverso cui un soggetto garantisce il
445
pagamento se l’obbligato principale non vi
provveda) vale tale principio d’indipendenza:
la validità dell’obbligazione principale non
costituisce presupposto della validità
dell’avallo. Per questo motivo l’avallo
cambiario si distingue dalla fideiussione, che
ha carattere accessorio (presupposto della
validità dell’obbligazione del fideiussore è la
validità del negozio da cui nasce il rapporto
principale). Sulla base della citata
disciplina411 negli studi sull’argomento si è
sostenuto che <<il concetto di garanzia non è
contraddittorio né con la natura accessoria, né
con la natura autonoma dell’obbligazione di
garanzia>>412, o anche che non è consentito
<<identificare con la fideiussione ogni sorta
411 In particolare vedi art. 37 comma 2 legge cambiaria.412 ROSSI, L’avallo come garanzia cambiaria tipica, in Banca borsa tit. cred.,
1962, I, p. 13 ss.
446
di garanzia personale ed elevare la disciplina
della prima ad archetipo di tutte le
obbligazioni contraddistinte da tale
funzione>>413, e ancora che <<tra il rapporto di
garanzia e il rapporto oggetto della garanzia
non è necessario che esista un nesso di
subordinazione, che si esprime nel concetto di
accessorietà, in quanto è sufficiente che
esista un nesso di coordinazione>>414.
Com’è stato giustamente osservato415, il
risultato cui questi studi nel campo
dell’obbligazione cambiaria di garanzia
approdano è duplice: da un lato si nega
all’accessorietà l’attitudine ad esprimere <<
sul piano concettuale un carattere della
413 G. F. CAMPOBASSO, Coobbligazione cambiaria e solidarietà diseguale,
Napoli1974, p. 138.414 ROSSI, o.u.c., p. 14.415 F. NAPPI, op. cit., p. 67.
447
garanzia personale>> e dall’altro che
accessorietà e autonomia più che porsi in
rapporto di species, nell’ambito del genus
garanzia personale, esprimano <<la varietà di
configurazioni>> che il fenomeno della garanzia
personale può assumere.
Ancora, nell’ambito di un’analisi
comparatistica riguardante la fideiussione, la
promessa del fatto del terzo e la garanzia
autonoma416, un Autore ha giustamente sostenuto
che <<non è possibile identificare con la
fideiussione ogni forma di garanzia personale
ed elevare la disciplina fideiussoria ad
archetipo di tutte le obbligazioni
caratterizzate da una funzione di garanzia>>417,
individuando poi l’esistenza di un spazio
416 E. BRIGANTI, op. cit., p. 138 ss.417 E. BRIGANTI, op. cit., p. 145.
448
sistematico per inquadrare accanto ad
obbligazioni di garanzia caratterizzate
dall’accessorietà al rapporto principale,
garanzie che creano obbligazioni indipendenti
dalle vicende dello stesso. L’A. afferma
inoltre che è <<arbitrario elevare (il
carattere di accessorietà) a criterio
fondamentale per determinare l’appartenenza al
gruppo dei rapporti di garanzia>>, dato che
<<entro certi limiti la stessa obbligazione
fideiussoria è o può essere resa indipendente
dalle vicende dell’obbligazione principale>>,
citando ad esempio di tale assunto l’art. 1939
cod. civ. ult. comma, nonché la possibilità che
l’obbligazione fideiussoria, per volontà delle
parti, sopravviva alla nullità,
all’annullamento o all’estinzione
dell’obbligazione garantita.
449
Infine è possibile giungere alla conclusione
che autonomia ed accessorietà dell’obbligazione
di garanzia siano concetti complementari418
anche sulla base di una ricostruzione teorica
volta ad individuare il profilo causale comune
alle garanzie autonome ed accessorie nel <<far
sì che il garantito (…) che si attende in via
primaria da un terzo la soddisfazione di un
proprio interesse, veda accresciuta la
possibilità di realizzare comunque tale
interesse attraverso, appunto, l’obbligazione
del garante>>419. Com’è agevole rilevare, la
circostanza che la funzione della garanzia vada
inquadrata in relazione ad un “interesse” del
garante e non in relazione ad un credito dello
418 In tal senso P. DE SANNA, Accessorietà ed autonomia ne sistema delle
garanzie a prima richiesta, Milano, 1988, p. 41.419 A. MAZZONI, Lettere di patronage, mandato di credito e promessa del fatto del
terzo, cit., p. 361. Tesi su cui già ci si è soffermati in una
prospettiva critica, nel par. 14 del capitolo II.
450
stesso, è idonea a descrive il funzionamento di
quelle garanzie autonome che coprono rischi
atipici, per cui il garante è costretto a
pagare anche in ipotesi di nullità o
inesistenza del negozio da cui nasce il
rapporto principale. In tal caso la garanzia
sarà comunque funzionale alla tutela di un
“interesse” del beneficiario all’ottenimento
del risultato economico. L’autonomia in
quest’ottica, più che un distacco tra i due
rapporti, individua il collegamento che
sussiste tra il rapporto di garanzia e il
rapporto base, con la precisazione che la
garanzia non è fornita a protezione di un
diritto soggettivo, nel qual caso le vicende
estintive si ripercuotono sull’obbligazione del
garante, bensì tutela un semplice interesse di
fatto, dedotto nel rapporto di garanzia in
451
quanto tale420 (a titolo esemplificativo si
prospetta l’esempio dell’interesse del
creditore all’ottenimento di una certa
prestazione, che sopravvive alla nullità del
contratto per difetto di forma)421. In altri
termini la tesi citata riconduce il concetto di
autonomia dell’obbligazione di garanzia a
quello di accessorietà, precisando che
l’accessorietà delle garanzie autonome non va
ravvisata in relazione ad un rapporto
principale e dunque ad un credito, bensì in
collegamento con un interesse di fatto (privo
dell’habitus del diritto soggettivo) che è
oggetto di un “rapporto-base”, cui accede il
rapporto di garanzia.
420 La citata ricostruzione dottrinale è del P. DE SANNA, op. cit.,
p. 62 ss., 421 P. DE SANNA, op. cit., p. 54 nota 3.
452
Sebbene risulti apprezzabile lo sforzo
dell’individuazione di una causa – funzione di
garanzia, che, nei termini in cui è stata
descritta, risulti idonea a spiegare il
funzionamento sia della classica garanzia
fideiussoria, sia di quelle garanzie in cui le
vicende del rapporto base non si ripercuotono
su quello di garanzia, lascia però
inevitabilmente perplessi la possibilità di
giustificare l’attribuzione patrimoniale del
garante sulla base di un interesse di fatto. Il
nostro sistema giuridico, infatti, non conosce
situazioni in cui il solo interesse (privo del
proprio habitus giuridico) possa legittimare una
pretesa patrimoniale422.
422 È decisamente contrario alla possibilità di un inquadramento
sistematico delle garanzie autonome che faccia leva sulla loro
“autonomia”: F. NAPPI, op. cit., p. 54 ss., in particolare pag. 95-
96.
453
L’individuazione del fondamento causalistico
delle garanzie autonome nella causa-funzione di
garanzia, così come descritta dalla dottrina
sopra citata, altro non comporta che
individuare la giustificazione causale dei
contratti che si ascrivono alla categoria nella
causa cavendi, ossia nello scopo di garantire una
precedente obbligazione, con la precisazione
che nelle garanzie autonome l’interesse
protetto è spoglio del suo habitus giuridico.
L’interesse del promissario dovrebbe costituire
giusta causa dell’attribuzione del garante, pur
non essendo rivestito dei caratteri del diritto
soggettivo, ma si rimane perplessi, perché
l’interesse, se non integra un diritto
soggettivo, non ha dall’ordinamento quel
riconoscimento che gli permette di costituire
454
giusta causa dell’attribuzione in un diverso
rapporto (di garanzia).
Dunque non convince la descrizione della
garanzia autonoma nel senso di un’accessorietà
ad un interesse (che non integra un diritto
soggettivo) da cui trarrebbe la propria
giustificazione causale.
Questo lineare ragionamento induce a compiere
una riflessione sull’utilità d’individuare nel
genus delle garanzie personali due diverse
specie caratterizzate da autonomia ed
accessorietà dell’obbligazione di garanzia,
talvolta ravvisando in esse una dicotomia,
talaltra concetti complementari ed ancora varie
configurazioni del fenomeno. Com’è stato
giustamente osservato 423 l’utilità della
costruzione di un genus garanzia del credito423 F. NAPPI, op. cit., p. 61 ss.
455
dovrebbe servire <<ad indicare i confini entro
cui è possibile proporre in termini specifici
ed unitari, per una serie di fenomeni, alcune
problematiche, come, per esempio, quella della
giusta causa dell’attribuzione>>, o ancora le
condizioni e la misura <<in cui la disciplina
del diritto di garanzia risenta delle vicende
del diritto garantito>>424.
Sembra allora da condividere l’opinione
dottrinale che non ritiene possibile spiegare
l’esistenza nel nostro ordinamento di garanzie
non caratterizzate da quel nesso di
accessorietà del rapporto di garanzia al
424 Problematica questa correttamente individuata dall’A. cui è
attribuibile l’individuazione della c.d. causa – funzione di
garanzia, A. MAZZONI, Lettere di patronage, mandato di credito e promessa del
fatto del terzo, cit., p. 361 nota 93; L’A tuttavia, pur individuando
correttamente la funzionalità della categoria concettuale (qual è
quella della causa funzione di garanzia) sembra non accorgersi
dell’inidoneità della stessa a descrivere il funzionamento delle
garanzie autonome.
456
rapporto garantito (che comporta che il diritto
del creditore di escutere la garanzia si fondi
su un preesistente diritto dello stesso verso
un debitore garantito) richiamando lo schema
della causa cavendi, dovendosi invece
necessariamente distinguere tra un concetto di
garanzia in senso tecnico, garanzia fornita in
relazione alla soddisfazione di un credito,
dalla garanzia fornita in relazione
<<all’eventualità di un pregiudizio che possa
colpire un proprio interesse, mediante
l’assunzione dell’onere economico del danno
temuto>>425.
Il profilo della diversa giustificazione
causale di tali contratti autonomi di garanzia425 In questo senso descrive la funzione di garanzia della
promessa del fatto del terzo G. SCALFI, La promessa del fatto altrui,
cit., p. 45. Del resto l’inquadramento della promessa del fatto del
terzo come negozio di garanzia allude proprio a questo concetto di
garanzia.
457
si lega poi con la diversa funzionalità di
questi contratti, rispetto alle garanzie
accessorie ad un debito principale. La funzione
della fideiussione infatti può essere ravvisata
nel garantire il creditore contro
l’inadempimento del debitore principale, dove
l’inadempimento rinvia necessariamente
all’esistenza di un credito di cui si attende
soddisfazione; la fideiussione in altri termini
comporta un aumento delle possibilità del
creditore di vedere soddisfatto il proprio
interesse creditorio. Le garanzie che prevedono
l’assunzione di un rischio atipico, per cui il
“creditore” avrà diritto ad ottenere un quid da
parte del garante, anche se vicende originarie
o successive riguardanti il contratto – base o
il rapporto escludano la possibilità di esigere
l’adempimento dal debitore principale (esempio:
458
nullità, annullabilità, impossibilità
sopravvenuta della prestazione) comportano
l’assunzione dell’onere economico del danno
temuto in relazione al rischio di un
pregiudizio che possa colpire un interesse del
beneficiario della garanzia. È di fondamentale
importanza sottolineare che tal interesse non è
necessariamente tutelato in un distinto
rapporto obbligatorio ed in questo senso
diverso da quello tutelato attraverso la
garanzia fideiussoria, ma può essere
considerato esclusivamente nel negozio di
garanzia426.
In quest’ottica l’autonomia della garanzia non
esprime un distacco del rapporto di garanzia da
quello garantito (distacco che ha una valenza
descrittiva nell’indicare che non sono
426 In questo senso F. NAPPI, op. cit., p. 58.
459
opponibili eccezioni relative al rapporto base,
o nel descrivere l’irrilevanza della nullità
del contratto base ai fini della validità della
garanzia), ma la circostanza che l’interesse
tutelato attraverso la garanzia autonoma può
non essere omogeneo rispetto a quello tutelato
in un eventuale rapporto base.
La causa del negozio di garanzia non sarà
allora ravvisata nella protezione di un
interesse oggetto di un rapporto base
(riproducendo lo schema della causa cavendi, con
la precisazione che l’entità tutelata non è un
diritto ma un interesse); la tutela di un
interesse dell’oblato sarà solo l’effetto della
prestazione della garanzia. Si pone allora
l’esigenza di analizzare quali possono essere
le giustificazioni causali delle. garanzie che
460
non si fondano su di un rapporto obbligatorio
preesistente.
10. La causa della garanzia consistente nell’obbligazione
preesistente garantita.
Si è vista nel primo capitolo427 la duplice
accezione strutturale e funzionale
dell’accessorietà fideiussoria. Si sono
riportate in quella sede anche le critiche
volte a sfatare l’assolutezza del concetto, in
presenza di disposizioni (secondo periodo art.
1939 cod. civ.; secondo periodo art. 1945 cod.
civ.) che escludono che talune vicende del
rapporto garantito si ripercuotano sul rapporto
di garanzia, recidendo per tal verso il nesso
di accessorietà (la fideiussione è valida se il
debito è stato assunto da un soggetto incapace;
il fideiussore non può opporre al creditore
427 Retro, par. 9, cap. 1.
461
garantito l’incapacità del debitore
principale).
Bisogna ora sottolineare l’importanza dell’art.
1950 cod. civ., che riconoscendo al fideiussore
che ha pagato il diritto di regresso, fa’ in
modo che il peso definitivo del debito, ricada
in via definitiva sul debitore principale,
anche nel caso in cui costui fosse incapace,
sia pure nei limiti “di ciò che sia stato
rivolto a suo vantaggio” e non del solutum. Il
fideiussore che abbia pagato quanto dovuto dal
debitore principale, avrà pertanto sempre
diritto al regresso verso quest’ultimo428.428 Il fideiussore che abbia pagato ha sempre diritto al regresso
contro il debitore principale. È da precisare che il divieto di
agire contro il debitore principale ex art. 1952 cod. civ. si pone
solo in relazione ad ipotesi in cui il fideiussore abbia pagato
senza dare avviso al debitore principale, che a sua volta ha
pagato ugualmente il debito, o si è trovato nell’impossibilità di
sottrarsi al pagamento sollevando delle eccezioni verso il
creditore, eccezioni che potrà proporre nei confronti del
fideiussore (art. 1952 comma 2, cod. civ.).
462
Generalizzando, si può dire che in ogni caso in
cui un soggetto s’impegni accessoriamente al
debito che grava su un debitore principale avrà
diritto al regresso nei confronti di
quest’ultimo. La surrogazione d’altro canto
svolgerà la funzione di far subentrare il
garante nelle garanzie costituite a favore del
creditore. L’opinione dottrinale secondo cui
l’esistenza di un’obbligazione principale (che
attraverso la fideiussione si garantisce)
giustifica, di per sé sola, il sacrificio cui
il promittente si espone429, potrebbe spiegarsi
proprio in ragione della circostanza per cui
attraverso il regresso il peso definitivo del
debito si radica sul debitore principale,
<<ossia nel patrimonio di un soggetto del cui
429 Per tutti: G. CASTIGLIA, op. cit., p. 392 ss.; A. CHECCHINI,
Indennizzo e risarcimento, cit., p. 597 - 600; E. BRIGANTI, op. cit., p.
34 ss.
463
impegno l’ordinamento ha valutato aliunde la
giustificazione causale>>430, giusta
l’osservazione secondo cui l’accessorietà
<<assicura la circolarità delle attribuzioni
patrimoniali>>431.
Se da un lato attraverso i negozi di garanzia
“accessori”, ossia quelli che presuppongono un
rapporto obbligatorio principale, l’ordinamento
stimola la concessione del credito, dall’altro
il legislatore si preoccupa di predisporre
degli strumenti che permettono al garante che
ha pagato di non essere il destinatario
definitivo del peso del debito. In altri
termini attraverso il regresso e la
surrogazione l’ordinamento concilia la funzione
di stimolazione del credito (prodotta dalla
430 F. ROCCHIO, op. cit., p. 58.431 A. CHECCHINI, op. ult. cit., p. 599.
464
maggiore protezione del creditore) con
l’esigenza di lasciare indenne il
garante/accessorio che ha pagato, di modo che
gli effetti del pagamento vadano in definitiva
a ricadere sul patrimonio del debitore
principale432.
Sembra allora da condividere l’opinione secondo
cui la causa sufficiente dell’obbligazione del
fideiussore è da individuarsi <<nella
preesistenza di una valida obbligazione
principale accessoria che, con l’assicurare il
diritto di regresso, permetta la circolarità
delle attribuzioni patrimoniali>>433; l’assunto
conduce a concludere nel senso che al di fuori
432 G. CASTIGLIA, op. cit., p. 392, il quale nella nota 192 avverte
che lo stesso discorso, volto a rinvenire nella preesistenza del
rapporto obbligatorio la causa sufficiente di chi s’impegna allo
scopo di garantire il debito altrui, vale per i negozi di
assunzione del debito altrui. 433 F. ROCCHIO, op. cit., p. 62.
465
della garanzia prestata per una valida
obbligazione principale non vi sia spazio per
descrivere il profilo causale di quei negozi di
garanzia che prescindono dalla validità
dell’obbligazione principale, secondo lo schema
della causa cavendi. Perviene a tale conclusione
quell’illustre Autore, più volte citato nel
corso del presente lavoro434, quando riguardo il
profilo funzionale dei negozi di garanzia
sottolinea la necessità di non <<sottovalutare
i confini che opportunamente distinguono la
garanzia c.d. in senso tecnico(...) fornita in
relazione alla soddisfazione di un credito,
dalla garanzia di cui si discorre nel senso che
una parte venga garantita dall’altra in vista
di un pregiudizio che possa colpire un proprio
interesse, mediante l’assunzione dell’onere
434 F. NAPPI, op. cit., p. 57 ss.,
466
economico del danno temuto (detta anche
assunzione del rischio)>>; e più
esplicitamente, riguardo il profilo causale
della garanzia, afferma che <<la garanzia
autonoma non si lascia imbrigliare nello schema
della <<causa cavendi>> e che il fondamento
casuale della garanzia c.d. autonoma dovrà
rinvenirsi <<nelle comuni ragioni
giustificatrici di un negozio, senza che debba
essere ricondotta in un precostituito modello
funzionale>>435.
435 F. NAPPI, op. cit., p. 197 e p. 200.
467
11. Segue: la causa della garanzia autonoma436, intesa come
causalità dell’assunzione dell’obbligo di garanzia.
Si è chiarito nel paragrafo precedente che
l’obbligazione preesistente garantita
436 A fini di chiarezza espositiva è necessario precisare che per
“causa sufficiente” dell’obbligazione di garanzia, locuzione che
useremo nel corso del presente paragrafo, s’intende far
riferimento alla ragione che giustifica l’obbligo del garante. Il
concetto rinvia a quello di causa dell’obbligazione, ossia alla
ragione sostanziale del sacrificio di chi abbia assunto
l’obbligazione (R. SACCO, in R. SACCO-G. DE NOVA, Il contratto, I, in
Trattato di diritto civile diretto da R. Sacco, Torino, 2005, p. 792).
La Cassazione in una recente sentenza (Cass. 8 maggio 2006, n.
10490) ha avuto modo di chiarire che per causa del contratto si
deve intendere la <<sintesi degl’interessi reali che il contratto
stesso è diretto a realizzare (al di là del modello, anche tipico,
adoperato)>>, ancorando pertanto il concetto alla funzione
economico-sociale che il (singolo) contratto è volto a realizzare.
In un passaggio della sentenza, tra l’altro si legge che bisogna
rigettare una nozione di causa che <<sovrapponga, del tutto
incondivisibilmente, il concetto di causa del contratto con quello
di causa/fonte dell'obbligazione>>.
Sia consentito ricordare che sin dall’entrata in vigore del codice
del 1942 l’analisi del significato della nozione di causa ha
prodotto un coacervo di tesi: la causa del contratto da
individuare nella controprestazione; la causa intesa come lo scopo
pratico perseguito dalla parte; la causa intesa come funzione
economico-sociale o ancora come funzione economico-individuale;
del resto è noto che il significato della nozione di causa è tema
468
costituisce la causa sufficiente d’una garanzia
accessoria. Bisogna ora compiere un’indagine
sulle possibili ragioni giustificatrici di una
garanzia non accessoria ad un rapporto
tra i più discussi nell’ambito della dottrina civilistica. Con la
sentenza sopra citata la Cassazione, abbandonando la tesi della
funzione economico-sociale, che tra l’altro non consentirebbe di
capire perché un contratto tipico possa avere causa illecita,
adotta una nozione di causa incentrata sulla funzione che il
singolo negozio è deputato a svolgere, ossia sulla sintesi
degl’interessi reali che il contratto deve realizzare.
Il legislatore qualifica la causa come requisito essenziale del
contratto, comminandone la nullità in caso di mancanza o
illiceità. La precisazione comporta la necessità d’individuare il
requisito causale com’elemento immanente al negozio. Questo dato
non esclude però la possibilità (e in taluni casi la necessità) di
pervenire all’individuazione della giustificazione causale
dell’atto negoziale sulla base della valutazione della complessiva
operazione che presiede alla stipula del singolo contratto. In
altri termini, la ragione per cui un soggetto assume un
determinato obbligo può orientarsi sulla causa della conclusione
del contratto, piuttosto che sulla causa (funzione tipica) del
singolo atto negoziale; attraverso tale metodo si giunge alla
conclusione che una stessa prestazione può trovare fondamento su
supporti causali differenti (che è quanto in dottrina si predica
in relazione alla prestazione di garanzia: F. NAPPI, op. cit., p.
194 ss.). Il risultato consente di fare luce sulla giustificazione
causale della garanzia autonoma, laddove è chiaro che la causa di
garanzia del contratto non è idonea a spiegare il funzionamento
469
obbligatorio preesistente, nel senso che non
esista alcun rapporto-base (come può accedere
per la promessa del fatto del terzo), o nel
senso che l’operatività della garanzia
del negozio, non potendosi prestare una garanzia, da un punto di
vista logico prima che giuridico, per un credito che non esista o
che non è altrimenti azionabile. Il distacco dell’obbligazione di
garanzia da quella garantita impone di rinvenire necessariamente
un supporto causale del contratto di garanzia che sia idoneo a
spiegare perché quest’ultima possa essere escussa, nonostante la
non azionabilità del credito garantito sulla base del rapporto
sottostante.
In quest’ottica la nozione di causa intesa come giustificazione
del sacrificio di chi assume l’obbligazione, spostando l’analisi
sull’operazione complessiva sottesa alla stipula del singolo
negozio (di garanzia), permette d’individuare un fondamento
giustificativo dell’obbligo del garante, autonomo e diverso
rispetto a quello che fonda l’obbligo del debitore principale.
Questo elemento costituirà la causa del contratto di garanzia,
inteso come elemento immanente del singolo contratto, ma
determinato dalla complessiva operazione negoziale che presiede
alla stipula del negozio.
Per interessanti riflessioni sul tema: F. ROCCHIO, La promessa con
funzione di garanzia, cit., p. 26 ss., cui si rinvia per un’amplia
bibliografia sulle questioni del significato e della funzione
della nozione di causa. L’. A. individua com’elementi essenziali
del contratto (ex. art. 1325 n.2) la causa dell’obbligazione e del
rapporto fondamentale <<quale rapporto che ha portato
all’emissione della promessa>> (A. e op. ult. cit., p. 38.). A
470
prescinda da eventuali vizi genetici o
funzionali del negozio o del rapporto-base
(nullità, annullabilità, rescindibilità,
risoluzione del contratto). Non configurandosi
una garanzia accessoria e conseguentemente non
essendoci una circolarità di attribuzioni
patrimoniali che faccia confluire il peso
definitivo del debito dal garante che paga al
debitore, si tratterà d’individuare quali
quest’ultimo risultato l’A. perviene per deduzione dall’analisi
dell’art. 1988 cod. civ. che dispensa colui che fa una promessa di
pagamento o una ricognizione di debito dall’onere di provare il
rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria; si
produrrebbe pertanto <<un’inversione dell’onere della prova circa
la sussistenza del rapporto fondamentale, e non invece l’effetto
di far sorgere un’obbligazione che prescinde da detto rapporto>>,
da cui <<l’inammissibilità nel nostro ordinamento dell’atto
astratto, ossia dell’atto che crei un altro rapporto accanto al
rapporto fondamentale, dal quale astrae>>. La regola evidentemente
trova un’eccezione per i titoli di credito, in cui l’astrazione
dal rapporto fondamentale si accompagna però all’incorporazione
del credito nel documento, e alla previsione di una disciplina che
presiede alla circolazione di questo.
471
possano essere le ragioni giustificatrici
dell’onere economico che grava sul garante.
Si dica innanzitutto che le considerazioni che
si faranno di seguito valgono anche per la
promessa del fatto del terzo, in quanto pur non
configurandosi la relazione tra quest’ultima
fattispecie e il contratto autonomo di garanzia
nei termini di un’assoluta identità, bisogna
tuttavia convenire sulla circostanza che la
promessa del fatto del terzo è autonoma in un
duplice senso: 1) può prescindere da un
rapporto preesistente da garantire; 2) nel caso
in cui si configuri come promessa del fatto –
adempimento del terzo, le vicende del rapporto
base non si ripercuotono sull’obbligo del
472
promittente di pagare l’indennità, se il
fatto/adempimento del terzo non si verifichi.437
A) Innanzitutto una causa sufficiente del
sacrificio patrimoniale del garante “autonomo”,
nell’ambito di uno schema bilaterale, può
essere rinvenuta nello scambio, ossia nella
presenza di una controprestazione a carico del
creditore/promissario. Precisamente, a) secondo
lo schema dell’assicurazione del credito, il
creditore può pagare una somma a beneficio del
437 Come visto nel par. 12, lettera B, Capitolo II, la funzione
restitutoria del pagamento dell’indennizzo impone di aderire alla
conclusione secondo cui il promittente dovrà comunque ristorare il
promissario del pregiudizio subito per avere intrapreso una certa
iniziativa economica, facendo affidamento sul buon esito della
promessa, anche per il caso in cui ricorrano ipotesi di patologia
del negozio o del rapporto (nullità, annullabilità,
rescindibilità, risoluzione del contratto), che escludano che il
promissario (creditore nel rapporto base) possa esigere
direttamente l’adempimento dell’obbligo da parte del terzo
(debitore nel rapporto base). L’indennizzo varrà a riequilibrare
gl’interessi economici sottesi alla stipula del contratto, valendo
in altri termini a restituire al promissario ciò che ha perduto
concludendo il contratto o l’affare economico.
473
garante, affinché costui ne assicuri la
soddisfazione438; b) la controprestazione può
consistere nell’assunzione di un’obbligazione
da parte del creditore garantito nei confronti
del garante (di erogare un credito, oppure di
concedere una dilazione) cui costui sia
interessato, nella forma del contratto a favore
del terzo (dove stipulante è il garante,
promittente il creditore e terzo il debitore),
o con prestazione al terzo; l’elemento che
distingue le due fattispecie è l’intenzione dei
contraenti (garante e creditore garantito) di
attribuire al terzo il diritto di pretendere
l’esecuzione dell’obbligazione contratta dal
creditore nei confronti del garante, oppure la
diversa intenzione di attribuire al terzo solo438 L. BARBIERA, Garanzia del credito e autonomia privata, Napoli, 1971, p.
165 ss.; A, LENER, <<Expressio causae>> e astrazione processuale. Note
preliminari ad uno studio sistematico sull’astrazione, in Studi in onore di F. Santoro
Passarelli, III, NAPOLI, 1972, p. 43; F. ROCCHIO, op. cit., p. 63.
474
la prestazione a carico del garantito, senza il
diverso e più ampio potere di esigerla439.
c) La prestazione della garanzia può, peraltro,
porsi in rapporto di scambio con una
controprestazione del creditore, non
corrispettiva rispetto alla prima: è l’ipotesi
in cui la prestazione della garanzia è
condizionata all’esecuzione di una determinata
prestazione da parte del creditore garantito440.
Lo schema in cui ricondurre una tale ipotesi di
garanzia sarà quello dell’art. 1333 cod. civ.,
per cui per la conclusione del contratto di
garanzia non sarà necessaria l’accettazione del
creditore ed intanto il garante presterà la
garanzia in quanto il creditore garantito439 F. ROCCHIO, op. cit., p. 64.440 G. GORLA, Promesse <<condizionate>> ad una prestazione, in Riv. dir. comm.,
I, 1968, p 438ss, fa il caso della fideiussione per una futura
concessione di credito, secondo il seguente schema <<Se tu farai
credito a Tizio io sarò fideiussore>>; F. ROCCHIO, op. loc. ult. cit.
475
esegua la prestazione cui il garante è
interessato (erogazione del credito al terzo,
concessione di una dilazione, concessione di un
tasso d’interesse agevolato)441. La mancanza del
nesso di corrispettività tra le due prestazioni
non esclude che vi sia un rapporto di scambio
tra le stesse, idoneo a fornire una causa
sufficiente dell’attribuzione patrimoniale in
capo al garante; piuttosto la mancanza di
corrispettività comporterà che in caso di
441 Tale fattispecie ricorre nella giurisprudenza in tema di
garanzie infragruppo, v. Trib. Nocera Superiore, 15 giugno 1999,
in Corr. giur., 2000, p. 940, con nota di E. COSENTINO, Autonomia ed
astrattezza nelle garanzie a prima richiesta (la fattispecie portata alla
cognizione del giudice è quella di soci che promettono con
funzione di garanzia al fine di far concedere credito alla società
da loro partecipata); App. Torino, 4 dicembre 2000, n. 8159, Giur.
it., 2001, 1675, con nota di S.A. CERRATO, Osservazioni in tema di
operazioni infragruppo e di vantaggi compensativi (fattispecie della società
che promette con funzione di garanzia al fine di far concedere un
credito alla società da essa controllata); Cass., 15 giugno 2000,
n. 8159, in Giur. comm., 2002, II, 24 ss., con nota di D. MONACI,
Una nuova pronuncia della Cassazione in tema di limiti alla validità delle garanzie
infragruppo.
476
sopravvenuta eccessiva onerosità della
prestazione del garante, costui non potrà fare
ricorso al rimedio della risoluzione ex art.
1467 cod., civ., ma potrà ricorrere unicamente
al rimedio della riconduzione ad equità ex art.
1468 cod. civ.442.
Una riprova del rapporto di scambio esistente
tra la prestazione di una garanzia e un
beneficio concesso dal creditore può trarsi
dalla norma contemplata dall’art. 1186 cod.
civ.: il creditore che abbia concesso al
debitore un determinato termine per adempiere,
può esigere immediatamente la prestazione se il
debitore è divenuto insolvente e se (questa è
l’ipotesi che qui ci interessa) il debitore ha
442F. MASTROPAOLO - A. CALDERALE, Fideiussione e contratti di garanzia
personale, in AA.VV., I contratti di garanzia, a cura di F. Mastropaolo, I,
in Trattato dei contratti, diretto da P. Rescigno e E. Gabrielli,
Torino, 2006, p. 604.
477
diminuito le garanzie che aveva dato, o non ha
dato le garanzie che aveva promesso. La
spiegazione della disciplina può fondarsi sul
venir meno del rapporto di scambio tra la
concessione del termine e la prestazione della
garanzia, onde il creditore non è tenuto a
rispettare il termine concesso e dunque può
esigere immediatamente la prestazione443.
B) Nell’ambito degli schemi unilaterali una
causa sufficiente della prestazione di una
garanzia autonoma (che non abbia fondamento sul
rapporto preesistente garantito) può essere
rinvenuta nell’obbligazione preesistente di
prestare la garanzia, che il garante ha
precedentemente assunto.
L’obbligazione preesistente di prestare la
garanzia può essere stata assunta nei confronti443 F. ROCCHIO, op. cit., p. 68.
478
del creditore garantito: in questa ipotesi la
prestazione della garanzia costituirà
l’esecuzione di un contratto preliminare444.
L’obbligo di prestare una garanzia può essere
assunto nei confronti del debitore: avremo in
quest’ipotesi un pactum de contrahendo cum tertio, in
esecuzione del quale il garante presterà la
garanzia a favore del creditore445. In relazione
a tale patto stipulato dal debitore e dal
garante bisogna distinguere l’eventualità che
ricorra un contratto a favore di terzo, oppure
un contratto con prestazione al terzo. Secondo
lo schema del contratto a favore di terzo, i
contraenti intendono attribuire al creditore
444 M. FRAGALI, Fideiussione (dir. Priv.), in Enc. dir., XVII, Milano 1968,
p.371; M. FRAGALI, Fideiussione – mandato di credito, in Commentario del
codice civile, a cura di. Scialoja e Branca, Bologna-Roma 1968, p. 21;
F. MASTROPAOLO – A. CALDERALE, op. cit., p. 377.445A. RAVAZZONI, La fideiussione, Milano 1957, p. 147 ss.; M. FRAGALI,
op. loc. ult. cit.
479
non solo la prestazione della garanzia, ma
anche il potere di esigerla. Tale forma
contrattuale ha una delle sue manifestazioni
più diffuse nelle polizze fideiussorie. Si
tratta di contratti in cui una compagnia di
assicurazioni, dietro versamento di un premio
da parte del debitore, garantisce l’adempimento
delle obbligazioni gravanti su questo in favore
del creditore)446.
Come si è precedentemente visto447, lo schema
del contratto con prestazione (di garanzia) al
446 F. NAPPI, op. cit., p. 220; M. FRAGALI, Recenti indirizzi sulla natura
dell’assicurazione fideiussoria, in Banca borsa tit. cred., 1972, I, p. 514; per
applicazioni giurisprudenziali più recenti: Cass., 10 maggio 2002,
n. 6728, in Giust. civ. 2003, I, p. 165 ss; Cass., 18 maggio 2001, n.
6823, in Foro it. 2001, I, p. 3174 ss., con nota di R. PARDOLESI,
Polizza fideiussoria in cerca d’identità; assicurazione, fideiussione o contratto autonomo
di garanzia?447 In relazione al diverso caso, su citato, in cui il creditore
(promittente) ripromette al garante (stipulante) la concessione di
un mutuo o di altro beneficio al debitore (terzo); qui si tratta
del garante (promittente) che promette al debitore (stipulante) di
prestare una garanzia nei confronti del creditore (terzo).
480
terzo ricorre invece quando debitore e garante
intendono attribuire al creditore soltanto la
prestazione della garanzia e non il potere di
esigerla.
In queste due ipotesi (contratto a favore di
terzo, contratto con prestazione al terzo) la
causa che giustifica l’onere economico che il
garante sopporta con l’assunzione della
garanzia va ravvisata nell’assunzione
dell’obbligo di prestare la garanzia (obbligo
che a sua volta trae giustificazione dal
contratto oneroso attraverso il quale il
garante s’impegna).
Quanto al rapporto tra debitore e garante sulla
cui base il secondo presta la garanzia,
assolutamente maggioritaria è l’opinione
481
secondo cui si tratta di un mandato448; isolata,
ma significativa, è l’opinione secondo cui
questo rapporto tra garante e debitore mai
potrebbe nascere da un mandato o da una
gestione d’affari449. L’A. individua
l’impossibilità che il rapporto tra garante e
debitore nasca da una gestione d’affari nella
circostanza che <<la prestazione di garanzia
non può mai essere configurata come un affare
del debitore>>, in quanto costui <<non può
garantire se stesso e quindi anche se volesse
non potrebbe far propria l’obbligazione del
garante attraverso una ratifica>>. L’art. 2031
cod. civ. prevede infatti che “qualora la
448 G. B: PORTALE, Fideiussione e Garantieverträge nella prassi bancaria, in AA.
VV, Le operazioni bancarie, a cura di Portale, Milano, 1978, II, p.
1071; R. CICALA, op. cit., p. 197; G. BOZZI, Le garanzie atipiche, I,
Garanzie personali, Milano, 1999, p. 56; E. BRIGANTI, Garanzie personali
atipiche, in Banca borsa tit. cred., 1988, I, p. 591.449 F. ROCCHIO, op. cit., p. 72.
482
gestione sia stata utilmente iniziata,
l'interessato deve adempiere le obbligazioni
che il gestore ha assunte in nome di lui”: la
norma , applicata alla garanzia, imporrebbe
pertanto che il debitore adempia l’obbligazione
di garanzia, snaturando così la funzione della
stessa di apprestare un rimedio satisfattorio o
indennitario contro l’inadempimento del
debitore450.
Per quanto riguarda l’impossibilità di
configurare un contratto di mandato nel patto
attraverso il quale il garante s’impegna a
prestare una garanzia verso il terzo, l’A.
richiama la circostanza per cui nella
definizione legislativa del contratto di
mandato ricorre la nozione dell’obbligarsi
<<per conto>>, concetto che esprime il
450 F. ROCCHIO, op. loc. cit.
483
riverberarsi degli effetti degli atti compiuti
dal mandatario nel patrimonio del mandante (in
via diretta o indiretta), atti che il mandante
stesso avrebbe potuto giuridicamente compiere.
Tale circostanza, afferma l’A., non potrebbe
ricorrere nel caso di specie, perché
indubbiamente il debitore non può garantire se
stesso attraverso una garanzia personale, senza
snaturare la funzione della garanzia che è
quella di aumentare le possibilità del
creditore di essere soddisfatto.
Esclusa la possibilità di configurare un
rapporto di mandato, l’A individua
nell’apertura di credito di firma il contratto
socialmente tipico attraverso il quale il
garante (banca) s’impegna ad un facere nei
confronti del cliente, consistente
484
nell’assumere o nel garantire un’obbligazione
del debitore/cliente451. In virtù di tale
contratto la banca si trova in una posizione di
soggezione nei confronti del cliente, che ha il
diritto potestativo di far sorgere
l’obbligazione della banca, individuandone il
creditore452. Ciò che allora viene comunemente
indicato come contratto di mandato, nell’ottica
dell’A. altro non sarebbe che l’esercizio del
diritto potestativo del cliente d’individuare
il soggetto cui la banca, sulla base del
credito di firma, deve prestare la garanzia,
trasformando la posizione di soggezione della
451 F. MESSINEO, Operazioni di borsa e di banca, Milano, 1954, p. 35; G.
FAUCEGLIA, I contratti bancari, in Trattato di diritto commerciale, diretto da
V. Buonocore, III – 2, Torino, 2005, p. 340; Cass., 17 aprile
1993, n. 4552, in Giust. civ., 193, I, p. 2686 ss.452 Qualificano come diritto potestativo la posizione soggettiva
che nasce in capo al cliente, tra gli altri F. GIORGIANNI, I crediti
disponibili, Milano, 1974, p. 259; R. TETI, Dell’apertura di credito bancario,
in Il codice civile. Commentario / fondato e già diretto da P.
Schlesinger / continuato da F. D. Busnelli, Milano, 2005, p. 29.
485
banca nella vera e propria obbligazione di
prestare la garanzia al creditore453.
Altra ipotesi tipica di pactum de contrahendo cum
tertio è la c.d. polizza fideiussoria, contratto
a favore di terzo, che si differenzia dal
contratto di apertura di credito di firma (che
ricade nello schema del contratto con
prestazione al terzo) per la circostanza che
mentre nel caso della polizza fideiussoria il
creditore ha diritto di esigere la prestazione,
nella prima ipotesi i contraenti stabiliscono
453 F. ROCCHIO, op. cit., p.92: l’A. spiega la circostanza per cui in
dottrina generalmente si configura il rapporto tra debitore e
garante come contratto di mandato o anche come gestione d’affari,
con il peso esercitato dalla tradizione romanistica: i Romani
infatti disciplinavano il regresso del garante ricorrendo agli
schemi del mandato e dell’actio negotiorum gestorum. L’omaggio alla
tradizione afferma l’A non può certamente giustificarsi nel
sistema attuale, dove il mandato è caratterizzato dall’agire per
conto, circostanza che non può verificarsi per la prestazione
della garanzia. Per un’interessante ricostruzione romanistica del
diritto di regresso del garante v. F. ROCCHIO op. cit., p. 47 e p.
74.
486
una prestazione al creditore/terzo, senza
conferirgli il diritto alla stessa.
In sostanza quando il garante assume un obbligo
di prestare una garanzia verso il debitore,
seguendo tale ricostruzione, avremo un pactum de
contrahendo cum tertio, nello schema del contratto
a favore di terzo (la cui ipotesi socialmente
tipica è la polizza fideiussoria)454, oppure454In dottrina v’è chi ha sostenuto l’impossibilità di configurare
nei termini di un contratto a favore di terzo l’accordo con cui il
debitore si accorda con il garante affinché costui presti una
garanzia. Viene richiamata a tal fine la norma contenuta nell’art.
1411 comma 3 cod. civ., secondo cui “in caso di revoca della
stipulazione, o di rifiuto del terzo di profittarne, la
prestazione rimane a beneficio dello stipulante”. Si è allora
detto che mai potrebbe la prestazione di garanzia rimanere a
beneficio del debitore; sarebbe assurdo che il debitore ottenga
per sé la garanzia della propria obbligazione. In tal senso, P.
CORRIAS, op. cit., p. 487 ss. Tale tesi, seppure corretta
nell’escludere che la prestazione della garanzia possa essere
rivolta a beneficio dello stipulante/debitore, non tiene in
considerazione l’eccezione contemplata nello stesso art. 1411
comma 3 cod. civ. Il legislatore, con la locuzione <<salvo che
diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del
contratto>>, prevede infatti l’ipotesi in cui, per volontà delle
parti, o per la natura del contratto, la prestazione a favore del
487
nello schema del contratto con (sola)
prestazione al terzo, (la cui ipotesi tipica è
rappresentata dall’apertura del credito di
firma).
C) Una causa sufficiente a giustificare
l’attribuzione patrimoniale del garante può
essere rappresentata dall’interesse che ha il
garante nel prestare la garanzia, in relazione
ad un vantaggio più o meno diretto. Il
vantaggio economico diretto o indiretto vale a
fornire un supporto causale all’onere economico
che grava sul garante455. L’originaria
configurazione del Garantieverträge faceva
riferimento a tale tipo di supporto causale del
contratto, riconducibile in sostanza ad una
causa di scambio tra la prestazione della
terzo (nel caso di specie la prestazione della garanzia) non
rimane a beneficio dello stipulante.455 G. CASTIGLIA, op. cit., p. 362 ss.
488
garanzia e il vantaggio diretto o indiretto che
il garante ne riceve.
D) Deve infine considerarsi, a fini più
teorico-sistematici che pratici, l’ipotesi in
cui la problematica della giustificazione
causale della garanzia “autonoma” riguardi una
garanzia assunta nella forma della donazione456.
In tal caso non si porrebbe un problema di
giustificazione causale del contratto di
garanzia, costituendo la donazione, fatta per
456 Prospetta la possibilità d’individuare il fondamento causale
della garanzia autonoma in un animus donandi del promittente: F.
NAPPI, op. cit., p. 199; riguardo alla problematica che concerne la
possibilità di configurare la promessa del fatto del terzo (ma
anche la garanzia autonoma) come donazione aleatoria Cfr. E.
BRIGANTI, op. cit., p. 114 ss, il quale sottolinea che per fondare
la causa della promessa su di un animus donandi del promittente
sarebbe in ogni caso necessaria la forma dell’atto pubblico, ed
esclude che in tal caso possa parlarsi di donazione aleatoria,
dato che il sacrificio che il promittente subisce con la stipula
della promessa non va individuato nel pagamento solo eventuale
dell’indennizzo, ma nella sopportazione del rischio del mancato
compimento del fatto, che il promittente sopporta sin dal momento
della stipula della promessa.
489
atto pubblico e alla presenza di due testimoni
(ex art. 182 cod. civ. e art. 48 l. 16 febbraio
1913, n. 89), causa sufficiente
dell’obbligazione del garante.
12. La Cassazione a Sezioni Unite si pronuncia sulle
differenze sul piano morfologico funzionale ed
interpretativo tra la fideiussione ed il contratto autonomo
di garanzia, in particolare affrontando la problematica
della qualificazione giuridica delle polizze fideiussorie. Una
sentenza storica. Sintesi della controversia portata a
conoscenza della S.C.
Negli ultimi dieci anni, data l’enorme
affermazione nella prassi nazionale ed
internazionale delle garanzie c.d. autonome, la
giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi
diffusamente sul tema. Tra le molteplici
sentenze che è possibile rinvenire nei
490
repertori di giurisprudenza dell’ultima decade,
è da segnalare la recentissima sentenza delle
Sezioni Unite della Cassazione457, che
costituirà certamente un punto di riferimento
necessario per gli operatori del diritto, data
l’autorevolezza dell’organo che l’ha
pronunciata. Risulta fondamentale, pertanto,
l’analisi della sentenza.
Le Sezioni Unite sono intervenute relativamente
ad una controversia riguardante la
qualificazione di una convenzione di garanzia
in termini di fideiussione strictu sensu,
piuttosto che di contratto autonomo di
garanzia. L’intervento delle Sezioni Unite,
come si legge nell’ordinanza interlocutoria di
rimessione degli atti al Primo Presidente per
457 Cass., Sez. Unite, 18 febbraio 2010, n. 3947, in allegato al
presente lavoro.
491
l’eventuale rimessione alle S. U., era stato
richiesto ai fini di un’actio finium regundorum tra
le due fattispecie, finalizzata da un lato a
“chiarire i tratti differenziali, sul piano
morfologico, funzionale e interpretativo”;
dall’altro a “risolvere il contrasto circa la
natura delle polizze assicurative
fideiussorie”.
La controversia portata a conoscenza della S.
C. riguarda una domanda di pagamento di una
somma di denaro oggetto di polizza
fideiussoria, costituita da un appaltatore a
favore di un committente presso una compagnia
di assicurazioni. Il committente affermava di
avere diritto al pagamento della somma da parte
della compagnia assicurativa, perché in
conseguenza dell’inadempimento dell’appaltatore
492
( ai sensi dell’art. 10 sesto comma del D.P.R.
1063/1962) aveva dichiarato unilateralmente
risolto il contratto di appalto. A sua volta la
compagnia di assicurazioni resisteva alla
domanda affermando che il diritto di escutere
la garanzia si fosse estinto per decorso del
termine, ex art. 1957 cod. civ. Il problema era
dunque rappresentato dall’applicabilità al caso
di specie di una norma dettata nell’ambito
della disciplina della fideiussione, questione
che presupponeva la qualificazione della
polizza de quo come contratto tipico
fideiussorio, o quanto meno la possibilità di
applicare analogicamente la relativa
disciplina.
È da premettere che il giudice di primo grado
investito della controversia aveva rigettato la
493
domanda, perché qualificando la garanzia come
fideiussione e non come contratto autonomo di
garanzia, così come postulato dall’attore,
aveva ritenuto estinto il diritto di escutere
la garanzia, ai sensi dell’art. 1957 cod. civ.,
non avendo il creditore rispettato i termini,
ivi previsti, nel proporre domanda contro il
debitore. La sentenza del Tribunale era stata
confermata dalla Corte d’appello adita, per
avere la stessa escluso la configurabilità nel
caso di specie di un contratto autonomo di
garanzia. Le Sezioni Unite della Corte,
viceversa, hanno ritenuto fondato il ricorso,
interpretando la convenzione negoziale
intercorsa tra la compagnia assicurativa ed il
soggetto beneficiario nei termini di “contratto
autonomo di garanzia”. Tale qualificazione
giuridica si è fondata su un triplice ordine di
494
ragioni: a) sulla base della pattuizione che il
garante pagasse entro un breve termine dalla
richiesta scritta; b) sulla base dell’impegno
assunto dalla ditta debitrice di rimborsare al
garante tutte le somme pagate, con rinuncia a
sollevare qualsiasi eccezione; c) alla luce del
richiamo alla normativa pubblicistica che
considerava la polizza fideiussoria sostitutiva
di una cauzione458. Pertanto le S. U. hanno
dichiarato inapplicabile alla fattispecie la
decadenza di cui all’art. 1957 cod. civ.,
dovendosi ritenere che la semplice richiesta
scritta del creditore fosse sufficiente a
manifestare la volontà del creditore di
avvalersi della garanzia.
458 Art. 10, sesto comma, del DPR 1063/1062, applicabile alla
vicenda processuale ratione temporis.
495
13. Segue: la Corte di Cassazione sembra inquadrare in
maniera unitaria le diverse ipotesi di “garanzia autonoma”.
Con tale ponderosa sentenza la S. C. analizza
la tematica del rapporti tra il negozio tipico
fideiussorio e il contratto autonomo di
garanzia (Garantieverträge), in relazione a quelli
che sono stati i contributi di dottrina e
giurisprudenza sul tema. In particolare la
sentenza analizza la questione concernente la
qualificazione delle c.d. polizze fideiussorie
e conseguentemente il problema della disciplina
applicabile a detta fattispecie negoziale.
In via di premessa, sembrerebbe a chi scrive
che la S. C. si riferisca al contratto autonomo
di garanzia in termini di categoria unitaria.
L’asserzione secondo cui “sulla polizza fideiussoria si
riverbera l’eco del dibattito sul contratto autonomo di
496
garanzia”, e ancora il rilievo che “l’inserimento nel
contratto di clausole a pagamento a prima richiesta comporta
un’alterazione del tipo fideiussorio, tale da provocarne un
exodus verso la categoria del Garantieverträge”,
evidenziano che la S.C. riconduce il contratto
de quo nell’alveo della citata categoria
contrattuale (omogeneamente considerata) ed
inquadra unitariamente le fattispecie in cui
“l’autonomia” si riferisce peculiarmente alle
c.d. clausole di <<pagamento a prima
richiesta>>, <<senza eccezioni>> etc., e quelle
fattispecie di garanzia in cui l’autonomia
comporta l’assunzione di rischi atipici
(rischio dell’invalidità, dell’impossibilità
sopravvenuta, dell’eccessiva onerosità
sopravvenuta). Si aggiungano a conferma di tale
risultato interpretativo le considerazioni che
la S.C. compie circa la causa “concreta” del
497
contratto autonomo di garanzia: il riferimento
ad una causa del contratto autonomo di garanzia
ha infatti la finalità d’individuare il profilo
funzionale del negozio (socialmente) tipico, la
sintesi degl’interessi reali che il contratto
“tipo” realizza, pur con la precisazione che la
causa del contratto andrà sempre verificata in
concreto459.
Giuste le considerazioni fatte, occorre
osservare che questa ricostruzione della
categoria “garanzia autonoma” rappresenta un
approdo diametralmente opposto alle conclusioni
della migliore dottrina460, che consiglia di
esaminare la tematica delle garanzie autonome
459 La nozione di causa concreta, accolta nella giurisprudenza
della Corte, intende condurre al risultato di una verifica in
concreto del profilo causale, talché anche un contratto tipico può
nel caso di specie non essere sorretto da un supporto causale.
Cfr. infra, nota 125.460 Cfr . in particolare F. NAPPI, op. cit., p. 100 ss.
498
disarticolando le diverse fattispecie
contrattuali, in particolare distinguendo,
quanto ad inquadramento sistematico e a
disciplina integrativa applicabile, quelle
ipotesi in cui l’autonomia dell’obbligazione di
garanzia significa <<assunzione di rischi
atipici>> e quelle ipotesi in cui l’autonomia
significa <<pagamento a prima richiesta e senza
eccezioni>>461.
461 Cfr. tra gli altri, F. NAPPI, op. cit., p. 112 ss., L. RUGGERI –
S. MONTICELLI, op. cit., p. 235.; chiaramente nel senso di
distinguere le ipotesi in cui con il contratto di garanzia
s’intende solo evitare il ritardo nel pagamento della garanzia,
dalle diverse fattispecie in cui si miri alla copertura del
rischio atipico, R. CICALA, Saggi, cit., p. 195-196.
499
14. Segue: gli aspetti peculiari del contratto autonomo di
garanzia, sotto il profilo morfologico e funzionale, nella
ricostruzione operata dalla sentenza in esame. Limiti
all’autonomia del contratto autonomo di garanzia e
proponibilità di talune eccezioni fondate sul rapporto base.
La S. C. con la sentenza menzionata ha
evidenziato gli aspetti peculiari del contratto
autonomo di garanzia, sotto il profilo
morfologico e funzionale, giungendo a talune
conclusioni ad oggi tutt’altro che pacifiche.
Sotto l’aspetto morfologico si evidenzia che
nel contratto autonomo di garanzia
l’obbligazione del garante non è accessoria
rispetto all’obbligazione principale. Il garante
infatti s’impegna a pagare illico et immediate, senza opporre
eccezioni in ordine alla validità e/o efficacia del rapporto base,
e identico impegno assume (l’eventuale)
500
controgarante nei confronti del garante, in
deroga agli art. 1936, 1941, 1945 cod. civ.
Nell’analisi della S. C. si evidenzia però,
sulla scia di recenti sentenze della stessa
giurisprudenza di legittimità462, che la
462 Fra le altre, Cass. 24 aprile 2008, n. 10652, in Giust. civ. Mass.
2008, 4, 627; Id. in De iure, banca dati on line, Giuffrè; tale
sentenza giustifica l’opponibilità delle eccezioni d’inesistenza
del rapporto principale, di nullità del contratto principale
illecito e di escussione abusiva o fraudolenta, sulla base di una
triplice esigenza: a) la natura di garanzia del contratto comporta
che l’inopponibilità delle eccezioni riguardanti il rapporto base
deve trovare un limite nell’inesistenza del rapporto base
(trattandosi di un rapporto di garanzia l’autonomia non potrebbe
essere intesa al punto di garantire un rapporto che non è mai
sorto o che non esiste più. Pertanto il rapporto autonomo di
garanzia sarebbe valido ed efficace indipendentemente dalla
validità ed efficacia del rapporto di base, ma non si potrebbe
sostenere detta validità ed efficacia indipendentemente
dall'esistenza di quest'ultimo.); b) è necessario applicare il
fondamentale principio di buona fede, per cui non può essere
protetto l’interesse del garantito ad escutere senz’altro la
garanzia autonoma in caso di escussione abusiva, da cui il
diritto-dovere del garante di sottrarsi al pagamento (se il
garante, avendo la prova liquida ed incontestabile dell’escussione
abusiva, paga ugualmente, perde il diritto di regresso); c) si
pone la necessità di non permettere che si garantiscano risultati
vietati dall’ordinamento.
501
protezione dell’interesse del beneficiario
della garanzia ad essere manlevato dalle
conseguenze dell’inadempimento (seppure
incolpevole) del debitore non è assoluta, così
come non assoluto è il distacco
dell’obbligazione di garanzia rispetto alle
vicende dell’obbligazione principale. Le
Sezioni Unite, infatti, evidenziano una serie
di limiti alla rinuncia del garante a sollevare
eccezioni relative al rapporto base:
a) il garante può far valere l’inesistenza del
rapporto garantito, perché <<trattandosi pur
sempre di un contratto (di garanzia) la sua
essenziale -quindi inderogabile- funzione è
quella di garantire un determinato
adempimento>>;
502
b) il garante può far valere la nullità del
contratto-base per contrarietà a norme
imperative o per illiceità della causa perché
<<attraverso il contratto di garanzia si tende
ad assicurare il risultato che l’ordinamento
vieta>>;463
c) il garante può opporre l’exceptio doli generalis in
caso di escussione fraudolenta o abusiva della
garanzia, quando per adempimento o per altra
causa il debito garantito si sia estinto, con
la precisazione che per sottrarsi al pagamento
il garante deve fornire la prova liquida ed
incontestabile del fatto che qualifica
l’escussione come abusiva o fraudolenta;
l’esecuzione di pagamenti arbitrariamente
intimati comporterebbe, del resto, la perdita
463 Di recente in tal senso Cass., 3 marzo, 2009, n. 5044, in Giust.
civ. Mass. 2009, 3, 367.
503
del diritto di regresso nei confronti del
debitore principale. In tal senso s’individua
pertanto un diritto-dovere del garante di
opporsi all’escussione abusiva.
d) sono opponibili infine, come per il caso di
garanzie accessorie, le eccezioni derivanti dal
contratto di garanzia medesimo, che possono
sinteticamente raggrupparsi in tre categorie:
a) eccezioni letterali; b) eccezioni attinenti
alla invalidità o inefficacia del contratto di
garanzia; c) eccezioni dirette e personali
(questione discussa). Le eccezioni letterali
sono quelle che si fondano sul testo della
garanzia, per il caso che, essendo previsto che
l’escussione della garanzia avvenga sulla base
di determinati requisiti formali, essi non
sussistono al momento della richiesta di
504
pagamento al garante (esempio: il garante
escute la garanzia senza produrre una certa
documentazione indicata nel testo del contratto
come requisito di legittimazione necessario464).
Le eccezioni attinenti all’invalidità o
inefficacia del contratto autonomo di garanzia
sono certamente più rare, poiché lo strumento
contrattuale è utilizzato quasi esclusivamente
da operatori professionali (banche, compagnie
di assicurazioni) che si avvalgono di modelli
standard collaudati. Tuttavia in astratto è
possibile ipotizzare tale eventualità, ad
esempio nell’ipotesi in cui il contratto in
questione sia stipulato da una persona fisica
464 Trib. Milano, 30 dicembre 1991, in Banca borsa tit. cred., 1992, II,
p. 692 ss., ha accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta
dal garante, poiché la richiesta di pagamento oggetto
d’ingiunzione non poteva essere accolta, in quanto il beneficiario
non aveva fornito la documentazione attestante che l’invio della
merce fosse avvenuto nei termini stabiliti.
505
in veste di garante465. Infine le eccezioni
dirette e personali sono quelle fondate sul
rapporto garante-beneficiario (ad esempio
l’eccezione di compensazione del credito del
beneficiario della garanzia con un
controcredito vantato dal garante nei suoi
confronti466); l’assunto della legittimità di
tali eccezioni ricalca l’opinione diffusa in
465 L. RUGGERI – S. MONTICELLI, op. cit., p. 251 ss, l’A. prospetta
un’ipotesi di nullità-inefficacia del contratto di garanzia ove
mai il garante sia una persona fisica, che si ascriva alla
categoria dei consumatori, e possa pertanto applicarsi la
normativa di cui agli art. 1469 bis e ss. A seguito
dell’abrogazione dell’inciso contenuto nel testo originario
dell’art. 1469 bis comma 1, che si riferiva al contratto <<che ha
per oggetto la cessione di beni o la prestazioni di servizi>>, non
sussisterebbero più limitazioni all’applicabilità della disciplina
ai contratti di garanzia conclusi tra il consumatore ed il
professionista. Si richiama a mo di esempio il caso in cui il
socio concluda il contratto autonomo di garanzia con una banca, a
garanzia degli obblighi che la società ha assunto verso la
stessa.. 466 Cass. 10 maggio 2002, n. 6728, in Giust. civ., 2003, I, 1615,
richiamata dalla sentenza che si sta esaminando.
506
dottrina467 secondo cui l’opponibilità di tali
eccezioni non sarebbe preclusa dall’inserimento
nel contratto della clausola <<senza
eccezioni>>, che sarebbe riferita solamente
all’inopponibilità delle eccezioni fondate sul
rapporto-base.
Come anticipato, la prescrizione della
legittimità del triplice ordine di eccezioni
fondate sul rapporto base non è nuova nella
giurisprudenza della S.C. In precedenti
sentenze essa aveva ritenuto, tra l’altro, che
l’opponibilità dell’exceptio doli generalis
all’escussione fraudolenta o abusiva della
garanzia valesse a salvaguardare la necessità
467 Per tutti F. BONELLI, Le garanzie bancarie a prima domanda nel commercio
internazionale, Milano, 1991, p. 88. In senso contrario però G. B.
PORTALE, Le garanzie bancarie internazionali, (questioni), cit., p. 17, nota 23,
secondo cui la rinuncia ad opporre eccezioni comprenderebbe anche
quelle relative al rapporto stesso di garanzia.
507
della tutela del fondamentale principio di
buona fede nell’esecuzione del contratto468.
Sembra necessario soffermarsi su tale questione
delle eccezioni relative al rapporto – base,
perché esse escludono l’assoluta autonomia del
contratto oggetto di studio; la compatibilità
logica, prima che giuridica, di eccezioni
relative al rapporto base con il concetto
stesso di garanzia autonoma, è una delle
questioni più spinose e dibattute sul tema. La
problematica pone in primo piano la necessità
di una tutela del garante e del debitore contro
escussioni indebite, ma dal punto di vista
tecnico – giuridico pone all’interprete il
difficile compito di comprendere come sia
possibile affermare da un lato l’autonomia
dell’obbligazione di garanzia da quella
468 In tal senso Cass., 24 aprile 2008, n. 10652, cit.
508
principale, e dall’altro predicare
l’opponibilità di talune eccezioni fondate sul
rapporto principale. A ben vedere sul tema
delle eccezioni opponibili al rapporto base
sembra riverberarsi l’idea che la causa del
contratto di garanzia autonomo, ammesso che
possa continuarsi a parlare in questi termini
del coacervo di fattispecie negoziali che si
usa riportare alla categoria, consista nel
garantire un interesse latu sensu creditorio.
15. Segue: profili valutativi dell’incidenza sul contratto
autonomo di garanzia della nullità del contratto illecito.
Sia consentito ricordare, preliminarmente, che
la tematica del riverbero della illiceità del
negozio principale sul negozio di garanzia è
questione che si è posta negli stessi termini
anche per la promessa del fatto del terzo.
509
Affermava un autorevole Autore:<<l’illiceità
del fatto del terzo permette di considerare
illecito anche l’interesse che sarebbe
soddisfatto dalla prestazione del terzo>>, da
cui l’<<illiceità si riversa sulla
garanzia>>469.
In primis, è evidente che l’idea secondo cui
l’illiceità del negozio si comunica al
contratto di garanzia autonomo implica <<il
ravvisare la causa del contratto de quo nella
funzione di garantire il rapporto di valuta
come tale>>.470 Il riverbero dell’illiceità del
negozio – base sulla garanzia autonoma
ripeterebbe in sostanza il meccanismo
contemplato dalla disciplina della fideiussione
ex art. 1939 cod. civ. A ben vedere però469 SCALFI, op. cit., p. 113.470 In tal senso, di recente, L. RUGGERI – S. MONTICELLI, op. cit.,
p. 226.
510
l’autonomia del contratto di garanzia è
incompatibile con la funzione di garantire il
rapporto di valuta, giusta quell’opinione
dottrinale secondo cui <<nel Garantieverträge non
può identificarsi una causalità fondata sul
rapporto di valuta>> perché <<se l’altrui
debito dovesse giustificare l’obbligazione del
garante (…) questa non dovrebbe neppure nascere
quando esso non esista>>471, oppure, si potrebbe
aggiungere, quando sia nullo il negozio da cui
nasce. In altri termini questa funzione di
garanzia del rapporto di valuta in quanto tale
sarebbe senz’altro idonea a descrivere le
garanzie personali accessorie. Del resto,
quella tesi dottrinale in cui si perviene al
risultato che <<per rendere causale questo
contratto (il Garantieverträge) basta la
471 R. CICALA, Saggi, cit., p. 203.
511
dichiarazione in esso dello scopo di garanzia e
che sia fatto comunque dalle parti riferimento
ad un rapporto fondamentale, che valga a
giustificare l’obbligazione del garante>>472,
intendendo il richiamo all’obbligo – base come
un fatto dovuto, a prescindere dal valore
giuridico e quindi dall’esistenza di un
diritto, è ben consapevole dell’incongruenza
dell’applicazione del meccanismo della causa
cavendi alla garanzia autonoma.
Queste considerazioni conducono alla
conclusione che se con la garanzia si intendono
coprire i rischi atipici, ossia il rischio di
vizi genetici o funzionali del contratto-base,
le patologie di quest’ultimo (compresa
l’illiceità del contratto) non dovrebbero
interferire sull’operatività della garanzia;
472 G. B: PORTALE, Fideiussione e Garantieverträge, cit., p. 1064.
512
l’alternativa sarebbe quella di ritenere che
essendo comunque la funzione del contratto de
quo quella di garantire il rapporto di valuta,
le eccezioni d’invalidità del rapporto base
sono opponibili (tutte). Si è certamente
consapevoli che seguendo la prima alternativa
proposta si perviene alla conclusione della
legittimità dell’escussione di una garanzia
prestata per “assicurare” un risultato
illecito; quello che si vuole però qui
sottolineare è che il significato pieno
dell’autonomia della garanzia dovrebbe condurre
a questa conclusione.
S’impone al riguardo una precisazione.
L’affermazione secondo cui il garante può
opporre l’illiceità del contratto base sembra
rinviare alla circostanza che il garante sia
513
ignaro della natura dell’obbligazione
garantita, rilevando pertanto l’errore
essenziale e riconoscibile che compie nel
concludere il contratto di garanzia, o al più i
raggiri usati dall’incaricante nel nascondergli
la portata illecita dell’operazione garantita.
Ragionando su tal ipotesi, si prospetta la
possibilità applicativa degli art. 1427 ss.
cod. civ. e potrebbe allora sostenersi che il
garante ignaro della natura dell’obbligazione
garantita subisce una menomazione della libertà
e spontaneità del volere, per cui s’impegna ad
una prestazione di garanzia che tutela un
interesse illecito del beneficiario. La ragione
d’invalidità del contratto di garanzia sarebbe
pertanto determinata da un vizio del consenso e
non da ragioni attinenti all’invalidità del
rapporto garantito. In quest’ottica la
514
proponibilità dell’eccezione di nullità del
contratto base per illiceità dello stesso
(contratto con causa o oggetto illecito, o
concluso per un motivo illecito comune ad
entrambi) sarebbe giustificata dalla
circostanza che si tratta di un’eccezione
fondata sul contratto di garanzia medesimo473.
La Cassazione ritiene che il garante possa
opporsi all’escussione della garanzia sulla
base dell’illiceità del contratto base. Si è
osservato474 che il legislatore non detta una
disciplina differenziata per le diverse ragioni
di nullità, circostanza che fa pensare che in473 Cfr. F. NAPPI, op. cit., p. 178 ss., che analizza l’ipotesi in
cui il negozio principale sia invalido perché viziato da errore,
violenza, o dolo. L’A. perviene alla conclusione che l’invalidità
del negozio principale non è ragion sufficiente per predicare
l’invalidità del negozio di garanzia, salvo che le circostanze che
determinano l’invalidità del negozio garantito non abbiano una
ripercussione diretta sullo stesso negozio di garanzia, limitando
la libertà del volere o l’autodeterminazione del garante.474 In tal senso, L. RUGGERI – S. MONTICELLI, op. cit., p. 226.
515
tutte le ipotesi di nullità sia insito un
similare giudizio di disvalore da parte
dell’ordinamento Perché allora il garante può
opporsi all’escussione della garanzia se il
negozio garantito è illecito e non anche quando
ricorra un’altra ipotesi di nullità? D’altro
canto nella prassi ci sono contratti di
garanzia stipulati per assicurare un
determinato risultato al beneficiario, anche in
ipotesi di nullità del rapporto base. Ad
esempio la garanzia per il rischio di misure
valutarie restrittive. Evidentemente il
funzionamento di garanzie di tal fatta può
spiegarsi solo astraendo totalmente la validità
del contratto di garanzia da quella del
contratto base, con la precisazione che il
requisito della causalità del contratto sarà
comunque rispettata se si guarda all’elemento
516
della causa dell’assunzione dell’obbligo da
parte del garante. L’autonomia del contratto di
assunzione di rischi atipici (ad esempio di
nullità del contratto base) richiama un
distacco radicale dal rapporto base; se così va
impostata la questione, perché la validità
della garanzia dovrebbe essere messa in
discussione dall’illiceità del contratto
principale, ma non dalle altre ipotesi di
nullità dello stesso?
16. Segue: La causa del contratto autonomo di garanzia
nella ricostruzione delle Sez. Unite.
517
La causa concreta475 del contratto autonomo di
garanzia viene individuata dalla S. C.
nell’assunzione, da parte del garante, del
rischio dell’inadempimento, rischio che
475 Sulla nozione di causa concreta del contratto la S.C. ha avuto
modo di esprimersi in una recente sentenza, Cass. 8 maggio 2006,
n. 10490, in Giust. civ. 2007, 9, 1985, in cui si afferma che, pur
rimandando la nozione di causa del contratto alla funzione
economico-sociale del negozio (tanto è possibile desumere dalla
relazione del ministro guardasigilli), è necessario procedere ad
un’ermeneutica del concetto di causa che <<sul presupposto della
obsolescenza della matrice ideologica che configura la causa del
contratto come strumento di controllo della sua utilità sociale>>,
costituisca un superamento della teoria della predeterminazione
causale del negozio, che del resto non spiega perché un contratto
tipico possa avere una causa illecita, e conduca ad una
ricostruzione di tale elemento <<in termini di sintesi
degl’interessi reali che il contratto stesso è diretto a
realizzare (al di là del modello, anche tipico, adoperato).
Sintesi (e dunque ragione concreta) della dinamica contrattuale,
si badi, e non anche della volontà delle parti>>. Il concetto di
causa secondo tale accezione rimanderebbe pur sempre alla funzione
dell’atto, ma alla <<funzione individuale del singolo, specifico
contratto posto in essere, a prescindere dal relativo stereotipo
astratto, seguendo un iter evolutivo del concetto di funzione
economico-sociale del negozio che, muovendo dalla
cristallizzazione normativa dei vari tipi contrattuali, si volga a
cogliere l'uso che di ciascuno di essi hanno inteso compiere i
contraenti adottando quella determinata, specifica (a suo modo
518
normalmente sarebbe sopportato dal creditore.
Il altri termini il contratto esplicherebbe la
funzione di trasferimento del rischio economico della mancata
esecuzione di una prestazione contrattuale, a prescindere
che tale fatto avvenga per inadempimento
colpevole, oppure no.
Questa peculiarità del profilo causale del
contratto comporta, sul piano effettuale, che
il contratto autonomo di garanzia abbia una
funzione indennitaria: a differenza del
fideiussore che si obbliga a compiere la stessa
prestazione cui è tenuto il debitore
principale, il garante autonomo si obbliga a
unica) convenzione negoziale>>. Nella citata sentenza la S.C.
aveva ritenuto nullo, per difetto della causa, un contratto di
consulenza stipulato da una società con un amministratore della
stessa, in quanto essendo l’amministratore già tenuto, in quanto
tale, a prestare l’attività di consulenza, .il contratto in
questione non avrebbe potuto realizzare lo scambio del pagamento
verso la prestazione del consulente.
519
tenere indenne il creditore dalle conseguenze
del mancato adempimento, e pertanto, si dice,
la garanzia autonoma si inquadra nelle garanzie
successive di tipo indennitario.
È importante sottolineare che le S. U., tra
l’altro, in un passaggio della sentenza
affermano che l’individuazione nel contratto autonomo di
garanzia di una causa di protezione dell’interesse del
beneficiario a non subire le conseguenze nefaste
dell’inadempimento, consente di superare l’ossimoro celato
dietro il concetto di garanzia autonoma. Da un punto di
vista logico prima che giuridico, giustamente
la S.C. rileva che il concetto di garanzia
rimanda ad un quid che debba essere garantito,
ed è palese che questa entità garantita non
possa essere l’obbligazione principale, perché
questo comporterebbe l’identificazione della
520
garanzia tipicamente accessoria a quella qui
analizzata. Ciò che si garantisce con la
garanzia autonoma, secondo la ricostruzione
della S. C. è l’interesse del beneficiario a
non essere leso dall’inadempimento, seppure
incolpevole, del debitore. La Cassazione
richiama non troppo velatamente quella tesi che
individua nella causa-funzione di garanzia dei
contratti (tipici e atipici) la finalità di
protezione di un interesse del garantito,
seppure spoglio dell’habitus giuridico, così da
fornire una spiegazione all’operatività della
garanzia nei casi in cui i vizi del rapporto
principale non permettano d’individuare
l’esistenza di un valido credito che debba
essere soddisfatto476. Si sono però già viste476 A. MAZZONI, Lettere di patronage, mandato di credito, promessa del fatto del
terzo, cit., p. 361, P. DE SANNA, Accessorietà e autonomia, cit., p. 41.
Per i termini del dibattito attorno a tale concetto di causa –
funzione di garanzia vedi retro par. 9, e par. 14 del capitolo II.
521
nel secondo capitolo, cui si rinvia per ragioni
di brevità, le critiche suscitate da tale tesi.
17. Segue: le Sezioni Unite qualificano le polizze fideiussorie
stipulate a garanzia delle obbligazioni di un appaltatore
come garanzia atipica e non fideiussoria, e pervengono ad
un importante cambiamento di rotta sulla rilevanza delle
<<clausole a prima richiesta>> e <<senza eccezioni>>,
inserite nel testo del contratto, ai fini della sua
qualificazione come contratto autonomo di garanzia.
Per quanto concerne le polizze fideiussorie la
S.C. ne conferma la natura di contratto a
favore di terzo e pertanto parti del contratto
saranno il debitore (stipulante) ed il garante
promittente, assumendo il creditore la qualità
di terzo beneficiario del contratto. Tale
morfologia segnerebbe una prima differenza
522
rispetto alla fideiussione, che intercorre,
invece, ai sensi dell’art. 1936 cod. civ., tra
il creditore e il garante. Inoltre tali polizze
fideiussorie sono necessariamente onerose, in
quanto la garanzia è prestata in cambio del
pagamento di un premio, laddove la fideiussione
può essere anche gratuita477.
Quanto alla problematica della qualificazione
giuridica delle polizze fideiussorie, che si
riverbera sull’individuazione della disciplina
applicabile, la S. C. ha nel tempo fornito
risposte diverse.
Secondo un primo orientamento, poiché la causa
del contratto de quo consisterebbe nel garantire
l’adempimento dell’obbligazione principale, il
negozio avrebbe natura fideiussoria, con477 Il meccanismo del regresso assicura infatti la circolarità
delle attribuzioni, per cui il peso definitivo del debito non
resta a carico del garante, v. retro par. 10 del presente capitolo.
523
conseguente applicabilità della disciplina
della fideiussione, ove non esplicitamente
derogata dalle parti (in particolare con la
conseguenza dell’applicabilità dell’art. 1941
cod. civ., che sancisce la regola secondo cui
il fideiussore non può essere obbligato in
duriorem causam).
Secondo un altro filone interpretativo, quando
la polizza fideiussoria è prestata a garanzia
dell’adempimento dell’obbligazione di un
appaltatore non ha i caratteri morfologici
tipici della fideiussione, ma diventa garanzia
atipica (fideiussio indemnitatis), non essendo il
garante obbligato in solido con il debitore
principale ad eseguire la medesima obbligazione
cui costui è tenuto. Il creditore per tal caso
può ottenere dal garante il pagamento di un
524
indennizzo o un risarcimento, ossia una
prestazione diversa rispetto a quella cui aveva
diritto sulla base del rapporto principale478.
Questo indirizzo ha fondamento sulla
considerazione per cui nelle polizze
fideiussorie non si riscontra l’elemento
“essenziale e normale” del vincolo
fideiussorio, l’essere il fideiussore tenuto ad
una prestazione identica a quella cui è tenuto
il debitore principale. In tal caso quindi, non
potendo la garanzia assicurare l’adempimento
specifico dell’obbligazione principale, avrà la
funzione di soddisfare l’interesse economico
del beneficiario vulnerato dall’inadempimento,
funzione indennitaria quindi e non
satisfattoria. La funzione tipica della
478 Cass., 27 maggio 2002, n. 7712, in Danno e resp., 2002, p. 946.;
Cass.,31 gennaio 2008, n. 2377, in De iure, banca dati on line,
Giuffrè.
525
fideiussione è infatti quella di garantire
l’adempimento dell’obbligazione principale,
mentre quella delle polizze è di offrire al
creditore un soggetto solvibile, che lo tenga
indenne in caso d’inadempimento del debitore
principale479. Si verifica, in quest’ottica, una
“migrazione” delle polizze fideiussorie verso
lo schema del contratto autonomo di garanzia,
la cui funzione la Corte individua appunto nel
tenere indenne il creditore dalle conseguenze
del mancato adempimento della prestazione
gravante sul debitore principale, laddove il
fideiussore garantisce l’adempimento della
medesima obbligazione altrui.
479 Il discorso svolto dalla Corte richiama alla mente quella
dottrina che individua la ragione dell’autonomia del contratto
autonomo di garanzia nella peculiarità del rischio assunto dal
garante, F. NAPPI, op. cit., p. 58 ss.
526
Con la sentenza che si sta qui esaminando le
Sezioni Unite prendono posizione su tale nodosa questione
circa la natura delle polizze fideiussorie e sull’individuazione
della disciplina conseguentemente applicabile. Esse hanno
ritenuto di dare continuità al secondo orientamento citato e
pertanto hanno qualificato la polizza fideiussoria stipulata a
garanzia delle obbligazioni assunte da un appaltatore come
garanzia atipica e non fideiussoria, con conseguente
inapplicabilità della relativa disciplina.
La Corte ha ritenuto di dover respingere le
obiezioni avanzate da quel filone
interpretativo che predicava l’equiparazione
della polizza de qua alla fideiussione. Tali
critiche alla configurazione della polizza
fideiussoria come contratto atipico di
garanzia, piuttosto che come fideiussione, si
erano mosse in una triplice direzione: a)
527
attraverso la polizza fideiussoria non si
garantisce l’adempimento dell’obbligazione
primaria, ma quella secondaria consistente nel
pagamento di una somma di denaro prestabilita,
per cui non verrebbe meno quell’elemento,
qualificante la fideiussione, consistente
nell’essere identico l’oggetto
dell’obbligazione principale e di quella di
garanzia; b) il requisito della fungibilità
della prestazione, necessario al fine di avere
due obbligazioni (quella principale e quella di
garanzia) con identico oggetto, non dovrebbe
essere stabilito in relazione all’oggetto
materiale della prestazione, ma in riferimento
all’interesse del creditore, ex art. 1173 cod.
civ., secondo il seguente assioma: se
l’interesse del creditore può essere
soddisfatto da prestazione diversa rispetto a
528
quella primaria, la prestazione è fungibile; c)
non è sufficiente a determinare la fuoriuscita
dal tipo fideiussorio, con conseguente
inapplicabilità della disciplina ex art. 1936
ss. (in particolare art. 1957 cod. civ.), una
più accentuata autonomia dell’obbligazione di
garanzia, determinata dalla presenza di
clausole di pagamento <<a prima richiesta,
senza eccezioni>> e simili, in quanto il
sistema giuridico italiano non conosce una
“nozione tecnica” di accessorietà, ossia non
esiste una disciplina uniforme del fenomeno;
pertanto nell’ordinamento sarebbe
sostanzialmente riconosciuta la possibilità di
una certa indipendenza dell’obbligazione di
garanzia da quella garantita.
529
Le Sezioni Unite hanno ritenuto di respingere
in uno tali obiezioni ritenendo che non possa
mettersi in dubbio la circostanza per cui si
configura una fideiussio indemnitatis nel caso in cui
l'insostituibilità della prestazione faccia venire meno la
solidarietà dell'obbligazione del garante, per cui il creditore
può pretendere da lui soltanto un indennizzo o un risarcimento,
prestazione questa diversa da quella alla quale aveva diritto.
La fideiussio indemnitatis non costituisce dunque
garanzia preventiva dell’adempimento, ma
garanzia contro il rischio dell’inadempimento,
ossia garanzia della reintegrazione, con
conseguenza fuoriuscita dal tipo del negozio
fideiussorio480. Sulla falsariga della sentenza
480 Tesi precedentemente sostenuta da Cass. 31 gennaio 2008, n.
2377, cit., che riconduce la polizza fideiussoria a garanzia
dell’obbligazione assunta dall’appaltatore alla figura della
fideiussio indemnitatis, estranea all'area delle garanzie di tipo
satisfattorio proprie delle prestazioni fungibili, caratterizzate
“dall'identità della prestazione, dal vincolo della solidarietà e
dall'accessorietà, e riconducibile invece all'area delle garanzie
530
citata la S. C. ha ritenuto che la polizza
fideiussoria prestata a garanzia delle
obbligazioni assunte da un appaltatore ripete i
caratteri della fideiussio indemnitatis, con
conseguente exodus dal tipo fideiussorio e
inapplicabilità della relativa disciplina.
Altro elemento che ha posto un problema di
compatibilità delle polizze fideiussorie con il
modello fideiussorio, è stato ravvisato, com’è
noto, in quelle clausole c.d. <<di pagamento a
prima richiesta>> e <<senza eccezioni>>. La
S.C. nella sua analisi rileva come tali
clausole costituiscano una valida espressione di
autonomia negoziale, che impone però di verificare
se si tratti di una semplice deroga della
disciplina legale della fideiussione, oppure se
di tipo indennitario, nelle quali il garante non è tenuto ad
eseguire la prestazione mancata, bensì ad indennizzare il
creditore insoddisfatto”.
531
l’alterazione del tipo negoziale è tale da
provocare la fuoriuscita del negozio dal tipo
fideiussorio e il conseguente inquadramento
nell’alveo del contratto autonomo di garanzia
come praticato nel commercio nazionale e
transnazionale (bid bond, performance bond, repayment
bond).
In passato circa l’idoneità delle clausole di
pagamento a prima richiesta o senza eccezioni a
configurare un contratto autonomo di garanzia
si erano contrapposti due orientamenti della
giurisprudenza di legittimità.
Secondo un primo indirizzo sarebbe sufficiente
l’inserimento nel contratto di tali clausole
per qualificare il negozio come contratto
autonomo di garanzia e non come fideiussione,
532
essendo tali clausole incompatibili con il principio di
accessorietà che caratterizza la fideiussione481.
Secondo un altro filone
interpretativo,viceversa, l’inserimento nel
contratto di clausole che obbligano il garante
a pagare a prima richiesta, sulla base della
semplice asserzione del creditore che si è
verificato il presupposto per l’escussione
della garanzia, non sarebbe senz’altro determinante nel
senso della qualificazione del negozio come
contratto autonomo di garanzia. Secondo tale
indirizzo il criterio per distinguere una
fideiussione da un contratto autonomo di
garanzia andrebbe ravvisato non nel mero
inserimento di clausole <<a prima richiesta>> o
<<a semplice richiesta scritta>>, ma nella481 Cass., 14 febbraio 2007, n. 3257, in Foro it. 2007, I, p. 2810;
Cass., 27 giugno 2007, n14853, in Mass. Foro it. 2007, p. 1137; Cass.,
13 maggio 2008, n. 11890, in De iure, banca dati on line, Giuffrè.
533
relazione, desumibile dal complessivo
regolamento negoziale, in cui le parti hanno
inteso porre l’obbligazione principale e quella
di garanzia482.
Le sezioni Unite della Cassazione con la
sentenza in commento, ispirandosi ad un principio
di parità di decisioni a parità di situazioni esaminate hanno
ritenuto di dare continuità al primo
orientamento citato. La ratio decidendi è nella
necessità di evitare spazi interpretativi
“forieri di decisioni differenti a parità di
situazioni esaminate”, consentendo di prevedere
ex ante la qualificazione giuridica del
contratto in caso di controversia. Pertanto la
Corte a Sez. unite ha ritenuto che il contratto di garanzia che
contenga clausole <<a prima richiesta>>, <<senza eccezioni>>
482 Recentemente, Cass., 28 febbraio 2007, n. 4661, in Mass. Foro it.
2007, p. 713; Cass. 3 marzo 2009, n. 5044, in De iure, banca dati
on line, Giuffrè.
534
debba essere qualificato come contratto autonomo di garanzia,
salvo “evidente, patente, irrimediabile discrasia con l’intero
contenuto altro della convenzione negoziale”, ossia salvo
che il resto del contratto non induca a
ritenere che le parti non abbiano inteso
recidere il nesso di accessorietà tra
l’obbligazione di garanzia e quella garantita
che caratterizza la fideiussione.
La Corte enuncia pertanto un principio
interpretativo sulla cui base si dirà che
l’inserimento nel contratto delle clausole
suddette comporta la qualificazione del negozio
come contratto autonomo di garanzia, a meno che
il resto della convenzione negoziale non
escluda senz’altro questa ipotesi. Alla stregua
di tale conclusione dovrebbe pertanto dirsi, ma
la Corte non lo precisa, che l’inserimento nel
535
contratto di una clausola a prima richiesta
abbia il valore di una presunzione iuris tantum,
con conseguente inversione dell’onere della
prova a carico di chi voglia far valere la non
autonomia dell’obbligazione di garanzia
rispetto al rapporto base.
Conseguenza della qualificazione del negozio
come contratto autonomo di garanzia sarà, tra
l’altro, l’inapplicabilità dell’art. 1957 cod.
civ. che statuisce l’onere del creditore di far
valere tempestivamente (sei/due mesi) le sue
istanze contro il debitore attraverso un’azione
giudiziaria, per poter conservare il diritto di
escutere la garanzia anche dopo la scadenza
dell’obbligazione principale; rileva la S.C.
che, poiché la norma sancisce un collegamento
tra l’obbligazione di garanzia e l’obbligazione
536
principale, essa rientra tra quelle norme su
cui si fonda il principio di accessorietà
fideiussoria e pertanto è inapplicabile al caso
in cui le parti abbiano inteso stipulare un
contratto autonomo di garanzia.
In conclusione, il principio di diritto cui le
Sez. Unite pervengono è il seguente: <<la polizza
fideiussoria stipulata a garanzia delle obbligazioni assunte da
un appaltatore assurge a garanzia atipica, a cagione
dell’insostituibilità della obbligazione principale, onde il
creditore può pretendere solo un risarcimento, prestazione
diversa da quella alla quale aveva diritto>>.
18. Spunti sistematici forniti dalla sentenza della
Cassazione ora citata.
Bisogna soffermarsi su di un dato che la Corte
ha avuto modo di sottolineare, perché esso
offre un argomento per una più precisa
537
collocazione della promessa del fatto del terzo
nel sistema delle garanzie personali.
Le Sezioni Unite hanno ritenuto che la polizza
fideiussoria, se prestata a garanzia
dell'obbligazione dell'appaltatore, non ripete
i caratteri morfologici della fideiussione, ma
si configura come garanzia atipica, in quanto
l'infungibilità della prestazione
dell'appaltatore fa venire meno la solidarietà
dell'obbligazione del garante e comporta che il
creditore possa ottenere da lui solo un
indennizzo o un risarcimento, che è prestazione
diversa da quella alla quale aveva diritto.
Questo dato segnerebbe il tratto differenziale
rispetto alla fideiussione, in cui l’elemento
"normale ed essenziale" del vincolo
fideiussorio è pur sempre l'identità
538
dell’obbligazione principale nella sua stessa
qualità e nelle sue stesse condizioni. Al
contrario, la polizza fideiussoria non mira a
garantire l'adempimento dell'obbligazione del
debitore principale (come accade nella
fideiussione), ma ad assicurare al creditore la
presenza di un soggetto solvibile in grado di
tenerlo indenne dall'eventuale inadempimento
del medesimo, ciò che dimostrerebbe il venire
meno di uno degli elementi strutturali della
fideiussione, vale a dire l'accessorietà
dell'obbligazione del garante rispetto a quella
del debitore principale, con conseguente
slittamento verso il modello del contratto
autonomo di garanzia e inadeguatezza del
modello legale fideiussorio.
539
Tali considerazioni richiamano alla mente
quella dottrina483 che, in tema di differenze
tra la funzione della fideiussione e della
promessa del fatto del terzo, sottolinea la
finalità della fideiussione di <<conferire al
creditore maggiore sicurezza per l’estinzione
satisfattoria della obbligazione garantita,
potendo egli pretendere da altro soggetto
(fideiussore) l’adempimento di una prestazione
identica a quella principale (naturalmente
quando sia fungibile), contro la funzione di
garanzia (in senso lato) della promessa, che si
estrinseca nella riparazione successiva del
danno, trasferendo il rischio dell’eventuale
rifiuto del terzo, garantendo l’indennizzo in
previsione di tal evento. Da ciò conseguirebbe
la qualificazione della fideiussione come483 Cfr. E. BRIGANTI, Fideiussione e promessa del fatto del terzo, cit., p.
192. ss.
540
<<garanzia dell’adempimento (cioè garanzia
preventiva di tipo satisfattorio)>>, mentre la
promessa si qualificherebbe come <<garanzia
indennitaria (cioè garanzia successiva di tipo
risarcitorio)>>484.
L’identità dell’iter argomentativo svolto dalla
Cassazione per distinguere la differenza su di
un piano funzionale tra le c.d. polizze
fideiussorie e la fideiussione rispetto a
questo su citato, mette in evidenza, da un
punto di vista sistematico, la similitudine che
corre tra la prestazione cui è tenuto il
garante autonomo (compagnia di assicurazioni
che ha prestato la polizza fideiussoria) e
quella cui è tenuto il promittente in caso di
mancato compimento del fatto del terzo:
l’essere le due prestazioni qualitativamente
484 E. BRIGANTI, op. ult. cit., p. 193.
541
diverse rispetto a quella cui è tenuto il
debitore principale, e sostanzialmente rivolte
alla riparazione di un pregiudizio subito dal
beneficiario.
Se allora da un canto è lecito ravvisare nella
promessa del fatto del terzo una funzione di
garanzia (in senso lato) consistente nella
tutela dell’interesse del promissario al
verificarsi del fatto del terzo promesso,
sopportando il promittente il rischio della
frustrazione della promessa (e dunque il
rischio del sacrificio patrimoniale che il
promittente sopporta nell’ottica di uno
scambio, o della soddisfazione di un proprio
interesse), bisognerà aggiungere che tale
garanzia avrà una funzione
successiva/indennitaria, diversa da quella
542
svolta dalla fideiussione, ed assimilabile
invece a quella svolta dal contratto autonomo
di garanzia.
Si avverte tuttavia l’esigenza di evidenziare
che tale funzione successiva indennitaria, se è
certamente ravvisabile nel caso della polizza
fideiussoria prestata a favore del committente,
non si può riscontrare in alcune tipologie di
contratto autonomo di garanzia, caratterizzate
dalla circostanza che le prestazioni cui sono
tenuti il garante ed il debitore del rapporto
principale sono omogenee (es. garanzia del
rimborso degli acconti, in cui sia il garante
che il debitore sono tenuti alla medesima
prestazione). Si dirà pertanto che la dicotomia
garanzia preventiva di tipo
satisfattorio/garanzia successiva di tipo
543
indennitario non vale a distinguere le garanzie
accessorie da quelle autonome rispetto al
rapporto principale, ma si pone come uno
strumento d’inquadramento trasversale delle
diverse forme tipiche e atipiche di garanzia.
In altri termini affermare che la fideiussione
è certamente garanzia preventiva di tipo satisfattorio,
non significa che la medesima funzione non
possa essere esercitata dalle garanzie che
s’inquadrano al di fuori del tipo fideiussorio.
L’impostazione ha un rilievo pratico nella
misura in cui stacca le possibili forme di garanzia di tipo
satisfattorio dalla disciplina della fideiussione,
riconoscendo alle garanzie di tipo
satisfattorio <<un fondamento concettuale che
esorbiti dall’ancoraggio all’interpretazione
544
della disciplina della fideiussione contenuta
nel nostro codice civile>>485.
19. Una comprensione più approfondita del funzionamento
e dell’inquadramento giuridico delle diverse tipologie
contrattuali che si usa ascrivere alla categoria della
garanzia autonoma, richiede che si distingua innanzitutto
tra garanzia <<senza eccezioni>>, come assunzione di rischi
atipici, e garanzie <<a prima domanda>>, in cui l’interesse
del beneficiario è quello di poter escutere senza ritardo la
garanzia.
Alla stregua di un leitmotiv, si è più volte
detto nel corso del presente capitolo che
diffusa in dottrina è l’opinione secondo cui
con il termine contratto autonomo di garanzia
non s’individua un’omogenea categoria
negoziale, ma un insieme variegato d’ipotesi.
Occorre ora cercare di chiarire la portata di
485 In tal senso, F. NAPPI, La garanzia autonoma, cit., p. 146.
545
tale affermazione, individuando alcuni profili
idonei a distinguere le varie tipologie
negoziali che si usa ascrivere alla nozione di
garanzia autonoma.
Nel paragrafo 13 di questo capitolo si è
evidenziato che la stessa Corte di Cassazione
inquadra in maniera unitaria le diverse
tipologie contrattuali di garanzia c.d.
“autonoma”; l’inserimento di clausole di
pagamento a prima domanda e senza eccezioni
assume, nella ricostruzione dogmatica della
Corte, un valore tipologico nella direzione
della qualificazione del negozio come contratto
autonomo di garanzia, salvo che dal resto della
convenzione negoziale non rilevi la chiara
volontà delle parti di non recidere il nesso di
546
accessorietà tra l’obbligazione del garante e
l’obbligazione del garantito486.
Anche in dottrina si è talora enfatizzata la
rilevanza tipologica delle clausole a prima
domanda, come carattere essenziale del
contratto autonomo di garanzia487. A tal
proposito appare necessario riportare la tesi
di un autorevole e attento studioso della
tematica488 che ha spiegato la ragione del peso
assunto dai caratteri essenziali delle garanzie
<<a prima domanda>>, ai fini della
qualificazione del contratto autonomo di
garanzia, attraverso due ordini di questioni:
a) la conoscenza approssimativa della486 Cass., Sez. Unite, 18 febbraio 2010, n. 3947, cit., p.48 ss.
allegato.487 F. MASTROPAOLO, I contratti autonomi di garanzia, cit., p. 141, ma vedi
sin da p. 125 ss., che considera l’obbligo di pagamento a prima
domanda un <<carattere essenziale dei contratti autonomi di
garanzia>>.488 F. NAPPI, op. cit., p. 104.
547
costruzione del Garantieverträge stammleriano489,
il cui fondamento causale autonomo (l’interesse
del garante) consentiva al garante di assumere
il rischio dell’inadempimento del debitore, pur
essendo nullo il contratto da cui nasceva il
rapporto base; b) l’interesse verso la
categoria del Garantieverträge determinato dalla
necessità d’inquadrare proprio le garanzie a
prima domanda, circostanza che avrebbe indotto
la dottrina a <<modellare uno schema di
contratto fortemente caratterizzato dagli
elementi peculiari delle fattispecie c.d. di
garanzia a prima domanda e, quindi, in virtù di
questa restrizione relativamente compatto>>490.
Un corretto inquadramento giuridico delle
diverse ipotesi di garanzia autonoma deve
489 Vedi sopra par. 2.490 F. NAPPI, op. loc. ult. cit.
548
pertanto prendere le mosse dalla necessità
prospettata dalla migliore dottrina491 di
distinguere due serie d’ipotesi: a) fattispecie
negoziali<<in cui s’intenda solo evitare (...)
che la soddisfazione del creditore subisca
ritardi per contestazioni sollevate dal garante
o dal debitore>>, ma restando il beneficiario
della garanzia esposto alla ripetizione da
parte del debitore, cui il garante conteggiò il
pagamento, di quanto pagato dal garante; b)
<<ipotesi in cui si miri addirittura alla
copertura, a favore del creditore, del rischio
c.d. atipico, correlativo alla nullità,
491 La distinzione operata da R. CICALA, Saggi, cit., p. 195 ss., è
ripresa ed elaborata da F. NAPPI, op. cit., p. 132 ss.; l’A. eleva
la distinzione a criterio fondamentale d’inquadramento giuridico
delle diverse ipotesi di garanzia autonoma, ravvisando tuttavia la
pregnanza del concetto nei soli casi di assunzione di rischi
atipici. Nel prosieguo della esposizione ci riferiremo proprio a
tale costruzione dottrinale, che ci sembra capace di cogliere
l’essenza del fenomeno che si sta analizzando.
549
annullabilità, ecc. (frustrazione in genere del
contratto di valuta (…) per spostare
definitivamente dal suo patrimonio il danno
provocato dalla frustrazione del rapporto>>.
L’autonomia della garanzia ha nelle due serie
di casi una diversa valenza funzionale,
realizzando per le prime ipotesi esposte
l’interesse del creditore a ricevere subito
quanto gli è (a suo parere) dovuto, e per le
seconde l’interesse del beneficiario a ricevere
senz’altro un quid, cioè un’attribuzione
patrimoniale che resta definitivamente
acquisita alla sua sfera patrimoniale.
L’idea di una omogenea categoria contrattuale
(la garanzia autonoma) si ricollega alla
circostanza che in entrambi i casi si ha una
deroga al principio di accessorietà, alla cui
550
stregua 1) l’invalidità del contratto – base
dovrebbe riverberarsi sul contratto di garanzia
(corollario che nel contratto di fideiussione
si esplicita nell’art. 1939 cod. civ.); 2) il
garante potrebbe paralizzare l’escussione della
garanzia opponendo al creditore le eccezioni
che avrebbe potuto opporre il debitore
principale (corollario che per il contratto di
fideiussione è previsto dall’art. 1945 cod.
civ.). Questo quid minus che caratterizza il
contratto di garanzia autonoma rispetto alla
fideiussione (la mancanza dell’accessorietà)
costituisce però l’unico elemento che unifica
le due diverse serie di fattispecie,
considerando che, se da un lato, sia per la
garanzia a prima domanda, che per la garanzia
di assunzione di rischi atipici, il garante è
tenuto ad adempiere l’obbligo di garanzia in
551
caso d’inadempimento del debitore principale,
ogni eccezione rimossa, dall’altro solo
nell’ipotesi della garanzia a prima domanda
l’oblato resta esposto alla ripetizione di
quanto ricevuto, se non dovuto.
È evidente pertanto che alla diversità del
rischio assunto dal garante corrisponde anche
un ben preciso interesse del beneficiario: per
l’ipotesi delle garanzie a prima domanda
l’interesse del beneficiario è quello di
escutere la garanzia subito, in caso
d’inadempimento dell’obbligo da parte del
debitore principale; nel caso della garanzia di
assunzione di rischi atipici l’interesse
soddisfatto è quello di escutere la garanzia
senz’altro, in caso d’inadempimento del
debitore principale.
552
Quando la S.C. a sezioni unite in una sentenza
del 1987492 affermava la non assolutezza
dell’autonomia del contratto di garanzia a
prima domanda, perché <<la definizione del
rapporto principale è in ogni caso destinata a
determinare anche quella del negozio
fideiussorio>>, con conseguente riequilibrio
delle posizioni contrattuali attraverso il
sistema delle rivalse493, si riconosceva la
validità del contratto di garanzia a prima
domanda, ma non anche si spostava l’attenzione
sul fenomeno complessivo della garanzia
autonoma.
Del resto, come si è giustamente
sottolineato494, l’individuare la condizione di
492 Cass. sez. un., 1 ottobre 1987, n. 7341, in Foro it., I, 1988, c.
103 ss.493 Cass. sez. un., 1 ottobre 1987, cit., c.123.494 L. RUGGERI - S. MONTICELLI, op. cit., p. 225.
553
ammissibilità della garanzia autonoma nel
riequilibrio degli spostamenti patrimoniali,
significa <<negare che il giudizio di liceità
su un’operazione economica funga da presupposto
perché sia accertato il diritto delle parti ad
azionare le pretese>> fondate sulle
negoziazioni che concorrono al conseguimento di
un quel dato risultato. Questo giudizio di
liceità, in un ordinamento improntato al
principio causalistico, dovrebbe basarsi
sull’individuazione della giustificazione
causale del negozio, giusta la notazione
secondo cui <<ove l’originaria mancanza di
un’idonea giustificazione causale operasse a
posteriori, sul piano della rivalsa, ci
troveremmo di fronte ad un’anomalia funzionale,
bisognosa di spiegazione>>495.
495 F. NAPPI, op. ult. cit., p. 116, nota 52.
554
S’impone pertanto la necessità d’individuare
per le due diverse ipotesi di garanzia autonoma
prospettate uno schema causale che possa
fornire l’individuazione di una giusta causa
obligandi.
555
20. La garanzia autonoma come assunzione di rischi atipici.
Cenni alla fattispecie dell’indemnity, che nell’area di
common law assolve alla stessa funzione svolta dal
Garantieverträge nell’ordinamento tedesco.
L’obbligazione di garanzia può essere autonoma in senso
assoluto solo se il contratto avente ad oggetto la
prestazione di garanzia abbia una giustificazione causale
autonoma. In tal caso andranno distinti nettamente due
piani dell’analisi: a) l’oggetto del contratto, ossia la
prestazione della garanzia; b) la causa dello stesso, che
andrà individuata nelle comuni ragioni giustificatrici di un
negozio. Le uniche eccezioni opponibili dal garante al
beneficiario saranno quelle derivanti dal contratto di
garanzia medesimo.
Si è detto che l’idea di una garanzia autonoma,
in deroga alla disciplina della fideiussione, è
stata accettata purché si accolga una nozione
556
di autonomia solo relativa496, che non escluda
un riequilibrio delle posizioni contrattuali
delle parti attraverso il sistema delle
rivalse.
Bisogna ora verificare se sia concepibile una
garanzia attraverso cui si possano coprire i
rischi (atipici) relativi alla frustrazione del
rapporto principale, assicurando in via
definitiva una determinata prestazione al
beneficiario, pure in ipotesi di nullità,
annullabilità, risoluzione del contratto
principale. In tal caso l’oblato potrà escutere
la garanzia anche per l’eventualità che non
abbia un diritto da far valere alla stregua del
rapporto principale.
Sia consentito en passant di spostare
l’attenzione in ambito internazionale, per fare496 Cass., Sezioni Unite, 1 ottobre 1987, cit., p. 129
557
un accenno ad una figura contrattuale
utilizzata nella prassi anglosassone:
l’indemnity, che costituisce sul versante del
common law un equivalente del Garantieverträge
stammleriano. Si tratta di un contratto di
garanzia in cui il garante è tenuto a risarcire
la perdita subita dal creditore nel rapporto
principale; ma ciò che più preme sottolineare è
che la garanzia opera anche nell’ipotesi in cui
il promissario non abbia diritti da far valere
ai sensi del contratto principale497. La figura
dell’indemnity svolge pertanto una funzione
analoga a quella del Garantieverträge nell’area
tedesca. Entrambi i contratti, infatti, fanno
da contraltare ai contratti “accessori di
garanzia”, la Bürgschaft del BGB e la guaranty del
497 F. NAPPI, op. cit., p. 133 ss; F. ROCCHIO, op. cit., p. 66 ss.; V.
TEDESCHI e G. ALPA, Il contratto nel diritto nord-americano, Milano 1980, p.
136.
558
common law. Questi contratti accessori di
garanzia sono ispirati ad un maggiore intento
protettivo del garante: entrambi richiedono la
forma scritta, e la loro validità è subordinata
a quella dell’obbligazione principale anche per
il caso in cui essa sia stata assunta da un
incapace (a differenza di quanto previsto nel
nostro ordinamento per la fideiussione: cfr.
art. 1939, cod. civ.).
Il fugace riferimento a tali figure
contrattuali mostra che nelle aree di civil law e
common law si sono elaborate forme di garanzia
del credito “in ogni caso”, prima che si
affermasse in ambito internazionale la
problematica delle garanzie a prima domanda498.
Accanto a contratti di garanzia che pongono
esigenze di tutela del garante più pregnanti
498 F. NAPPI, op. cit., p. 136.
559
per il caso questi si obblighi a garanzia di un
debito altrui, si pongono pertanto forme
negoziali di garanzia (Garantieverträge e indemnity)
in cui l’attenuazione delle esigenze di tutela
del garante si spiega in relazione ad un
interesse sostanziale del soggetto che si
assume la copertura del <<rischio atipico>>.
Quest’interesse del garante costituisce una
giustificazione causale del contratto di
garanzia, tale da obbligare il garante in modo
del tutto indipendente rispetto alle vicende
originarie o successive del rapporto base.
Si dica, incidentalmente, che la mancata
elaborazione di forme analoghe di garanzia
nell’ordinamento italiano può offrire una
spiegazione all’opinione, diffusa in dottrina e
in giurisprudenza, secondo cui le clausole <<a
560
prima domanda>> e <<senza eccezioni>> hanno una
valenza tipologica al fine della qualificazione
del contratto autonomo di garanzia499, come se
le possibilità esplicative di tale forma
contrattuale si riducessero a staccare il nesso
di accessorietà tra l’obbligazione di garanzia
e quella garantita nella fase dell’escussione,
ogni eccezione relativa al rapporto-base
rinviata alla fase della rivalsa del debitore,
“cui il garante ha conteggiato il pagamento”500.
La prospettiva da cui osservare il fenomeno
della garanzia assolutamente autonoma, intesa
come assunzione dei rischi atipici del
contratto (nullità annullabilità, risoluzione),
dovrà essere necessariamente quella della499 Un esempio del valore tipologico dato a tali clausole può
rinvenirsi in F. MASTROPAOLO, I contratti autonomi di garanzia, cit., p.
141.500 In questi termini operano normalmente le c.d. garanzie <<a
prema domanda>, <<senza eccezioni>> e simili.
561
individuazione del profilo causale del
contratto. In altri termini, si potrà sostenere
che il garante debba eseguire la prestazione di
garanzia a titolo definitivo, cioè senza la
possibilità di successive azioni di rivalsa,
nonostante che il creditore non abbia diritti
da far valere alla stregua del contratto
principale, sempre che si possa individuare una
causa “autonoma” del contratto di garanzia,
ossia indipendente rispetto al rapporto che
s’intende garantire.
Si sono già individuati i possibili supporti
causali di un’obbligazione di garanzia che
prescinda strutturalmente o funzionalmente da
una preesistente obbligazione del debitore
principale501; ciò che ora si vuole sottolineare
è che quando l’interprete si trovi di fronte ad
501 Vedi retro, par. 11 di questo capitolo.
562
un contratto di garanzia che abbia in se stesso
la propria giustificazione causale (perché il
contratto di garanzia è stipulato verso una
controprestazione del beneficiario, oppure a
soddisfazione di un interesse del garante)
bisognerà tenere distinti due piani
dell’analisi:
1) La prestazione di garanzia, intesa come
oggetto dell’obbligo che assume il contraente –
garante;
2) La funzione negoziale (causa del contratto)
in cui è inserita la prestazione stessa.
In altri termini per la comprensione del
fenomeno della garanzia autonoma di assunzione
dei rischi atipici bisognerà partire dal dato
che <<il termine garanzia oltre a rappresentare
lo scopo negoziale, può essere utilizzato per
563
esprimere il contenuto di un’obbligazione, la
quale può (contribuire a) realizzare svariati
schemi causali>>502.
Come si è notato, da parte dell’attento Autore
cui è da attribuire l’utile precisazione
surriportata, la manifestazione del fenomeno di
un’obbligazione di garanzia che può avere
fondamento su diverse giustificazioni causali
può rinvenirsi nella fattispecie della promessa
del fatto del terzo (art. 1381 cod. civ.)503;
anzi l’A. prospetta la possibilità che
l’assunzione di rischi atipici del contratto-
base avvenga proprio attraverso una promessa
del fatto altrui504, <<qualora a questa figura502 F. NAPPI, op. cit., p. 156.503 Si è visto nei par. 3 e 4 del capitolo II, cui si rinvia per
ragioni di brevità, che la promessa del fatto del terzo può essere
stipulata per una varietà di ragioni (interesse del promittente,
sacrificio corrispettivo sostenuto dal promissario) idonee a
costituire iusta causa obligandi del promittente.504 F. NAPPI, op. loc ult. cit.
564
tipica si riconosca la natura di promessa di
garanzia>>.
In buona sostanza, parlando di promessa di
garanzia assolutamente autonoma si farà
riferimento non alla causa della promessa, ma
alla natura (di garanzia) dell’effetto. Il
contraente-garante si obbligherà sulla base di
una ragione negoziale che prescinde
dall’esistenza o dalla validità
dell’obbligazione garantita, costituendo essa
stessa iusta causa obligandi. In quest’ottica il
riferimento alla mancanza di accessorietà del
contratto di garanzia assumerà un significato
molto più intenso di un distacco
dell’obbligazione di garanzia dall’obbligazione
garantita nella fase dell’escussione,
esplicando la possibilità di determinare uno
565
spostamento patrimoniale definitivo a carico
del garante, nonostante l’inesistenza,
l’invalidità o la risoluzione del contratto
principale. L’impressione di un sacrificio
patrimoniale del garante non sorretto da una
giusta causa andrà rigettato sulla base del
rilievo del profilo causale “autonomo” del
contratto di garanzia, che non ha fondamento
sul preesistente rapporto obbligatorio,
svolgendo una funzione differente dal
rafforzamento dell’aspettativa creditoria
(tipica ad esempio della fideiussione). Il
nostro contratto di garanzia esplicherà la
funzione di coprire il rischio del mancato
ottenimento di una certa utilità da parte del
beneficiario della garanzia, in vista del quale
costui, nell’interesse del garante, ha concluso
un negozio o ha intrapreso un’iniziativa
566
economica che lo espongono al rischio di un
danno; di qui l’esigenza di protezione
attraverso la prestazione della garanzia.
Ricapitolando, lo strumento tecnico attraverso
cui si fornisce la sicurezza è la prestazione
di garanzia. Il fondamento causale di un tale
contratto con prestazione di garanzia non va
ravvisato necessariamente nel preesistente
rapporto principale, ma nelle comuni ragioni
giustificative di un negozio. Solo in tal modo
si potrebbe spiegare la circostanza di una
garanzia prestata a protezione della
soddisfazione di un interesse del beneficiario,
qualora questi non abbia diritti da far valere
alla stregua del rapporto principale.
L’inquadramento giuridico prospettato per le
garanzie di assunzione di rischi atipici
567
comporterà che le uniche eccezioni opponibili
al beneficiario da parte del garante saranno
quelle fondate sul contratto di garanzia e sul
rapporto garante-beneficiario: a) eccezioni
letterali; b) eccezioni attinenti
all’invalidità o inefficacia del contratto di
garanzia; c) eccezioni dirette e personali.
Trattandosi in sostanza di due rapporti
distinti (con la precisazione che nel caso
della promessa del fatto del terzo il rapporto
base potrebbe addirittura non esistere)
nascenti da autonomi contratti, richiamando il
principio di relatività degli effetti del
contratto (art. 1372 cod. civ.) dovrebbe dirsi
che il garante non possa far valere eccezioni
fondate su un rapporto cui è estraneo.
568
Aderendo a tale impostazione, che in sostanza
esalta la piena autonomia dei due rapporti,
l’unica ipotesi in cui le vicende del rapporto
principale si riverberano sul contratto di
garanzia autonomo è quella in cui i vizi del
contratto garantito, che ne determinano
l’invalidità, hanno una incidenza diretta sul
rapporto “di garanzia”.
Proviamo a formulare degli esempi.
Esempio n. 1. È opinione diffusa e corretta che
l’illiceità del contratto-base determini la
nullità del contratto di garanzia autonomo; ma
in dottrina505 ed in giurisprudenza506 tale
conclusione è per lo più fondata sul rilievo505 Per tutti vedi F. MASTROPAOLO, Pagamento a prima richiesta, limiti alla
opponibilità delle eccezioni e problemi probatori, in Banca, bor. tit. cred., 1990,
II, p.569. L’assunto del riverbero dell’illiceità del contratto
base su quello di garanzia sembra risalire a G. B. PORTALE, Le
garanzie bancarie internazionali, Milano, 1989, p.21- 49 ss.506 Da ultimo la recente Cass., 18 febbraio 2010, n. 3947, cit.
569
che in siffatta ipotesi il contratto di
garanzia è nullo perché ha causa illecita, in
quanto mira ad assicurare in via surrettizia un
risultato che la legge condanna ed esclude;
questo ragionamento, se apprezzabile da un
punto di vista giuridico-sociale, in quanto è
palese che l’ordinamento non possa assicurare
tutela ad un interesse illecito, da un punto di
vista tecnico-giuridico presuppone che il
nostro contratto abbia una causa di garanzia,
ossia che la sua funzione sia quella di
garantire il rapporto di valuta in quanto tale,
conclusione che abbiamo rigettato in toto.
A mio sommesso parere, tuttavia, si potrebbe
pervenire al medesimo risultato di ritenere
nullo il contratto di garanzia stipulato a
protezione di un interesse illecito del
570
contraente - beneficiario, spostando il
ragionamento sull’oggetto del contratto. L’art.
1418 cod. civ. contempla tra le ragioni di
nullità del contratto l’ipotesi in cui
l’oggetto del contratto non abbia i requisiti
richiesti dall’art. 1346 cod. civ., ossia la
possibilità, la liceità, la determinatezza o la
determinabilità. Pertanto è nullo il contratto
con oggetto illecito.
Nell’esame circa la giustificazione causale
della garanzia (assolutamente) autonoma si è
visto507 che il sacrificio economico di chi
presta la garanzia può spiegarsi in relazione
alla controprestazione che il beneficiario
esegue nei confronti del garante o anche nei
confronti del terzo, ma pur sempre
nell’interesse del primo (causa di scambio del
507 Vedi retro, par. 11, lettera A.
571
negozio). Ipotizzando un contratto di garanzia
autonoma stipulato verso una controprestazione
illecita del beneficiario a favore del terzo,
cui il garante ha interesse, si dirà che il
contratto di garanzia è nullo per illiceità
dell’oggetto, costituendo la prestazione di
garanzia il pretium sceleris508, ossia il
corrispettivo della controprestazione illecita
del beneficiario.
Esempio n. 2. Un altro caso in cui le ragioni
che determinano l’invalidità del contratto
principale intaccano anche il contratto di
garanzia potrebbe rinvenirsi nella prestazione
della garanzia autonoma in relazione ad un
negozio annullabile per dolo o violenza. In
siffatta ipotesi, qualora i vizi del consenso
che hanno compromesso la validità del contratto
508 A. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, Padova 1998, p. 520.
572
principale limitino anche la volontà del
garante, il negozio di garanzia è annullabile,
ma pur sempre per un vizio proprio e non
relativo al solo rapporto-base.
In conclusione, quando il contratto di garanzia
abbia una propria autonoma giustificazione
causale, sia essa da rinvenirsi in una
prestazione corrispettiva del beneficiario,
oppure nell’interesse del garante, le vicende
del rapporto garantito non avranno alcuna
influenza sul rapporto di garanzia; si dirà che
il fenomeno del riverbero dei vizi del
contratto-base su quello di garanzia è solo
apparente, poiché in realtà, in talune
situazioni, le ragioni dell’invalidità del
negozio–base determineranno un’autonoma
patologia del nostro contratto.
573
21. La garanzia autonoma <<a prima domanda>>. La
riconduzione di tali figure contrattuali alla garanzia
autonoma costituisce un errore di prospettiva?
L’altro fenomeno cui rinvia il concetto di
garanzia autonoma riguarda talune figure
contrattuali, particolarmente diffuse nei
rapporti tra imprese e tra queste e la Pubblica
Amministrazione, in cui l’escussione della
garanzia avviene <<a prima domanda>> e <<senza
eccezioni>>. La nozione di autonomia usata per
descrivere questi contratti con funzione di
garanzia si riferisce alla circostanza
dell’immediata, ma provvisoria conseguibilità
della prestazione di garanzia da parte del
beneficiario, a prescindere dagli eventuali
vizi del rapporto principale. Si parla di
un’autonomia relativa di tali forme di
garanzia, poiché <<la definizione del rapporto
574
principale è destinato a determinare anche
quella del negozio di garanzia>>509.
L’inserimento delle citate clausole nel
contratto di garanzia ha la funzione di rendere
insensibile il rapporto di garanzia rispetto
alle vicende del rapporto principale,
determinando, per questo verso, una differenza
incolmabile rispetto alla fideiussione, che,
alla stregua degli articoli 1936 ss. cod. civ.,
è una garanzia accessoria all’obbligazione
garantita. Il principio di accessorietà
dell’obbligazione fideiussoria, secondo
opinione costante della dottrina
tradizionale510, costituisce la conseguenza del
fondamento causale del negozio, un corollario
509 Cass., sez. unite, 1 ottobre 1987, cit., c. 123.510 Per i problemi di compatibilità con l’ordinamento che pongono
le clausole di deroga al principio di accessorietà, v. G.B.
PORTALE, Fideiussione e Garantieverträge nella prassi bancaria, cit., p. 5 ss.
575
della sua causa cavendi. Il concetto stesso di
garanzia richiama infatti un quid cui s’intende
attribuire protezione. Questo elemento esterno
al contratto di fideiussione è da ravvisarsi
nel diritto di credito che nasce da un rapporto
principale. La disciplina dettata dal
legislatore per il contratto di fideiussione va
letta pertanto alla luce del profilo causale
del negozio, che consistendo nel rafforzare le
possibilità di soddisfazione di un interesse
creditorio, comporterà che il contratto
presupponga una valida obbligazione principale
(art. 1939 cod. civ.), che il fideiussore non
possa essere obbligato in duriorem causam rispetto
al debitore principale (art. 1941 cod. civ.),
ed infine che il garante possa opporre le
eccezioni opponibili da parte dell’altro
obbligato (art. 1945 cod. civ.).
576
Quando sulla scena dei rapporti commerciali
irrompono i contratti di garanzia che
contengono al loro interno clausole che
recidono il nesso di accessorietà tra il
rapporto garantito e quello di garanzia la
dottrina e la giurisprudenza si sono dovute
confrontare con il problema dell’ammissibilità
nel nostro ordinamento delle garanzie
“autonome” rispetto al rapporto principale. In
particolare, se la non opponibilità di talune
eccezioni nella fase dell’escussione della
garanzia è stata sin da subito giustificata
alla stregua dell’art. 1462 cod. civ., ossia
alla stregua del meccanismo del solve et repete,
problemi più delicati ha posto la clausola di
deroga all’art. 1939 cod. civ. riprodotta nelle
fideiussioni bancarie attive e passive, secondo
cui <<la fideiussione mantiene i suoi effetti
577
anche se l’obbligazione principale sia
dichiarata invalida>>.
L’iniziale posizione della dottrina rispetto a
tali pattuizioni fu fondata sull’assunto che la
funzione di garanzia potesse essere realizzata
esclusivamente attraverso il tipo fideiussorio,
vigendo al di fuori del tipo il regime della
nullità, dovuta all’inderogabilità della
relativa disciplina511. Le considerazioni della
migliore dottrina rispetto all’ammissibilità di
deroghe al principio dell’accessorietà
fideiussoria hanno evidenziato successivamente
la necessità di non confondere la nozione di
causa-funzione del contratto con quella di tipo
511 Ricostruisce e il pensiero della dottrina che lo ha preceduto:
G. B. PORTALE, op. ult. cit., p. 1 ss. Diffusa in dottrina è la tesi
dell’incompatibilità della clausola in deroga all’art. 1939 cod.
civ. con il principio di causalità vigente nel nostro ordinamento:
L. PONTIROLI, Spunti critici e ricostruttivi per lo studio delle garanzie bancarie a
prima richiesta, in Contr. impr., 1989, 1018 ss.
578
negoziale, potendo la prima esplicarsi
attraverso diverse tipologie contrattuali512. Si
è allora notato513 che le norme descrittive di
un tipo negoziale sono inderogabili solo
all’interno di questo, per coerenza con la
fattispecie. Laddove le parti abbiano pattuito
una deroga a tali norme si dovrebbe dire che il
patto è nullo e sostituito di diritto dalla
norma imperativa prevista per il tipo negoziale
(ex art. 1419 comma 2 cod. civ.), salvo che
risulti che le parti non avrebbero concluso il
contratto senza quella specifica pattuizione.
In tal caso esse avranno posto in essere un
contratto atipico, che alla luce dell’art.
1322, comma 2, cod. civ. dovrà superare il
giudizio di meritevolezza dell’ordinamento.
512 G. DE NOVA, Il tipo contrattuale, Padova, 1974, p. 63 ss.513 G. B. PORTALE, op. ult. cit., p. 9. Il contributo dell’Autore è
certamente uno dei più significativi in materia.
579
Sulla scia di tali riflessioni si è formato un
consolidato orientamento dottrinale514, che
trova riscontro anche in giurisprudenza515,
secondo cui i contratti in esame favoriscono il
traffico giuridico poiché rispondono alle
esigenze di speditezza e affidabilità del
commercio nazionale ed internazionale, e
superano pertanto, senza riserva alcuna, il
giudizio di meritevolezza della funzione.
Problema invece ancor’oggi dibattuto è quello
della giustificazione causale di tali
contratti, questione su cui la nozione di causa
del contratto esercita evidentemente tutto il
peso della propria “indefinitezza”. In
particolare, per ciò che concerne il nostro
tema, si confrontano due concezioni: a) la514 Tra gli altri, G. BOZZI, Le garanzie atipiche, cit., p. 62.515 Cass., 17 maggio 2001, n. 6757, cit.; Cass., 20 agosto 1998, n.
8248, in Mass. giur. it., 1998.
580
causa come sintesi degl’interessi reali che il
contratto realizza, o funzione che il negozio
persegue in concreto516 e b) la causa come
ragione del sacrificio patrimoniale cui il
promittente-garante si espone prestando la
garanzia517.
Ogni contratto plurilaterale, per definizione,
assolve la funzione di sintetizzare una
molteplicità (almeno due) d’interessi. Il
rischio che si annida in questo modo
d’intendere la causa del contratto è però
quello di far apparire identiche, situazioni
(funzionali) che, analizzate sotto un profilo516 Nozione accolta dalla giurisprudenza. In particolare la tesi è
sostenuta dalla recente sentenza Cass., 18 febbraio 2010 n. 3947,
cit., in allegato p.42.517 La tesi è esplicitamente sostenuta da F. ROCCHIO, op. cit., cap.
I, p. 7.; sembra invece essere implicita nella ricostruzione della
conformazione della garanzia autonoma proposta da F. NAPPI, op.
cit., cap. II, par. 22; critico verso la definizione di causa come
funzione anche G. FERRI, L’invisibile presenza della causa del contratto, in
Eur. dir. priv., 2002, p. 901.
581
strutturale, sono differenti. La dottrina che
intende la causa come la ragione del sacrificio
patrimoniale dell’obbligato sottolinea che
<<nel momento in cui si cerca la causa della
garanzia autonoma nella funzione che essa
persegue, oltre a compiersi un evidente
ribaltamento logico – perché si cerca la
ragione di un fenomeno nel tipo di effetti che
esso produce – con altrettanta evidenza si
sovrappone il piano della meritevolezza della
funzione perseguita, di cui si occupa l’art.
1322, comma 2 , cod. civ., (…) con il piano del
tutto diverso della causa della promessa
sufficiente ad evitare il rispetto della forma
della donazione>>518. In altri termini, secondo
tal impostazione, la ricerca della causa delle
garanzie “autonome” andrebbe svolta nella
518 F. ROCCHIO, op. cit., p. 122.
582
direzione di giustificare la sanzionabilità
giuridica dell’impegno assunto dal garante, e
non in quella diversa d’individuare la funzione
assolta dal contratto, potendo questa essere
simile per una pluralità di negozi che si
fondano su un supporto causale differente e che
sono eterogenei quanto a struttura.
Quando in una recentissima sentenza519 la S.C.,
investita del problema della qualificazione
giuridica delle polizze fideiussorie, individua
la causa concreta del Garantieverträge nel
<<trasferire da un soggetto ad un altro il
rischio economico connesso alla mancata
esecuzione di una prestazione contrattuale, sia
essa dipesa da un inadempimento colpevole
oppure no>>, per poi affermare che <<sulla
519 Cass., Sezioni Unite, 18 febbraio 2010, n. 3947, cit., in allegato
p. 36 e 42.
583
polizza fideiussoria si riverbera (…) l’eco del
dibattito sul contratto autonomo di garanzia e
sulla sua causa>>, essa enuclea un medesimo
supporto causale per una pluralità di figure,
diverse sotto il profilo strutturale. È
necessario, infatti, tener presente che la
locuzione garanzia autonoma, anche in questa
accezione più limitata che stiamo qui
analizzando, ossia come garanzia relativamente
autonoma, contempla una varietà di fattispecie
negoziali; in particolare si distinguono due
tipologie contrattuali: le garanzie bancarie
passive (c.d. Bankgarantie)520 e le polizze
fideiussorie. D’altro canto, come in un
articolato gioco di scatole cinesi, quando si
passa a verificare il grado di omogeneità
520 La Bankgarantie a sua volta individua una varietà tipologica di
contratti molto ampia, che si è analizzata nel par. 5 di questo
capitolo.
584
interno alle due citate categorie si verifica
che se dal punto di vista della struttura di
tali contratti è individuabile una chiara
distinzione tra lo schema delegatorio che regge
le prime e lo schema del contratto a favore di
terzo in cui si inquadrano le seconde, dal
punto di vista dell’oggetto della prestazione
del garante si possono individuare due ipotesi:
sia per le varie specie di Bankgarantie, che per
le polizze fideiussorie, il garante può infatti
essere tenuto ad una prestazione identica a
quella del debitore, oppure ad una prestazione
indennitaria, consistente nel pagamento di una
somma preventivamente liquidata521.
521 Si deve a R. CICALA, Saggi, cit., p. 197, l’individuazione di
tale alternativa configurazione dell’oggetto della prestazione del
garante. Il garante può essere tenuto ad una prestazione
indennitaria o satisfattoria, sia per il caso del negozio di
assunzione di rischi atipici, che comporterà una attribuzione
patrimoniale definitiva a favore del beneficiario e a carico del
garante, che per il caso dei negozi di garanzia che riproducono il
585
Si pensi per esempio alla differenza che corre
tra la polizza di garanzia dei diritti
doganali, rispetto a quella che garantisce
l’ente appaltante di opere pubbliche: La prima
obbliga il garante in via sussidiaria ad
eseguire una prestazione identica a quella cui
è tenuto il debitore principale; la seconda
obbliga il garante n via principale ad eseguire
una prestazione sostitutiva di cauzione. Stesso
discorso può svolgersi in relazione alla
differenza che passa tra tipologie di
Bankgarantie che hanno una funzione più
propriamente cauzionale (esempio performance
bond) e quelle in cui il garante è obbligato in
via sussidiaria ad eseguire la medesima
prestazione dovuta dal debitore principale,
seppure la condizione dell’escussione della
meccanismo del solve et repete.
586
garanzia si risolva sostanzialmente
nell’affermazione (giustificata) dell’avvenuto
inadempimento522.
La necessità di disarticolare le diverse
fattispecie contrattuali di garanzia <<a prima
domanda>> non ha un’importanza solo teorica,
per così dire, di coerenza del profilo
strutturale con l’inquadramento giuridico che
se ne offra. La riconduzione delle diverse
ipotesi negoziali ad un tipo unitario (fenomeno
che ha fondamento proprio nella “suggestione”
di uno stesso profilo causale) comporterà,
infatti, la tendenza a risolvere in maniera
omogenea i problemi di disciplina che esse
pongono (per esempio la questione delle
eccezioni opponibili dal garante).
522 Esempi tratti da F. NAPPI, op. cit., p. 217.
587
Da questo punto di vista mostra tutta la
propria utilità il concepire la causa del
negozio di garanzia come la giustificazione del
sacrificio patrimoniale del garante. La
circostanza per cui tal assunto non riconduce i
nostri negozi di garanzia ad una unitaria
categoria consentirà infatti di affrontare le
questioni che essi pongono in maniera
diversificata, valorizzando le relative
peculiarità strutturali.
588
22. Segue: la qualificazione della Bankgarantie fondata
sulla circostanza che l’obbligazione del garante è contratta
all’interno di un procedimento tipologicamente
riconducibile a quello delegatorio. La causa della garanzia
bancaria passiva è costituita dall’obbligazione adempiuta
eseguendo l’incarico del cliente.
Nell’analisi dell’operatività pratica delle
garanzie a <<prima domanda>> si evidenziano due
profili essenziali del fenomeno: a) il credito
garantito è immediatamente realizzabile, sia
pure attraverso una giustificazione scritta
dell’inadempimento del debitore principale; b)
l’eventuale esistenza di vizi del rapporto
garantito non sarà fatta valere dal garante in
sede di ripetizione, ma dal debitore a cui
favore è stata prestata la garanzia. La
prestazione patrimoniale a favore del
beneficiario non è pertanto definitiva in
589
presenza di vizi genetici o funzionali del
contratto o del rapporto – base, ma solo
provvisoria. Il concetto di “autonomia” usato
per descrivere tali negozi di garanzia
differisce così in modo assoluto rispetto a
quello, omonimo, utilizzato per i contratti con
funzione di garanzia che si sono
precedentemente analizzati, attraverso i quali
il garante, in virtù di un rapporto di scambio
tra la prestazione della garanzia e la
“controprestazione” del beneficiario, può
assumersi il rischio della copertura di rischi
atipici del contratto; nell’eventualità della
frustrazione del rapporto garantito,
l’attribuzione patrimoniale a favore del
beneficiario sarà definitiva, poiché fondata
sulla causa di scambio del contratto stesso.
590
In relazione alle garanzie che qui si
considerano, a ben vedere, il <<distacco>> tra
l’obbligazione di garanzia e quella garantita
si realizza, nei termini di un’immediata
escutibilità della garanzia, solo nella fase di
realizzazione del credito, potendo in realtà il
debitore garantito far valere attraverso
l’azione di ripetizione i vizi del rapporto
principale; pertanto la relazione sostanziale
tra i due rapporti (quello di garanzia e quello
principale) rimane ancorata all’orbita della
garanzia accessoria, producendosi solo una
posticipazione del riverbero delle vicende del
rapporto principale sul rapporto di garanzia,
secondo una logica assimilabile a quella del
solve et repete, o a quella analoga del deposito
cauzionale: se l’escussione della garanzia non
era legittima, il debitore, cui il garante ha
591
conteggiato il pagamento, potrà ripetere quanto
prestato dal primo. In questo <<sdoppiamento
tra il soggetto tenuto al pagamento della somma
garantita e quello legittimato a far valere in
sede di ripetizione gli eventuali vizi del
rapporto garantito>>523 si concentra in sostanza
la differenza rispetto al meccanismo del solve et
repete, che, inserito nello schema fideiussorio,
comporterebbe la legittimazione all’azione di
ripetizione da parte dello stesso garante.
Dal punto di vista normativo, a differenza
della fideiussione, la garanzia <<a prima
richiesta>> rientra nei "contratti atipici",
ovvero in quei contratti che pur non essendo
previsti e disciplinati dalla legge, sono
ammessi purché leciti e diretti a realizzare523 Terminologia utilizzata da F. NAPPI, op. cit., p. 226, per indicare
la circostanza cui in sostanza rinvia la nozione di autonomia
utilizzata per descrivere tali contratti.
592
interessi meritevoli di tutela (art. 1322 cod.
civ.). Una tal definizione della garanzia
bancaria passiva <<a prima richiesta>> è però
muta riguardo ad una peculiarità strutturale
del negozio in questione, che emerge ad uno
studio più attento del fenomeno, ossia
analizzando l’operazione negoziale complessiva
che presiede alla stipula del contratto di
garanzia. Da tale angolo visuale emerge che il
negozio di garanzia, che è concluso tra la
banca ed il beneficiario e che si perfeziona
secondo lo schema del contratto unilaterale
(art. 1333 cod. civ.), trattandosi di un
contratto che vede obbligato solo il garante524,
poggia su di un rapporto che la banca
524 Il contratto dovrà ritenersi concluso nel momento e nel luogo
nel quale la proposta giunge al beneficiario, se entro la scadenza
del termine -richiesto dalla natura degli affari o dagli usi- il
beneficiario non manifesterà una volontà contraria
all’accettazione.
593
intrattiene con un proprio cliente (debitore
che chiede alla banca la prestazione della
garanzia). Precisamente, il cliente conclude
con l’istituto di credito un contratto di
apertura di credito (di firma), attraverso cui
la banca assume un obbligo di fare consistente
nell’assunzione di obbligazioni verso terzi, ad
esempio accettazioni di cambiali tratte, o
prestazione di garanzie a favore del proprio
cliente.
In conseguenza di tale rapporto la banca si
troverà in una posizione di soggezione verso il
proprio cliente, il quale potrà esercitare il
diritto potestativo525 d’indicare il soggetto
con cui l’istituto di credito avrà l’obbligo di
concludere il negozio di garanzia.
525 F. GIORGIANNI, I crediti disponibili, cit., p. 259; R. TETI, op. cit., p.
29.
594
Detta ricostruzione comporterà che si possa
addivenire alla seguente conclusione. La causa
obbligandi del garante, nell’ipotesi che stiamo
analizzando, dovrà essere ricercata al di fuori
del rapporto che corre tra costui ed il
beneficiario. Si dirà che il fondamento causale
dell’impegno della banca (garante) è costituito
dall’obbligazione preesistente assunta nei
confronti del cliente con l’apertura di un
credito di firma, giusto l’assunto secondo cui
in generale <<non porrà alcun problema sotto il
profilo causale ogni promessa con funzione di
garanzia autonoma formulata per dare seguito ad
un incarico che, in mancanza di diverso
inquadramento in alcuna delle figure tipizzate,
può definirsi quale contratto con prestazione
al terzo>>526.526 F. ROCCHIO, op. cit., p. 93. Si deve a M. GIORGIANNI, op. ult. cit.,
p. 566, l’idea che la garanzia autonoma, nella sua configurazione
595
Quest’idea di una giustificazione causale della
garanzia autonoma fondata sul rapporto garante
– ordinante è stata criticata sul presupposto
che, se da un lato essa giustifica l’assunzione
dell’obbligo da parte del garante, parimenti
non offre una <<giustificazione causale
dell’attribuzione del beneficiario>>527. A ben
vedere però, ragionando in questi termini,
dovrebbe dubitarsi anche della giustificazione
dell’attribuzione patrimoniale proveniente al
creditore da un terzo che adempia
spontaneamente, ma a tale questione sarebbe
agevole rispondere che l’ordinamento consente
che l’obbligazione possa essere adempiuta da un
di garanzia bancaria passiva, sia assistita da una causa esterna
rappresentata dal rapporto ordinante-garante. Come ipotesi tipica
di tali negozi l’Autore prospetta il caso di prestazioni verso
terzi, effettuate in adempimento di obblighi contenuti in altri
negozi.527 L. PONTIROLI, Le garanzie autonome e il rischio del creditore, Padova 1992,
p. 79, nota 67.
596
terzo (ex art. 1180 cod. civ.) anche contro la
volontà del creditore, se questi non ha
interesse a che il debitore esegua
personalmente la prestazione; nel contempo è
escluso che il terzo che adempie
volontariamente il debito altrui possa ripetere
quanto ha prestato (argomentando sulla base del
combinato disposto degli art. 1180 e 2036 cod.
civ.).
Al medesimo risultato d’individuare la causa
della garanzia bancaria passiva (autonoma) nel
rapporto “d’incarico” che corre tra l’istituto
di credito ed il cliente, giunge quella
dottrina che riconduce le garanzie in questione
allo schema della delegazione528. Si afferma
infatti che <<l’obbligazione del garante (…)
528 Tra gli altri, R. CICALA, op. cit., p. 197 ss.; F. NAPPI, op. cit.,
p. 230 ss.
597
rinviene il suo presupposto nell’ordine (il
c.d. iussum) ricevuto dal debitore
principale>>, che potrà essere considerato come
<<la causa del rapporto delegato-delegatario,
in quanto ciò è consono con gli scopi che il
legislatore in genere persegue nell’esigere la
presenza di una causa per la validità di
qualsiasi attribuzione patrimoniale>>529.
L’interprete, che di fronte alla citata
affermazione si chiedesse quali sono questi
scopi, dovrebbe orientare la propria analisi
sulla circostanza per cui se si esegue una
prestazione non supportata da una specifica
causa (solvendi, cavendi, adquirendi per il caso di
promesse interessate) l’attribuzione potrebbe
qualificarsi donazione, laddove però lo scopo
della prestazione è quello di adempiere,
529 F. NAPPI, op. cit., p. 229 ss.
598
garantire, o acquistare un’opportunità, e non
quello di donare (causa donandi). L’attribuzione
sarebbe nulla perché effettuata contro la
volontà di donare e in assenza, tra l’altro,
della forma ad substantiam richiesta per tale
negozio530. In sostanza una tal prestazione
determinerebbe un arricchimento ingiustificato
dell’oblato.
In relazione alla vicenda che qui si esamina,
in cui chi paga conteggia il pagamento
all’ordinante, mai potrebbe la prestazione
determinare un arricchimento senza causa del
beneficiario, perché intanto il garante non
subisce alcun detrimento patrimoniale in virtù
del citato meccanismo del conteggio, ma inoltre
il debitore potrà certamente esperire l’azione
di rivalsa verso l’oblato nel caso che il suo
530 G. GORLA, Il contratto, Milano 1955, p. 268 ss.
599
sacrificio patrimoniale risulti ingiustificato
alla luce delle vicende del rapporto
principale531.
Il richiamo al meccanismo delegatorio ai fini
dell’inquadramento sistematico delle garanzie
bancarie passive ha incontrato un duplice
ordine di obiezioni in dottrina: a) in primo
luogo (ex art. 1268 comma 2 cod. civ., alla cui
stregua il creditore che ha accettato
l’obbligazione del terzo non può rivolgersi al
delegante, se prima non ha richiesto al
delegato l’adempimento) si è rilevato che
essendo la delegazione funzionale
all’assunzione di un debito altrui, essa non
potrebbe configurarsi come negozio produttivo
di un’obbligazione di garanzia532; b) quanto531 Cfr. F. NAPPI, op. cit., p. 229 ss.532 G. GRIPPO, La garanzia automatica in bilico tra “tecnica” e “politica”: tendenze
della giurisprudenza, in Banca, borsa, tit. cred., 1985, II, p. 93.
600
all’opponibilità dell’eccezione di nullità
della doppia causa (art. 1271 comma 2 cod.
civ.) si è detto che essa, sebbene possa
costituire un utile strumento contro eventuali
abusi del beneficiario della garanzia, sarebbe
in contrasto con le esigenze che i contratti di
garanzia <<a prima domanda>> sono volte a
realizzare, segnando per questo verso
un’incompatibilità con il meccanismo
delegatorio.
L’orientamento citato - che ai fini
dell’inquadramento della garanzia autonoma
assunta in adempimento di un incarico individua
nello iussum del debitore il supporto causale
dell’obbligazione del garante - ritiene però
che alla garanzia in esame possa essere
applicato lo schema generale della delegazione,
601
depurato da quegli aspetti connaturati alla
funzione negoziale di assunzione del debito
altrui, quali la non sussidiarietà
dell’obbligazione del delegato (art. 1268 comma
2 cod. civ.) e l’eccepibilità della nullità
della doppia causa (art. 1271 comma 2 cod.
civ.)533. Secondo la citata tesi <<il
procedimento delegatorio non esaurisce le sue
possibilità operative all’interno del modello
tipico previsto negli art. 1268 e ss.>>, ma
<<costituisce solo una delle possibili
applicazioni di uno schema generale
identificabile tutte le volte che si ponga in
essere quel complesso di atti giuridici per cui
un soggetto A, delegante, fa promettere o
semplicemente effettuare, con effetto sul suo
patrimonio, una certa prestazione da un altro
533 R. CICALA, Saggi, cit., p. 198 ss.
602
soggetto B, delegato, verso un soggetto C,
delegatario, sia o no il delegante debitore del
delegatario>>534. In quest’ottica si riconosce
che <<il c.d. beneficium ordinis costituisce un
effetto solo naturale, non essenziale, della
delegazione>> e pertanto <<l’art. 1268 comma 2
sarebbe disapplicabile per volontà delle parti,
giacché ora ricorre -programmato nel mandato ed
attuato nel contratto concluso tra quest’ultimo
ed il creditore - l’intento pratico di
obbligare il delegato solo in via
sussidiaria>>535.
534 F. NAPPI, op .cit., p. 231.535 F. NAPPI, op. cit., p. 233, il quale a sostegno dell’opinione
espressa richiama la tesi di B. GRASSO, Assunzione cumulativa del debito e
beneficium ordinis , in Saggi, cit., p. 131 ss., secondo cui il beneficium
ordinis non è connaturato ad ogni negozio di assunzione del debito
altrui, ma al solo contratto delegatorio di assunzione del debito,
per cui, afferma il Nappi, poiché il mandato è funzionale ad
obbligare il delegato solo in via sussidiaria, il richiamo del
negozio d’incarico nel contratto tra quest’ultimo e il creditore
comporterà che costui debba attenersi al programma contrattuale.
603
Per quanto concerne invece la possibilità di
una deroga all’art. 1271 comma 2 cod. civ. si
afferma che la logica dell’eccezione della
nullità della doppia causa sarebbe da
rinvenirsi nell’esigenza di evitare azioni di
ripetizioni a catena, laddove siano nulli sia
il rapporto di provvista che quello di valuta,
anche al fine di evitare che gravi sul delegato
il rischio dell’insolvenza del delegante.
Pertanto il rimedio sarebbe disapplicabile, non
avendo fondamento <<nella logica essenziale del
negozio delegatorio>>536, che è tipicamente
astratto dal rapporto di provvista e da quello
di valuta e che si fonda sul fattore del
conteggio al delegante di quanto prestato dal
delegato, per ottenere il quale è senz’altro
536 A. e op. ult. cit., p. 239.
604
sufficiente l’efficacia dello iussum anche in
ipotesi di nullità dei rapporti sottostanti.
In definitiva le conclusioni cui la dottrina
citata perviene è che per quelle forme di
garanzia a prima domanda in cui il garante è
tenuto alla stessa prestazione dovuta dal
debitore principale (garanzia di restituzione
degli acconti, garanzia di pagamento etc.) e
conteggia al debitore quanto paga,
sussisterebbe la possibilità di un’applicazione
analogica della disciplina della delegazione
c.d. pura, in quanto astratta dalla provvista e
dalla valuta.
Si pone infine la necessità di un duplice
ordine di precisazioni.
A) Abbiamo detto che il negozio delegatorio
s’incentra sul fattore del conteggio e che per
605
ottenere quest’effetto è necessario e
sufficiente l’efficacia dello iussum, anche in
ipotesi di nullità dei rapporti sottostanti.
S’impone ora la necessità di chiarire la
portata di quest’affermazione in relazione
all’altra secondo cui la delegazione pura è
tipicamente astratta dal rapporto di provvista
e dal rapporto di valuta. Infatti, se con tale
assunto si volesse intendere che il delegato
(garante) non può eccepire al delegatario
(beneficiario della garanzia) il difetto
causale consistente nella inefficacia
dell’incarico ricevuto dal delegante (debitore
principale), avremmo un’astrazione assoluta del
nostro schema, che escluderebbe la possibilità
di rinvenire la causa del nostro contratto
nell’assunzione da parte del garante
606
dell’obbligo d’impegnarsi nei confronti del
beneficiario.
Per scongiurare una tale conclusione bisogna
sottolineare la seguente circostanza: l’art.
1271 comma 2 cod. civ., nell’impedire al
delegato di sollevare le eccezioni che potrebbe
opporre al delegante, non gl’impedisce di
sollevare le eccezioni che al lui delegato
potrebbe opporre il delegante, ossia la
mancanza del’incarico, al fine di evitare che
il delegato possa rifarsi su di lui per il
pagamento al delegatario537. Dunque l’astrazione
del negozio delegatorio dal rapporto di
provvista e di valuta non comporterà anche
l’astrazione dell’impegno del delegato nei
confronti del delegatario dalle vicende
dell’incarico impartito dal delegante.
537 F. NAPPI, op. cit., p. 237; F. ROCCHIO, op. cit., p. 110 ss.
607
Applicando il ragionamento alla garanzia
bancaria passiva si dirà che la causa del
negozio è quella esterna rappresentata
dall’obbligazione sorta dall’incarico del
debitore. Questo poi comporterà, come vedremo,
che il garante possa opporre al beneficiario
l’invalidità dell’incarico, che costituirà
un’eccezione causale e non relativa al rapporto
di provvista.
B) Abbiamo più volte ripetuto che un’analisi
attenta delle garanzie “autonome” rileva grossi
tratti di discontinuità tra le singole figure,
finanche all’interno di figure negoziali dello
stesso tipo. In relazione alla garanzia
bancaria passiva si è per esempio
sottolineato538 che andrebbero distinte quei
contratti sulla cui base il garante è tenuto ad
538 R. CICALA, op. cit., p. 197.
608
eseguire una prestazione identica a quella cui
è tenuto il debitore principale (ad es.
garanzia di rimborso degli acconti, o anche
garanzia di pagamento), da quei negozi che
prevedono che il garante sia tenuto ad una
prestazione indennitaria in caso
d’inadempimento del debitore principale (si
pensi a quei contratti di garanzia in cui il
garante si accolli il rischio della mancata
sottoscrizione del contratto principale, oppure
garantisca la buona esecuzione dei lavori
oggetto del contratto principale, o ancora
s’impegni a pagare una certa somma al
committente nel caso in cui l’appaltatore non
elimini i difetti emersi al termine dei
lavori). In tutte queste ipotesi la prestazione
cui è tenuto il debitore principale non è né
609
identica né omogenea rispetto a quella cui è
tenuto il debitore principale.
Ebbene la dottrina maggioritaria, in relazione
a queste ipotesi da ultimo prospettate, rigetta
la possibilità di un inquadramento sistematico
che faccia leva sul richiamo allo schema
delegatorio, poiché il delegato assume nei
confronti del delegatario un obbligo di
contenuto identico rispetto a quello che grava
sul delegante (debitore principale). Quanto poi
all’inquadramento di queste tipologie di
garanzia bancaria passive le opinioni espresse
oscillano tra la configurazione di un negozio
di tipo assicurativo, in cui il mancato
adempimento del rapporto derivante dal
contratto base o il mancato rispetto
dell’offerta contrattuale vengono presi in
610
considerazione come sinistri che il terzo
(garante) assicura539, e la prospettazione di
una funzione latamente cauzionale dei negozi in
questione540.
A ben vedere, però, la possibilità d’inquadrare
in maniera unitaria le garanzie bancarie
passive è offerta dalla citata tesi541 secondo
cui - a seguito dell’apertura di un credito di
firma (contratto socialmente tipico attraverso
il quale la banca s’impegna ad un facere nei
539 L. RUGGERI, op. cit., p. 240; l’assimilazione dei contratti con
funzione di garanzia al contratto di assicurazione non dovrebbe
però essere consentita sulla base almeno di tre argomenti: a)
l’assicuratore a differenza del garante autonomo deve avere
necessariamente determinati requisiti pubblicistici; b) a
differenza del garante autonomo l’assicuratore gestisce
professionalmente il rischio; c) l’obbligazione dell’assicuratore
nasce con la dimostrazione e quantificazione del danno da
risarcire, mentre nell’ipotesi della garanzia a prima domanda al
più esiste l’onere del beneficiario di giustificare
l’inadempimento del debitore sulla base delle formalità convenute.540 F. NAPPI, op .cit., 229. 541 F. ROCCHIO, op. cit., p. 91.
611
confronti del cliente, consistente
nell’assumere o nel garantire un’obbligazione
del debitore/cliente) - la banca si trova in
una posizione di soggezione nei confronti del
cliente, che ha il diritto potestativo di far
sorgere l’obbligazione della banca di
concludere il contratto di garanzia con il
beneficiario che le sarà indicato. Sulla base
di tale descrizione dell’operazione negoziale
che intercorre tra il garante ed il debitore
principale si afferma che <<l’impegno del
garante autonomo sarà allora assistito da una
causa esterna rappresentata dall’obbligazione
preesistente assunta per aver aperto un credito
di firma al proprio cliente>>542. La circostanza
per cui attraverso questa ricostruzione non si
richiama in maniera espressa il meccanismo
542 A e op. ult. cit., p. 92 ss.
612
delegatorio comporterà che si possa fornire un
inquadramento unitario delle garanzie bancarie
passive, come contratti con prestazione al
terzo, stipulati in adempimento di un obbligo
precedentemente assunto, che costituirà in
definitiva la causa esterna del contratto
stesso.
23. Segue: La qualificazione delle polizze fideiussorie come
contratto a favore di terzi con causa di scambio, per essere
il debitore garantito tenuto a pagare una somma alla
compagnia di assicurazioni.
Le polizze fideiussorie (altrimenti denominate
assicurazioni fideiussore, fideiussioni
cauzionali) sono contratti con cui una
compagnia di assicurazioni, dietro versamento
di una somma (altrimenti definita premio) da
parte del debitore, garantisce l’adempimento
613
delle obbligazioni che su questo gravano in
favore del creditore543.
Si tratta di una promessa con funzione di
garanzia emessa nell’ambito di un contratto a
favore di terzo tra la compagnia assicurativa
ed il debitore principale, dove stipulante è il
debitore, promittente il garante e terzo il
creditore.
In passato si è dubitato circa la natura di
garanzia di tale contratto: chi ne valorizzava
il profilo soggettivo (contratto concluso da
una compagnia di assicurazioni e con modalità
tecniche tipicamente assicurative, cioè secondo
calcoli che tengono conto delle probabilità di
verificazione del danno) ravvisava in esso un
543 G. BOZZI, L’autonomia negoziale nel sistema delle garanzie personali, Napoli
1990, p. 261.
614
negozio di assicurazione544. Al giorno d’oggi,
per opinione unanime, si nega che la polizza
fideiussoria abbia natura assicurativa.
L’assunto si fonda su tre ragioni fondamentali:
a) volendo applicare la normativa dettata in
tema di contratto di assicurazione la polizza
fideiussoria non coprirebbe la fonte più grave
del potenziale danno per il creditore (l’art.
1900 cod. civ. prevede infatti che non è
concesso il risarcimento del danno causato dal
contraente con dolo o colpa grave)545; b) la
prestazione dell’assicuratore è subordinata
all’effettiva esistenza del danno (che dovrà
pertanto essere provata) ed è determinata nei
limiti della misura del danno provato, mentre
544 G. STOLFI, Natura giuridica dell’assicurazione cauzioni, in Ass., 1958, I,
p. 67 ss.; Trib. Napoli, 20 marzo 1992, in Banca, borsa tit. cred.,
1993, II, p. 85.545 P. CORRIAS, op. cit., p. 496, nota 393.
615
per le polizze fideiussorie la prestazione del
garante è predeterminata nel quantum ed è
dovuta sulla base dell’escussione a prima
richiesta del beneficiario, che sarà tenuto al
solo rispetto delle formalità convenute (c.d.
garanzia giustificata)546; c) infine si
evidenzia che mentre il regresso del
promittente nella polizza fideiussoria è quello
tipico che spetta a chi paghi un debito altrui,
il regresso dell’assicuratore è quello tipico
dei contratti di assicurazione nei confronti
dell’autore del danno, per cui all’assicuratore
è preclusa la rivalsa nei confronti
dell’assicurato delle somme versate a titolo
d’indennizzo547.
546 P.CORRIAS, op. cit., p. 497.547 P. CORRIAS, op. loc. ult. cit.
616
Per quanto concerne la qualificazione di questo
contratto ed in particolare l’individuazione
della sua causa, si è visto548 che la
Cassazione, pur confermandone la natura di
contratto a favore di terzo, procede attraverso
una sua riconduzione all’alveo della categoria
del Garantieverträge, la cui causa concreta viene
individuata nell’assunzione, da parte del
garante, del rischio dell’inadempimento,
rischio che normalmente sarebbe sopportato dal
creditore549.
Anche in tal caso, come per la Bankgarantie,
l’analisi dell’operazione negoziale complessiva
che presiede alla promessa di garanzia,
potrebbe però fornire una ricostruzione
alternativa a quella operata dalla S. C.
548 Vedi retro par. 13 e 17 di questo capitolo.549 Vedi retro par. 16 di questo capitolo.
617
Abbiamo detto che la polizza fideiussoria
ripete lo schema del contratto a favore di
terzo. Dunque la sua causa sarà rappresentata
dalla causa di tale contratto. Nel caso che
stiamo analizzando in cui “l’assicurato” paga
una somma alla compagnia di assicurazioni
affinché questa faccia la promessa di garanzia,
la causa di detta promessa sarà rappresentata
dallo scambio con il pagamento del premio da
parte del debitore e con la promessa del
rimborso. A sua volta la causa
dell’attribuzione del garante (promittente)
andrà individuata nello scopo di adempiere
(causa solvendi) l’obbligazione che ha assunto con
il contratto concluso con lo stipulante550.
L’adesione a questa ricostruzione sistematica
della polizza fideiussoria, come meglio vedremo
550 F. MESSINEO, Dottrina generale del contratto, Milano 1948, p. 405.
618
nel paragrafo successivo, comporterà però che
sulla base di tale forma di garanzia autonoma
il beneficiario resti esposto alle eccezioni
fondate sul rapporto di provvista. Si è visto
relativamente alla Bankgarantie che il garante
può paralizzare l’escussione della garanzia
esclusivamente opponendo al beneficiario le
eccezioni che il debitore stesso potrebbe
opporre a lui garante (dunque non potrebbe
paralizzare l’escussione della garanzia
opponendo l’inadempimento del cliente -
debitore garantito nei suoi confronti). Nel
caso delle polizze fideiussorie, invece,
l’applicazione delle norme in tema di contratto
a favore di terzo, ed in particolare l’art.
1413 cod. civ., implicherà, in mancanza di
diversa ed espressa pattuizione, il rilievo di
qualsiasi eccezione relativa al rapporto di
619
provvista e pertanto il garante potrà
paralizzare l’escussione della garanzia anche
eccependo l’inadempimento del debitore nei suoi
confronti (mancato pagamento del servizio
prestato).
24. Autonomia ed accessorietà della garanzia e regime
delle eccezioni. Le eccezioni relative al contratto ed al
rapporto di garanzia (rinvio). Riesame della problematica
alla luce della proposta ricostruzione delle garanzie
bancarie passive e delle polizze fideiussorie: le eccezioni
relative alla causa della promessa con funzione di garanzia
autonoma.
Il tema delle eccezioni opponibili da parte del
garante per paralizzare l’escussione del
beneficiario costituisce indubbiamente lo snodo
centrale in cui si concentra, in tutta la sua
evidenza, la differenza operativa tra la
620
garanzia autonoma e la garanzia accessoria
(fideiussoria).
Certamente opponibili, indipendentemente dal
tipo di garanzia prestata, sono quelle
eccezioni fondate sul rapporto di garanzia, che
è possibile distinguere schematicamente in: a)
eccezioni letterali, b) eccezioni attinenti
all’invalidità o inefficacia del contratto di
garanzia e c) eccezioni dirette e personali. Di
queste eccezioni si è già trattato
nell’enunciare la posizione della S.C. in
materia, per cui, per ragioni di brevità, non
resta che rinviare a quella sede551.
Cercheremo ora di dimostrare che la
qualificazione proposta della garanzia bancaria
passiva e della polizza fideiussoria, l’una
sussumibile nello schema delegatorio (puro),551 Retro, par. 14, lettera d. del presente capitolo.
621
l’altra costituente un contratto a favore di
terzo, rende possibile opporre anche talune
eccezioni concernenti il difetto causale del
contratto di garanzia.
A) Analizzando il contratto di garanzia
bancaria passiva abbiamo visto che, poiché la
banca assume l’obbligazione di garanzia in
adempimento dell’obbligazione preesistente
sorta dall’incarico conferitole dal cliente,
taluni autori inquadrano la descritta
operazione nell’ambito dello schema della
delegazione pura552. Quest’inquadramento della
garanzia bancaria passiva consente di affermare
che il negozio in questione, se da un lalto è
astratto dai rapporti di provvista e di valuta,
certamente non lo è in riferimento alle vicende
552 Retro, par. 22 del presente capitolo.
622
dell’incarico553. Si perviene a questa
conclusione considerando che l’art. 1271 che
vieta al delegato di opporre al delegatario le
eccezioni che potrebbe opporre al delegante,
non gli vieta di opporre al delegatario le
eccezioni che a lui delegato potrebbe opporre
il delegante, ossia proprio quelle eccezioni
attinenti alle vicende dell’incarico, che, ove
mai il delegato avesse eseguito la prestazione
verso delegatario, paralizzarebbero l’azione di
rivalsa verso il delegante.
Applicato alla nostra garanzia bancaria passiva
il descritto regime comporterà che in assenza
dell’incarico del debitore, che costituisce il
<<presupposto>> dell’impegno del garante,
oppure qualora detto incarico sia nullo, sia
stato annullato o rescisso, l’impegno del
553 Così F. NAPPI, op. cit., p. 229.
623
garante sarà da considerarsi nullo perché
carente di causa; il garante potrà opporre al
beneficiario quelle eccezioni che il debitore
potrebbe opporre a lui garante per paralizzare
l’azione di rivalsa554, ossia le citate
patologie del negozio d’incarico.
Si impone una precisazione. Abbiamo detto che
le eccezioni opponibili dal garante sono quelle
d’inesistenza, nullità, annullabilità,
rescissione del rapporto d’incarico. L’assunto
va però coniugato con la lettera dell’art. 1271
comma 2, cod. civ., che consente al delegato di
opporre al delegatario le sole eccezioni che il
delegante potrebbe opporre a lui delegato. Si
dirà allora che l’eccezione di nullità e quella
d’inesistenza del rapporto d’incarico, ai sensi
dell’art. 1271 comma 2 cod. civ., sono sempre
554 F. ROCCHIO, op. cit., p. 137; Cfr. F. NAPPI, op. cit., p. 237.
624
opponibili al delegatario (beneficiario della
garanzia), poiché si tratta di eccezioni che il
delegante stesso (debitore) potrebbe opporre al
delegato (garante) impedendogli così l’azione
di rivalsa.
L’eccezione di annullamento, deve considerarsi
opponibile al beneficiario solo nell’ipotesi in
cui l’annullamento sia previsto a beneficio del
debitore (incapace, o che ha concluso il
negozio sulla base di un vizio della volontà),
che può così opporlo al garante;
l’annullamento, qualora fosse previsto a
beneficio del garante, integrerebbe
un’eccezione inopponibile (arg. ex art. 1271
comma 2), secondo cui <<il delegato non può
opporre al delegatario, benché questi ne fosse
625
a conoscenza, le eccezioni che avrebbe potuto
opporre al delegante>>.
La possibilità di opporre l’eccezione di
rescissione del contratto dev’essere contenuta
negli stessi limiti esposti per quella di
annullamento. Anche la sua proposizione deve
ritenersi possibile qualora la rescissione
fosse prevista nell’interesse del debitore, e
pertanto da costui opponibile alla banca
garante.
B) Per quanto concerne le polizze fideiussorie
abbiamo visto che, in base a concorde opinione
di dottrina e giurisprudenza, esse vengono
sussunte nello schema del contratto a favore di
terzo. Questa qualificazione del negozio de quo
deve però tener conto del regime delle
eccezioni previste a favore del promittente,
626
che insidiano, come vedremo, l’autonomia
assoluta del rapporto di garanzia rispetto ai
sottostanti. Da un lato infatti l’art. 1413
cod. civ. consente al promittente di opporre al
terzo le eccezioni fondate sul rapporto dal
quale il terzo trae il suo diritto, ossia
quelle fondate sul rapporto con lo stipulante.
Dall’altro l’art. 1411 cod. civ. statuisce che
è valida la stipulazione a favore di un terzo,
qualora lo stipulante vi abbia interesse.
Riguardo all’ultimo articolo citato, secondo
un’opinione diffusa in dottrina555, l’interesse
dello stipulante richiesto al fine della
validità della stipulazione a favore del terzo
555 U. MAJELLO, Contratto a favore di terzo, in Dig. disc. priv., sez. civ.,
IV, Torino, 1989, p. 240; R. SACCO-DE NOVA, Il contratto, II, in
Trattato diritto civile, diretto da R. Sacco, Torino, 2004, p. 212 ss.; M.
SESTA, Interesse, causa e motivi nella stipulazione a favore di un terzo, in Studi in
memoria di G. Gorla, III, Milano, 1994, p. 2081 s.; C. M. BIANCA,
Diritto civile, 3, Il contratto, Milano, 2000, p. 568.
627
è fondato su di una valida causa
dell’attribuzione al terzo, per cui tal
interesse non sussisterebbe laddove il rapporto
di valuta sia invalido, annullato, rescisso,
etc. In altri termini la validità della
stipulazione a favore del terzo presupporrebbe
un valido rapporto tra stipulante e terzo.
Questo comporterebbe che il promittente possa
eccepire al terzo i vizi del rapporto di
valuta, perché vizi relativi alla validità
della stipulazione in suo favore.
È chiaro allora che, se così fosse,
riconoscendo la natura di contratto a favore di
terzo della polizza fideiussoria, nulla
resterebbe dell’autonomia della garanzia in
questione, perché il garante sarebbe
legittimato a paralizzare l’escussione della
628
garanzia eccependo i vizi del rapporto di
provvista, ai sensi dell’art. 1413 cod. civ.,
ossia quelli relativi al rapporto con lo
stipulante (debitore), ma nel contempo potrebbe
anche far valere i vizi relativi al rapporto di
valuta, debitore (stipulante) – terzo
(creditore), ai sensi dell’art. 1411 cod. civ.
Secondo un’altra interpretazione556 l’interesse
dello stipulante contemplato dall’art. 1411
cod. civ. non avrebbe alcun’attinenza con la
causa dell’attribuzione al terzo e, quindi, con
il rapporto di valuta. La norma sarebbe stata
prevista dal legislatore con la stessa finalità
per cui è stato previsto l’art. 1174 cod. civ.,
alla cui stregua la prestazione che forma
oggetto dell’obbligazione dev’essere
suscettibile di valutazione economica e deve
556 F. ROCCHIO, op .cit., p. 140 ss.
629
corrispondere ad un interesse anche non
patrimoniale del creditore. Com’è noto la norma
allude <<alla necessità di patrimonializzare le
conseguenze dell’inadempimento>>, perché <<in
assenza di sanzione non si potrebbe parlare di
obbligazione in senso giuridico>>557.
L’Autore citato, cui è da attribuire la tesi
che qui si riporta, sostiene però che l’art.
1174 cod. civ. sembra fondato su di un
equivoco, sciolto il quale si chiarisce il
senso del riferimento all’interesse dello
stipulante contenuto nell’art. 1411 cod. civ.
Afferma infatti l’A. che <<al fine di
predisporre una sanzione per il caso
d’inadempimento, quello che conta non è la
patrimonialità della prestazione, bensì la
557 Relazione del guardasigilli, n. 557.
630
patrimonialità dell’interesse del
creditore>>558. Si fa l’esempio della
compravendita di un quadro di famiglia al cui
ritrovamento l’acquirente abbia dedicato tutta
la vita. Per tal caso, si afferma, far
consistere il danno da inadempimento nel solo
valore economico del bene significa frustrare
l’interesse (non patrimoniale), ma sostanziale
dell’autore. Al contempo però una liquidazione
del danno risarcibile che tenga conto di questo
suo interesse potrebbe essere possibile solo
sulla base della pattuizione di una clausola
penale che predetermini l’entità economica del
danno.
Il contratto a favore di terzi, nel caso in cui
lo stipulante intenda effettuare una liberalità
al terzo, pone lo stesso ordine di problemi,
558 A. e op. ult. cit., p. 141.
631
ossia la sanzionabilità del promittente, per
l’inadempimento dell’obbligo assunto con la
stipula del contratto a favore di terzo,
laddove <<non sia patrimonialmente valutabile
l’interesse dello stipulante a che il
promittente esegua la prestazione al terzo>>559.
Per tal caso l’inadempimento del promittente
resterebbe privo di sanzione.
Sulla base di tal interpretazione l’interesse
dello stipulante richiesto al fine della
validità del contratto a favore di terzo (e
quindi della nostra polizza fideiussoria) non è
attinente alla causa dell’attribuzione che lo
stipulante compie al terzo per mezzo del
promittente, ossia alla causa del rapporto di
valuta. Pertanto i vizi di questo rapporto non
potranno essere fatti valere dal promittente
559 A. e op. ult. cit., p. 142.
632
come vizi del contratto a favore di terzi.
L’art. 1411 cod. civ. andrà pertanto letto nel
senso che <<una volta accertata la
patrimonialità dell’interesse dello stipulante
o la possibilità di sanzionare altrimenti
l’inadempimento del promittente, la
stipulazione a favore del terzo sia valida e
pertanto sorga l’obbligazione del promittente
nei confronti del terzo>>560.
Per tale via sarà salva l’autonomia della polizza
fideiussoria rispetto alle vicende del rapporto garantito.
Alla luce dell’art. 1413 cod. civ. non può però
dirsi salva l’autonomia del nostro contratto di
garanzia dal rapporto di provvista. Si pone al
riguardo la necessità di verificare la
possibilità che le parti pattuiscano
l’inopponibilità al terzo, beneficiario della560 F. ROCCHIO, op. loc. ult. cit.
633
garanzia, delle eccezioni fondate sul rapporto
che intercorre tra lo stipulante ed il
promittente, in particolare per quanto concerne
l’eccezione di mancato pagamento del premio,
perché se fosse sufficiente l’assenza del detto
pagamento per legittimare l’assicuratore a
resistere all’escussione della garanzia,
evidentemente l’utilità della garanzia autonoma
sarebbe delusa del tutto.
Si dica in primis che il problema potrebbe essere
risolto all’origine attraverso un’espressa
previsione di legge che impedisse
all’assicuratore – garante di opporre al
beneficiario l’inadempienza dello stipulante al
pagamento del premio561. Per quanto riguarda la561 M. FRAGALI, Fideiussione e mandato di credito, cit., p. 170, propende
per l’inopponibilità dell’eccezione di mancato pagamento del
premio, anche per il caso di polizze fideiussorie non regolate da
leggi speciali, fermo restando la possibilità dell’assicuratore di
resistere all’escussione della garanzia sulla base di tutte le
634
possibilità di configurare una rinuncia del
promittente a sollevare le eccezioni fondate
sul rapporto di provvista, dovrebbe dirsi, alla
stregua dell’art. 1462 comma 1 cod. civ., che
la clausola con cui si stabilisce che il
promittente non può opporre eccezioni al fine
di ritardare o evitare la prestazione dovuta al
terzo, non ha effetto per le eccezioni di
nullità, annullabilità, risoluzione del
contratto a favore di terzo. Il promittente
potrebbe invece rinunciare ad opporre
l’eccezione di mancato pagamento del premio da
parte dello stipulante debitore, perché essa
configura una tipica eccezione d’inadempimento,
di cui si può disporre ai sensi dell’art. 1462
cod. civ.
altre eccezioni relative al rapporto di provvista.
635
Le eccezioni d’invalidità e rescissione del
contratto a favore di terzo saranno sempre
opponibili al beneficiario, in quanto si tratta
di eccezioni indisponibili ai sensi dell’art.
1462 cod. civ.
Sulla base della soluzione prospettata,
l’autonomia della polizza fideiussoria rispetto
alle vicende del rapporto di provvista è solo
parzialmente salva, ma lo è in relazione ad una
vicenda del rapporto di provvista, ossia il
mancato pagamento del premio da parte del
debitore, che potrebbe minare alla base ogni
forma di utilità della garanzia in questione
nella prassi.
Si sottolinei infine che ragioni di prudenza
dovrebbero indurre il beneficiario della
polizza a pretendere che nel testo della
636
garanzia sia inserita l’espressa rinuncia da
parte del promittente-garante ad opporre
l’eccezione di mancato pagamento del premio.
25. Segue: Il problema dell’opponibilità al beneficiario delle
eccezioni derivanti dal contratto e dal rapporto principale.
La proponibilità dell’exceptio doli in caso di escussione
fraudolenta o abusiva del creditore può costituire uno
strumento per prevenire possibili abusi?
Il tratto peculiare delle garanzie autonome che
stiamo considerando (Bankgarantie e polizze
fideiussorie), che ne evidenzia l’utilità
concreta nell’ambito dei traffici economici,
consiste nel distacco delle vicende
dell’obbligazione garantita rispetto
all’obbligazione di garanzia, alla cui stregua
la legittimazione del beneficiario
all’escussione della garanzia dovrebbe essere
637
valutata alla luce del solo rapporto di
garanzia, non rilevando, sotto tale profilo, le
vicende del rapporto garantito.
È evidente che nella prassi questo regime
potrebbe comportare la perpetrazione di abusi
da parte del beneficiario che, formalmente
legittimato all’escussione, non lo sia sulla
base del rapporto principale.
In dottrina ed in giurisprudenza si è posto
pertanto il quesito dell’ammissibilità, in
talune circostanza, di un <<superamento del
principio dell’astrattezza dell’obbligazione
del garante rispetto ai rapporti
sottostanti>>562.
La posizione della giurisprudenza sul tema è
che in presenza di anomalie genetiche o562 In questi termini G. B. PORTALE, Fideiussione e Garantieverträge nella
prassi bancaria, cit., p. 32.
638
funzionali particolarmente gravi del rapporto
base l’autonomia dei nostri contratti non è
assoluta. In particolare si ritengono
opponibili dal garante autonomo al
beneficiario, oltre alle eccezioni propriamente
attinenti al contratto o al rapporto di
garanzia563, le c.d. eccezioni di frode, fondate
sulle vicende originarie o successive del
rapporto principale e ammissibili per il caso
che il beneficiario, pur formalmente
legittimato all’escussione sulla base del
rapporto di garanzia, non lo sia alla stregua
del rapporto principale, e tenti pertanto di
escutere abusivamente quanto il garante si era
impegnato a prestargli. Presupposto
d’ammissibilità delle eccezioni in parola è che
563 Vedi retro par. 14, Lettera d.
639
il tentativo di frode risulti da una prova
certa ed incontestata (prova liquida)564.
Più precisamente, le eccezioni da ultimo
menzionate potrebbero essere fondate: a)
sull’avvenuto adempimento del rapporto
principale565; b) sulla risoluzione del
contratto principale per fatto non imputabile
al debitore principale566; c) sull’invalidità
del rapporto principale567. 564 Cass., Sezioni Unite, 18 febbraio 2010, n. 3947, cit. , p. 44
allegato.565 Cass., 1 ottobre 1999, n. 10864, in Banca, borsa, tit. cred., 2001,
II, p. 666 ss.566 App. Genova, 25 luglio 2003, in Giur. merito, 2003, I, 2362, con
nota di C. BELFIORE, Garanzia autonoma e litisconsorzio (non) necessario.567 Cass., Sezioni Unite, 18 febbraio 2010, cit., p. 44. Bisogna
specificare che pressoché pacifica è l’opinione secondo cui il
garante possa eccepire la nullità del contratto-base illecito
(G.B. A. MAZZONI, Le lettere di patronage nelle procedure concorsuali: contributo
allo studio dei profili sistematici delle garanzie autonome, in Banca, borsa, tit. cred.,
1984, II, p. 395; F. NAPPI, op. cit., p. 182). Secondo taluni autori
il rimedio sarebbe esperibile anche per l’eventualità che il
contratto principale sia nullo per ragioni diverse, o comunque sia
stato caducato, purché tuttavia sussista una sentenza passata in
giudicato (G. B. PORTALE, Nuovi sviluppi, cit., p. 181 s. e 184,
640
Sulla base di tale regime si potrebbe dire che
l’unico elemento che segna la differenza tra la
garanzia accessoria e quella autonoma, sotto il
profilo delle eccezioni opponibili, stia nel
fatto che la non debenza della garanzia
autonoma alla stregua del rapporto principale
debba risultare da una prova liquida, ossia
certa ed incontestata.
È fuor di dubbio che l’assoluta autonomia delle
garanzie che qui si esaminano ponga un problema
di ragionevole tutela del debitore garantito,
cui spetta l’azione di ripetizione d’indebito
in caso di escussione abusiva della garanzia e
su cui in definitiva verrebbe a gravare il
rischio dell’insolvenza del beneficiario. Il
problema però è quello della compatibilità di
tali eccezioni rispetto al regime convenzionale
nota 32).
641
delle garanzie in questione, che, imponendo di
valutare la legittimazione del beneficiario
alla stregua del solo rapporto di garanzia,
astrae quest’ultimo dalle vicende del rapporto
sottostante568. Non è inutile ricordare che
queste garanzie nascono proprio per assicurare
l’immediata escutibilità della garanzia,
posticipando l’accertamento relativo alla
esistenza o meno del diritto di credito che la
legittima.
In verità l’ammissibilità dell’exceptio doli come
rimedio generale per evitare gli abusi ad opera
del beneficiario della garanzia è tutt’altro
che pacifica in dottrina.
Un primo dubbio si pone infatti per il caso che
una specifica disposizione non autorizzi
568 Questione già trattata retro, par. 15 di questo capitolo, cui si
rinvia.
642
espressamente il rimedio. Il legislatore ne
ammette l’esperibilità in taluni casi speciali;
un esempio è la previsione dell’exceptio doli
cambiaria (art. 21 legge cambiaria), che, sulla
base dell’art. 1993 cod. civ., è espressamente
estesa ai titoli di credito in generale569.
Secondo questa prima posizione l’ammissibilità
del rimedio sarebbe subordinata ad una
specifica disposizione che lo autorizzi.
In secondo luogo, da un punto di vista
comparatistico, si rileva l’incrinatura che
s’introduce nel sistema, laddove si nega al
delegato di sollevare eccezioni riferite al
rapporto di valuta, quando la delegazione non
sia titolata con riferimento a questo rapporto,
consentendo invece al garante autonomo di
569 G. B. PORTALE, Fideiussione e Garantievertrage nella prassi bancaria, cit.,
p. 33.
643
sollevare eccezioni riferite al rapporto
garantito. Per tale via, si è affermato, ciò
che è consentito al delegato, che pure assume
l’obbligazione oggetto del rapporto principale,
sarebbe negato al garante autonomo, che invece
assume un debito proprio570.
Quanto poi alla possibilità di rinvenire un
fondamento positivo all’eccezione di frode
nella precettività del principio di buona fede
nell’esecuzione del contratto (art. 1375 cod.
civ.), violato dal beneficiario che escuta
abusivamente la garanzia, non essendovi
legittimato alla stregua del rapporto
principale571, si è obiettato572 che il dovere di
correttezza del beneficiario andrebbe valutato
alla luce del solo rapporto di garanzia. In570 F. ROCCHIO, op. cit., p. 156.571 F. NAPPI, op. cit., p. 251; G. B. PORTALE, op. ult. cit., p. 34.572 Cfr. F. ROCCHIO, op. cit., p. 159.
644
altri termini, non essendovi un nesso di
rilevanza giuridica del rapporto garantito
rispetto a quello di garanzia (diversa sarebbe
l’ipotesi della garanzia accessoria che poggia
sul rapporto fondamentale che ne costituisce la
causa interna), il principio di relatività
degli effetti del contratto (sancito dall’art.
1372 cod. civ.) escluderebbe che il garante
possa far valere eccezioni fondate su di un
rapporto rispetto al quale è estraneo. Una tal
possibilità, alla stregua dell’art. 1372 comma
2 cod. civ., potrebbe essere concessa solo se
una specifica disposizione di legge la
contemplasse (come accade in Francia, dove
l’art. 2321, comma 2, code civil, consente
espressamente al garante di far valere
l’eccezione di frode nei confronti del
beneficiario).
645
Tuttavia, laddove l’escussione della garanzia
debba essere documenta, dovendo il beneficiario
presentare i documenti che attestano
l’inadempimento del debitore principale,
l’escussione potrebbe essere paralizzata sulla
base di un’eccezione documentale. In altri
termini, ipotizzando ad esempio l’avvenuto
adempimento del rapporto principale, laddove il
beneficiario pretenda ugualmente di escutere la
garanzia, potrebbe essergli opposta, non
l’exceptio doli, ma un’eccezione contrattuale
fondata sul contratto di garanzia.
Questa circostanza dovrebbe consigliare la
stipula di garanzie a prima domanda
documentali, perché queste restringono lo
spazio per comportamenti abusivi del
beneficiario, che in definitiva si riverberano,
646
come già detto, sul beneficiario della
garanzia573.
26. Riepilogo.
Le origini teoriche della c. d. garanzia
autonoma sono rintracciabili nella figura del
Garantieverträge, il cui fondamento causale veniva
individuato dallo Stammler nell’“interesse di
animazione”, che può rendere “indipendente” il
negozio di garanzia dalle vicende del rapporto
principale, differenziandolo per tal verso
dalle garanzie accessorie (fideiussione,
mandato di credito etc.).
La dottrina moderna e la giurisprudenza
inquadra nel Garantieverträge soprattutto una
serie di garanzie a prima domanda utilizzate
nella prassi contrattuale internazionale.
L’operazione è però compiuta trascurando le573 Cfr. F. NAPPI,. op. cit., p. 252 ss.
647
peculiarità causali del tipo negoziale
originario e richiamandone il solo effetto
dell’autonomia dell’obbligazione di garanzia,
che diventa idoneo, forse senza i necessari
approfondimenti, ad inquadrare una serie non
omogenea di fattispecie negoziali.
Sulla base di un’analisi che tenga conto del
principio di causalità vigente nel nostro
ordinamento574, nonché delle peculiarità forti
delle singole figure contrattuali che si usa
ascrivere alla categoria “garanzia autonoma”,
sembrerebbe che il riferimento ad un coacervo
di negozi fondati sull’indipendenza della
garanzia rispetto ai vizi genetici o funzionali
del rapporto principale possa essere utilizzato
più com’espressione di comodo, piuttosto che
fondare una categoria scientifica.
574 V. retro, par. 11, del presente capitolo.
648
Si pone pertanto il problema di una separata
valutazione e di una riqualificazione che tenga
conto delle specificità di ogni figura.
Quest’operazione ha condotto ad individuare un
primo gruppo di contratti con funzione di
garanzia che possono addirittura prescindere
dalla stessa esistenza del negozio principale,
o attraverso cui il garante può assumere i c.d.
rischi atipici del contratto, ossia l’evenienza
dell’invalidità, o della risoluzione del
negozio principale. Il risultato del
<<distacco>> dell’operatività della garanzia
rispetto alle vicende del negozio “garantito”
costituirà per siffatta forma contrattuale un
effetto del suo fondamento casuale autonomo. La
locuzione “contratto di garanzia” starà qui ad
indicare non la causa del negozio (causa
649
cavendi), bensì la funzione della prestazione
posta in essere dal garante, volta alla
protezione dell’interesse del beneficiario a
non subire detrimento per la conclusione di un
certo affare.
Da questo fenomeno va distinto quello delle
garanzie a prima domanda. L’autonomia di questi
contratti si sostanzia nella legittimazione del
beneficiario all’escussione della garanzia alla
luce del solo rapporto di garanzia,
costituendone presupposto necessario e
sufficiente l’affermazione dell’inadempimento
dell’obbligo principale, con l’allegazione
(eventuale, ma auspicabile) dei documenti
previsti dal testo del contratto.
Nell’ambito di tal ultima sottocategoria si
pone la necessità di mettere in luce le
650
peculiarità strutturali dei singoli negozi,
relegando il concetto di autonomia a termine
meramente descrittivo dell’indipendenza della
garanzia nella fase dell’escussione, senza che
esso possa assumere un ruolo nell’inquadramento
delle singole figure. Si è visto che per quanto
concerne la Bankgarantie e le polizze
fideiussorie una qualificazione soddisfacente
delle stesse è possibile richiamando per la
prima lo schema delegatorio puro, e per le
seconde quello del contratto a favore di terzo.
La disciplina integrativa di dette forme di
contratti atipici di garanzia, per quanto non
disciplinato dalle parti, potrà così essere
utilmente attinta dagli istituti richiamati.
651
CONCLUSIONI
Sezione prima: la promessa del fatto del terzo
allo “stato dell’arte interpretativo”.
1. Gli effetti obbligatori della promessa del fatto del terzo.
L’evoluzione dialettica delle varie opinioni
formulate sul tema della natura dell’impegno
assunto dal promittente ha condotto ad
individuare l’assunzione di un obbligo di
garanzia da parte di chi promette
l’obbligazione o il fatto del terzo.
Tralasciando l’orientamento secondo cui il
promittente assume un obbligo di pagare
l’indennità, sospensivamente condizionato al
mancato compimento del fatto del terzo575, si
575 Si è già esposto (retro, par. 9, capitolo secondo) a quali
irragionevoli conseguenze conduce la tesi sopra citata.
652
prospetta576l’ipotesi ricostruttiva che dalla
promessa nasca un’obbligazione di garanzia in capo al
promittente, in quanto costui assume il rischio del
mancato compimento del fatto del terzo, che
fisiologicamente dovrebbe gravare sul
creditore, indipendentemente da ciò che farà
per convincere il terzo a compiere il fatto
promesso577.
Secondo questa prospettiva il promittente
assume ab initio l’onere economico del danno della
mancata esecuzione del fatto, rischio che viene
trasferito dal promissario in capo al
promittente; se poi il terzo non compie il
576 G. SCALFI, op. cit., p. 60 ss.; E. BRIGANTI, Fideiussione e promessa del
fatto del terzo, cit.; p. 107 ss. A. MAZZONI, lettere di patronage, mandato di
credito e promessa del fatto del terzo, cit., p. 334 ss; MASTROPAOLO,
Promessa del fatto altrui, garanzie personali e sindacati di voto, cit., p. 695 ss;
M.C. CHERUBINI, La promessa del fatto del terzo, cit., p. 45 ss.577 La tesi è stata compiutamente ricostruita al par. 10 del
capitolo secondo.
653
fatto, la garanzia si converte nell’obbligo di
pagare l’indennizzo578.
Sennonché non è affatto pacifica
l’ammissibilità di un’obbligazione di garanzia579, ove
con tale termine s’intenda far riferimento ad
una particolare nozione di rapporto
obbligatorio, caratterizzato da una struttura
sui generis; poiché la garanzia si traduce in
concreto in un’attribuzione patrimoniale che
esplica una funzione di garanzia, essa meglio
corrisponde all’idea di prestazione580.
578 In tal senso SCALFI, op. cit., p. 74. L’A. ravvisa tanto
nell’ipotesi del contratto di assicurazione, quanto nella promessa
del fatto del terzo, un’ipotesi di responsabilità senza debito
attuale.579 Tesi sostenuta da G. SCALFI, op. cit., p. 60 ss.580 Cfr. E. BRIGANTI, op. cit., p. 102 ss.; F. NAPPI, La garanzia
autonoma, cit., p. 138 ss.; A. CHECCHINI, La promessa del fatto del terzo,
cit., p. 392; F. ROCCHIO, op. cit., p. 1 ss, e p. 61 ss. E’ da
segnalare la posizione dell’Autore da ultimo citato, che contesta
la stessa nozione di “prestazione di garanzia” intesa come
“cooperazione” del garante che assume il rischio patrimoniale
dell’evento nefasto, poiché ritiene che <<non basta dire che
654
Si è inoltre argutamente notato che la
ricostruzione dianzi menzionata opera una
“posposizione logica dei termini della
fattispecie”581, che sono il promettere il fatto
del terzo ed il garantirlo. Secondo questa
visione, che potremmo a ragione definire “un
compromesso” tra le diverse teorie prospettate,
la garanzia del compimento del fatto da parte
del terzo, che si traduce nell’obbligo di
pagare l’indennizzo se l’evento non si
verifichi, è un posterius rispetto all’obbligo
del promittente di adoperarsi per procurare il
compimento del fatto da parte del terzo, poiché
un’obbligazione abbia una funzione di garanzia per escludere che
il suo oggetto sia un dare; perché in ogni caso, qualsiasi
funzione un’obbligazione persegua, essa dovrà farlo attraverso uno
dei suoi oggetti tipici, ossia un fare, un non fare, ma
soprattutto un dare, come avviene praticamente nella totalità
delle ipotesi di promesse con funzione di garanzia: ciò
sicuramente in caso di garanzia indennitaria, ma anche nel caso di
garanzia satisfattoria>>. 581 F. ALCARO, op. cit., p. 77.
655
l’interesse del promissario “alla sicurezza” è
solo succedaneo rispetto all’aspettativa
all’esecuzione del fatto del terzo.
In altri termini, muovendosi la promessa in
direzione di un interesse del promissario al
verificarsi dell’evento, sarebbe ragionevole
ritenere che tal interesse debba ricevere una
protezione nell’ambito di una struttura
giuridica obbligatoria. Esclusa la
configurabilità di un obbligo di procurare “il
fatto altrui”, si è ritenuto582 che il
promittente debba operare perché l’evento
atteso si realizzi, secondo modalità che
dipenderanno dalla natura del fatto promesso.
La circostanza che la norma contenuta nell’art.
1381 sia muta circa il collegamento che582 M.C. CHERUBINI, op. cit., p. 30 ss.; F. MASTROPAOLO, Promessa del
fatto altrui, garanzie personali e sindacati di voto, cit., p. 709, p. 716 ss., p.
737; A. CHECCHINI, La promessa del fatto del terzo, cit., p. 407.
656
sussiste tra la promessa ed il fatto del terzo
non significa che una relazione tra le suddette
fattispecie non esista, o sia logicamente
inconcepibile. Il rilievo dell’interesse del
promissario alla realizzazione dell’evento
prospettato sembra, all’opposto, condurre alla
conclusione che la promessa dia luogo ad
obblighi di comportamento, prima di tradursi
nell’obbligo di pagare l’indennizzo.
Dalla puntuale disamina dello “stato dell’arte
interpretativo” prende avvio l’orientamento
della Cassazione iniziato con la sentenza n.
12973 del 1995583 e confermato dalle sentenze
più recenti584.
L’individuazione di un’obbligazione di garanzia
a carico del promittente, che pur descrive,583 Cass. 20 dicembre 1995, n. 12973, cit., p. 177.584 Da ultimo, Cass. 10 luglio 2009, n. 16305, in De iure, banca dati
on line, Giuffrè.
657
secondo la S. C., una conseguenza essenziale
della stipulazione della promessa, non è
sufficiente a riassumere ed esaurire il
comportamento cui è tenuto il promittente.
L’assunzione del rischio del mancato compimento
del fatto del terzo non è idoneo a soddisfare
per intero la situazione d’interesse del
promissario, che mira ad ottenere prioritariamente
l’obbligazione o il fatto del terzo e, in
subordine, la sicurezza di essere indennizzato
per il caso che il terzo non compia il fatto
promesso.
Conseguentemente la S. C. ritiene che dalla
promessa nasca una prima obbligazione di fare -
consistente nell’adoperarsi affinché il terzo
compia quanto promesso dal promittente- ed una
successiva obbligazione di dare -cioè di
658
corrispondere l’indennizzo- ove mai, nonostante
l’impegno profuso in tal senso, il terzo
rifiuti di tenere il comportamento conforme
alla promessa.
Qualora il promittente non adempia l’obbligo di
adoperarsi, il promissario avrà a disposizione
gli ordinari rimedi contro l’inadempimento,
quali la risoluzione del contratto e
l’eccezione d’inadempimento. Gli spetterà
inoltre il risarcimento del danno qualora a
seguito di tal inadempimento subisca un
pregiudizio economicamente valutabile e
sussista il nesso di causalità fra
inadempimento ed evento dannoso.
Se il promittente adempie l’obbligo di fare, ma
il fatto promesso non venga comunque compiuto,
659
diverrà attuale l’altra obbligazione di pagare
l’indennizzo.
Ove poi il fatto promesso abbia natura tale che
il promittente non possa influire sul suo
compimento, sarà logico ritenere che nasca in
capo al promittente il solo obbligo di
“manlevare” il promissario dalle conseguenze
dell’inadempimento.
2. Funzione dell’indennizzo e determinazione del suo
ammontare.
La citata ricostruzione lascia ancora irrisolta
una questione, su cui, ad oggi, non si è
formato un orientamento univoco: che funzione
ha il pagamento dell’indennizzo ed a quali
parametri andrà ancorato il suo ammontare?
Dall’analisi del panorama dottrinale e
giurisprudenziale si evidenziano due possibili
660
soluzioni al quesito. a) L’indennizzo ha la
funzione di far conseguire al promissario
l’equivalente economico del fatto promesso; la
determinazione del suo ammontare avviene alla
luce delle medesime disposizioni che presiedono
alla quantificazione del danno da risarcire
(art. 1223 ss.). b) L’obbligo di corrispondere
l’indennizzo per il caso che il terzo ometta il
fatto promesso, pur essendosi il promittente
impegnato in tal senso, è preordinato alla
compensazione della lesione subita dal
promissario, per aver fatto affidamento sul
compimento del fatto promesso585.
Quanto però alla determinazione in concreto
dell’indennizzo, si è visto che provengono
dalla giurisprudenza indicazioni divergenti
585 Le due posizioni sul tema sono state più dettagliatamente
esaminate al par. 16 del capitolo secondo.
661
circa i criteri da utilizzare a tal fine,
escludendosi talora dal calcolo della somma
dovuta a titolo d’indennizzo il mancato
guadagno, altre volte stabilendosi che
l’ammontare dello stesso non possa che essere
valutato secondo un criterio equitativo586.
Prescindendo da valutazioni dogmatiche e
astratte, una soluzione alla questione in
parola sembra potersi trarre dal complessivo
assetto d’interessi che presiede alla
stipulazione della promessa del fatto del
terzo.
Dall’analisi del Repertorio
giurisprudenziale587, emerge che la ragione per
586 Per una panoramica più esaustiva circa le posizioni della
giurisprudenza sul tema si rinvia al capitolo secondo, par. 17,
lettera c di A.587 Si è accennato alla questione retro, par. 16, capitolo secondo,
in relazione alla problematica configurazione di una promessa del
fatto del terzo disinteressata.
662
cui si promette il compimento di un certo fatto
da parte di un terzo soggetto si fonda
sull’interesse del promittente alla conclusione
di un certo affare con il promissario, o al
compimento da parte di quest’ultimo di un certo
atto. In altri termini, tra la prestazione
della promessa e quanto il promissario è
indotto a compiere sulla base dell’aspettativa
generata dalla stessa, corre un rapporto di
scambio.
In questa prospettiva appare ragionevole
affermare che, poiché il promissario è stato
indotto alla conclusione di un certo affare, al
compimento di un certo atto (anche nei
confronti di un soggetto che non sia il
promittente, ma magari proprio il terzo),
facendo affidamento sull’aspettativa del
663
verificarsi dell’evento promesso, l’indennizzo
debba avere la funzione di eliminare il
pregiudizio subito dall’oblato per avere
affrontato un determinato sacrificio economico
nell’interesse (anche) del promittente588.
La promessa del fatto del terzo costituiva la
ragione della conclusione di un negozio tra il
promittente ed il promissario, o del compimento
di un certo atto da parte di quest’ultimo. La
frustrazione della promessa renderà
ingiustificato il sacrificio patrimoniale
588 La tesi è stata sostenuta da A. CHECCHINI, Indennizzo e risarcimento
nella promessa del fatto del terzo, cit., p. 563 ss.; ID., La promessa del fatto
del terzo, cit., p. 395. In quest’ultimo scritto l’A. afferma che
<<dire che l’indennizzo rappresenta l’equivalente economico del
fatto promesso significa ammettere che vi è maggiore
responsabilità nella promessa del fatto altrui di quella che sorge
dalla promessa del fatto proprio, perché nel primo caso si deve
fornire una prestazione che soddisfa comunque (…) l’interesse
creditorio, anche se la frustrazione di tale interesse (positivo)
non deriva da colpa del debitore, mentre nella promessa del fatto
proprio si è tenuti solo nei limiti in cui vi è obbligo di
adempiere>>.
664
affrontato dal promissario, sulla base
dell’aspettativa dell’evento promesso. Il
promittente dovrà allora restituire quanto il
promissario abbia perduto, riequilibrando
gl’interessi economici sottesi alla conclusione
della complessiva operazione negoziale, cui la
promessa accede.
In concreto, l’adesione alla tesi secondo cui
l’indennizzo ha funzione propriamente
risarcitoria comporterà che la determinazione
del quantum debetur avvenga alla stregua degli
articoli 1223 ss. cod. civ. L’assunto secondo
cui l’indennizzo ex art 1381 cod. civ. ha
funzione di riequilibrio degl’interessi coinvolti nel più
ampio assetto negoziale in cui s’inserisce la promessa,
implicherà che il corrispettivo pagato per la
stipula della promessa e gl’interessi maturati
665
su tale somma circoscrivano il pregiudizio
indennizzabile subito dal promissario589; ove
mai nessun esborso abbia effettuato il
promissario, ma costui sia stato indotto, sulla
base della promessa del fatto del terzo, alla
stipulazione di un certo negozio (ad esempio
una compravendita), che altrimenti non avrebbe
concluso, il promittente dovrebbe essere
obbligato a corrispondere al promissario il
“minor valore che costui ha ottenuto nel
negozio garantito”590, rispetto al sacrificio
che ha affrontato591.589 A. CHECCHINI, La promessa del fatto del terzo, cit., p. 422, sostiene
tuttavia che dovrebbe comunque essere fatta salva la prova di un
maggior danno subito dal promissario. Se l’A. intendesse riferirsi
alla prova del lucro cessante, la tesi della funzione restitutoria
inevitabilmente finirebbe per cadere, assimilandosi all’opinione
secondo cui nessuna differenza esiste tra la somma dovuta a titolo
di risarcimento e quella a titolo di indennizzo. Sembrerebbe
allora che il danno “indennizzabile” debba essere pur sempre il
danno emergente.590 A. CHECCHINI. La promessa del fatto del terzo, cit., p. 422.591 Per esempio il promissario acquista un immobile senza la
porzione di terreno che il terzo si è rifiutato di vendere; oppure
666
Qualora poi il sacrificio affrontato dal
promissario non consenta una valutazione
oggettiva del pregiudizio subito, il giudice
dovrebbe procedere ad una valutazione secondo
equità.
In sostanza, l’asserita causa di scambio tra la
controprestazione del promissario e
l’assunzione del rischio da parte del
promittente comporterà che, avendo il
promissario accettato i termini del contratto
in vista del compimento del fatto del terzo,
garantito dal promittente, costui dovrà
<<riequilibrare i termini dello scambio
attraverso l’indennizzo>>, in ogni caso che il
fatto del terzo non venga compiuto.
il promissario ha acquistato un immobile senza la licenza di
abitabilità, che la P.A. non ha concesso.
667
La pretesa equivalenza economica tra
l’ammontare dell’indennizzo ed il fatto
promesso sarà solo eventuale e ricorrerà
precisamente quando il sacrificio patrimoniale
affrontato del promissario sia pari al valore
economico della prestazione attesa dal terzo.
Va infine ricordata un’importante conseguenza
di ordine processuale derivante dalla
distinzione tra indennizzo ex art. 1381 cod.
civ. e risarcimento del danno: sarà
inammissibile, per diversità di causa petendi, la
proposizione per la prima volta in appello
della domanda d’indennizzo, laddove in primo
grado sia stato richiesto il risarcimento del
danno592.
592 Così Cass., 5 settembre 1997, n. 8614, in Studium iuris , 1998, p.
190.
668
Sezione seconda: Promessa del fatto del terzo e
garanzia del credito.
1. Configurabilità di una promessa dell’altrui adempimento.
Un’ipotesi accettabile?
Secondo un orientamento dottrinale593,
confermato da talune decisioni
giurisprudenziali594, sarebbe configurabile una
promessa del fatto – adempimento del terzo, già
debitore del promissario sulla base di un
pregresso rapporto obbligatorio. Un argomento
testuale a favore di tale assunto595 si è tratto
dalla lettera stessa dell’art. 1381 cod. civ.
che, facendo riferimento alla promessa
dell’obbligazione o del fatto del terzo,
593 E. BRIGANTI, op. cit., p. 138 ss.594 Trib. Milano, 10 maggio 1979, in Banca, borsa, tit, cred., 1981, II,
p. 88; Trib. Milano 1 dicembre 1983, in Banca, borsa, tit. cred., 1984,
II, p. 383.595 Lo spunto non recente è di MESSINEO, Il contratto in genere, cit., p.
98.
669
consentirebbe di contemplare come oggetto della
promessa anche il fatto - adempimento del
terzo, cui costui sia già tenuto in virtù di un
rapporto obbligatorio con il promissario596.
Sulla base di tale premessa e di un’asserita
omogeneità funzionale tra indennizzo e
risarcimento 597 si è sostenuto598 che attraverso
la promessa del fatto del terzo si può
garantire il promissario – creditore “contro il
rischio dell’inadempimento” del terzo – debitore. In
quest’ottica la fattispecie ex art. 1381 cod.
civ. avrebbe una medesima valenza “di genere”
596 Di contrario avviso F. NAPPI, op. cit., p. 162 ss. Afferma l’ A.:
<<nel substrato tipologico della promessa del fatto altrui,
codificato nell’art. 1381 c. c., la promessa del fatto –
adempimento (…) riveste un ruolo tutt’altro che caratterizzante.
Ed anzi sembrerebbe non azzardato affermare che i confini
concettuali della figura ricevono nel’ottica tipologica una
restrizione che tende ad escludere proprio le ipotesi di promessa
del fatto – adempimento (…)>>.597 E. BRIGANTI, op. cit., p. 186 ss.598 A. e op. ult. cit., p. 192 ss.
670
rispetto alla fideiussione, operando come
strumento di garanzia del credito, ma un
diverso contenuto.
La fideiussione, com’è noto, assicura al
creditore un ampliamento delle probabilità di
ricevere soddisfazione dell’interesse
creditorio dedotto nel rapporto principale,
potendo il titolare di una situazione
soggettiva attiva pretendere l’adempimento di una
prestazione identica a quella dovuta dal debitore
principale; la funzione specifica della
promessa consisterebbe invece nella riparazione
successiva del danno, assumendo il promittente il
rischio del mancato adempimento e garantendo,
per tal caso, il pagamento dell’indennizzo.
Mentre il fideiussore in altri termini si
obbliga a far conseguire al creditore la stessa
671
prestazione che quest’ultimo si attende dal
debitore, il promittente si obbligherebbe a far
conseguire al promissario il conseguimento di
un’utilità vicaria (l’indennizzo), per il caso che il
debitore non adempia il suo obbligo599.
L’assunto presuppone che l’ammontare
dell’indennizzo sia pari al valore economico
del fatto promesso, conclusione che si è intesa
rigettare, alla luce della considerazione
dell’assetto d’interessi sotteso all’operazione
negoziale cui la promessa accede.
Quanto poi alla natura dell’obbligazione
garantita attraverso le due diverse forme di
garanzia, è noto che la fideiussione presuppone
la fungibilità della prestazione garantita.
Pertanto, in caso di prestazione infungibile
(ad esempio quella dell’appaltatore), secondo
599 A. e op. ult. cit., p. 193.
672
la tesi in parola, il creditore non potrà
garantirsi l’adempimento, dato che questo potrà
essere effettuato dal solo debitore principale,
ma potrà “assicurarsi” (attraverso la
stipulazione della promessa del fatto –
adempimento del terzo) il risarcimento del
danno conseguente all’inadempimento600.
Alla luce di siffatta ricostruzione la
fideiussione potrà a ragione definirsi garanzia
preventiva - d’adempimento; la promessa del fatto
del terzo, garanzia successiva - indennitaria.
La diversa funzione esplicata giustificherebbe,
poi, le peculiarità di disciplina dei due
distinti negozi. Il fideiussore garantisce
l’esecuzione dell’obbligo altrui e pertanto è
obbligato in solido (eccetto diversa
pattuizione) ed è obbligato ad eseguire la600 A. e op. ult. cit., p. 195.
673
medesima prestazione del debitore principale;
potrà opporre tutte le eccezioni che può
opporre il debitore principale, tranne quella
derivante dall’incapacità; si surroga nei
diritti che il creditore aveva verso il
debitore principale.
Il promittente garantirebbe invece il
promissario contro il rischio del verificarsi
dell’inadempimento; qualora esso si verificherà
dovrà l’indennizzo. A differenza del
fideiussore, poi, non avrebbe a disposizione
nessuna azione verso il debitore principale ed
in particolare né quella di regresso, né quella
di arricchimento601.
Quanto a quest’ultimo punto sembra evidente
che, avendo il promittente adempiuto l’obbligo
del debitore principale, seppure per601 Così espressamente A. e op. ult. cit., p. 78.
674
equivalente, dovrà ritenersi che gli spetti
anzitutto l’azione di arricchimento, per
essersi il debitore indebitamente avvantaggiato
dell’estinzione del proprio debito. Per quanto
concerne invece la spettanza dell’azione di
surrogazione, si è opportunamente rilevato602,
sulla base di una revisione interpretativa dell’art.
1203 n. 3, che l’azione di surrogazione spetta
anche a chi, pur non essendo debitore dello
specifico obbligo adempiuto verso il creditore,
sarebbe comunque costretto a sopportare il peso
economico dell’altrui inadempimento e perciò
potrebbe avere interesse al pagamento per
evitare quella conseguenza603. L’interesse a
pagare il debito (ovviamente sul presupposto
della fungibilità della prestazione dovuta),
piuttosto che versare l’indennità, potrebbe602 B. GRASSO, Saggi, cit., p. 177 ss.603 A. e op. ult. cit., p. 123.
675
sorgere quando, per vicende sopravvenute,
questa sia divenuta più gravosa di quello604.
Pertanto dovrà ritenersi che, trovandosi il
promittente in quella relazione qualificata che
consente l’operatività del meccanismo della
surrogazione (il non essere il promittente
debitore dello specifico obbligo fungibile
adempiuto, avendo però interesse ad adempierlo per
evitare le conseguenze pregiudizievoli
dell’inadempimento del debitore principale),
spetterà anche a lui, come al fideiussore,
l’azione di surrogazione.
Prescindendo da tali considerazioni, se è ben
chiaro il pensiero dell’Autore sopra citato605,
sembrerebbe che questa costruzione della
promessa dell’adempimento del terzo nasca dalla
604 Così B. GRASSO, op. ult. cit., p. 182.605 E. BRIGANTI, Fideiussione e promessa del fatto del terzo, cit., p. 186 ss.
676
necessità sistematica di prospettare uno
strumento negoziale che “garantisca
l’adempimento” di un’obbligazione avente ad
oggetto una prestazione infungibile,
attribuendo al beneficiario il diritto di
ottenere l’equivalente pecuniario della
prestazione garantita, senza che l’obbligazione
del garante sia sospensivamente condizionata
all’infruttuosa escussione del patrimonio
principale (ipotesi, questa, che ricade nella
fattispecie della fideiussio indemnitatis). In altri
termini, volendo fornire un’interpretazione orientata
sulle linee di politica del diritto che si possono
rinvenire nello studio da ultimo citato606, si
potrebbe rilevare che l’esigenza che muove la
prospettazione della configurabilità della
promessa del fatto del terzo come strumento di
606 Cfr. E. BRIGANTI, op. cit., par. 10 e 11.
677
garanzia dell’adempimento, sia quella di
rinvenire una figura di garanzia
dell’obbligazione a contenuto infungibile, in
cui il fideiussore sia direttamente obbligato a
pagare l’equivalente economico di quanto dovuto dal
debitore principale. Tale strumento di garanzia
sarebbe certamente più conforme alle esigenze
di celerità che devono presidiare la tutela del
credito.
Sennonché questa complessa ed arguta
ricostruzione pone, in primis, un problema di
compatibilità con i risultati cui sono
pervenute la giurisprudenza di legittimità e la
dottrina più recenti, concernenti la
configurazione di un doppio obbligo in capo al
promittente, con conseguente distinzione
dell’obbligo di risarcire il danno (che nasce
678
quando il promittente non si adopera in modo
conforme a quanto promesso) e di pagare
l’indennizzo (obbligo che nasce quando,
nonostante l’impegno profuso in tal senso, il
terzo non compie il fatto promesso). L’ostacolo
maggiore sarebbe rappresentato dalla
individuata funzione restitutoria del pagamento
dell’indennizzo, la quale escluderebbe che tale
rimedio possa attribuire al promissario
l’equivalente economico del fatto promesso e
pertanto il valore monetario della prestazione infungibile
rimasta ineseguita.
679
Si è sostenuto607, d’altro canto, che il tipo
normativo608 avuto presente dal legislatore
quando ha dettato la norma in tema di promessa
del fatto del terzo non era quello della
promessa del “fatto adempimento”. Una lettura
tipologica dell’istituto609 dovrebbe condurre,
607 F. NAPPI, op. cit., p. 162 ss.; ma vedi anche A. MAZZONI, Le lettere di
patronage nelle procedure concorsuali, cit., p. 393, secondo cui
<<l’originaria configurazione storica dell’istituto può indurre a
dubitare che, pur a fronte dell’attuale, molto ampia formula
dell’art. 1381, esso possa essere applicato anche all’ipotesi in
cui preesista o venga assunta un’obbligazione da parte del terzo
verso il promissario e il fatto promesso consista proprio
nell’esecuzione (adempimento) di quest’obbligazione>>.608 La locuzione rinvia al fondamentale studio sul tema: DE NOVA, Il
tipo contrattuale, in AA. VV., Tipicità e atipicità dei contratti, cit., p. 33 ss.609 Il metodo tipologico esclude l’applicabilità integrale della
disciplina legale ad un contratto che è <<sussumibile nel tipo
legale, quale risulta dalla disciplina legislativa, ma non
corrisponde al tipo normativo che il legislatore aveva presente
quando ha dettato la corrispondente disciplina. Poiché
determinante non è che un contratto possa essere sussunto nella
definizione, bensì che esso corrisponda al tipo normativo tenuto
presente dal legislatore, il ricorso al metodo tipologico avrà una
funzione deterrente da applicazioni errate, servirà cioè ad
evitare che si applichino norme di legge al di fuori dei casi cui
si attagliano>>. Così testualmente A. e op. loc. ult. cit.
680
così, ad espungere dai confini della figura le
ipotesi di promessa del fatto – adempimento del
terzo, con la conseguente esclusione della
possibilità per il promittente di addossarsi i
rischi connessi al mancato verificarsi del
fatto - adempimento.
La promessa del fatto del terzo in quest’ottica
sembra “naturalmente” procedere su binari
diversi da quelli della garanzia indennitaria
del credito. Quest’esigenza è invece perseguita
nella prassi attraverso l’elaborazione di nuove
figure di garanzia, che assicurano la soddisfazione
dell’interesse del creditore ad essere protetto
dai rischi dell’inadempimento, perseguendo per via
atipica quell’esigenza di assicurare una forma
indennitaria di tutela, per il caso che l’obbligo del
debitore avente ad oggetto una prestazione
681
infungibile non sia adempiuto (ad esempio
attraverso le c.d. polizze fideiussorie prestate a
garanzia delle obbligazioni dell’appaltatore).
Anzi si può asserire che la menzionata
necessità -sottesa alla costruzione della
promessa del fatto del terzo come garanzia
indennitaria- di assicurare al creditore una
forma di tutela più celere della fideiussio
indemnitatis, per essere questa subordinata
all’escussione automatica del debitore
principale, sarà ancor meglio perseguibile
attraverso le forme di garanzia c.d. autonoma
che la prassi va elaborando, per essere in tali
ipotesi inopponibili in sede di escussione
della garanzia le eccezioni fondate sul
rapporto principale.
682
2. La promessa del fatto del terzo come possibile strumento
per garantire il creditore contro i rischi atipici del
contratto?
L’autonomo significato della fattispecie in
esame potrebbe prospettarsi, invece, quando si
prometta che il terzo terrà fede agli impegni
assunti, nonostante l’invalidità o successiva
inefficacia del contratto in base al quale il
terzo è obbligato verso il creditore –
promissario610. In tal caso l’obbligazione del
promittente verrebbe ad assumere carattere di
autonomia rispetto a quella che lega il terzo
al promissario.
Il problema, in via preliminare, è se sia
concepibile garantire quanto dovuto dal
610 Secondo SEGNI, La lettre de patronage, cit., p. 155 ss., solo in
quest’ipotesi sarebbe prospettabile una promessa del fatto del
terzo, mentre laddove si prometta il fatto – adempimento si
ricadrebbe nell’ipotesi della fideiussione.
683
debitore principale, pure in ipotesi di
nullità, annullabilità, risoluzione del
contratto principale, attribuendo al
“creditore” il diritto di escutere la garanzia
pure per il caso che non abbia diritti da far
valere sulla base del rapporto principale. È
evidente, in primo luogo, che nell’ipotesi
prospettata ricorrerebbe una figura atipica di
garanzia, presupponendo i contratti tipici di
garanzia un valido ed efficace rapporto - base,
alla cui stregua il garante possa dirsi
obbligato ad eseguire quanto dovuto dal debitore
principale.
Alla luce dell’art. 1322 cod. civ. bisognerà
stabilire, pertanto, se un tale contratto sia
funzionale a realizzare interessi meritevoli di
tutela. Al riguardo si dovrebbe dire che, se la
684
ragione della promessa di garanzia sia da
rinvenire in un interesse proprio di colui che
assume il rischio dell’invalidità o inefficacia
del contratto, al fine d’indurre il contraente
a concludere un certo affare, o a compiere un
certo atto (magari nei confronti del debitore
garantito), tale promessa costituirà uno
strumento utile ad incentivare lo svolgimento
dei rapporti d’affari, laddove il promissario,
per ragioni di prudenza, sarebbe indotto a non
compiere “il fatto” occasionato dalla promessa
di garanzia, non avendo sicurezza di essere
manlevato per l’ipotesi di rischi atipici del
contratto. Una tale forma contrattuale
realizzerà, quindi, da un lato, l’interesse del
promittente alla conclusione di un certo
affare; dall’altro, l’esigenza di sicurezza del
promissario.
685
La possibilità che il garante sia tenuto ad
eseguire la prestazione di garanzia per il caso
che il creditore non abbia diritti da far
valere alla stregua del rapporto principale,
presuppone, però, che si possa individuare una
causa autonoma del contratto di garanzia, ossia
indipendente rispetto al rapporto che s’intende
garantire. La dottrina formatasi in materia di
contratto autonomo di garanzia sottolinea il
ruolo causale dell’interesse che muove un
soggetto a rilasciare la garanzia. In questa
prospettiva la causa non è concepita come funzione
economico – sociale del contratto, ma come ragione sufficiente
a giustificare lo spostamento patrimoniale a carico del
garante611.
Si è prospettata in dottrina la possibilità che
la garanzia di assunzione dei rischi atipici
611 Sul punto v. retro, par. 11, capitolo terzo.
686
del contratto-base sia prestata attraverso la
promessa del fatto del terzo, qualora a questa
figura tipica si riconosca la natura di
promessa di garanzia612. Lo stesso A. cui si
deve tal ipotesi applicativa avverte, tuttavia,
che, qualora si ritenesse che la fattispecie ex
art. 1381 non determini una responsabilità a
titolo di garanzia, all’attribuzione in parola
andrebbe in ogni caso riconosciuto il carattere
dell’atipicità613.
Attraverso la promessa di assunzione dei rischi
atipici del contratto non viene promesso il
fatto – adempimento del debitore principale, ma
un vero e proprio “fatto” del terzo, poiché se
è invalido o risolto il contratto che vedeva
obbligato il terzo nei confronti del
promissario, l’esecuzione della prestazione non612 F. NAPPI, op. cit., p. 156.613 A. e op. loc. ult. cit.
687
potrà qualificarsi come adempimento,
presupponendo tale fenomeno un obbligo
giuridicamente vincolante.
In quest’ottica l’evento promesso verrebbe in
considerazione come mero fatto nel suo oggettivo
accadimento, a prescindere da una
giustificazione fondata sul rapporto tra terzo
e promissario.
Al riguardo si può fare la seguente
considerazione: la figura disciplinata
dall’art. 1381 cod. civ. è muta circa la
propria causa; dunque se si ravvisasse
nell’interesse del promittente a promuovere una
certa iniziativa del promissario la causa
dell’attribuzione patrimoniale del promittente
(o detto altrimenti la causa dell’assunzione
dell’onere economico del rischio), avremo la
riproposizione dello schema negoziale in cui lo
688
Stammler614 inquadrava quei contratti di
garanzia che, non essendo accessori ad
un’obbligazione principale, trovavano la loro
fonte in un atto di autonomia privata,
prescindendo dal rapporto con altra
obbligazione principale e generando
un’obbligazione autonoma del promittente615,
causalmente fondata sull’interesse di
animazione di costui. Tali contratti erano
nella prassi del tempo utilizzati appunto per
garantire un risultato utile al beneficiario
anche in ipotesi d’invalidità o addirittura
inesistenza del contratto principale.
La giustificazione causale di una tale promessa
andrà rinvenuta nello scambio tra la prestazione
cui è tenuto il promissario ed il sacrificio
614 Studioso tedesco cui si deve la teorizzazione dei contratti
autonomi di garanzia.615 V. retro par. 2 cap. 3.
689
cui il garante si espone prestando la garanzia.
La locuzione “contratto di garanzia” starà qui
ad indicare non la causa del negozio (causa
cavendi), bensì la funzione della prestazione
posta in essere dal garante, volta alla
protezione dell’interesse del beneficiario a
non subire detrimento per la conclusione di un
certo affare.
In tal caso si avrebbero due distinti rapporti:
quello principale e quello di garanzia. Le
uniche eccezioni opponibili al beneficiario da
parte del garante saranno quelle fondate sul
contratto di garanzia e sul rapporto garante-
beneficiario: a) eccezioni letterali; b)
eccezioni attinenti all’invalidità o
inefficacia del contratto di garanzia; c)
eccezioni dirette e personali. Il promittente
non potrà far valere eccezioni fondate sul
690
rapporto principale, salvo che le ragioni che
determinano l’invalidità del rapporto
principale si riverberino direttamente sul
rapporto di garanzia616.
Resta comunque fermo che, ormai per esperienza
ultradecennale, non è questa la ricostruzione
della fattispecie ex art. 1381 proposta dalla
S. C. e pertanto una tal forma contrattuale si
esporrebbe ad una possibile interpretazione
giudiziale non conforme agl’interessi
perseguiti dalle parti. Non vi dovrebbe essere
ragione, tuttavia, per negare la
configurabilità di una figura atipica di
garanzia, attraverso cui s’intendano coprire i
rischi atipici del contratto.
616 Sul punto v. retro par. 20, capitolo terzo.
691
INDICE DEGLI AUTORI CITATI
A
ALCARO F., Promessa del fatto del terzo, in Enc. dir.XXXVII, s.d., ma Milano 1988.
ALLARA M., Natura giuridica dell’obbligazione del fattoaltrui, in Riv. dir. comm., 1929, I.
ARU L., Della fideiussione, in Comm. cod. civ. direttoda d’Amelio e Finzi, Libro delle obbligazioni, II, 2,Firenze, 1948.
B
BARASSI L., La teoria generale delle obbligazioni, II,Milano, 1946.
BARBERO D., Sistema istituzionale del diritto privatoitaliano, II, Torino, 1949.
BARBIERA L., Garanzia del credito e autonomia privata,Napoli, 1971.
BETTI E., Il concetto della obbligazione costruito dalpunto di vista dell’azione, Pavia, 1920.
BIANCA C. M., Il divieto del patto commissorio, Milano,1957.
BISCONTINI G., Solidarietà fideiussoria e “decadenza”,Napoli, 1980.
BO F., Fideiussione (dir. civ.), in Nuovo Digesto.italiano, V, Torino, 1938.
BO G., Garanzia, in Noviss. Dig. it., VI, Torino, 1938.
692
BONELLI F., Le garanzie bancarie a prima domanda nelcommercio internazionale, Milano, 1991.
BOZZI G., L’autonomia negoziale nel sistema dellegaranzie personali, Napoli, 1990.
BOZZI G., La fideiussione, le figure affini el’anticresi, in Tratt. dir. priv. Rescigno, 13, Torino,1985.
BOZZI G., Le garanzie atipiche, vol. I, Garanziepersonali, Milano, 1999.
BRIGANTI E., Fideiussione e promessa del fatto delterzo, Napoli 1981.
BUSNELLI F. D., L’obbligazione soggettivamentecomplessa: profili sistematici, Milano, 1974.
BUSNELLI F. B., Della tutela dei diritti, inCommentario del codice civile, Libro VI, Tomo IV,Torino, 1964.BUTTARO L., L’interesse nell’assicurazione, Milano,1954.
C
CAMPOBASSO G. F., Coobbligazione cambiaria esolidarietà diseguale, Napoli 1974.
CARNELUTTI F., Lezioni di diritto processuale civile.Processo di esecuzione, Padova, 1929, I.
CARRESI F, Corso di diritto civile sul contratto,Bologna, 1961.
CASTIGLIA G., Promesse unilaterali atipiche, in Riv.dir. comm., 1983, I.
693
CHECCHINI A., La promessa del fatto del terzo, inTrattato di diritto privato a cura di Mario Bessone,volume XIII, Torino, 2002.
A. CHECCHINI, Indennizzo e risarcimento nella promessadel fatto altrui, in Riv. dir. civ., 1999, I.CHERUBINI M.C., La promessa del fatto del terzo, Milano1992.
CICALA R., Saggi sull’obbligazione e le sue vicende,Napoli, 2001.
CICALA R., Concetto di divisibilità ed indivisibilitàdelle obbligazioni, Napoli, 1953.
CICALA R., Il negozio di cessione del contratto,Napoli, 1962.
COMPORTI M., Esposizione al pericolo e responsabilitàciv., Napoli, 1965.
CORRIAS P., Garanzia pura e contratti di rischio,Milano, 2006.
D
D’AMELIO M., Dell’anticresi, in Comm. cod. civ.D’Amelio e Finzi, Libro delle obbligazioni, II,Firenze, 1949.
DE NICTOLIS R., Nuove garanzie personali e reali,Padova, 1998.
DE NOVA G., Il tipo contrattuale, Padova, 1974.
DE SANNA P., Accessorietà ed autonomia ne sistema dellegaranzie a prima richiesta, Milano, 1988.
DI SABATO, Fideiussione e negozi d’assunzione deldebito altrui: criteri d’interpretazione, in Riv. dir.civ., 1961, II.
694
DI SABATO, L’assuntore del concordato fallimentare,Napoli, 1960.
DONATI, Trattato del diritto delle assicurazioniprivate, II, Milano, 1954.
DONISI, Il problema dei negozi giuridici unilaterali,Napoli, 1972.
F
FAUCEGLIA G., I contratti bancari, in Trattato didiritto commerciale, diretto da V. Buonocore, III – 2,Torino, 2005.
FRAGALI M., Fideiussione – mandato di credito, in Comm.cod. civ. a cura di Scialoja e Branca, Libro IV, Delleobbligazioni, art. 1936 – 1959, Bologna – Roma, 1968.
FRAGALI M., Fideiussione, (dir. priv.), in Enc. dir.,XVII, Milano, 1968.
FRAGALI M., Garanzia, in Enc. del dir., Vol. XVIII,Milano, 1969.
FRAGALI M., L’anticresi, in Comm. cod. civ. Scialoja eBranca, Bologna-Roma, 1974.
G
GALEOTTI S., La garanzia costituzionale (presupposti econcetto), Milano, 1950.
GIORGIANNI F., I crediti disponibili, Milano, 1974.
GIOVENE A., Il negozio giuridico rispetto ai terzi,Torino, 1917.
GRASSO B., L’interesse del fideiussore tutelatodall’art. 1945 cod. civ., in Rass.dir. civ., 1980.
GRASSO B., Saggi di diritto civile, Napoli, 1989.
695
L
LENER A., <<Expressio causae>> e astrazione processuale.Note preliminari ad uno studio sistematicosull’astrazione, in Studi in onore di F. SantoroPassarelli, III, Napoli, 1972.
LOBUONO M., Contratto e attività economica nellegaranzie personali, Napoli, 2002.
M
M. BIANCA C., Diritto civile, 3, Il contratto, Milano,2000.
MAJELLO U., Contratto a favore di terzo, in Dig. disc.priv., sez. civ., IV, Torino, 1989.
MARELLA M.R., Promessa del fatto del terzo, in Dig.disc. priv., XXV, Torino, 1997.
MASSIDDA C. F., Fideiussione, in Enc. giur. Treccani,XIV, Roma, 1988.
MASTROPAOLO F.- CALDERALE A., Fideiussione e contrattidi garanzia personale, in AA.VV., I contratti digaranzia, a cura di F. Mastropaolo, I, in Trattato deicontratti, diretto da P. Rescigno e E. Gabrielli,Torino, 2006.
MASTROPAOLO F., I contratti autonomi di garanzia,Torino, 1995.
MASTROPAOLO, Promessa del fatto altrui, garanziepersonali e sindacati di voto, in Riv. Dir. Comm.,1992, I.
MAZZONI A., Lettere di patronage, Milano 1986.
MESSINEO F., Dottrina generale del contratto, Milano1948.
696
MESSINEO F., Il negozio giuridico plurilaterale, inStudi di diritto delle società, Milano, 1949.
MESSINEO F., Operazioni di borsa e di banca, Milano,1954.
MESSINEO, Il contratto in genere, in Trattato didiritto covile e commerciale, diretto da CICU eMESSINEO, XXI, t. 2., Milano, 1972.
N
NAPPI F., La garanzia autonoma, Profili sistematici,Napoli 1992.
NICOLO’ R., L’adempimento dell’obbligo altrui, inScritti, II, Milano, 1980.
P
PACCHIONI G., La promessa del fatto di un terzo, inRiv. Dir. Comm. 1911, II.
PASTORI F., Profilo dogmatico e storicodell’obbligazione romana, Milano, 1951.
PERLINGIERI P., Profili istituzionali del dirittocivile, Napoli, 1979.
PERLINGIERI, Introduzione alla problematica dellaproprietà, Camerino – Napoli, 1970.
PERSICO G.; Anticresi (Diritto civile), in Enc. dir.,II, Milano, 1958.
PIAZZA L, Garanzia I) Diritto civile, in Enc. giur.Treccani, Vol. XIV, Roma, 1989.
PONTIROLI L., Le garanzie autonome e il rischio delcreditore, Padova 1992.
697
PORTALE G.B., Fideiussione e Garantieverträge nellaprassi bancaria, in AA. VV, Le operazioni bancarie, acura di Portale, Milano, 1978, II.
PORTALE G.B., Fideiussione e Garantieverträge nellaprassi bancaria, in AA. VV., Nuovi tipi contrattuali etecniche di redazione nella pratica commerciale,Profili comparatistici, a cura di P.Verrucoli, Milano,1978.
PORTALE G.B., Le garanzie bancarie internazionali,Milano, 1989.
PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile,Napoli, 2006.
PUGLIESE G., Giudicato civile (dir. vig.), in Enc.dir., XVIII, Milano, 1969.
R
RAVAZZONI A., La fideiussione, Milano 1957.
REDENTI E., Fideiussione, in Dizionario pratico deldiritto privato, diretto da Scialoja, De Ruggiero eBonfante, III, Milano, 1923.
RESCIGNO, Obbligazioni (diritto privato) A) Nozionigenerali, in Enc. dir. XXIV, Milano, 1979.
ROCCHIO F., La promessa con funzione di garanzia,Napoli 2009.
RODOTA’, Espromissione, in Enc. dir., XV, Milano, 1966.
RUBINO D., La responsabilità patrimoniale, Torino,1956.
RUBINO D., La compravendita, Milano, 1962.
698
RUGGERI L., La fideiussione, in Trattato di dirittocivile del consiglio nazionale del notariato, direttoda P. Perlingieri, Napoli, 2005.
S
SACCO R.- DE NOVA G., Il contratto, II, in Trattatodiritto civile, diretto da R. Sacco, Torino, 2004.
SACCO, Il contratto, in Trattato di diritto civileitaliano, diretto da Vassalli, VI, t. 2°, Torino, 1975,I.
SALANDRA V., Assicurazione, Comm. al cod.civ. a cura diScialoja e Branca, p. 228, Roma – Bologna, 1948.
SALVESTRONI U., La solidarietà fideiussoria , Padova,1977.
SCALFI G., La promessa del fatto del terzo, MilanoVarese, 1955.
SCARLATA FAZIO M., Il contratto di anticresi, in Studiin memoria di Antonino Giuffrè, II, Milano, 1967.
SCHINNERER E.–AVANCINI P., Bankverträge, III, Wien,1976.
SESTA M., Interesse, causa e motivi nella stipulazionea favore di un terzo, in Studi in memoria di G. Gorla,III, Milano, 1994.
STAMMLER, Der garantievertrage, in Arch. Civ. priv.Prax 69, 1886.
STOLFI G., Natura giuridica dell’assicurazionecauzioni, in Ass., 1958, I.
STOLFI G., La promessa del fatto di un terzo, in Riv.Dir. comm., 1927, I.
699
T
TALAMANCA M., Fideiussione, in Enc. dir. (partestorica), vol. XVII, Milano, 1968.
TEDESCHI V., Anticresi, in Noviss. dig. it., Torino,1968, I.
TEDESCHI V. e ALPA G., Il contratto nel diritto nord-americano, Milano 1980.
TETI R., Dell’apertura di credito bancario, in Ilcodice civile. Commentario / fondato e già diretto daP. Schlesinger / continuato da F. D. Busnelli, Milano,2005.
TRABUCCHI A., Istituzioni di diritto civile, Padova1998.
TRIMARCHI, Rischio e responsabilità oggettiva, Milano,1961.
Z
ZARRELLI A., Fungibilità ed infungibilitànell’obbligazione, Napoli, 1969.
ZUDDAS G., Anticresi, in Enc. giur. Treccani, I, Roma,1988.
700
INDICE DELLE SENTENZE CITATE
Cass., Sez. Unite, 18 febbraio 2010, n. 3947, inallegato.
Cass., 3 marzo, 2009, n. 5044, in Giust. civ. Mass.2009, 3. ID. in De iure, banca dati on line, Giuffrè.
Cass., 13 maggio 2008, n. 11890, in De iure, banca dation line, Giuffrè.
Cass., 31 gennaio 2008, n. 2377, in De iure, banca dation line, Giuffrè.
Cass., 27 giugno 2007, n. 14853, in Mass. foro it.2007.
Cass., 28 febbraio 2007, n. 4661, in Mass. foro it.2007.
Cass., 14 febbraio 2007, n. 3257, in Foro it. 2007, I.
Cass., 27 maggio 2002, n. 7712, in Danno e resp., 2002.
Cass. 10 maggio 2002, n. 6728, in Giust. civ., 2003, I.
Cass., 18 maggio 2001, n. 6823, in Foro it. 2001, I.
Cass., 1 ottobre 1999, n. 10864, in Banca, borsa, tit.cred., 2001, II.
Cass., 20 agosto 1998, n. 8248, in Mass. Giur. It.,1998.
Cass., 20 dicembre 1995, n. 12973, in Giur. It., 1997,I, 1.
Cass., 17 aprile 1993, n. 4552, in Giust. civ., 193, I.
Cass., sez. lav., 21 giugno 1991, n. 6984, in Rep Foroit., 1991.
701
Cass., 8 agosto 1988, n. 4871, in Banca borsa tit.cred., 1989, II.
Cass. sez. un., 1 ottobre 1987, n. 7341, in Foro it.,1988, I.
Cass. 24 gennaio 1986, n. 466, in Dir. fall., 1986, II.
Cass., 31 agosto 1984, n. 4738, in Banca borsa tit.cred., 1985, II.
Cass., 12 aprile 1984, n. 2369, in Foro it., 1985, I.
Cass., 27 novembre 1951, n. 2696, in Foro it. 1952, I.
Trib. Napoli, 20 marzo 1992, in Banca, borsa tit.cred., 1993, II.
Trib. Milano, 30 dicembre 1991, in Banca borsa tit.cred., 1992, II.
Trib. Venezia, 8 luglio 1991, in Foro it., 1992.
Trib. Monza, 6 febbraio 1989, in Rep. Foro it., 1989,I.
Trib. Urbino, 3 marzo 1952, in Rep. Foro it., 1953, I.
702