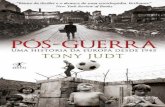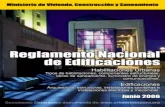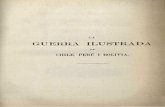La Guerra di Gradisca nella storiografia secentesca-parte III
Transcript of La Guerra di Gradisca nella storiografia secentesca-parte III
filologiacritica&
rivista quadrimestrale diretta dabruno basile, renzo bragantini, roberto fedi,
enrico malato, matteo palumbo, manlio pastore stocchidirettore responsabile: enrico malato
anno xxxiii • 2008
salerno editriceroma
Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 16065 del 13.10.1975L’annata viene stampata con un contributo
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Tutti i diritti riservati - All rights reserved
Copyright © 2008 by Salerno Editrice S.r.l., Roma. Sono rigorosamente vietati la ri pro duzione, la traduzione, l’adattamento, anche parziale o per estratti, per qual-sia si uso e con qualsiasi mezzo effettuati, compresi la copia fotostatica, il mi cro film, la memorizzazione elettronica, ecc., senza la preventiva autorizzazione scritta della
Salerno Editrice S.r.l. Ogni abuso sarà perseguito a norma di legge.
DirezioneBruno Basile, Renzo Bragantini, Roberto Fedi,
Enrico Malato, Matteo Palumbo, Manlio Pastore Stocchi
Direttore responsabileEnrico Malato
redazioneClaudio Gigante, Massimiliano Malavasi, Emilio Russo
161
CAPRIATA, ZILIOLI E LA GUERRA DI GRADISCA:MISERIA E GRANDEZZA
DELLA STORIOGRAFIA SECENTESCA
la guerra è soprattutto una gran confusione,sul campo e anche nella testa della gente: mol-te volte non si capisce neppure chi ha vinto echi ha perso, lo decidono poi dopo i generali equelli che scrivono i libri di storia.*
1. Pietro Giovanni Capriata
Un giorno per noi imprecisabile del 1638, presumibilmente in un qual-che palazzo signorile di Genova, il gentiluomo veneziano Andrea Balbi elo storico Pietro Giovanni Capriata1 si appartarono per un colloquio riser-
* P. Levi, Se non ora, quando?, in Id., Opere, Torino, Einaudi, 1988, vol. i pp. 183-517, a p. 194.1. Capriata, già citato dagli storici contemporanei (vd. V. Siri, Memorie recondite, Lyon,
Anisson et Posuel, vol. vii 1679, p. 118), e già canonizzato nella storiografia letteraria del suostesso secolo (vd. R. Soprani, Li scrittori della Liguria, Genova, Pietro Giovanni Calenzani,1667, rist. anast. Bologna, Forni, 1971, p. 242) e poi in quella successiva (G.B. Spotorno, Storialetteraria della Liguria, Genova, Tipografia Ponthenier, to. iii 1825, pp. 60-62), sarà tra le fontiprincipali del Muratori degli Annali d’Italia dal principio dell’era volgare sino all’anno 1749, to. xi.Dall’anno 1601 dell’Era Volgare sino all’Anno 1700, Milano, Pasquali, 1749 (con esplicite citazionialle pp. 40, 95, 116, 123, ecc.). Quando la scuola storica ottocentesca si metterà a rovistare trale carte degli archivi, ritroverà numerosi documenti che lo riguardano: si vedano i contributidi E. Ricotti, Della veracità di alcuni scrittori di storie italiane del secolo XVII, in Id., Storia dellamonarchia piemontese, Firenze, Barbera, vol. v 1869, pp. 363-73; A. Neri, Saggi storici intorno aPier Giovanni Capriata e Luca Assarino scrittori genovesi del secolo XVII, Genova, Tipografia delR. Istituto Sordo-muti, 1875, pp. 1-42; G. Claretta, Storia della reggenza di Cristina di FranciaDuchessa di Savoia, Torino, Stabilimento Civelli, 1869, pp. 489-91. Nel Novecento gli storici sisono confrontati con la sua testimonianza per valutare fatti e vicende dell’Italia del XVIIsecolo: vd. V. Vitale, Breviario della storia di Genova, Genova, Società Ligure di Storia Patria,1955, vol. i pp. 247 e 310; A. De Rubertis, La congiura spagnola contro Venezia nel 1618, secondo idocumenti dell’Archivio di Stato di Firenze, in «Archivio storico italiano», a. cv 1947, pp. 11-49; F.Nicolini, Don Gonzalo Fernández de Córdoba e la cosiddetta reponsabilità della guerra del Monferrato,in Italia e Spagna. Saggi sui rapporti storici, filosofici ed artistici tra le due civiltà, Firenze, Le Monnier,1941, pp. 193-244; Istruzioni e relazioni degli ambasciatori genovesi, vol. ii. Spagna (1619-1635), a curadi R. Ciasca, Roma, Ist. Storico Italiano per l’Età Moderna e Contemporanea, 1955, pp. 243-44 e 253. Da ultimo, oltre alla voce di M. Giansante per il Dizionario biografico degli italiani(Roma, Ist. della Enciclopedia Italiana, vol. xix 1976, pp. 195-97), è stata pubblicata e a luiattribuita una commedia in dialetto genovese (P.G. Capriata, Ra finta caritè: la carità perscherzo, intermezzo burlesco, a cura di F. Toso, Genova, Le Mani, 1996, su cui vd. le rec. di Q.
massimiliano malavasi
162
vato nel corso del quale Balbi rese noto al suo interlocutore il disagio, forseaddirittura il fastidio, che circolava negli ambienti politici e diplomaticidella Serenissima per i toni con i quali costui aveva raccontato le vicen-de della battaglia di Valeggio nella sua ultima fatica, l’attesa prima parte –finalmente completa in tutti i suoi capitoli – dell’Historia.2 Nella battagliadi Valeggio infatti, che risaliva ad otto anni addietro, le truppe veneziane,in marcia per andare al soccorso di Mantova assediata dagli imperiali, sierano praticamente dissolte prima ancora di combattere lasciando la popo-lazione alla mercé della furia delle truppe tedesche, in circostanze cheavevano rivelato la vigliaccheria dei soldati e l’incapacità operativa dei co-mandanti. Ma per la sensibilità veneziana, evidentemente, i colori del veroerano stati profusi da Capriata sulla pagina con toni un po’ troppo accesi,laddove la spiacevole e disonorevole vicenda avrebbe forse meritato un gu-sto cromatico piú sfumato, piú ombreggiato.
Questo si sarebbero detti Capriata e Balbi in quel colloquio secondoquanto ne riferisce lo storico genovese che accenna a quell’incontro nelladedica della seconda parte della sua Historia.3 Sennonché quelle doglienze(cosí le chiamava lo stesso autore) provate nelle interne stanze del potere
Marini, in R.L.I., num. 1 1997, pp. 313-14, e quella di S. Termanini, in «Drammaturgia.Quaderni», a. v 1998, p. 150).
2. Nel 1625 era uscito un primo specimen dell’opera: [P.G. Capriata,] I due primi libri dell’Istoriadi Pietro Giovanni Capriata Dottor di Leggi Sopra i movimenti d’Arme successi in Italia dall’Anno diN.S. mdcxiii fino al mdcxviii. Aggiuntivi i Sommari de gli altri quattro libri che mancano al com-pimento dell’opra, Genova, Per Giuseppe Pavoni, 1625 (d’ora in avanti Historia-Specimen 1625)poi ristampato Milano, Bidelli, 1627. Appunto, solo nel 1638 esce la prima parte completa:Dell’Historia di Pietro Giovanni Capriata libri dodici. Ne’ quali si contengono tutti i movimenti d’armesuccessi in Italia dal mdcxiii fino al mdcxxxiv, Genova, Pietro Giovanni Calenzano e Gio.Maria Farroni, 1638 (le pagine delle citazioni da questa edizione, che contiene il raccontooggetto dell’analisi, saranno indicate direttamente a testo dando per implicita l’edizione diriferimento); l’opera ebbe diverse ristampe: Ginevra, Chouet, 1639; Bologna, Monti-Zenero,1639; Genova-Torino, Cavalleris, 1640; Genova, Gamonet, 1641; Ginevra, Chouet, 1644. Solonel 1649 uscirà la seconda parte: Dell’Historia di Pietro Giovanni Capriata parte Seconda, in sei libridistinta, nel primo dei quali si contengono alcuni movimenti d’Armi fuor d’Italia succeduti e ne’ cinquesussequenti la continuazione di quei d’Italia dall’anno mdcxxxiii fino al mdcxliii, Genova, Chouet,1649 (d’ora in avanti: Historia, parte ii 1649), anch’essa con alcune ristampe: Genova, Farroni,1649, Venezia, Tomasini, 1649 e ancora Genova, Chouet, 1650. Postuma, a cura del figlio,uscí la terza parte: Dell’Historia di Pietro Giovanni Capriata parte terza ed ultima in sei libri distinta,ne quali si contengono tutti li movimenti d’Arme succeduti in Italia dall’anno mdcxli fin al mdcl, Ge-nova, Giovanni Ambrosio de Vincenti, 1663.
3. All’Illustriss. Signor Gio. Battista Raggio del Signor Francesco, in Capriata, Historia, parte ii1649, pp. 11-21 n.n., a p. 19 n.n. Non sarà certo un caso che tale speciosa apologia non compaianell’ed. Venezia, Tomasini, 1649.
capriata, zilioli e la guerra di gradisca
163
veneziano per il racconto del Capriata dovevano aver comportato dei maloriintestini assai dolorosi, con acidi e contorsioni, se è vero che un «personag-gio sanguinario» (ovvero un sicario professionista) si sarebbe presentato dilí a poco agli Inquisitori di Stato offrendosi di uccidere lo storico genovesein cambio della soppressione del bando che gravava sulla sua persona. Lascellerata offerta fu però rifiutata, a salvaguardia dell’onore e della generosi-tà della Repubblica, per l’intervento di Zaccaria Sagredo: costui, fratello diquel Giovanni tanto impegnato nei dialoghi scientifici a sostener le tesi delGalilei,4 era stato nientemeno che al comando dell’armata veneta cosí gof-famente dissoltasi proprio in conseguenza della sua sciagurata decisione diabbandonare la rocca fortificata della cittadina di Valeggio, e per il fatto erastato processato e condannato a pene suppergiú equiparabili ai nostri “ar-resti domiciliari” e all’“interdizione dai pubblici uffici” per ben dieci anni.5
Del racconto di Capriata sui vergognosi fatti di Valeggio, Sagredo era dun-que colui che ne faceva le spese maggiori e tuttavia proprio il nobiluomosi era opposto alla bieca offerta, ricusando la truce vendetta e perdonando, conaristocratica magnanimità, l’irrispettoso storico che, «come di Genovese», aveva«conceduto piú al livore che al debito». Non mancava però, evidentemen-te, di vantarsi del beau geste anni dopo in un colloquio con lo storico parmenseal servizio di Luigi XIV, quel Vittorio Siri al quale dobbiamo il racconto diquesto secondo retroscena.6
I due quadretti, cosí gustosi e cosí tipicamente secenteschi, incentraticome sono sul dialogo confidenziale tra lo storico e l’uomo di potere, ri-spondono piú al genio del secolo di quanto non sembrino assomigliare alvero delle historie, tuttavia – oltre, come mi piace presumere, a divertire gli
4. Si veda A. Favaro, Amici e corrispondenti di Galileo, Firenze, Salimbeni, 1983, vol. i p. 262.5. Sulla vicenda si veda S. Romanin, Storia documentata di Venezia (1858), Venezia, Libreria
Filippi Editore, vol. vii 1974, pp. 194-218. Naturalmente Sagredo, pur « inculpado di maladirezione», fu nominato già nel 1635 podestà di Padova, città che – ovviamente – condurràa inusitata prosperità (G.A. Capellari Vivaro, Il Campidoglio Veneto, Venezia, BibliotecaNazionale Marciana – d’ora in avanti BMV –, It. VII 15-18 [= 8304-8308], vol. iv c. 37v).
6. «Tale fu il successo di Valezzo di sí ingrata ricordanza a’ Veniziani che non ponnosoffrirlo ne’ suoi veri colori dipinto nell’Historia; onde abborrendone la narrazione in quelladel Capriata, come di Genovese che avesse conceduto piú al livore che al debito, si rinvennepersonaggio sanguinario che s’offrí a gl’Inquisitori di Stato di farlo ammazzare per redimerese stesso dal bando. Tra questi annoveravasi allora per primo quel Magistrato Zaccaria Sagredoche nel fatto di Valezzo reggeva il supremo comando dell’armata, e che trafitto e mal tratta-to, risentivasi di quelle Scritture; e nondimeno prevalendo in lui la grandezza d’animo, e lagenerosità della Repubblica, e sua al privato suo senso, rigettò ben lungi (come a noi recita-va) una sí atroce esibizione» (Siri, Memorie recondite, cit., p. 118).
massimiliano malavasi
164
studiosi contemporanei –, se proprio non raccontano eventi realmente ac-caduti, esprimono bene il valore e il significato che le Historie del Capriataassumevano nella realtà culturale e politica del tempo. Ma per compren-dere appieno quel significato dobbiamo cominciare con l’osservare che fuevidentemente la testimonianza del Siri a suggerire ai critici – al Neri perprimo –7 che l’ambasciatore veneziano Balbi si fosse lamentato proprio delracconto della battaglia di Valeggio: Capriata, di suo, non fornisce partico-lari cosí dettagliati ma si limita a ribattere alle accuse di livore antivenezianodichiarando genericamente e con certa spavalderia (assai poco condivisibile,come avremo modo di vedere) di aver parlato di Venezia e delle sue «guerretanto di mare quanto di terra» sempre inclinando nella piú «benigna inter-pretazione».8
Ma dal momento che nella guerra per la successione del ducato diMantova non risulta fosse impiegata quella marina militare veneziana (néin effetti è citata a riguardo nell’Historia) che sembra invece chiaramentechiamata in causa da quel riferimento alle «guerre di mare», si è indotti apensare che Andrea Balbi si fosse lamentato non tanto o non solo delracconto dei fatti di Valeggio che tanta infamia gettavano sul povero ZaccariaSagredo, ma che avesse soprattutto espresso le sue doglienze in merito alracconto che Capriata aveva proposto dell’altro fatto storico che coinvolge-va Venezia e che veniva narrato, questo sí con dispiego di pagine e di in-chiostro, dallo scrittore genovese, ovvero la guerra di Gradisca:9 una do-glienza invero assai piú probabile quando si considera che un parente di Bal-bi, tal Almerico – parente lontano ma pur sempre membro della casata –aveva avuto il comando della nave “di famiglia” (il Galeone Balbi) al tem-po delle battaglie in Adriatico.10
7. Neri, Saggi storici, cit., p. 12.8. Capriata, Historia, parte ii 1649, p. 19 n.n.9. Tanto piú che, a dirla tutta, la stessa presenza nell’Historia del Capriata di riferimenti a
vicende che vedevano il coinvolgimento della Serenissima sarebbe ben poca cosa qualo-ra volessimo ridurla al breve accenno ai fatti di Valeggio. Oltre al corposo resoconto dellaguerra di Gradisca si contano pochi altri brevissimi accenni a Venezia, naturalmente tutt’al-tro che lusinghieri, nel racconto delle vicende della rivolta dei Grigioni in Valtellina (pp. 374,404-6, 417, 460, 463, 472, 590) e dei complotti franco-piemontesi contro Genova (pp. 459 e518).
10. «Almerico Balbi, figliuolo di Giovanni, nel 1616 fu creato Capitano di un straordi-nario Galeone ne’ moti di guerra causati dal Duca di Ossuna Vice Re di Napoli » (Capella-
ri Vivaro, Campidoglio veneto, cit., vol. i c. 78r). Almerico fu accusato dall’inquisitore PietroFoscarini di non aver inseguito il nemico in circostanze favorevoli alla vittoria e, riconosciu-to colpevole, fu relegato a Zara per 3 anni e privato per sempre delle cariche marittime (vd.
capriata, zilioli e la guerra di gradisca
165
Quel conflitto infatti, che aveva opposto la Serenissima e l’Impero tra il1615 e il 1617, aveva visto combattere i fanti e i cavalieri veneziani e austriacisulle alpi carsiche, ma aveva altresí assistito agli inseguimenti e alle batta-glie navali nell’Adriatico tra la flotta della Serenissima e i galeoni del Ducadi Ossuna, viceré di Napoli, impegnatosi in un’azione di disturbo tesa adaiutare quella corona austriaca cosí strettamente legata al trono del suosignore, Filippo III di Spagna. Il conflitto era insorto per la questione degliUscocchi: con la definizione di “rifugiati” (dacché questo è il significatodella parola uskok in lingua croata)11 si indicavano gli abitanti di alcunipiccoli centri della costa dalmata meridionale i quali, sfuggiti all’avanzataturca, si erano riuniti in alcuni villaggi arroccati sulle scogliere del Quarnaro(in particolare a Senij) e da qui, utilizzando piccole ed agili imbarcazioni,avevano continuato per qualche decennio a compiere azioni di guerrigliaantiturca con l’appoggio e il sostegno dell’Impero, e in particolare di Graz,capitale dell’Innerösterreich, il distretto del quale erano sudditi. Ma poi,privi di sostegno economico e militare, si erano dati alla pirateria compien-do azioni, spesso efferate, sia contro le navi commerciali turche, sia – so-prattutto – contro i battelli della Domina dell’Adriatico, quella Venezia troppo“amica degli infedeli”, per non dire in verità semplicemente cosí ricca dacostituire un ghiotto boccone per una comunità di rifugiati progressiva-mente trasformatasi in un esercito di criminali e di predoni.
La Serenissima aveva piú volte protestato presso Praga per ottenere daparte di Graz degli interventi decisi per controllare i suoi pericolosi suddi-ti, ma le autorità austriache avevano tutto l’interesse a minare il diritto vene-ziano a controllare (anche con l’imposizione di tributi) quel mar Adriaticosul quale la città lagunare esercitava un dominio che veniva rivendicatoanche in virtú della capacità di garantirne la tranquilla navigabilità. La lun-ga serie di tensioni che sorsero tra Venezia e Graz vide un’accelerazionecon l’inizio del Seicento e portò infine ad una guerra aperta che si combattéin Friuli, sotto le mura della città fortificata di Gradisca, dal 1615 e fino alsettembre 1617, quando gli ambasciatori veneziani Bon e Gussoni firmaro-no a Parigi una pace che portò alla distruzione delle fortezze uscocche deipromontori della Dalmazia (e alla fine degli atti di pirateria) ma che impedíalla Serenissima un trionfo definitivo nel conflitto, dal momento che qual-
M. Nani Mocenigo, Storia della marina veneziana da Lepanto alla caduta della Repubblica, Roma,Ministero della Marina - Tipo-Lit. dell’Ufficio di Gabinetto, 1935, p. 113 n. 3).
11. Per una piú precisa definizione del termine cfr. E. Ivetic, Gli uscocchi fra mito e storiografia,in «Venezia non è da guerra». L’Isontino, la società friulana e la Serenissima nella guerra di Gradisca(1615-1617), a cura di M. Gaddi e A. Zannini, Udine, Forum, 2008, pp. 389-97, a p. 389.
massimiliano malavasi
166
che settimana in piú avrebbe probabilmente permesso all’esercito venetodi espugnare la città di Gradisca e di conquistare tutto il Friuli arciducale.Gli scontri in mare tra la flotta veneta e quella napoletana sarebbero invececontinuati fino al 1620, fino cioè alla decisiva vittoria del Leone di San Marcoe alla rimozione del Duca di Ossuna. La decisione degli ambasciatori Bone Gussoni di accettare le clausole stabilite a Madrid e riformulate a Parigiera stata certamente apprezzata da quel prudente partito dei “vecchi” delSenato veneziano che si era opposto all’entrata in guerra e sempre si mo-strava restio a sfidare apertamente la potenza asburgica, che pure predomi-nava in Italia e mostrava di voler soffocare le restanti roccaforti indipen-denti della Penisola, in primis Venezia; una decisione specularmente invisaal coraggioso partito dei “giovani”, convinto che un’eccessiva passività epavidità della Repubblica ad altro non avrebbe condotto che alla sottomis-sione al potere spagnolo. Sebbene il conflitto fosse terminato piú di vent’anniprima, il racconto che ne faceva Capriata doveva aver infastidito, se non iprotagonisti, che andavano scomparendo dal theatrum mundi, almeno l’or-goglio della Serenissima.12
Lo storico genovese aveva sicuramente già messo in conto di narrare levicende della guerra di Gradisca al tempo in cui dava alle stampe lo specimendella sua opera, dunque nel 1625, quando i torchi dello stampatore Pavonidavano alla luce I due primi libri dell’Istoria di Giovanni Capriata, tutti impe-gnati a rivelare al mondo le infamie e le meschine azioni di Vittorio Ema-nuele I di Savoia. Lo snello volume però, per quanto riguardava la guerradi Gradisca, si limitava a fornire nell’indice i sommari (quasi degli abstracts)già, a dire il vero, decisamente espliciti nel rivelare l’orientamento antivene-ziano dello storico, un orientamento d’altra parte obbligato per chi, comelui, prendeva senza remore le parti della corona di Spagna.13 Ma solo l’ap-
12. Questa guerra fu discussa da una vasta messe di pamphlet e di opere storiografichecoeve; rimando a due miei precedenti lavori: M. Malavasi, I nodi nella tela dell’«historia»: laguerra di Gradisca, in Tra ‘res’ e ‘verba’. Studi offerti a Enrico Malato per i suoi settant’anni, a cura diB. Itri, Cittadella, Bertoncello Artigrafiche, 2006, pp. 207-54, e Tre monografie storiche secenteschesulla guerra di Gradisca, in F.eC., a. xxxii 2007, fasc. 2 pp. 243-74. Quel lontano conflitto èevidentemente meno dimenticato di quanto immaginavo mentre scrivevo quei miei primidue contributi, dal momento che nel 2007 è uscita una nuova monografia storica su queglieventi (R. Caimmi, La guerra del Friuli 1615-17 altrimenti nota come guerra di Gradisca o degliUscocchi, Gorizia, Leg, 2007) e nello stesso anno è stato organizzato sull’argomento un con-vegno del quale sono prontamente usciti gli atti contenuti nel cit. vol. «Venezia non è daguerra». Per la bibliografia meno recente rimando alle note dei miei cit. contributi e agli attidel recente convegno.
13. Vi si leggeva, ad es., che « I Vineziani, travagliando con poco frutto nel Friuoli, sono
capriata, zilioli e la guerra di gradisca
167
parizione del testo della prima edizione completa della prima parte dell’Hi-storia nel 1638 rendeva note le parole di Capriata, parole sorprendenti nontanto per i contenuti, che in buona parte riprendevano quanto già divulga-to dalla libellistica filospagnola intervenuta sulla vicenda, quanto per la stra-tegia retorica messa in atto che, ai lettori piú attenti e smaliziati, mostravain Capriata un vero maestro della storiografia partigiana e prezzolata.
Lo scrittore genovese comincia il racconto con un elogio del dominiospagnolo in Italia, ragguardevole per potenza e commendevole per sag-gezza, un elogio che da subito pone come assiomi fondativi del discorso iconcetti dell’invincibile forza militare iberica e della produttività della feli-ce pax hispanica, essendo gli spagnoli «della pace d’Italia oltremodo zelanti[…] solleciti, e diligentissimi protettori» (p. 4).
L’immagine che viene invece via via offerta dei veneziani è di segno op-posto e astutamente definita per pennellate successive: i veneziani sonodei subdoli finanziatori segreti del Duca di Savoia (evidentemente prefe-rendo far combattere ad altri le proprie guerre: vd. p. 182); di là dall’allean-za, del tutto interessata e mercenaria, con l’infido piemontese, la Serenissi-ma si muove in un clima di generale ostilità da parte di tutti gli altri statarelliitaliani centro-settentrionali (pp. 216-17); sogna la riconquista di tutto il Friu-li arciducale, aspirazione ingiusta – dal momento che questi territori nonhanno responsabilità alcuna nella pirateria uscocca –, e irragionevole, venen-do tale evento a turbare il quadro di sapiente equilibrio di poteri stabilito-si sul territorio italiano (pp. 213 e 308); ancora, i veneziani sono espressionedi uno stato diviso, come rivela la primissima loro apparizione sulla scenadell’Historia, che li raffigura nel corso di una seduta del maggior consigliodove si assiste allo scontro tra la fazione dei “giovani”, favorevole a concede-re i finanziamenti a Carlo Emanuele di Savoia perché continui la sua guer-ra contro gli spagnoli, e una fazione dei “vecchi”, decisamente contrari atale azzardo (pp. 127 e 212). La stessa decisione di entrare in guerra è ilrisultato di una deriva “populistica” che ha spinto alcuni dei senatori piúricchi e autorevoli, «per far acquisto dell’aura popolare», ad unirsi allo scia-gurato «ardore della gioventú», onde «rimase, come talvolta suole nellamoltitudine avvenire, la migliore dalla maggiore opinione superata» (p. 212).
Piú in generale, secondo uno dei cavalli di battaglia della pubblicistica
ancora travagliati nel mare dall’Armata Spagnuola mandata nel Golfo dal Viceré di Napoli,la quale, non avendo potuto tirar a battaglia la Vineziana, occupa tre galee cariche di mercidi grandissimo valore» (Historia-Specimen, p. 170); oppure che: « Il Viceré di Napoli mandanell’Adriatico alquanti Galeoni per difesa de’ Ragusei danneggiati dall’Armata Vineziana; laquale venuta a battaglia co’ galeoni rimase perdente» (ivi, p. 171).
massimiliano malavasi
168
antiveneziana, la Serenissima è uno stato ormai in declino, afflitto da unacronica debolezza economica e quindi presto ridotto sul lastrico dalle spe-se di guerra; epitome delle sue ridicole pretese è la grottesca festa popolareimprovvisata per le strade cittadine, dove la plebe brucia un fantoccio cheraffigura il viceré di Napoli, salvo scoprire poi che tali allegrezze sono deltutto fuori luogo perché la notizia che ha originato i festeggiamenti, unavittoria navale sulla flotta dell’Ossuna, è del tutto falsa, donde il ritorcer-si della gioia in angoscia (p. 306); Venezia, insomma, è una società stanca,vecchia, capace solo di astuzie diplomatiche, di sapienti trattative, di accor-di commerciali, ma esangue, debole, effeminata, inabile a sostenere unconflitto con le armi in pugno (pp. 298-99):
Ma la Repubblica, abbondantissima di Navi, di Galeazze e d’ogni bellico apparec-chio, pativa strettezza grandissima d’uomini, tanto da remo quanto da combattere.Perciocché quel popolo e que’ contorni, per li secoli passati esercitati e però assaigloriosi nella milizia di mare, dalla quale la Grandezza del nome Viniziano ebbe ilprincipio e l’aumento, al presente, assuefatti a’ loro domestici esercizi e non aven-do per molti anni veduto il nemico, eran divenuti imbelli e nell’ozio comuneinviliti. Né di Capitani si trovava però meglio provveduta, attesoché la Nobiltàdedita alle arti della pace, non aveva per li tempi addietro stimato la milizia, eccet-to la maritima; e questa ancora, dopo d’acquistato l’impero di terra ferma, e dopola pace ultima col Turco, era ridotta in mercanzia o in semplice amministrazionee comandamento civile di un corpo d’armata che non serviva per altro che perostentazione della grandezza di quella Repubblica.14
Capriata non manca di presentare le ragioni dei veneziani, il loro puntodi vista, ma – con ennesima astuzia espositiva – lascia che sia la voce di unsenatore della Repubblica, con tutto il peso della parzialità sulle spalle, aparlare dell’«aperto pericolo della comune libertà» (p. 127) italiana minac-ciata dal progetto della monarchia universale spagnola; oppure, pur espri-mendosi in prima persona con la sua voce di storico, non manca di ricon-durre al parere dei veneziani le opinioni espresse, minando la credibilitàdelle affermazioni con parole dubitative o dichiaratamente soggettive (profes-sandosi, parendole) riuscendo cosí a formulare i topoi della propaganda filo-
14. Capriata propone anche un brevissimo accenno alle cause sociopolitiche dei problemimilitari della Serenissima, ma non ha interesse alcuno a sviluppare la riflessione e si limita ascrivere che: «La Prefettura Suprema del Mare, per essere carico il maggiore che dopo il Du-cato la Repubblica conferisse, non si commetteva solo a soggetti fra la Nobiltà molto emi-nenti, i quali essendo piú negl’ufici e ne’ governi della Repubblica, che nell’arte della miliziamarinaresca esercitati, riuscivano affatto ignari per quel mestiere al quale venivano prepostie avevano essi piú bisogno d’esser governati che talento di governare» (p. 299).
capriata, zilioli e la guerra di gradisca
169
veneziana – ufficialmente presenti sulla sua pagina di storico – con dei tonicapaci di evidenziare solamente la ridicola velleità dei propositi di unostato piccolo e sfinito che si è intestardito nel combattere un impero infi-nitamente maggiore, al quale non può contrapporsi né con le forze né colconsiglio, al massimo con l’arte e con meschine alleanze segrete (p. 294):
Solo i Viniziani, professandosi liberi da qualunque rispetto e dependenti da se me-desimi, e veggiando molto acuratamente nella sigortà Italiana, stavano su gl’occhia quella corte [quella spagnola] e a quella nazione, parendole che piú de gl’altris’allacciassero la cura di sostenere lo stato quasi tremante della patria comune: eche sotto questo colore ambissero di parer quelli cui desse l’animo d’alzare la fron-te e stare a petto alla Grandezza del nome Spagnuolo: e farle se non giusto con-trappeso colle forze, col consiglio, almeno, coll’arte, e coll’intendersi con altri Prin-cipi, qualche riparo acciò (quel di che ansiosamente dubitavano) fuora dalle suesponde facilmente traboccando, troppo la sigortà comune dell’Italia soffocasse.
Il contrasto con il resto della riflessione dello scrittore genovese apparein tutta la sua evidenza proprio confrontando il passo citato con il resto deidiscorsi sostenuti nei quali invece Capriata, riprendendo la sua piena vocedi storico che, sotto la propria responsabilità, giudica il dritto e ’l torto dellequestioni politiche che va narrando, lascia che sia il punto di vista spagnoloa dettare i ragionamenti: il controllo che i veneziani esercitano sull’Adria-tico è illegale, sostenuto dalle armate navali senza «certo fondamento diautentica concessione o di legitimo titolo acquistato» (p. 206); ingiusti quin-di i dazi che i funzionari della Serenissima impongono alle navi contro il“diritto internazionale”, che stabilisce «l’uso del mare per ragion delle gentia tutti gl’uomini comune» (ibid.).
Capriata è l’unico che vede quali prospettive logiche apra una simile af-fermazione che era stata ribadita da tutta la pubblicistica e dalla storiografiaantiveneziana senza essere mai portata alle ultime conseguenze. Infatti, iresoconti della vicenda scritti fino ad allora – per quanto di parte austriacao spagnola – avevano sempre finito per rappresentare il conflitto in manie-ra tale da rivelarlo, volens/nolens, per quello che di fatto era: da un lato ungruppo di ex piccoli signorotti locali, divenuti predoni per mancanza di unceto di pescatori, contadini e artigiani da sfruttare; feudatari senza feudo,barbari e violenti, e solo strumentalmente rivestitisi di vessilli ideologiciquali la difesa della cristianità e la rivendicazione della propria appartenen-za etnico-territoriale alle regioni in mano al turco, nonostante la distanzagenerazionale dagli avi cacciati da quelle terre e nonostante l’ormai mas-siccia intromissione nelle proprie fila di predoni e criminali di ogni rismae provenienza; dall’altro una società raffinata, ricca, organizzata, produtti-
massimiliano malavasi
170
va, i cui orrori nascosti (lo sfruttamento delle colonie adriatiche e medio-rientali, l’occupazione dell’entroterra veneto, la spietata violenza verso irematori – vera base primaria del sistema produttivo veneziano –, l’arroc-camento dell’alta nobiltà, ecc.) rientravano nel novero dei “peccati origina-li” di ogni sistema di potere del tempo e dunque poco avrebbero potuto,qualora nominati, mutare quella sensazione di disagio che il lettore secen-tesco – letterato, politico, nobiluomo o anche semplice artigiano, comun-que alfabetizzato e dunque incline a riconoscersi in un determinato siste-ma di valori sociali e civili – doveva provare nel far convivere la sua appar-tenenza ideologica al fronte asburgico e la difesa di un imbarazzante bran-co di predoni sanguinari. Ma invece Capriata, con una soluzione che hadel geniale, preferisce una vera e propria falsificazione storica a montedella vicenda, e invece di riferire il vero sull’origine degli uscocchi, ovverola loro natura di rifugiati datisi alla lotta antiturca e poi, con mille scuse, aquella antiveneziana, ce li presenta come una soluzione coscientementeadottata dagli austriaci per difendere la libertà di navigazione (p. 207):
[i principi d’Austria], in guerre piú gravi contro il Turco impegnati, non potendocoll’armi, né con gl’ufici rimuover la Repubblica dall’impresa [di controllare l’Adria-tico], stimarono finalmente unico e singolar rimedio di quella piaga introdurre inque’ contorni alcuni popoli della Croazia, i quali furono poscia chiamati volgar-mente Uscocchi, gente fiera, coraggiosa, e sprezzatrice della vita, accioché standoquivi quasi stecco su gl’occhi alla Repubblica, con legni minori difendessero ilmeglio che potevano a’ sudditi dell’Arciduca la facoltà e libertà della navigazioneper que’ mari. A costoro, invece dello stipendio, si permise da principio il corseggiare,ma contro Turchi solamente, come nemici comuni e del Principe loro, della qualepermissione o abusando contro’ legni Viniziani, o volendo lor render la pariglia(perché da’ Viniziani venivan perseguitati) diedero alla Repubblica occasione diquerelarsi […].
Non si tratta dunque piú di parteggiare per una infrequentabile bandadi pirati rozzi e violenti, ma di riconoscere costoro come il braccio armato– e solo come tale rozzo e violento, al pari di tutti gli eserciti del tempo –dei signori austriaci di Graz, di Vienna, di Praga, con le loro gorgiere, leloro livree, le loro maniche coi merletti. La mossa strategica di Capriatapermette una manovra che ribalta completamente la questione: all’originedi tutto, e quindi anche delle atrocità uscocche,15 c’è la Serenissima e la sua
15. Atrocità che Capriata non nasconde, ma racconta con sufficienza, in maniera cursoria,sempre minando la credibilità del dettato con verbi che dichiarano esplicitamente di ripor-tare quanto detto dai veneziani, non di riferire quanto sicuramente successo (vd. p. 209).
capriata, zilioli e la guerra di gradisca
171
arbitraria occupazione de «lo mare chiamato legittimamente Adriatico enon con tiranica usurpazione Golfo di Ven[ezia]».16 Venezia infatti, di frontealle azioni di questi “difensori della libertà di navigazione”, «datasi conmolto studio a rimuover piú l’effetto che la cagione del male, si mossecontro costoro e cominciò a perseguitarli come corsari e pubblici ladroni»(pp. 207-8).
Avendo riedificato secondo tale strategica architettura le strutture por-tanti dell’argomentazione generale, Capriata ha poi facile gioco nel riferireil conflitto ricorrendo anche ai temi piú utilizzati dai resoconti antivene-ziani della vicenda come a corollari della sua esposizione: può narrarnel’inizio come l’esito ineludibile di una serie di reciproche vessazioni («co-minciarono a perturbare scambievolmente i confini con scorrerie, abbrug-giamenti di case, rapine d’armenti, e destruzione delle campagne», p. 211)che solo i veneziani condussero oltre il limite della vera e propria invasio-ne armata («e poscia, crescendo il furore, entrati i sudditi de’ Viniziani nelpaese dell’Istria con mille cinquecento fanti e alcuni cavalli», ibid.); puòdescriverne le azioni raccontando senza problemi dell’avanzata delle trup-pe della Serenissima nei territori dell’arciduca – magari accompagnandolecon qualche commento riduttivo (p. 228) –, per poi insistere con spietatez-za sul tema dell’impreparazione, della vigliaccheria, dell’inefficienza delletruppe e della flotta veneziane (pp. 214-15, 220-21, 224-26, 287-89, 291, 305,309, 311, 314 e 357), pure afflitte da «morbi pericolosissimi» (p. 226); nonchésulla corruzione dilagante tra i capitani veneti «intenti piú ad arricchireche a guerreggiare» (pp. 287-88), sui loro atti di inumana violenza (p. 317),sui problemi legati alle precedenze gerarchiche nell’organigramma del qua-dro di comando (pp. 224-25, 288 e 316), fino ai sospetti sulla lealtà del Me-dici (p. 316). Può presentare una lunga serie di vittorie veneziane (pp. 226-27) come una «variazione» delle «loro cose» (p. 227), e subito opporvi lanotizie di una vittoria arciducale (ibid.) e commentare con un bilancio fi-nale che giudica gli «affari [dei veneziani] invecchiati in piccioli progressi»e loro stessi «declinati di riputazione» (p. 228).
Ma anche qui, nel confronto con la pubblicistica antiveneziana, Capria-ta dimostra un’abilità nettamente superiore: rinuncia infatti all’invettivadi certi pamphlet o al disprezzo di certa storiografia (ad esempio quella delRith di Colenberg) ed è al contrario prodigo di espressioni di formale ri-
16. Cosí scriveva un anonimo opuscolo a stampa pubblicato all’inizio del conflitto, la Ri-sposta contro il manifesto publicato per la Rep. di Venezia per occasione della presente guerra, s.i.t., p. 3n.n. (Roma, Biblioteca Nazionale, Misc. 69 1 B 26 int. 27).
massimiliano malavasi
172
spetto per la Serenissima, per poter poi piú a fondo spingere la lama delgiudizio negativo o per rigirarla – con tanto piú dolor – con sofisticati emalevoli ragionamenti. Venezia, ad esempio, è governata da uomini savi eprevidenti e può contare su una oculata amministrazione e una prontarisposta dei cittadini alle esigenze delle finanze statali, e tuttavia la discesain guerra ha aperto un baratro nelle finanze della Serenissima che, essen-dosi «sul bel principio della guerra data a cattar danari da’ forestieri e, nonavendone trovato molti», s’è «in poco men d’un anno interessata co’ propricittadini e indebitata per piú di un milione di contanti», sminuendo «nonleggiermente la grande opinione che comunemente s’aveva del publicotesoro, stimato fra tutti quei de’ Principi Italiani ricchissimo» (p. 218).17
Nonostante «che in que’ Padri risplendesse fra tanti travagli e avversità lamedesima grandezza d’animo» (p. 292) nel proseguire la guerra, tuttavia,ritrovandosi assediati nel Golfo dalle navi dell’Ossuna, «considerato ma-turamente il picciolo frutto che dalla guerra conseguivano, il danno chenel pubblico e nel privato ne risultava: e antivedendo oltreaciò i pericoliimminenti allo stato loro […] rimessa per tanto qualche cosa della durez-za primiera, cominciarono a desiderare che fossero ripigliate le pratichedegl’accordi già interrotte» (pp. 292-93). Ecco allora che tutta la baldanzadei difensori della libertà d’Italia contro la Monarchia universale iberica, tutto«il desiderio che avevano di far palese al Mondo in che piccolo conto e ilRe e tutta la Casa d’Austria tenessero» (p. 295) viene meno: non potendoconfidare né nel papa («al quale la Repubblica stimava non esser i suoitravagli intrinsecamente discari», p. 293) e nemmeno nel re di Francia (im-possibilitato ad agire per la complessa situazione politica interna), Veneziadeve pregare di svolgere la funzione di intermediario al re di Spagna «pocomen che aperto nemico» (ibid.). Naturalmente Filippo III accetta l’incari-co per «il desiderio di non aver guerra in Italia» (ibid.) ma anche e soprat-tutto perché, se da un lato rischia di non guadagnare particolari soddisfazionidai termini dell’accordo, «dall’altro lato parevagli che assai venisse a conse-guire per la tacita confessione della Repubblica, la quale a se [ovvero allaSpagna] ricorrendo per ottener la pace, veniva non legiermente a ricono-scer l’Austriaca Maestà e Grandezza» (p. 295).
17. Naturalmente la Repubblica trovò «contro l’opinione d’ognuno comodità di supplirecol publico denaro a tutti i bisogni che le sopravvennero» (p. 218), e tuttavia (in cauda venenum)«per relazione di persone molto pratiche ed esperimentate nelle loro cose venne costante-mente affermato avere la Republica […] per questa occasione sparso fino a quattordici mi-lioni di Ducati» e che « lo stato […] ne rimase gravemente indebitato» (pp. 218-19): è quelloche nel linguaggio giornalistico attuale viene detto panino.
capriata, zilioli e la guerra di gradisca
173
E ancora: il vero capolavoro della dietrologia che Capriata applica in unasola direzione con lo scopo di denigrare la Serenissima è nella spiegazio-ne che offre dei continui avvicendamenti alla guida della flotta venezianaimpegnata nel Golfo contro le navi dell’Ossuna: le cronache di parte vene-ziana del tempo denunciavano lo scontro in corso tra le autorità militaridella marina in lotta contro il nemico e contro evidenti tentativi di sabo-taggio da parte di graduati vicini al partito dei “vecchi”.18 Capriata offredella vicenda un’interpretazione completamente diversa: si tratterebbe di(p. 297)
una delle solite cautele de’ Viniziani, i quali, scaricando la debolezza delle com-messioni sopra gl’uficiali, sogliono, senz’avventurare le proprie forze, coprire pru-dentemente la pubblica diffidenza, e la riputazione dell’armi loro in un istessotempo sostenere.
Un’offesa, questa della rimozione, ben tollerata dai comandanti colpiti dalprovvedimento i quali, passata la tempesta, sono solitamente risarciti concariche di grande rilievo e onorati da tutti i savi della Repubblica che bensanno che il loro “disonore” è un atto formale di suprema devozione allapatria.19
Venezia, a detta del Capriata, avrebbe adottato una tattica simile anchein occasione delle trattative di pace: dapprima la Serenissima avrebbe traf-ficato per trasferirle a Parigi col solo scopo di denigrare Filippo III di Spa-gna, approfittando delle smanie dei ministri di Luigi XIV, «desiderosidi conchiudere questo negozio per ambizione che ’l Re loro paresse l’arbi-tro delle controversie Italiane» (p. 336). Una complice strumentalizzazioneche lo storico genovese smaschera facilmente nel momento in cui consta-ta, con malcelata soddisfazione, che il re di Francia finirà per accordare «imedesimi capitoli come già dettati dal Re Cattolico» (p. 337). Ma il Senato,non pago dell’affronto portato a Filippo, cerca di imporre l’inserimentodella clausola relativa alla restituzione delle navi veneziane catturate dallaflotta del Duca di Ossuna: Venezia in realtà, ben sapendo di non poterlaaver vinta su questo punto, avrebbe ordinato ai suoi delegati a Parigi di
18. Cfr. Malavasi, I nodi nella tela dell’«historia», cit., pp. 232-33 e 244-46.19. Tale è la consapevolezza dei dirigenti veneziani della debolezza della propria flotta,
che un mancato combattimento dovuto all’alzarsi di un forte vento viene salutato comeesito provvidenziale: «E per tanto molti innalzando i discorsi e fissando piú in alto i pensieri,attribuirono a gran miracolo e riconobbono per segnalatissimo favore della Divina Bontàquella subita e improvisa mutazione del vento» (p. 305).
massimiliano malavasi
174
firmare il trattato salvo poi fingersi «malissimo soddisfatta» dei terminidell’accordo e scaricarne «con le solite arti tutta la colpa ne gl’Ambasciadori»(p. 338):20
Cosí riuscí alla Repubblica col favore dell’armi del Duca tener gl’eserciti Spagnuolida’ suoi stati lontani, e con gl’artifici ottener ancora quel vantaggio nell’accordoche coll’arme proprie non era possibile che conseguisse.21
E sebbene esuli dall’argomento che ci siamo prefissati, pur essendo aquello strettamente contiguo, non mi trattengo dall’accennare all’interpre-tazione che Capriata suggerisce della celebre Congiura del Bedmar, pre-sentata come il vertice della malizia veneziana: spietata declinazione diuna machiavellica Ragion di Stato, la celebre congiura sarebbe stata inven-tata dai piú alti poteri della Serenissima col duplice scopo di infamare leautorità spagnole in Italia – facendo balenare l’allusione alla loro vergo-gnosa complicità in un atto di terrorismo internazionale – e per la neces-sità di eliminare fisicamente le numerose bande di mercenari, relitti dellaguerra appena terminata, che stazionavano nella città lagunare costituendoun pericoloso germe di delinquenza cittadina, se non – addirittura – diinstabilità politica (pp. 360-61).
Inutile continuare con i minimi corollari dell’abile orazione antivenezia-na proclamata da Capriata nelle sue pagine storiografiche, corollari che ac-cusano Venezia di aver continuato il conflitto dopo la firma della pace (p.354), che – mentendo – dichiarano che il Duca di Ossuna interruppe leostilità in mare immediatamente dopo il trattato (pp. 355-56), che la Sere-nissima infierí – spietata e vendicativa – sulla città di Ragusa, rea di averdato ricetto all’armata spagnola (p. 356), che subí continue sconfitte in maresegno della sua decadenza anche su questo fronte (p. 358):
Afflisse non mediocremente la Repubblica il successo di questa battaglia nellaquale i suoi avendo cosí malamente corrisposto alla disciplina marinaresca e all’an-tica gloria de’ maggiori, venne con perdita della riputazione dell’armi terrestri a
20. Rimando ancora al mio I nodi nella tela dell’«historia» (pp. 246-53) per l’interpretazionedella complessa vicenda delle trattative di pace e per la questione della restituzione dellenavi veneziane, navi da trasporto merci catturate dalla flotta dell’Ossuna che non aveva maiufficialmente dichiarato guerra a Venezia.
21. Capriata, Historia, p. 341. E ancora: « [la pace] fu conclusa con molto vantaggio de’Viniziani, secondo il solito di quella Repubblica; la quale come prevale di consiglio e riescedi studio militare a gl’altri Principi inferiore, cosí, non maneggiando molto felicemente l’ar-mi, le riesce poscia conchiuder per mezzo delle negociazioni con maggior riputazione le pa-ci» (p. 317).
capriata, zilioli e la guerra di gradisca
175
diminuire e quasi a cadere da quella opinione che nella marittima pur ancora ri-teneva presso tutte le nazioni.
Dunque Capriata è l’unico scrittore che prende le parti dell’Austria, omeglio della Spagna, utilizzando una strategia retorica complessa e raffina-ta che molto deve ai margini di ambiguità che si ritaglia nella tessitura deldettato. La sua indubitabile e – per certi versi – ammirevole abilità risiedenella capacità di elaborare delle strategie analitiche cosí complesse (quel-le che lui chiamava le «piú sottili speculazioni»)22 che gli permettono disussumere le posizioni degli avversari smontandole e riducendole ad unmucchio di congegni rotti che compaiono sulla sua pagina ma non servo-no piú la causa avversaria, anzi confutano in anticipo le argomentazionidella parte contraria: in questo senso Capriata si pone come l’unico veroantagonista della complessità intellettuale di un Sarpi. Nella sua astuzianon si priva certo del gusto di far mostra di possedere un giudizio equili-brato avanzando delle critiche anche nei confronti di personaggi di rilievodella parte asburgica: gli è sufficiente bersagliare quelle figure che nel frat-tempo erano cadute in disgrazia o che non avevano adempiuto a doverel’incarico loro affidato.23
Ma l’ambiguità del discorso di Capriata ha anche una funzione pratica:i congegni della macchina della propaganda avversa, come dicevo, giaccio-no smontati sulla sua pagina; smontati, appunto, non irrimediabilmentedanneggiati: è sufficiente ricollocarli nell’ordine del macchinario a cui ap-partengono, lavorare qui e là col cacciavite, ed ecco che si può facilmente
22. Capriata, Historia, p. 832.23. Ad es. accenna al fatto che andavano «diminuendo ancora gl’affari dell’esercito in
Lombardia di forze e di riputazione e per lo malo governo andando di mal in peggio» (p.295), esprimendo scarso apprezzamento per quel Pedro de Toledo governatore di Milanorimosso nel 1618; non manca di rimbrottare anche il Trautmannsdorf, morto da tempo,cavaliere di gran nascita e di grande coraggio «ma di genio e di consiglio piú alle scaramucciee a picciole fazioni che alla somma delle imprese declinato. Onde meritò nome piú di buonsoldato che di Eccellente Capitano», dal momento che, pur disponendo dei mezzi per spaz-zare via dalle terre dell’Arciduca un esercito « indisciplinato e imbelle» quale quello vene-ziano, «non seppe mai trovar partito per totalmente vincerlo e debellarlo», onde «quantun-que nelle private fazioni sempre e assalitore e superiore rimanesse, parve nondimeno chepiú in difesa che ad offesa combattesse. E i Vineziani continuamente assaliti e perdenti, par-vero in universo i vincitori, avendo sempre portata la guerra nel paese nemico e senza per-der punto l’acquistato» (p. 314); ma la colpa, dice poi Capriata, era da alcuni attribuita «a’ se-greti ordini de’ Ministri principali dell’Imperadore, dall’oro de’ Viniziani corrotti» (p. 315), do-ve il malevolo riferimento è chiaramente scoccato ai danni del cardinale Klesl, arrestato nel1618 per sospetto tradimento.
massimiliano malavasi
176
trasformare un testo nel suo contrario, l’appoggio a un partito in quelloopposto, l’esaltazione della Spagna in lode della Francia e viceversa. Cercoevidentemente di mostrare quali sono le modalità di scrittura adottate daCapriata per realizzare le pratiche di compravendita del pensiero da lui di-sinvoltamente esercitate nel corso della sua intera esistenza. È ben notoinfatti, a partire dagli studi della scuola storica ottocentesca, e cioè dai saggidi Ricotti prima e di Neri poi, che Capriata incarna una delle figure piúemblematiche della storiografia corrotta e venale frequentemente pratica-ta nel Seicento e poi, da allora, fino ad oggi, con il controllo da parte deitycoons del sistema di informazione giornalistico.24 Se Spotorno, nel suocandore, poteva credere alle dichiarazioni di indipendenza e di libertà del-la propria penna sparpagliate dal Capriata nelle premesse dei suoi libri,25
Ricotti e Neri rinvenivano in vari archivi le sue lettere ricattatorie o me-retricie nelle quali lo storico inviava parti manoscritte dell’opera che anda-va redigendo ai vari potentati con l’intento – suggerito con le usuali parolesoavi e le espressioni melliflue tipiche del dialogo con le autorità – di in-durli a remunerarlo affinché revisionasse il testo facendo apparire principi,sovrani e senati in una luce migliore. È ad esempio probabilmente riferitoa lui quanto scrive il Mazzarino in una lettera inviata al suo informatoregenovese Giannetto Giustiniani, proprio nel periodo che precedeva la pub-blicazione della seconda parte dell’Historia:
V.S. ha ragione che con cotesta sorta di gente, che fa il mestiere di scrivere historiema non la verità, bisognano regali, e se io non avessi tante cose per il capo, nonaverei trascurata questa diligenza, ma quello che vi è di buono è che se i Spagnuolicon seicento scudi hanno fatto mutare sei fogli, noi ancora saremo a tempo difargliene cambiar sei altri coi nostri denari.26
24. « […] hordes of somewhat clever and altogether unhealthy young men were alreadybeing employed for the purpose. In a sweeter age many of these young men might havebecome artists, but they had not been strong enough to stand against the growing strength ofdollars. They had become instead newspaper correspondents and secretaries to politicians. Allday and every day they used their minds and their talents as writers in the making of puffs andthe creating of myths concerning the men by whom they were employed. They were like thetrained sheep that are used at great slaughter-houses to lead other sheep into the killing pens.Having befouled their own minds for hire, they made their living by befouling the minds ofothers» (S. Anderson, A Poor White [1920], Whitefish, Kessinger, 2004, p. 56).
25. «vivendo in città libera, e scrivendo senza amor di pecunia, dispensa con giusta manoe gli encomj ed i biasimi» (Spotorno, Storia letteraria della Liguria, cit., pp. 60-61).
26. Lettere del Cardinale Giulio Mazzarini a Giannetto Giustiniani patrizio di Genova, edite dalmarchese V. Ricci, in Miscellanea di storia italiana edita a cura della Regia Deputazione di StoriaPatria, Torino, Stamperia Reale, to. iv 1863, pp. 1-235, a p. 116.
capriata, zilioli e la guerra di gradisca
177
E difatti, lo storico che aveva difeso ed esaltato la Spagna nella prima partedella sua opera, diventerà – com’è ben noto – filofrancese nel secondo vo-lume della sua Historia.
Tuttavia, il di piú che emerge dalla lettura e dall’analisi di queste pagine,è la strategia del Capriata, il quale strutturava i suoi attacchi su un duplicelivello, quello privato e quello “politico”. Infatti, di là dall’infamia gettatasu quel capitano o questo provveditore, sul singolo diplomatico o lo speci-fico ambasciatore (tutte figure che potevano essere invitate a comprarsi unamigliore raffigurazione delle proprie gesta), le riflessioni di questo storicoin merito alla guerra di Gradisca – come abbiamo visto – tendevano acriticare lo stato veneziano nella sua stessa struttura e anima, facendo assu-mere alla propria ricostruzione storica una specifica posizione nello schie-ramento della “politica internazionale” del tempo, sebbene si trattasse diuna posizione tutt’altro che vissuta con intima partecipazione ma sempli-cemente assunta strategicamente, come dimostrano poi le “giravolte” po-litiche della successiva carriera del Capriata.
Non si spiegherebbe altrimenti la rappresentazione del potere dei Diecisecondo i truci colori e i cupi stilemi della “leggenda nera” relativa allaspietata Ragion di Stato praticata nel Palazzo dei Dogi, il mancato ricono-scimento del diritto di Venezia al controllo dell’Adriatico, la reiterata con-statazione della cronica debolezza dei suoi eserciti terrestri e marittimi. Inquesto modo Capriata collocava coscientemente la sua opera nell’alveodelle preferenze politiche della Repubblica di Genova, dove lavorava estabiliva le sue “collaborazioni” con informatori e autorità da ricattare. Sen-nonché, quell’ambiguità di cui parlavo, ovvero il ricorso ai topoi della pro-paganda del partito avverso, le frasi di rispetto formale per le autorità dellanazione nemica, la struttura a cerchi concentrici dei ragionamenti che per-mette – ad ogni curva – di far apparire uno stato o un personaggio in unaluce ora positiva ora negativa, con l’inserimento di un «non» o di una fraseipotetica in piú (magari aggiunta nell’ultima spirale), buona a rigirare ildiscorso in qualunque direzione, insomma tutto l’astuto apparato di strate-gie retoriche che ho illustrato, era utile anche in casi come questi, a librogià stampato, a permettere all’autore apologie, giustificazioni, interpreta-zioni difensive false e capziose ma formalmente ben strutturate:
Per soddisfazione delle quali querimonie, dirò quel che passai col Sig. AndreaBalbo Gentiluomo Viniziano di molto merito, il quale si trovò in Genova quandouscí la parte primiera in luce, e mi fece di ciò amichevolmente qualche doglienze.Alle quali cosí risposi, Sig. V.S. non si può dolere ch’io non abbia onorato la Sere-nissima sua Repubblica quanto al sapientissimo suo Governo, al quale tutti restia-
massimiliano malavasi
178
mo obbligati per l’accurata vigilanza verso la salute e conservazione della communelibertà, la quale, non men che la sua particolare, con ogni studio procura di difen-dere, sostenere e conservare. Quanto poi a’ successi delle guerre tanto di marequanto di terra, non avendole recato gusto quando succedettero, è impossibile cheglie ’l recchino quando si descrivono; onde non v’ha colpa lo Scrittore, se confor-me al vero i rappresenta. Né essendo esso suddito, o stipendiato della Repubbli-ca non può tenersi offesa, se colla medesima libertà scrive le guerre di lei, con laquale si veggono scritte quelle delle due Corone e d’altri Principi. E se V.S. anderàparagonando i nostri scritti con quei d’alcuni Veneti Scrittori troverà che, comecon maggior verità cosí, con rispetto maggiore ho i successi poco felici dell’armiViniziane rapresentati, avendo nelle cose dubbie sempre nella piú benigna inter-pretazione inclinato. In maniera che le nostre opre sono pubblicamente nella stes-sa Città di Venezia vendute, lette e con applausi non minori che altrove ricevute,dove quelle de’ loro Scrittori rimanendo affatto sterminate, non compaiono inluce, e gl’Autori ne sono stati puniti, e puniti ancora i Capitani che mal si diportaronone’ sinistri incontri dell’arme e delle pubbliche fazioni.27
Lo storico genovese, che aveva strutturato la sua pagina facendovi com-parire ora le severe condanne della politica veneziana e ora le dichiarazionibellicose dei suoi senatori, le irrisioni a lei rivolte per l’inefficienza dellesue truppe e della sua flotta e poi gli omaggi formali alla saggezza dei suoigovernanti, poteva ora allestire una difesa apparentemente inoppugnabileche faceva coincidere i giudizi poco benevoli e i racconti poco edificanticon le opinioni e le relative decisioni prese dal Senato in riferimento aglistessi eventi da lui narrati e commentati con malevola intenzione. Natural-mente Balbi e gli altri rappresentanti del potere veneziano, con la loro se-colare esperienza di smaliziata conoscenza degli uomini e della politica,non si fecero certo ingannare dai ragionamenti difensivi di quel Capriatache non si era limitato a raccontare gli esiti negativi di alcune delle azionidella Repubblica, ma aveva a piú riprese condannato l’ethos stesso della cittàlagunare, il suo progetto politico e culturale, la sua rivendicazione di in-dipendenza, per giunta omettendo il racconto della vittoria finale delle na-vi veneziane in Adriatico nella battaglia contro il Duca di Ossuna;28 quelCapriata insomma che cercava con una pagina di spiegazioni di nasconde-re i lunghi capitoli pieni solo di critiche e di veleni.
Una pagina che, tra l’altro, si chiudeva – ennesimo ricorso del nostro
27. Capriata, Historia, parte ii 1649, pp. 19-20 n.n.28. Battaglia che, al tempo della pubblicazione della Dedica, era già stata raccontata – sep-
pur in maniera generica e riferendosi all’intera campagna navale di quell’anno – da almenouno storico veneziano, quello Zilioli di cui ci occuperemo nelle prossime pagine.
capriata, zilioli e la guerra di gradisca
179
storico alla sua “arte” o meglio agli “artifizi” della sua retorica – con unomaggio all’eroica ed impari guerra che Venezia iniziava a sostenere con-tro l’Impero Ottomano per la difesa del possesso coloniale dell’isola diCandia:
Le quali cose mi fan credere, che quei sapientissimi SS. [senatori] col loro buongiudizio, abbino appreso che il nostro stilo, benché con tutti ugualmente amicodella verità, non sia però punto alieno dalla stima, venerazione e ammirazionedella Maestà di quell’Augustissimo Governo, il quale dopo il Romano fra quanti silegga o si sappia essersi al Mondo ritrovati, non ha mai avuto superiore. E se itermini prescritti alla nostra Storia alle sole guerre d’Italia ristretti non mi proibis-sero il trapassarli, onde potessi scrivere la guerra da quella Repubblica gloriosissi-mamente contro il Turco a dí d’oggi sostenuta, si vedrebbe quanto il nostro stilegioirebbe di rapresentarla, quale merita, ed è degna d’essere alla presente e venturaetà rapresentata.
Una guerra che – ed è notazione di rilievo – Venezia andava combattendocon quella flotta che Capriata aveva descritto come ormai alla fine dellasua lunga e gloriosa tradizione, ridotta all’inefficienza dalla crisi endemicadello stato veneziano, crisi messa a nudo dalle incursioni delle navi delDuca di Ossuna; laddove invece la marina militare veneziana, per i venti-cinque anni successivi al 1644, rinverdendo i suoi fasti, avrebbe tenuto testaa uno dei piú potenti eserciti navali del mondo, quale quello turco, com-battendo per di piú in condizioni logistiche sfavorevoli in quella guerrache però Capriata dichiara di non poter narrare essendosi prefissato qualelimite del suo racconto i confini del territorio italiano: curioso però chepoi spenda pagine e pagine per narrarci della fine del Wallenstein che daltempo della guerra di Gradisca in Italia non aveva mai piú messo piedeconcludendo la sua celebre e tragica vicenda nella Germania devastata dallaGuerra dei Trent’anni.
2. Alessandro Zilioli29
Pochi anni dopo, nel 1642, venivano stampate le Historie memorabili de’suoi tempi30 del «cittadino» veneziano Alessandro Zilioli, una “storia uni-
29. Le pagine che seguono rielaborano alcuni capitoli della mia tesi di dottorato «Perdocumento e per meraviglia»: stile e ideologia nelle ‘Historie memorabili’ di Alessandro Zilioli (Univer-sità di Roma Tre, xiv ciclo, 1998-2001), seguita nel ruolo di relatore dal prof. Marco Ariani:colgo con grande piacere questa occasione per ringraziarlo della serietà professionale e dellapassione intellettuale con la quale indirizzò le mie ricerche.
30. [A. Zilioli,] Delle Historie memorabili De’ suoi tempi scritte da Alessandro Ziliolo libri dieci
massimiliano malavasi
180
versale” articolata in dieci capitoli (libri, nel lessico del tempo) che davanoconto delle piú importanti vicende accadute in Europa tra l’inizio del XVIIsecolo e il 1618. La pubblicazione in sé costituisce un episodio di un certointeresse nel panorama della storiografia e dell’editoria secentesca e meritaqualche istante di attenzione. Il primo volume dell’opera (la prima parte),venne data alle stampe dai Turrini di Venezia, una famiglia di editori i cuivari componenti (Antonio, Giacomo, Giovanni Maria, Pietro) – ora sottol’egida famigliare, ora in gruppi di due o di tre, ora autonomamente – fu-rono molto attivi a Venezia tra il 1637 e il 1680.31 La seconda parte delle Hi-storie di Zilioli, che racconta le vicende europee degli anni 1615-1627, ven-ne invece pubblicata sempre a Venezia ma dall’editore Giovanni AntonioGiuliani nello stesso 1642 (il titolo però non specifica che si tratta del segui-to del precedente volume) e poi ristampata a Bologna da Giacomo Monti,«a spese delli Turrini», tre anni piú tardi (con esplicita indicazione di «Par-te seconda»).32
Difficile stabilire, in assenza di testimonianze o di documentazione, leragioni di questa momentanea interruzione del rapporto di collaborazionetra l’autore e l’editore Turrini:33 certo è che dopo il fugace “tradimento”,
dedicati all’Illustrissimo ed Eccellentissimo Signor Francesco Molino Procurator di San Marco, Venezia,Per li Turrini, 1642.
31. Ricavo le notizie da Le edizioni veneziane del Seicento, a cura di C. Griffante, con lacollab. di A. Giachery e S. Minuzzi, intr. di M. Infelise, Venezia-Milano, Regione Veneto-Editrice Bibliografica, vol. ii 2006, pp. 496-98. Un catalogo secentesco di Giovan MariaTurrini si trova alla fine di G. Brusoni, Delle Historie Memorabili. Contiene le Guerre d’Italia De’Nostri Tempi. E questo Volume viene ad essere in ordine la Sesta parte delle Historie Memorabili diAlessandro Zilioli, Venezia, Turrini, 1656.
32. [A. Zilioli,] Delle Istorie memorabili de’ Suoi Tempi Scritte d’Alessandro Ziliolo Libri otto chesono dall’anno 1615 sin al 1627, Venezia, Appresso Gio. Antonio Giuliani con Licenza e Privi-legio, 1642 (da cui le citazioni che verranno, per le quali indicherò ove possibile direttamentea testo le pagine chiamate in causa); e [Id.,] Delle Historie memorabili De’ suoi tempi. Scritte daAlessandro Ziliolo. Parte seconda libri viii, In Bologna, Per Giacomo Monti, A spese delli Turrini,1645.
33. Ma non si trattò di un caso di pirateria editoriale, dal momento che la seconda parterisulta regolarmente inscritta nel registro dei Privilegi per stampa, il libro dell’«Arte dei Librai,stampadori e ligadori veneziani» nel quale gli editori del tempo dichiaravano l’intenzione dipubblicare un’opera garantendosene cosí i diritti («ne acquisisce privilegio giusto le leggi»,secondo la formula ritualmente impiegata). Ma si noti tuttavia l’incertezza dell’addetto allaregistrazione che per un attimo pensò fosse necessario dichiarare che si trattava della secon-da parte dell’opera e poi tornò sui suoi passi cassando con una linea orizzontale la parola « IlSecondo»: «Adi 28 Agosto 1642 / Il Mag.co Gio. Ant.o Giuliani dà in nota di voler stamparIl Secondo le Istorie Memorabili de suoi tempi che sono dall’Anno 1613 sino al 1627 libri ottoscritti da Aless.o Ziliolo che per esser libro non piú stampato ne consegue Privileggio Giusta
capriata, zilioli e la guerra di gradisca
181
sarà di nuovo il Turrini a investire nell’opera del suo concittadino storicodando alle stampe la terza parte (1646), ultima e postuma, relativa agli avve-nimenti europei degli anni 1625-1632, alla quale premise una dedica in cuiricordava lo scrittore appena scomparso;34 e poi, soprattutto, alcuni annipiú tardi, organizzando un’articolata strategia editoriale che prevedeva lariproposizione di un vecchio repertorio storiografico universale del primoSeicento, Il giardino d’Istorie di Bartolomeo Dionigi,35 con un sottotitolo tesoa presentare il testo come un prequel dell’opera zilioliana; e poi la ristampadei primi due volumi delle Historie memorabili dello Zilioli (1654), e la pro-duzione e distribuzione dei seguiti di quest’opera: le nuove pubblicazioni,tutte unificate dal titolo complessivo di Historie memorabili de’ nostri tempi (esi noti il passaggio del possessivo alla prima persona plurale, già anticipatodal sottotitolo della ristampa del testo di Dionigi), vennero scritte rispetti-vamente da Maiolino Bisaccioni (1653), Giovan Battista Birago Avogadro(1654) e Girolamo Brusoni (1656) – tre professionisti della storiografiasecentesca – e, sebbene perdano il carattere “universalisti-co” che avevanoi volumi dello Zilioli (essendo specificatamente dedicate rispettivamente
la lezze» (Archivio di Stato di Venezia – d’ora in avanti ASV –, Arti 166, Privilegi di stampa:1632-1709, c. 34r). Naturalmente anche le edizioni del Turrini delle Historie memorabili risul-tano regolarmente registrate: la prima a c. 31r («Adi 30 ottobre 1641»), la terza a c. 45r (« 1646.8 Mag-gio»).
34. [A. Zilioli,] Delle Historie memorabili De’ suoi Tempi, scritte da Alessandro Ziliolo, ParteTerza Libri iv. All’Em.mo e Reverendiss.mo Prencipe il Sig. Cardinale Camillo Panfilo Nipote di SuaSantità, Venezia, Per li Turrini, Con licenza de’ superiori, e Privilegio, 1646. Nella descrizionedella raccolta di manoscritti posseduta dallo Zilioli, Giacomo Filippo Tomasini cita le «Hi-storie memorabili de’ suoi tempi dall’anno 1600 fin al 1640 Volumi Trenta fol.» (J.Ph. Tomasini
Bibliothecae Venetae manuscriptae publicae et privatae, Utini, Typis Nicolai Schiratti, 1650, p. 101),il che ha fatto ritenere che esistessero parti dell’opera – magari incomplete e dunque esclusedal terzo e postumo volume – relative agli ultimi anni della quarta decade del XVII secolo(cfr. J. Morelli, Biblioteca manoscritta di Tommaso Giuseppe Farsetti, Venezia, Fenzo, 1771, p. 369).
35. Delle Historie piú memorabili del mondo, dal suo principio sino l’anno 1606 narrate da BartolomeoDionigi da Fano, sotto titolo di Giardino d’Istorie dal qual tempo sino al 1536 [sic, ma 1636] vengono poidescritte da Alessandro Zilioli ne’ suoi tre vollumi d’Istorie memorabili de’ nostri tempi, Venezia, Gio.Maria Turrini, 1650. Il repertorio di Dionigi era stato pubblicato in diverse edizioni venezia-ne (Eredi di Francesco e di Michiele Tramezzino, 1583; Giunti, 1585, 1592 e 1598; Francescodi Franceschi, 1591-1592) come la continuazione del supplemento di Mambrino Roseo alleHistorie di Giovanni Tarcagnota, la summa di storia universale cinquecentesca pensata comeopera divulgativa ed effettivamente di grande successo editoriale. Segnali del progetto delTurrini di coprire con una serie di pubblicazioni l’«historia universale» del XVII secolo sicolgono nella premessa che lo stesso scrisse alla quarta parte delle Historie di Galezzo GualdoPriorato (1651) dove, riferendosi tra l’altro al lavoro del Tarcagnota, lo definisce «opera vera-mente singolare e della quale il Mondo n’ha bisogno» (p. 4 n.n.).
massimiliano malavasi
182
alle Guerre di Germania, alle Sollevazioni di stato de’ nostri tempi e alle Guerred’Italia), vengono esplicitamente presentate come la parte quarta, quinta esesta della stessa impresa storiografica e aspirano, e in parte riescono, nel-l’obiettivo di delineare un quadro complessivo delle vicende di maggiorrilievo avvenute in Europa e nel mondo negli ultimi anni.36 Questi treseguiti hanno tutta l’aria di essere stati commissionati dal Turrini ai rispet-tivi autori in nome di un calcolato progetto editoriale, ed è forte la tenta-zione – pur in assenza di prove cogenti – di ritenere riferita proprio aquest’impresa una lettera scritta all’editore veneziano da Giovan FrancescoLoredan:
Al Sig. Gio. Maria Turrini. S. Martino.Ho veduto il Libro mandatomi dal Sig. Colombo; e come mi glorio d’esser
eletto per Giudice de i studiosi impieghi del Signor Berni, cosí mi duole non poterproferir un giudicio senz’opposizione. I sudori d’un Virtuoso meritano un poz-zo d’oro; ma il secolo se la passa o con complimenti, o con ingratitudini. Una granVirtú però non ammette mediocrità. Tralasciato contuttociò ogni altro particolare,la sola fatica d’aver unito insieme tante erudizioni, merita cento Doppie. Non in-tendo contuttociò che si pubblichi questo mio pensiero; onde si compiacerà V.S.passarla con un complimento semplice; e scrivere al Sig. Colombo che il giudicarel’Opere de i Virtuosi è un peccare in temerità. Attenderò alle figure mentre augu-randole dal Cielo ogni bene me le confermo etc. Venezia.37
Non è un caso che un progetto di promozione libraria cosí complesso earticolato – se non unico, certamente raro nel panorama editoriale del tem-po – sia stato elaborato da un operatore del settore quale Giovan MariaTurrini, e anzi numerosi aspetti della sua attività renderebbero auspicabileuno studio di settore specificatamente dedicato a questa famiglia di editori
36. Ecco i dati di queste cinque pubblicazioni: [A. Zilioli,] Delle Historie memorabili de’ nostritempi scritte da Alessandro Ziliolo. Parte Prima, Venezia, presso il Turrini, 1654; [Id.,] Delle Historiememorabili de’ nostri tempi scritte da Alessandro Ziliolo. Parte Seconda, ivi, id., 1654; [M. Bisaccioni,]Delle Historie memorabili de’ nostri tempi, Che contengono le Guerre di Germania Dalla mossa del Redi Svezia doppo la Pace di Lubecca, fino alla Pace di Munster, seguita l’Anno 1650. Scritte dal Co.Maiolino Bisaccioni Gentiluomo ordinario della Camera del Re Cristianissimo, e suo Cavaliere. E questovolume viene ad essere in ordine la quarta parte delle Historie memorabili di Alessandro Zilioli, ivi, id.,1653; [G.B. Birago Avogadro,] Delle Historie memorabili Che contiene le Sollevazioni di stato de’nostri tempi, scritte dal dottor Gio. Battista Birago Avogadro. A cui si è aggionti li Rumori moderni diFrancia. E questo Volume viene ad essere in ordine la quinta parte delle Historie memorabili di AlessandroZilioli, ivi, id., 1653; il vol. di Brusoni è cit. alla n. 31.
37. [G.F. Loredano,] Lettere del signor Gio. Francesco Loredano Nobile Veneto. Divise in cinquan-tadue Capi e Raccolte da Henrico Giblet Cavalier, Venezia, Guerigli, 1665, pp. 272-73 (della secon-da parte).
capriata, zilioli e la guerra di gradisca
183
e ai suoi membri. Una sommaria analisi del catalogo delle sue edizioni lorivela quale operatore librario teso in maniera vivacemente agonistica allaconquista del mercato attraverso una estrema varietà dell’offerta, assai in-tento quindi a seguire i gusti e le mode del pubblico.38
Lo dimostrano anche i suoi contatti col Loredano, contatti che sembra-no l’indizio di un piú generale tentativo del Turrini di legarsi all’ambientedegli Incogniti, vera miniera di autori capaci di conquistare i favori delpubblico. Senza questo rapporto con il “principe” delle lettere della Vene-zia del tempo, non sarebbero pensabili le collaborazioni con Bisaccioni eBrusoni, continuatori dell’opera dello Zilioli, dal momento che costoroerano tra le figure piú vicine al Loredano e tra i maggiori animatori dellavita culturale organizzata a S. Zanipolo (si consideri che Bisaccioni cureràl’edizione delle Cento novelle amorose dei signori Accademici Incogniti di Veneziae diventerà segretario dell’Accademia, e che al Brusoni viene tradizional-mente riconosciuto un ruolo di rilievo nella stesura del repertorio de LeGlorie degli Incogniti ). Il Turrini probabilmente approfittò di quel periododegli inizi degli anni ’50 (quando il Valvasense, editore di riferimento del-l’Accademia, era costretto all’inattività per via della stampa d’un libro proibi-to)39 per insinuarsi nell’ambiente degli Incogniti, stringere contatti col fonda-
38. Grande spazio è occupato dai libri “Rossi”, ovvero liturgici, prodotti in una notevolevarietà di gamme e di tipologie (dalle piú economiche, che si limitano ad offrire il testo, allepiú costose con incisioni in legno, in rame, con “lettera grossa”, ecc.): uno spazio ampio chenon stupisce dal momento che notoriamente l’“indotto” ecclesiastico rappresentava unadelle principali aree di consumo di prodotti librari. Tra i libri “Neri”, invece, pagato il tributoalla cultura religiosa con qualche libello edificante e qualche raccolta prestigiosa (l’Arsenal diConcetti Predicabili del Giuliano, il Catechismo romano, le Orazioni Sacre dell’Azzolini, i Panegiricisacri del Tesauro), ecco che si apre un’offerta intesa a soddisfare i desideri piú immediati ditutti i possibili lettori: ce n’è un po’ per la scuola (le Epistole scelte di Cicerone, gli Elementidi Euclide), per l’università (e in particolare per i giuristi: le Controversiae forenses di MerlinoPignatelli), per la curiosità geografica (l’Introductio in universam geographiam del Clüver, ilTheatrum orbis terrarum dell’Ortels) e medica (gli Aforismi di Ippocrate, il De morbis mulierumdel Fonteyn); e poi soprattutto i generi piú in voga presso il grande pubblico dell’epoca: ilromanzo (l’Argenis di John Barclay nella traduzione del Pona, l’Aldimiro e il Ruremondo delLengueglia, l’Almerinda dell’Assarino, l’Istoria del cavalier Perduto del Pasini, la Maria Maddalenapeccatrice e convertita del Brignole Sale) e la storiografia (appunto i tre volumi delle Historiememorabili, il citato repertorio di Bartolomeo Dionigi, ma anche le Guerre di Germania delRicci). Spicca infine, per la cura e l’attenzione specificatamente dedicategli, l’edizione delleopere di Ferrante Pallavicino, vera officina di best sellers dell’epoca («Palavicino tutte le Ope-re, ripartite in 4. Tomi con la vita, ed effigie in 24»).
39. I torchi del Valvasense rimasero forzatamente inattivi dal 1651 al 1655: cfr. M. Miato,Gli stampatori veneziani e la censura, in Ead., L’accademia degli Incogniti di Giovan Francesco Loredan.
massimiliano malavasi
184
tore, stabilire rapporti di collaborazione con i maggiori rappresentanti. Lastessa edizione delle opere del Pallavicino, il pupillo dell’Accademia, ama-to e protetto finché fu possibile proprio dal Loredano e dal Brusoni, nonè pensabile senza il placet degli Incogniti. Dunque anche il tipo di editorecertifica che le Historie memorabili furono un libro di successo, sostenuto,forse dopo un’iniziale incertezza, con iniziative coraggiose e impegnativeda un promotore del settore librario capace di riconoscere i capi di razza edi valorizzare i cavalli della propria scuderia nella corsa al best seller.
Ce lo conferma la diffusione dell’opera: notoriamente siamo privi di datiin merito alle tirature dei libri antichi, il fatto tuttavia che uno o piú volumidella serie delle Historie memorabili sia presente in praticamente tutte le gran-di biblioteche europee40 testimonia per certo che si tratta di un testo cheebbe vasta diffusione, almeno presso il pubblico dei lettori dei volumi distoria secenteschi, che è ragionevole immaginare costituito non soltantodai «consiglieri nelle corti» e dai «dottori nelle scuole», ma da quegli stessi«barbieri eziandio e [da]gli altri piú vili artefici» che «nelle botteghe e neiritrovi loro discorrevano e questionavano della ragion di stato», secondo latestimonianza di Ludovico Zuccolo,41 tanto piú che costoro assai di radoleggevano libri di teoria politologica e invece si nutrivano proprio di quelladisciplina in re, descritta nelle storie de’ loro tempi. Ma l’opera ebbe una certafortuna anche presso gli storici del tempo: Brusoni ne riprende quasi pa-rola per parola il racconto delle vicende genovesi (vol. iii, libro iv) nella suaHistoria d’Italia,42 e lo stesso farà Ricci nelle Rerum Italicarum sui temporis nar-rationes;43 viene esplicitamente incluso tra le fonti del suo Mercurio da Gi-
Venezia (1630-1661), Firenze, Olschki, 1998, pp. 121-66; e M. Infelise, Libri e politica nella Veneziadi Arcangela Tarabotti, in «Annali di storia moderna e contemporanea», a. viii 2002, pp. 31-45;sul ruolo di Loredan nel sistema dell’editoria veneziana del ’600 si veda Id., «Ex ignoto notus?».Note sul tipografo Sarzina e l’Accademia degli Incogniti, in Libri tipografi bibilioteche. Ricerche storichededicate a Luigi Balsamo, Firenze, Olschki, 1997, vol. i pp. 207-23. I rapporti del Turrini colLoredano sono documentati anche dalla lettera spedita da quest’ultimo a Pace Pasini (Loredan,Lettere, cit., pp. 266-67 della prima parte) come accompagnamento all’invio dei fogli appenastampati proprio dall’editore Turrini del romanzo di Pasini Historia del cavalier perduto.
40. Ho personalmente preso visione di quelle conservate a Roma (Vaticana, Angelica,Casanatense, Nazionale), a Parigi (Bibliothèque Nationale), Londra (British Library). Mauna veloce verifica sui cataloghi bibliotecari informatizzati ne rivela la presenza assai diffusa.
41. L. Zuccolo, Della ragion di stato (1613), in Politici e moralisti del Seicento, a cura di B.Croce e S. Caramella, Bari, Laterza, 1930, pp. 23-41, a p. 25.
42. Il debito di Brusoni nei confronti di Zilioli su questo punto fu individuato già nelXIX secolo (cfr. G. Luzzato, Cenni intorno alla vita e alle opere storiche di Girolamo Brusoni, in«L’Ateneo Veneto», a. xxii 1899, pp. 6-26, spec. pp. 14-16).
43. G. Ricci, Rerum Italicarum sui temporis narrationes. Quibus omnia bella, eventa, notabiles ca-
capriata, zilioli e la guerra di gradisca
185
rardi,44 ed è l’obiettivo polemico di un’anonima cronaca mantovana delSeicento per via del suo resoconto dell’assedio della città.45 Ma l’opera go-dette dell’attenzione anche di lettori di alto profilo intellettuale: nienteme-no che Gottfried Wilhelm Leibniz, di passaggio a Venezia, cercò di pro-curarsi i materiali di lavoro di Zilioli;46 Muratori lesse l’opus storiograficozilioliano e lo citò nei suoi Annali d’Italia,47 e Manzoni – dovendo appro-fondire la storia del Seicento per la stesura del suo romanzo – si affrettò aprocurarsi le Historie memorabili.48
Le Historie memorabili sono un prodotto storiografico di tipo ben diversorispetto all’Historia del Capriata: Zilioli non vuole ricattare principi o capi-tani e nemmeno affascinare politici o diplomatici con la complessità dellesue interpretazioni dietrologiche degli arcana status; il suo obiettivo princi-pale è sedurre il “lettore comune”, l’alfabetizzato di base che nel Seicentoera identificabile con numerose categorie professionali, conquistarlo conla sua storiografia attenta a tutti gli aspetti della vita pubblica, solo se pro-prio necessario anche quelli relativi alla faccia oscura del potere; soprattut-to Zilioli intende sedurre con i mirabilia, gli eventi curiosi, lo spettacolo
sus continentur, quae ab anno 1613 usque ad annum 1653 in Italia acciderunt, Venetiis, Apud Tur-rinum, 1655. Vd. in partic. la Vacherii coniuratio. Narratio sexta (pp. 212-24) e la parte su Gradi-sca: Carnicum et Foroiuliense bellum. Narratio secunda (pp. 50-86).
44. F. Girardi, Il Mercurio del Decimosettimo secolo nel quale si contengono i fatti piú illustrisucceduti nel Mondo dal 1601 fino al 1650, Napoli, Giacinto Passaro, 1664, p. 166.
45. Si tratta della Cronica di Mantova conservata all’Archivio Gonzaga (Documenti Patrii,n. 77) ed edita in appendice a H. von Zwiedineck-Südenhorf, Die Politik der Republik Ve-nedig während des dreissigjährigen Krieges, ii. Band. Die Befreiung des Veltlin und der Mantuaner Erb-folgekrieg, Stuttgart, J.G. Cotta, 1885, pp. 290-347.
46. «Leibniz an Pietro Andrea Andreini, Venedig 5. Märs 1690: Legi indicem MSorumBibliothecarum Venetarum a Thomasino editum; in eo memorantur 30 volumina MSa adhistoriam recentiorem pertinentia quae extabant in Bibliotheca Alexandri Zilioli JCtihistoriarum cultoris. Peto ut occasione data inquiras, an constet ubi lateant. Sed illud quoque,quorsum iverit Bibliotheca Dominici Molini patricii Veneti ac Senatoris, Heinsii et aliorumeruditorum amicitia celebris» (G.W. Leibniz, Allgemeiner politischer und historischer Briefwechsel,herausgegeben von Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Berlin-Hildesheim-New York, Akademie Verlag-Georg Olms, 1970, vol. v p. 540). Manca ogni accenno alla que-stione nelle lettere di risposta di Andreini, né Leibniz ritornerà sulla vicenda nel suo episto-lario.
47. Muratori, Annali d’Italia, cit., p. 126.48. La presenza del testo di Zilioli tra le fonti dei Promessi sposi è dichiarata, tra i tanti, da
F. Nicolini, Arte e storia nei ‘Promessi Sposi’, Milano, Longanesi, 1958, p. 47. Possediamo anchel’appunto col quale Manzoni formulava la richiesta di venire in possesso dell’opera delloZilioli (e di quella del Capriata): vd. Manzoni a Brera. Dono Ester della Valle di Casanova Bonacossae nuove acquisizioni, Milano, Scheiwiller, 1993, p. 38.
massimiliano malavasi
186
tragico e grandioso delle battaglie, le scene di vita a corte, insomma tuttoquello che è riuscito a raccontare, come dice lui stesso, «per documento eper meraviglia»,49 in un’abile declinazione storiografica del piú divulgatoassioma di base della poetica barocca. Tuttavia, sotto questa patina da set-timanale d’intrattenimento, si cela una precisa ideologia che non manca dirivelarsi anche nelle pagine che Zilioli dedicò alla guerra di Gradisca, com-battuta ormai ventiquattro anni prima. Infatti il «cittadino» (e cioè “alto-borghese”) veneziano Zilioli ha una lunga serie di ragioni per raccontarcile vicende della guerra friulana assumendo il punto di vista della Serenis-sima: anche lasciando sullo sfondo quelle pratiche – l’esigenza di pubblica-re l’opera in città e di non incorrere quindi nella censura o nel fastidio delleautorità – la scelta filoveneziana di Zilioli nasce da un marcato senso diappartenenza alla Serenissima, al suo progetto politico e culturale, al suoethos civico, eredità – come vedremo piú avanti – di una lunga e ricca storiafamiliare.
Compaiono quindi sulla pagina tutti gli elementi che caratterizzavanole ricostruzioni di parte veneziana della vicenda: la descrizione degli uscocchiquali barbari truci e sanguinari, ultimi inveleniti avanzi del popolo cacciatodall’avanzata turca, capaci di violenze mostruose che vanno oltre la notavicenda di Venier;50 le responsabilità degli arciduchi nella mancata sop-pressione di tale risma di criminali (p. 2); l’elogio di Venezia, città di fattoinespugnabile (pp. 32-33), e del suo buon governo («l’Ottimo governo del-la Repubblica Veneta», p. 16); la difesa – senza margini di trattativa – delsuo diritto al dominio sull’Adriatico, certificato nei secoli dalla lunga seriedi principi e imperatori che hanno chiesto l’autorizzazione ad attraversarloriconoscendo quindi il governo della Serenissima su «quel Mare, che per-ciò da tutti si chiama Golfo di Venezia» (p. 36): al punto che la protestaespressa nelle scritture «de i dottori Napoletani» tese a contestare tale do-minio «non poteva ascoltarsi senza riso» (ibid.). Quale naturale conclu-sione della vicenda, Zilioli chiude il i libro della ii parte delle sue Historiecon il racconto della vittoria finale veneziana in mare (un particolare che
49. Zilioli, Delle Historie memorabili […] , Parte Terza, cit., p. 10.50. Zilioli non si limita a raccontare gli orrori della vicenda del Venier (al quale « tagliaro-
no dopo molti ludibri la testa e mangiarono il core, dando poi il cadavero ai cani», p. 3), maricorda anche l’omicidio del rettore di Pago Antonio Giorgio (p. 3) e del commissario impe-riale Rabata («ammazzato barbaramente in camera propria», p. 2), e accenna genericamenteai misfatti degli uscocchi commessi «ammazzando i passeggieri, taglieggiando i prigioni edusando quantunque maggior crudeltà» (pp. 2-3).
capriata, zilioli e la guerra di gradisca
187
Capriata si era guardato bene dal narrare), della “Congiura del Bedmar” edella tragica fine della carriera politica e della vita stessa del Duca di Ossuna,uno dei piú subdoli e ostinati nemici della Serenissima (p. 40):
Dopo di che, essendo fra tanto state accomodate le cose d’Uscocchi e di Gradiscacon l’adempimento dei Capitoli di Parigi, e licenziati gli eserciti di Friuli e d’Istria,[gli] Spagnuoli anch’essi ritirarono l’armata dal Golfo, dove tornati poi l’anno se-guente a condotta dell’Almirante di Napoli, furono, né senza perdita d’alcuni deloro vascelli, messi in fuga da Pietro Barbarigo, il quale trascorso vittoriosamentecon quaranta Galeoni e quarantotto Galere e Galeazze sino a Brandizzi, terra stataaltre volte soggetta a Veneziani, risarcí con pienissima lode gl’insulti usati da coloroi mesi antecedenti contro la Republica, alla quale furono poi doppo qualche temporestituite le tre Galere depredate dall’armata dell’Aragona. Il Duca di Ossuna ri-chiamato in Spagna ed accusato di varii mancamenti e d’aver tentato anco conmodi sediziosi, seducendo la povertà, di continuare nel governo di quel Regnooltre il tempo statuito, fu di ordine reggio riserrato in stretta carcere, dove l’uomo,feroce e impaziente del tedio e dei rigori della giustizia, caduto in disperazione edivenuto prima melanconico e poi matto ed in ultimo infermo anco del corpo,terminò in spazio di pochi mesi infelicemente quella vita con la quale aveva perinanzi dati tanti essempi curiosi di audacia, di ambizione e di vanità.51
Tuttavia, nel raccontare la guerra sul Carso, Zilioli mantiene un profilosostanzialmente equilibrato: elude le invettive virulente contro il nemico,ammette persino che i contadini friulani favorivano gli imperiali (p. 16) e,soprattutto, propone una ricostruzione degli episodi bellici in cui le vitto-rie dei veneziani e degli austriaci si alternano sulla pagina secondo i crismidella credibilità e seguendo un andamento che, proprio dalla collazionedelle varie testimonianze, appare – di là dalle dichiarazioni propagandisti-che – come quello presumibilmente piú vicino al vero: la fase iniziale fa-vorevole alle truppe di Pompeo Giustiniani, il lungo periodo di vittorio-se sortite degli uomini del Trautmannsdorf, la ripresa positiva per i ve-neziani che finisce con la morte del loro comandante, la valida difesa degliaustriaci, il progressivo stringersi dell’assedio con l’arrivo delle truppe olan-desi.52
Le questioni piú spinose che al tempo del conflitto rendevano proble-
51. La rimozione e morte dell’Ossuna erano stati per Capriata motivo di vistoso imbaraz-zo: lo storico filospagnolo si limita ad accennare in modo assai sbrigativo alla sostituzionedel viceré ed eludendo la notizia della sua incarcerazione e morte: «E non molto dopo, fa-cendone ancora molta istanza i Napoletani, fu mandato successore allo stesso d’Ossuna» (p.367).
52. Vd. il vol. cit. di Caimmi (La guerra del Friuli) per un riscontro.
massimiliano malavasi
188
matica la descrizione degli aspetti politici legati alla vicenda sono trattatedallo storico veneziano “con i guanti bianchi”, con un atteggiamento di pru-dente cautela per il quale si potrebbe impiegare il concetto, assai piú recen-te, di “perbenismo”: nessun particolare interesse per la divisione tra “vec-chi” e “giovani” (a p. 38 compare un generico riferimento ai vecchi masenza alcuna spiegazione); nessuna allusione al sabotaggio della macchinabellica veneziana (cui pure alludevano altre fonti),53 nessuna riflessione sulpossibile “tradimento” da parte degli ambasciatori che firmarono la pace aParigi. Lodi anzi per tutti i quadri dirigenti dell’esercito di terra: Giustinia-no (pp. 8, 10, 14), Priuli (pp. 10 e 12), Foscarini (p. 13), Zorzi e Michiel (p.20), Barbarigo (pp. 31-32).54 La scelta di Zilioli va ricondotta da un lato alleindicazioni della sua fonte, l’Historia dell’ultima guerra nel Friuli di FaustinoMoisesso, che appunto narrava la guerra sul Carso nei termini qui ripro-posti;55 dall’altro alla lontananza cronologica dai fatti e dal clima politico e
53. Vd. Malavasi, I «nodi» nella tela dell’historia, cit., pp. 232-35 e 244-46.54. Persino il de’ Medici, che per i piú combinò ben poco e per alcuni fu persino sospetto
di intesa coi “vecchi” per impedire la vittoria veneziana, agli occhi di Zilioli fu un capitanoche si affaticava «di continuo con l’intelletto e con la mano, come un altro Giulio Cesare nelscrivere istruzioni e nel dissegnar fortificazioni e nuove machine per i soldati » (p. 31).
55. Cfr. Malavasi, Tre monografie secentesche, cit., pp. 251-60. È questa l’occasione per unadoverosa palinodia di alcune delle conclusioni da me proposte in quell’articolo in meritoall’ideologia del Moisesso: costui, al pari dello Zilioli, da un lato incensava i vertici dell’eser-cito veneziano, dall’altro esprimeva durissime accuse nei confronti dei piccoli nobili cheinfestavano i quadri intermedi di comando con angherie, peculato, incompetenza, e accom-pagnava le sue rampogne con riflessioni sulla decadenza della nobiltà italiana e con invettivecontro la mentalità aristocratica e la sua dannosa sopraffazione di una ben piú auspicabilelogica meritocratica. La sostanza della sua pagina, l’intentio operis, rimane quella che ho de-scritto e tale rimane anche il valore culturale e sociologico che la sua opera viene ad assume-re nel contesto italiano del Seicento, come dimostra il caso di Zilioli, capace – come vedre-mo – di portare alle estreme, coerenti conseguenze il senso logico di quelle affermazioni;ma – differentemente da quanto credevo – Moisesso non era un burocrate dell’alta borghe-sia provinciale, bensí un piccolo nobile (pur sempre di provincia), come ha dimostrato il belsaggio di Francesca Tamburlini, La figura e l’opera di Faustino Moisesso (in «Venezia non è daguerra», cit., pp. 349-88), e dunque diversa era la intentio auctoris nel proferire quelle accuse:non la coscienza di classe di un burocrate borghese, ma quella di un piccolo nobile diprovincia sostanzialmente squattrinato che, nel tentativo di costruirsi una carriera come in-tellettuale nella “capitale”, si ritrova a ragionare con parametri “protoborghesi” e a formu-lare principi meritocratici che le alte sfere del potere veneziano – come appunto osservavo– guardavano con benevolenza intendendole rivolte contro la piccola nobiltà estromes-sa dalle stanze dorate del potere. Segnalo che col nome del Moisesso è firmato anche unopuscolo non citato dalla Tamburlini, una breve composizione in latino contenuta in unostampato posseduto dalla Biblioteca Apostolica Vaticana (Chigi IV 2294): In Adventum Sere-nissimi Ferdinandi Gonzaghæ Mantuæ et Montisferrati Ducis una cum Serenissima Catharina Medicea
capriata, zilioli e la guerra di gradisca
189
culturale di quel tempo: nel 1617 la Spagna e la sua parentela austriaca co-stituivano una vorace e oppressiva superpotenza vistosamente intenziona-ta ad estendere il proprio dominio con modalità e finalità tali da renderecredibile che mirasse alla Monarchia universale, cosí come denunciavano isuoi nemici, in primis i veneziani, che vedevano l’Italia ridotta a una sequeladi statarelli stretti tra il viceregno meridionale e quello lombardo, entram-bi controllati dalla Spagna. Un’egemonia, quella spagnola, che – con l’ap-prossimazione cui hanno diritto i quadri storiografici generali ma senzacedimenti a impropri tentativi revisionisti di una realtà la cui intepretazionefornita sin dall’Ottocento resta sostanzialmente valida – si esprimeva nelprogetto economico di un neofeudalesimo prevalentemente agrario e delsuo corrispettivo sovrastrutturale dell’imposizione del cattolicesimo triden-tino. Ma nel 1642 il quadro politico e militare europeo è del tutto mutato:la Francia dell’editto di Nantes, la Francia alleata dei calvinisti olandesi edei luterani svedesi, la Francia che con il sistema della vendita degli ufficipubblici ha creato una rete di burocrati statali legati alla corona che favo-risce i commerci e che ha semplicemente inventato lo stato moderno sbri-ciolando l’antica struttura feudale, la Francia – in breve – del cardinal Ri-chelieu, ha ormai praticamente vinto la guerra dei Trent’anni imponendo-si come nuova potenza sovranazionale e lasciando l’Austria tra le maceriedella Germania distrutta e la Spagna alle prese con la fame e le intestineguerre di secessione.
Agli occhi di Zilioli non aveva piú senso alcuno rimanere ancorati agliodii e alle polemiche di 25 anni prima: la risposta alle insinuazioni, alleperfidie, ai sarcasmi degli storici di parte spagnola che ancora in tempirecenti (appunto il Capriata) e ancora negli anni successivi (Assarino)56 en-travano in polemica contro Venezia per la scelta di scatenare la guerra del1615, la forniva la Storia dichiarando il fallimento definitivo del progetto diegemonia iberica e del suo sogno, nemmeno tanto segreto, di incatenaredefinitivamente la Serenissima al giogo di Madrid. E non aveva piú alcunsenso nemmeno rivangare lo scontro interno alla politica veneziana, l’op-posizione tra i “vecchi” e i “giovani”, e i sospetti sui possibili riflessi cheaveva avuto sull’organizzazione della macchina militare della Serenissima.
coniuge præstatissima ad inclytam Venetiarum Urbem Carmen Eidem Sereniss. Principi a Faustino MoisessoSumma animi propensione dicatum, Venezia, Apud Paulum Guerilium, 1623.
56. L. Assarino, Delle guerre e successi d’Italia, Torino, Appresso Bartolomeo Zavatta, 1665,pp. 149-67, 222-50, 262-67, 281-93; l’Assarino, tra l’altro, riprende spesso alla lettera il raccontodel Capriata.
massimiliano malavasi
190
E cosí, estendendo quel tono di compiaciuto e ammirato e devoto osse-quio che Moisesso rivolgeva ai responsabili dell’esercito veneziano di terra,Zilioli – eludendo le voci e le dicerie (pure fissate su carta vergata e stam-pata) sul sabotaggio, l’imperizia, la codardia di alcuni comandanti di mare– elogia anche figure assai discusse: i comandanti Zane, Venier e perfino ilchiacchieratissimo Belegno agirono sempre con saggezza e ponderazionenella loro condotta come capi della flotta veneziana (pp. 22 e 23-24). E gliambasciatori non tradirono il loro mandato, né agirono con l’intento di im-pedire la caduta di Gradisca e la completa vittoria di Venezia, e la loro fir-ma – frettolosamente apposta sul trattato di pace – fu ragionevole, come ri-conosciuto dalle stesse autorità veneziane, pur obbligate, dal contesto, aprocedere a un doveroso processo a carico dei due diplomatici per l’infra-zione da loro commessa delle regolari procedure (pp. 37-38).
Questa zuccherosa glassa “perbenista”, che addolciva il palato dei Rifor-matori allo Studio di Padova e rendeva immediatamente “digeribile” – ecioè pubblicabile – un testo appartenente a un genere, quello storiografico,naturalmente assaggiato con sospettosa ingordigia dai magistrati preposti,era poi ulteriormente condita dall’abile “pasticciere” Zilioli con generosemanciate di gustosi aneddoti ed episodi che uno storico ligio a una piú ri-gorosa metodologia professionale non avrebbe dovuto prendere in consi-derazione, ma che invece il nostro «cittadino» distribuisce sulla pagina conuna certa cadenzata frequenza, secondo quella sua tendenza, o istintiva ostrategicamente meditata, a trasformare l’opera storiografica in una letturache all’ammaestramento accompagni una piacevolezza che non confidapiú semplicemente in uno stile alto e decoroso, ma trova piú proficua for-mulazione nell’inserzione dell’aneddoto curioso, di un particolare insolito,di un fatto storicamente irrilevante ma carico di un suo spicciolo e im-mediato pathos; come quello del soldato che si insinua tra i nemici per uc-cidere il comandante veneziano Giustiniano: il suo moschetto si incep-pa proprio quando ormai è a tiro ma Giustiniano, ammirato dal suo corag-gio, lo grazia, offrendo il destro all’autore per sfoggiare una bella sentenza(«Cosí alle volte, a confusione della sapienza umana, giovano piú l’ingiurieche i beneficii, e da quello che si aspetta la morte si riceve anzi la libertà ela vita istessa», p. 7); oppure il «caso meraviglioso» di un soldato muto cheper il terrore – vedendosi spacciato – recupera la favella (p. 19), al pari delfiglio di Creso (Erodoto, Historiae, i 85 1-4), subito rievocato per l’occasio-ne; oppure l’excursus sul celebre bandito Zanone, ucciso in quei giorni dauna sommossa popolare nel territorio di Salò dove imperversava (pp. 19-20); il «successo miserabile d’una zattera di soldati» austriaci che si incaglia
capriata, zilioli e la guerra di gradisca
191
di fronte alla trincea dei veneziani i quali li invitano a disertare e a passaredalla loro parte, fatto che spinge gli austriaci ancora a terra sulla riva oppo-sta ad eliminare i commilitoni a fucilate in un macabro tiro a segno («spet-tacolo lagrimabile di crudeltà», p. 25); l’invenzione di un nuovo tipo di can-none – che non risulta sia stato decisivo nella guerra in corso – del qualesubito Zilioli ci fornisce una attenta descrizione («Saltamartino inventatoda un Cittadino popolare», p. 31); l’appassionato racconto di un duellospettacolare narrato con significativa spesa di inchiostro e impiego di carta,nonostante si concluda con una soddisfazione di entrambi i contendentiche Zilioli marchia come «vanagloria» (p. 32).
A fronte delle cautele politiche e di questa strategia comunicativa, assu-me allora un significato di particolare rilievo il fatto che Zilioli mantengaun altro aspetto della sua fonte, il citato Moisesso, ammettendo senza remo-re le scempiaggini tattiche, la pavidità di parte delle truppe, la disorganizza-zione militare dell’esercito della Serenissima (p. 7):
Passavano allora le cose del Campo Veniziano, nononostante le diligenze del Se-nato e dei Capitani maggiori, con molti disordini, poiché non solamente eranorisorte diverse gare tra i Capitani e soldati a perturbazione danosissima di tutti gliordini e funzioni militari, ricusando alcuni di obedire a i loro superiori, ed impie-gandosi altri licenziosamente nelle dissoluzioni di giuoco, di meretrici, e del vinoprezioso che nasce in quei paesi, ma moltissimi eziandio, o fosse per timore, ofosse per altri affetti, si trasfugivano a i nemici, e qualche volta a squadre intiere, siche era necessario tal volta che i Sergenti a meza notte cambiassero il nome eriarmassero i posti abbandonati dai fuggitivi.
Ed ecco allora che gli albanesi, nel pieno dell’azione, si fermano a spo-gliare i cadaveri dei nemici invece di continuare a combattere (p. 11); eccole sortite vittoriose degli arciducali che spesso mettono i veneziani in ver-gognosa fuga (pp. 6, 8, 9, 19 e 25-26); ecco che gli austriaci assaltano ilcampo dei veneziani notando in questo «un certo tumulto» causato da«due Capitani della Repubblica venuti a contesa per causa poco onesta diun paggio» (p. 8); ecco i problemi di precedenza tra il de’ Medici e il Nassau,comandante delle truppe ausiliarie olandesi (pp. 26 e 28); ecco «le cauteledel Medici accompagnate con la tardanza e negligenza d’altri capitani» (p.27); ecco che lo stesso deve far uccidere i capi di una rivolta delle trup-pe olandesi che protestavano per ottenere un aumento di stipendio (p. 26);che la Serenissima decide di riorganizzare l’organigramma (p. 10); che daalcuni capitani «attendevasi solamente a corsegiar la campagna» (p. 16);che Pietro Barbarigo viene mandato da Venezia a riprendere le redini del-
massimiliano malavasi
192
l’assedio e della vita del campo («levò molti incarichi a molti o inutili osospetti alla Republica», p. 31). E anzi, completando anche in quest’ambitola testimonianza del Moisesso, Zilioli riporta alcune delle notizie suglianaloghi mancamenti commessi dalla flotta veneziana (p. 35), notizie chenei giorni della guerra circolavano in città, come documentato da una cro-naca manoscritta della Marciana e dal pamphlet di Pomponio Emigliani57
(p. 34):
è incredibile con quanta passione fosse sentito quel successo dalla Cittadinanzatutta e dal resto del popolo insieme, detestandosi da essi a piena voce non meno laprosunzione de Spagnuoli e Napolitani che la ignavia e dessidia de Ministri mede-simi della Republica, i quali intenti solamente a giocchi, crapule ed insolenze, siavessero lasciati prender quei vascelli su gl’occhi proprij e permesso che l’armata diSpagna calpestasse insolentemente l’acque di quel Golfo nel quale già tanti anninon si erano vedute altre bandiere né altre armi che quelle della Republica Vene-ziana, però intenti i Senatori al rimedio […].
Parimenti significativo che Zilioli riprenda, e anzi inasprisca, la conclusio-ne della denuncia già sporta dal Moisesso, lanciandosi in una virulenta in-vettiva contro il clientelismo nobiliare e i favoritismi di casta, contro una lo-gica di distribuzione degli incarichi che ha riempito l’esercito dello stato ve-neziano di una masnada di inefficienti e corrotti capitani (pp. 6-7):
Ma nel Campo Veneziano nasceva in gran parte la disubidienza dalla qualità deCapitani ed Officiali che commandavano alle compagnie, poiché essendosi intro-dotto con abuso danosissimo il dar i Capitanati non a quei soldati che con lungoesercizio dell’arte o con qualche fedel servitú si fossero mostrati degni di maggiorgrado, come è stato stile non meno onorevole che fruttuoso de Romani, de Tur-chi, e di tutte le nazioni grandi, ma a persone solamente che o per ricchezza o perparentella o per altro erano accetti a i Capitani maggiori, si vedevano le compagniede Fanti e de Cavallieri in mano o di Giovani non piú stati alla guerra, o d’uominiinsolenti e facinorosi i quali (perché è dottrina molto vera che non può ben co-mandare chi non ha imparato prima a ben ubidire) non avendo alcuna attitudinenel reggere gli altri, né quelle maniere proprie di trattar con soldati che sarebberostate necessarie, rittenevano appresso di loro piccolissima grazia, e minore autorità,onde ancorché adulati in apparenza da i soldati per loro fini particolari, nelle occa-sioni nondimeno confondendosi l’inesperienza col timore ed agravandosi il so-spetto col disprezzo, partorivano sempre danno a loro e del Prencipe istesso, sini-stri ed impensati effetti.
La denuncia del Moisesso ritorna in termini persino piú virulenti: la mili-
57. Il rinvio è ancora a Malavasi, I «nodi» nella tela dell’historia, cit., pp. 232-35, 244-46.
capriata, zilioli e la guerra di gradisca
193
zia è diffusamente inquinata da valutazioni di censo e di parentela, una lo-gica nepotistica di tipo oligarchico si è insinuata nel modulo organizzativodell’esercito mettendo in secondo piano il merito e conducendo la forzamilitare veneziana ad una pericolosa inefficienza. Si tratta naturalmentesolo di un inciso: Zilioli non ha strutturato il racconto delle vicende dellaguerra agli arciducali intorno a questa tesi, né ci si poteva aspettare diver-samente considerato il contesto nel quale operava e i codici espressivi dellacultura del secolo. Tuttavia vi sono elementi che rivelano come la scelta diquesto storico sia tutt’altro che neutra e abbia invece un marcato caratte-re ideologico che la configura in termini di “antagonismo” sociale e cultu-rale.58
Tale inciso infatti rivela il suo piú pregnante significato se lo si associaalla constatazione che la narrazione della guerra del 1615-1617 proposta daZilioli accosta ai fatti e ai citati addobbi da intrattenimento una serie di ri-flessioni improntate a un profondo disprezzo per due figure di rilievo delsistema di ossequiosi riferimenti ideologici e culturali della scrittura secen-tesca: il soldato e il nobile di provincia, figure da Zilioli spesso assimilate,sovrapposte, confuse in un’immagine unica fatta di boria volgare, tempera-mento violento, attitudine all’ozio o comunque estraneità ad una mentali-tà produttiva; tratti dei quali viene stigmatizzata proprio la nefasta influen-za sulla qualità della vita civile e dell’organizzazione dello stato (p. 4):
La campagna [del Friuli], all’uso di Francia e di Polonia, è abitata da molta quantitàdi nobili, o sia di gentiluomini viventi d’entrata e professori per lo piú di bravura[cioè vita da bravi] e vita licenziosa ed oziosa, dalle quali condizioni nasce che ilpaese è pieno d’uccisioni e d’altri scandalosi successi, con rovina miserabile di fa-
58. D’altra parte, in un altro inciso, Zilioli non esita – pur con un ragionamento contortoe con parole ambigue – ad “alzare il tiro”: quando il comandante in capo, il de’ Medici,decide di inoltrare una lettera di protesta al Senato veneto lamentando che le questioni di“precedenza” nobiliare e l’arroganza di molti aristocratici del campo gli impediscono di con-durre la guerra nel migliore dei modi, riceve una risposta chiaramente evasiva: «Dal qualofficio avendo conosciuto il Medici l’intenzione del Senato, e che indarno cercava acrescimentid’auttorità dove si desiderava anzi disminuire e di rafrenare l’eccedenze de i troppo potenti,tralasciò di pretender altro ed attese poi con l’animo quieto alla sua carica » (p. 31). Una fraseche contiene una chiara aporia logica: il Senato sarebbe il luogo dove si lavora per «disminuiree […] rafrenare l’eccedenze de i troppo potenti»: ma qui, invece di offrire al de’ Medici ilnecessario «acrescimento d’auttorità» per poter condurre la guerra (dunque non si tratta diridurre un potere che c’è e sarebbe troppo, ma di conferirne uno giusto e necessario), ilSenato evita di limitare quello dei suoi fratelli di casta, quei nobili che al campo, con la loro«eccedenza» di potere (proprio quella che sarebbe opportuno «disminuire»), stanno ren-dendo difficile la gestione dell’esercito.
massimiliano malavasi
194
miglie che, già ricche e mercantili, applicatesi poi all’ingiurie di nomi e di affetti,sono cadute nell’ultime calamità.
I soldati poi, anche quelli che militano nell’esercito della propria città, sonosolo «persone feroci e sanguinarie, e per il piú di cattivi costumi», chespesso «perdono il timore dovuto verso i magistrati, conturbano tuttigl’ordini, precipitano l’imprese, e riducono finalmente se medesimi e glialtri in perdizione» (p. 7), e la «professione della guerra, che si stima pureesser la piú grave ed importante di tutte le arti che si trattano fra gli uomi-ni», è «conforme anzi all’istessa pazzia» (p. 9).59 Un crescendo che giungea compimento nel grandioso affresco delle “vite parallele” del glorioso co-mandante Orazio Baglioni e dell’abile mercante Bartolomeo Bontempel-li, deceduti entrambi in breve spazio di tempo ed entrambi celebrati dalloStato veneziano nella stessa chiesa cittadina, coincidenza che permette aZilioli l’impari confronto tra il buon soldato, che per quanto lodabile restaun operatore di morte e di distruzione, e il buon mercante, costruttore dibenessere per sé e per lo stato. Una pagina che per la sua pregnanza e perla sua rarità nell’ambito della cultura secentesca, merita di essere riportataper intero (pp. 29-30):
Nel qual tempo medesimamente fu celebrata la memoria di Bartolomeo Bontem-pelli mercante Veneziano di preclara ricordazione, il quale essendo vissuto lunga-mente in quella Patria con piena integrità e splendidezza, ed avendo edificato edotato riccamente l’ospitale famoso de Poveri Mendicanti, si meritò che nella Chie-sa del luogo predetto gli fosse eretta l’efigie in marmo e scolpito anco l’Epitaffiocontenente le qualità sue. Onde fu data ampia occasione a i curiosi di discorreredel merito dell’uno e dell’altro e comparando insieme le azioni loro, di considerarequale di essi maggior gloria e felicità si avesse acquistata, o il Perugino con la spadao il Viniziano con la penna, al quale molti, né senza fondamento, giudicavano inciò doversi attribuire il primo luogo. Poiché se quegli aveva servito fedelmente alsuo Prencipe e perduta anzi per ciò la vita propria, questi aveva all’incontro ottenu-ta l’istessa gloria co ’l soministrare mediante i suoi trafichi, l’alimento al publico edil nutrimento a i privati. E se in quello il comando e la pompa militare fu riguar-devole, anco in questi riuscí considerabile lo splendor dell’oro e delle mercanzieed i favori e dimostrazioni di benevolenze che ricevette da molti Prencipi grandi
59. Sull’esaltazione della gloria militare quale tratto formale costante della cultura aristo-cratica che dominava l’Italia del Seicento si veda G. Benzoni, I « frutti dell’armi»: volti e risvoltidella guerra nel ’600 in Italia, Roma, Ist. della Enciclopedia Italiana, 1980 (e poi Ventimiglia,Philobiblon, 2004), con la mia “postilla” Ancora sui « frutti dell’armi», tra “Polimnia” e “Clio”:l’immagine della guerra nel Seicento dai generi letterari alla storiografia, in Scrittori di fronte alla guerra.Atti delle giornate di studio, Roma, 7-8 giugno 2002, a cura di M. Fiorilla e V. Gallo,Roma, Aracne, 2003, pp. 121-45.
capriata, zilioli e la guerra di gradisca
195
fin dentro le proprie case. Chi, se si riguarda all’arti per se medesime, chi potevacomparar quella del Soldato, essercitata dal primo con ingiuria e violenza e conesterminio di tante famiglie, con che si rese odioso ed inimico di molti, alla profes-sione della mercatura trattata quiettamente da quest’altro e senza ingiuria d’alcu-no, ma con sollevazione anzi di molte case, ristorazione de luoghi sacri, riputazionedella Patria e benevolenza estraordinaria di tutti gli ordini de gl’abitanti? Avendofinalmente il Veneziano di gran lunga superato il Perugino nella lunghezza e pro-sperità della vita e nel genere della morte, a che quello lieta e tranquilla e piantacon vere lagrime da molti, ed a quest’altro dopo un lungo corso di patimenti, d’in-giurie e di altre calamità, toccò molto lagrimoso e doloroso e da chiamarsi ancodetestabile, se l’abuso dell’ingegno umano non la facesse apparire in qualche partedifferente di specie ed onorevole appresso coloro che dall’essercizio di quest’artericonoscono principalmente la conservazione e l’agrandimento delle loro fortune.
Le ragioni profonde delle scelte ideologiche del «cittadino» venezianoZilioli vanno cercate nella sua formazione intellettuale e nella sua biogra-fia e quindi – in ultima analisi – nella storia della sua dinastia familiare.Considerando l’interesse che recentemente hanno suscitato la sua figura ei suoi scritti di storiografia letteraria, e risultando antiquate o lacunose lenotizie attualmente disponibili sulla sua persona,60 non sarà inopportunodescrivere a grandi linee la storia di questo poligrafo veneziano del Seicen-to e della sua famiglia proprio per comprendere appieno il senso dellescelte stilistiche e tematiche da lui operate nelle sue Historie memorabili.
Tale storia è ricostruibile grazie a un testo di particolare valore memo-rialistico e documentario, la Cronichetta da Ca’ Ziliol redatta da Andrea Ziliol,avo del nostro storico, nella prima metà del Cinquecento e poi continuatada Alessandro un secolo dopo.61 Presentati prima nell’italiano venezianeg-
60. Alessandro e tutti i suoi antenati quattro-cinquecenteschi sono tra i principali oggettidi studio di una ricerca di ampio raggio compiuta da Anna Bellavitis (Identité, mariage, mobilitésociale. Citoyennes et citoyens à Venise au XVIe siècle, Rome, École Française de Rome, 2001), mala studiosa non ha potuto in quella sede approfondire l’indagine sul nostro storico. Se si tra-lasciano le indicazioni biografiche assai imprecise contenute nel breve intervento di MicheleCataudella (Introduzione alla lettura delle ‘Vite dei poeti’ di Alessandro Zilioli, in «Esperienzeletterarie», a. iv 1979, fasc. 3 pp. 103-11), il ritratto piú esauriente del nostro scrittore è ancoraquello di Morelli (Biblioteca manoscritta, cit., pp. 364-71). Zilioli costituí l’eminenza grigia dellastoriografia letteraria sette-ottocentesca (a riguardo si veda F. Arato, La storiografia letterarianel Settecento italiano, Pisa, Ets, 2002, spec. le pp. 21-23) per le sue Vite de’ poeti, un repertorioa tutt’oggi manoscritto di cui si conserva l’autografo (Genova, Biblioteca Durazzo, ms. A I 2)e tre copie: BMV, It. X 1 (= 6394); Civico Museo Correr (da qui in poi CMC), ms. n. 869;University of Kansas, Spencer Library, ms. C 209 (vd. D. Dutschke, Census of Petrarchan Ma-nuscripts, Padova, Antenore, 1986, pp. 154-55).
61. CMC, ms. Correr 963/5 (da cui le citazioni che seguiranno). La Cronichetta è stata
massimiliano malavasi
196
pubblicata in appendice a Bellavitis, Identité, mariage, mobilité sociale, cit., pp. 337-53. AndreaZiliol (1457-1544) fu anch’egli storico: a lui si deve l’inedita cronaca Storie dei suoi tempi conser-vata nel codice BMV, It. VIII 328 (= 8513). L’attribuzione della seconda parte della Cronichet-ta ad Alessandro risale già ad Apostolo Zeno (Appunti genealogici e biografici di famiglie venete,BMV, It. VII 351 [= 8385], c. 367r); vd. anche G. Tassini, Cronaca di Famiglie Cittadine OriginarieVenete, ASV, Miscellanea Codici - serie i - Storia veneta 16, to. xiii cc. 2318r-2319r; inoltre:Cronaca di Famiglie Cittadine Originarie Venete, BMV, It. VII 27 (= 7761), cc. 75r-79v. L’attribu-zione viene anche certificata da Giovanni Degli Agostini (Notizie istorico-critiche intorno la vitae le opere degli scrittori viniziani, Venezia, Simone Occhi, 1752, rist. anast. Bologna, Forni, 1975,p. 608). Dallo stesso patrimonio di memorie familiari, coadiuvate da conferme contenutein atti ufficiali dello stato, nacque un opuscolo a stampa intitolato Summario dei meriti dellafamiglia Ziliola (s.i.t.) – BMV, It. XI 211 (= 6735) – fatto stampare da Camillo Ziliol intorno al1610 per promuovere la propria candidatura al ruolo di Segretario del Consiglio dei Dieci.
giante di Andrea e poi nella lingua postbembesca (ma qui ancora convenature dialettali) di Alessandro, sfila innanzi al lettore la malinconicagalleria di uomini e donne della famiglia Ziliolli, quattro secoli di una di-nastia di mercanti, guerrieri, burocrati, letterati che avevano conosciutomomenti di grande splendore economico e politico, come rivelano le vi-cende di quel Zuanne che aveva armato una compagnia di soldati metten-dola al servizio della Serenissima nella guerra contro Zara nel 1204, comefece anche un Piero che combatté contro la stessa città nel 1345 con una suacompagnia di 40 balestrieri; di Paolo Zilioli, che aveva comprato all’asta ibeni del doge decapitato Marin Falier nel 1355; di Marco, che aveva armatoper la guerra contro Genova una sua nave (la Cocca Ziliola) e Zambon, cheaveva approntato la piú grande nave da mercanzie del XV secolo.
Membri di spicco della «cittadinanza originaria» veneziana, ovvero diquel ceto altoborghese dedito perlopiú ai grandi commerci, gli Zilioli –privi di titoli di nobiltà – erano esclusi dalla gestione diretta del potere: maa seguito di una serie di difficoltà incontrate nei traffici, si dedicarono conimpegno ad occupare ruoli di rilievo dell’apparato burocratico della Sere-nissima, ottenendo incarichi di grande prestigio: addetto all’Ufficio delleAcque, «extraordinario dell’ordene de Secretar», «Guardian Grando dellaScola di S. Marco», Avvocato della Avogaria Criminale, Avvocato fiscaledella Repubblica, Deputato della Camera d’Imprestidi, Cancelliere Ducale.Carriere prestigiose che crearono nella famiglia Zilioli un marcato senso diappartenenza allo stato veneziano e un profondo senso di responsabilitànella gestione dell’organizzazione della repubblica, sentimenti che spiega-no l’orgoglio con il quale la Cronichetta racconta l’episodio dell’incendio delPalazzo Ducale durante il quale i membri della famiglia si affannarono pertrasferire l’archivio dello stato dalle stanze minacciate dalle fiamme diretta-
capriata, zilioli e la guerra di gradisca
197
mente nelle loro case (cc. 146v-147r). Una cosí ramificata presenza nei mean-dri della macchina amministrativa, a strettissimo contatto con le massimecariche della politica veneziana (i Cancellieri ducali collaboravano diretta-mente con il Doge e il Consiglio dei Dieci) si accompagnò naturalmentealla difesa dei propri interessi commerciali e dunque alla prosperità econo-mica, ai legami matrimoniali con casate importanti anche della migliorenobiltà cittadina, all’aumento del numero dei membri della famiglia passatiper gli studi universitari, alla frequentazione del milieu intellettuale vene-ziano, all’emergere di scrittori (in particolare lo storico Andrea e il poligrafoVettor, amico del Sansovino)62 e addirittura a forme di mecenatismo (comequella di Scipione nei confronti di Andrea Calmo).63 Un percorso che cul-minò nella partecipazione di Cesare e Giulio (padre del nostro storico) alballottaggio per la carica di «Cancelliere Grando», il vertice assoluto dellamacchina burocratica statale, figura in possesso di grandi poteri, di fattosuperiore a tutti i ranghi della nobiltà esclusa dal Consiglio dei Dieci, unruolo che avrebbe forse consentito di avviare la casata verso quella prosperasolidità economica che, complici le occasioni offerte dalle vicende del XVIIsecolo, avrebbe potuto costituire il preludio alla nobilitazione.
Rampollo di questa gloriosa dinastia, Alessandro era nato presumibil-mente nel 1598: la notizia si ricava dall’atto di assunzione nel ruolo di «re-pertor» di una delle Cancellerie inferiori stilato il 7 agosto 1614;64 si tratta diun piccolo gesto di ordinario nepotismo dal momento che il documento èfirmato dal padre di Alessandro, Giulio, e dal suo collega Bartolomeo Moro,i due Cancellieri ducali in carica: considerando che al tempo l’età minimaper l’assunzione di notai di rispetto nei ranghi di tale sezione della Cancel-leria inferiore era di 16 anni,65 e che in quei giorni la fortuna politica di
62. Sansovino celebra la famiglia Ziliol e ricorda l’amico Vettor in Venezia città nobilissimae singolare, Venezia, appresso Iacomo Sansovino, 1581, risp. pp. 236r e 259r. Un altro Vettor èricordato da Girolamo Diedo ne L’Anatomia celeste, Venezia, Zenaro, 1593, p. 295.
63. Cfr. [A. Calmo,] Le lettere di messer Andrea Calmo, riprodotte sulle stampe migliori conintroduzione ed illustrazioni di V. Rossi, Torino, Loescher, 1888, pp. 212-14.
64. ASV, Avogaria di Comun, 4463, Penale 313/12, c. 2r.65. A. Zannini, Burocrazia e burocrati a Venezia in età moderna: i cittadini originari (sec. XVI-
XVIII), Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, 1993, p. 174. Il ruolo di «coadiutor»o «repertor» della Cancelleria costituiva una delle mansioni di piú basso profilo nell’ambitodel funzionamento della macchina burocratica veneziana e consisteva nel prelevare dall’ar-chivio i documenti richiesti dal notaio per la stesura di atti, trattati, proposte di legge: «Essen-do l’ufficio della Cancelleria inferior della importanza a tutti nota sí per causa della custodiadelli testamenti come di tutte le altre scritture della Cancelleria inferior a lor commesa síetiam per le sue varie operazioni che continuamente sono obligati esercitar per le qual sono
massimiliano malavasi
198
Giulio Zilioli era ai suoi massimi (e dunque per costui doveva essere facilefar assumere il primogenito nella burocrazia statale), ecco che ricaviamoquella presunta data di nascita che bene si accorda con l’altra testimonianzaa nostra disposizione, quella di Angelico Aprosio, il quale in una lettera aLeone Allacci afferma che Zilioli «fu cittadino veneziano dotato di buonacognizione di lettere. Fu, mentre visse, mio amico e l’anno 1645 fu rapitodi morte improvvisa d’età di 46 in 48 circa».66
Se ne può dedurre, data la giovane età di Alessandro al tempo dell’assun-zione, che il nostro storico non avesse compiuto studi universitari, comeusuale nell’ambito della burocrazia spicciola della Serenissima, ma avessefrequentato le scuole cittadine che formavano i futuri membri della cancel-leria,67 come la famosa Scuola Grande di San Marco della quale il bisnonnoVettor, il nonno Alessandro, il padre Giulio e un gran numero di zii e pa-renti vari avevano ricoperto il ruolo di “Guardian Grando” o avevano svoltovari impieghi organizzativi e amministrativi e dove lui stesso, per gli anni1614 e 1627, risulta insignito della carica annuale di «Degano di tutt’anno».68
soliti aver sempre li suoi Repertori over coadiutori di loro dependenti come persone dellequali si potessero fidar in far cercar le scritture secondo il bisogno di ciascuno» (estratto dalLibro delle promissioni del Prencipe [7 gennaio 1527] conservato in ASV, Avogaria di Comun, 4463,Penale 313/12, c. 3r). Che si trattasse di un compito davvero umile lo testimonia anche il co-lorito aneddoto riportato da Trebbi che ricorda come un’autorità quale Renier Zeno, in oc-casione di una sorta di sciopero dei secretari, «convenne da per sé, con rischio anco della vita,pigliar la scala, e portarla dov’era il libro, e salirla con la veste, e stola di Capo del Consiglio deiDieci, e venir giú tutto polvere» (G. Trebbi, Il segretario veneziano. Una descrizione cinquecentescadella cancelleria ducale, in «Archivio storico italiano», a. cxliv 1986, pp. 35-73, a p. 58).
66. G. Manacorda, Dai carteggi allacciani. Note bibliografiche, in «La Bibliofilia», a. iii 1902,pp. 382-87, a p. 383. Anche questa notizia è coerente con quanto dichiarato dall’editore GiovanMaria Turrini nella premessa alla terza parte delle Historie Memorabili, datata 1646: «questaterza figlia postuma del Signor Alessandro Ziliolo, della quale ho avuto io la cura per darlela luce delle mie stampe» (pp. 2-3 n.n.).
67. «Elemento indispensabile per sostenere questa condizione civile era la preparazionescolastica. Si è visto come tutti i cittadini frequentassero fin dalla piú giovane età lezioniprivate o pubbliche, fossero seguiti da precettori o, se già inseriti nella carriera cancelleresca,attendessero ai corsi della scuola di San Marco» (Zannini, Burocrazia, cit., p. 278); e «Laformazione letteraria e filosofica non venne mai considerata determinante […] per la carrie-ra cancelleresca, ne faceva prova l’esiguo numero di funzionari che potevano vantare studiuniversitari » (ivi, p. 175; sul tema vd. anche G. Trebbi, La cancelleria veneta nei secoli XVI eXVII, in «Annali della fondazione Luigi Einaudi», a. xiv 1980, pp. 65-125). Al periodo deglistudi scolastici risale una sorta di quaderno di appunti di Alessandro (CMC, ms. 25) intitola-to Lucubrationes variae Alexandri Zilioli Julii filii. Volumen Quartum. Venetiis. Anno mdcxiiii (nono-stante l’indicazione del titolo, la maggior parte dei “capitoli” interni riporta la data 1611).
68. ASV, Fondo Scuola Grande di San Marco, Busta 6 bis: Registri dei confratelli, cc. 37ve 38v.
capriata, zilioli e la guerra di gradisca
199
Di Alessandro sappiamo inoltre che si sposò verso la fine del 1626 conAgnesina Roma (appartenente a una famiglia di rispettabile tradizione manon nobile e nemmeno iscritta alla Cittadinanza originaria), come docu-mentato dal contratto matrimoniale stipulato dal padre Giulio il 7 settem-bre di quell’anno.69 Dall’unione nacquero due figli che con rigorosa fedeltàonomastica alla tradizione familiare furono chiamati Giulio ed Elena (esat-tamente come i nonni). La sposa portava in dote 16.000 ducati, una cifradavvero considerevole70 che documenta il prestigio raggiunto dalla fami-glia Zilioli, tale da spingere i familiari di Agnesina a impegnare una sommache avrebbe potuto procurare un matrimonio nobiliare pur di garantirsiun legame con la potente famiglia cittadinesca. Tuttavia, proprio la sceltadi un matrimonio cosí remunerativo fa sorgere il sospetto che l’impegnoeminentemente politico e burocratico di Giulio e una scarsa predisposizioneverso gli affari e la carriera da parte di Alessandro potessero aver incrinatola situazione finanziaria e reso prioritaria l’esigenza di “fare cassa” rispettoa quella di continuare nella tattica tesa ad intrecciare legami con il patrizia-to, quella tattica che aveva portato Giulio e il fratello Camillo a sposaredelle Bragadin.
Ma le notizie piú interessanti sulla vita di Alessandro provengono da unaltro documento dell’Archivio dei Frari, gli atti del processo intentato aisuoi danni agli inizi del 1628:71 nei primi giorni di gennaio Francesco Eriz-zo, membro della Cancelleria inferiore, chiedeva alla Avogaria di interve-nire nei confronti di Alessandro Zilioli, «repertor o coadiutor» della Can-celleria inferiore stessa. Costui «il quale se ben non vole attender a dettosuo carico però solito a capitar alle volte in essa Cancelleria, si è dato a talforma di disprezzo e di mali costumi meco che è impossibile poterlo to-lerare»; «avendo lungamente sofferto ho convenuto di passar condoglian-ze a esso Signor suo Padre, mio collega, acciò che dall’avvertimento delPadre, qual poi mi ha riferito averlo ammonito, si riducesse al buon co-stume ed all’essecuzion dell’obligo suo»; ma invece Alessandro «fatto piúaltiero et piú insolente da questo atto mio cortese è divenuto a tanto di-sprezzo che il primo giorno del corrente di mattina capitato nella Cancel-leria non solamente senza scoprirsi [il capo] ma con atti di gran sprezaturavoltandomi apertamente la schiena dal qual cattiva sua opperazione aven-
69. ASV, Ospedali e lughi Pii Diversi, 132, fasc. A, cc. 22r-30v.70. Cfr. Bellavitis, Identité, mariage, mobilité sociale, cit., spec. il par. Valeurs, compositions,
significations de la dot, pp. 184-207.71. ASV, Avogaria di Comun, 4463, Penale 313/12.
massimiliano malavasi
200
dolo corretto, prorumpe in parole indecenti cosí alla mia nascita ed al ca-rico che io tengo come al luogo mio solito ove risiedo che è la Cancelle-ria»; «[…] non contento di questo suo eccesso, con grande impeto», Ziliolisi sarebbe proteso verso l’Erizzo e chissà cosa sarebbe successo se «da per-sone che si trovavano presenti a tanto mostro e dal proprio suo padre nonfosse stato quasi da peso portato fuori dalla Cancelleria» (c. 1r).
Il giudice incaricato provvedette a procurarsi i documenti necessari esubito cominciò gli interrogatori dei testimoni72 e dell’imputato, il qualeaffermò che «Avendo già dato risposta al M. Francesco Erizzo […] questoprorupe contro di me in parole brute ingiuriosissime, e che me intacavanonella riputazion, replicandole molte volte con voce strepitose» e che «MesserErizzo mi tirò effettivamente alla volta della testa due Caramali di bron-zo, che certo se mi colpivano mi privavano di vita» (c. 21r). Le altre testi-monianze delineavano un quadro di inveterate tensioni personali senzarimandare ad altro che all’incompatibilità caratteriale tra i due. La sentenzaarrivò il 4 marzo 1629: sospendeva Alessandro per quattro anni dall’incari-co e lo bandiva dalla Cancelleria inferiore sotto minaccia di condanna al-l’esilio: «Ma se nel termine di mesi doi prossimi averà la pace da M. Fran-cesco Erizzo Cancellier inferiore» resterà «privo della suddetta Repertoria,et di poter andar nelli pubblici offizi per mesi sei solamente, e nelle spesedel processo» (c. 27r).
Sulla vicenda si possono svolgere le seguenti riflessioni. Innanzitutto,Alessandro, assunto nel 1614 con l’umile mansione di «repertor», dopo quin-dici anni di servizio non è salito di un solo gradino nella scalata ai piani al-ti della pubblica amministrazione. Erizzo, nella denuncia, allude al suoassenteismo e alla mancanza di impegno nel lavoro («il quale se ben nonvole attender a detto suo carico però solito a capitar alle volte in essa Can-celleria»): l’accusa potrebbe essere originata da semplice livore personale,ma certo aveva buone possibilità di essere creduta dal momento che l’as-
72. Eccone uno specimen che restituisce il clima della situazione, una scenetta da comme-dia goldoniana; Girolamo da Riva testimoniò che Alessandro aveva risposto al saluto del-l’Erizzo: « cavandosi anche lui la beretta gli rispose dicendo “Bondí Messer Erizzo” et essoM. Erizzo sogionse “ti non ti vergogni petulante, o isfazzado” o parole simili “a venir quisenza salutarmi”, rispose esso Zilioli “perché mostri che ti saludei, non ti voglio saludar”, equi cominciorno una parte e l’altra a dirsi […] delle villanie e delle parole ingiuriose» e«cominciando ad ingiuriarsi da parole si dettero a delli caramali […] l’uno contro l’altro chenon so chi da loro sia stato il primo a trar» (c. 4r-v). Secondo Giovanni (Zuanne) BonfantiErizzo per primo aveva detto «“ti [s]e un furbo” e il detto Alessandro gli rispose “ti so per unfurbo e un furfante ti”» (c. 11v).
capriata, zilioli e la guerra di gradisca
201
senteismo degli “statali” era annoso problema del funzionamento dellaCancelleria.73 Simile condotta era motivata dalla stessa molteplicità degliincarichi sostenuti dagli impiegati (ragion per la quale quella che risultavaassenza da un servizio era in realtà svolgimento di un’altra mansione all’in-terno dello stesso ufficio pubblico); ma soprattutto va ricordato che il cit-tadino originario, pur impiegato nel servizio, doveva continuare a gestiregli affari di famiglia dal momento che lo stipendio pubblico non gli garan-tiva nemmeno lo status sociale aduguato alla posizione lavorativa, l’«hono-revolezza» che testimoniava e giustificava la posizione raggiunta e prepa-rava la strada agli avanzamenti di carriera.
Per il caso di Alessandro poi dobbiamo tenere presente la passione pergli studi e per le ricerche, passione che doveva togliergli altro tempo edessere, presumibilmente, la prima delle sue preoccupazioni. Sarà stato for-se questo insieme di elementi a determinare la stasi della sua carriera, macerto sembra strano che l’importante posizione occupata dal padre Giulionon gli avesse permesso, proprio in un quadro in cui l’assenteismo eramanchevolezza diffusa, di far passare in secondo piano lo scarso impegnonella professione e di avanzare nell’ordine dei ranghi della Cancelleria.Vanno poi considerate la stessa velocità e la determinazione con le qualil’Avogaria di Comun intervenne nei confronti di Alessandro,74 aspetti chelasciano pensare che la vicenda del furioso litigio con l’Erizzo fosse il rifles-so di una prova di forza già in atto non solo tra i due ma tra le rispettivefamiglie o tra schieramenti interni alla Cancelleria, e l’esito fu una sconfit-ta degli Zilioli.75
73. «Un altro fattore di disfunzione del servizio era costituito dall’attitudine, ben radica-ta nel corpo dei funzionari, ad assentarsi dal lavoro o a svolgere in maniera inadeguata leproprie incombenze» (Zannini, Burocrazia, cit., p. 127).
74. Quando un gruppo sociale mira a forzare i meccanismi dello stato e le leggi di mer-cato per costituirsi casta socioeconomica privilegiata ha l’esigenza primaria di rendere inef-ficiente l’amministrazione della giustizia o con leggi specificatamente tese a difendere ipropri membri o svalutando l’operato della magistratura con incertezze legislative e lungag-gini operative. Il gruppo sociale della piú alta aristocrazia veneziana, per poter difendere ipropri privilegi, oltre a promuovere riforme della costituzione statale, come l’istituzione delConsiglio dei Dieci o la Serrata del Maggior Consiglio, lasciò progressivamente cadere nelcaos organizzativo l’amministrazione della giustizia, un campo in cui prosperava una curio-sa forma di corruzione tesa non tanto a ottenere processi falsati, quanto semplicemente adaffrettare i giudizi per le cause per le quali si riteneva probabile una vittoria: cfr. G. Cozzi,Giustizia « contaminata». Vicende giudiziarie di nobili ed ebrei nella Venezia del Seicento, Venezia,Marsilio, 1996.
75. Per avere un’idea della complessa trama delle lotte interne agli apparati statali vene-ziani si può leggere l’aneddoto relativo alla contestata elezione di Giulio Zilioli al ruolo di
massimiliano malavasi
202
Non sappiamo quale fu il seguito della vicenda. Alessandro era certa-mente di nuovo a Venezia nel 1633, cioè allo scadere dei quattro anni: nonsappiamo quindi se fosse riuscito ad ottenere, chissà a prezzo di quali umi-liazioni, il perdono di messer Erizzo, né se avesse continuato imperterritonel suo atteggiamento sprezzante, magari rimettendo piede in Cancelle-ria, con la conseguente condanna all’esilio; oppure se avesse fatto trascor-rere pazientemente i quattro anni in attesa di riprendere le sue mansioni,conservando l’inimicizia con il collega del padre. Possiamo solo dire chenel 1633 era certamente a Venezia, come dimostra il già citato documentodell’ASV, Ospedali e luoghi Pii Diversi 132/A, che alle cc. 32r-38v contieneuna serie di dichiarazioni rilasciate da Alessandro e dalla sorella Caterinadavanti a un notaio in merito alla restituzione della dote, dichiarazionirelative al patrimonio del padre, il quondam messer Giulio, e alle sostanzedella madre ancora in vita, per la quale viene affittata un’abitazione inContrà S. Caterina. Tra il 1629 e il 1633 era dunque morto il venerandoSecretario Ducale Giulio e la vedova Elena abbandonava l’abitazione dirappresentanza per andare a vivere in affitto. È forse un indizio della diffi-cile situazione patrimoniale della famiglia.76
Il processo, la morte del padre (che qualunque fosse stato il seguito dellavicenda processuale, lo lasciò alla mercé dei suoi nemici), le probabili dif-ficoltà economiche, le responsabilità nella conduzione della famiglia: sa-ranno certamente queste le sventure alle quali allude Alessandro quando si
Cancelliere Ducale narrato da Cicogna (vd. E. Cicogna, Delle iscrizioni veneziane, Venezia,presso la Tipografia Andreola, vol. vi 1853, pp. 583-84).
76. L. Megna, Comportamenti abitativi del patriziato veneziano (1582-1740), in «Studi venezia-ni», a. xxii 1991, pp. 253-323. L’intervento è dedicato al ceto nobiliare, ma ne emergono utiliindicazioni anche per i cittadini dal momento che i rappresentanti di alto rango di questogruppo sociale tendevano ad equipararsi al patriziato nello stile di vita. Sulla base delle de-cime del catasto (la tassa sulla casa) la Megna ha evidenziato che almeno la metà dei nobili(non necessariamenti i piú poveri) tendevano a vivere in affitto; ma certo l’abbandono dellacasa di S. Anzelo, piú volte ricordata come orgoglio e cura degli avi nella Cronichetta, sembraindice di un’esigenza di risparmio: «Momento imprescindibile di autoaffermazione familia-re per il nuovo patriziato è soprattutto la costruzione o l’acquisto e la piú o meno radicalericostruzione o semplicemente l’abbellimento della propria residenza» (ivi, p. 313). Una se-rie di indizi che sarebbe lungo analizzare in questa sede e che provengono dalle carte con-tenute nel faldone Cicogna 3430 (Documenti riguardanti la famiglia Ziliola) del CMC fanno pen-sare al tramonto della casata; in breve si può ripetere per gli Zilioli quanto affermato da Zan-nini relativamente ad altre famiglie cittadinesche: « il fatto che a metà ’600 […] non si offri-rono di sostenere l’esborso di 100.000 ducati necessario per acquistare la nobiltà seguendoaltre famose famiglie» è indizio del « tramonto di questa onorevole casata cancelleresca»(Zannini, Burocrazia, cit., p. 147).
capriata, zilioli e la guerra di gradisca
203
definisce «infelice per lunga serie di calamità» in un’opera con tutta pro-babilità databile alla seconda metà del 1633. Si tratta della Difesa delle Ragionie Maestà della Serenissima Repubblica di Venezia Contro il Libro Publicato da Sa-voiardi, un trattato sulle polemiche relative al possesso legale dell’isola diCipro scritto col dichiarato intento di guadagnarsi l’aiuto della massima auto-rità veneziana.77
Le esplicite evidenze documentarie sulla vita di Alessandro Zilioli fini-scono qui: per gli ultimi anni di vita del nostro scrittore disponiamo solodella citata testimonianza di Aprosio, che informa sulla presenza e l’attivitàa Venezia intorno alla metà degli anni ’40, testimonianza da associare al-l’evidenza dell’ampia produzione (i tre volumi delle Historie Memorabili e levarie altre opere manoscritte), che lascia presupporre un lungo periodo diraccolta di materiali (libri storici, gazzette manoscritte e a stampa, relazionidi viaggiatori e di diplomatici, ecc.) e di studi e ricerche. Si può quindi soloimmaginare che il nostro storico abbia trovato una qualche sistemazioneche, se non garantiva piú prestigio e ricchezze alla famiglia, dovette tutta-via permettergli una certa tranquillità e la possibilità di dedicarsi finalmen-te alla passione degli studi storici e letterari: la riammissione nei ranghiinferiori della Cancelleria o la svogliata gestione dei traffici commercialifamiliari s’adattano bene entrambi al quadro delineato.
Valutando ora quel breve inciso sulla guerra di Gradisca nel contesto diun’intera esperienza biografica di questo tipo, si inizia a intuire il nesso trala dialettica tra i ceti veneziani vissuta da Zilioli e la sua particolare ricettivitànei confronti delle riflessioni sociologiche e politiche del Moisesso. Unapur superficiale indagine sul resto della produzione letteraria di questo po-ligrafo veneziano rivela un sentimento forte di appartenenza al proprio ce-to «cittadinesco» ma anche lo sviluppo di tale afflato emotivo in una ri-flessione ideologicamente marcata che lo conduce a formulare un vero e
77. BMV, It. VII 334 (= 7778). Sicuramente autografo, per l’evidente similitudine con altrimanoscritti zilioliani nonché per una serie di elementi che documentano trattarsi di unabozza di lavoro forse da destinare alla stampa: tratto veloce e disattento, numerose correzio-ni e riscritture, presenza alle cc. 73-74 di appunti personali, tutti elementi incompatibili conla dedica al Doge e che rendono impensabile il dono di questo codice. Nella citata dedicaZilioli afferma che «Non doveva alcuno Serenissimo Prencipe Illustrissimo […] attribuire atemerità se io debole per dottrina et infelice per lunga serie di calamità ardisco di appresentarmialle Eccellenze Vostre che sono per esempio delle Grazie, l’albergo della speranza e l’essem-plare della felicità» (c. 2r). E da notare che il fallimentare tentativo di proporsi come storiografoe polemista segnala la coscienza di Zilioli di appartenere ormai a un’altra condizione socialee culturale rispetto agli avi, coscienza che lo spinse a proporsi come strumento della propa-ganda del suo stato nell’ambito della storiografia.
massimiliano malavasi
204
proprio programma culturale ispirato a quella che appare a tutti gli effettiuna matura coscienza di classe, espressa con accenti e toni davvero sor-prendenti per il tempo in cui visse. A partire dal giovanile poema Costan-tinopoli acquistata,78 dove, narrando della guerra sotto le mura di Zara nel1204, fa scendere in campo, nelle vesti e nei modi di un eroe epico, il suoantenato Ziliolo Zilioli per sconfiggere in singolar tenzone il campione deizaratini ribelli a Venezia (iv 85-87, pp. 99-101), delineando un quadro do-ve la boria nobiliare si accompagna perlopiú a origini infami e a condottaimmorale,79 e avanzando esplicite indicazioni sull’obbligo che corre ai sag-gi governanti di riconoscere la “nobiltà” dei benefattori dello stato (v 21, p.117):
L’istessa plebe e ’l popolo piú vilenon disprezzar, ma strada e modo impartiper cui inalzato inanzi chi fu umilete aggrandir possa e piú poter desiarti.Ma chi Natura fe ricco e gentile,fa che goda di sé: dal volgo il partidi nome e di potere. È villanianon nobile chiamar chi nobil sia.
Per passare a Le due corone della nobiltà veneziana,80 un repertorio di sche-de storiche sulle famiglie nobili e su quelle “cittadine” veneziane, significa-tivamente e coraggiosamente accomunate sotto l’unica etichetta di “nobil-tà” secondo un programma ideologico e culturale ben costruito su un ter-reno di solide conoscenze storiche e dichiarato a piena voce (c. 1r-v):
In Vinegia, Città nobilissima non solo d’Italia ma del Mondo tutto, due ordini digentiluomini si ritrovano come a ciascheduno è noto. Percioché quei nobeli, cheportano seco dalla nascita giurisdizione e prerogativa d’intervenire col voto Lo-ro nel maggior Consiglio della Città, Patrizi e nobili di Consiglio sono chiama-ti. Quegli veramente che nascono, e viveno nobilmente ma non hanno voto nel
78. [A. Zilioli,] Copia de i primi Cinque Canti della Costantinopoli Acquistata, Poema Eroico DiAlessandro di Giulio Ziliolo, s.i.t., 1620, e poi Venezia, Bernardino Corsi, 1622 (da cui le citazio-ni che seguono).
79. «Costui d’animo vil, di stirpe umile: / meretrice ebbe madre: il nome espose / dinobil casa e si formò gentile, / a maniere sprezzanti e boriose / le vesti aggiunse di valorsimile» (iv 51, p. 90).
80. BMV, It. VII 4-5 (= 7925-7926), autografo, e It. VII 549 (= 7942), copia settecentesca.Altra copia in CMC, 2459. L’opera è anonima, ma l’attribuzione a Zilioli è tradizionale erisale al Seicento stesso, probabile ricordo degli ambienti eruditi cittadini, e la dichiara Gio-vanni Palazzi nei Fasti ducales (Venetiis, Typis Hieronymi Albrizzi, 1696, pp. 193, 250 e 263).
capriata, zilioli e la guerra di gradisca
205
maggior Consiglio, gentiluomini popolari si restano. Ma secondo l’uso volgare iprivati vengono chiamati gentiluomeni Nobeli, et gli altri […] Gentiluomeni Cit-tadini. I quali due ordini benché differenti fra loro de autorità, e di condizione(percioché i Patrizi ottengono il Prencipato della Repubblica ed i gentiluomenipopolari, a Loro suditi, sono quelli [che] esercitano i generalati, le Prefetture, LeLegazioni, ed altri magistrati, questi attendono quietamente a godersi le facoltàLoro e quegl’onori, che nella Città Loro ed altrove conseguiscano) nondimenoregnano una egualità […] molto notabile nella vita civile, cosí come nell’uso delleToghe, e nelle splendidezze del vivere, come nelle pratiche e ne i spettacoli, scam-bievoli son le cose dell’uno e dell’altro ordine. Di donde poi è nata tanta meravigliadi forastieri per la stabile, e perpetua unione de animi e d’operazioni ne i Cittadinidi questa Eccellente Repubblica, con la quale per tanti secoli ella ha mantenutavenerabile la grandezza di se stessa, e conservato l’antico splendore d’Italia dall’In-solenza de barbari, e con la quale i privati […] di richezze, di riputazione, e d’ognialtra felicità si sono maravigliosamente accresciuti sopra qualunque Città di Italia.
E se nelle Due corone sembra prevalere un ottimismo dal sapore perbenista,donde la sviolinata sulla concordia cittadina, pomposamente dichiarataprobabilmente per moderare l’ardito accostamento nobiltà-cittadini origi-nari, ben diverso è il tono intimo, cupo e amareggiato col quale Zilioli tor-nava su questo tema nella Cronichetta, scrivendo (c. 141r):
essendosi la Città arricchida de danari con il trafico, e in particolar quelli delConseglio, hanno potuto di poveri mercanti ch’erano, e botteghieri farse grandi, ecomprar gran parte delli Territori Padovano, Trivisano e di Polesine, ed altri luo-ghi ed avanzarsi continuamente. Sí come anco hanno fatto alcune altre Casadenon del Conseglio, ma queste sono rovinate presto, e quelle che al presente fio-riscano mostrano dover poco durar, come quasi necessariamente comporta lacondizion loro. Essendo impossibile che niuna famiglia ricca, che non abbia de iprimi luoghi nella sua Patria, si possa lungamente conservar in tal stato come èbenissimo noto a chi ha pratica di questa Città ed ha giudizio sufficiente a cono-scer lo stato suo. Ma da qui inanzi ancora niuno che non sia di Conseglio potràannobilirsi o aggrandirsi per via di mercature, percioché essendo in estremo accre-sciuta la potenza particular del Cittadin di Consiglio e l’insolenza, in molti hannochiuse e vanno chiudendo tutte le strade per le qual el popolare, od altro possaspuntare, avendo loro per mira che altri non si faccia troppo grande ed al tirar in séco i parentadi e altre vie le ricchezze fra il populo sparse al qual fine hanno eziamdioprocurato sempre che in Vinezia siano manco Naturali e Cittadini che sia possibi-le, e gl’è riuscito, percioché non credo che in Vinezia vi siano sei mila Vinezianiantichi. Ma lasciando queste cose fastidiose e da me malvolentiera raccordate […].
La diffusione limitata entro le mura familiari o forse – al massimo –estesa fino al leggio di qualche casada amica e magari compagna di sventu-
massimiliano malavasi
206
ra, permette a Zilioli di profferire, nei toni della malinconica e rabbiosaprotesta, un potente e severo atto di accusa contro quell’aristocrazia lagunareche si rivela quale antenata e prototipo di quell’alta borghesia italiana che,dal tempo delle Signorie e fino ad oggi, non ha mai avuto il senso dellostato ma ha sempre concepito le strutture pubbliche come la garanzia perl’occupazione di ruoli di privilegio all’interno della realtà del mercato, elu-dendo le dinamiche di miglioramento della produzione tipiche del siste-ma liberale, causando la stasi politica e la povertà delle altre classi socialidella nazione.
E cosí ecco che Zilioli, memore – a un livello ben piú alto – dei dop-piogiochismi dei libertini che riempivano le accademie letterarie della suacittà, si inventa una storiografia a doppia faccia: lo specimen delle Historiememorabili del quale abbiamo trattato, quello appunto relativo alla guerradi Gradisca, valga da proverbiale unguis per conoscere il leonem, ovveroun’opera storiografica dove da un lato si porta alle estreme conseguenzeformali la ricerca di quella fruibilità piú immediata del testo che cosí benesi adatta all’espansione del settore del mercato librario interessato alle vi-cende storiche, elaborando una peculiare retorica divulgativa, una sorta diestetica del nascente giornalismo, tesa a sintetizzare in una lingua piana etrasparente il racconto essenziale degli eventi per poi indugiare – con lacompiaciuta ricercatezza descrittiva propria delle meravigliose delitie dellostile del tempo – in forbite orazioni, pompose feste di corte, grandiosescene di battaglia, seriose sentenze dal sapore ora biblico e ora classicheg-giante; ma le Historie dello Zilioli, dall’altro lato, pur attente ad ammantarsicon la veste di una adesione – tra l’altro del tutto sentita – ai valori idealidella Serenissima, diventano lo strumento per far arrivare al mondo deilettori l’atto di accusa di un «cittadino originario» di Venezia che rifletten-do sulle angherie dei nobili della propria città che hanno causato la rovinadella sua famiglia e infiniti problemi alla sua vita personale, riesce a collo-care la sua esperienza privata in un piano storico generale, quello dell’evo-luzione del mondo da una civiltà di guerrieri a una di mercanti, rileggendole vicende dei primi trent’anni del Seicento con una coerente “logica diclasse” che si rivela non solo nel breve inciso sull’esercito veneziano dellaguerra di Gradisca, ma ancor di piú in passaggi cruciali dei suoi libri dedi-cati alle vicende del secolo.
Penso in particolare al racconto della lotta politica in Francia al tempodell’istituzione della Paulette, uno dei provvedimenti legislativi con cui siformalizzò la venalità delle cariche pubbliche: come accennavo, quel prov-vedimento eliminava antichi privilegi feudali togliendo alla nobiltà france-
capriata, zilioli e la guerra di gradisca
207
se un’importante fonte di guadagno per donarla invece a un ceto di am-ministratori di origine mercantile, i quali speculavano sul funzionamentodella macchina statale arricchendo però la corona e fornendole i mezzi persconfiggere sul piano militare le “fronde” nobiliari e imporre cosí l’assolu-tismo.81
Ebbene Zilioli, ed è un dato che chiude il cerchio della nostra riflessio-ne, nell’offrirci un resoconto assai dettagliato della vicenda, da un lato ri-legge la realtà francese costringendola, con evidenti forzature, nelle cate-gorie sociopolitiche della sua Venezia, seminando nella pagina gli usualiriferimenti al suo “stato ideale” e le sue abituali invettive contro il “classismo”dell’aristocrazia veneziana (pp. 59-60):
Stati si chiamano in Francia i tre ordini ne i quali si distingue per antica consuetu-dine il Popolo Francese capace sempre d’una medesima libertà e nel quale nascen-do tutti equalmente popolari e abili al Gran Consiglio della Nazione, non si cono-sce alcun altra distinzione tra gli uomini privati che quelle della robba e della virtú.Primo tra questi […] è l’ordine Ecclesiastico […], gl’altri due si chiamano l’uno de’Feudatari, o sia Nobili, i quali usciti da varii ordini della plebe hanno acquistatoqualche feudo e giurisdizione con obligo di servir in guerra al Prencipe, e l’altro dei Terziari, o sia Popolari, che non hanno giurisdizione di feudi né obligo di servirin guerra, ma attendono alla professione del Senatore o del Mercante o altri esserciziia loro piacimento. Ciascuno può essere del primo ordine e a sua elezione e benspesso in un’istessa famiglia e fratena vi sono persone comprese in tutti e tre gl’ordini,onde non è in considerazione alcuna la voce odiosa e ridicola che s’usa alle volteper ingiuria in altri luoghi di Nobile non Nobile, di Popolano non Popolano con-tro le persone ricche e onorate di nascimento e di virtú.
Ma dall’altro – unico fra tutti gli storici italiani e francesi del tempo che sioccuparono della vicenda – riconosce nella Paulette un evento fondativodella modernità occidentale: la fine dell’antica menzogna cavalleresca (ri-velata nella sua essenza come «pazzia» della guerra e «ozio» dei nobili diprovincia) e la giusta decisione di un potere regio responsabile (per quantointeressato) di affidare la gestione della macchina amministrativa dello sta-
81. Il dibattito sulla Paulette e sugli altri istituti legislativi (come il droit annuel) che re-golamentavano la vendità degli uffici (e che furono – in quegli anni – promossi, combattuti,ridefiniti, aboliti, reintegrati, ecc.) è ampio e complesso e tuttora soggetto a diverse e contra-stanti interpretazioni; in questa sede, dando per ovvio il giudizio che ne offro, sia sufficienteil rimando al grande classico degli studi sull’argomento, quello di Mousnier, dove si leggeche « fut le droit annuel qui permit au XVIIe siècle l’achèvement de l’absolutisme» (R.
Mousnier, La Venalité des Offices sous Henry IVe et Louis XIIIe, Rouen, Maugard, 1945, p. 623).
massimiliano malavasi
208
to al ceto dei «cittadini» d’Oltralpe. Una decisione che finiva per valoriz-zare le forze produttive della nazione e legarne il destino a quello dellacorona avviando un processo di fondazione dello stato moderno destina-to a risultare vincente fino alla fine del Settecento (fino cioè all’irromperenella realtà politica dei ceti operai e piccolo-borghesi), determinando cosíquell’evoluzione della società che non si era avuta, né si sarebbe mai avuta,a Venezia, né – tantomeno – nel resto d’Italia.
Massimiliano Malavasi
★
Vengono confrontati i resoconti relativi alla Guerra di Gradisca tra Austria e Venezia(1615-1617) proposti da due storiografi secenteschi, il genovese Giovan Battista Capriata(nelle Historie) e il veneziano Alessandro Zilioli (nelle Historie memorabili de’ suoi tempi).Il primo costruisce un racconto di grande strategia retorica che pronuncia frasi di ri-spetto formale per la Serenissima e recupera i topoi della propaganda veneziana, ma difatto poi critica tutta la politica della città lagunare, il suo ethos civile e culturale, descri-vendo Venezia come uno stato ormai in crisi, prossimo al tracollo, militarmente ineffi-ciente e governato da un ceto dirigente incosciente e capace solo di sotterfugi diploma-tici. Il secondo invece, «cittadino originario» veneziano, costruisce un’opera storiograficache da un lato sembra caratterizzata semplicemente da un’adesione piena alle ragionidella sua patria e spinta solo da un gusto barocco per la pagina elegante e forbita riser-vata agli eventi spettacolari, ai fatti curiosi, alle feste di corte; ma invece, a una piú at-tenta analisi, contiene severe critiche alla chiusura oligarchica del ceto veneziano e unarivendicazione dei diritti di quel ceto “alto borghese” da cui proveniva, ceto escluso dalgoverno cittadino. Tale ideologia trova conferma nella biografia di questo scrittore, quiper la prima volta ricostruita sulla base di documenti provenienti dagli archivi venezia-ni, e da una prima indagine condotta sulle sue altre opere letterarie ed erudite.
This article puts forward a comparison between two narrative versions, that describe the war ofGradisca between Austria and Venice (1615-1617) proposed by two seventeenth century historiographers,the Genoese Giovan Battista Capriata (in his Historie) and the Venetian Alessandro Zilioli (inthe Historie memorabili de’ suoi tempi). The first work is a narration of great rhetorical strategy,pronouncing phrases of formal respect towards the Republic of Venice and recovering topoi of Venetianpropaganda, but in actual fact the author is very critical of the politics of the Serenissima, of its civiland cultural ethos, and describes the Republic of Venice as a state in imminent crisis and close to itsdownfall, militarily inefficient and governed by an irresponsible administrative class, adept only indiplomatic subterfuge. The second historian, a « cittadino veneziano», seems, on the one hand, toadhere totally to the policies of the state in his historical account, almost as if interested only in givinga baroque taste to his elegant and well written pages concerning spectacles, curious events, and partiesat court; but on the other hand, on analysing the text a bit more closely, it abounds in severe criticismsdirected to the closed, oligarchic Venetian class and he reclaims the rights of the “high bourgeoisie”
capriata, zilioli e la guerra di gradisca
209
to which he himself belongs, and which is totally excluded from the government of the city. Thisideology finds confirmation in the biography of the latter author, here reconstructed for the first timeon the basis of documents conserved in the Venetian archives, and from a first survey conducted on hisother literary and erudite works.