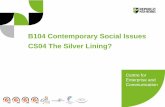La città generica: "Singapore" di Rem Koolhaas
Transcript of La città generica: "Singapore" di Rem Koolhaas
Laboratorio di Ricerca sulle CittàIstituto di Studi SuperioriAlma Mater Studiorum Università di Bologna
Sguard
i sulle città in
trasform
azion
e
E 22,00 (i.i.)
Il Convegno “Sguardi sulle citt à in trasforma-zione”, che ha avuto luogo il 7 aprile 2011 presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna, costi tuisce una delle molteplici iniziati ve a caratt ere scienti fi co e culturale intraprese dal Laboratorio di Ricerca sulle Citt à negli ul-ti mi anni. Il tema è maturato all’interno di un lavoro di ricerca che si propone l’obietti vo di raccoglie-re il contributo di studiosi di diverse discipli-ne e di diversi paesi per disegnare un pano-rama dell’idea di citt à e delle sue trasforma-zioni il più possibile composito e arti colato. In questa giornata di studi si è svolto un at-tento esame di alcune signifi cati ve realtà urbane, individuandone non solo le caratt e-risti che storiche, urbanisti che e architett oni-che, ma anche le implicazioni sociologiche, lett erarie e fi losofi che. La sinergia dei contri-buti ha dato luogo a un ricco dibatti to che ha coperto un ampio ventaglio di prospetti ve, spaziando dall’Estremo Oriente all’Europa, fi no al Brasile, passando per l’India, Singapo-re, Dubai, Istanbul, Toronto e New York.
Collana di Studi del Laboratorio di Ricerca sulle Citt à
Sguardi sulle città in trasformazioneAtti del ConvegnoBologna, 7 aprile 2011
a cura di Laura Ricca
Sguardi sulle cittàin trasformazione
Atti del Convegno Bologna, 7 aprile 2011
a cura diLaura Ricca
Laboratorio di Ricerca sulle Città
Istituto di Studi Superiori
Alma Mater Studiorum Università di Bologna
ISBN 978-88-7586-349-4© 2012 Editrice La Mandragora s.r.l.Via Selice, 92 - 40026 Imola (Bo) ItalyTel. 0542 642747 - Fax 0542 647314e-mail: [email protected]
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i paesi.
Si ringraziano gli autori:Mimma Congedo, contrattista di ricerca presso le cattedre di Indologia e di Lingua e letteratura sanscrita dell’Università degli Studi di Milano.Jale Nejdet Erzen, docente di Storia dell’arte e dell’architettura presso la Facoltà di Architettura della Middle East Technical University di Ankara.Marco Filoni, chercheur associé presso il «Centre International d’Etude de la Philosophie Française Contemporaine» dell’Ecole Normale Supérieure di Parigi.Elena Lamberti, docente di Letterature Anglo-Americane presso il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere Moderne dell’Università di Bologna.Francesco Lizzani, docente di filosofia, saggista e documentarista (progetti “Imago Urbis” ed “Esperia”).Franco Minganti, docente di Lingue e Letterature Anglo-Americane presso il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere Moderne dell’Università di Bologna.Giovanna Potestà, docente presso il Dipartimento di Architettura del College of Engineering dell’Univer-sità del Kuwait.Laura Ricca, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Orientali dell’Università di Bologna. È stata Lettrice di Italiano e in seguito Research Fellow presso l’Università del Tohoku di Sendai in Giappone.Monica Sassatelli, Lecturer al Dipartimento di Sociologia Goldsmiths dell’Università di Londra.Gino Scatasta, docente di Letteratura Inglese presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Uni-versità di Bologna.Zoltán Somhegyi, storico e critico d’arte. Insegna presso la Facoltà di Pedagogia dell’Università Szent István.Gilles A. Tiberghien, docente di Estetica presso la Sorbona di Parigi. Visiting Professor in varie università straniere.Roberto Vecchi, docente di Letteratura Portoghese e Brasiliana presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Bologna.
Indice
IntroduzioneDal villaggio globale alla capannadi Laura Ricca ............................................................................................................ 7
La città generica: Singapore di Rem Koolhaasdi Marco Filoni ........................................................................................................ 17
Tokyo città aperta, capitale del XXI secolo. Ritratto di una città-raccontodi Francesco Lizzani e Laura Ricca .......................................................................... 27
Nessuna São Paulo esiste, forse non esistono nemmeno i paulistanidi Roberto Vecchi ................................................................................................... 69
Dubai: the deconstruction of a citydi Giovanna Potestà ................................................................................................ 79
Fathpur Sikri: il non-luogo del poteredi Mimma Congedo ................................................................................................ 87
Istanbul through pagan, christian and muslim histories: a city’s transformationdi Jale Nejdet Erzen ............................................................................................. 105
La seconda casa di Virginia Woolf a Londradi Gino Scatasta ................................................................................................... 127
Londra città globale: la metropoli e la vita dello spirito nel ventunesimo secolodi Monica Sassatelli ............................................................................................. 139
Segnata dalla storia. Berlino e i suoi simbolidi Zoltán Somhegyi .............................................................................................. 149
Toronto & Co.: il mosaico nel crogiolo?di Elena Lamberti .................................................................................................. 159
No(n) New York. Le trasformazioni del Lower East Sidedi Franco Minganti ............................................................................................... 171
AppendiceDemeurer, habiter, transiter : une poétique de la cabanedi Gilles A. Tiberghien ........................................................................................... 185
La città generica: Singapore di Rem KoolhaasMarco Filoni
L’urbanistica è tornata a essere, dopo l’esplosione economica di paesi come Cina, India, Brasile, un tema politico. E la città un nodo decisivo per la pro-gettazione del futuro. Questo implica che si abbia un’idea chiara di come si vorrebbe il mondo. Ovvero, urbanistica e architettura. O, meglio, un modo di intendere l’architettura. Di questa si può discutere fondamentalmente in due modi, come ricordava spesso un grande maestro come Giancarlo De Carlo1: o come se fosse un’attività autonoma che si definisce da sola, attraverso quel che produce con gli strumenti della sua propria specializzazione (quindi i suoi oggetti: gli edifici e le opere); oppure come fosse un sistema di comuni-cazione e di espressione che si può decifrare soltanto se si conosce il contesto in cui sono emessi e ricevuti i messaggi (quindi i processi di interrelazione con le vicende umane). Entrambi i metodi, se di metodo si può parlare, for-niscono indicazioni importanti. Ma il secondo porta più lontano.
Lo sa bene Rem Koolhaas, cha da anni non si limita a praticare l’architet-tura in senso stretto – nonostante le sue opere siano considerate, a ragione, fra le più stimolanti del recente panorama architettonico. Giusto per avere un’idea, basti dire che ha firmato il Netherlands Dance Theatre dell’Aja; la bi-blioteca pubblica di Seattle; il rinnovamento architettonico di Lille con il Grand Palais e l’avveniristico Euralille, che comprende la stazione del tgv sulla linea che unisce Parigi e Bruxelles a Londra; e poi l’ambasciata olandese a Berlino, l’Auditorium di Porto, il Kunsthal di Rotterdam, il gigantesco complesso re-sidenziale di Fukuoka in Giappone, gli studios della Universal a Los Angeles, il negozio Prada a New York (che in qualche modo ha rivoluzionato il con-cetto stesso di shopping). Per non parlare poi del colossale quartier generale
1 Cfr. Giancarlo De Carlo, Gli spiriti dell’architettura, a cura di Livio Sichirollo, Roma, Editori Riuniti, 1999.
18 Sguardi sulle città in trasformazione
della televisione cinese a Pechino, o il Campus di Chicago realizzato sui di-segni di Mies van der Rohe2.
Insomma, un protagonista, un simbolo degli ultimi vent’anni architetto-nici celebrato come una vera e propria star – viatico del passaggio millenario coronato con il prestigioso Premio Pritzker, il “nobel” dell’architettura ricevuto nel 2000.
Ma Koolhaas non è solo questo. Fra un edificio e l’altro, ha trovato il tempo per imporsi come acutissimo teorico, visionario e al tempo stesso con-creto, famoso per le sue idee radicali e poco convenzionali. Con i suoi scritti non manca occasione per essere all’altezza della propria fama. L’aveva fatto nel 1978 con Delirious New York, il “manifesto retroattivo” di Manhattan che rivoluzionò la lettura della metropoli contemporanea3. Poi nuovamente con quell’immaginazione fervida e innovativa che lo contraddistingue – e che non smette di irritare molti suoi colleghi – con un piccolo e denso volumetto dal titolo Junkspace4.
Le reazioni a questo scritto, da noi in Italia, sono state piuttosto risentite. Koolhaas è stato bollato come conservatore e anche un po’ reazionario, “pro-fondamente antipolitico” e per nulla “radicale”, “garante dello status quo” che ne fa una sorta di “cospiratore in favore dell’ordine costituito”. In parte que-sto atteggiamento è comprensibile. Occorre dire che l’Italia è un paese parti-colarmente refrattario alle tesi di Koolhaas: non solo è l’ultimo paese occiden-tale ad aver tradotto Delirious New York (solo nel 2001) ma è anche il paese che in Europa coltiva il tabù della tabula rasa e della città generica, arroccato in di-fesa dell’identità dei propri centri storici quasi tutti tutelati dall’Unesco – salvo poi lasciar franare le volte della Domus Aurea o i muri di Pompei. Va posto l’accento con forza però sul fatto che Koolhaas considera la scrittura un’atti-vità del tutto autonoma da quella dell’architettura, un piano distinto in cui poter lavorare e pensare in modo diverso.
Il volumetto Junkspace recita come sottotitolo: Per un ripensamento radicale dello spazio urbano. Ciò che Koolhaas sembra voler proporre è un serrato con-fronto con l’architettura e le sue possibilità – che vengono contemplate, colte e analizzate a partire dalla realtà attuale. I tre scritti che compongono il volume
2 Un’ottima guida alla scoperta delle sue opere è Roberto Gargiani, Rem Koolhaas/oma, Roma-Bari, Laterza, 2010.3 Cfr. Rem Koolhaas, Delirious New York. A Retroactive Manifesto for Manhattan, New York, Oxford University Press, 1978 (tr. it. a cura di Marco Biraghi, Milano, Electa, 2001).4 Rem Koolhaas, Junkspace. Per un ripensamento radicale dello spazio urbano, a cura di Gabriele Mastrigli, Macerata, Quodlibet, 2006 – si tratta di una raccolta di tre scritti riuniti dall’autore per l’edizione italiana: Bigness ovvero il problema della Grande Dimensione (1995), La Città Generica (1995) e Junkspace (2001).
19La città generica: Singapore di Rem Koolhaas
(Bigness, La città Generica e Junkspace) sono le tappe di un percorso: oggi l’archi-tettura, concepita come gerarchia degli spazi, composizione, tipologia e inte-grità materiale o artistica, è fagocitata dal junkspace, ossia dallo spazio-spazza-tura composto da quella roba «assolutamente caotica e paurosamente asettica» che è generata nel mondo dalle attività commerciali e le sue dinamiche. Ma questo non significa una resa alla situazione-spazzatura, tantomeno una mancanza di idee e proposte capaci di intervenire sullo status quo.
Basta leggere lo stesso Koolhaas, che qualche anno fa in un’intervista ha dichiarato di occuparsi dello junkspace «perché, in una società come la nostra, dobbiamo viverci. Si tratta di spazi che subiscono continue trasformazioni. Debbono modificarsi senza sosta, perché le loro funzioni e le loro esigenze cambiano. Capirne l’evoluzione è una delle sfide che dobbiamo raccogliere. Il nostro mondo non è statico. È spinto da un dinamismo perenne che rimette tutto in discussione. Nel bene e nel male, possiamo imparare tante cose dagli spazi-spazzatura. E rendere gli altri molto più vivi».
Bisogna saper “leggere” la realtà nella quale viviamo, lo spazio nel quale trascorriamo le nostre esistenze. È quello che fa l’architetto olandese: non si li-mita a costruire, ma “abita” e “pensa” – componendo così l’esortazione del fa-moso saggio Costruire, abitare, pensare di Martin Heidegger. Certo, vi è un pa-
1. Singapore, città generica.
20 Sguardi sulle città in trasformazione
radosso evidente nello spazio-spazzatura: gli spazi delle nostre città sono stati creati dal consumo delle merci e a loro volta sono consumati da questo stesso consumo. Bisogna però esserne coscienti – cosa per nulla scontata. Solo così gli spazi, minacciati dallo loro solennità, potranno esser salvati dalla loro stessa arguzia (e lo stesso può dirsi degli scritti di Koolhaas). E per capirlo, basterà l’a-neddoto che riguarda lo shopping center Prada a New York: uno spazio gran-dioso, nel quale i prodotti sono nascosti e mimetizzati, abiti e accessori posti in gabbie sospese che scorrono su rotaie pronte a scomparire all’occorrenza per far diventare uno spazio commerciale anche pubblico, nel quale la parte bassa si trasforma in palco per eventi e i piani di esposizione diventano sedili per un pubblico raccolto come a teatro. Un design che evoca romanità, il teatro e la ba-silica, con schermi nei quali scorrono sequenze dei capolavori del cinema ita-liano. E quando Koolhaas è stato chiamato all’inaugurazione di quanto aveva progettato e gli hanno chiesto di definire l’elemento architettonico più impor-tante dell’intera opera, la sua risposta è stata: «la carta da parati».
Ma al di là della boutade, ciò che è alla base dello scandalo Koolhaas, spe-cie in Italia, è la totale assenza di moralismo all’interno dei suoi scritti. Gilles Deleuze, il filosofo da cui Koolhaas più si tiene alla larga per eccesso di affi-nità5, ha scritto a proposito di Spinoza – il più filosofo dei filosofi – che la sua Etica non ha nulla a che vedere con una morale, bensì egli la concepisce come un’etologia, cioè come una “composizione di velocità e lentezze”6. Per Spinoza un corpo non viene definito mediante una forma o attraverso funzioni. Piuttosto la forma globale, la forma specifica, le funzioni organiche dipen-deranno da rapporti di velocità e di lentezza. Lo stesso sviluppo di una forma (il suo processo) dipende da questi rapporti, e non l’inverso. Analogamente – e forzando un po’ la mano – potremmo affermare che l’architettura di Rem Koolhaas non viene definita mai da una forma precostituita ma da un “rap-porto complesso di velocità”, come direbbe Deleuze. E non a caso Koolhaas ha reindirizzato e reimposto all’attenzione generale l’uso del diagramma nella progettazione architettonica. I diagrammi sono speciali forme di rap-presentazione comunicativa. Che cosa comunicano? Il movimento, «essi trac-
5 «When I first came across Deleuze – maybe six or seven years ago, through conversations with Hubert Damisch – I started to read the books and almost immediately closed them be-cause of their uncanny analogies, their incredibly free-ranging speculations. I closed them, clearly, out of fear of becoming Deleuzian and a sense that maybe it was already too late. Now I have read them in small doses. It’s the anxiety of influence», Thinking Big. John Rajchman Talks with Rem Koolhaas, in «Artforum», dec. 1994. – Devo all’amico Manuel Orazi molte indicazioni utili sul tema, nonché la gentilezza di avermi messo a disposizione alcune sue pagine inedite sul rapporto Koolhaas-Spinoza.6 Cfr. Gilles Deleuze, Spinoza et nous, in Id., Spinoza. Philosophie pratique, Paris, Minuit, 1981 (tr. it. Spinoza. Filosofia pratica, a cura di Marco Senaldi, Milano, Guerini e Associati, 1991).
21La città generica: Singapore di Rem Koolhaas
ciano delle possibilità di fatto, ma non costituiscono ancora un fatto»7.
Se l’etologia è per Deleuze innanzi-tutto “lo studio dei rapporti di velocità e di lentezza”, ecco dunque Koolhaas che studia in particolare città, o meglio me-galopoli in movimento. Come Singapore, un emblema, dalla quale l’architetto fa af-fiorare le proprie “songlines” (termine che riecheggia Le Vie dei canti aborigene di Bruce Chatwin, dove nei canti si indivi-duano miti della creazione e mappe im-materiali del territorio)8. Città e megalo-poli in movimento perché in espansione, che raddoppiano o triplicano le loro di-mensioni in pochi anni: Lagos, le città ci-nesi del delta del Pearl River, Dubai. La sua parola chiave è “accelerazione”. La citazione di Lee Kuan Yew9 in apertura di Singapore Songlines sottolinea appunto il tema della velocità urbana: «Singapore è un posto molto piccolo, in un mondo molto molto grande, vario e mutevole, e se non sarà agile e veloce nell’adeguarsi, perirà e la gente lo sa».
Così come nel caso di Las Vegas indagata da Venturi, Scott Brown e Izenour nel 1968, le città africane, arabe o asiatiche studiate da Koolhaas e dai suoi studenti sono luoghi sottovalutati dagli accademici occidentali e anzi quasi rimossi, deprecati per il loro folle e incomprensibile sistema di vita.
E invece queste città sono importanti perché ci permettono di porci una domanda: come saranno le città del futuro? E Koolhaas va a guardare a Singapore, l’isola asiatica sorta meno di 50 anni fa che rappresentava la Città futuribile: effetto congiunto di un’impetuosa crescita economica e insieme di una nuova forma di democrazia autoritaria. Lee Kuan Yew ha realizzato quello che Koolhaas chiama il “parossismo dell’operativo”, ovvero una nuova città interamente costruita in tempi rapidi, priva di storia e di tutti quegli arche-
7 Gilles Deleuze, Francis Bacon. Logique de la sensation, Paris, Différence, 1981, capitolo 12: Diagramma (tr. it. a cura di Stefano Verdicchio, Macerata, Quodlibet, 1995).8 Rem Koolhaas, Singapore Songlines. Ritratto di una metropoli Potemkin… o trent’anni di tabula rasa, a cura di Manfredo di Robilant, Macerata, Quodlibet, 2010.9 Artefice principale dell’indipendenza di Singapore dalla Gran Bretagna, primo ministro per oltre trent’anni della città-stato asiatica, una sorta di “tiranno illuminato”.
2. Lee Kuan Yew, artefice di Singapore.
22 Sguardi sulle città in trasformazione
tipi spaziali che noi in Europa riteniamo necessari e fondamentali affinché vi sia una città: strade, piazze, vie…
La specificità di Koolhaas è la sua inclinazione ad analizzare insieme uo-mini e città senza distinguere mai fra Natura e Artificio, con la freddezza e la lucidità di un etologo appunto. Scrive per esempio nella scioccante introdu-zione che «Singapore Songlines è dunque anche l’esplorazione di un sistema politico diverso da quello che l’Europa considera “naturale”. Investiga le con-seguenze di quel sistema sulla città che ne emerge».
Tale inclinazione, deleuziana (e in fondo spinozista), permette a Koolhaas di saltare a piè pari tutte le ideologie con cui gli occidentali hanno giudicato i paesi postcoloniali e di sospendere ogni giudizio morale per meglio osser-vare il funzionamento di quei mondi lontani.
In quest’ottica lo studio dell’architetto olandese dedicato alla città-stato asia-tica va considerato, come egli stesso scrive, l’«ultimo ritratto di una città reale esistente». E racconta una profezia, in sostanza avveratasi: «È stato a Singapore che, spossato dalle minuziosità della ricerca, ho sentito improvvisamente che stavo iniziando ad afferrare l’essenza non solo di quella città, ma di ogni città nuova, ed è qui che ho scritto, spinto da un impulso febbrile, la prima stesura della Città Generica, una versione un po’ camuffata, astratta e generalizzata di Songlines»10. Koolhaas dice in sostanza che l’essenza di Singapore è quella di ogni nuova città. Quando scriveva, nel 1995, guardava allo sviluppo urbano ci-nese, e indicava appunto il modello della città generica come fonte per le na-scenti megalopoli in Cina (e così, sostanzialmente, è stato). Nel prologo all’edi-zione italiana rilancia, e la sua profezia si allarga a tutte le città: l’artificiosità di Singapore ha messo le radici e, pian piano, sta crescendo anche nell’ecologia delle nostre città, «dall’ubiquo inserimento di prati e zone piantate ad arbusti, al pulito splendente, all’ossessione del controllo». Ecco allora che il modello di Singapore è, già ora, il prototipo di ogni città e rappresenta perciò il nostro fu-turo: «Songlines suggerisce che la città-stato è una sorta di laboratorio seman-tico dove le sconcertanti questioni che caratterizzano la nostra epoca, come la coesistenza razziale, sono state esaminate prima che divenissero enormi im-passe o crisi nel nostro continente. Gli esperimenti svolti a Singapore vent’anni fa non sono così diversi da quelli nell’Europa di oggi – nella semplificazione dell’educazione, nella medicina, nelle relazioni fra etnie». Insomma, «siamo meno diversi da Singapore di quanto speravamo», conclude Koolhaas.
A questo punto è utile capire in cosa Singapore debba considerarsi un mo-dello. L’architetto olandese è chiaro: è proprio la sua “non fondazione” a es-sere la traccia principale da seguire nella progettazione architettonica e urba-
10 Koolhaas, Singapore Songlines, cit., p. 9.
23La città generica: Singapore di Rem Koolhaas
nistica del futuro. O meglio: una fondazione dal nulla. La città qui pensata è una città senza luogo, una città – come ha giustamente osservato Dario Gentili – «la cui forma è oggetto costante di trasformazione e, pertanto, è questa stessa forma a diventare “regolatrice” del luogo e dell’identità collettiva»11.
È appunto la città generica, quella sorta da una tabula rasa e pianificata, pen-sata e imposta dall’alto. Non ha avuto un movimento proprio delle città ca-noniche: il suo movimento è dato dal non fondarsi, da un’origine non indivi-duabile, se non nella decisione senza appello, arbitraria, del gesto politico dell’origine e della fondazione – come se ci muovessimo fra i terreni del mito, e non quelli fatti di edifici, strade e giardini. Perciò Songlines è anche un testo che esplora un sistema politico differente da quello, per noi naturale, della democrazia: parliamo qui di un sistema autoritario, quello che ha sovrinteso la costruzione di Singapore. E pone diversi interrogativi su questo sistema e
11 Dario Gentili, Singapore. L’Occidente d’Europa, in http://architettura.it/books/20101212001/index.htm; cfr. inoltre, dello stesso autore, Topografie politiche, Macerata, Quodlibet, 2009.
3. La tabula rasa.
25La città generica: Singapore di Rem Koolhaas
le sue conseguenze sulla città. Proprio questa è la parte più interessante e an-che controversa del testo di Koolhaas.
Se, come sostiene l’architetto, la città generica è anche il futuro delle nostre città occidentali, allora a ragione bisogna interrogarsi sul sistema politico che genera questo modello (uno stile senza uno stile, un’urbanizzazione senza progetto). Ha perciò ragione, ancora, Dario Gentili, che pone con forza il tema di Koolhaas: «L’ultima differenza che, per Koolhaas, ancora sussiste tra que-ste due vie all’occidentalizzazione, l’asiatica e l’europea, è di natura politica. L’urbanizzazione di Singapore, infatti, ha una genesi non democratica, auto-ritaria. Perché, tuttavia, non essere radicali fino in fondo, decostruendo an-che le ultime resistenze ideologiche: se è vero che la Città Generica si sta dif-fondendo anche in Europa, il carattere non-democratico della sua genesi orien-tale non trova un corrispettivo nei nostri regimi “compiutamente” democra-tici, pienamente “formalizzati” e “omogenei”, dominati dalla dittatura della maggioranza e dei sondaggi? L’“autoritarismo senza autore” o il “fascismo senza dittatore”, di cui scrive Koolhaas in Junkspace, non sono forse formule che, da Singapore all’Europa, per vie diverse, rappresentano il medesimo esito dell’“occidentalizzazione”?»12.
12 Ibidem.