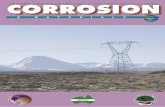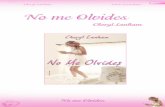L. Alderighi, M. Benvenuti, F. Cambi, L. Chiarantini, C. X.H. Chiesa, A. Corretti, A. Dini, M....
Transcript of L. Alderighi, M. Benvenuti, F. Cambi, L. Chiarantini, C. X.H. Chiesa, A. Corretti, A. Dini, M....
Rassegna archeologica
ESTRATTO
Annalidella Scuola NormaleSuperiore di PisaClasse di Lettere e Filosofia
serie 5 2013, 5/2
supplemento
SCAVI DI ANTICHITà
NOTIZIED E G L I
C O M U N I C A T E D A L L A
SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
Rassegna archeologica del Laboratorio di Scienze dell’Antichità
Supplemento agli Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa Classe di Lettere e Filosofia serie 5 2013, 5/2
Scavi e ricerche a Segesta (Calatafimi-Segesta, TP; 2012), Entella (Contessa Entellina, PA),Kaulonia (Monasterace, RC; 2011-13),Roca (Melendugno, LE) e Isola d’Elba (LI; 2008-12)cura redazionale: Chiara Michelini
PremessaCarmine Ampolo vii
Segesta
Scavi nell’area dell’agora (2012): risultati e prospettive di ricerca Carmine Ampolo, Maria Cecilia Parra 3
Agora. Area della Stoa Nord (SAS 4; 2012) Antonino Facella, Riccardo Olivito 10
Agora. Settore NordEst (SAS 4; 2012) Oriana Silia Cannistraci, Marianna Perna 15
Agora. Settore Est (SAS 4; 2012) Agata Abate, Donatella Erdas, Angela Clara Infarinato 21
Agora. Analisi architettonica dell’ingresso monumentale all’ambiente I della stoa Nord Agata Abate, Oriana Silia Cannistraci 29
L’approvvigionamento ceramico a Segesta nel VI-VII sec. d.C.: il contributo delle analisi archeometriche Antonino Facella, Claudio Capelli, Michele Piazza 49
Entella
Un kyma lapideo dall’area del vallone orientale Maria Cecilia Parra, Nicola Giaccone 67
Kaulonia
Scavi nel santuario di Punta Stilo (2011-13):verso una lettura d’insieme del complesso Maria Cecilia Parra 81
Area a Sud del tempio dorico (SAS 1 SudOvest; 2011-12) Antonino Facella, Nicola Giaccone 96
Indagini nell’area della ‘Porta Santuario’ (2011-13) Oriana Silia Cannistraci, Riccardo Olivito, Alfonsa Serra 104
Una deposizione votiva arcaica. Note preliminari Vanessa Gagliardi 120
Roca
I rapporti tra l’Italia e l’Egeo nell’età del bronzo e il ruolo di Roca. Alcuni spunti di riflessione Riccardo Guglielmino 131
Un’associazione di reperti ceramici e lignei provenienti da un pozzo basso-medievale Eda Kulja 152
Isola d’Elba
Aithale. Ricerche e scavi all’Isola d’Elba. Produzione siderurgica e territorio insulare nell’antichità Lorella Alderighi, Marco Benvenuti, Franco Cambi, Laura Chiarantini, Caterina X.H. Chiesa, Alessandro Corretti, Andrea Dini, Marco Firmati, Laura Pagliantini, Claudia Principe, Luisa Quaglia, Luisa Zito 169
Abbreviazioni bibliografiche 189
illustrazioni 227
PremessaCarmine Ampolo
Si presenta qui l’ottavo fascicolo delle Notizie degli scavi di Antichità della Scuola Normale Superiore, il quarto che appare nella nuova ve-ste editoriale, come sezione a sé stante degli Annali. Avviando questa Rassegna Archeologica abbiamo inteso rispondere alla finalità di rende-re noti alla comunità scientifica in tempi brevi i risultati delle ricerche del Laboratorio di Scienze dell’Antichità (LSA), frutto dell’unificazione del Laboratorio di Storia, Archeologia e Topografia del Mondo Antico (LSATMA) e del Laboratorio Informatico per le Lingue Antiche (LILA) in una nuova ed unica sede, sita nel Palazzo della Canonica, che si affac-cia a Sud sulla piazza dei Cavalieri.
Come di consueto, le Notizie offrono un quadro delle attività sul ter-reno condotte dal LSA in collaborazione con Soprintendenze, Parchi Archeologici e Università. In queste attività il Laboratorio impegna non solo personale, strutturato e non, ma anche attrezzature di qualità tec-nica tale da garantire gli esiti di documentazione migliori: ad esempio il LSA si è dotato, dal 2011 e 2012, di due droni, velivoli U.A.V. multimo-tore radioguidati, dotati di altimetro, GPS e fotocamera, che ci permet-tono di eseguire riprese e filmati ad alta risoluzione utilizzabili sia per ricerca scientifica avanzata che per una aggiornata ed eloquente divul-gazione dei dati. Nell’apparato illustrativo di queste Notizie se ne pos-sono vedere esempi significativi, che si aggiungono ai molti già editi in precedenza. Quest’anno, i droni sono stati utilizzati, oltre che sugli scavi di Segesta e di Kaulonia, anche ad Entella dove, nell’autunno 2013, sono state effettuate riprese nella città e nel territorio. In particolare, si sono documentati alcuni siti oggetto di prospezione archeologica, in vista del-la ormai imminente pubblicazione della carta archeologica del territorio comunale di Contessa Entellina (figg. 1-4). Nel sito di Entella si è inoltre testata la termocamera a raggi infrarossi Optris PI450 LightWeight, sia sorvolando e riprendendo aree in cui erano già documentate strutture interrate, sia eseguendo riprese dedicate in settori della città antica in
cui la probabilità di resti strutturali antichi era maggiore, sia operando sui maggiori siti messi in luce nel territorio. I filmati – eseguiti dopo il tramonto per sfruttare al meglio il differenziale termico – sono in cor-so di elaborazione nel Laboratorio di Scienze dell’Antichità, con primi risultati senz’altro incoraggianti. Le immagini ricavate sono georeferen-ziabili mediante GPS integrato nel drone. Una selezione di immagini da drone è stata presentata in una mostra presso la Scuola Normale.
Analoghe finalità di ricerca e di corretta divulgazione hanno le ela-borazioni 3D, finalizzate alla ricostruzione ed alla modellazione di ma-teriali archeologici e di complessi monumentali: ne abbiamo già pre-sentate varie nelle precedenti Notizie, altre compaiono in questa sede. Ma il lavoro si estende e si perfeziona ancor più, sempre con la colla-borazione dell’Università di Pisa, che si è ampliata da circa un anno al DREAMSLAB della Scuola Normale (diretto dal Prof. V. Barone). Quest’ultimo sta utilizzando i modelli 3D già sviluppati per applicazio-ni di avanzata tecnologia virtuale particolarmente rilevanti (vd. infra, Introduzione alla sezione dedicata a Segesta).
I siti oggetto delle indagini presentate in questa sede sono Segesta, Kaulonia e Rocavecchia, dove le indagini archeologiche continuano e forniranno ancora materia alle prossime Notizie degli scavi.
Quest’anno abbiamo deciso di dare spazio maggiore a piccoli contri-buti di approfondimento su temi circoscritti, collegati a specifiche ricer-che in corso presso il LSA: temi ‘segestani’ e ‘kauloniati’, ma uno anche di tema ‘entellino’, cioè lo studio di un frammento architettonico arcai-co dall’area pubblica Entella, che molto dice sulla precocità di ricezione di stilemi greci da parte di un centro anellenico della Sicilia occidentale.
Rimando ai singoli rapporti per una illustrazione dei risultati, limi-tandomi a mettere ancora una volta in rilievo il significato storico che hanno assunto le indagini a Segesta: nuovi dati si sono aggiunti ad ar-ricchire la documentazione relativa alla rinascita su scala monumentale dell’agora in età ellenistica, con ulteriori contributi per una conoscenza più ampia delle trasformazioni di età romana e, dopo l’abbandono nel III sec. d.C., della rioccupazione tardo-antica e alto-medievale e di quel-la più sistematica di età sveva. Nel 2012 le indagini si sono concentrate ancora in due settori della imponente stoa ad alae che chiudeva a Nord la grande piazza lastricata, esprimendo con le sue forme e le sue misure toni di ‘teatralità’ e di ‘gigantismo’ di lunga tradizione in Sicilia.
Nuovi dati permettono di apprezzare meglio l’ala Est nella sua arti-colazione, non solo planimetrica e funzionale – ben distinta rispetto a
VIII Carmine Ampolo
quella dell’ala Ovest – ma anche di fasi. Di grande interesse la struttura ad archi individuata già dallo scorso anno al centro del lato lungo della stoa, dove è continuato l’intervento di scavo che ne ha chiarito la fun-zione di sostruzione. Tali archi sono infatti in corrispondenza di lacune o di punti deboli della parete rocciosa, ma dovevano servire anche per sostenere il secondo ordine della stoa. Il muro di fondo celava alla vista un ambulacro di servizio, oltre alle stesse arcate di sostegno.
A Kaulonia, sempre più è leggibile l’articolato tessuto, monumentale e di fasi, in cui si inserisce anche il tempio dorico scoperto da Paolo Orsi nel 1912, che non appare più un monumento isolato quale per quasi un secolo è rimasto fino all’avvio delle nostre ricerche. Le indagini che il Laboratorio conduce in collaborazione con l’Università di Pisa, hanno ormai recuperato per larghe porzioni la fase monumentale in cui l’edificio andò ad inseririrsi nella prima metà del V sec. a.C. Ma tra il 2011 e il 2013 sono stati recuperati alla conoscenza soprattutto dati per-tinenti alle fasi precedenti: l’ ‘area dei cippi’ prossima al tempio è stata prodiga di deposizioni votive, tra cui l’eccezionale gruppo di armi con l’elmo dedicato a Zeus, associato a due schinieri destri, diversi tra loro; e quella più meridionale, a Sud del grande altare, ha restituito la porta alto-arcaica, trasformata in postierla per motivi difensivi e poi sostituita dalla grande ‘Porta Santuario’ della fine del VI sec. a.C.
Quest’anno il patrimonio epigrafico del santuario kauloniate, già ac-cresciuto nel 2011 e nel 2012, si è arricchito nel 2013 in modo signifi-cativo con la scoperta della più lunga iscrizione greca in alfabeto acheo nota dalla Magna Grecia. L’accurato restauro eseguito presso il Museo di Monasterace su un nucleo di frammenti di lamina in bronzo, ha per-messo di riconoscere una lunga dedica metrica del V sec. a.C., stoiche-don, iscritta su una tabella in bronzo larga cm 25; dopo ulteriori analisi di laboratorio, ne sto preparando l’edizione con la collaborazione di un mio allievo perfezionando della Scuola Normale.
La teoria minimalista recentemente formulata da Emma Blake, sec-ondo cui i rapporti tra l’Italia e l’Egeo nel corso dell’età del bronzo sarebbero stati tanto scarsi e discontinui da produrre effetti trascurabili nello sviluppo delle comunità indigene, è il punto di partenza del con-tributo dedicato a Roca. L’insediamento costituirebbe un’eccezione as-soluta, l’unica realtà comparabile con i grandi centri portuali del Medi-terraneo orientale. Ma, piuttosto, la fisionomia di questo centro sembra potersi considerare paradigmatica dell’identità culturale composita che doveva accomunare i principali scali della penisola e delle isole mag-
IX PremessaIX Premessa
giori e che la sua apparente eccezionalità, suggerita dall’abbondanza dei materiali esotici rinvenuti, possa derivare in larga misura dall’ampiezza delle aree indagate. Il modello teorico che sembra attagliarsi meglio alle caratteristiche di questi scali sembra quello della community colony, che presuppone la presenza di un nucleo di immigrati egei integrati nella società indigena con un ruolo non dominante. Occupato per oltre tre millenni, il promontorio di Roca conobbe la sua ultima e importante fase insediativa nel tardo Medioevo, quando vi fu costruita una città per volontà di Gualtieri VI di Brienne, conte di Lecce e duca d’Atene. Ispirata alle bastides francesi, presentava una piazza centrale su cui in-sisteva una chiesa a ridosso della quale venne scavato un pozzo colmo di ceramiche di varia tipologia ed inquadrabili tra il XIV e il XVI sec. d.C.: a questo contesto è dedicato il secondo contributo edito in questa sede.
Mi preme infine ringraziare calorosamente il Direttore della nostra Scuola e gli amici del Servizio Parco Archeologico di Segesta e della So-printendenza BB.CC.AA. di Trapani, insieme a quelli della Soprinten-denza Archeologica della Calabria, i quali ci hanno sempre assicurato il loro supporto, anche in questo momento non facile per le amministra-zioni pubbliche.
Un ricordo particolare va, come sempre, al personale ed ai collabora-tori del Laboratorio, il cui impegno consente di realizzare i progetti di ricerca sia sul terreno che nella nostra nuova sede pisana, fino all’elabo-razione e redazione finale di queste Notizie. Sono inoltre grato, per la consueta disponibilità mai disgiunta da una grande professionalità, alla Redazione degli Annali, che dallo scorso anno (2012) sono stato chia-mato a dirigere, nonché a tutti gli amici delle Edizioni della Normale.
Addendum
Va segnalata la grave situazione causata nel santuario di Kaulonia da violente mareggiate che stanno compromettendo – in assenza di ade-guate opere di protezione – la conservazione di un patrimonio impor-tante, solo in parte indagato dai tempi di P. Orsi alle ricerche in corso (cfr. Parra, Addendum, in questa sede).
X Carmine Ampolo
1. Aithale. Ricerche e scavi all’Isola d’Elba. Produzione siderurgica e territorio insulare nell’antichitàLorella Alderighi, Marco Benvenuti, Franco Cambi, Laura Chiarantini, Caterina X.H. Chiesa, Alessandro Corretti, Andrea Dini, Marco Firmati, Laura Pagliantini, Claudia Principe, Luisa Quaglia, Luisa Zito
1.1. Introduzione
Parlare dell’isola d’Elba significa ancora oggi – a più di trent’anni dalla chiusura definitiva delle miniere di ferro nel 1981 – rievocare un mondo minerario e siderurgico che ebbe un grande rilievo nell’econo-mia e nella società dell’isola, o almeno della sua parte orientale, e che tuttora ne costituisce un aspetto fortemente identitario.
Per quanto si trattasse di giacimenti di media entità, in nessun modo paragonabili alle risorse ferrifere disponibili ad altre nazioni europee1, le miniere di Rio (e quelle di Vigneria, Rialbano, Terranera, Calamita) ebbero un ruolo centrale nella discussione sul futuro siderurgico dell’I-talia postunitaria fino all’esperienza dell’autarchia2.
Questa prospettiva, se, da una parte, ha mantenuto vivo l’interesse an-che sulle precedenti epoche di coltivazione mineraria dell’isola, dall’al-tra ha proiettato nel passato, anche remoto, problematiche e aspettative proprie dell’età moderna.
In altre parole, una valutazione oggettiva dei tempi, dei modi, del-le dimensioni, degli attori dello sfruttamento delle risorse minerarie dell’Elba nell’antichità deve necessariamente svincolarsi dalle sugge-stioni del passato più recente. Limitandoci al minerale ferroso (gli affio-
Il presente contributo è stato scritto da Franco Cambi, Alessandro Corretti e Laura Pagliantini per conto del gruppo «Aithale».
La campagna di scavo a San Giovanni 2012 si è potuta avvalere di un finanziamento della Provincia di Livorno e del Comune di Portoferraio, nonché di un contributo di Italia Nostra - Isola d’Elba.
1 Secondo Pistolesi 2011, pp. 102-3, alla fine del XIX sec. l’intero ammontare sti-mato dei giacimenti di ferro dell’Elba corrispondeva alla metà della produzione annuale della sola Gran Bretagna.
2 Ibid., p. 382; AA.VV. 1938.
ramenti di rame dell’isola pongono infatti problemi di diverso ordine3), la gestione antica dei giacimenti di Rio – gli unici in produzione fino all’età moderna4 – può aver conosciuto variazioni anche radicali nelle modalità operative e nei livelli di produzione, con conseguente diverso impatto sull’ambiente5 e sulle comunità locali (isolane e populoniesi) e con diverse ricadute in un areale più ampio, comprendente almeno il Tirreno. Individuare fin dove sia giunto il ferro elbano (come minerale, come semilavorato o manufatto) permetterà di gettare nuova luce su dinamiche interstatali (in primis i rapporti tra Populonia e Siracusa nel corso del V e del IV sec. a.C.6) in cui il controllo della risorsa ferrifera avrebbe rivestito un ruolo importante se non primario.
Un’indagine di questo tipo necessita del contributo parallelo di com-petenze diverse (storiche, archeologiche, topografiche, geologiche, mi-neralogiche per citare solo le principali). Queste si sono incontrate nel gruppo di ricerca Aithale, formalizzatosi in convenzione nel 2010 tra le Università di Firenze e Siena, la Scuola Normale Superiore di Pisa, il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Geoscienze e Georisorse di Pisa, la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, con il contributo del Sistema dei Civici Musei Archeologici dell’Isola d’Elba.
1.2. Lo stato della ricerca: per una carta archeologica dell’isola d’Elba
La valutazione dell’impatto dell’attività mineraria e siderurgica nel comprensorio elbano-populoniese presuppone per il territorio in que-stione una sufficiente conoscenza della rete insediativa (necropoli, in-sediamenti produttivi, abitati in genere) e delle altre forme materiali in cui una comunità umana ‘modella’ il paesaggio. Purtroppo dal punto di
3 Notizie antiquarie (in primis lo stesso brano di Mir. ausc., 93), resoconti di inge-gneri minerari del XIX sec. (Simonin 1858, p. 357; Jervis 1862, pp. 60-1), osservazioni di moderni geologi (Mascaro, Guideri, Benvenuti 1991) confermano l’esistenza di affioramenti cupriferi di minima entità in varie località dell’Isola, senza che si possa parlare di vere e proprie miniere.
4 In Fabri 1887, pp. 11-2 si trovano cenni sull’apertura delle altre miniere all’Elba intorno alla metà del XIX sec.; più in dettaglio AA.VV. 1938.
5 Williams 2009, con bibliografia precedente.6 Colonna 1981; Corretti 2009a.
170 Autori vari
vista archeologico l’isola d’Elba è tanto ricca quanto poco nota: i dati sui ritrovamenti sono spesso vecchi, vaghi, poco attendibili7 e sono, in mol-ti casi, il frutto non di ricerche sistematiche ma di scoperte occasionali, anche da parte di gruppi di ricerca locali, meritoriamente impegnati a supporto della Soprintendenza nella difficile tutela del territorio8. Al-cune sintesi, anche recenti9, sono utili ma richiedono cautela nell’uti-lizzo dei dati riportati. Le principali imprese di scavo condotte negli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso – le fortezze d’altura di Monte Castello di Procchio e di Castiglione di San Martino – sono tuttora note solo tramite notizie preliminari10; così come altri scavi importanti per le tematiche oggetto della nostra ricerca: la necropoli del Buraccio e l’im-pianto siderurgico di San Bennato11.
Nell’ambito del progetto Aithale è stato quindi avviato, mediante un dottorato di ricerca, un censimento sistematico della documentazione archeologica elbana edita e inedita. In particolare sono stati documen-tati tutti i reperti temporaneamente custoditi dall’ispettore onorario per l’isola d’Elba Sig. Gino Brambilla12. Queste ed altre informazioni di carattere archeologico sono poi confluite in un GIS, che verrà imple-mentato con le informazioni geologiche e archeometriche relative alle risorse minerarie sfruttate in antico (rame e ferro13).Una prima nota su questi ‘ritrovamenti’ in deposito è stata presentata nel 2011 al XXVIII Convegno di Studi Etruschi e Italici14. Tra le principali
7 Per una breve storia della ricerca archeologica all’Isola d’Elba: Corsi, Gras 1989; Rosolani, Ferrari 2001; Corsi 2004; Firmati 2009.
8 Per la tutela del patrimonio archeologico elbano i vari funzionari che si sono succe-duti si sono potuti avvalere sul posto della collaborazione di Gino Brambilla, per decen-ni Ispettore Onorario sull’isola, infaticabile e onnipresente sulla terraferma e nei fondali intorno all’Elba, animatore di appassionati locali confluiti poi nel Gruppo Archeologico e Naturalistico Elbano.
9 Zecchini 2001, con bibliografia precedente.10 Vd. da ultimo Corretti 2012, con bibliografia precedente.11 Su Cavo vd. ora Corretti, Firmati 2011, con bibliografia precedente. Per la ne-
cropoli del Buraccio Firmati, Paoli 2007, pp. 74-5; Firmati 2009, p. 188; Maggiani c.d.s.
12 Si tratta di 720 schede relative a 63 siti.13 Minime presenze di stagno e piombo, irrilevanti ai fini dello sfruttamento minera-
rio, vengono segnalate all’Elba da Tanelli (1989, p. 1414) e Giardino (1995, p. 119).14 Cambi, Corretti, Pagliantini c.d.s.
171 Aithale. Ricerche e scavi all’Isola d’Elba
acquisizioni vale la pena di segnalare una nuova, possibile ‘fortezza d’altura’ nell’area di Monte Cuccolino, nell’immediato entroterra del Golfo di Portoferraio, oltre ad abbondante materiale di età romano-repubblicana dal sito di riduzione del ferro di Marciana Marina.
1.3. Lo stato della ricerca: l’attività mineraria e metallurgica sull’Isola
A parte un’oscura notizia nel De Mirabilibus Auscultationibus (93), ben poco sappiamo delle prime fasi di sfruttamento delle miniere di fer-ro dell’Elba15. I recenti risultati ottenuti dallo studio della composizione mineralogica e chimica dei giacimenti ematitici dell’Elba16 consentono di fare delle ipotesi scientificamente fondate sulla provenienza o meno dall’isola di frammenti di minerale ematitico ritrovati in diversi contesti archeologici. Due casi di minerale di probabile provenienza elbana in contesti del Paleolitico Superiore a Livorno e presso il Lago del Bilanci-no sono riferibili al suo impiego come pietra ornamentale, vista la sua lucentezza e lavorabilità17. Il noto frammento di ematite dallo ‘Scarico Gosetti’ di Ischia, anch’esso di probabile provenienza elbana18, viene purtroppo da un contesto stratigrafico disturbato e con riferimenti cro-nologici molto vaghi. Più interessanti i ritrovamenti di ematite elbana associata a attività metallurgica in contesti affidabili: i materiali di Pisa-Area Scheibler19 e Pisa-San Piero a Grado, inquadrabili tra fine VII e primi decenni del VI sec. a.C.20, quelli dall’edificio industriale di Po-pulonia, databili dall’inizio del VI sec. a.C.21, quelli di Follonica - Ron-
15 Corretti 2004; Acconcia, Milletti 2009.16 Benvenuti et al. 2013: vd. capitolo 3.17 Sammartino 2009, p. 49 fig. 5; Aranguren et al. c.d.s.18 Analisi eseguite da Massimo D’Orazio e Andrea Dini. Ringraziamo la dott.ssa Co-
stanza Gialanella per la disponibilità e la collaborazione dimostrata.19 Bonamici 1989.20 Bruni 2001. Analisi eseguite da Massimo D’Orazio e Andrea Dini. Ringraziamo
il prof. Stefano Bruni, le dott.sse Silvia Ducci, Emanuela Paribeni, Elena Sorge per la disponibilità e la collaborazione dimostrata.
21 Bonamici 2006; Ead. c.d.s.
172 Autori vari
delli22 e di Genova23. Lo studio dell’ematite proveniente da un contesto votivo di Pyrgi è invece appena iniziato24. Questi ritrovamenti mostra-no una diffusione del minerale grezzo almeno a partire dalla fine del VII-inizio VI sec. a.C. La presenza a Populonia di un edificio destina-to alla lavorazione del ferro già dall’inizio del VI sec. a.C. presuppone un afflusso di minerale certo e controllato, segno quindi di un’attività strutturata dall’estrazione alla trasformazione25; mancano tuttavia ele-menti per una valutazione quantitativa complessiva della produzione e, più in generale, per una collocazione cronologica delle fasi di avvio dello sfruttamento minerario organizzato sull’Isola.
I dati della spiaggia di Baratti mostrerebbero fino a tutto l’VIII sec. a.C. l’esclusiva attestazione di attività di trasformazione di minerali di rame, mentre dall’VIII-VII sec. a.C. è documentata la presenza di scorie ferrose26, seppure non in quantità paragonabili agli accumuli di III-II sec. a.C. Questi dati, pur provvisori e indiziari, contribuiscono comun-que al più ampio dibattito sul ruolo effettivo delle risorse minerarie – e nella fattispecie del ferro elbano – come possibile elemento di attrazio-ne di movimenti coloniali e commerciali dall’VIII sec. a.C. in poi.
All’isola d’Elba, le più antiche tracce di attività siderurgica primaria non sembrano risalire oltre la fine del III sec. a.C. Per i periodi prece-denti non abbiamo evidenza certa, sebbene sia ragionevole supporre limitate attività di trasformazione per uso locale27, secondo quanto in-diziato anche in altre località vicine28.
È dalla fine del III e per tutto il II sec. a.C. che vengono invece atti-vati sul litorale toscano grandi centri di riduzione del ferro, localizzati
22 Aranguren et al. 2004; Aranguren, Giachi, Pallecchi 2009, con bibliografia precedente.
23 Corretti, Benvenuti 2001, p. 143 e nota 91.24 Luciana Drago ci ha segnalato la presenza di ematite inglobata in manufatti votivi
in piombo rinvenuti nell’area sacra di Pyrgi. Per un primo studio archeometrico Bel-lafiore 2011-12.
25 Aranguren et al. 2004; Bonamici 2006; Ead. 2007; Ead. c.d.s.26 Chiarantini, Benvenuti 2009, con bibliografia precedente.27 Per il più antico fondo di forno o forgia messo in luce a San Bennato-Cavo è dispo-
nibile una datazione archeomagnetica al 450 ± 100 al momento isolata rispetto ai più antichi materiali raccolti nel sito (Firmati, Arrighi, Principe 2006).
28 Aranguren et al. 2004.
173 Aithale. Ricerche e scavi all’Isola d’Elba
tra l’altro a Populonia stessa e a Follonica29, oltre che all’isola d’Elba. Si contano all’Elba almeno 21 di questi punti di riduzione, quasi tutti in località costiere30. Nessuno di questi siti era stato indagato scienti-ficamente, con la parziale eccezione dell’accumulo degli Spiazzi di Rio Marina, dove Vincenzo Mellini poté comunque raccogliere qualche dato31, e dello scavo di emergenza a San Bennato-Cavo, nel 199932. La distruzione degli accumuli nel XX secolo per il recupero delle scorie ad alto tenore di ferro avvenne senza alcun controllo scientifico33. È pro-prio la quantità di scorie recuperate (in un solo sito 20500 t34 sebbene sia più ragionevole una stima complessiva per tutta l’isola nell’ordine di 100.000 t di scorie commerciali, cioè già selezionate in base al tenore in ferro), che fornisce una indicazione di massima sulla notevole dimen-sione del fenomeno. L’intensità dell’impatto sulle risorse minerarie e boschive dipende naturalmente dalla durata dell’attività di riduzione, a sua volta ricostruibile su base archeologica. I siti sono stati però oggetto finora solo di prospezione di superficie negli anni Ottanta del secolo scorso e precedentemente 35, per cui si dispone al momento solo di una ‘forchetta’ cronologica di massima che non può distinguere eventua-li frequentazioni dei siti per attività non connesse alla metallurgia36. Il limitato panorama ceramico restituito dalle prospezioni è comunque
29 Cambi 2009, p. 227 (Populonia); Baiocco et al. 1990 (Follonica).30 Corretti, Firmati 2011 con bibliografia precedente.31 Mellini 1879.32 Firmati, Arrighi, Principe 2006; Firmati 2009, pp. 188-189.33 Pistolesi 2013.34 Si deve allo studioso svedese J. Nihlen (1960) la raccolta di testimonianze dirette
presso coloro che avevano preso parte al recupero delle scorie. Il testo dattiloscritto, originariamente depositato presso l’Ente Valorizzazione Elba, è andato perduto. Da una copia in lingua originale (svedese) con traduzione in tedesco, ottenuta grazie all’interes-samento del prof. R. Francovich, sono stati ricavati i dati quantitativi editi in Corretti 1988 e 1991. Per un inquadramento generale dell’attività moderna di recupero delle scorie all’Elba vd. Pistolesi 2013.
35 Corretti, Firmati 2011, con bibliografia precedente.36 Attività produttive possono insediarsi in aree precedentemente destinate ad altri
utilizzi: oltre il caso-limite di Populonia, con la necropoli sommersa dalle scorie ferro-se, si pensi per l’Elba all’accumulo degli Spiazzi di Rio Marina, asportato nel 1877, in cui le scorie di età romana coprivano un livello più antico con sepolture a inumazione (Mellini 1879).
174 Autori vari
omogeneo (fine III-II sec. a.C., con attardamenti nel I sec. a.C.37, da valutare anche alla luce dello scavo di San Giovanni, su cui vd. infra) e appare confermato sia dai ritrovamenti di San Bennato, presso Cavo38, sia dai materiali recentemente schedati dalla Pagliantini39.
Proprio ai fini di un migliore inquadramento cronologico dell’attività metallurgica elbana e populoniese sono stati effettuati, da parte del La-boratorio di Archeomagnetismo del CNR di Viareggio, che partecipa al gruppo Aithale, campionamenti di alcune strutture metallurgiche sia nel territorio di Cavo (Isola d’Elba) sia sulla costa populoniese, volti alla definizione dell’età archeomagnetica (l’‘ultimo fuoco’). Alcune delle strutture analizzate non hanno dato esito positivo all’analisi. Si tratta di tracce di forni la cui presenza era da tempo nota lungo i sentieri dell’area di Cavo e che sono risultati non in giacitura originaria. A questi si ag-giungono due strutture all’interno del quartiere metallurgico di Popu-lonia, dove non erano presenti nelle argille concotte minerali ferrosi in quantità tale da permettere una datazione, oltre ad un fornetto venuto alla luce sempre a Populonia all’interno dell’area di scavo sulla spiaggia di San Cerbone, i cui materiali sono anch’essi risultati all’analisi troppo debolmente magnetizzati. Altre datazioni hanno invece dato risultati interessanti40 che incoraggiano la prosecuzione di questo tipo di analisi.
La grande quantità di scorie recuperate all’isola e sul continente41, le modalità di formazione degli accumuli e la loro stessa localizzazio-ne indicano un’attività intensa, pianificata, efficacemente descritta da Diodoro in un brano riferito proprio all’Elba (5,13,1-2) e giustamente valorizzato in passato per delineare forme di produzione protoindu-striale e precapitalistiche nel mondo antico42. In particolare, l’incetta di spugne ferrose operata dagli emporoi e l’organizzazione di veri e propri opifici in cui si riuniscono numerosi artigiani vanno in questa direzio-ne. Il testo diodoreo getta quindi luce su un sistema produttivo che,
37 Cambi 2009, p. 227; Corretti, Firmati 2011.38 Ibid.; Firmati, Arrighi, Principe 2006. Nell’ambito del progetto Aithale si è
proseguita la documentazione dei reperti da San Bennato custoditi ed esposti presso il Museo Archeologico del Distretto Minerario a Rio nell’Elba.
39 Cambi, Corretti, Pagliantini c.d.s.40 Firmati, Arrighi, Principe 2006; Principe et al. 2011.41 Su cui vd. Pistolesi 2006.42 Vd. da ultimo Corretti 2009b.
175 Aithale. Ricerche e scavi all’Isola d’Elba
coinvolgendo tutto l’areale tirrenico, ripartisce su un più vasto territo-rio l’impatto derivante dall’attività siderurgica, soprattutto per quan-to riguarda la produzione di carbone di legna. I dati dello scavo sulla spiaggia di Baratti43 confermano l’impressione generale di un drastico salto a livello quantitativo in epoca medio e tardorepubblicana44, che presuppone anche un diverso e perentorio approccio al territorio e alle sue risorse e, probabilmente, un deciso apporto di manodopera servile sia per la miniera sia per i siti di riduzione e le attività connesse (in primis la produzione di carbone di legna). Tra gli apporti esterni van-no naturalmente considerati gli emporoi, uno dei quali potrebbe essere quell’Aulus Vettius che ha graffito il suo nome su una coppa a vernice nera rinvenuta nelle acque del Cavo, a poca distanza dalle miniere e da un sito di riduzione45.
L’avvio di questa nuova fase produttiva è certamente posteriore all’av-vio della romanizzazione dell’area elbano-populoniese46, mentre non è chiaro il rapporto con la fornitura di ferro a Scipione nel 205 a.C. ricor-data da Livio (28,45,2)47, che può essere interpretata sia come il primo risultato di un nuovo sistema di gestione della risorsa del ferro, sia come una situazione di emergenza che avvia un rinnovamento radicale.
Quando e perché abbia poi avuto fine questa iron rush è tuttora og-getto di indagine. A Populonia le scorie di questa fase sono obliterate da strutture databili all’inizio del I sec. a.C.48. A San Bennato-Cavo mate-riali di I sec. a.C. sigillano il livello di abbandono dell’edificio siderurgi-co49. Ma il dato più chiaro proviene al momento dalle indagini portate avanti dal gruppo Aithale a San Giovanni, Portoferraio (vd. infra, parr. 1.5.1 e 1.5.2).
43 Acconcia, Cambi 2009.44 È un fatto che l’edificio industriale di Populonia, che dalla fine del VI sec. a.C.
aveva ospitato attività di lavorazione del ferro – accompagnata o meno da altre attività commerciali: Bonamici 2006 e 2007 – venga abbandonato e sepolto dagli accumuli di scorie entro la prima metà del III sec. a.C.
45 Firmati, Arrighi, Principe 2006, 304; Firmati, Paoli 2007, 75; Firmati 2009, p. 188; Maggiani c.d.s.
46 Cambi 2009, pp. 226-7.47 Da ultimo Corretti 2009b.48 Acconcia, Cambi 2009.49 Firmati, Arrighi, Principe 2006, p. 305.
176 Autori vari
1.4. Lo stato della ricerca: analisi composizionali di minerali elbani e di scorie siderurgiche
Lo studio di documentazione materiale di attività produttive non può prescindere dalla collaborazione totale (e quindi non limitata alla sola fornitura di analisi di corredo) tra archeologi e studiosi di scien-ze naturali, in primis ovviamente geologi e mineralogisti. Nel gruppo Aithale gli scienziati partecipano alla formulazione delle domande che indirizzano la ricerca, alla raccolta dei dati sul campo, alla discussione finale dei risultati di tutte le discipline messe in campo, anche di quelle umanistiche.
La domanda comune riguardava la possibilità o meno di seguire le tracce del ferro elbano negli spostamenti e nelle trasformazioni dallo stato minerale alla produzione di oggetti fino ad arrivare all’ingresso di questi nella stratificazione archeologica. Per quanto l’ematite di Rio sia, talvolta, riconoscibile al semplice esame autoptico, generalmente non è possibile distinguerla con certezza da ematiti provenienti da al-tri giacimenti presenti nel Mediterraneo e quindi accessibili agli anti-chi. Quindi, anche se frammenti di ematite definita «elbana» sono stati segnalati a più riprese in contesti archeologici di tutto il Tirreno, da Ischia a Genova e nell’interno fino a Marzabotto50, la loro effettiva pro-venienza dalle miniere di Rio – con quel che ne consegue in termini di ricostruzione storica – rimane da provare in modo inoppugnabile. Come già sopra accennato, lo studio di dettaglio delle mineralizzazioni ferrifere delle miniere elbane (in particolare Rio Marina e Terra Nera) ha portato all’individuazione di minutissime inclusioni – nell’ematite – di minerali di stagno e tungsteno (cassiterite, scheelite, ferberite, etc.) che determinano concentrazioni assai elevate in questi due elementi metallici51. Sulla base dei dati fin qui raccolti, queste caratteristiche mi-neralogiche e chimiche sembrano peculiari dei giacimenti ad ematite dell’Elba a scala europea e possono quindi costituire degli importanti traccianti di provenienza per i minerali di ferro elbani trasportati e trat-tati in siti metallurgici di varia collocazione geografica e cronologica (vd. par.. 1.2).
Per le scorie – la più comune traccia di attività siderurgiche da conte-
50 Corretti, Benvenuti 2001, pp. 142-3, con bibliografia precedente.51 Benvenuti et al. 2013.
177 Aithale. Ricerche e scavi all’Isola d’Elba
sti archeologici – il problema è ancora più complesso: le diverse tappe della filiera del ferro (riduzione, raffinamento, forgiatura, battitura in forgia) comportano ognuna la produzione di diversi tipi di scorie, an-che da punti diversi del medesimo impianto produttivo (fuori o dentro il forno di riduzione, dentro la forgia o intorno all’incudine). Le vecchie prospezioni sugli accumuli di scorie dell’Elba e del continente, gene-ralmente condotte da archeologi senza il diretto supporto di scienziati, non permettevano di riconoscere quali tappe della filiera del ferro erano state attivate nei diversi accumuli.
1.5. Il progetto Aithale: bilancio delle prime attività sul campo.
Sono stati scelti come siti campione gli accumuli di scorie di età ro-mana di San Giovanni (Portoferraio), Magazzini - Tenuta la Chiusa (Portoferraio) e l’accumulo di epoca medievale di Monte Strega (Rio nell’Elba).
Nei tre siti, nell’ambito di tre tesi di laurea presso il Dipartimento di Scienze della Terra - Università di Firenze (prof. M. Benvenuti), sono state eseguite prospezioni di superficie con raccolta totale di scorie e materiali ceramici in quadrati campione52. Le scorie sono state distinte tipologicamente, contate e pesate sul posto e campionate per le analisi. I primi dati confermano le differenze a livello tecnologico e operativo tra i siti romani e medievali: mentre nei primi veniva praticato solamente il primo stadio della lavorazione (la riduzione del minerale) con pro-duzione di spugne informi da raffinare altrove53, nel sito medievale di Monte Strega l’attività comprendeva anche la raffinazione del blumo, la produzione di semilavorati e, probabilmente, anche prodotti finiti54.
In base a queste prospezioni, valutando aspetti logistici e la disponi-bilità dei proprietari, la ricerca si è concentrata sul sito di San Giovanni, Portoferraio.
Il sito, che si trova ai piedi delle pendici occidentali della collina occu-pata dalla Villa delle Grotte (fig. 117), era già noto da notizie antiqua-
52 Corretti et al. c.d.s.53 Come esplicitamente descritto in Diod., 5,13,2.54 Corretti et al. 2012.
178 Autori vari
rie55 e per rinvenimenti incontrollati: nel 1889 vi sarebbe stato trovato un tesoretto della prima età augustea56 mentre reperti di V-IV sec. a.C. comprendenti a quanto sembra anche ceramica a figure rosse57, sareb-bero venuti alla luce nelle immediate vicinanze intorno al 1930. Nel corso delle prospezioni archeologiche del 1985 e del 1987 fu individua-to il limite del taglio operato per l’asportazione delle scorie e si raccolse-ro reperti ceramici che inquadravano la frequentazione del sito tra fine III e I sec. a.C.58.
Nel 2008 è stata effettuata una prospezione geoelettrica59 lungo tre fasce lunghe m 24 e larghe 2, parallele tra loro e perpendicolari alla scar-pata dell’escavazione per il recupero delle scorie.
Contestualmente si sono raccolte informazioni sulla attività di recupero sia presso testimoni oculari60 sia mediante una ricerca archi-vistica61. Lo sfruttamento del deposito di scorie di San Giovanni era iniziato nel 1938. Il muro di cinta settentrionale della tenuta62, prospi-ciente la costa, venne in parte abbattuto per collegare il cantiere ad un pontile per l’imbarco delle scorie; lo scavo procedette a partire dal mare verso SudEst e fu eseguito senza mezzi meccanici. Non è ancora chiaro se i due enormi blocchi di scoria presenti nel mare a poche decine di metri dalla costa siano in situ o siano stati spostati nel corso di questi lavori. Dal sito sarebbero state asportate ca 10000 t. di scorie63.
Nel settembre 2011 è stata invece condotta una prospezione mediante gradiometro a flusso64 che ha riguardato l’intera area a NordEst della Villa Gasparri e un limitato settore a SudEst.
55 Coresi del Bruno 1740, p. 172; Lambardi 1791, pp. 7 e 142.56 Mantovani 1892.57 Zecchini 1978, p. 207 (nessuna notizia in Id. 2001).58 Corretti 1988, pp. 13-5; Corretti, Firmati 2011, pp. 232-4.59 Eseguita da Nicoletta Barocca e Carlo Isola, Università di Siena.60 La signora Anna Maria Gasparri, comproprietaria con i nipoti Chiara, Paolo e
Raffaella del terreno oggetto dell’indagine, si prestò ad una lunga intervista nel settem-bre 2008. Ci piace che, sia pure postumo, le giunga il nostro ringraziamento per la sua gentilezza e l’ammirazione per la lucidità e la precisione del suo racconto.
61 Pistolesi 2013.62 Segnalato da Sabbadini (1919-20, p. 20) per la presenza di scorie ferrose nella
muratura.63 Notizia raccolta da Nihlen 1960, nr. 14.64 Eseguita da Laura Cerri della Ditta Tecne s.r.l. - Riccione.
179 Aithale. Ricerche e scavi all’Isola d’Elba
Il rilevamento ha permesso registrare una serie di anomalie positive. Alcune di queste erano relative a presumibili strutture interrate nell’a-rea immediatamente circostante la Villa; una a un probabile grande muro con orientamento SudEst-NordOvest; numerosi punti caratteriz-zati da picchi di magnetismo, nell’area a NordEst della villa, lasciavano supporre la presenza nel sottosuolo di strutture e di resti metallurgici.
1.5.1. Lo scavo di San Giovanni: campagna 2012La prima campagna di scavi, svoltasi dal 17 settembre al 6 ottobre
2012 in località San Giovanni (Portoferraio, Isola d’Elba), sotto la di-rezione della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, è nata quindi dall’intento di verificare la presenza e la consistenza dei re-sti delle strutture metallurgiche.
Il sito è stato esplorato attraverso due saggi di 12 x 6 e 6 x 8 m (figg. 118-9), impostati sulle aree che avevano restituito le anomalie più con-sistenti; l’indagine non ha però riportato in luce i resti dei forni per la riduzione dei minerali di ferro, che potrebbero trovarsi ancora molto sotto la fase di vita che è stata in maniera inattesa individuata.
Nel saggio 1 sono emersi i resti di un grande edificio, interessato da un consistente strato di crollo di tetto e pareti. Sono stati finora messi in luce tre ambienti: due coperti da un tetto e separati da una soglia (amb. I e II) e un terzo (amb. III), forse un cortile, in parte coperto da una tettoia (figg. 119-20).
Tutte le pareti dell’edificio, almeno nella porzione indagata, sono re-alizzate attraverso l’impiego dell’argilla cruda. Questa tecnica edilizia, impiegata prevalentemente nei muri divisori interni per la scarsa resi-stenza all’umidità di risalita e all’acqua piovana e per problemi di sicu-rezza, presenta, oltre alla rapidità ed economicità della messa in opera, caratteristiche di isolamento termico e di salubrità che ne giustificano l’utilizzo in contesti diversificati65.
Nel sito di San Giovanni la sopravvivenza di tali muri è stata sicura-mente favorita da un incendio: gli strati di crollo appaiono di color ros-so intenso, ricchi di frammenti di terra cruda cottasi per combustione, che conservano ancora tracce evidenti dell’incannicciata di sostegno, alternati a strati di colore nero, dovuti al disfacimento degli elementi lignei delle strutture.
65 Adam 1988, pp. 61-5, 132-5; De Arch., 2,8,20.
180 Autori vari
I due muri delimitanti l’amb. II, di cui restano visibili gli zoccoli in muratura (fig. 121), appaiono realizzati con la tecnica in mattoni crudi, ottenuti pressando argilla, sabbia e materiale organico e disposti suc-cessivamente su zoccoli in pietra66; questi, oltre a garantire solidità alla struttura, costituivano una protezione contro l’umidità. Infatti, le ana-lisi palinologiche hanno evidenziato la presenza sul sito di consistenti spore fungine, che testimoniano come il terreno fosse interessato dal persistente ristagno d’acqua. Il rivestimento dell’alzato era infine carat-terizzato da una terra argillosa mista a grandi frammenti di anfore, su cui doveva essere steso uno strato d’intonaco, parzialmente individuato nel crollo dell’ambiente.
Il rinvenimento, negli amb. I e II, di numerosissime tracce di strutture lignee carbonizzate, la presenza di impronte di canne all’interno della terra cruda combusta e la notevole quantità di chiodi di ferro documen-tano l’utilizzo della tecnica dell’opus craticium67, di cui è stata messa in luce un’ampia porzione in posto, che costituiva la parete Nord del primo ambiente (fig. 122).
Descrivendo la tecnica dell’opus craticium, Vitruvio (2,8,20) sottoli-nea che, a fronte della velocità di esecuzione, del minimo ingombro e della loro leggerezza, utile soprattutto nei piani superiori, i muri così realizzati sono però soggetti ad incendiarsi facilmente. Questa tecnica edilizia prevedeva una struttura lignea con funzione portante alla quale era fissato un intreccio di canne palustri ricoperte da uno strato d’into-naco, che proteggeva, regolarizzava e rivestiva le pareti. Muri a graticcio sono documentati a Pompei e nella Gallia meridionale in contesti datati tra il I sec. a.C. e il II sec. d.C.68; un confronto puntuale è offerto dall’e-dificio del saggio IV a valle delle Logge di Populonia, nel quale sono sta-te riportate in luce strutture murarie in mattoni crudi e opus craticium ascrivibili alla tarda età repubblicana69.
Nella porzione NordOvest dell’ambiente è stato inoltre parzialmente messo in luce un pavimento in cocciopesto, con inserti litici di piccole dimensioni, ricoperto dal disfacimento di intonaco bianco che doveva rappresentare il rivestimento parietale dell’ambiente stesso.
66 Adam 1988, pp. 63-4; Giuliani 1990, p. 152.67 De Arch., 2,3,1; Plin., n.h., 35, 48-49.68 Adam 1988, pp. 133-4; Lasfargues 1985.69 Cavari, Coccoluto 2008, pp. 145-68.
181 Aithale. Ricerche e scavi all’Isola d’Elba
La parete in opus craticium costituiva il lato meridionale di un gran-de ambiente, il III, interpretabile come un vasto cortile scoperto, dove sono stati localizzati cinque grandi dolia defossa, utilizzati per comple-tare la fermentazione del vino o per la sua conservazione (figg. 123-4).
Campioni pollinici prelevati all’interno dei dolia indiziano un pano-rama vegetale molto antropizzato, segnato dalla scomparsa del manto boschivo e dalla presenza di specie tipiche delle zone umide70. L’esa-me dei carboni ha messo in evidenza la costante presenza di essenze di Quercus ilex, largamente diffuse anticamente nell’Arcipelago Toscano. Sulle patine aderenti al fondo di un dolio è stata inoltre individuata una traccia di DNA, nella quale sono riconoscibili cristalli a granulometria eterogenea, tipici dei residui di vino antico71: il prosieguo delle analisi potrà quindi fornire indicazioni utili per la codifica degli antichi vitigni presenti sull’isola.
In questa prima campagna di scavo è stato possibile individuare sol-tanto cinque contenitori e completare lo scavo di due di essi, ma il dolia-rium dell’edificio di San Giovanni doveva essere sicuramente più esteso.
Nel saggio 2 un imponente muro, realizzato con blocchi regolari di pietra legati da malta cementizia, ha permesso di individuare l’estensio-ne occidentale dell’edificio (figg. 119, 125): questo muro delimitava in-fatti ad Ovest un’area esterna e ad Est una interna, da dove sono emer-si strati incoerenti composti da mattoni crudi, chiodi, elementi lignei carbonizzati, frammenti di intonaco e di pavimento in opus signinum, con inserti di tessere bianche disposte a formare un motivo geometrico. Questa tipologia di pavimento, che indica un elevato livello qualitativo delle strutture dell’edificio, è attestata in un arco cronologico compreso tra la fine del III e la fine del I sec. a.C.; pavimenti con le stesse decora-zioni geometriche sono attestati a Cosa in età cesariana (89-70 a.C.)72.
1.5.2. Hermia e i Valerii Messallae a San Giovanni e alla Villa delle GrotteDal fortunato recupero di alcuni bolli su opus doliare, ancora in fase
di studio, è stato possibile ricavare indicazioni preziose e convergenti
70 I campioni sono stati analizzati da C. Milanesi, C. Faleri, A. Gradi, A. Buracchi del Laboratorio Archeobotanico, Dipartimento Scienze della Vita, Università degli Studi di Siena, cui va il nostro ringraziamento.
71 Milanesi et al. 2011.72 Bueno 2006, pp. 39-56.
182 Autori vari
sulla probabile proprietà tanto degli edifici scavati quanto della vicina villa marittima, in linea con un’ipotesi che negli ultimi anni ha acquisito sempre maggiore consistenza: l’appartenenza dell’adiacente villa delle Grotte al patrimonio dei Valerii Messallae73.
Come già congetturato da Orlanda Pancrazzi, sulla sola base di un passo di Ovidio, il legame della gens con l’Elba è noto già dai versi dell’autore latino che rammenta di essersi recato sull’isola per salutare, alla vigilia della sua partenza per l’esilio (8 d.C.), l’amico Cotta Massi-mo74, figlio minore di Marcus Valerius Messalla Corvinus, uomo politi-co legato alla famiglia imperiale e protettore delle arti, e della seconda moglie di lui, una Aurelia degli Aurelii Cottae. In seguito all’adozione da parte dello zio materno, Marcus Aurelius Cotta, ne assume il cogno-men divenendo Lucius Aurelius Cotta Maximus Messallinus75.
Cotta Massimo doveva possedere sull’isola una residenza degna del suo alto rango, che verosimilmente potrebbe essere identificata con una delle tre monumentali ville marittime note: alle Grotte e alla Linguella, nel golfo di Portoferraio, o a Capo Castello, nella punta nord-orientale dell’isola. Tutte e tre le ville sono accomunate dalla posizione in località di grande impatto scenico e dall’altissima qualità edilizia, che permette di ricondurne l’edificazione all’età augustea76.
Più di recente, Elisabeth J. Shepherd77 si è spinta a ipotizzare, sulla base di una nuova lettura di un noto bollo laterizio di provenienza urba-na dalla villa delle Grotte, che proprio questa potesse essere la residenza di Massimo Cotta.
Su un frammento di bipedale è conservato il bollo lacunoso, impresso in cartiglio rettangolare, L. Corvini78: nella produzione doliare il cogno-me Corvinus compare nei bolli di Liberalis, servo di Calpurnia Corvini e di Lucius Valerius Corvinus, identificati con il Marcus Valerius Messalla Corvinus, padre di Cotta Massimo, e la prima moglie di lui. La con-
73 Pancrazzi 1995; Gliozzo, Manacorda, Shepherd 2004; Dallai, Ponta, Shepherd 2006.
74 Ex Ponto, 2,3,83-90.75 Sternini 2000, pp. 44-7.76 Pancrazzi 1995; Pancrazzi, Ducci 1996.77 Dallai, Ponta, Shepherd 2006, p. 183. Si ringrazia E.J. Shepherd per i cortesi e
solleciti suggerimenti78 Casaburo 1997, p. 99, tav. 29e.
183 Aithale. Ricerche e scavi all’Isola d’Elba
ferma di queste ipotesi è offerta dalle importanti testimonianze epigra-fiche rinvenute nel doliarium di San Giovanni: due dei dolia interrati finora individuati nell’ambiente produttivo presentavano due bolli in planta pedis (fig. 126) che, sebbene frammentari, consentono di recu-perare l’intero contenuto testuale con il nome del produttore: Hermia Va(leri) M(arci) s(ervus)/ fecit. Il servo Hermia usa una formula ono-mastica ben documentata nell’opus doliare tra tarda età repubblicana e prima età augustea79, come lascia supporre l’uso di posporre il praeno-men del dominus al suo gentilizio; ancora ad Hermia, verosimilmente lo stesso, rimandano due bolli frammentari su laterizi: in un cartiglio rettangolare (fig. 127), accanto alle sole due lettere iniziali del nome He(rmia) – anche qui legate come nei bolli in planta pedis del dolio – è raffigurato in rilievo un bel delfino col dorso inarcato. Dimensioni e cura dell’immagine colpiscono, come in altri punzoni usati tra la tarda età repubblicana e la prima età imperiale ma, oltre ad un generico rife-rimento al regno di Nettuno, cui certamente la distribuzione dell’opus doliare è legata, o alle attività alieutiche, l’animale potrebbe avere un si-gnificato diverso, legato alle numerose storie narrate in antico sulla sua filantropia. Sono infatti numerosi gli episodi di amore e benevolenza tra uomo e delfino, ambientati in diverse città greche, ma colpisce tra quelle ricordate da Plinio, la ricorrenza di due storie d’amicizia tra un delfino e un bambino accadute entrambe a Iasos, in Caria80: nella prima l’amore che un delfino nutre nei confronti di un fanciullo, lo porta a se-guirlo fin sulla spiaggia, dove però morirà arenato. Alessandro Magno a Babilonia prepose questo bambino al culto di Nettuno interpretando quell’amore come un segno del favore divino; Eliano aggiunge come in memoria dell’avvenimento gli abitanti di Iaso abbiano adottato come simbolo monetale un fanciullo che cavalca un delfino81.
Nella seconda storia ricordata da Plinio, tratta da Egesidemo, è ricor-dato un bambino che percorreva i mari a cavallo di un delfino82. Dopo che il bambino era rimasto ucciso dalle onde di una tempesta improv-visa, il delfino, tornato alla riva e riconoscendo la sua responsibilità per la tragedia avvenuta, non ritornò in mare e spirò sulla spiaggia. Il nome
79 Per l’area pisana: Ciampoltrini, Andreotti 1991.80 Plin., n.h., 9, 27-31.81 Aelian., NA, 6,15.82 Plin., n.h., 9, 31-33.
184 Autori vari
di questo fanciullo era proprio Ermia. Forse l’officinator dal nome gre-canico, come molti degli operatori impiegati nelle attivissime figlinae dell’Etruria settentrionale negli ultimi decenni del I sec. a.C., voleva evocare la propria terra d’origine83.
Un altro ritrovamento molto significativo è rappresentato da una te-gola recante un bollo in cartiglio quadrato, frammentario, inquadra-bile nella serie di bolli monogrammati VOLVS, ben nota e oggetto di una recente e approfondita disamina da parte di Ghiozzo, Manacorda e Shepherd, volta a verificare l’esistenza, tra i proprietari terrieri o i pro-duttori di materiali ceramici noti nell’Etruria settentrionale costiera, di personaggi cui attribuire i laterizi bollati con l’ermetico monogramma84.
La serie era stata letta da Dressel come Volus(i)85. La diffusione di que-sti esemplari, di cui sono stati individuate tre tipologie sulla base delle diversità dei punzoni utilizzati, si estende lungo tutta la costa toscana, da Luni fino al centro di Roselle (con attestazioni anche a Populonia), ma le condizioni di rinvenimento, perlopiù raccolte di superficie o con-testi non stratigrafici, non hanno consentito di fissare puntualmente la cronologia del bollo. Il larghissimo impiego di legature e l’organizza-zione della formula onomastica suggeriscono però per questi bolli una datazione tra tarda età repubblicana ed età augustea. Come argomenta Elisabeth J. Shepherd il cognome Volusus, tradizionalmente usato dalla gens Valeria, rimanda probabilmente al vasaio Marcus Valerius Volu-sus che marchia la produzione di terra sigillata italica di area pisana e la cui attività è collocata tra il 15 a.C. ed il 15-20 d.C86. L’esemplare emerso nello scavo di San Giovanni, in contesto stratigrafico affidabile, rappresenta quindi un’importante conferma delle ipotesi che vedevano legati il ceramista pisano con una delle più celebri e nobili famiglie ro-mane, quella dei Valerii. Marcus Valerius Volusus poteva appartenere alla famiglia dei Valerii, oppure essere un discendente di un esponente locale che aveva acquisito il nome del patrono e che poteva operare in una proprietà dei Valerii stessi, con un nome talmente caratterizzante e famoso che bastava, per farsi riconoscere, imprimere semplicemente un
83 Menchelli 2003, p. 167.84 Gliozzo, Manacorda, Shepherd 2004, pp. 191-212.85 CIL XI, 6689, 267.86 Shepherd 2004, pp. 205-7.
185 Aithale. Ricerche e scavi all’Isola d’Elba
monogramma. Hermia potrebbe quindi lavorare nella figlina di Marcus Valerius, la stessa da cui uscirebbero i prodotti col bollo VOLVS.
È attualmente in corso da parte di Gloria Olcese lo studio archeome-trico delle argille relative alle tegole di copertura e ai dolia, grazie alle quali sarà possibile risalire al centro o ai centri di produzione.
Sulla base dello studio dei materiali ceramici rinvenuti e delle atte-stazioni epigrafiche l’edificio e il doliarium di San Giovanni risalgono quindi alla prima metà del I sec. a.C. ed il loro abbandono è segnato da un incendio avvenuto nel I sec. d.C., che, ‘cuocendo’ le strutture in terra cruda, ne ha garantito la conservazione.
Questo grande complesso è interpretabile sicuramente come la pars rustica della Villa delle Grotte, scavata negli anni Sessanta del secolo scorso87 e situata sul promontorio adiacente, in posizione dominante su tutto il braccio di mare compreso fra il litorale di Piombino e l’insena-tura di approdo di Portoferraio, chiusa sull’altro lato dalla villa romana della Linguella. Si tratta di una residenza di grande prestigio, che rispet-ta le esigenze proprie di una grande famiglia; una famiglia come quella dei Valerii che ha stretti rapporti con la capitale, dalla quale fa perve-nire manodopera specializzata, materiali da costruzione e opere d’arte.
Sulla base di una recente revisione dei materiali e delle fasi edilizie della villa delle Grotte, effettuata da Sonia Casaburo, è stato possibile ascrivere all’età augustea il suo impianto originario, mentre l’assenza delle principali forme e produzioni della fine del I e poi del II sec. d.C. inducono a porre nella seconda metà del I sec. d.C. l’abbandono della residenza con uno spoglio molto consistente dei suoi elementi d’arredo più preziosi88.
La pars rustica e la pars urbana erano dunque separate, ma collegate da una grande scalinata rivolta verso San Giovanni, di cui sono visibi-li alcuni resti sul promontorio, che doveva costituire anche uno degli ingressi della villa: in questo caso la parte adibita alle funzioni produt-tive si trovava quindi in edifici distaccati dal vero e proprio complesso residenziale ed una soluzione simile è ipotizzata dal Mellini anche per la villa di Capo Castello, dove la pars rustica è identificata nei resti rin-venuti sul poco distante Capo Mattea89.
87 Monaco 1975, pp. 11-26; Monaco, Tabanelli 1976; Casaburo 1997.88 Casaburo 1997.89 Mellini Monaco 1965; Firmati 2004, pp. 171-83.
186 Autori vari
Gli elementi desunti dagli strati di crollo dell’edificio di San Giovanni pongono nello stesso momento la fine della frequentazione dell’edifi-cio, consentendo di proporre che sia stato proprio l’evento drammatico dell’incendio, che colpisce il cuore produttivo della villa, a segnare l’ab-bandono da parte dei proprietari.
In conclusione, la grande Villa delle Grotte può essere definitivamente e legittimamente annoverata tra le numerose proprietà fondiarie della gens Valeria, radicata saldamente lungo tutta la costa Toscana: i ritro-vamenti nel doliarium di San Giovanni, la diffusione del bollo Cotta in un sito produttivo e manifatturiero come quello del Sontrone (Folloni-ca) e in un porto fortemente legato ai traffici elbani come il Puntone di Scarlino, possono dunque essere inquadrati all’interno di un unico con-testo nel quale il controllo economico si estendeva sia sui siti produtti-vi, dediti alla manifattura di laterizi, di ceramica e alla lavorazione del metallo, sia nei centri atti alla commercializzazione di questi prodotti90.
È infatti assai verosimile che le ville elbane abbiano costituito origi-nariamente la residenza sul posto di personaggi che avevano avuto, fino a qualche tempo prima, interessi legati anche alle attività minerarie. I lavori per la costruzione della pars rustica della villa rappresentano ve-rosimilmente la fine della fase metallurgica che interessò il sito di San Giovanni per tutto il II sec. a.C. Le scorie di lavorazione, che i costrut-tori dovettero trovare in grande abbondanza sul sito, furono utilizzate infatti come piano preparatorio dei pavimenti in cocciopesto ed in opus signinum; le indagini di superficie condotte sui centri di riduzione di epoca romana sull’isola pongono per ora la cessazione dell’attività di lavorazione del ferro tra la fine del II e la metà del I sec. a.C.91, ma, an-cora negli ultimi decenni del I sec. a.C., Strabone vede arrivare al porto di Populonia il minerale che non può più essere ridotto sull’isola92; no-nostante la fine delle attività siderurgiche nella piana di S. Giovanni, il commercio dell’ematite elbana deve quindi essersi protratto, in forme ridotte, almeno fino alla fine del I sec. a.C.
Il fundus di San Giovanni può essere quindi stato sfruttato sia per gli interessi legati al commercio dei minerali di ferro, sia per la coltivazione agricola. Cotta Massimo è infatti ricordato tra gli autori da cui Plinio
90 Dallai, Ponta, Shepherd 2006, pp. 187-90.91 Corretti 1988; Corretti, Firmati 2011.92 Strabo, 5,2,6.
187 Aithale. Ricerche e scavi all’Isola d’Elba
attinse per la stesura della sua opera, in particolare per i libri sulla colti-vazione della vite, degli olivi e degli alberi da frutto93.
È verosimile che fossero proprio questi diversificati interessi econo-mici a motivare l’eccezionale concentrazione tra l’Elba e la costa anti-stante di personaggi illustri, legati alla cerchia augustea.
93 Plin., n.h., 1,14 e 15; Sternini 2000, p. 28.
188 Autori vari
AA.VV. 1938: AA.VV., Miniere e ferro dell’Elba dai tempi etruschi ai nostri giorni. Mostra autarchica del minerale italiano, Roma 1938;
Abate, Cannistraci 2012: A. Abate, O.S. Cannistraci, La stoa Nord dell’agora di Segesta. Alcune note preliminari sull’elevato architettonico dell’ala Ovest, in Ampolo 2012a, pp. 305-19;
Abate, Erdas, Giaccone 2011: A. Abate, D. Erdas, N. Giaccone, Segesta. Agora. Settore Est (SAS 4; 2009-10), in NotScASNP 2011, pp. 36-41;
Acconcia, Cambi 2009: V. Acconcia, F. Cambi, Pratiche metallurgiche e circolazione di saperi all’origine di Populonia, in Cambi, Cavari, Mascione 2009, pp. 171-9;
Acconcia, Milletti 2009: V. Acconcia, M. Milletti, Pratiche metallurgiche e circolazione di saperi all’origine di Populonia, in Cambi, Cavari, Mascione 2009, pp. 141-7;
Adam 1988: J.P. Adam, L’arte di costruire presso i Romani. Materiali e tecniche, Milano 1988;
Ambra per Agamennone 2010 = Ambra per Agamennone. Indigeni e Micenei tra Adriatico, Ionio ed Egeo. Catalogo della mostra, Bari, 28 maggio-16 ottobre 2010, a cura di F. Radina, G. Recchia, Bari 2010;
Ampolo 2007a: C. Ampolo, Iscrizioni greche dal santuario di Punta Stilo, in Parra 2007b, pp. 43-54;
Ampolo 2007b: C. Ampolo, Nota preliminare sulla nuova iscrizione osca, in Parra 2007b, pp. 50-4;
Ampolo 2009a: C. Ampolo (a cura di), Agorai di Sicilia, agorai d’Occidente, Pre-print degli Atti del Seminario di Studi, Pisa, 30 giugno-2 luglio 2008, Pisa 2009 [ora in Ampolo 2012a];
Ampolo 2009b: C. Ampolo (a cura di), Immagine ed immagini della Sicilia e delle altre isole del Mediterraneo antico, Atti delle seste giornate internazionali di studi sull’area elima e la Sicilia occidentale nel contesto mediterraneo, Erice, 12-16 ottobre 2006, Pisa 2009;
Ampolo 2012a: C. Ampolo (a cura di), Agora greca e agorai di Sicilia, Pisa 2012;
Ampolo 2012b: C. Ampolo (a cura di), Sicilia occidentale. Studi, rassegne, ricerche, Pisa 2012;
Ampolo 2012c: C. Ampolo, Una nuova testimonianza dell’uso del greco a Segesta in età augustea, in NotScASNP 2012, pp. 22-5;
Ampolo et al. c.d.s. = C. Ampolo, A. Corretti, R. Guglielmino, C. Michelini, M.C. Parra, M.A. Vaggioli, Entella: istituzioni e aspetti della forma urbana, in La città e le città della Sicilia antica, Atti delle ottave giornate internazionali di studi sull’area elima e la Sicilia occidentale nel contesto mediterraneo, Pisa, 18-21 dicembre 2012, a cura di C. Ampolo, c.d.s.;
Ampolo, Parra 2003: C. Ampolo, M.C. Parra, Segesta. Scavi nell’area dell’agora (2002-2005, campagna primaverile): risultati e prospettive di ricerca, in NotScASNP 2003, pp. 391-402;
Ampolo, Parra 2004: C. Ampolo, M.C. Parra, Segesta. Scavi nell’area dell’agora (2005-2006): risultati e prospettive di ricerca, in NotScASNP 2004, pp. 405-13;
Ampolo, Parra 2009: C. Ampolo, M.C. Parra, L’agora di Segesta. Uno sguardo d’assieme tra iscrizioni e monumenti, in Ampolo 2009a, pp. 125-41;
Ampolo, Parra 2010: C. Ampolo, M.C. Parra, Segesta. Scavi nell’area dell’agora (2007-08): risultati e prespettive di ricerca, in NotScASNP 2010, pp. 3-5;
Ampolo, Parra 2011: C. Ampolo, M.C. Parra, Segesta. Scavi nell’area dell’agora (2009-10): risultati e prospettive di ricerca, in NotScASNP 2011, pp. 3-8;
Ampolo, Parra 2012a: C. Ampolo, M.C. Parra, L’agora di Segesta: uno sguardo d’assieme tra iscrizioni e monumenti, in Ampolo 2012a, pp. 271-85;
Ampolo, Parra 2012b: C. Ampolo, M.C. Parra, Segesta. Scavi nell’area dell’agora (2011): risultati e prospettive di ricerca, in NotScASNP 2012, pp. 3-7;
Ampolo, Parra c.d.s. a: C. Ampolo, M.C. Parra, La grande stoa di Segesta: dalle realtà alle ricostruzioni virtuali, e oltre, in Restauri dell’antico. Ricerche ed esperienze nel Mediterraneo di età greca, Atti del Convegno di Studi, Selinunte, 20-23 ottobre 2011, c.d.s.;
Ampolo, Parra c.d.s. b: C. Ampolo, M.C. Parra, Segesta: organizzazione civica e spazi urbani, in La Città e le città della Sicilia antica, Atti delle ottave giornate internazionali di studi sull’area elima e la Sicilia occidentale nel contesto mediterraneo, Pisa, 18-21 dicembre 2012, a cura di C. Ampolo, c.d.s.;
192 Bibliografia
Andreou, Fotiadis, Kotsakis 1996: S. Andreou, M. Fotiadis, K. Kotsakis, Review of Aegean Prehistory V: The Neolithic and Bronze Age of Northern Greece, «AJA», 100, 1996, pp. 537-97;
Andrikou 1997: E. Andrikou, Thoughts and Considerations on the Mycenaeanisation of Crete, Motivated by the Pottery from Archanes, in La Crète mycénienne, Actes de la Table Ronde Internationale organisée par l’École française d’Athènes, 26-28 Mars 1991, éd. par J. Driessen, A. Farnoux, Paris 1997 («BCH», Supplément 30), pp. 9-22;
Angeletti 2012: V. Angeletti, Nell’agora di Segesta: un contributo sui monumenti minori, in Ampolo 2012a, pp. 321-6;
Aprile 2013: J.D. Aprile, The New Political Economy of Nichoria: Using Intrasite Distributional Data to Investigate Regional Institutions, «AJA», 117, 2013, pp. 429-36;
Aranguren et al. 2004: B.M. Aranguren, G. Ciampoltrini, L. Cortesi, M. Firmati, G. Giachi, P. Pallecchi, P. Rendini, P. Tesi, Attività metallurgica negli insediamenti costieri dell’Etruria centrale fra VI e V secolo a.C., in L’artisanat métallurgique dans les sociétes anciennes en Méditerranée occidentale, Atti del Convegno, Ravello 2000, éd. par A. Lehöerff, Rome 2004, pp. 323-39;
Aranguren et al. c.d.s.: B. Aranguren, F. Cavulli, M. D’Orazio, S. Grimaldi, A. Revedin, F. Santaniello, Territory Exploitation in Central and Western Gravettian Italy, in World of Gravettian Hunters, Krakow, 26-28 June 2013, c.d.s.;
Aranguren, Giachi, Pallecchi 2009: B.M. Aranguren, G. Giachi, P. Pallecchi, L’area siderurgica di Rondelli ed il contesto produttivo etrusco nel Golfo di Follonica e al Puntone di Scarlino, in Cambi, Cavari, Mascione 2009, pp. 159-62;
Ardizzone 1995: F. Ardizzone, La ceramica fine da mensa, in Agrigento. La necropoli paleocristiana sub divo, a cura di R.M. Bonacasa Carra, Roma 1995, pp. 87-117;
Arena et al. 2001: M.S. Arena, P. Delogu, L. Paroli, M. Ricci, L. Saguì, L. Vendittelli, Roma dall’antichità al Medioevo. Archeologia e storia nel Museo Nazionale Romano Crypta Balbi, Milano 2001;
Arthur 1997: P. Arthur, Uno stampo eucaristico bizantino da Soleto (Le), «Archeologia Medievale», 24, 1997, pp. 525-30;
Arthur 2003: P. Arthur, I Βalcani e il Salento nel Medioevo, in Archeologia dell’Adriatico dalla Preistoria al Medioevo, Atti del Convegno, Ravenna, 7-9 giugno 2001, a cura di F. Lenzi, Firenze 2003, pp. 654-65;
Arthur 2005: P. Arthur, L’Albania e la Terra d’Otranto nel Medioevo: tre casi
193 Bibliografia
studio, in Gli Illiri e l’Italia, Convegno Internazionale di Studi, Treviso, 16 ottobre 2004, Treviso 2005, pp. 77-92;
Arthur, Bruno 2007: P. Arthur, B. Bruno, Muro Leccese. Alla scoperta di una terra medievale. Una città, la sua gente, le sue radici, Lecce 2007;
Arthur, Fiorentino, Leo Imperiale 2008: P. Arthur, G. Fiorentino, M. Leo Imperiale, I manufatti del pozzo, in L’insediamento in località Scorpo (Supersano, Le) nel VII-VIII secolo. La scoperta di un paesaggio di età altomedievale, «Archeologia Medievale», 35, 2008, pp. 365-80;
Aversa 2013: G. Aversa, I tetti achei. Terrecotte architettoniche di età arcaica in Magna Grecia, Paestum 2013;
Bacile di castiglione 1927: G. Bacile Di Castiglione, Castelli pugliesi, Roma 1927 [rist. anast. Bologna 1978];
Badami 2000: M. Badami, Indagine geologica sul Monte Barbaro a Segesta, in Terze Giornate Internazionali di Studi sull’Area Elima. Atti del Convegno, Gibellina-Erice-Contessa Entellina, 23-26 ottobre 1997, Pisa-Gibellina 2000, pp. 47-55;
Baiocco et al. 1990: G. Baiocco, F. Bucci, L. Ferretti, N. Gero, R. Magagnini, L. Verdini, Metallurgia antica e medievale nel Golfo di Follonica, Follonica 1990;
Baldassari 2009: R. Baldassari, Il materiale del carico del relitto: analisi tipologica e quantitativa della ceramica locale da fuoco, in Tusa, Zangara, La Rocca 2009, pp. 91-106;
Barber 2010: R.L.N. Barber, Late Bronze Age: Cyclades, in The bronze Age Aegean (ca. 3000-1000 BC), ed. by E.H. Cline, Oxford 2010, pp. 160-70;
Barello 1995: F. Barello, Architettura greca a Caulonia. Edilizia monumentale e decorazione architettonica di una città della Magna Grecia, Firenze 1995 (Studi e Materiali di Archeologia 9);
Barletta 1990: B. Barletta, An “Ionian Sea” Style in Archaic Doric Architecture, «AJA», 94, 1990, pp. 45-72;
Barletta 1999: B. Barletta, Ionic Influence in Western Greek Architecture: Towards a Definition and Explanation, in Die Ägäis und das westliche Mittelmeer, Akten des Symposions, hrsg. von F. Krinzinger, Wien 1999, pp. 203-16;
Basso et al. 2008: E. Basso, C. Capelli, M.P. Riccardi, R. Cabella, A Particular Temper: Mineralogical and Petrographic Characterisation of Ceramic Fabrics with Glauconitic Inclusions, «ArchéoSciences», 32, 2008, pp. 93-7;
Bell 1986: M. Bell, La fontana ellenistica di Morgantina, «Quaderni dell’Istituto di Archeologia della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Messina», 4, 1986, pp. 111-24;
194 Bibliografia
Bell 1988: M. Bell, Excavations at Morgantina, 1980-1985: Preliminary Report XII, «AJA», 92, 1988, pp. 313-42;
Bell 2008: M. Bell, Continuità e rotture a Morgantina nel V sec. a.C., in Morgantina a cinquant’anni dall’inizio delle ricerche sistematiche, Atti dell’Incontro di Studi, Aidone, 10 dicembre 2005, a cura di G. Guzzetta, Caltanissetta-Roma 2008, pp. 9-21;
Bellafiore 2011-12: C. Bellafiore, Analisi archeometriche di reperti metallici rinvenuti nel santuario meridionale etrusco di Pyrgi (Santa Severa), Univ. La Sapienza di Roma, rell. L. Drago, M. Benvenuti, 2011-12;
Benelli et al. 1995: M.V. Benelli, M. de Cesare, M. Paoletti, M.C. Parra, Lo scavo dell’area 3000 (SAS 3), in AA.VV., Segesta. Parco archeologico e relazioni preliminari delle campagne di scavo 1990-1993, «ASNP», s. 3, 25, 1995, pp. 662-755;
Benvenuti et al. 2013: M. Benvenuti, A. Dini, M. D’orazio, L. Chiarantini, A. Corretti, P. Costagliola, The Tungsten and Tin Signature of Iron Ores from Elba Island (Italy): a Tool for Provenance Studies of Iron Production in the Mediterranean Region, «Archaeometry», 55, 3, 2013, pp. 479-506;
Benzi 1984: M. Benzi, Evidence for a Middle Minoan Settlement on the Acro-polis at Ialysos (Mt. Philerimos), in Minoan Thalassocracy 1984, pp. 93-105;
Benzi 1987: M. Benzi, I Micenei a Iasos, in Studi su Iasos di Caria, Roma 1987 («BA», Supplemento), pp. 29-34;
Bernabò Brea 1985: L. Bernabò Brea, Gli Eoli e l’inizio dell’età del bronzo nelle isole Eolie e nell’Italia meridionale, Napoli 1985;
Bernabò Brea, Cavalier 1980: L. Bernabò Brea, M. Cavalier, Meligunìs Lipára IV. L’acropoli di Lipari nella Preistoria, Palermo 1980;
Bernabò Brea, Cavalier 1991: L. Bernabò Brea, M. Cavalier, Meligunìs Lipára VI. Filicudi, insediamenti dell’età del bronzo, Palermo 1991;
Betancourt 2008: P.P. Betancourt, Minoan Trade, in The Cambridge Companion to the Aegean Bronze Age, ed. by C.W. Shelmerdine, Cambridge 2008, pp. 209-29;
Bettelli 1999: M. Bettelli, Da Occidente a Oriente: uomini, modelli e manufatti dall’Italia all’Egeo nella tarda Età del Bronzo, in Epi ponton plazomenoi, Simposio italiano di Studi Egei dedicato a Luigi Bernabò Brea e a Giovanni Pugliese Carratelli, Roma, 18-20 febbraio 1998, a cura di V. La Rosa, D. Palermo, L. Vagnetti, Roma 1999, pp. 461-72;
Bettelli 2002: M. Bettelli, Italia meridionale e mondo miceneo, Firenze 2002;
Bettelli 2004: M. Bettelli, Elementi del Bronzo Recente dell’Italia continentale nell’Europa al di là delle Alpi e nel Mediterraneo orientale, in L’età del Bronzo recente in Italia, Atti del Congresso Nazionale, Lido di
195 Bibliografia
Camaiore, 26-29 ottobre 2000, a cura di D. Cocchi Genick, Viareggio 2004, pp. 301-11;
Bettelli 2010: M. Bettelli, Italia ed Egeo prima e dopo il crollo dei palazzi micenei: le ceramiche d’impasto e grigia tornita in Grecia e a Creta alla luce delle più recenti scoperte, in Ambra per Agamennone 2010, pp. 119-27;
Bettelli et al. 2006: M. Bettelli, S.T. Levi, R.E. Jones, L. Vagnetti, Le ceramiche micenee in area medio-tirrenica: nuove prospettive, in Studi di protostoria in onore di Renato Peroni, Firenze 2006, pp. 399-406;
Bettelli et al. 2010: M. Bettelli, R.E. Jones, S.T. Levi, L. Vagnetti, Ceramicne egee e di tipo egeo lungo il versante adriatico pugliese: centri di produzione, livelli di circolazione, contesti d’uso, in Ambra per Agamennone 2010, pp. 109-17;
Bettelli, Levi, Vagnetti 2001-02: M. Bettelli, S.T. Levi, L. Vagnetti, Cronologia, topografia e funzione dei siti con testimonianze micenee in Italia meridionale, «GeogrAnt», 10-1, 2001-02, pp. 65-95;
Biancofiore 1967: F. Biancofiore, Civiltà micenea nell’Italia meridionale, Roma 1967;
Bietak 1996: M. Bietak, Avaris: The Capital of the Hyksos, London 1996;Bietak, Marinatos 1995: M. Bietak, N. Marinatos, The Minoan Wall
Paintings from Avaris, in Trade, Power and Cultural Exchange: Hyksos Egypt and the Eastern Mediterranean World 1800-1500 B.C., ed. by M. Bietak, Wien 1995, pp. 49-62;
Bietti Sestieri 1996: A.M. Bietti Sestieri, Protostoria. Teoria e pratica, Roma 1996;
Bietti Sestieri 2003: A.M. Bietti Sestieri, Un modello per l’interazione fra oriente e occidente mediterranei nel II millennio a.C.: il ruolo delle grandi isole, in Atti della XXXV Riunione Scientifica I.I.P.P., Castello di Lipari, 2-7 giugno 2000, Firenze 2003, pp. 556-86;
Bietti Sestieri 2010: A.M. Bietti Sestieri, I metalli, in Ambra per Agamennone 2010, pp. 77-83;
Biffi 2006: N. Biffi, Strabone di Amasea. Magna Grecia e dintorni (Geografia, 5, 4, 3 - 6, 3, 11), introduzione, traduzione, testo e commento a cura di N. Biffi, Bari 2006;
Bintliff 1999: J. Bintliff, Introduction, in From Minoan Farmers to Roman Traders: Sidelights on the Economy of Ancient Crete, ed. by A. Chaniotis, Stuttgart 1999, pp. 1-14;
Blake 2008: E. Blake, The Mycenaeans in Italy: a Minimalist Position, «PBSR», 76, 2008, pp. 1-34;
Boehringer, Krauss 2013: E. Boehringer, F. Krauss, Das Temenos für den Herrscherkult. Prinzessinnen Palais, Berlin 2013;
196 Bibliografia
Boldrini 1994: S. Boldrini, Gravisca. Scavi nel santuario greco, 4. Le ceramiche ioniche, Bari 1994.
Bolohan 2003: N. Bolohan, An Essay Concerning the Trans-Balkan Relations during the Middle and Late Bronze Age to the Early Iron Age, in The Periphery of the Mycenaean World, Second International Interdisciplinary Colloquium, Lamia, 26-30 September 1999, ed. by N. Kyparissi Apostolika, M. Papakonstantinou, Athens 2003, pp. 99-106;
Bonamici 1989: M. Bonamici, Contributo a Pisa arcaica, in Secondo Convegno Internazionale Etrusco, Firenze 1985, Roma 1989, pp. 1135-47;
Bonamici 2006: M. Bonamici, Nuove ricerche nell’area degli edifici industriali di Populonia, «Agoghé», 3, 2006, pp. 255-62;
Bonamici 2007: M. Bonamici, Nuove ricerche nel quartiere industriale di Populonia, «Annali della fondazione per il Museo “Claudio Faina”, 14, 2007, pp. 431-53;
Bonamici c.d.s.: M. Bonamici, Ricerche negli stabilimenti industriali di Populonia, in La Corsica e Populonia, Atti del XXVIII Convegno di Studi Etruschi e Italici, Bastia-Aléria-Piombino 2011, c.d.s.;
Bonanno 2008: C. Bonanno, Gli scavi nell’area del teatro di Morgantina (2004-2005) e i lavori per la riapertura del Museo di Aidone, in Morgantina a cinquant’anni dall’inizio delle ricerche sistematiche, Atti dell’Incontro di Studi, Aidone, 10 dicembre 2005, a cura di G. Gazzetta, Caltanissetta-Roma 2008, pp. 69-80;
Bonanno 2009: C. Bonanno (a cura di), Kalè Akté. Scavi in contrada Pantano di Caronia Marina 2003-2005, Roma 2009;
Bonanno et al. 2010: C. Bonanno, R. Cabella, C. Capelli, M. Piazza, Nuove esplorazioni in località Gerace (Enna-Sicilia), in LRCW3. Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and archaeometry, Oxford 2010 ed. by S. Menchelli, S. Santoro, M. Pasquinucci, G. Guiducci (BAR International Series 2185/I), pp. 261-72;
Bonanno, Sudano 2006: C. Bonanno, F. Sudano, Kalè Akté. L’insediamento in contrada Pantano a Caronia Marina, in D. Malfitana, J. Poblome, J. Lund, Old Pottery in a New Century. Innovating Perspectives on Roman Pottery Studies, Atti del Convegno Internazionale di Studi, Catania, 22-24 aprile 2004, Catania 2006, pp. 435-49;
Bonanno, Sudano 2009: C. Bonanno, F. Sudano, I materiali, in Bonanno 2009, pp. 29-46;
Bonifay 2004: M. Bonifay, études sur la céramique romaine tardive d’Afrique, Oxford 2004;
Bonifay, Capelli, Brun 2012: M. Bonifay, C. Capelli, C. Brun, Pour une
197 Bibliografia
approche intégrée archéologique, pétrographique et géochimique des sigillées africaines, in INDVSTRIA APIVM. L’archéologie: une démarche singulière, des pratiques multiples. Hommages à Raymond Brulet, sous la direction de M. Cavalieri, Louvain 2012, pp. 41-62;
Bonifay, Capelli, Polla 2002-03: M. Bonifay, C. Capelli, S. Polla, Notes de céramologie africaine. Observations archéologiques et archéométriques sur les céramiques modelées du groupe dit «Calcitic ware», in «AntAfr», 38-9, 2002-03 [2005], pp. 431-40;
Branigan 1981: K. Branigan, Minoan Colonialism, «ABSA», 76, 1981, pp. 23-35;
Branigan 1984: K. Branigan, Minoan Community Colonies in the Aegean?, in Minoan Thalassocracy 1984, pp. 49-53;
Branigan 1989: K. Branigan, Minoan Foreign Relations in Transition, in Transition. Le monde égéen du Bronze moyen au Bronze récent, Actes de la deuxième rencontre égéenne internationale de l’Université de Liège, 18-20 avril 1988, éd. par R. Laffineur, Liège 1989 (Aegaeum 3), pp. 65-71;
Branigan 1991: K. Branigan, Mochlos: An Early Aegean ‘Gateway Community’?, in Thalassa. L’Egée préhistorique et la mer, Actes de la troisième rencontre égéenne internationale de l’Université de Liège, Station de recherches sous-marines et océanographiques (StaReSo), Calvi, 23-25 avril 1990, éd. par R. Laffineur, L. Basch, Liège-Austin 1991 (Aegaeum 7), pp. 97-105;
Branigan 1999: K. Branigan, Late Neolithic Colonization of the Uplands of Eastern Crete, in Neolithic Society in Greece, ed. by P. Halstead, Sheffield 1999, pp. 57-65;
Broodbank 2000: C. Broodbank, An Island Archaeology of the Early Cyclades, Cambridge 2000;
Broodbank, Strasser 1991: C. Broodbank, T.F. Strasser, Migrant Farmers and the Neolithic Civilization of Crete, «Antiquity», 65, 1991, pp. 233-45;
Bruni 2001: S. Bruni, Ad Gradus Arnenses. Il distretto della foce del ramo settentrionale del delta dell’Arno in età antica, in Tombolo. Territorio della Basilica di San Piero a Grado, Pisa 2001, pp. 83-99;
Bruno, Capelli 2000: B. Bruno, C. Capelli, Nuovi tipi di anfore da trasporto a Malta, in Le Scienze della Terra e l’Archeometria, Atti della 6a Giornata, Este, 26-27 febbraio 1999, a cura C. D’Amico, C. Tampellini, Este 2000, pp. 59-65;
Bryce 1989: T.R. Bryce, The Nature of Mycenaean Involvement in Western Anatolia, «Historia», 38, 1989, pp. 1-21;
Bueno 2006: M. Bueno, I pavimenti in cementizio decorati dell’Etruria centro-
198 Bibliografia
settentrionale, «Antenor», 5, 2006, pp. 39-56;Büsing 1970: H.H. Büsing, Die Griechische Halbsäule, Wiesbaden 1970;Cabella, Capelli, Piazza 2009: R. Cabella, C. Capelli, M. Piazza, Analisi
petrografiche in sezioni sottili da Caronia e Furnari Tonnarella, in Bonanno 2009, pp. 59-61;
Cacciaguerra, Facella, Zambito c.d.s.: G. Cacciaguerra, A. Facella, L. Zambito, Continuity and Discontinuity in Seventh Century Sicily: Rural Settlement and Economy, in The Long Seventh Century: Continuity and Discontinuity in an Age of Transition, Proceedings of the 2013 Edinburgh Seventh Century Colloquium, c.d.s.;
Cambi 2009: F. Cambi, Conclusioni. Ferro, territorio e bacini di approvvigionamento fra il periodo etrusco e il periodo romano, in Cambi, Cavari, Mascione 2009, pp. 221-30;
Cambi, Cavari, Mascione 2009: F. Cambi, F. Cavari, C. Mascione (a cura di), Materiali da costruzione e produzione del ferro. Studi sull’economia populoniese fra periodo etrusco e romanizzazione, Bari 2009;
Cambi, Corretti, Pagliantini c.d.s.: F. Cambi, A. Corretti, L. Pagliantini, Aithale. Per una ripresa della ricerca archeologica all’Isola d’Elba, in La Corsica e Populonia, Atti del XXVIII Convegno di Studi Etruschi e Italici, Bastia-Aléria-Piombino 2011, c.d.s.;
Campagna 2003: L. Campagna, Il capitello della cosidetta agorà di Siracusa e la cronologia dei più antichi capitelli corinzio-sicelioti, in Studi classici in onore di Luigi Bernabò Brea, a cura di G.M. Bacci, M.C. Martinella, Messina 2003 («Quaderni del Museo Archeologico Regionale Eoliano “Luigi Bernabò Brea”», Suppl. II), pp. 149-68;
Campagna, La Torre 2008: L. Campagna, G.F. La Torre, Ricerche sui monumenti e sulla topografia di Tauromenion: una stoà ellenistica nell’area della Naumachia, «Sicilia Antiqua», 5, 2008, pp. 115-46;
Cannistraci 2011: O.S. Cannistraci, Problemi di definizione. Il caso delle stoai con oikoi/oikemata e stoai con ergasteria, «ASAA», 89, 2011, pp. 359-78;
Cannistraci, Perna 2011: O.S. Cannistraci, M. Perna, Segesta. Agora. Settore NordEst (SAS 4; 2009-10), in NotScASNP 2011, pp. 28-35;
Cannistraci, Perna 2012: O.S. Cannistraci, M. Perna, Segesta. Agora. Settore NordEst (SAS 4; 2011), in NotScASNP 2012, pp. 12-6;
Capelli, Bonifay 2007: C. Capelli, M. Bonifay, Archéométrie et archéologie des céramiques africaines: une approche multidisciplinaire, in LRCW2. Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry, ed. by M. Bonifay, J.-C. Treglia, Oxford
199 Bibliografia
2007 (BAR International Series 1662/II), pp. 551-68;Capelli, Bonifay c.d.s.: C. Capelli, M. Bonifay, Archéométrie et archéologie
des céramiques africaines: une approche pluridisciplinaire, 2. Nouvelles données sur la céramique culinaire et les amphores, in LRCW4. Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry, Oxford (BAR International Series), c.d.s.;
Caprino 2006: P. Caprino, Appunti sulla ceramica da fuoco fra Basso-Medioevo e Rinascimento nel Salento, Galatina 2006, «Quaderni della Ceramica di Cutrofiano», 10, 2, 2006, pp. 11-43.
Caprino 2008: P. Caprino, La ceramica da fuoco, in Roca nel Basso Medioevo 2008, pp. 412-4;
Caprino et al. 2013: P. Caprino, F. Ghio, M. Andrea Sasso, Il complesso di S. Maria del Tempio a Lecce (Scavi 2011- 2012), Lecce 2013;
Carancini, Peroni 1997: L Carancini, R. Peroni, La koinè metallurgica, in Le Terramare. La più antica civiltà padana, a cura di M. Bernabò Brea, A. Cardarelli, M. Cremaschi, Milano 1997, pp. 595-601;
Casaburo 1997: S. Casaburo, Elba romana: la villa delle Grotte, Torino 1997;Castellana 2000: G. Castellana, La cultura del Medio Bronzo
nell’Agrigentino ed i rapporti con il mondo miceneo, Agrigento 2000;Castleden 1993: R. Castleden, Minoans. Life in Bronze Age Crete, New
York 1993;Castleden 1998: R. Castleden, Atlantis Destroyed, London-New York 1998;Castronovi 1999: C. Castronovi, La ceramica postmedievale, in Da
Apigliano a Martano. Tre anni di archeologia medievale: 1997-1999, a cura di P. Arthur, Galatina 1999, pp. 68-72;
Castronovi, Matteo 2000: C. Castronovi, S. Matteo, Le produzioni di ceramica graffita nel Salento, Galatina 2000, «Quaderni della Ceramica di Cutrofiano», 4-5, 2000, pp. 11-31;
Catalano et al. 2010: R. Catalano, G. Avellone, L. Basilone, A. Sulli, M. Barchi, C. Di Maggio, R. Sprovieri, M. Agate, C. Albanese, M. Gasparo Morticelli, C. Gugliotta, G. Lena, Note Illustrative della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000, Foglio 607 Corleone, Palermo 2010;
Catalano et al. 2011: R. Catalano, M. Agate, L. Basilone, C. Di Maggio, M. Mancuso, A. Sulli, E. Di Stefano, M. Gasparo Morticelli, G. Avellone, B. Abate, M. Arnone, G. Lo Cicero, M. Scannavino, C. Gugliotta, Note Illustrative della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000, Foglio 593 Castellammare del Golfo, Palermo 2011;
Catling 1973: H.W. Catling, The Achaean Settlement of Cyprus, in The Mycenaeans in the Eastern Mediterranean, Acts of the International
200 Bibliografia
Archaeological Symposium, Nicosia, 27th March-2nd April 1972, Nicosia 1973, pp. 34-9;
Catling 1989: H.W. Catling, Some Problems in Aegean Prehistory c. 1450-1380 BC, Oxford 1989;
Cavalier 1960: M. Cavalier, Les cultures préhistoriques des îles éoliennes et leur rapport avec le monde égéen, «BCH», 84, 1960, pp. 319-46;
Cavanagh 2010: W.G. Cavanagh, Central and Southern Peloponnese, in The bronze Age Aegean (ca. 3000-1000 BC), ed. by E.H. Cline, Oxford 2010, pp. 631-42;
Cavari, Coccoluto 2008: F. Cavari, M. Coccoluto, Tecniche edilizie in terra cruda nel saggio IV, in Materiali per Populonia 7, a cura di V. Acconcia, C. Rizzitelli, Firenze 2008, pp. 145-68;
Cavazzuti 2002: I. Cavazzuti, Ceramica arcaica fine dal santuario di Punta Stilo, in Parra 2002b, pp. 249-78;
Cazzella, Moscoloni 1991: A. Cazzella, M. Moscoloni, Aspetti dell’economia di sussistenza durante l’età del bronzo a Coppa Nevigata e nell’Italia meridionale, «Scienze di Antichità», 5, 1991, pp. 233-64;
Cazzella, Moscoloni, Recchia 2001: A. Cazzella, M. Moscoloni, G. Recchia, Coppa Nevigata: campagne di scavo 1999 e 2000, in Atti del 21° Convegno di Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia, San Severo, 24-26 novembre 2000, San Severo 2001, pp. 153-70;
Chiarantini, Benvenuti 2009: L. Chiarantini, M. Benvenuti, I bacini di approvvigionamento dei minerali metallici e le tecnologie produttive del rame e del ferro, in Cambi, Cavari, Mascione 2009, pp. 203-12;
Ciampoltrini, Andreotti 1990-91: G. Ciampoltrini, A. Andreotti, Figline pisane, «Opus», 9-10, 1990-91, pp. 161-7;
Ciminale 2000: D. Ciminale, Lecce nel XVI secolo e l’isola del Governatore: i materiali ceramici, in Lecce. Frammenti di storia urbana. Tesori archeologici sotto la Banca d’Italia, Catalogo della Mostra, Lecce, dicembre 2000-marzo 2001, a cura di L. Giardino, P. Arthur, G.P. Ciongoli, Bari 2000, pp. 93-106;
Cline 1991: E.H. Cline, Orientalia in the Late Bronze Age Aegean; A Catalogue and Analysis of Trade and Contact Between the Aegean and Egypt, Anatolia, and the Near East, Ph.D. Dissertation, University of Pennsylvania 1991;
Cline 1994: E.H. Cline, Sailing the Wine-Dark Sea: International Trade and the Late Bronze Age Aegean, Oxford 1994 (BAR International Series 591);
Cline 1995: E.H. Cline, Egyptian and Near Eastern Imports at Late Bronze Age Mycenae, in Egypt, the Aegean and the Levant: Interconnections in the Second Millennium BC, ed. by W.V. Davies, L. Schofield, London 1995, pp. 91-115;
201 Bibliografia
Coldstream, Huxley 1984: J.N. Coldstream, G.L. Huxley, The Minoans of Kythera, in Minoan Thalassocracy 1984, pp. 107-12;
Colonna 1981: G. Colonna, Presenza greca ed etrusco-meridionale nell’Etruria Mineraria, in L’Etruria mineraria, Atti del XII Convegno di Studi Etruschi e Italici, Firenze-Populonia-Piombino 1979, Roma 1981, pp. 443-52;
Conti 1994: M.C. Conti, Il più antico fregio dell’Heraion del Sele, Torino 1994;Cook 1988: V. Cook, Cyprus and the Outside World during the Transition
from the Bronze Age to the Iron Age, «OAth», 17, 1988, pp. 13-32;Coresi del Bruno 1740: G.V. Coresi del Bruno, Zibaldone di memorie,
1740, ms., Firenze, Biblioteca Marucelliana [1927];Corretti 1988: A. Corretti, Indagine preliminare sull’attività di riduzione
del ferro in età romana all’Isola d’Elba, «Geoarcheologia», 2, 1988, pp. 7-39;Corretti 1991: A. Corretti, Metallurgia medievale all’Isola d’Elba, Firenze
1991;Corretti 2004: A. Corretti, Per un riesame delle fonti greche e latine sull’Isola
d’Elba nell’antichità. I. Lo sfruttamento minerario, in Gualandi, Mascione 2004, pp. 269-89;
Corretti 2009a: A Corretti, Le isole toscane tra storia e mito: l’arcipelago che non c’è, in Ampolo 2009a, pp. 295-313;
Corretti 2009b: A. Corretti, Siderurgia in ambito elbano e populoniese: un contributo dalle fonti letterarie, in Cambi, Cavari, Mascione 2009, pp. 133-9;
Corretti 2012: A. Corretti, Le fortezze d’altura dell’isola d’Elba: lo stato della questione, in Il ruolo degli oppida e la difesa del territorio in Etruria: casi di studio e prospettive di ricerca, a cura di F. Cambi, Trento 2012 (Aristonothos. Scritti per il mediterraneo antico 5), pp. 347-70;
Corretti, Benvenuti 2001: A. Corretti, M. Benvenuti, The Beginning of Iron Metallurgy in Tuscany, with Special Reference to Etruria Mineraria, «MedArch», 14, 2001, pp. 127-45;
Corretti et al. 2012: A. Corretti, L. Chiarantini, G. Giuntoli, M. Benvenuti, F. Cambi, M. Firmati, C. Isola, L. Pagliantini, Un sito di lavorazione del ferro da Monte Strega (Rio nell’Elba, LI). Nuovi dati sulle attività dei “fabri pisani” all’Elba nel medioevo, in VI Congresso nazionale di archeologia medievale, L’Aquila 2012, a cura di F. Redi, A. Forgiane, Firenze 2012, pp. 650-5;
Corretti et al. c.d.s.: A. Corretti, M. Benvenuti, F. Cambi, L. Chiarantini, A. Dini, S. Ducci, M. Firmati, F. Lo Schiavo, P. Pallecchi, C. Principe, Siderurgia e bacini di approvvigionamento all’Elba in età etrusca e romana. Primi dati del progetto “Aithale”, in Ports antiques et leurs territoires: productions et commercialisation, ed. by A. Hesnard, M. Pasquinucci, c.d.s.;
202 Bibliografia
Corretti, Firmati 2011: A. Corretti, M. Firmati, Metallurgia antica e medievale all’isola d’Elba: vecchi dati e nuove acquisizioni, in Archeometallurgia: dalla conoscenza alla fruizione, Atti del Workshop, Cavallino, Lecce, 22-25 maggio 2006, a cura di C. Giardino, Bari 2011, pp. 229-41;
Corsi 2004: L. Corsi, L’Elba in età moderna: il paesaggio, l’economia, i riflessi dell’antico con gli occhi del tempo, in Archeologica Pisana. Scritti per Orlanda Pancrazzi, a cura di S. Bruni, T. Carusi, M. Massa, Pisa 2004, pp. 130-42;
Corsi, Gras 1989: L. Corsi, M. Gras, s.v. Elba (isola), in Bibliografia Topografica della Colonizzazione Greca in Italia e nelle Isole Tirreniche, VII, Pisa-Roma 1989, pp. 127-46;
Coulton 1968: J.J. Coulton, The Stoa at the Amphiaraion, Oropos, «BSA», 63, 1968, pp. 147-83;
Coulton 1976: J.J. Coulton, The Architectural Development of the Greek Stoa, Oxford 1976;
Cultraro 2010: M. Cultraro, Museo Archeologico della Provincia di Bari. Sigillo miceneo, in Ambra per Agamennone 2010, pp. 379-80;
Custer 2007: J.S. Custer, Priesthood’s Pledge, Eucharist and Tradition in the Byzantine Rite of Ordination, «Gregorianum», 88, 2, 2007, pp. 373-86;
D’Agata, Boileau, De Angelis 2012: A.L. D’Agata, M-C. Boileau, S. De Angelis, Handmade Burnished Ware from the Island of Crete: A View from the Inside, «Rivista di Scienze Preistoriche», 62, 2012, pp. 295-330;
Dallai, Ponta, Shepherd 2006: L. Dallai, E. Ponta, E.J. Shepherd, Aurelii e Valerii sulle strade d’Etruria, in Territorio e produzioni ceramiche: paesaggi, economia e società in età romana: Territory and pottery: Landscapes, Economy and Society in Roman Times, Atti del convegno internazionale, Pisa, 20-22 ottobre 2005, a cura di S. Menchelli, M. Pasquinucci, Pisa 2006, pp. 181-92;
D’Andria 1981: F. D’Andria, Scavi d’emergenza ad Otranto. Nota preliminare, «Archeologia Medievale», 6, 1, 1981, pp. 267-70;
Davis, Bennet 1999: J.L. Davis, J. Bennet, Warfare, Territorial Expansion, and Representations of the other in the Pylian Kingdom, in Polemos. Le contexte guerrier en égée à l’âge du Bronze, Actes de la 7e Rencontre égéenne internationale, Université de Liège, 14-17 avril 1998, éd. par R. Laffineur, Liège 1999 (Aegaeum 19), pp. 105-20;
Day et al. 1998: P.M. Day, D.E. Wilson, E. Kiriatzi, Pots, Labels and People: Burying Ethnicity in the Cemetery at Aghia Photia, Siteias, in Cemetery and Society in the Aegean Bronze Age, ed. by K. Branigan, Sheffield 1998, pp. 133-49;
De Ferraris 1974: A. De Ferraris (galateo), De Situ Japigiae, in Epistule
203 Bibliografia
Salentine, a cura di M. Paone, Galatina 1974, p. 119;Demakopoulou 2007: K. Demakopoulou, The Role of Midea in the Network
of Mycenaean Citadels in the Argolid, in Keimelion: Elitenbildung und Elitärer Konsum von der Mykenischen Palastzeit bis zur Homerischen Epoche, Akten des internationalen Kongresses vom 3. bis 5. Februar 2005 in Salzburg, hrsg. von E. Alram-Stern, G. Nightingale, Wien 2007, pp. 65-80;
Denaro 2007: M. Denaro, La ceramica fine da mensa, in Agrigento dal Tardo Antico al Medioevo. Campagne di scavo nell’area della necropoli paleocristiana. Anni 1986-1999, a cura di R.M. Bonacasa Carra, F. Ardizzone, Todi 2007, pp. 103-12;
De Pascalis 2004: G. De Pascalis, Una città di fondazione tra XIII e XIV secolo: il caso di Roca in Terra d’Otranto, in Le città medievali dell’Italia meridionale e insulare, Atti del convegno, Palermo, 28-29 novembre 2002, a cura di A. Casamento, E. Guidoni, Roma 2004 (Storia dell’urbanistica/Sicilia 4), pp. 304-14;
De Sanctis 1914: G. De Sanctis, Caulonia nelle fonti classiche, in Orsi 1914, coll. 685-98;
De Siena 1983: A. De Siena, Termitito, campagna di scavo 1982, in Magna Grecia e Mondo Miceneo, Atti del XXII Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto, 7-11 ottobre 1982, Taranto 1983, pp. 125-31;
De Siena 1986: A. De Siena, Termitito, in Marazzi, Tusa, Vagnetti 1986, pp. 41-54;
De Siena, Bianco 1982: A. De Siena, S. Bianco, Termitito, in Magna Grecia e Mondo Miceneo. Nuovi Documenti, a cura di L. Vagnetti, Taranto 1982, pp. 69-96;
Dickers 2001: A. Dickers, Die spätmykenischen Siegel aus weichem Stein: Untersuchungen zur spätbronzezeitlichen Glyptik auf dem griechischen Festland und in der Ägäis, Rahden 2001;
Dickinson 1976: O.T.P.K. Dickinson, Schliemann and the Shaft Graves, «G&R», 23, 1976, pp. 159-68;
Dickinson 1977: O.T.P.K. Dickinson, The Origins of Mycenaean Civilisation, Göteborg 1977;
Dietz 1998: S. Dietz, The Cyclades and the Mainland in the Shaft Grave Period - A Summary, «Proceedings of the Danish Institute at Athens», 2, 1998, pp. 9-36;
Doepner 2002: D. Doepner, Steine und Pfeiler für die Götter. Weihgeschenkgattungen in westgriechischen Stadtheiligtümern, Wiesbaden 2002;
Doumas 1977: C. Doumas, Early Bronze Age Burial Habits in the Cyclades, Göteborg 1977 (Studies in Mediterranean Archaeology 48);
204 Bibliografia
Doumas 1982: C. Doumas, The Minoan Thalassocracy and the Cyclades, «AA», 1982, pp. 5-14;
Eder 2007: B. Eder, Im Spiegel der Siegel: Die nördlichen und westlichen Regionen Griechenlands im Spannungsfeld der mykenischen Paläste, in Keimelion: Elitenbildung und Elitärer Konsum von der Mykenischen Palastzeit bis zur Homerischen Epoche, Akten des internationalen Kongresses vom 3. bis 5. Februar 2005 in Salzburg, hrsg. von E. Alram-Stern, G. Nightingale, Wien 2007, pp. 81-124;
Emporia 2005: Emporia: Aegeans in the Central and Eastern Mediterranean, Proceedings of the 10th International Aegean Conference, Athens, 14-18 April 2004, ed. by R. Laffineur, E. Greco, Liège-Austin 2005 (Aegaeum 25);
Erdas 2010: D. Erdas, Segesta. Settore Nord dell’agora (2007-08), in NotScASNP 2010, pp. 41-9;
Erdas, Giaccone 2012: D. Erdas, N. Giaccone, Segesta. Agora. Settore Est (SAS 4; 2011), in NotScASNP 2012, pp. 17-21;
Evans 1906: A.J. Evans, The Prehistoric Tombs of Knossos, London 1906;Evans 1928: A.J. Evans, The Palace of Minos at Knossos II, London 1928;Evans 1935: A.J. Evans, The Palace of Minos at Knossos IV, London 1935;Fabri 1887: A. Fabri. Relazione sulle miniere di ferro dell’Isola d’Elba, Roma
1887;Facella 2009: A. Facella, Segesta tardoantica: topografia, cronologia e
tipologia dell’insediamento, in Ampolo 2009a, pp. 589-607;Facella 2011: A. Facella, Dinamiche generali del popolamento dalla
preistoria alla tarda antichità, in Parra, Facella 2011, pp. 295-336;Facella 2013: A. Facella, Nuove acquisizioni su Segesta tardoantica, in
«ASNP», s. 5, 5/1, 2013, pp. 285-315;Facella, Giaccone 2010: A. Facella, N. Giaccone, Kaulonia. Area subito
a Sud del tempio dorico (SAS 1; 2006-08), in NotScASNP 2010, pp. 110-30;Facella, Giaccone 2012: A. Facella, N. Giaccone, Area a Sud del tempio
dorico (SAS 1 SudEst; 2009-10), in NotScASNP 2012, pp. 37-44;Facella, Minniti, Capelli c.d.s.: A. Facella, B. Minniti, C. Capelli,
Ceramiche da un contesto tardoantico presso l’agorà di Segesta (TP), «Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta», 43, c.d.s.;
Facella, Olivito 2011: A. Facella, R. Olivito, Segesta. Area della strada e della piazza triangolare (SAS 3; 2009-10), in NotScASNP 2011, pp. 9-21;
Facella, Olivito 2012: A. Facella, R. Olivito, Segesta. Agora. Area della stoa Nord (SAS 4; 2011), in NotScASNP 2012, pp. 8-11;
Fallico 1971: A.M. Fallico, Siracusa. Saggi di scavo nell’area della Villa Maria, «NSA», 1971, pp. 581-639;
Fioravanti 2002: C. Fioravanti, Note su alcuni problemi storico-topografici
205 Bibliografia
relativi al territorio di Kaulonia in età arcaica e classica, in Parra 2002b, pp. 27-57;
Firmati 2004: M. Firmati, La villa romana di Capo Castello all’Isola d’Elba: vecchie testimonianze e nuove acquisizioni per la storia del monumento, in Archeologica Pisana, Scritti per Orlanda Pancrazzi, a cura di S. Bruni, T. Caruso, M. Massa, Pisa 2004, pp. 171-83;
Firmati 2009: M. Firmati, L’Arcipelago Toscano e la romanizzazione: il contributo delle ultime ricerche, in Cambi, Cavari, Mascione 2009, pp. 187-93;
Firmati, Arrighi, Principe 2006: M. Firmati, S. Arrighi, C. Principe, L’impianto metallurgico tardo repubblicano di San Bennato all’Isola d’Elba, «Agoghé», 3, 2006, pp. 301-12;
Firmati, Paoli 2007: M. Firmati, L. Paoli, La Terra di Rio, Firenze 2007;Fisher 1988: E.A. Fisher, A Comparison of Mycenaean Pottery from Apulia
with Mycenaean Pottery from Western Greece, Ph.D. Dissertation, University of Minnesota 1988;
Flouda 2010: G. Flouda, Agency Matters: Seal Users in Pylian Administration, «OJA», 29, 2010, pp. 57-88;
Fraiegari 2008: P. Fraiegari, Le lucerne tardoantiche e altomedievali siciliane, egizie e del Vicino Oriente nel Museo Nazionale Romano, Roma 2008;
Francavilla I 2010: K. Jacobsen, S. Handberg, Excavation on Timpone della Motta, Francavilla Marittima (1992-2004) I. The Greek Pottery, Bari 2010;
Frielinghaus 2011: H. Frielinghaus, Die Helme von Olympia. Ein Beitrag zu Waffenweinhungen in Griechischen Heiligtümern, Berlin-New York 2011 (Olympische Forschungen 33);
Fulford, Peacock 1984: M.G. Fulford, D.P.S. Peacock, Excavations at Carthage: The British Mission, 1.2. The Avenue du President Habib Bourguiba, Salammbo: the Pottery and Other Ceramic Obiects from the Site, Sheffield 1984;
Furumark 1941: A. Furumark, The Mycenaean Pottery. Analysis and Classification, Stockholm 1941;
Gagliardi 2002: V. Gagliardi, Ceramica a vernice nera dal Santuario di Punta Stilo: contributi all’analisi delle produzioni, in Parra 2002b, pp. 279-318;
Gagliardi 2003: V. Gagliardi, Kaulonia. Area del grande altare a Sud del tempio (SAS 4), in NotScASNP 2003, pp. 452-6;
Gagliardi 2007a: V. Gagliardi, La ceramica arcaica fine dal santuario di Punta Stilo, in Parra 2007b, pp. 55-92;
206 Bibliografia
Gagliardi 2007b: V. Gagliardi, La ceramica a vernice nera dalla vasca cultuale a Nord-Ovest del tempio, in Parra 2007b, pp. 129-38;
Gagliardi 2007c: V. Gagliardi, Il kerameikos di Contrada Lupa: per una revisione dei dati, in Parra 2007b, pp. 493-534;
Gagliardi 2009: V. Gagliardi, Segesta tardoantica: ceramiche di importazione e circolazione di merci, in Ampolo 2009b, pp. 609-21;
Gagliardi 2011: V. gagliardi, Considerazioni sui rinvenimenti di cultura materiale dall’età greca alla tarda antichità, in Parra, Facella 2011, pp. 337-48;
Gagliardi 2012a: V. Gagliardi, Ceramica fine e anfore a Kaulonia in età arcaica: alcune note, in Convivenze etniche, scontri e contatti di cuture in Sicilia e Magna Grecia, Atti del Convegno Internazionale di Studi, Milano, 14-16 dicembre 2010, Trento 2012 (Aristonothos 7), pp. 365-91;
Gagliardi 2012b: V. Gagliardi, SAS 1 SudOvest (2009-10), in NotScASNP 2012, pp. 51-4;
Gaifman 2012: M. Gaifman, Aniconism in Greek Antiquity, Oxford 2012;Gallet de Santerre 1961: M. Gallet de Santerre, Concerning Délos
primitive et archaïque: Letter to the Editor, «AJA», 65, 1961, pp. 64-5;Gargini 2007: M. Gargini, Kaulonia: la vasca cultuale a Nord-Ovest del
tempio, in Parra 2007b, pp. 93-127;Garr 1987: W.R. Garr, A Population Estimate of Ancient Ugarit, «BASO»,
266, 1987, pp. 31-43;Gennusa 1997: I. Gennusa, I materiali lapidei nelle strutture archeologiche di
Rocca d’Entella, in Seconde Giornate Internazionali di Studi sull’Area Elima, Gibellina, 22-26 ottobre 1994, Pisa-Gibellina 1997, pp. 845-64;
Giangiulio 1989: M. Giangiulio, Ricerche su Crotone arcaica, Pisa 1989;Giardino 1995: C. Giardino, Il Mediterraneo Occidentale fra XIV e VIII
secolo a.C. Cerchie minerarie e metallurgiche. The Western Mediterranean between the 14th and the 8th Centuries B.C. Mining and Metallurgical Spheres, Oxford 1995 (BAR International Series 612);
Gillis 1995: C. Gillis, Trade in the Late Bronze Age, in Trade and Production in Premonetary Greece: Aspects of Trade, Proceedings of the Third International Workshop, Athens 1993, ed by C. Gillis, C. Risberg, B. Sjöberg, Jonsered 1995 (Studies in Mediterranean Archaeology 134), pp. 61-86;
Ginouvès 1992: R. Ginouvès, Dictionnaire méthodique de l’architecture grecque et romaine 2. éléments constructifs: supports, couvertures, aménagements intérieurs, Paris-Rome 1992;
Giuliani 1990: C.F. Giuliani, L’edilizia nell’antichità, Roma 1990;Gliozzo, Manacorda, Shepherd 2004: E. Gliozzo, D. Manacorda,
207 Bibliografia
E.J. Shepherd, I bolli Volus nell’Etruria romana: tipologia e problemi d’interpretazione, in Gualandi, Mascione 2004, pp. 191-216;
Gödecken 1988: K.B. Gödecken, A Contribution to the Early History of Miletus: The Settlement in Mycenaean Times and its Connections Overseas, in Problems in Greek Prehistory, ed. by E.B. French, K.A. Wardle, Bristol 1988, pp. 307-17;
Gorgoglione 2002: M.A. Gorgoglione, Lo Scoglio del Tonno. Problematiche precoloniali nel II millennio, in Strutture e modelli di abitati del Bronzo tardo da Torre Castelluccia a Roca Vecchia, Atti del Convegno di Studio, Pulsano (Taranto), 28-29 novembre 1996, a cura di M.A. Gorgoglione, Manduria 2002, pp. 125-40;
Granese 2006: M.T. Granese, Culto e pratiche rituali nel santuario arcaico di Francavilla Marittima (Sibari - CS), «ASAA», s. 3, 84, 2006, pp. 417-64;
Gravili 1999: G. Gravili, Il gioco, Da Apigliano a Martano. Tre anni di archeologia medioevale: 1997-1999, a cura di P. Arthur, Galatina 1999, pp. 45-7;
Graziadio 2009: G. Graziadio, Gli sviluppi della società cipriota nei secoli XIV e XIII a.C. ed i primi rapporti con il Mediterraneo centrale, in Ampolo 2009a, pp. 359-83;
Graziadio, Guglielmino 2011: G. Graziadio, R. Guglielmino, The Aegean and Cypriot Imports to Italy as Evidence for Direct and Indirect Trade in the 14th and 13th Centuries BC, in Intercultural Contacts in the Ancient Mediterranean, Proceedings of the International Conference at the Netherlands-Flemish Institute in Cairo, 25th-29th October 2008, ed. by K. Duistermaat, I. Regulski, Leuven 2011, pp. 309-27;
Gualandi, Mascione 2004: M.L. Gualandi, C. Mascione (a cura di), Materiali per Populonia 3, Firenze 2004;
Guglielmino 2003: R. Guglielmino, Il sito di Roca Vecchia. Testimonianze di contatti con l’Egeo, in L’Archeologia dell’Adriatico dalla Preistoria al Medioevo, Atti del Convegno, Ravenna, 7-9 giugno 2001, a cura di F. Lenzi, Firenze 2003, pp. 91-119;
Guglielmino 2006: R. Guglielmino, Roca Vecchia (Lecce): testimonianze di attività metallurgiche e di contatti con l’Egeo in un sito costiero del Bronzo Finale, in ΑΕΙ ΜΝΗΣΤΟΣ, Miscellanea di studi per Mauro Cristofani, a cura di B. Adembri, Firenze 2006, pp. 32-50;
Guglielmino 2008: R. Guglielmino, Alcune considerazioni sul ruolo di Roca nei rapporti tra Creta e l’Italia nel II millennio a.C., «Creta Antica», 9, 2008, pp. 27-45;
Guglielmino 2011: R. Guglielmino, Alcune riflessioni sui rapporti tra Creta
208 Bibliografia
e l’Italia nell’età del bronzo, in Kretes Minoidos, Tradizione e identità minoica tra produzione artigianale, pratiche cerimoniali e memoria del passato, Studi offerti a Vincenzo La Rosa per il suo 70° compleanno, a cura di F. Carinci, N. Cucuzza, P. Militello, O. Palio, Padova 2011, pp. 419-37;
Guglielmino et al. 2010: R. Guglielmino, G. Maggiulli, C. Pagliara, M. Rugge, Indizi di comunanza di culti e riti tra genti indigene ed egee, in Ambra per Agamennone 2010, pp. 129-32;
Guglielmino, Iacono, Rugge 2011: R. Guglielmino, F. Iacono, M. Rugge, Before the Stream: the Social and Economic Role of Exotica in the Central Mediterranean. The Case of Ivory Items from Roca, in Exotica in the Prehistoric Mediterranean, ed. by A. Vianello, Oxford 2011, pp. 172-85;
Guglielmino, Levi, Jones 2010: R. Guglielmino, R.E. Jones, S.T. Levi, Relations between Aegean and Apulia in the Late Bronze Age: the Evidence from an Archaeometric Study of the Pottery at Roca (Lecce), «Rivista di Scienze Preistoriche», 60, 2010, pp. 257-82;
Guglielmino, Pagliara 2010: R. Guglielmino, C. Pagliara, Roca, in Ambra per Agamennone 2010, pp. 236-9;
Guidoni 2008: E. Guidoni, Città grandi, ricche, sicure, sante e belle. L’apogeo urbano nell’Europa del Trecento, in La città europea del trecento: trasformazioni, monumenti, ampliamenti urbani, Atti del Convegno Internazionale, Cagliari, 9-10 dicembre 2005, a cura di M. Cadinu, E. Guidoni, Roma 2008, pp. 13-56.
Guiducci 2009: G. Guiducci, Distribuzione e commercio della ceramica di Pantelleria nel Mediterraneo, in Tusa, Zangara, La Rocca 2009, pp. 369-79;
Gull 2008: P. Gull, Lo scavo degli ambienti CXXXIV-CXL, in Roca nel Basso Medioevo 2008, pp. 383-7;
Gullini 1983: G. Gullini, Urbanistica e architettura, in Megale Hellas, a cura di G. Pugliese Carratelli, Milano 1983, pp. 207-328;
Hallager 1985: B.P. Hallager, Crete and Italy in the Late Bronze Age III Period, «AJA», 89, 1985, pp. 293-305;
Hallager, Hallager 2003: E. Hallager, B.P. Hallager, The Greek-Swedish Excavations at the Agia Aikaterini Square. Kastelli, Khania. 1970-1987 and 2001. III: The Late Minoan IIIB: 2 Settlement, Stockholm 2003;
Haskell 1997: H.W. Haskell, Mycenaeans at Knossos: Patterns in the Evidence, in La Crète mycénienne, Actes de la Table Ronde Internationale organisée par l’École française d’Athènes, 26-28 Mars 1991, éd. par J. Driessen, A. Farnoux, Paris 1997 («BCH», Supplément 30), pp. 187-93;
Higgins 1954: R.A. Higgins, Catalogue of the Terracottas in the Department of Greek and Roman Antiquities, I, London 1954;
209 Bibliografia
Hirth 1978: K.G. Hirth, Interregional Trade and the Formation of Prehistoric Gateway Communities, «American Antiquity», 43, 1978, pp. 35-45;
Holloway 1981: R.R. Holloway, Italy and the Aegean 3000-700 B.C., Louvain-Ia-Neuve 1981;
Hood 1967: S. Hood, The Home of the Heroes: The Aegean before the Greeks, London 1967;
Hood 1990: S. Hood, The Cretan Element on Thera in Late Minoan IA, in Thera and the Aegean World III, Vol. 1: Archaeology, Proceedings of the Third International Congress, Santorini, 3-9 September 1989, ed. by D.A. Hardy, C.G. Doumas, J.A. Sakellarakis, P.M. Warren, London 1990, pp. 118-23;
Hornblower 2008: S. Hornblower, A Commentary on Thucydides, III, Oxford 2008;
Howell 1992: R.J. Howell, The Middle Helladic Settlement: Pottery, in Excavations at Nichoria in Southwest Greece, II: The Bronze Age Occupation, ed. by W.A. McDonald, N.C. Wilkie, Minneapolis 1992, pp. 43-204;
Iannelli 2010: M.T. Iannelli, Monasterace - Le case sul fronte a mare. L’abitazione nei pressi della casamatta, in Lepore, Turi 2010, pp. 135-51;
Iannelli et al. 2012: M.T. Iannelli, B. Minniti, F.A. Cuteri, G. Hyeraci, Hipponion, Medma e Caulonia: nuove evidenze archeologiche a proposito della fondazione, in Alle origini della Magna Graecia. Mobilità, migrazioni, fondazioni, Atti del 50° Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto, 1-4 ottobre 2010, Taranto 2012, pp. 857-911;
Iannelli, Rizzi 1985: M.T. Iannelli, S. Rizzi, Kaulonia: indagini ed ipotesi sull’impianto urbano di età ellenistica alla luce delle più recenti campagne di scavo, «Rivista Storica Calabrese», n.s., 6, 1985, pp. 281-316;
Incoronata 2 1992: AA.VV., Ricerche archeologiche all’Incoronata di Metaponto. 2. Dal villaggio indigeno all’emporio greco. Le strutture e i materiali del saggio T, Milano 1992;
Incoronata 3 1995: AA.VV., Ricerche archeologiche all’Incoronata di Metaponto. 3. L’oikos greco del saggio S. Lo scavo e i reperti, Milano 1995;
ISPRA 2010: ISPRA, Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000, Foglio 607 Corleone, Roma 2010;
ISPRA 2011: ISPRA, Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000, Foglio 593 Castellammare del Golfo, Roma 2011;
ISPRA c.d.s.: ISPRA, Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000, Foglio 605 Paceco, c.d.s.;
Jervis 1862: W.P. Jervis, The Mineral Resources of Central Italy, London 1862;Jones 1986: R.E. Jones, Chemical Analysis of Aegean-Type Late Bronze Age
Pottery Found in Italy, in Marazzi, Tusa, Vagnetti 1986, pp. 205-14;Jones, Mee 1978: R.E. Jones, C.B. Mee, Spectrographic Analyses of Mycenaean
210 Bibliografia
Pottery from Ialysos on Rhodes: Results and Implications, «JFA», 5, 1978, pp. 461-70;
Karageorghis 1995: V. Karageorghis, Cyprus and the Western Mediterranean: Some New Evidence for Interrelations, in The Ages of Homer: A Tribute to Emily Townsend Vermeule, ed. by J.B. Carter, S.P. Morris, Austin 1995, pp. 93-8;
Kilian 1990: K. Kilian, Mycenaean Colonization: Norm and Variety, in Greek Colonists and Native Populations, Proceedings of the First Australian Congress of Classical Archaeology Held in Honour of A.D. Trendall, Sidney, 9-14 July 1985, ed. by J-P. Descoeudres, Oxford 1990, pp. 445-67;
Killebrew 1998: A.E. Killebrew, Aegean and Aegean-Style Material Culture in Canaan during the 14th-12th Centuries BC: Trade, Colonization, Diffusion, or Migration?, in The Aegean and the Orient in the Second Millennium, Proceedings of the 50th Anniversary Symposium, Cincinnati, 18-20 April 1997, ed. by E.H. Cline, D. Harris Cline, Liège-Austin 1998 (Aegaeum 18), pp. 159-69;
Kiryeleis 2011: H. Kiryeleis, Olympia. Archäologie eines Heiligtums, Darmstadt-Mainz 2011;
Knapp 1992: A.B. Knapp, Bronze Age Mediterranean Island Cultures and the Ancient Near East, «The Biblical Archaeologist», 55, 1992, pp. 112-28;
Knapp 1994: A.B. Knapp, Emergence, Development and Decline on Bronze Age Cyprus, in Development and Decline in the Mediterranean Bronze Age, ed. by C. Mathers, S, Stoddart, Sheffield 1994, pp. 271-304;
Knapp 2008: A.B. Knapp, Prehistoric and Protohistoric Cyprus: Identity, Insularity and Connectivity, Oxford 2008;
Knapp 2009: A.B. Knapp Migration, Hybridisation and Collapse: Bronze Age Cyprus and the Eastern Mediterranean, «Scienze dell’Antichità», 15, 2009, pp. 219-39;
Krzyszkowska 2005: O. Krzyszkowska, Travellers’ Tales: The Circulation of Seals in the Late Bronze Age Aegean, in Emporia 2005, pp. 767-75;
Kulja 2008: E. Kulja, La ceramica graffita, in Roca nel Basso Medioevo 2008, pp. 401-4;
Kunze 1991: E. Kunze, Beinschienen, Berlin-New York 1991 (Olympische Forschungen 21);
La dea di Sibari 2006: La dea di Sibari e il santuario ritrovato. Ceramiche di importazione, di produzione coloniale e indigenena, I,1, ed. by F. van der Wielen-van Ommeren, L. de Lachenal, «BA», 2006, vol. speciale;
La dea di Sibari 2008: La dea di Sibari e il santuario ritrovato. Ceramiche di importazione, di produzione coloniale e indigena, I,2, ed. by F. van der Wielen-van Ommeren, L. de Lachenal, «BA», 2008, vol. speciale;
de La Genière, Greco, Donnarumma 1997: J. de La Genière, G. Greco,
211 Bibliografia
R. Donnarumma, L’Héraion de Foce del Sele, découvertes récentes, «CRAI», 1997, pp. 333-50;
Lambardi 1791: S. Lambardi Memorie antiche e moderne dell’Isola d’Elba, Firenze 1791;
Lang 2009: M. Lang, Der bunte Himmel - Untersuchungen zu den Tondächern westgriechischer Typologie, Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn, Bonn 2009;
Lapadula 2008: E. Lapadula, Oggetti accessori dell’abbigliamento, di ornamento e di uso personale dal cimitero basso medievale di Roca Vecchia (LE), «Studi di Antichità», 12, 2008, pp. 151-69;
La Rosa 1996: V. La Rosa, La civiltà cretese dal MM III al Miceneo, in Atti e Memorie del Secondo Congresso Internazionale di Micenologia, Roma-Napoli, 14-20 ottobre 1991, a cura di E. De Miro, L. Godart, A. Sacconi, Roma 1996, pp. 1063-89;
Lasfargues 1985: J. Lasfargues, Architecture de terre et de bois. L’habitat privé des provinces occidentals du monde romain. Antécédentes et prolongements: Protohistoire, Moyen Age et quelques experience contemporaines, Actés du II Congrès Archéologique de Gaule Méridionale, Lyon, 2-6 novembre 1983, Paris 1985, pp. 80-128;
Lauter 1986: H. Lauter, Die Architektur des Hellenismus, Darmstadt 1986;Lauter-Bufe 1987: H. Lauter-Bufe, Die Geschichte des sikeliotisch-
korinthischen Kapitells. Der sogenannte italisch-republikanische Typus, Mainz am Rhein 1987;
Laviosa 1984: C. Laviosa, The Minoan Thalassocracy, Iasos and the Carian Coast, in Minoan Thalassocracy 1984, pp. 183-5;
Lepore, Turi 2010: L. Lepore, P. Turi (a cura di), Caulonia tra Crotone e Locri, Atti del Convegno Internazionale, Firenze, 30 maggio-1 giugno 2007, Firenze 2010;
Lippolis 2001: E. Lippolis, Culto e iconografie della coroplastica votiva. Problemi interpretativi a Taranto e nel mondo greco, «MEFRA», 113, 1, 2001, pp. 225-55;
Lippolis 2009: E. Lippolis, Rituali di guerra: i Dioscuri a Sparta e a Taranto, «ArchClass», 60, 2009, pp. 117-59;
Lippolis c.d.s.: E. Lippolis, Spazio sacro e culti civici, in Poleis e politeiai nella Magna Grecia arcaica e classica, Atti del 53° Convegno Internazionale di Studi sulla Magna Grecia, Taranto, 26-29 settembre 2013, c.d.s.
Lippolis, Parisi 2012: E. Lippolis, V. Parisi, La ricerca archeologica e le manifestazioni rituali tra metropoli e apoikiai, in Alle origini della Magna
212 Bibliografia
Graecia. Mobilità, migrazioni, fondazioni, Atti del 50° Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto 1-4 ottobre 2010, Taranto 2012, 423-70;
Locri IV 1992: Locri Epizefiri IV. Lo scavo di Marasà Sud. Il sacello tardo arcaico e la “casa dei leoni”, a cura di M. Barra Bagnasco, Firenze-Torino 1992;
Long 1961: C.R. Long, Reply to M. Gallet de Santerre, «AJA», 65, 1961, pp. 65-6;
Macdonald 1986: C. Macdonald, Problems of the Twelfth Century BC in the Dodecanese, «ABSA», 81, 1986, 125-51;
Maggiani c.d.s.: A. Maggiani, L’Elba in età ellenistica, in La Corsica e Populonia, Atti del XXVIII Convegno di Studi Etruschi e Italici, Bastia-Aléria-Piombino 2011, c.d.s.;
Malfitana et al. 2008: D. Malfitana et al., Roman Sicily Project («RSP»): Ceramics and Trade. A Multidisciplinary Approach to the Study of Material Culture Assemblages. First Overview: the Transport Amphorae Evidence, «Facta», 2, 2008, pp. 127-92;
Malfitana, Franco 2011: D. Malfitana, C. Franco, “Archeologia dell’artigianato” nella Provincia Sicilia: nuove prospettive di indagine dal “Roman Sicily Project: ceramics and trade”, in Roma y las provincias: modelo y difusión, ed. by T. Nogales, I. Rodà, Roma 2011, pp. 79-92;
Mantovani 1892: A. Mantovani, Portoferraio, «NSA», 1892, pp. 49-50;Maran 2009: J. Maran, The crisis years? Reflections on Signs of Instability
in the Last Decades of the Mycenaean Palaces, «Scienze dell’Antichità», 15, 2009, 241-62;
Marazzi 1995: M. Marazzi, Tokens e strategie di memorizzazione senza scrittura: nuove attestazioni nel Mediterraneo del II millennio a.C., «AION (ling)», 17, 1995, pp. 161-70;
Marazzi, Tusa, Vagnetti 1986: M. Marazzi, S. Tusa, L. Vagnetti (a cura di), Traffici micenei nel Mediterraneo, Atti del Convegno, Palermo, 11-12 maggio e 3-6 dicembre 1984, Taranto 1986;
Marinatos 1967: S. Marinatos, Anaskafi Thiras, «PAAH», 1967, pp. 124-50;Marinatos 1968: S. Marinatos, Excavations at Thera. First Preliminary
Report, Athens 1968;Marinatos, Hirmer 1960: S. Marinatos, M. Hirmer, Crete and Mycenae,
London 1960;Martin 1974: R. Martin, L’architecture archaïque de Thasos et l’Anatolie, in
Mansel’e armagan. Mélanges Mansel, I-III, Ankara 1974, pp. 451-65;Mascaro, Guideri, Benvenuti 1991: I. Mascaro, S. Guideri, M.
Benvenuti, Inventario del patrimonio minerario e mineralogico in Toscana. Aspetti naturalistici e storico-archeologici, Firenze 1991;
213 Bibliografia
Massaro 1993: A. massaro, Territorio, società e potere, in Storia di Lecce dai bizantini agli aragonesi, a cura di B. Vetere, Bari 1993, pp. 274-9;
Matteo 1998: S. Matteo, La ceramica postmedievale del Trappeto di Piscopio, «Quaderni del Museo della Ceramica di Cutrofiano», 3, 1998, pp. 41-78;
Matteo 2002: S. Matteo, La produzione di ceramica graffita in Cutrofiano, «Quaderni del Museo della Ceramica di Cutrofiano», 7, 2002, pp. 9-32;
Mee 1978: C. Mee, Aegean Trade and Settlement in Anatolia in the Second Millennium B.C., «AS», 28, 1978, pp. 121-56;
Mee 1982: C. Mee, Rhodes in the Bronze Age, Warminster 1982;Melas 1985: E.M. Melas, The Islands of Karpathos, Saros and Kasos in
the Neolithic and Bronze Age, Göteborg 1985 (Studies in Mediterranean Archaeology 68);
Mellini 1879: V. Mellini, Ricerche sulla prima età del ferro all’Isola d’Elba, «BPI», 5, 1879, pp. 84-90;
Mellini, Monaco 1965: V. Mellini, Memorie storiche dell’Isola d’Elba, con parte archeologica a cura di G. Monaco, Firenze 1965;
Mellink 1966: M.J. Mellink, Anatolia: Old and New Perspectives, «Proceedings of the American Philosophical Society», 110, 1966, pp. 111-29;
Menchelli 2003: S. Menchelli, Il commercio marittimo dei laterizi: alcune considerazioni per le rotte alto-tirreniche, in Atti del II Convegno Nazionale di Archeologia Subacquea, Castiglioncello 2001, a cura di A. Benini, M. Giacobelli, Bari 2003, pp. 167-74;
Menchelli et al. 2010: LRCW3. Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean. Archaeology and archaeometry. Comparison between western and eastern Mediterranean, Oxford 2010 ed. by S. Menchelli, S. Santoro, M. Pasquinucci, G. Guiducci (Bar International Series 2185);
Mertens 1993: D. Mertens, Der alte Heratempel in Paestum und die archaische Baukunst in Unteritalien, Mainz am Rhein 1993;
Mertens 1996: D. Mertens, Elementi di origine etrusco-campana nell’architettura della Magna Grecia, in Magna Grecia, Etruschi, Fenici, Atti del XXXIII Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto, 8-13 ottobre, 1993, Taranto 1996, pp. 195-219;
Mertens 2000: D. Mertens, Lo ionico nell’architettura dell’Occidente. Problemi e questioni, in Magna Grecia e Oriente mediterraneo prima dell’età ellenistica, Atti del XXXIX Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto, 1-5 ottobre 1999, Taranto 2000, pp. 519-56;
Mertens 2006: D. Mertens, Città e monumenti dei Greci d’Occidente, Roma 2006;
214 Bibliografia
Milanesi et al. 2011: C. Milanesi, J. Bigliazzi, C. Faleri, C. Caterini, M. Cresti, Microscope Observations and DNA Analysis of Wine Residues from Roman Amphorae Found in Ukraine and from Bottles of Recent Tuscan Wines, «Journal of Archaeological Science», 38, 2011, pp. 3675-80;
Milanesio Macrì 2005: M. Milanesio Macrì, Il Thesmophorion di contrada Parapezza a Locri Epizefiri, in S. Settis, M.C. Parra (a cura di), Magna Graecia. Archeologia di un sapere, Catalogo della mostra, Catanzaro, 19 giugno-31 ottobre 2005, Milano 2005, pp. 229-35;
Milanesio Macrì 2010: M. Milanesio Macrì, Forme di culto nel Thesmpphorion di c.da Parapezza, in Lepore, Turi 2010, pp. 331-50;
Militello 2004: P. Militello, Commercianti, architetti ed artigiani, Riflessioni sulla presenza micenea nell’area iblea, in Le presenze micenee nel territorio siracusano, Atti del Primo simposio siracusano di preistoria siciliana in memoria di Paolo Orsi, Siracusa, 15-16 dicembre 2003, a cura di V. La Rosa, Padova 2004, pp. 295-336;
Minniti 2007= B. Minniti, Contributo allo studio della ceramica arcaica di Kaulonia (scavi in proprietà Zaffino, Casa Gazzera, Sottopasso Contrada Lupa, Sottopasso, S.S. 106 e Proprietà Anas), in Parra 2007b, pp. 431-91;
Minoan Thalassocracy 1984: The Minoan Thalassocracy. Myth and Reality, Proceedings of the Third International Symposium at the Swedish Institute in Athens, 31 May-5 June 1982, ed. by R. Hägg, N. Marinatos, Stockholm 1984;
Monaco 1975: G. Monaco, L’Elba preistorica e romana, in Atti del I Convegno di Storia dell’Elba, «Rivista Italiana di Studi Napoleonici», 12, 1975, pp. 11-26;
Monaco, Tabanelli 1976: G. Monaco, M. Tabanelli, Guida all’Elba archeologica ed artistica dalla preistoria al 1700, Forlì 1976;
Montana et al. 2007: G. Montana, B. Fabbri, S. Santoro, S. Gualtieri, I. Iliopoulos, G. Guiducci, S. Min, Pantellerian Ware: a Comprehensive Archaeometric Review, «Archaeometry», 49, 3, 2007, pp. 455-82;
Moreschini 1990: D. Moreschini, SAS 12, in AA.VV. Entella. Relazione preliminare della campagna di scavo 1988, «ASNP», s. 3, 20, 2-3, 1990, pp. 505-12;
Moreschini 1992: D. Moreschini, SAS 12, in AA.VV. Entella. Relazione preliminare della campagna di scavo 1989, «ASNP», s. 3, 22, 4, 1992, pp. 700-4;
Moschos 2009a: I. Moschos, Evidence of Social Re-organization and Reconstruction in Late Helladic IIIC Achaea and Modes of Contacts and Exchange via the Ionian and Adriatic Sea, in Dall’Egeo all’Adriatico: organizzazioni sociali, modi di scambio e interazione in età postpalaziale (XII-XI sec. a.C.), Atti del Seminario Internazionale, Udine, 1-2 dicembre
215 Bibliografia
2006, a cura di E. Borgna, P. Cassola Guida, Roma 2009, pp. 345-414;Moschos 2009b: I. Moschos, Western Achaea During the Succeeding LH III
C Late Period - The Final Mycenaean Phase and the Submycenaean Period, in LH III C Chronology and Synchronisms III: LH III C Late and the Transition to the Early Iron Age, Proceedings of the International Workshop Held at the Austrian Academy of Sciences at Vienna, February 23rd and 24th, 2007, ed. by S. Deger-Jalkotzy, A.E. Bächle, Wien 2009, pp. 235-88;
Mountjoy 1993: P.A. Mountjoy, Mycenaean Pottery: An Introduction, Oxford 1993;
Mountjoy 1999: P.A. Mountjoy, Regional Mycenaean Decorated Pottery, Rahden 1999;
Mountjoy, Ponting 2000: P.A. Mountjoy, M.J. Ponting, The Minoan Thalassocracy Reconsidered: Provenance Studies of LH II A/LM I B Pottery from Phylakopi, Ay. Irini and Athens, «ABSA», 95, 2000, pp. 141-84;
Mylonas 1959: G.E. Mylonas, Aghios Kosmas: An Early Bronze Age Settlement and Cemetery in Attica, Princeton 1959;
Nenci 1990: G. Nenci, Iscrizioni greche, elime, latine, in AA.VV. Entella. Relazione preliminare della campagna di scavo 1988, «ASNP», s. 3, 20, 2-3, 1990, pp. 547-52;
Nepoti 1991: S. Nepoti, Ceramiche graffite dalla donazione Donini Bear, Faenza 1991;
Niemeier 1986: W-D. Niemeier, Creta, Egeo e Mediterraneo agli inizi del Bronzo Tardo, in Marazzi, Tusa, Vagnetti 1986, pp. 245-70;
Niemeier 1995: W-D. Niemeier, Aegina - First Aegean ‘State’ Outside of Crete?, in Politeia: Society and State in the Aegean Bronze Age, Proceedings of the 5th International Aegean Conference, University of Heidelberg, Archäologisches Institut, 10-13 April 1994, ed. by R. Laffineur, W-D. Niemeier, Liège-Austin 1995 (Aegaeum 12), pp. 73-80;
Niemeier 2004: W-D. Niemeier, When Minos ruled the waves: Knossian power overseas, in Knossos: Palace, City, State, Proceedings of the Conference in Herakleion organised by the British School at Athens and the 23rd Ephoreia of Prehistoric and Classical Antiquities of Herakleion, in November 2000, for the Centenary of Sir Arthur Evans’s Excavations at Knossos, ed. by G. Cadogan, E. Hatzaki, A.Vasilakis, London 2004, pp. 393-98;
Niemeier 2005: W-D. Niemeier, The Minoans and Mycenaeans in Western Asia Minor: Settlement, Emporia or Acculturation, in Emporia 2005, pp. 199-204;
Niemeier, Niemeier 1999: B. Niemeier, W-D. Niemeier, The Minoans of Miletus, in Meletemata: Studies in Aegean Archaeology Presented to Malcolm
216 Bibliografia
H. Wiener as He Enters His 65th Year, ed. by P.P. Betancourt, V. Karageorghis, R. Laffineur, W-D. Niemeier, Liège 1999, pp. 543-54;
Nihlen 1960: J. Nihlen, Fynd av ädre järntillverkning pa Elba, Portoferraio 1960, ms.;
NotScASNP 2001: AA.VV., Relazioni preliminari degli scavi a Segesta (Calatafimi-Segesta, TP; 1995-1997), Kaulonia (Monasterace, RC; 1999-2001). Sintesi delle ricerche a Roca Vecchia (Melendugno, LE), in Notizie degli scavi di Antichità comunicate dalla Scuola Normale Superiore di Pisa. Rassegna Archeologica del LSATMA, «ASNP», s. 4, 6, 2, 2001 [2005], pp. 411-555;
NotScASNP 2003: AA.VV., Relazioni preliminari degli scavi a Segesta (Calatafimi-Segesta, TP; 2002-2005) e Kaulonia (Monasterace, RC; 2001-2005), in Notizie degli scavi di Antichità comunicate dalla Scuola Normale Superiore di Pisa. Rassegna Archeologica del LSATMA, «ASNP», s. 4, 8, 1-2, 2003 [2006], pp. 387-473;
NotScASNP 2004: AA.VV., Relazioni preliminari degli scavi a Segesta (Calatafimi-Segesta, TP; 2002-2003, 2005-2006), Entella (Contessa Entellina, PA; 2000-2001, 2003; 2005), Calatamauro (Contessa Entellina, PA; 2006), Roca Vecchia (Melendugno, LE; 2002-2006), in Notizie degli Scavi di Antichità comunicate dalla Scuola Normale Superiore di Pisa. Rassegna Archeologica del LSATMA, «ASNP», s. 4, 9, 2, 2004 [2008], pp. 399-600;
NotScASNP 2010: AA.VV., Relazioni preliminari degli scavi a Segesta (Calatafimi-Segesta, TP; 2007-08), Entella (Contessa Entellina, PA; 2007-08), Kaulonia (Monasterace, RC; 2006-08). Ricerche recenti a Roca (Melendugno, LE), in Notizie degli Scavi di Antichità comunicate dalla Scuola Normale Superiore di Pisa. Rassegna Archeologica del LSATMA, «ASNP», s. 5, 2/2, 2010, Supplemento;
NotScASNP 2011: AA.VV., Relazioni preliminari degli scavi a Segesta (Calatafimi-Segesta, TP; 2009-10) e Entella (Contessa Entellina, PA; 2007-08), in Notizie degli Scavi di Antichità comunicate dalla Scuola Normale Superiore di Pisa. Rassegna Archeologica del LSA, «ASNP», s. 5, 3/2, 2011, Supplemento;
NotScASNP 2012: AA.VV., Relazioni preliminari degli scavi a Segesta (Calatafimi-Segesta, TP; 2011), Kaulonia (Monasterace, RC; 2009-10). Ricerche recenti a Roca (Melendugno, LE). Saggi di controllo a Entella (Contessa Entellina, PA; 2008), in Notizie degli Scavi di Antichità comunicate dalla Scuola Normale Superiore di Pisa. Rassegna Archeologica del LSA, «ASNP», s. 5, 4/2, 2011, Supplemento;
Olivito, Serra 2012: R. Olivito, A. Serra, Kaulonia. Area del grande altare
217 Bibliografia
a Sud del tempio dorico (SAS 4; 2009-10), in NotScASNP 2012, pp. 45-50;Olivito, Sorrentino 2010: R. Olivito, C. Sorrentino, Kaulonia. Area del
grande altare a Sud del tempio (SAS 4; 2006-08), in NotScASNP 2010, pp. 131-43;
Orsi 1913: P. Orsi, Rosarno (Medma). Esplorazione di un grande deposito di terrecotte ieratiche, «NSA», 1913, suppl., pp. 55-144;
Orsi 1914: P. Orsi, Caulonia. Campagne archeologiche del 1912, 1913, 1915, «MonAL», 23, 1914 (2a puntata 1916), coll. 685-947;
Østby 1990-91: E. Østby, Templi di Pallantion e dell’Arcadia: confronti e sviluppi, «ASAA, 68-9, n.s. 51-2, 1990-91, pp. 285-390;
Pagliara et al. 2007: C. Pagliara, G. Maggiulli, T. Scarano, C. Pino, R. Guglielmino, J. De Grossi Mazzorin, M. Rugge, G. Fiorentino, M. Primavera, L. Calcagnile, M. D’Elia, G. Quarta, La sequenza cronostratigrafica delle fasi di occupazione dell’insediamento protostorico di Roca (Melendugno, Lecce). Relazione preliminare della campagna di scavo 2005 - Saggio X, «Rivista di Scienze Preistoriche», 57, 2007, pp. 311-62;
Pagliara et al. 2008: C. Pagliara, R. Guglielmino, L. Coluccia, I. Malorgio, M. Merico, D. Palmisano, M. Rugge, F. Minnonne, Roca Vecchia (Melendugno, Lecce), SAS IX: relazione stratigrafica preliminare sui livelli di occupazione protostorici (campagne di scavo 2005-2006), «Rivista di Scienze Preistoriche», 58, 2008, pp. 239-80;
Pancrazzi 1995: O. Pancrazzi, Frequentatori di “ville di delizie”: una visita di Ovidio all’Elba, in Miscellanea in memoria di Giuliano Cremonesi, Pisa 1995, pp. 311-4;
Pancrazzi, Ducci, 1996: O. Pancrazzi, S. Ducci (a cura di), Ville e giardini nell’Elba romana, Firenze 1996;
Panella et al. 2010: C. Panella, L. Saguì, M. Casalini, F. Coletti, Contesti tardoantichi di Roma: una rilettura alla luce di nuovi dati, in Menchelli et al. 2010, pp. 57-78;
Paroli, Vendittelli 2004: L. Paroli, L. Vendittelli (a cura di), Roma dall’antichità al Medioevo II. Contesti tardoantichi e altomedievali, Milano 2004;
Parra 2002a: M.C. Parra, Con Paolo Orsi, ed altri, nel santuario di Punta Stilo. Campagne di scavo 1999-2001, in Parra 2002b, pp. 219-48;
Parra 2002b: M.C. Parra (a cura di), Kaulonía, Caulonia, Stilida (e oltre). Contributi storici, archeologici e topografici. I, Pisa 2002 («ASNP», s. 4, Quaderno 11-12, 2001);
Parra 2003: M.C. Parra, Ad Entella, tra un granaio ed un oikos: nuovi dati sulla thysia di fondazione, in Quarte Giornate Internazionali di Studi
218 Bibliografia
sull’Area Elima, Atti del Convegno, Erice, 1-4 dicembre 2000, Pisa 2003, pp. 1029-48;
Parra 2005: M.C. Parra, Riflessioni e novità intorno al santuario di Punta Stilo, in M.L. Nava, M. Osanna, Lo spazio del rito. Santuari e culti in Italia meridionale tra indigeni e greci, Atti delle giornate di studio, Matera, 28-29 giugno 2002, Bari 2005, pp. 27-42;
Parra 2006: M.C. Parra, Note di architettura ellenistica a Segesta, intorno all’agora, in Sicilia ellenistica, consuetudo italica. Alle origini dell’architettura ellenistica d’Occidente, Atti dell’Incontro di studio, Spoleto, 5-7 Novembre 2004, a cura di M. Osanna, M. Torelli, Roma 2006, pp. 107-22;
Parra 2007a: M.C. Parra, Ancora dal santuario di Punta Stilo, con Paolo Orsi e altri. Dopo le campagne di scavo 2001-2005, in Parra 2007b, pp. 3-42;
Parra 2007b: M.C. Parra (a cura di), Kaulonía, Caulonia, Stilida (e oltre). Contributi storici, archeologici e topografici. II, Pisa 2007 («ASNP», s. 4, Quaderno 17-18, 2004);
Parra 2010a: M.C. Parra, Dei, devoti, offerte: nuovi temi di ricerca nel “tessuto” del santuario di Punta Stilo, in Lepore, Turi 2010, pp. 45-65;
Parra 2010b: M.C. Parra, Marmi kauloniati, un contributo, in Scolpire il marmo. Importazioni, artisti itineranti, scuole artistiche nel Mediterraneo antico, Atti del Convegno di Studio, Pisa, 9-11 novembre 2009, a cura di G. Adornato, Pisa 2010, pp. 143-58;
Parra 2011a: M.C. Parra, Dal santuario di Afrodite a Punta Stilo, guardando alla città e al territorio, dopo oltre un decennio di ricerche, in Parra, Facella 2011, pp. 3-44;
Parra 2011b: M.C. Parra, Riti, offerte, officine nel santuario di Afrodite a Kaulonia, in Miti di guerra, riti di pace, Atti del Convegno, Torgiano-Perugia, 4-6 maggio 2009, a cura di C. Masseria, D. Labate, Roma 2011, pp. 23-38;
Parra 2012a: M.C. Parra, Scavi nel santuario di Punta Stilo (2009-10): risultati e prospettive di ricerca, in NotScASNP 2012, pp. 29-36;
Parra 2012b: M.C. Parra, Tra approdo preurbano e stanziamento brettio: due note su Kaulonia, in Convivenze etniche, scontri e contatti di culture in Sicilia e Magna Grecia, Atti del Convegno Internazionale di Studi, Milano, 14-16 dicembre 2010, Trento 2012 (Aristonothos 7), pp. 347-63;
Parra c.d.s.: M.C. Parra, Il santuario del Capo Cocinto: “nuovo” osservatorio occidentale di presenze multiculturali, in Sanctuaries and the Power of Consumption. Networking and the Formation of élites in the Arcaic Western Mediterranean World, International Conference, Innsbruck, 20-23 March 2012, c.d.s.;
219 Bibliografia
Parra et al. 2001: M.C. Parra et al., Kaulonia. Santuario di Punta Stilo (1999-2001), in NotScASNP 2001, pp. 511-33;
Parra et al. 2003 = Kaulonia, in NotScASNP 2003, pp. 431-67;Parra et al. 2010 = Kaulonia, in NotScASNP 2010, pp. 101-43;Parra et al. 2012 = Kaulonia, in NotScASNP 2012, pp. 29-61;Parra, Facella 2011: M.C. Parra, A. Facella (a cura di), Kaulonía,
Caulonia, Stilida (e oltre), III. Indagini topografiche nel territorio, Pisa 2011;Parra, Facella 2012: M.C. Parra, A. Facella, L’area centrale di Entella tra
spazio civico e spazio cultuale, in Ampolo 2012a, pp. 239-43;Patitucci Uggeri 1977: S. Patitucci Uggeri, La ceramica medievale alla
luce degli scavi di Mesagne, Mesagne 1977;Pedley, House, Waugh 1976: H.M. Pedley, M.R. House, B. Waugh, The
Geology of Malta and Gozo, «Proceedings of the Geologists Association», 87, 3, 1976, pp. 325-41;
Pensabene 1993: P. Pensabene, Elementi architettonici di Alessandria e di altri siti egiziani, Roma 1993;
Peroni, Trucco, Vagnetti 1986: R. Peroni, F. Trucco, L. Vagnetti 1986, Broglio di Trebisacce (Cosenza), in Marazzi, Tusa, Vagnetti 1986, pp. 55-69;
Pistolesi 2006: C. Pistolesi, La miniera di Baratti. Lo sfruttamento delle scorie etrusche dal 1915 al 1939, Pisa 2006;
Pistolesi 2011: C. Pistolesi, L’età delle miniere. L’industria mineraria italiana dall’Unità alla seconda guerra mondiale, Venturina 2011;
Pistolesi 2013: C. Pistolesi, Ferro autarchico. L’uso delle antiche scorie ferrifere di Baratti, Poggio Butelli e dell’isola d’Elba nella siderurgia del Novecento, Venturina 2013;
Platon 1981: N, Platon, La civilization égéenne, Paris 1981;Platon, Karantzali 2003: L. Platon, E. Karantzali, New Evidence for the
History of the Minoan Presence on Karpathos, «ABSA», 98, 2003, pp. 189-202;
Principe et al. 2011: C. Principe, S. Arrighi, J. Malfatti, D. Brocchini, Datazione archeomagnetica di alcune fornaci dell’Isola d’Elba, in Isola d’Elba - Atlante delle fornaci, a cura di F. Ramacogi, Viterbo 2011, pp. 83-97;
Pulak 2005: C. Pulak, Who Were the Mycenaeans aboard the Uluburun Ship?, in Emporia 2005, pp. 295-310;
Quercia 2006: A. Quercia, Rapporti e contatti tra isole del Mediterraneo centrale: la Pantellerian Ware a Malta, in L’Africa Romana. Mobilità delle persone e dei popoli, dinamiche migratorie, emigrazioni ed immigrazioni nelle province occidentali dell’Impero romano, Atti del XVI convegno di studio, Rabat, 15-19 dicembre 2004, a cura di A. Akerraz, P. Ruggeri, A. Siraj, C. Vismara, Roma 2006, pp. 1597-613;
220 Bibliografia
Re 1994: L. Re, Ceramica di fabbrica corrente di tradizione mesoelladica e ceramica corrente micenea, in Vivara: centro commerciale mediterraneo dell’età del bronzo, II: Le tracce dei contatti con il mondo egeo, scavi 1976-1982, a cura di M. Marazzi, S. Tusa, Roma 1994, pp. 221-94;
Rehak, Younger 1998: P. Rehak, J.G. Younger, Review of Aegean Prehistory VII: Neopalatial, Final Palatial, and Postpalatial Crete, «AJA», 102, 1998, pp. 91-173;
Reinholdt 1992: C. Reinholdt, Ein minoischer Steinhammer in Ägina, «AKB», 22, 1992, pp. 57-62;
Renfrew et al. 1985: C. Renfrew, P.A. Mountjoy, E. French, J.G. Younger, J.F. Cherry, A. Daykin, J. Moody, L. Morgan, N. Bradford, C. MacFarlane, R. Torrence, C. Gamble, T. Whitelaw, The Archaeology of Cult. The Sanctuary at Phylakopi, London 1985;
Ricci 1998: M. Ricci, La ceramica comune dal contesto di VII secolo della Crypta Balbi, in Saguì 1998, pp. 351-82;
Rizzo 1990: M.A. Rizzo, Le anfore da Trasporto e il commercio etrusco arcaico, Roma 1990;
Rizzo, Danile, Zambito c.d.s.: M.S. Rizzo, L. Danile, L. Zambito, L’insediamento rurale nel territorio di Agrigento: nuovi dati da prospezioni e scavi, in L’islamisation de la Méditerranée centrale, Actes du colloque, Palerme, 8-10 novembre 2012, éd. par F. Ardizzone, A. Nef, c.d.s.;
Rizzo et al. c.d.s.: M.S Rizzo, L. Zambito, F. Giannici, R. Giarrusso, A. Mulone, Anfore di tipo siciliano dal territorio di Agrigento, in LRCW4. Fourth International Conference on Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry. The Mediterranean: a Market without Frontiers, Thessaloniki, 7-10 April 2011, c.d.s.;
Rizzo, Zambito 2010: M.S. Rizzo, L. Zambito, Ceramiche comuni ed anfore dal villaggio tardoantico di Cignana (Naro-Agrigento, Sicilia, Italia), in Menchelli et al. 2010, pp. 293-300;
Roca nel Basso Medioevo 2008 = Roca nel Basso Medioevo. Strutture abitative e cultura materiale di un centro urbano dell’Adriatico meridionale (scavi 2005), a cura di P. Gull, «Archeologia Medievale», 35, 2008;
Rosolani, Ferrari 2001: R. Rosolani, M. Ferrari (a cura di), Elba. Territorio e civiltà di un’isola, Genova 2001;
Rumscheid 1994: F. Rumscheid, Untersuchungen zur kleinasiatischen Bauornamentik des Hellenismus, I. Text, II. Katalog, Mainz 1994;
Sabbadini 1919-20: R. Sabbadini, I nomi locali dell’Elba, «RIL», 52-3, 1919-20, pp. 97-120, pp. 835-58;
Sacconi 1991: A. Sacconi, I sistemi grafici del mondo egeo tra la fine del II e
221 Bibliografia
l’inizio del I millennio a.C., in La Transizione dal Miceneo all’Alto Arcaismo. Dal palazzo alla città, Atti del Convegno Internazionale, Roma, 14-19 marzo 1988, a cura di D. Musti, A. Sacconi, L. Rocchetti, M. Rocchi, E. Scafa, L. Sportiello, M.E. Giannotta, Roma 1991, pp. 43-52;
Saguì 1998: L. Saguì (a cura di), Ceramica in Italia: VI-VII secolo, Atti del Convegno in onore di J.W. Hayes, Roma, 11-13 maggio 1995, Firenze 1998;
Sakellarakis 1996: Y. Sakellarakis, Minoan Religious Influence in the Aegean: The Case of Kythera, «ABSA», 91, 1996, pp. 81-99;
Sami 2010: D. Sami, From Theodosius to Constans II: Church, Settlement and Economy in Late Roman and Byzantine Sicily (AD 378-668), PhD Thesis, Leicester 2010;
Sammartino 2009: F. Sammartino, Il sito epigravettiano di Villa Padula-Le Sughere (Livorno), «Quaderni del Museo di Storia naturale di Livorno», 22, 2009, pp. 43-55;
Santoro 2007: S. Santoro, Le ceramiche da cucina prodotte in Italia ed esportate nel Mediterraneo: un primo panorama archeometrico ed archeologico sulla base di una banca dati, in LRCW2. Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry, ed. by M. Bonifay, J-C. Tréglia, Oxford 2007 (BAR International Series 1662), pp. 365-77;
Scarano 2012: T. Scarano, Roca I. Le fortificazioni della media età del Bronzo. Le strutture, i contesti, i materiali, Foggia 2012;
Schaeffer 1936: C.F.A. Schaeffer, Missions en Chypre 1932-1935, Paris 1936;
Scheweingruber 1950: F.H. Scheweingruber, Anatomie of European Woods. An Atlas for the Identification of European Trees, shrubs and dwarf ahrubs, Stuttgart 1950;
Schiering 1975: W. Schiering, Die Minoisch-Mykenische Siedlung in Milet vor dem Bau der Grossen Mauer, «Istambuler Mitteilungen», 25, 1975, pp. 9-16;
Scibona, Tigano 2009: G. Scibona, G. Tigano (a cura di), Alaisa-Halaesa. Scavi e ricerche (1970-2004), Messina 2009;
Semeraro 1997: G. Semeraro, ἐν νηυσὶ. Ceramica greca e società nel Salento arcaico, Lecce-Bari 1997;
Shepherd 2004: E. J. Shepherd, Valerii in Etruria, in E. Gliozzo, D. Manacorda, E. J. Shepherd, I bolli Volus nell’Etruria romana: tipologia e problemi d’interpretazione, in Gualandi, Mascione 2004, pp. 204-16;
Sherratt, Sherratt 1991: A. Sherratt, S. Sherratt, From Luxuries to Commodities: The Nature of Mediterranean Bronze Age Trading Systems, in
222 Bibliografia
Bronze Age Trade in the Mediterranean, ed. by N.H.Gale, Göteborg 1991 (Studies in Mediterranean Archaeology 90), pp. 351-86;
Sherratt, Sherratt 1998: A. Sherratt, S. Sherratt, Small Worlds: Interaction and Identity in the Ancient Mediterranean, in The Aegean and the Orient in the Second Millennium, Proceedings of the 50th Anniversary Symposium, Cincinnati, 18-20 April 1997, ed. by E.H. Cline, D. Harris Cline, Liège-Austin 1998 (Aegaeum 18), pp. 329-43;
Shoe 1936: L.T. Shoe, Profiles of Greek Mouldings, Cambridge 1936;Shoe 1952: L.T. Shoe, Profiles of Western Greek Mouldings, Roma 1952;Siena, Troiano, Verrocchio 1998: E. Siena, D. Troiano, V. Verrocchio,
Ceramiche dalla Val Pescara, in Saguì 1998, pp. 665-704;Simonin 1858: L. L. Simonin, De l’exploitation des mines et de la métallurgie
en Toscane pendant l’antiquité et le moyen age, «Annales des Mines», s. 5, 14, 1858, pp. 557-615;
Smith 1987: T. Smith, Mycenaean Trade and Interaction in the West Central Mediterranean, 1600-1000 B.C., Oxford 1987 (BAR International Series 371);
Sorrentino 2013: C. Sorrentino, Appendice. Note preliminari sul materiale osteologico animale proveniente da un piccolo ambiente tardoantico (US 30263, 30261, 30259), «ASNP», s. 5, 5/1, 2013, pp. 316-8;
Sourisseau 2006: J.C. Sourisseau, Les amphores commerciales de la nécropole de Rifriscolaro à Camarine, in Camarina, 2600 anni dopo la fondazione: nuovi studi sulla città e sul territorio, a cura di P. Pelagatti, G. Di Stefano, L. de Lachenal, Roma 2006, pp. 129-47;
Sparkes, Talcott 1970: B.A. Sparkes, L. Talcott, The Athenian Agora XII. Black and Plain Pottery of the 6th, 5th and 4th Centuries B.C., Princeton (N.J.) 1970;
Staffa 1998: A.R. Staffa, Le produzioni ceramiche in Abruzzo tra fine V e VII secolo, in Saguì 1998, pp. 437-80;
Stager 1991: L.E. Stager, Ashkelon Discovered: From Canaanites and Philistines to Romans and Moslems, Washington 1991;
Sternini 2000: M. Sternini, La villa romana di Cottanello, Bari 2000;Stillwell 1964-65: R. Stillwell, The Theater of Morgantina, «Kokalos», 10-
11, 1964-65, pp. 579-88;Stubbings 1972: F.H. Stubbings, Prehistoric Greece, London 1972;Taccola 2012: E. Taccola, Ricostruzioni 3D per l’agora di Segesta, in Ampolo
2012a, pp. 287-9;Tagliente 2002: P. Tagliente, Lecce: il rinvenimento di scarti di produzione
di vasi da mensa della fine del Quattrocento: primi dati, «Archeologia Medievale», 29, 2002, pp. 542-55;
223 Bibliografia
Tagliente 2003a: P. Tagliente, La ceramica dell’età di transizione nella Puglia meridionale: la fine delle “RMR” e l’inizio delle produzioni graffite, in Atti del III Congresso della Società degli Archeologi Medievisti Italiani, a cura di P. Peduto, R. Fiorillo, Firenze 2003, pp. 153-8;
Tagliente 2003b: P. Tagliente, Lecce. Castello Carlo V. Le ceramiche invetriate, Tomo I, Relazione depositata presso il Dipartimento dei Beni delle Arti e della Storia, Lecce 2003;
Tagliente 2007: P. Tagliente, Ceramica rivestita da mensa, in Lecce, ex convento del Carmine. Un’associazione di reperti ceramici, vitrei, faunistici e botanici in un silo del XIV secolo, a cura di P. Gull, «Archeologia Medievale», 34, 2007, pp. 151-6;
Tagliente 2009a: P. Tagliente, Il castello aragonese di Taranto. Rinvenimenti ceramici: la dipinta a bande, Studi e ricerche 2004-2006, in Atti del II Seminario, Taranto, 6-7 giugno 2007, Taranto 2009, pp. 273-82;
Tagliente 2009b: P. Tagliente, Il castello aragonese di Taranto. Rinvenimenti ceramici: la graffita policroma. Studi e ricerche 2004-2006, in Atti del II Seminario, Taranto, 6-7 giugno 2007, Taranto 2009, pp. 283-313;
Tanelli 1989: G. Tanelli, I depositi metalliferi dell’Etruria e le attività estrattive degli Etruschi, in Atti del Secondo Congresso internazionale Etrusco, Firenze 1985, Roma 1989, pp. 1409-17;
Tartaron 1996: T.F. Tartaron, Bronze Age Settlement and Subsistence in Southwestern Epirus, Greece. Ph.D. Dissertation, Boston University 1996;
Tartaron 2005: T.F. Tartaron, Glykys Limin and the Discontinuous Mycenaean Periphery, in Emporia 2005, pp. 153-62;
Taylour 1958: W. Taylour, Mycenaean Pottery in Italy and Adjacent Areas, Cambridge 1958;
Tomasello 1972: E. Tomasello, Monasterace Marina (Reggio Calabria). Scavi presso il tempio dorico di Punta Stilo, «NSA», 1972, pp. 561-643;
Tréziny 1989: H. Tréziny, Kaulonia I. Sondage sur la fortification nord (1982-1985), Naples 1989 (Cahiers du Centre Jean Bérard 13);
Trump 1980: D.H. Trump, The Prehistory of the Mediterranean, London 1980;Tusa, Zangara, La Rocca 2009: S. Tusa, S. Zangara, R. La Rocca (a cura
di), Il relitto tardo-antico di Scauri a Pantelleria, Palermo 2009;Vaggioli 1997: M.A. Vaggioli, Ricerche archeologiche e topografiche
sull’agora di Segesta, in Seconde giornate internazionali di studi sull’area elima, Atti del Convegno, Gibellina, 22-26 ottobre 1994, Pisa-Gibellina 1997, pp. 1329-54;
Vagnetti 1982: L. Vagnetti, Quindici anni di studi e ricerche sulle relazioni tra il mondo egeo e l’Italia protostorica, in Magna Grecia e Mondo Miceneo. Nuovi Documenti, a cura di L. Vagnetti, Taranto 1982, pp. 7-36;
224 Bibliografia
Vagnetti 1991: L. Vagnetti, Le ceramiche egeo-micenee, Appendice III, in L. Bernabò Brea, M. Cavalier, Meligunìs Lipára VI. Filicudi, insediamenti dell’età del bronzo, Palermo 1991, pp. 263-305;
Vagnetti 1994: L. Vagnetti, Ceramiche protostoriche del Mediterraneo: il contributo dell’archeometria alla definizione dei circuiti di scambio tra l’Egeo e l’Italia, in 1st European Workshop on Archaeological Ceramics, a cura di F. Burragato, O. Grubessi, L. Lazzarini, Roma 1994, pp. 43-53;
Vagnetti 2000: L. Vagnetti, I Micenei fra Mediterraneo orientale ed occidentale dopo la fine dei palazzi, in Magna Grecia e Oriente Mediterraneo prima dell’età ellenistica, Atti del XXXIX Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto, 1-5 ottobre 1999, Taranto 2000, pp. 63-89;
Vagnetti 2000-01: L. Vagnetti, Preliminary Remarks on Mycenaean Pictorial Pottery from the Central Mediterranean, «OAth», 25-6, 2000-01, pp. 107-15;
Vagnetti 2001a: L. Vagnetti, L’artigianato dell’avorio e del corno, in Torre Mordillo 1987-1990. Le relazioni egee di una comunità protostorica della Sibaritide, a cura di F. Trucco, L. Vagnetti, Roma 2001, pp. 341-5;
Vagnetti 2001b: L. Vagnetti, Le ceramiche egeo-micenee, in Torre Mordillo 1987-1990. Le relazioni egee di una comunità protostorica della Sibaritide, a cura di F. Trucco, L. Vagnetti, Roma 2001, pp. 299-327;
Vagnetti et al. 2009: L. Vagnetti, R.E. Jones, S.T. Levi, M. Bettelli, L. Alberti, Ceramiche egee e di tipo egeo lungo i versanti adriatico e ionico della penisola italiana: situazioni a confronto, in Dall’Egeo all’Adriatico. Organizzazioni sociali, modi di scambio e interazione in età postpalaziale (XII-XI sec. a.C.), Atti del Seminario Internazionale, Udine, 1-2 dicembre 2006, a cura di E. Borgna, P. Cassola Guida, Roma 2009, pp. 171-83;
Vagnetti, Jones 1988: L. Vagnetti, R.E. Jones, Towards the Identification of Local Mycenaean Pottery in Italy, in Problems in Greek Prehistory, ed. by E.B. French, K.A. Wardle, Bristol 1988, pp. 335-48;
Vallet, Villard 1966: G. Vallet, F. Villard, Mégara Hyblaea 4. Le temple du IVe siècle, Paris 1966;
Ventris, Chadwick 1956: M. Ventris, J. Chadwick, Documents in Mycenaean Greek, Cambridge 1956;
Vianello 2005: A. Vianello, Late Bronze Age Mycenaean and Italic Products in the West Mediterranean: a Social and Economic Analysis, Oxford 2005 (BAR International Series 1939);
Villa 1988: A. Villa, I capitelli di Solunto, Roma 1988;Wachsmann 1998: S. Wachsmann, Seagoing Ships and Seamanship in the
Bronze Age Levant, College Station, Texas A&M University Press 1998;Watrous 1993: L.V. Watrous, Cretan Relations with the Aegean in the Late
Bronze Age, in Wace and Blegen: Pottery as Evidence for Trade in the Aegean
225 Bibliografia
Bronze Age 1939-1989, Proceedings of the International Conference held at the American School of Classical Studies, Athens, Dec. 2-3, 1989, ed. by C. Zerner, P. Zerner, J. Winter, Amsterdam 1993, pp. 81-90;
Watrous 1994: L.V. Watrous, Review of Aegean Prehistory III: Crete from Earliest Prehistory through the Protopalatial Period, «AJA», 98, 1994, pp. 695-753;
Watrous 2001: L.V. Watrous, Crete from Earliest Prehistory through the Protopalatial Period, in Aegean Prehistory: A Review, ed. by T. Cullen, Boston 2001, pp. 157-215;
van Wijngaarden 2002: G.J. van Wijngaarden, Use and Appreciation of Mycenaean Pottery in the Levant, Cyprus and Italy (ca. 1600-1200 BC), Amsterdam 2002;
Williams 2009: J. Williams, The Environmental Effects of Populonia’s Metallurgical Industry: Current Evidence and Future Directions, «Etruscan Studies», 12, 2009, pp. 129-48;
Yakar 1976: J. Yakar, Hittite Involvement in Western Anatolia, «AS», 26, 1976, pp. 117-28;
Yasur-Landau 2003: A. Yasur-Landau, Why Can’t We Find the Origin of the Philistines? In Search of the Source of a Peripheral Aegean Culture, in The Periphery of the Mycenaean World, Proceedings of the 2nd International Interdisciplinary Colloquium, Lamia, 26–30 September 1999, ed. by N. Kyparissi-Apostolika, M. Papakonstantinou, Athens 2003, pp. 587-98;
Yasur-Landau 2010: A. Yasur-Landau, The Philistines and Aegean Migration at the End of the Late Bronze Age, Cambridge 2010;
Younger 1973: J.G. Younger, Towards the Chronology of Aegean Glyptic in the Late Bronze Age, Ph.D. University of Cincinnati 1973;
Younger 1981: J.G. Younger, The Island Sanctuaries Group: Date and Significance, in Studien zur minoischen und helladischen Glyptik, Beiträge zum 2. marburger Siegel-Symposium, 26.-30. September 1978, hrsg. von W-D. Niemeier, Berlin 1981, pp. 263-72;
Younger 1987: J.G. Younger, The End of Mycenaean Art, in Forschungen zur Aegaeischen Vorgeschichte das Ende der mykenischen Welt, Akten des internationalen Kolloquium, 7-8 Juli 1984 in Köln, hrsg. von T. Eberhard, Köln 1987, pp. 63-72;
Younger 2010: J.G. Younger, Mycenaean Seals and Sealings, in The bronze Age Aegean (ca. 3000-1000 BC), ed. by E.H. Cline, Oxford 2010, pp. 329-39;
Zecchini 1978: M. Zecchini, Gli Etruschi all’Isola d’Elba, Lucca 1978;Zecchini 2001: M. Zecchini, L’isola d’Elba: le origini, Lucca 2001;Zehnaker 2004: H. Zehnaker, Pline l’Ancien, Histoire Naturelle, livre III.
Texte établi, traduit et commenté par H. Zehnaker, Paris 2004.
226 Bibliografia
289 Autori vari
Isola d’Elba. San Giovanni. 117. Foto del golfo di Portoferraio da Google Earth(R). Il cerchio indica l’area di scavo,
l’asterisco la villa delle Grotte.118. Foto zenitale dell’area oggetto di indagine. In basso al centro la Villa Gasparri con la
Chiesa di San Marco, in alto a dx. i saggi 1 e 2 aperti nel 2012; le frecce indicano il limite dell’escavazione per il recupero delle scorie ferrose avvenuto nel 1938.
290 Autori vari
Isola d’Elba. San Giovanni. 119. Planimetria dell’area di scavo 2012.120. Veduta generale del saggio 1.
291 Autori vari
Isola d’Elba. San Giovanni. 121. Muri con zoccolo in
muratura dal saggio 1.122. Particolare della parete in
opus craticium in situ.
292 Autori vari
Isola D’Elba. San Giovanni. 123-4. Due dei dolia defossa in corso di scavo.125. Veduta generale del saggio 2.
293 Autori vari
Isola D’Elba. San Giovanni. 126. Particolare del bollo in planta pedis
su dolium in corso di scavo e disegno ricostruttivo del testo integrale.
127. Bollo in cartiglio rettangolare HE su tegola.