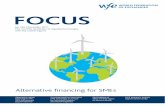Il focus group 6
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Il focus group 6
1
Cos’è il Focus Group?• Tecnica di osservazione che si applica su piccoli gruppi, animati da un conduttore (moderatore) che sollecita la discussione di un argomento specifico. Detto anche discussione focalizzata, gruppo di discussione.
• Moderatore coadiuvato da un osservatore che prende nota dell’interazione non verbale
• Gruppo artificiale di 6-10 persone, costituito ad hoc dal ricercatore
• Condizioni di interazione che consentono l’influenza reciproca dei partecipanti
2
A cosa serve il FG?• Rilevazione atteggiamenti, credenze, rappresentazioni, valori dei partecipanti alla discussione
• Il perché degli atteggiamenti, delle rappresentazioni, dei valori sostenuti da ciascuno dei componenti del gruppo;
• I processi di costruzione del consenso: gli «etnometodi» impiegati per identificare somiglianze e differenze di posizione, per esprimere la propria differenza (attribuzione di «noi»/«voi» «noi»/«loro»)
• Attenzione al cosa e al come dei discorsi sollecitati
3
Cosa NON è un FG• Non è un’intervista di gruppo;• Non è una pratica per l’osservazione di una conversazione naturale;
• Non è una procedura per la costruzione di consenso (come il Delphy, o la Nominal Group Technique).
• Nel FG il moderatore porge delle domande al gruppo e prende nota dell’interazione (linguistica e non) tra le persone che lo compongono.
• Queste caratteristiche pongono il FG in una posizione intermedia tra l’intervista discorsiva e l’osservazione partecipante.
4
Ambiti e possibilità di applicazione
• Ricerca sociale (cognitiva)• Marketing• Ricerca valutativa• Temi delimitati da:
– considerazioni etiche: nel FG non è possibile garantire il pieno anonimato dei partecipanti;
– grado di familiarità fra i partecipanti (es. colleghi di lavoro che dovranno frequentarsi anche dopo il focus group)
5
Forma “canonica” del FG• La forma canonica del focus group si basa sulla
costituzione di gruppi omogenei, composti da persone che riconoscono vicendevolmente le esperienze avute come affini al tema in discussione, e che dunque posseggono elementi per discuterne; gruppi, inoltre, costituiti da persone reciprocamente estranee, guidate da un moderatore, anch’esso estraneo, che conduce, modera o facilita la discussione ( modalità di conduzione).
• Omogeneità:– Accresce la possibilità di approfondimento del tema in discussione
– Contrae la gamma delle opinioni espresse e rilevate• Estraneità
– Facilita l’espressione delle opinioni dei partecipanti
– Offre maggiori garanzie di anonimato• Quando la reciproca estraneità non è possibile
– Evitare relazioni di dominio / subordinazione– Evitare relazioni di profonda amicizia o di intensa ostilità
6
Modalità di conduzioneIn ragione del grado di direttività imposto alla discussione dal moderatore si distinguono varie modalità di conduzione
Discussione auto/gestita
Discussione gestita dal ricercatore /moderatore
- direttività +
Autogestito: il ricercatore dà solo l’input iniziale e poi osserva
• debole focalizzazione del tema;• adeguato quando prevalgono finalità esplorative;• (parziale) sostituto dell’analisi delle
conversazioni naturali;• vulnerabile alle dinamiche di gruppo.Gestito dal ricercatore: dà tempi e modi di
discussione su ciascun tema• maggior focalizzazione del tema;• discussione «irreggimentata»;• minor vulnerabilità alle dinamica di gruppo
7
Impiego del FG
FG come
tecnica singola
tecnica associata ad altre
in posizione ancillare
in disegni multimetodo
Come tecnica di servizio (in posizione ancillare):•inchiesta campionaria: elaborazione questionario;
approfondimento dei risultati;•intervista discorsiva: elaborazione traccia;
approfondimento dei temi emersi con le interviste;•osservazione partecipante: costruzione di un quadro
d’insieme del contesto in studio, backtalk.
8
Disegno della ricerca• Progettazione dello studio:
– Individuazione del tema e delle domande cognitive per le quali la discussione dovrà suggerire una risposta;
– Individuazione sul piano teorico degli interlocutori appropriati (tipi di persone);
– Individuazione della sequenza delle sollecitazioni alla discussione;
– Scelta fra FG singolo e disegno con discussioni ripetute
– Definizione del disegno dello studio: trasversale o longitudinale (con stessi partecipanti o con partecipanti diversi)
9
Formazione dei gruppi• Individuazione, entro la categoria di interlocutori
individuata, di eventuali sottopopolazioni rilevanti;• Eventuale ricorso al mix-and-match design (creazione di
gruppi comprendenti mescolanza di tipi diversi di persone e confronto con i gruppi completamente omogenei)
• Composizione dei gruppi: omogeneità e reciproca estraneità. Possibile deroga dalla forma canonica ma attenzione a:– presenza di marcate differenze nelle capacità di verbalizzazione;
– presenza di relazioni di dominio e subordinazione;– presenta di amicizie o inimicizie particolarmente strette
• Numerosità del gruppo: il gruppo deve essere grande quanto basta per consentire la presenza di una gamma ampia di opinioni da mettere a confronto e, al contempo, sufficientemente piccolo da consentire a ciascuno dei presenti di esprimere la propria opinione 6-10 persone
10
Persone nel gruppo• Caratteristiche attese nei partecipanti:
– elevata qualità/quantità di informazioni sul tema in studio;
– adeguata motivazione al coinvolgimento in una discussione;
– disponibilità ad esprimere le proprie opinioni in un gruppo
• Individuazione della procedura empirica che consentirà il reclutamento dei partecipanti: selezione casuale da lista di nominativi con caratteristiche adeguate
selezione casuale da intervista telefonica di screening selezione a palla di neve (snow ball sample) selezione tramite testimoni privilegiati selezione in loco: formazione dei gruppi a partire da persone che convergono in un luogo per una ragione specifica (utenti di un servizio, visitatori di un museo, partecipanti a una conferenza ecc.) soluzione con vari rischi!
selezione tramite annunci: ultima spiaggia!
11
Reclutamento e partecipazione• Difficoltà a incrociare agende e disponibilità a partecipare = bassi tassi di partecipazione effettiva!
• Ricorso a incentivi e loro forma dipende dalla popolazione in studio! In genere sconsigliati incentivi in denaro, meglio in natura…
• Convocazione dei partecipanti: sovradimensionamento per bilanciare le defezioni: +2 persone (da coinvolgere ugualmente nella discussione)
12
Piano di campionamento e numero di gruppi
Es.: ricerca su pazienti psichiatrici e loro rappresentazioni della malattia A: 3 FG di sole
donne, oppure 3 FG di soli uomini B: 6 FG, 3 sole donne + 3 soli uomini C: 9 FG: 6 con i pazienti, di cui 3 di sole donne più 3 di soli uomini, più 3 FG di familiari che convivono con i pazientiD: 12 FG: 6 con i pazienti, (3U+3D), + 6 con familiari, di cui 3 di familiari che convivono con i pazienti, 3 di familiari che non convivono con i pazienti
Numero di gruppi: criterio della saturazione teorica
13
Grado di strutturazioneDefinito in ragione della domanda di ricerca e del profilo del gruppo:
• Forma autogestita appropriata quando l’intento è esplorativo o l’interesse prevalente è l’interazione del gruppo
• Forma moderata appropriata quando la domanda di ricerca è sufficientemente specificata e quando il confronto fra gruppi è cruciale
• Possibilità di combinazione entro il medesimo studio: prima auto-gestito (il gruppo definisce temi e aspetti specifici di discussione rilevanti) poi FG moderato
14
Traccia di discussione• Nei FG moderati con direttività variabile dal ricercatore la traccia è l’itinerario lungo il quale il gruppo dovrà procedere la discussione del tema in studio. 2 possibilità di articolare la traccia:
• Scaletta dei temi: – consente una discussione più fluida;– ma può creare difficoltà nella comparazione dei risultati fra gruppi;
– preferibile se il moderatore è uno soltanto per tutti i gruppi ed è sufficientemente esperto.
• Lista di domande/ stimoli:– discussione meno fluida;– maggior facilità nella comparazione fra gruppi;– preferibile in presenza di diversi moderatori non tutti egualmente esperti o caratterizzati da stili di conduzione differenti.
• Non più di 10-12 domande/stimoli
15
Tipi di stimoli• Domande rispettare consigli di «buona tecnica» come
per inchiesta campionaria e intervista discorsiva: semplicità di contenuto e sintattica, brevità, non ambiguità, precisione (tempi, luoghi ecc.)
• Immagini o grafici da commentare• Frasi da completare• Narrazioni (es.: storie di Marradi) da commentare• Costruire mappe cognitive (rappresentazioni delle
proprie conoscenze/concetti intorno a un argomento)• Privilegiare la discussione di esperienze concrete vs.
questioni astratte;• Far precedere la discussione da una breve
presentazione del tema;• Le prime domande devono consentire ai partecipanti di
intervenire facilmente;• Rivolgere i quesiti e gli stimoli a un soggetto
collettivo, voi o noi;• Progettare se necessario un momento di debriefing
16
Es. di stimoli: grafici
21,831,1
3644,9
0102030405060708090
m oltom eno delgiusto(7,4% )
un po'm eno delgiusto(33,9% )
il giusto(55,5% )
più delgiusto(3,2% )
% lavoro dom
estico marito (risp. marito)
5565,6
71,3 75,2
0102030405060708090
m eno delgiusto(3,7% )
il giusto(57,4% )
un po' piùdel giusto(26,7% )
m olto piùdel giusto(12,1% )
% lavo
ro dom
estico mog
lie (risp. mog
lie)
il m arito pensa di fare…la m oglie pensa di fare…
17
Es. di stimoli: una storiaModeratore: “Ascoltiamo la storia di Monica e Paolo. Loro devono prendere una decisione: aiutiamoli a scegliere, facciamo da consiglieri”
La storia:Monica e Paolo svolgono lavori differenti, ma che possiamo ritenere uguali sia come impegno di ore sia come stipendio. In più, hanno già un figlio. A un certo punto della loro storia, arriva un’opportunità di carriera per Monica: se accetta vedrà aumentare il proprio stipendio e il proprio prestigio sul lavoro, avrà un avanzamento in tutti i sensi. Ma la nuova mansione la porterà a frequenti trasferte, e dunque a passare almeno una notte fuori casa ogni tanto nel corso del mese. Naturalmente, tutto questo complicherebbe un po’ la situazione della famiglia, da diversi punti di vista.Monica deve dare una risposta ai capi, e dunque ne parla con Paolo.
Domande:Quali elementi, secondo voi, i due prendono in considerazione per formulare una decisione? E quale decisione prendono alla fine?Quali punti mettono nero su bianco, a tavolino, per decidere? Quali pro e contro sia del SI sia del NO di Monica?
18
Alla fine• La traccia deve prevedere uno più momenti di sintesi della discussione, utile per orientarsi per i partecipanti, per rilanciare la discussione, per controllare che non siano sfuggiti elementi importanti
• I partecipanti al FG, prima di andarsene, dovrebbero compilare un brevissimo questionario con alcune informazioni socio-demografiche base (età, titolo di studio, professione) e il nome con cui sono intervenuti nel corso della discussione (per legare identità partecipanti alle info del questionario)
19
Moderatore e osservatore nel FG
• Moderatore: – deve essere percepito dai partecipanti come una persona grado di comprendere e accettare la loro esperienza;
– deve avere un’adeguata conoscenza del tema in discussione
– capacità di ascolto, autocontrollo (comunicazione verbale e non)
– facilita / modera/ conduce la discussione;– esercita un controllo dolce, non intrusivo sull’interazione;
– segue la traccia e improvvisa • Osservatore:
– Capacità di osservazione– Coadiuva il moderatore nella conduzione del FG (evitando di metterne in forse l’autorevolezza);
– Prende nota interazione non verbale;– Gestisce l’apparato di audio/video registrazione;– Annota il nome e le prime battute di ciascun partecipante per facilitare la loro identificazione.
20
Setting del FG• Luogo neutro: non deve trasmettere ai partecipanti l’idea che alcuni discorsi siano più appropriati di altri;
• Facilmente raggiungibile dai partecipanti;• Deve consentire una registrazione audio delle conversazioni di buona qualità;
• Deve consentire una disposizione dei partecipanti che consenta ad ognuno di vedere tutti gli altri
• Durata discussione <2 ore, da rendere nota in anticipo ai partecipanti!
• Registrazione audio (sì) o video (valutare attentamente pro e contro) Trascrizione letterale e integrazione con note dell’osservatore.
21
Analisi della documentazione empirica
Lettura metodica del corpus testuale
Articolazione di una cornice teorica in cui inscrivere le opinioni espresse dai singoli e dai gruppi e le loro modalità di espressione.
• Estensione degli strumenti sviluppati per l’intervista discorsiva
• Integrazione con gli strumenti specifici dell’analisi della conversazione, dell’analisi dei materiali etnografici
22
Analisi della documentazione empirica
• Di che cosa e in che modo discute ciascun gruppo; • Chi sostiene le diverse opinioni (genere, età,
ruolo, status ecc.);• Gamma delle opinioni espresse;• Congruenze tra gruppi (group-to-group validation)• Tipo ideale come strumento di classificazione dei
gruppi e dei partecipanti• Nella comunicazione dei risultati attenzione a;• Ricostruzione dell’itinerario metodologico (disegno
della ricerca) e dei maggiori risultati dello studio;
• Combinazione di argomentazioni teoriche e citazioni;• Multivocalità;• Presenza di un resoconto sulle condizioni alle quali
l’osservatore ha fatto esperienza del proprio oggetto;
• Se possibile, corredare i risultati con la trascrizione integrale delle discussioni analizzate (a parte!)