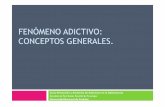Il fenomeno degli Orti Urbani come politica di sostenibilità green e di sensibilizzazione al...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of Il fenomeno degli Orti Urbani come politica di sostenibilità green e di sensibilizzazione al...
Università degli Studidi Udine
Dipartimento diScienze Economichee Statistiche
Unione CristianaImprenditori Dirigenti
Gruppo Friuli Venezia GiuliaSezione di Udine
Associazione Eticaed Economia di Udine
Universitatis UtinensisSchola de Negotiis Gerendis
Corso di Aggiornamento in:
“Etica ed Economia.“Per un’economia intelligente, inclusiva e sostenibile”
Tesina Finale
Il fenomeno degli Orti Urbani comepolitica di sostenibilita green e di
sensibilizzazione al consumoalimentare etico.
Referente dell’Area:Ambiente e Sostenibilita nell’Etica dell’EconomiaProf. Francesco Marangon
Aggiornando:Marco Ardengo
Anno Accademico 2012 – 2013
Indice
1 L’analisi della realta attraverso una considerazione critica della teoriaeconomica 11.1 Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.2 La teoria della crescita e dello sviluppo in un’ottica attuale. . . . . . . . 11.3 L’economia dello sviluppo in un’ottica di sostenibilita. . . . . . . . . . . 21.4 I Rendimenti Marginali Decrescenti come rappresentazione della situazio-
ne reale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.5 E possibile una via d’uscita? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 Paesaggio, urban agriculture e orti urbani. . . una politica di greensustainability per la citta. 72.1 Una nuova configurazione di paesaggio urbano . . . . . . . . . . . . . . . 72.2 Ridefinire il territorio cittadino: il caso PRGC di Udine. . . . . . . . . . 82.3 La risposta dell’agricoltura urbana alle esigenze della comunita . . . . . 9
2.3.1 Gli orti urbani udinesi: il progetto “L’Orto e la Luna” . . . . . . 102.3.2 L’iniziativa oggi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3 L’agricoltura urbana come strumento di sensibilizzazione al consumoalimentare responsabile ed etico 133.1 L’evoluzione dei consumi alimentari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133.2 Consumo responsabile e consumo etico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143.3 Considerazioni finali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Allegati 17
Bibliografia 19
Sitografia 22
iii
Capitolo 1
L’analisi della realta attraversouna considerazione critica dellateoria economica
1.1 Introduzione
Nell’ultimo secolo, caratterizzato da un’economia che possiamo senza dubbio definirecapitalistica, abbiamo assistito ad una serie di cambiamenti che hanno mutato signifi-catamene la struttura delle societa che ne sono state attraversate1 e, al contempo, hapermesso un processo di crescita esponenziale dei meccanismi socioeconomici.
Dalle ricerche condotte fino ad oggi, riusciamo a capire come l’utilizzo delle risorsea disposizione e caratterizzato da un andamento senza mezze misure tanto che per ilPianeta, pero, lo stile di vita americano o anche europeo, ad oggi, e semplicementeimproponibile. Considerando l’indicatore dell’impronta ecologica, si evidenzia comeoggigiorno l’umanita utilizza le risorse e i servizi di 1,3 Terre2 ogni anno, ovvero chela Terra ha bisogno di un anno e quattro mesi per rigenerare quello che usiamo in unanno3. Vista cosı la situazione e davvero critica, in quanto mancano una vera e propriaconsapevolezza, l’autocritica e il senso di responsabilita nei confronti dell’ambiente (inprimo luogo), ma anche di chi e cosa ci circonda; oggi l’obiettivo piu urgente sembraquello dell’accumulo di denaro e il raggiungimento dell’agio, quando invece sarebbenecessario un ritorno a quella semplicita volontaria che si allontana dai beni materiali,dal denaro e dall’avidita, al fine di vivere piu profondamente e pienamente, limitando laricchezza esteriore per una maggiore ricchezza interiore4.
1.2 La teoria della crescita e dello sviluppo in un’otticaattuale.
Negli ultimi decenni abbiamo assistito ad un proliferarsi di dibattiti e decisioni il cuiunico scopo era la crescita economica dei Paesi, ovvero un incremento a medio-lungo
1Bonaiuti M. (2013), La grande transazione. Dal declino alla societa della decrescita, BollatiBoringhieri, Torino.
2Bologna G., Worldwatch Institute, Yunus M. (2010), State of the World 2010: trasformare lacultura del consumo. Rapporto sul progresso verso una societa sostenibile, Edizioni Ambiente, Milano.
3Fonte: http://www.footprintnetwork.org/it/index.php/GFN/page/world_footprint/, visita-to il 20/06/2013.
4Ibidem
1
2 L’analisi della realta attraverso una considerazione critica della teoria economica
termine delle principali variabili macroeconomiche che permettesse un miglioramentodella qualita della vita, anche sulla base delle affermazioni teoriche che “di piu e meglio”.
Riflettendoci bene pero, siamo sicuri che la via della crescita economica sia la sola eunica strada possibile che il nostro Paese possa intraprendere? Oppure, considerando icosti sociali e ambientali associati al consumismo, sarebbe opportuno dirigere maggiorienergie verso pratiche che favoriscano il ripristino del benessere del Pianeta5?
Se andassimo a rivedere l’approccio neoclassico della crescita, meglio conosciutocome modello di Solow, e lampante notare come il modello si concentri esclusivamentesulla crescita di tipo endogeno, in funzione dei meccanismi interni al sistema economico,senza tener conto dei fattori esogeni (popolazione, scambio internazionale, contributodelle risorse naturali e dell’energia, ecc); pertanto nel lungo periodo si tenderebbe araggiungere sempre una situazione di stato stazionario stabile, anziche di crescita.
Oggigiorno il concetto di crescita sembra essere stato un po’ sopravalutato, assistendoad una vera e propria accumulazione di capitale, una concorrenza a dir poco spietata,crescita senza limiti, disuguaglianze, saccheggio sfrenato della natura6, il cui scopo equello di sfruttare, valorizzare, ricavare profitto dalle risorse naturali e umane. Purtroppoil concetto di sviluppo non puo essere considerato universalizzabile in modo generalizzatoperche dobbiamo tenere in considerazione che i prodotti che la terra offre sono risorsescarse, pertanto il tentativo di avvicinarsi allo stile di vita americano, renderebbeesplosivo e di conseguenza impossibile7 il processo di crescita. In questo momentonotiamo come il consumismo produce uno stato di insoddisfazione generalizzata chedefinisce la societa della crescita come il contrario di una societa dell’abbondanza8; e adifferenza di quanto viene affermato attraverso i modelli, il processo economico realenon e puramente meccanico e reversibile come si vuol far credere.
1.3 L’economia dello sviluppo in un’ottica di sostenibilita.
Considerando quanto affermato da Solow che, nel lungo periodo, l’economia di unPaese tende verso un punto di steady state, ci rendiamo quindi conto che non possiamoconsiderare solo ed esclusivamente il fenomeno della crescita.
Parlando ancora di sviluppo, sarebbe necessario includere in questo termine unavera e propria serie di variabili sociali non legate solo ed esclusivamente al reddito, ilcui dibattito sulla coerenza del termine crescita e sviluppo ha preso forma solamentenel momento in cui ci si e resi conto del forte divario tra Nord e Sud del mondo.
Nel tempo sono state formulate diverse teorie sul tema, ma quello che ci preme esporrein questo lavoro si rifa alla percezione del concetto di sviluppo umano e sostenibile, dueteorie eterodosse che non si focalizzano solo ed esclusivamente sulla ricchezza.
La pietra miliare per lo sviluppo sostenibile e stata posta nel rapporto della commissio-ne Brundtland, formulato in occasione dell’United Nations Conference on Environmentand Development svoltosi a Rio de Janeiro nel 1992, nel quale sono state elaboratestrategie e misure adatte ad arrestare e invertire gli effetti del processo di degradoambientale ormai evidenti9. Economisti eterodossi hanno considerato il concetto disviluppo sostenibile come una specie di “scappatoia dalla trappola logica della crescita”,
5Bologna G., Worldwatch Institute, Yunus M. (2010), State of the World 2010: trasformare lacultura del consumo. Rapporto sul progresso verso una societa sostenibile, Edizioni Ambiente, Milano.
6Latouche S. (2005), Cfr. Come sopravvivere allo sviluppo, Bollati Boringhieri, Torino, p. 27.7Ibidem8Cfr. Latouche S. in Bonaiuti M. (2013), La grande transizione. Dal declino alla societa della
decrescita, Bollati Boringhieri, Torino, pp. 27-28.9Mosello Tinacci M. (2008), Politica dell’ambiente – analisi, azioni, progetti. Il Mulino, Bologna.
1.3 L’economia dello sviluppo in un’ottica di sostenibilita. 3
perche da un lato costituisce l’obiettivo primario della politica economica e il fondamentodelle metodologie di valutazione delle performance dei sistemi socio-economici, dall’altroe il principale argomento di critica e di confutazione del modello dominante dal puntodi vista ambientalistico10.
All’interno del rapporto viene data anche una definizione di sviluppo sostenibile,ovvero uno sviluppo che soddisfi i bisogno del presente senza compromettere la capacitadelle generazioni future di soddisfare i propri.
Fermandoci a riflettere un attimo sul concetto in questione, ci rendiamo conto cometale scaturisca dall’esigenza di frenare un modello di sviluppo che avanza ad un ritmotroppo veloce e legato all’aspetto consumistico delle risorse naturali; pertanto sononecessarie scelte e decisioni congrue ai bisogni presenti e futuri, che permettano un usoottimale delle risorse ambientali, ma che contemporaneamente diano modo alla biosferadi assorbire gli effetti inquinanti delle attivita umane (carrying capacity); in altre parole,l’ambiente dovrebbe essere protetto per i benefici materiali dell’umanita, e non per ragionistrettamente legate alla morale e all’etica, basate solo ed esclusivamente sull’utilitarismoe sulla felicita personale. Per avere un termine di paragone e comprendere la criticita dellasituazione, nella figura 1.1 viene presentato il grafico che compara i livelli dell’improntaecologica con il livello di biocapacita11 dell’Italia dal 1961 al 2009.
Ecological Footprint
Biocapacity
Figura 1.1: Impronta Ecologica della domanda di risorse a persona e livello di biocapacita.
Diversi economisti hanno criticato pesantemente il concetto di sviluppo sostenibilee durevole, poiche se guardiamo al modello di sviluppo finora seguito da tutti i Paesi,notiamo come questo sia fondamentalmente non durevole. Una crescita omogenea,meccanica e quantitativa, per essere sostenibile, deve essere caratterizzata da unacrescita vigorosa e al tempo stesso socialmente e ambientalmente sostenibile.
Oggi quello di cui abbiamo bisogno e una nuova era di crescita vigorosa ma al tempostesso socialmente e ambientalmente sostenibile, in modo da costruire una vera e propriaalternativa allo sviluppo12.
10ibidem11Con il termine biocapacita o capacita biologica si intende la capacita degli ecosistemi di produrre
materia biologica utile (usata dal sistema economico) e di assorbire rifiuti generati dall’uomo, usando lepratiche agricole dominanti e la tecnologia prevalente. Quindi cio che e considerato utile puo variare dianno in anno. La biocapacita di un’area e espresso in ettari globali (hag) e si calcola moltiplicandol’area fisica per il fattore di rendimento e per il relativo fattore di equivalenza.
12In termini puramente economici si deve pensare ad un sistema che miri a stabilizzare il consumonel futuro ma al tempo stesso a massimizzare l’utilita u(ct) nel corso del tempo, scontata a un tasso di
4 L’analisi della realta attraverso una considerazione critica della teoria economica
Questo implica che l’utilita marginale aumenti nel tempo e che il consumo ne risultifrenato. Questo non impedisce alle risorse non rinnovabili di diminuire e pertanto lapreoccupazione per il mantenimento degli stock di risorse naturali al di sopra di uncerto livello potrebbe frenare ulteriormente i consumi, fino a rendere positiva l’utilitamarginale di un consumo pari a zero. L’ipotesi in questione di non-ossessione delconsumo rappresenta una delle piu importanti condizioni di comportamento dei soggettieconomici per realizzare la sostenibilita, intesa come mantenimento nel futuro dellecondizioni di soddisfacimento dei bisogni13. L’economista francese Serge Latouche nellasua opera “Come sopravvivere allo sviluppo” afferma in modo fermo e deciso come sia“arrivato il momento di smascherare l’ipocrisia dello sviluppismo”; pertanto e inutilecercarne uno migliore, perche in teoria quello che abbiamo va gia bene. Un altro sviluppoe nonsenso14.
1.4 I Rendimenti Marginali Decrescenti come rappresen-tazione della situazione reale.
Dagli anni Settanta ad oggi la ricerca economica ha messo in luce come le societacapitalistiche avanzate siano entrate in una fase di rendimenti decrescenti (DecliningMarginal Returns – DMR).
Con questo termine si afferma che a mano a mano che le strutture che compongonouna societa aumentano nella loro complessita, i benefici di successivi incrementi dicomplessita, oltre una certa soglia, si riducono.
Dal nostro punto di vista il principio in esame e sicuramente legato all’idea di“controproduttivita”, presentata da Ivan Illich gia negli anni Settanta. Questo principioprende forma dalle trasformazioni che hanno segnato il passaggio dal sistema fordista aquello dell’ “accumulazione flessibile”, permettendo di comprendere meglio le trasforma-zioni che hanno caratterizzato il mondo del lavoro, il welfare e la dinamica del debitopubblico negli ultimi decenni15.
Si nota quindi che i rendimenti marginali decrescenti aumentano a mano a manoche i fenomeni di complessita crescono. La maggiore complessita significa maggioridimensioni, maggiori abilita tecniche, un numero superiore di stratificazioni gerarchiche,maggiore differenziazione e specializzazione dei ruoli e, infine, maggiore produzione euso di informazione.
La tesi alla base del modello ci dice come i sistemi, nonostante la loro spinta all’evolu-zione verso gradi maggiori di complessita, sono al tempo stesso avversi, poiche una mag-giore complessita implica un ulteriore costo di materia, energia e informazione; pertantose le soluzioni che comportano costi minimi (in termini di materia/energia/informazione)verranno intraprese per prime, allora a mano a mano che verranno ad affermarsi formeorganizzative piu complesse, i costi tenderanno necessariamente ad aumentare (e diconseguenza i rendimenti a diminuire)16. Lo stesso discorso vale anche nei processiproduttivi sociali – agricoltura, energia e risorse minerarie, servizi educativi, ricercae sviluppo, sanita – dove, nelle fasi iniziali d’introduzione sul mercato, un prodottoinnovativo si sviluppera a tassi crescenti, ma al raggiungimento della fase di “ma-
attualizzazione i. Matematicamente il concetto puo essere formulato nel seguente modo:∑∞
t=0u(ct)(1+i)t
13Cfr. Tinacci Mosello M. (2008), Politica dell’ambiente: analisi, azioni, progetti, Il Mulino, Bologna,pp. 76-77.
14Cfr. Latouche S. (2005), Come sopravvivere allo sviluppo, Bollati Boringhieri, Torino, pp. 73.15Cfr. Bonaiuti M. (2013), La grande transazione, Bollati Boringhieri, Torino, pp. 101-102.16Ibidem
1.5 E possibile una via d’uscita? 5
turita”, continuera a espandersi a tassi decrescenti, sino a raggiungere il punto chepreludera il suo abbandono o la sua sostituzione con un nuovo prodotto che abbia nuovecaratteristiche17.
Stando a quanto finora esposto, l’ipotesi dei DMR puo essere analizzata prendendoin esame anche gli indici di benessere sociale.
Il PIL, inteso come indice di misurazione del benessere sociale, ci fornisce solouna rappresentazione meramente monetaria di quanto prodotto all’interno del Paesenell’arco di un anno. Ai fini che ci poniamo in questo lavoro, e utile tenere presenteanche quell’insieme di indici che hanno lo scopo di studiare in modo piu preciso ilvero benessere sociale di una popolazione (Indice di Benessere Economico Sostenibile,l’Indice di Progresso Genuino, l’Indice del Benessere Netto Sostenibile o ancora l’Indicedi Benessere Equo Sostenibile).
Dalla valutazione congiunta di questi indicatori, si nota in modo chiaro e lampantecome dagli anni Settanta l’ipotesi, secondo cui le economie avanzate sarebbero entratein un sentiero di DMR, non solamente e plausibile, ma sembrerebbe essere confermatadalle evidenze empiriche, che purtroppo non e possibile cogliere attraverso l’analisiesclusiva del PIL.
1.5 E possibile una via d’uscita?
Gli scenari attuali ci permettono di fare una valutazione critica e riflessiva riguardo i limiticoncreti relativi allo sviluppo e alla crescita. E quindi necessaria una modificazione delleabitudini consolidate – da dove si abita a cosa si mangia – e in molti casi semplificare ominimizzare. Sappiamo tutti che i cambiamenti che dovranno essere attuati non sarannomai benaccetti, poiche i modelli attuali sono comodi e percepiti come “naturali”18
e pertanto si dovra andare incontro ad un cambiamento sistemico e non solamentecongiunturale. Una sorta di doposviluppo, che ricerca i modi di realizzazione collettivanei quali non viene privilegiato un benessere materiale distruttivo dell’ambiente e deilegami sociali, bensı una ricostruzione e un ritrovo delle nuove culture.
Facciamo bene attenzione che quello che si vuole affermare in questa sede non e tantoun ritorno al passato o la riduzione del benessere, quanto una vera e propria rinunciaall’immaginario economico che “di piu” e uguale a meglio. Il bene e la felicita si possonorealizzare anche a minor prezzo e la scoperta della vera ricchezza nel dispiegamentodelle relazioni sociali conviviali, all’interno di un mondo sano, puo avvenire con serenitapraticando la frugalita, la sobrieta e anche una certa austerita nel consumo materiale;in altre parole questo significa mettere in discussione il dominio dell’economia sulla vita,nella teoria e nella pratica, ma soprattutto nelle nostre teste19.
Da alcune recenti ricerche e emerso che le societa piu eque presentano minori episodidi violenza, una salute migliore, livelli piu alti di alfabetizzazione, tassi d’incarcerazioneinferiori, meno obesita e livelli piu bassi di gravidanze in adolescenza; tutti straordinarivantaggi che deriverebbero dalla coltivazione di questo valore20.
17Cfr. Bonaiuti M. (2013), La grande transizione. Dal declino alla societa della decrescita, BollatiBoringhieri, Torino, pp. 115.
18Bologna G., Worldwatch Institute, Yunus M. (2010), State of the World 2010: trasformare lacultura del consumo. Rapporto sul progresso verso una societa sostenibile, Edizioni Ambiente, Milano.
19Cfr. Latouche S. (2005), Come sopravvivere allo sviluppo, Bollati Boringhieri, Torino, pp. 74-79.20Cfr. Bologna G., Worldwatch Institute, Yunus M. (2010), State of the World 2010: trasformare la
cultura del consumo. Rapporto sul progresso verso una societa sostenibile, Edizioni Ambiente, Milano, p.68.
6 L’analisi della realta attraverso una considerazione critica della teoria economica
Da quanto appena affermato, risulta chiaro come una rivisitazione dei valori oggipresenti nella nostra societa permetterebbe di vivere nel modo corretto, anche se lavisione personale puo variare nei diversi sistemi culturali; pertanto tre semplici obiettividovrebbero essere universalmente condivisi:
1. il consumo che mette a repentaglio il benessere deve essere attivamente scoraggiato– tabagismo, prodotti usa e getta, abitazioni gigantesche, cibo spazzatura, ecc.;
2. sostituire il consumo privato dei beni con quello pubblico, con il consumo diservizi e, laddove possibile, persino con consumi minimi o nulli – orti comunitari,produzione di cibo in orti comuni, spostamento con mezzi pubblici anziche in auto,maggiore tempo trascorso nei parchi, ecc.;
3. progettare beni che rimangono necessari affinche abbiano una lunga durata edovrebbero essere “dalla culla alla culla”, ossia prodotti che eliminano i rifiuti,utilizzano risorse rinnovabili e completamente riciclabili alla fine della loro vitautile21.
La transazione verso una cultura della sostenibilita dipendera molto da potenti retidi pionieri culturali che inizieranno, sosterranno e porteranno avanti questo nuovo esempre piu necessario modello.
Ovviamente siamo tutti consapevoli che per una modificazione della societa nonbasteranno pochi anni; nel frattempo noi ci proviamo presentando, nei prossimi capitoli,l’implementazione del fenomeno dell’agricoltura all’interno di un quadro urbano, ilquale permette alla popolazione locale un vero e proprio recupero delle zone dismes-se, della convivialita e di un consumo piu limitato quantitativamente e piu esigentequalitativamente di prodotti agricoli.
21Ibidem
Capitolo 2
Paesaggio, urban agriculture eorti urbani. . . una politica digreen sustainability per la citta.
2.1 Una nuova configurazione di paesaggio urbano
Il quadro urbanistico che caratterizzava la maggior parte dei paesi del Nord Est italianopresentava una sorta di continuum rurale-urbano, dove le citta beneficiavano, dal puntodi vista ecologico e non solo, dell’influenza della campagna circostante contando quindisul patrimonio di verde, produttivo e ornamentale, che arricchiva il tessuto urbano. Sedal secondo dopoguerra le aree periurbane sono state trasformate e caratterizzate dauna forte dipendenza alle infrastrutture e agli insediamenti industriali, oggigiorno lecomplesse relazioni tra campagna e citta stanno suscitando un crescente interesse nelmondo istituzionale e scientifico1, assistendo ad una vera riscoperta e (ri)valorizzazionedel paesaggio agricolo periurbano.
Abbiamo assistito ad una crescente spoliazione dei valori propri degli ambientirurali, i quali hanno esportato modelli e immagini metropolitani, determinando neltempo un’ibridazione della campagna, definendo i paesaggi periurbani della campagnaurbanizzata2. Lo sprawl urbano non solo ha comportato una deformazione della cittastessa, ma ha anche assoggettato lo spazio rurale a continue e diffuse pressioni, generandoun paesaggio la cui qualita e diminuita, la diversita e venuta meno e la perdita di identitae diventata una costante3.
Ora, sulla base degli obiettivi individuati per la sostenibilita, nonche sulle proposteper la tutela e la valorizzazione dei servizi degli ecosistemi4, avanzate dagli Stati Generalidella Green Economy5, ci si rende conto come l’idea che il paesaggio rurale possa essere
1Bajo N., Di Noi A., Reti ecologiche e paesaggi metropolitani, in: Carus S., De Marco P., Di ChiaraC., Piccini C., Scalzo G. (2004), Indicatori della biodiversita in ambiente urbano.
2Spagnoli L. (2012), I paesaggi della contemporaneita e le nuove progettualita, Bollettino dellaSocieta Geografica Italiana, Serie III, vol. V.
3Cfr. Spagnoli L. (2012), I paesaggi della contemporaneita e le nuove progettualita, Bollettino dellaSocieta Geografica Italiana, Serie III, vol. V., p. 564.
4Stati Generali della Green Economy (2012), 70 proposte per lo sviluppo della green economy percontribuire ad uscire dalla crisi italiana. Fonte: http://www.statigenerali.org/cms/wp-content/
uploads/2012/12/Roadmap_Green-Economy_70_proposte.pdf5Gli Stati Generali della Green Economy sono nati da un’idea del Ministro dell’Ambiente Italiano
con le principali associazioni di imprese “green” italiane, hanno l’ambizione di promuovere un nuovoorientamento dell’economia italiana verso una green economy per aprire nuove opportunita di sviluppo
7
8Paesaggio, urban agriculture e orti urbani. . . una politica di green sustainability per la
citta.
considerato strumento “per la progettazione di uno sviluppo territoriale integrato esostenibile” rappresenti un vero e proprio ruolo strategico nelle politiche di valorizzazionelocale, riscoprendo quelle aree agricole sulle quali attivare un processo di riqualificazionefunzionale sia degli spazi propriamente naturali sia di quelli urbani6, ristabilendo cosıun rapporto tra la citta e il mondo naturale, ma contemporaneamente, riportandonell’ambiente urbano il verde estetico-ornamentale e quello produttivo–agricolo degliorti che caratterizzavano la citta preindustriale.
2.2 Ridefinire il territorio cittadino: il caso PRGC diUdine.
Nel 2009 la nuova amministrazione comunale di Udine, ha deciso di “costruire” il nuovoPiano Regolatore Generale Comunale (PRGC), con lo scopo di migliorare i diversiinterventi che nel tempo si erano susseguiti. Il lavoro svolto non e stato solamente dimera sistemazione del quadro urbanistico, bensı di una presa di coscienza tenendo contoanche delle osservazioni7 avanzate da cittadini, scuole, imprese locali, commercianti,associazioni, istituzioni di quartiere, al fine di offrire un “prodotto” che accogliesse anchegli aspetti della mobilita sostenibile, dell’economia e dell’identita locale, del turismosostenibile e della condivisione partecipata delle scelte strategiche per il futuro delterritorio8.
Analizzando le osservazioni della comunita udinese sono emersi alcuni elementiche hanno fatto riflettere gli addetti ai lavori, poiche si evincono un vero e propriosenso di appartenenza alla citta udinese e un certo legame al quartiere in cui essivivono. Approfondendo, si e scoperto come sussista la “necessita” di avere a disposizioneopportunita di aggregazione sociale di quartiere, la volonta di valorizzazione deglielementi dell’ambiente naturale ed il recupero, nonche la riqualificazione delle areedegradate ai margini della citta. Di risposta a queste “esigenze”, l’AmministrazioneComunale ha attivato una serie di strategie incentrate sulla tutela e sulla valorizzazionedel patrimonio agricolo e naturale, il quale rappresenta il 47,8% del territorio comunale,e l’agricoltura rappresenta un’economia di rilievo e un presidio attivo dell’ambientenaturale9.
durevole e sostenibile ed indicare la via d’uscita dalla crisi economica e climatica.L’obiettivo e sviluppare una piattaforma programmatica per lo sviluppo di una green economy in Italiaattraverso l’analisi dei potenziali positivi, degli ostacoli, nonche delle politiche e delle misure necessarieper migliorare la qualita ecologica dei settori strategici.
6Spagnoli L. (2012), I paesaggi della contemporaneita e le nuove progettualita, Bollettino dellaSocieta Geografica Italiana, Serie III, vol. V., p. 566.
7Per far fronte all’esigenza di stimolare il dibattito e per definire meglio gli ambiti di discussione, alfine di conoscere esigenze, critiche, spunti e quant’altro, e stato somministrato un questionario-intervistanecessario per raccogliere contributi coerenti con le funzioni di un Piano Regolatore.
8Fonte: http://www.comune.udine.it/opencms/opencms/release/ComuneUdine/cittavicina/
territorio/Urbanistica/pianiurbanistici/nuovo_prgc/index.html?style=19Fonte: http://www.comune.udine.it/opencms/opencms/release/ComuneUdine/cittavicina/
territorio/Urbanistica/pianiurbanistici/nuovo_prgc/Materiali/Presentazione_Tavolo_
Tecnico.pdf
2.3 La risposta dell’agricoltura urbana alle esigenze della comunita 9
2.3 La risposta dell’agricoltura urbana alle esigenze dellacomunita
Negli ultimi decenni a livello internazionale ha iniziato ad esprimersi una nuova formadi “ruralita urbana” – meglio conosciuta con il termine di agricoltura urbana – come unvero processo di transizione verso un modello di strutturazione delle relazioni sociali,dei rapporti citta-campagna, societa-natura, societa-cibo, che e diventato l’obiettivodi quelle comunita locali che vogliono affrontare in maniera attiva le grandi sfide dellasostenibilita paesaggistica e ambientale , riconoscendo il significato e il ruolo assuntodal paesaggio periurbano, agricolo e naturale.
Questo processo d’integrazione/transizione/sviluppo sostenibile tra citta e campagnae stato implementato anche all’interno del PRGC udinese poiche, stando alle recentiricerche condotte, farebbe fronte alle necessita ed alle esigenze di sostenibilita della cittasotto diversi punti di vista: sociale, economico ed ambientale10. In questo contesto siafferma come l’agricoltura assolva sia compiti di produzione alimentare di qualita, sia disalvaguardia ambientale e paesaggistica, permettendo al contempo una riqualificazionedella periferia ed un miglioramento della qualita della vita e dell’urbanizzazione diffusa11.
Nel corso degli anni si e cercato di dare una definizione alquanto precisa sull’agricol-tura urbana e fra le tante qui riportiamo la seguente12:
Urban agriculture is an industry located within (intraurban) or on the fringe(periurban) of a town, a city or a metropolis, which grows or raises, processes anddistributes a diversity of food and non-food products, (re)using largely human andmaterial resources, products and services found in and around that urban area, andin turn supplying human and material resources, products and services largely tothat urban area.
L’agricoltura urbana e tendenzialmente un’attivita che si adatta ad ogni tipo dicondizione ambientale, anche se in realta sono state identificate cinque principali formedi coltivazione:
• coltivazioni ai margini delle infrastrutture;
• orti urbani (allotment gardens);
• community gardens (tipici del territorio inglese);
• tetti-giardino;
• imprese agricole peri-urbane.
In questo paper ci occuperemo solamente degli orti urbani, poiche rappresentanouna delle politiche di green sustainability adottate dalla citta di Udine. Quello checaratterizza il fenomeno in esame e l’aspetto sociale perche, oggi, a occuparsi della terra
10Deelstra T., Girardet H., Urban Agriculture and Sustainable Cities, in Bakker N., Dubbeling M.,Gundel S., Sabel-Koschella U., de Zeeuw H. (2000), Growing cities, growing food: urban agriculture onthe Policy Agenda: a reader an urban agriculture, Leusolen – Paesi Bassi.
11Pastore R. (2011), Redigere Linee Guida per illustrare nuovi modi di abitare le periferie urbanepubliesi suggeriti dal PPTR/Puglia, in Abitare l’Italia. Territori, Economie, Diseguaglianze. Atti dellaXIV Conferenza SIU, Torino.
12Djalali A., Virgilio G. (2007), Sistema alimentare e pianificazione urbanistica. Uno studio perl’Agricoltura Urbana a Bologna, (Diss. Tesi di Laurea, rel. Giovanni Virgilio, Universita degli Studi diBologna), Bologna.
10Paesaggio, urban agriculture e orti urbani. . . una politica di green sustainability per la
citta.
non sono piu solo gli agricoltori tradizionali o i nuovi contadini, ma anche famiglie,soggetti occupati in altri settori, disoccupati e inoccupati, pensionati, giovani – chevogliono tentare nuovi percorsi di vita – e addirittura disabili. Tutti spinti da diversemotivazioni come un’alimentazione piu sana, la volonta di vivere in un ambiente menoinquinato, il recupero immaginario dell’infanzia, l’autoconsumo, ecc.
A scanso di equivoci, teniamo bene presente che l’agricoltura di utilita sociale nonsvolge un mero ruolo di supplenza delle PP.AA. ne rappresenta una nuova nicchia dimercato per le nuove aziende agricole e cooperative sociali impegnate in agricoltura onel verde, ma abbraccia forme e soluzioni molto diverse proponendosi come un’ipotesidi lavoro piu ampia innescando percorso virtuosi tra le diverse componenti della societacapaci di produrre una ricchezza sociale per i territori rurali e periurbani, la comunita, leistituzioni e l’agricoltura stessa in una logica di sperimentazione sociale ed economica13.
Numerosi studi hanno dimostrato come l’agricoltura urbana puo contribuire a crearemolteplici benefits sociali, salutari, economici e ambientali 14 come riportato nella figuradell’allegato 1.
All’interno di questo insieme e curioso conoscere anche l’impatto che il fenomenoha nell’ambito dell’economia familiare. L’obiettivo principale che una famiglia si ponee sicuramente la massimizzazione del proprio benessere, anche attraverso l’utilizzo dirisorse familiari – lavoro, capitale, una serie di competenze personali, il prezzo e l’accessoagli input come il terreno. Dalle ricerche condotte si evince come questo obiettivo vienestimolato dalla sensazione di rischio e incertezza che la famiglia media di oggi percepiscenei confronti dei mercati, delle politiche, ma anche del tempo atmosferico; pertanto ladecisione di spendere il proprio tempo nell’attivita di agricoltura urbana e in lampanterelazione con il reddito e i salari, prezzi e opportunita lavorative15, soprattutto in questomomento di contrazione economica.
2.3.1 Gli orti urbani udinesi: il progetto “L’Orto e la Luna”
Fra le diverse politiche green adottate dal Comune di Udine vi e il progetto sugli ortiurbani, denominato “L’Orto e la Luna”.
Con il termine orti urbani, s’identificano piccoli appezzamenti di terreno (circa 30mq16) di proprieta comunale, adibiti alla sola ed esclusiva coltivazione non professionaledi ortaggi, piccoli frutti e fiori17 ad unico uso di consumo familiare.
Nel disciplinare l’iniziativa, il Comune di Udine ha posto l’attenzione ad alcuni aspet-ti cardine, frutto di diverse riflessioni, critiche e commenti, tenendo in considerazioneanche le altre realta vicine al territorio udinese – gli orti di Venezia Mestre e Klagen-furt (Austria). Gli elementi primari che caratterizzano questi orti sono sicuramentel’autoproduzione di ortaggi e l’esclusivo utilizzo del metodo di produzione biologico.Quest’ultimo aspetto ha una valenza molto forte e importante all’interno della comunita
13Hausmann C., Galasso A., Paolini S., Durastani F. (2010), L’agricoltura sociale per il benessereumano, in: Rapporto ISPRA – Multifunzionalita dell’azienda agricola e sostenibilita ambientale, n.128.
14Fonte: www.fiveboroughfarm.org/impact/ - visitato il 21/06/2013.15Nugent R., The impact of urban agriculture on the household and local economies, in Bakker N.,
Dubbeling M., Gundel S., Sabel-Koschella U., de Zeeuw H. (2000), Growing cities, growing food: urbanagriculture on the Policy Agenda, Leusolen – Paesi Bassi.
16La scelta di stabilire questo quantitativo di terreno nasce dalla consapevolezza che tale dimensionee in grado di soddisfare, in media, il bisogno di autoconsumo alimentare di ortaggi per una famiglia emezza.
17Tratto da: Linee guida per la concessione e l’uso degli orti urbani pubblici, fonte:http://www.comune.udine.it/opencms/opencms/release/ComuneUdine/cittavicina/territorio/
agenda21/orto_luna/materiali/Linee_guida_orti_urbani_Udine.pdf - visitato il 21/06/2013.
2.3 La risposta dell’agricoltura urbana alle esigenze della comunita 11
perche si fonda, da un lato sull’aspetto della sensibilizzazione alla sicurezza alimentare,ma dall’altro si caratterizza come elemento educativo alla produzione senza l’utilizzo difertilizzanti chimici e/o fitofarmaci. A questi due elementi se ne aggiungono altri, qualila tutela delle specie autoctone e il recupero, nonche la tutela, delle varieta a rischio.Questi elementi sono uniti fra loro mediante un unico filo conduttore, ovvero la creazionedi percorsi di cittadinanza attiva, che permettano una vera e propria focalizzazionesui momenti di aggregazione sociale favorendo i rapporti interpersonali, lo scambio diconoscenze e la valorizzazione dell’ambiente urbano.
Nell’attribuire questi orti, i richiedenti sono stati suddivisi in quattro categoriespecifiche (o target), ciascuno dei quali presenta caratteristiche e requisiti specifici18.
Nel caso specifico troviamo quindi:
• categoria A: orti per anziani;
• categoria B: orti per famiglie;
• categoria C: orti per le scuole;
• categoria D: orti per associazioni.
2.3.2 L’iniziativa oggi
A quattro anni dal suo avvio, il progetto conta quattro aree adibite a orto urbano perun totale di 72 lotti situati nel cuore dei diversi quartieri cittadini – via Zucchi, viaBariglaria, via Pellis e via Zugliano. Questi orti si trovano nei pressi di scuole, centricivici e sportivi, ponendo l’accento ancora una volta come l’aggregazione sociale sial’obiettivo fondante.
Ora, analizzando le statistiche relative agli assegnatari, notiamo come questi ortisiano affidati in porzioni uguali agli anziani (34,72%) e alle famiglie (34,72%), ai qualiseguono le associazioni (19,44%) e le scuole (11,11%)19.
Studiando piu a fondo i dati si evidenzia come il 34,4% degli assegnatari – anziani efamiglie – abbia chiesto l’esenzione del canone annuo, poiche presentano una situazioneeconomica inferiore alla soglia di poverta stabilita dalla Regione Friuli Venezia Giulia.Si osserva, infatti, che la categoria delle famiglie sia quella che soffre di piu (53,6%) inquesto periodo di crisi, seguita dagli anziani solamente per il 14,4%. In altre parole,il quadro ci conferma che la persona anziana media vive sostanzialmente in buonecondizioni, mentre le famiglie risentono maggiormente della situazione in cui versa ilnostro territorio, legata ai casi di disoccupazione e alla paura della perdita del lavoro.
Concatenando questo dato con l’indice percentuale di abbandono, possiamo rifletterecirca le possibili scelte strategiche che si possono attuare. Ora, se consideriamo che il 24%di abbandono proviene dalla categoria degli anziani, contro il 12% delle famiglie, possiamoarrivare alla conclusione che le famiglie sono le prime ad avere maggiore necessita di questiorti, in quanto rappresentano una maggiore sicurezza per la sussistenza e, di conseguenza,se lo tengono ben stretto. Pertanto, stando a questi dati ed alle considerazioni appenaavanzate, e possibile affermare come la redistribuzione degli appezzamenti da affidarealle famiglie, sottraendole agli anziani, possa essere una politica strategica di possibile erapida attuazione.
18Per i requisiti specifici si rimanda alla lettura del documento “Linee guida per la concessione el’uso degli orti urbani pubblici”
19Non a caso le scuole rappresentano il numero minore, poiche sussistono problemi di carattereorganizzativo relativamente alle attivita che possono essere svolte.
12Paesaggio, urban agriculture e orti urbani. . . una politica di green sustainability per la
citta.
Detto questo, quali sono le attivita che si svolgono all’interno di questo “spaziocomune”? Considerando che alla base di tutto vi e la necessita di aggregazione, leattivita svolte fino ad oggi sono innanzitutto di carattere formativo – l’organizzazione dicorsi teorico-pratici dedicati alla coltivazione e alla cura del terreno; progetti scolasticilegati alla conoscenza della terra e della natura; l’utilizzo di laboratori educativi e scambidi know-how fra i plessi didattici di quartiere, le associazioni e gli assegnatari – maanche di tipo sociale attraverso la creazione di feste e altre occasioni conviviali.
Nella tabella di seguito sono riportati, in sintesi, i principali benefici che si possonoottenere attraverso il fenomeno dell’orto urbano, anche se e bene specificare come taleclassificazione puo essere ampliata, o ridotta, a livello personale.
Tabella 2.1: Benefici degli orti urbani.
Benefici Sociali Benefici Economici Benefici Ambientali
Sicurezza alimentare Autoproduzione e Tutela della biodiversitaautosostentamento
Spazi sicuri Filiera corta Sicurezza salutare
Scambio di know how “Risparmio” sulla spesa Miglioramento del paesaggioalimentare
Progetti educativi per adulti Uso di materiali ecologici
Attivita associative Tutela della cultura rurale
Progetti scolastici
Non possiamo infine dimenticare che il progetto nel corso degli anni ha fruttatoimportanti risultati20: il Premio Greenfactor 2011, l’Oscar della salute 2013, il PremioNazionale per l’Agricoltura Civica 2013, confermando Udine Comune capofila nazionaledella rete degli orti urbani.
20Fonte: http://www.comune.udine.it/opencms/opencms/release/ComuneUdine/cittavicina/
territorio/agenda21/orto_luna/premi_riconoscimenti.html?style=1 - visitato il 21/06/2013.
Capitolo 3
L’agricoltura urbana comestrumento di sensibilizzazione alconsumo alimentare responsabileed etico
3.1 L’evoluzione dei consumi alimentari
Recenti ricerche hanno evidenziato come nel corso degli ultimi decenni abbiamo assistitoad un mutamento strutturale dei consumi alimentari delle famiglie. Nell’arco di quaran-t’anni, infatti, i consumi personali sono raddoppiati, ma la spesa per prodotti alimentarie rimasta quasi costante (+16%); quella destinata alle telecomunicazioni e aumentatadi circa 900%, e per la salute del 670%. Quello che e cambiato non e solamente lacomposizione dei consumi primari, ma anche la nostra cultura1; oggi il consumatoretende a selezionare i prodotti alimentari da acquistare, approfittando anche di questoquadro economico per ristrutturare ulteriormente il proprio regime alimentare.
Qui di seguito riportiamo sinteticamente i risultati della situazione reale, mostrando imutamenti che si sono verificati sulla base della fascia d’eta e la posizione occupazionale2.
Tabella 3.1: Mutamento consumi alimentari nel Nord-Est.
Modifiche % Fascia d’eta Occupazione
Nessun mutamento 40% Giovani (< 34 anni) Impiegati, Studenti,Liberi professionisti
Riduzione moderata 44% Giovani (15-24 anni) Imprenditori, Studenticonsumo alimentare Adulti (35-54 anni) Casalinghe, Disoccupati
(1-2 alimenti)
Riduzione diffusa 16% Adulti (> 45 anni) Operai, Casalingheconsumo alimentare Anziani Disoccupati, Pensionati
(3-4 alimenti)
1Cfr. Gurisatti P., I consumi alimentari falcidiati dalla crisi della terza settimana, in Demos&Pi(2013), Anche il Nord Est riduce i consumi alimentari, Osservatorio Nord Est.
2Ibidem
13
14L’agricoltura urbana come strumento di sensibilizzazione al consumo alimentare
responsabile ed etico
In conformita a questo quadro dobbiamo precisare come oggi la strada di rinnova-mento sembra essere la riscoperta della cultura dei prodotti tipici chiamati anche a “kmzero”.
Pertanto e curioso domandarci se il consumatore medio stia cercando di andare nelladirezione di un consumo piu responsabile ed etico, o meno.
3.2 Consumo responsabile e consumo etico
Nella societa post moderna, nella quale i consumi occupano un ruolo di primo pianonella vita delle persone, assistiamo – a piccoli passi – ad una consapevolezza circa idoveri sociali di ciascuno di noi anche in quanto consumatori. In altre parole siamo allapresenza di una parte minoritaria ma crescente di cittadini-consumatori che, nel farele proprie scelte di acquisto, pone attenzione agli effetti che queste possono avere sulbenessere di altri soggetti – produttori, lavoratori, cittadini e consumatori, animali el’ambiente.
L’idea di base e che scelte diverse riguardo a cosa produrre o al modo stesso diprodurre possano influire in modo differente, positivamente o negativamente, su altripaesi, persone, sulla natura, ecc., per cui un comportamento responsabile dovrebbe tenerconto dell’influenza che possono avere i consumi su questi aspetti. S’inizia a disegnarecosı la figura del consumatore-cittadino che non si accontenta piu di scelte basate solosul rapporto qualita-prezzo, ma pone attenzione anche al modo in cui un prodottoe realizzato, distribuito e alle fasi del post consumo3, attivando un c.d. processo discreening su tutta la filiera economica, che lo porta a scegliere fra un ventaglio dipossibili forme di consumo e che diviene cosı responsabile proprio perche considera lavalutazione degli effetti che queste scelte hanno su terzi, come riportato nella tabellache segue.
Con il concetto di consumo sostenibile si ha l’idea che l’attuale ritmo di consumonon sia sicuramente sostenibile nel tempo, comportando un’eccessiva pressione d’uso dirisorse non rinnovabili in tempi “brevi”, causando quindi inquinamento, degrado dellerisorse e danni alla salute umana.
Secondo l’approccio di consumo alternativo, l’aspetto della sostenibilita dovrebbebasarsi su uno stile di vita sobrio che poggi sulle 4 R: ridurre badando all’essenziale;recuperare riutilizzando lo stesso oggetto finche e servibile e riciclare tutto cio che puoessere rigenerato; riparare evitando di gettare gli oggetti al primo danno e rispettare illavoro altrui imparando a trattare bene le cose che ci rendono la vita possibile.
Con il diffondersi di questi comportamenti e l’allargarsi delle nicchie di mercato chevi corrispondono, e cresciuta anche la proliferazione di termini e definizioni ancora pococonsolidati4; cosı ad esempio e stato coniato il termine consumatore etico, con il qualeintendiamo:
Quel consumatore che cerca di declinare le scelte di consumo sul piano etico,ispirandosi ad un sistema di valori e rivivendo la pratica del consumo in carat-teristiche fisiche e funzionali, anche in base al suo impatto socio-ambientale o alcomportamento del produttore. Per il consumatore etico l’atto di consumo non e
3Gaito M. (2008), Il ruolo dell’Agricoltura Sociale e la collocazione dei sui prodotti sul mercato, Tesidi Dottorato di Ricerca in Politica Agraria, Universita degli Studi della Tuscia, Viterbo.
4Gaito M. (2008), Il ruolo dell’Agricoltura Sociale e la collocazione dei sui prodotti sul mercato, Tesidi Dottorato di Ricerca in Politica Agraria, Universita degli Studi della Tuscia, Viterbo.
3.3 Considerazioni finali 15
Tabella 3.2: Le forme di manifestazione del consumo responsabile.
Tipo di scelta Tipologie di prodotti e di scelte connesse al consumo
Consumo
Prodotti a prevalente contenuto ecologico-ambientale (prodotti verdi):- prodotti biologici- prodotti non inquinanti- confezioni a basso impatto ambientale
Prodotti a prevalente contenuto sociale e/o culturale:- prodotti del commercio equo e solidale- prodotti tipici- prodotti etnici
Prodotti (beni e servizi) variamente connessi alle precedenti dimensioni:- prodotti connessi ad una giusta causa (Cause Related Marketing)- Investimenti etici
Non consumoBoicotaggio (scelta collettiva)Prodotti/marche sgradite (scelta individuale)
Altre scelteRiduzione complessiva del livello dei consumiRiutilizzo dei beniRiciclo dei materiali
quindi un atto privato, ma rientra in una sfera pubblica poiche legato a questionidi ampia portata che riguardano l’interesse collettivo5.
Con questa definizione ci troviamo, quindi, di fronte ad una vera e propria rivisita-zione del concetto di consumo che, in quest’ottica, pone l’accento sulla responsabilita,legata al fenomeno di natura economica del principio utilitaristico e della convenienzaindividuale, ma riunisce anche una pluralita di significati e di funzioni sociali difficilmentedecifrabili secondo gli assiomi della teoria economica classica, perche forma innovativa diconsumo che subordina le caratteristiche tangibili del bene (o del servizio) a valutazionidi ordine etico, prestando maggiore attenzione alla qualita sociale6.
3.3 Considerazioni finali
Arrivati al termine di questo lavoro, possiamo quindi chiederci se il fenomeno dell’agri-coltura urbana e, di conseguenza, degli orti urbani possa rappresentare effettivamenteuna policy per la sostenibilita territoriale e sociale, nonche per un ritorno potenziale alconsumo responsabile dei prodotti alimentari.
Sulla base delle ricerche fino ad oggi condotte, e possibile affermare come questofenomeno porti benefici al territorio per tutta quella serie di aspetti ambientali e ditutela, e, al contempo, rappresenti una forma di “sostenibilita sociale”, specialmenteper i soggetti che si trovano in situazione di disagio economico, sociale, psicologico esalutare in senso ampio.
Sempre per la popolazione, esso rappresenta anche uno strumento utile alla sensi-bilizzazione verso un consumo alimentare responsabile ed etico. Tuttavia si pensa che
5Cfr. Saroldi A., Bert G. (2008), Il consumatore etico e i gruppi di acquisto solidali, in: L’agricolturadalla parte del consumatore. Domanda e offerta di prodotti alimentari: il punto di vista del consumatore,Atti del Convegno IRES Piemonte, Torino, p. 11.
6Lori M., Volpi F. (2005), Scegliere il “bene – Indagine sul consumo responsabile, Roma.
16L’agricoltura urbana come strumento di sensibilizzazione al consumo alimentare
responsabile ed etico
siano utili politiche di vera e propria sensibilizzazione e di coinvolgimento della societanella filiera, non ristrette solamente agli assegnatari degli orti, ma a tutta la popolazione,permettendo al cittadino di conoscere il quadro d’insieme dei diversi benefici che sipossono trarre.
In piu, se volessimo dare un valore aggiunto al tema della responsabilita socialee della sostenibilita, sarebbe interessante tenere in considerazione – e aggiungiamosoprattutto – quei soggetti che siano gia in possesso di un appezzamento di terreno, alfine di responsabilizzarli e spingerli a produrre in modo salubre, evitando l’utilizzo ditutto quell’insieme di prodotti chimici che purtroppo da un lato aumentano, in brevetempo, la resa dei terreni sfruttandoli il piu possibile, ma contemporaneamente intaccanola qualita del prodotto finale e dell’ambiente.
Sarebbe bello, e utile, un ritorno all’agricoltura di un tempo, che rispetti l’ambiente,la biodiversita e le colture tipiche del luogo, ma questo lo prendiamo come nuovo spuntoe sfida per il futuro della sostenibilita territoriale, sociale, economica e ambientale.
Bibliografia
[1] Abegunde A. A., Urban Horticulture and Community Economic Development ofLagging Regions, in Luna Maldonado A. I. (2012), Horticulture, InTech.
[2] Alberti M. (1996), Measuring urban sustainability, in Environmental ImpactAssessment Review, 16.3, pp. 381 – 424.
[3] Attiani C. (2012), L’agricoltura urbana, in Sociologia urbana e rurale, n. 98.
[4] Bajo N., Di Noi A., Reti ecologiche e paesaggi metropolitani, in: Carus S., DeMarco P., Di Chiara C., Piccini C., Scalzo G. (2004), Indicatori della biodiversitain ambiente urbano.
[5] Bauman Z. (2007), Consumo, dunque sono, Edizioni Laterza, Roma.
[6] Bauman Z. (2007), Homo consumens, Erickson, Gardolo – Trento.
[7] Bengston D. N., Fletcher J. O., Nelson K. C. (2004), Public policies for managingurban growth and protecting open space: policy instruments and lessons learnes inthe United States, in Landscape and Urban Planning, n. 69, pp. 271 – 286.
[8] Boggia A., Cortina C. (2008), Un modello per la valutazione della sostenibilitadello sviluppo a livello territoriale, in Aestimum n. 52, pp. 31 – 52.
[9] Bologna G., Worldwatch Institute, Yunus M. (2010), State of the world 2010:trasformare la cultura del consumo. Rapporto sul progresso verso una societasostenibile, Edizioni Ambiente, Milano.
[10] Bonaiuti M. (2013), La grande transizione. Dal declino alla societa della decrescita,Bollati Boringhieri, Torino.
[11] Bottero M., Ferretti V., Mondini G. (2012), La valutazione economica dei benipaesaggistici: una riflessione metodologica, Atti del convegno “Il paesaggio agrarioitaliano tra sviluppo e conservazione”, Roma.
[12] Bovolin S. (2010), La fattoria sociale come strategia di sviluppo rurale integrato: ladiversificazione dell’economia rurale per lo sviluppo sostenibile ed inclusivo dellacampagne, Tesi di Laurea Specialistica, Universita degli Studi, Padova.
[13] Calori A. (2009), Coltivare la citta: il giro del mondo in dieci progetti di filieracorta, Terre di Mezzo, Milano.
[14] Carus S., De Marco P., Di Chiara C., Piccini C., Scalzo G., Treves C. (2004),Indicatori della biodiversita in ambiente urbano, Criea.
19
20 Bibliografia
[15] Cersosimo D. (2011), I consumi alimentari. Evoluzione strutturale, nuove tendenze,risposte alla crisi. Atti del Workshop tenuto a Palazzo Rospigliosi, Roma.
[16] Cicatiello C., Pancino B., Franco S. (2012), Un modello per la valutazione dellasostenibilita territoriale delle filiere agroalimentari: struttura e applicazione allasfera ambientale, paper presentato alla Io Conferenza AIEAA “Verso una bio-economia sostenibile: aspetti economici e sfide di politica economica”, Trento.
[17] Cioni L. (2011), Orti-culture. Riflessioni antropologiche sull’orticultura urbana,Tesi di Laurea, Universita degli Studi, Bologna.
[18] Cognetti F., Conti S. (2012), Oggetti verdi come dispositivi. Milano, note da unaricerca sull’agricoltura urbana, in: Territorio, n. 60.
[19] Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Indagine conoscitivasull’agricoltura urbana, n. 12/10/CR7/C10.
[20] Consiglio d’Europa (2000), Convenzione Europea del Paesaggio.
[21] Corrado A., Tocci G. (2010), La Sostenibilita Agro-Alimentare Territoriale. Mo-dello di analisi, Relazione della II Conferenza Nazionale Annuale della sezioneSociologia del Territorio dell’Associazione Italiana di Sociologia “Citta-campagna:la sociologia di fronte alle trasformazioni del territorio”, Alessandria.
[22] Croce E., Perri G. (2010), Il turismo enogastronomico. Progettare, gestire, viverel’integrazione tra cibo, vino, territorio, Franco Angeli, Milano.
[23] de Zeeuw H., Guendel S., Waibel H. (2000), The integration of agriculture inurban policies, Urban Agriculture Magazine, vol. 1, n. 1.
[24] Deelstra T., Girardet H., Urban Agriculture and Sustainable Cities, in: BakkerN, Dubbeling N., Gundel M., Sabel-Koschella S., de Zeeuv H. (2000), Growingcities, growing food: urban agriculture on the policy Agenda: a reader an urbanagriculture on the Policy Agenda, Leusolen – Paesi Bassi.
[25] Della Valle M. F. (2009), Ruoli e funzioni degli orti nel paesaggio urbano, in:Agribusiness Paesaggio & Ambiente, vol. XII, n. 2, pp. 122-129.
[26] Di Iacovo F. (2011), Governance dell’innovazione nelle aree rurali: un’analisiinterpretativa del caso dell’agricoltura sociale, Rete Rurale Nazionale.
[27] Djalali A. (2007), Sistema alimentare e pianificazione urbanistica. Uno studio perl’Agricoltura Urbana a Bologna, Tesi di Laurea, Universita degli Studi, Bologna.
[28] Drescher A. W., Jacobi P, Amend J. (2000), Urban Agriculture, a response tocrisis?, in Urban Agriculture Magazine, vol. 1, n. 1.
[29] Finotto F. (2004), Gli orti urbani nella riqualificazione polifunzionale del Sangone:l’alterazione di una sistema spontaneo, in “Il Sistema rurale una sfida per laprogettazione tra salvaguardia, sostenibilita e governo delle trasformazioni, Attidel Convegno Internazionale, Politecnico di Milano.
[30] Franco S., Senni S. (2005), La funzione sociale delle attivita agricole: il caso delLazio, in Quaderni di Informazione Socioeconomica, n. 15.
Bibliografia 21
[31] Gaito M. (2008), Il ruolo dell’agricoltura sociale e la collocazione dei suoi prodottisul mercato, Tesi di Dottorato di Ricerca, Universita degli Studi della Tuscia,Viterbo.
[32] Galli M., Maraccini E., Lardon S., Bonari E. (2010), Il progetto agro-urbano: unariflessione sulle prospettive di sviluppo, in: Agriregionieuropa, n. 20.
[33] Giare F. (2008), Cosa cambia nei consumi. . . Cosa cambia nel mondo agricoloe rurale, in: “L’Agricoltura dalla parte del consumatore. Domanda e offerta diprodotti agroalimentari: il punto di vista del consumatore”, Atti del ConvegnoIres Piemonte, Torino.
[34] Giare F. (2012), Forme e modi dell’agricoltura, in Agriregionieuropa, n. 30.
[35] Goodstein E. S. (2008), Economics and the Environment, Wiley & Sons.
[36] Grillenzoni M. (2009), Sviluppo integrato tra aree metropolitane e spazi rurali,Pubblicazioni Ce.SET, n. 24.
[37] Gurisiatti P., I consumi alimentari falcidiati dalla crisi della terza settimana, in:Demos & pi (2013), Osservatorio Nord Est, “Anche il Nord Est riduce i consumialimentari”.
[38] Hausmann C., Galasso A., Paolini S., Durastani F., L’agricoltura sociale per ilbenessere sociale, in: Rapporto ISPRA (2010), Multifunzionalita dell’aziendaagricola e sostenibilita ambientale, n. 128.
[39] Kaufman J., Bailkey M. (2000), Farming inside cities: Entrepreneurial urbanagriculture in the United States, Working Paper, Lincoln Institute of Land Policies,Cambridge – MA.
[40] INEA, Giare F., Giuca S. (2012), Agricoltori e filiera corta: profili giuridici edinamiche socio-economiche, Atti del Seminario di Studi INEA, Roma.
[41] Latouche S. (2005), Come sopravvivere allo sviluppo, Bollati Boringhieri, Torino.
[42] Lori M., Volpi F. (2007), Scegliere il “bene”. Indagine sul consumo responsabile,Franco Angeli, Milano.
[43] Magnaghi A., Politiche e progetti di territorio per il ripopolamento rurale, in:Bonora P. (2012), Visioni e politiche del territorio: per una nuova alleanza traurbano e rurale.
[44] Masini S. (2011), Sulla qualita (alimentare) come regola conformativa delladestinazione d’uso del suolo, in: Aestimum, n. 59.
[45] Mougeot L. J. A. (2000), Urban agriculture: concept and definition, in UrbanAgriculture Magazine, vol. 1, n. 1.
[46] Munda G. (2006), Social multi-criteria evaluation for urban sustainability policies,in Land Use Policy, n. 23, pp. 86-94.
[47] Muzzillo F., Frettoloso C., Tortelli F. (2011), Dalla piramide alimentare all’in-tegrita territoriale. Spazi di relazione e produzione agricola per reinterpretare lacollettivita, Relazione del IX International Forum Le Vie dei Mercanti, Aversa,Capri.
22 Bibliografia
[48] Nugent R., The impact of urban agriculture on the household and local economies,in: Bakker N, Dubbeling N., Gundel M., Sabel-Koschella S., de Zeeuv H. (2000),Growing cities, growing food: urban agriculture on the policy Agenda: a readeran urban agriculture on the Policy Agenda, Leusolen – Paesi Bassi.
[49] Pastore R. (2011), Redigere Linee Guida per illustrare nuovi modi di abitare leperiferie urbane pugliesi suggeriti dal PPTR/Puglia, in: Abitare l’Italia. Territori,economie, disuguaglianze, Atti della XIV Conferenza SIU, Torino.
[50] Piras R. (2002), Dalla teoria dello sviluppo alla teoria della crescita, GiappichelliEditore, Torino.
[51] Porcellato N., Quelli che amano l’Europa e sono fedeli alla moneta unica, in:Demos & pi (2013), Osservatorio Nord Est. Anche il Nord Est riduce i consumialimentari.
[52] Saroldi A. (2008), Il consumatore etico e i Gruppi di Acquisto Solidali, in: “L’agri-coltura dalla parte del consumatore. Domanda e offerta di prodotti agroalimentari:il punto di vista del consumatore”, Atti del Convegno Ires Piemonte, Torino.
[53] Saumel I., Kotsyuk I., Holscher M., Lenkereit C., Weber F., Kowarik I. (2012),How healty is urban horticulture in high traffic areas? Trace metal concentrationin vegetable crops from plantings within inner city neighbourhoods in Berlin,Germany, in: Environmental Pollution, n. 165, pp. 124-132.
[54] Senni S. (2005), L’agricoltura sociale come fattore di sviluppo rurale, in:Agriregionieuropa, n. 2.
[55] Sharp J. S., Smith M. B. (2003), Social capital and farming at the rural-urbaninterface: the importance of nonfarmer and farmer relations, in: AgriculturalSystem, n. 76, pp. 913-927.
[56] Signorello G. (2007), La valutazione economica del paesaggio: aspetti metodologicie operativi, Atti del XXXVI Incontro di Studio Ce.S.E.T., Firenze UniversityPress, pp. 83-102.
[57] Smit J. (2000), Urban Agriculture and Biodiversity, in: Urban AgricultureMagazine, vol. 1, n. 1.
[58] Spagnoli L. (2012), I paesaggi della contemporaneita e le nuove progettualita, in:Bollettino della Societa Geografica Italiana, Serie XIII, vol. V, pp. 563-586.
[59] Stati Generali della Green Economy (2012), 70 proposte per lo sviluppo della greeneconomy per contribuire ad uscire dalla crisi italiana.
[60] Tinacci Mossello M. (2008), Politica dell’ambiente – analisi, azioni, progetti, IlMulino, Bologna.
[61] Tosto A. (2011), Evoluzione della politica agricola comune ed affermazione dellamultifunzionalita in agricoltura: l’agricoltura sociale in Sicilia, Tesi di Dottoratodi Ricerca, Universita degli Studi, Catania.
[62] Trisorio A. (2004), Misurare la sostenibilita. Indicatori per l’agricoltura italiana,INEA, Roma.
Sitografia
[63] Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO: http://www.fao.org
[64] Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT: www.istat.it
[65] Il Sole 24 Ore: www.ilsole24ore.com
[66] Istituto Nazionale di Economia Agraria: www1.inea.it
[67] Rivista di Storia online: www.storicamente.org
[68] Coldiretti: www.coldiretti.it, www.ambienteterritorio.coldiretti.it,www.udine.coldiretti.it
[69] Associazione per la Salvaguardia e la Conservazione dell’Ambiente in Italia:www.italianostra.org
[70] Five Borough Farm: progetto sull’agricoltura urbana a New York: www.
fiveboroughfarm.org
[71] i.rur Innovazione Rurale: www.irur.it
[72] Demos & Pi: Istituto di Ricerca Politica e Sociale: www.demos.it
[73] Comune di Udine: www.comune.udine.it
[74] Global Footprint Network: Advancing the Science of Sustainability: www.
footprintnetwork.org
[75] Centro Regionale di Informazione de Educazione Ambientale - C.R.I.E.A.: www.criea.eu
[76] Ortianimati: www.ortianimati.com
[77] Resource Centres on Urban Agriculture and Food Security - RUAF: www.ruaf.org
[78] Consiglio d’Europa: www.coe.int
[79] Stati Generali della Green Economy: www.statigenerali.org
[80] Rivista Agriregionieuropa: www.agriregionieuropa.univpm.it
[81] Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA: www.
ispraambiente.gov.it
[82] Rete Rurale 2007 2013: www.reterurale.it
[83] Orti di Pace: www.ortidipace.org
23