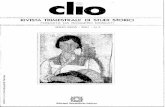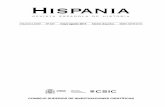Istanza etica e mito nella narrazione storica. Il caso dei fratelli Cervi
Il confino politico fascista tra discriminazione, esilio e contatto di culture. La narrazione...
Transcript of Il confino politico fascista tra discriminazione, esilio e contatto di culture. La narrazione...
Il confino politico fascista tra discriminazione,
esilio e contatto di culture. La narrazione
leviana come spunto di studio
FABIO ECCA
Il confino politico fascista1 rappresenta, probabilmente, una delle
esperienze più interessanti, per l’Italia del Ventesimo secolo, di esilio
e di viaggio. Si tratta di una misura punitiva che il regime
mussoliniano adottò nei confronti di numerosi oppositori: un vero e
proprio popolo2, trasferito coattamente, di perseguitati aderenti a ogni
ideologia, dai comunisti agli anarchici passando per i socialisti, i
giellisti, i popolari e i semplici antifascisti3. Condannati da uno a
cinque anni e allontanati dalla propria residenza per essere tradotti in
località «punitive», dove erano attentamente sorvegliati e isolati dal
resto della popolazione, gli oppositori politici maturarono durante il
ventennio esperienze di contatto e/o di conflitto fra culture diverse. Le
isole minori italiane, ad esempio Ponza, Ventotene, Ustica, Pantelleria
e le Tremiti, sono sicuramente le località di confino più conosciute,
1 È da ricordare che nel dopoguerra tale misura punitiva è stata abolita; tuttavia
è stato mantenuto il confino «comune», all'interno del «Testo unico di Pubblica
sicurezza» ereditato dal fascismo. Solo un lungo lavoro di riforma, iniziato negli anni
Cinquanta anche in base a sentenze della Corte Costituzionale, ha portato
successivamente all'abolizione totale del confino. 2 Tale definizione riprende quella usata nei cinque volumi editi dall’Archivio
Centrale dello Stato: ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, Il popolo al confino, Roma
1989-1994. 3 Per avere maggiori informazioni, si può consultare il prezioso strumento di
ricerca costituito dai volumi di A. DAL PONT e S. CAROLINI, L’Italia al confino. Le
ordinazioni di assegnazione al confino emesse dalle Commissioni provinciali dal
novembre 1926 al luglio 1943, La Pietra, Milano 1983.
555
anche perché da qui passarono moltissimi tra quelli che sarebbero stati
tra i protagonisti della storia dell’Italia repubblicana. Fra gli altri si
possono ricordare Sandro Pertini, Altiero Spinelli, Pietro Secchia,
Mauro Scoccimarro, Giorgio Amendola, Carlo Rosselli, Emilio Lussu
e Francesco Fausto Nitti. Ma molte altre località meno note sono state
sfruttate come luogo di confino: in particolare, quelle dell’entroterra
meridionale.
Fu in uno di questi paesi, ad Aliano (Gagliano nella finzione
letteraria) per l’esattezza, che venne ambientato il romanzo di Carlo
Levi Cristo si è fermato a Eboli4 da cui si è preso spunto per questa
ricerca. Questo libro rappresenta un esempio, una perfetta sintesi di
ciò che è stato il confino politico. Carlo Levi, giovane aderente a
Giustizia e libertà, fu arrestato e inviato dalla commissione provinciale
per l’ammonizione e il confino di Torino prima a Grassano e, quindi,
ad Aliano5. Qui conoscerà e svelerà quel Sud profondo e arretrato,
così diverso dal Nord industriale in cui aveva vissuto fino a quel
momento. Così tale opera letteraria di fatto sancirà la riscoperta, da
parte della classe intellettuale del Paese, dei problemi del Meridione,
tutt’altro che risolti, anzi forse amplificati, dal ventennio fascista.
Scriveva infatti lo stesso autore:
«noi non siamo cristiani», - essi dicono, [riferendosi ai contadini lucani,
ndr] - «Cristo si è fermato a Eboli» -. Cristiano vuol dire, nel loro
linguaggio, uomo […]. «Noi non siamo cristiani, non siamo uomini, non
4 Romanzo autobiografico, fu scritto tra il dicembre del 1943 e il luglio del 1944
a Firenze. Pubblicato per la prima volta da Einaudi nel 1945, ebbe subito un grande
successo e si conobbe in tutto il mondo. Già l’anno seguente ne uscì una seconda
edizione a cura della stessa casa editrice che ristamperà il volume anche nel 1947 e
nel 1963. In seguito sarà proposto in versione ridotta e rivisitata in numerose edizioni
scolastiche. Nel 1979 conoscerà anche il grande schermo, con la celebre versione
cinematografica a cura di Francesco Rosi. L’ultima edizione del volume è del 1994. 5 Sull’autore, come si potrà immaginare, esiste una vasta bibliografia dovuta
anche alla poliedricità dello stesso Carlo Levi, che fu apprezzato e conosciuto sia
come scrittore che come pittore. In particolare suggeriamo: G. RUSSO, Carlo Levi
segreto, Dalai Editore, Milano 2011 e i due tomi di D. SPERDUTO, Maestri futili?
Gabriele D’Annunzio, Carlo Levi, Cesare Pavese, Emanuele Severino, Aracne, Roma
2009 e ID., Armonie lontane, Aracne, Roma 2013.
556
siamo considerati come uomini, ma bestie, bestie da soma, e ancor
meno che le bestie […] perché noi dobbiamo invece subire il mondo dei
cristiani, che sono di là dall’orizzonte, e sopportarne il peso e il
confronto». Ma la frase ha un senso molto più profondo, che, come
sempre, nei modi simbolici, è quello letterale. Cristo si è davvero
fermato a Eboli, dove la strada e il treno abbandonano la costa di
Salerno e il mare, e si addentrano nelle desolate terre di Lucania.
«Cristo non è mai arrivato qui […]. Cristo è sceso nell’inferno
sotterraneo […]. Ma in questa terra oscura, […] Cristo non è disceso.
Cristo si è fermato a Eboli»6.
Si compie in questa maniera la denuncia all’opinione pubblica
dell’esistenza di due «Italie» diverse: due realtà quasi opposte tra loro.
Cristo si è fermato a Eboli riprende infatti un sillogismo lucano che
vuole sottolineare come la modernità e la civiltà, il «Cristo» del titolo,
si siano fermate in provincia di Salerno, a Eboli. Oltre questo
immaginario confine, esisteva il degrado e l’arretratezza di una società
quasi «primitiva». È in questa maniera, visto che anche Eboli fu
località di confino politico durante il ventennio fascista, che è sorta in
me l’idea di analizzare le diverse modalità di contatto che ebbero i
confinati, provenienti per lo più dalle regioni centro-settentrionali del
Paese, con queste due diverse località.
Ben ventinove persone vennero inviate nella cittadina
salernitana mentre quarantuno ad Aliano. Tutti questi settanta
perseguitati avevano in comune la solitudine: a differenza di chi
veniva inviato nelle isole minori italiane, dove si viveva insieme a
molti altri confinati, chi era mandato nell’entroterra doveva essere
isolato dalla popolazione locale e impossibilitato a stringere
qualsivoglia rapporto con gli eventuali altri confinati presenti.
Almeno in teoria. In pratica, la presenza di un confinato
rappresentava spesso elemento di ricchezza per il paese ospitante e
per i suoi abitanti. Chi vi veniva inviato era infatti costretto ad
affittare una casa, o quantomeno un locale dove abitare, e ad
acquistare quel poco di cibo necessario per sopravvivere. Tali spese
6 C. LEVI, Cristo si è fermato a Eboli, Einaudi, Torino 1994, pp. 3-4.
557
rappresentavano così una fonte di guadagno per la stessa località,
dove erano costretti a spendere. Altro elemento che accomunava
quasi tutti i confinati era quindi l’invio di richieste per ottenere un
sussidio economico7, un miglioramento dello stesso o capi vestiari.
Tuttavia, dall’analisi quantitativa e qualitativa delle missive emergono
le prime differenze tra Eboli e Aliano: dalla prima cittadina saranno
inviate «solo» diciotto domande per vestiti mentre ben ventiquattro da
Aliano e, per quanto riguarda il sussidio economico, alle autorità
competenti pervennero cinquantotto domande da Eboli e trentacinque
da Aliano. Una piccola grande ricchezza sarebbe stata spesa per cibo,
vestiti, medicine ma anche, soprattutto nel paese salernitano, per
investimenti.
Ciò che colpisce, tuttavia, è anche un altro dato: ciò che era
iniziato come un esilio forzato, si trasformava in alcuni casi in una
permanenza volontaria, complici anche le diverse condizioni socio-
ambientali, culturali ed economiche tra i due paesi. Come
testimonieranno i diversi confinati che rimarranno a Eboli anche dopo
la caduta del fascismo, in questa cittadina il clima e le condizioni di
vita erano effettivamente, come sembrava sostenere lo stesso
sillogismo Cristo si è fermato a Eboli, migliori rispetto a quelle di
altre realtà confinarie. La sua posizione ne faceva una cittadina salubre
e salutare, consigliata spesso esplicitamente per gli ammalati. Sia
Giovanni Marzoli che Ettore e Gino Silvestri8 domandavano ad
7 Il sussidio economico consisteva in un piccolo contributo che lo Stato versava
ad ogni confinato per il proprio mantenimento durante il periodo di condanna.
Inizialmente, nel 1926, la cifra era piuttosto consistente dato che prevedeva la
consegna di 20 lire giornaliere ma si ridusse quasi immediatamente fino a giungere,
già nella seconda metà degli anni Trenta, a 5 lire. Non si deve dimenticare, tuttavia,
che tale cifra serviva spesso anche per il mantenimento dei propri familiari, privati del
reddito paterno. 8 Nel caso di Silvestri Gino i documenti a lui inerenti sono stati distrutti durante
la seconda guerra mondiale, probabilmente a causa di un bombardamento. Se ne
ricostruisce comunque la biografia e si ritrovano numerose sue lettere in altri archivi
poi riversati in ACS e grazie alla fitta corrispondenza con il fratello Ettore. Per
ulteriori informazioni su Marzoli, ACS, Conf. Pol. Fasc. Pers. b. 636 f. Marzoli
Giovanni e ACS, CPC b. 3118 f. Marzoli Giovanni. Sui fratelli Silvestri invece ACS,
Conf. Pol. Fasc. Pers. b. 951 f. Silvestri Ettore e Silvestri Gino.
558
esempio il trasferimento indicando Eboli come la meta più ambita. In
particolare, nel caso dei due fratelli sopra menzionati assistiamo a una
vera e propria «chiamata»: Ettore fu il primo a giungere nella località
campana e, in seguito, avrebbe suggerito al fratello Gino di richiedere
lo stesso trasferimento. Non appagato, si adoperava inoltre per
facilitare questo ricongiungimento familiare: «Per ovviare a tale
disagio [si riferisce ad alcuni suoi problemi economici, ndr] […]
chiede che gli venga concessa al fratello celibe Gino Silvestri, anche
egli confinato a Pacentro (Aq) di risiedere col sottoscritto potendo in
tal modo riunire i rispettivi sussidi»9.
Furono invece le stesse autorità fasciste a richiedere il
cambiamento di destinazione per Carlo Giretti, ormai sessantenne e
malato di broncopolmonite, che era stato destinato in un primo
momento a Fabrizi (Aq), e a inviarlo a Eboli10
. Simili casi
riguarderanno anche Eugenio Baldassarri, confinato a Genzano (Rm) e
quivi trasferito, e Antonio Genta, ammalatosi di TBC a Buccino (Sa).
A proposito di quest’ultimo, in un documento della Prefettura di
Salerno si legge: «si trasmette, inoltre, altra istanza del Genta tendente
a essere trasferito in una località dal clima meno umido e meno alto
[…]. Propongo che il Genta sia trasferito a Eboli»11
. Un caso del tutto
peculiare sarà quello di Dino Philipson12
che chiese il prolungamento
del proprio soggiorno a Eboli e la sospensione del proprio
trasferimento a Lanciano (Ch). Tale richiesta sarebbe stata però
respinta in quanto si era appurato che egli si accompagnava spesso
9 ACS, Conf. Pol. Fasc. Pers. b. 951 f. Silvestri Gino (Fi) lettera all’On.
Ministero Interni del 28.6.1940. 10 ACS, Conf. Pol. Fasc. Pers. b. 489 f. Giretti Carlo (To) documento della
Questura di Catanzaro div. PS n. prot. 012363 del 7 novembre 1941. 11 ACS, Conf. Pol. Fasc. Pers. b. 466 f. Genta Antonio (Sv) documento della
Regia Prefettura di Salerno div. Gab, n. prot. 02311 del 2 luglio 1939. 12 Si tratta di una personalità di tutto rilievo: massone di origine ebraica, gestisce
l’azienda di famiglia ed esercita la professione di avvocato. Eletto deputato per il
Partito Liberale nel 1919, sarà uno dei più ricchi proprietari terrieri del pistoiese.
Inizialmente di simpatie fasciste, aderisce al movimento antifascista e per questo
confinato. Liberato, farà parte del governo Badoglio come Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio. Poi consultore nazionale.
559
con ufficiali tedeschi, con i quali aveva familiarizzato, e vantava altre
buone amicizie nel paese13
. Aveva inoltre contribuito alla potenziale
ricchezza della località decidendo di fare qui un discreto investimento,
acquistando vasti terreni agricoli e da allevamento.
Per quanto invece riguarda Aliano, troviamo numerosi casi
opposti: mentre Eboli esercitò un ruolo «attrattivo», la località lucana
fu «repulsiva». Domenico Migone e Corrado Rossi14
, ad esempio,
fecero esplicita richiesta di trasferimento lontano dalla cittadina
lucana. Scriveva il Migone che:
mi sento tuttora ammalato perche laria15
[sic!] di questo paese mi fa
molto male mi trovo pure in gravi disagi perche [sic!] […] io non
mangio tutti i giorni. […] voglio quindi cambiare di paese, anche perche
[sic!] in questo paese la vita costa molto cara, invece per esempio nel
paese di Santarcangelo [paese in provincia di Matera, ndr] sarebbe
molto più economico»16
. Corrado Rossi era malato invece di gengivite
tanto da dire che «mi si confiano [sic!] spesso le gengive e mi vengono
dei dolori insopportabili ai denti […].
Dovendo per questo essere seguito costantemente da un dentista,
assente ad Aliano, richiedeva il proprio trasferimento in una località
dotata di presidio medico, come i vicini paesi di Stigliano (Mt) e
Accettura (Mt)17
. Lo stesso Levi, che fu anche un medico, ci
testimonia, nel suo Cristo si è fermato a Eboli, di non aver avuto vita
facile perché era al centro di profonde gelosie e acredini. Sollecitato
13 ACS, Conf. Pol. Fasc. Pers. b. 788 f. Philipson Dino (Fi) documento della
Regia Prefettura di Salerno n. 01730 di prot. PS del 21 luglio 1943. 14 ACS, Conf. Pol. Fasc. Pers. b. 669 f. Migone Domenico e ACS, Conf. Pol.
Fasc. Pers. b. 885 f. Rossi Corrado 15 Si noti che molti confinati non avevano un elevato livello di cultura. Spesso si
trattava invece di analfabeti o semi-analfabeti. Non deve perciò stupire la presenza
così diffusa di errori grammaticali nelle loro lettere. 16 ACS, Conf. Pol. Fasc. Pers. b. 669 f. Migone Domenico (Ge) lettera
protocollata dal Min. Int. Dir. Gen. PS, div. Affari generali, sez I confino n. prot.
793/9272 del 8 giugno 1935. 17 ACS, Conf. Pol. Fasc. Pers. b. 885 f. Rossi Corrado (Na) documento della
Regia Prefettura di Matera, Divisione Gab. PS n. di prot. 1632 del 24 ottobre 1938.
560
dalla fiducia che sembrava ricevere dalla popolazione locale, esercitò
questo mestiere, ma fu vittima dell’invidia degli altri medici che lo
denunciarono18
. Numerosi sono i casi di confinati ad Aliano che
chiesero il trasferimento in un’isola: «il sottoscritto», scrisse Ernesto
Cassani, «chiede che sia fatto il possibile di essere mandato in un’isola
[…]. Se il sottoscritto deve rimanere ad Aliano, è come condannarlo
alla prigione nuovamente»19
. Anche la moglie di Andrea Colucci
chiese il trasferimento del marito da Aliano per motivi di salute e, tra
le località indicate, menzionò Eboli:
La sottoscritta […] prega fervidamente cotesto On. Ministero perché in
primo luogo disponga la concessione del domandato trasferimento […]
in un qualsiasi altro paese avente un clima mite, preferibilmente qualche
comune del Salernitano (Vietri sul mare, Eboli, Sala Consilina, etc.)
stante la sua documentata infermità di non poter vivere in un Comune
come Aliano20
.
Se per Eboli si può effettivamente parlare di incontro, inteso nella
specie come dialogo, tra culture diverse, per Aliano si può – non si sa
quanto estremizzando – parlare piuttosto di una più accesa
conflittualità. Non che il confinato non rappresentasse anche nella
cittadina lucana una fonte di ricchezza, ma tale elemento era come
«limitato» dal contesto socio-culturale locale. I vantaggi economici
portati dalla presenza di tali perseguitati politici non venivano infatti
distribuiti tra la popolazione ma spartiti dal «potentato» locale. Dove
questo – come nel caso dei medici – vedeva minacciati i propri
interessi privati, si adoperava per allontanare e/o penalizzare il
responsabile di tale «pericolo».
18 ACS, Conf. Pol. Fasc. Pers. b. 565 f. Levi Carlo (To) documento della Regia
Prefettura di Matera. Dir. Gen. Di PS. Sez. I confino, n. prot. 793/21422 dell’8
dicembre 1935. 19 ACS, Conf. Pol. Fasc. Pers. b. 216 f. Cassani Ernesto (Bo) lettera non
protocollata. 20 ACS, Conf. Pol. Fasc. Pers. b. 271 f. Colucci Andrea (Fg) documento della
Direzione Generale della PS, div. Affari Generale, Sez I confino n. prot. 79/9393
dell’11.5.1940.
561
Parimenti si verificarono anche molti casi in cui i perseguitati
richiesero il permesso per uscire dalla località di confino o in cui si
fecero raggiungere dai propri familiari. Erano diverse le motivazioni
per le quali il regime poteva autorizzare la visita dei familiari ma in
ogni caso era prevista l’eccezionalità della richiesta e la provvisorietà
del permesso. Ciò nonostante non furono poche tali richieste: a Eboli
le domande per farsi raggiungere da un parente furono ventisette, di
cui la maggior parte (venti) ricevette risposta positiva21
. Delle dodici
lettere provenienti da Aliano, invece, solamente la metà (sei) fu
accolta mentre due furono respinte e di quattro non se ne sa il
risultato. Si conferma così il ruolo «attrattivo» della prima cittadina e
quello «repulsivo» della seconda, vista la media di una lettera per ogni
confinato della cittadina campana mentre invece neanche un
perseguitato su tre, tra quelli presenti ad Aliano, scrisse missive aventi
questo oggetto. Ma tali dati portano a prendere in considerazione
anche un altro elemento: uno dei motivi per i quali si chiedeva il
«ricongiungimento familiare» era legato allo stato economico della
famiglia del confinato. Così, ad esempio, la moglie di Giuseppe
Bilanzuoli chiese l’autorizzazione per poter raggiungere il proprio
marito poiché essa, che «nulla possiede all’infuori delle proprie
braccia»22
, non era più in grado di provvedere al mantenimento dei
due figli. Decidere di raggiungere il proprio familiare al confino e di
vivere con lui per tutto il resto della condanna diveniva così una
soluzione pratica per poter sopravvivere perché permetteva la
condivisione di alcune spese, come l’alimentazione e la casa, e faceva
crescere la speranza di poter trovare un lavoro. Naturalmente, non tutti
potevano raggiungere il proprio parente: le autorità fasciste, infatti,
provvedevano a indagare non solo sull’effettiva necessità del
richiedente ma anche sugli stessi richiedenti per capire se questi
svolgessero attività contrarie al regime. Alla sorella e al cognato del
Morucci, che chiesero l’autorizzazione per raggiungerlo
temporaneamente a Eboli, non venne rilasciato il permesso il viaggio
21 Delle altre sette, solo una fu negativa mentre ben sei rimasero inevase. 22 ACS, Conf. Pol. Fasc. Pers. b. 115 f. Bilanzuoli Giuseppe (Ba) lettera n. prot.
793/30790.
562
perché la prima «è dedita alla prostituzione clandestina» e il secondo è
pregiudicato per furto e borseggio23
. Questa selezione, che poteva
essere sia di natura «politica» che «etica», delle persone autorizzate a
permanere nelle località di confino incideva anche sulle modalità di
relazione che si vennero a creare tra confinati e popolazione locale. La
pretesa delle autorità mussoliniane di non voler «contaminare» con
idee politiche e morali quella popolazione venne così pienamente
disattesa. Si pensi ad esempio allo scandalo che destò Eboli quando si
seppe che era stata l’amante a chiedere il ricongiungimento con
Ignazio Giove24
. Né deve tantomeno stupire che molti di questi
confinati furono promotori dell’attività politica contraria al regime
svolta nella stessa sede di confino. Per alcuni dei giovani abitanti
locali sarà proprio quest’esperienza a introdurli all’impegno sociale
nel dopoguerra. È il caso, fra gli altri, dello stesso Dino Philipson che
svolse tale attività a Eboli, dove ancora oggi è ricordato anche per
questo motivo.
Non sempre però la permanenza al confino era pacifica. Alcuni
confinati vennero infatti arrestati per aver contravvenuto alle regole
del regime confinario. Ad Aliano, ad esempio, su quarantuno persone
ospitate, ben otto furono fermate durante la loro permanenza nella
località lucana. Tale dato parrebbe smentire ciò che invece numerose
testimonianze asseriscono sul podestà, descritto come una persona «in
fin dei conti “buona” e “per niente severa”»25
. Tuttavia, studiando le
motivazioni per le quali si compirono questi arresti, emerge che la
trasgressione più diffusa era l’infrazione del coprifuoco (che iniziava
con il calar delle tenebre) e il contatto con la popolazione locale: è ciò
che accadde a Giuseppe Bilanzuoli, incarcerato a Stigliano (Mt)26
, e a
23 ACS, Conf. Pol. Fasc. Pers. b. 694 f. Morucci Umberto (Rm) relazione della
Regia Questura di Roma, div. Gab, n. 013063 AS del 5 giugno 1941. 24 ACS, Conf. Pol. Fasc. Pers. b. 488 f. Giove Ignazio (Pa) lettera del 29 maggio
1941 al Min. Interno, alla segreteria di S.E. il Capo della Polizia n. prot. 793/7039. 25 Testimonianza raccolta ad Aliano il 28.2.2008 a casa di Bruno Garambone,
nipote del podestà che governò Aliano. 26 (ACS, CPC b. 648 f. Bilanzuoli Giuseppe (Ba) documento della Regia
Prefettura di Matera, Divisione P.S., n. prot. 399 del 7 ottobre 1940).
563
Vittorio Trimboli27
. In alcuni casi poteva anche accadere che al
provvedimento di reclusione si sommasse un successivo trasferimento.
Ernesto Cassani, per esempio, venne arrestato al confino almeno due
volte: la prima nell’aprile 1937 quando fu rinchiuso nel carcere di
Bernalda (Mt) per sei mesi. Liberato e inviato ad Aliano, qui si rese
responsabile di altre contravvenzioni sicché la Regia Prefettura di
Matera scrisse che «il Cassani è elemento intollerante della disciplina
che quale confinato deve osservare». Sembrava infatti che il Cassani
avesse scritto in una sua lettera che «il sottoscritto rischia di non fare
più i quindici mesi di confino che gli restano a scontare». Immediata
fu la risposta delle autorità: «attraverso i necessari, accurati
interrogatori del Podestà e dell’Arma di Aliano [il Cassetti, ndr] ha
resa manifesta la scarsa volontà di osservare gli obblighi di confino,
non senza lasciare intravedere […] un possibile tentativo di
allontanamento dal luogo della coattiva dimora»28
. In tali casi
possiamo addirittura affermare che il trasferimento ad Aliano era
considerato dal regime come un ulteriore elemento di punizione.
Anche il caso di Spartaco Ieropoli è, da questo punto di vista,
significativo: arrestato al confino a Miglionico, in provincia di Matera,
a seguito della delazione della moglie di un altro confinato, egli scontò
tre mesi in carcere con l’accusa di offesa al Capo del Governo.
Liberato, fu inviato ad Aliano29
. Parimenti, anche Aldo Leonelli fu
arrestato ad Aliano per contravvenzione agli obblighi di confino e,
scontati tre mesi di carcere, fu inviato a Stigliano e la sorella, che lo
aveva raggiunto poco tempo prima e con cui esso viveva, allontanata
dal familiare30
. Parzialmente diverso è il caso di Domenico Migone,
27 Condannato prima dell’assegnazione al confino, il 24 luglio 1938, veniva
incarcerato per sei mesi a Stigliano (ACS, Conf. Pol. Fasc. Pers. b. 1025 f. Trimboli
Vittorio (Rc) documento della Regia Prefettura di Matera div. P.S. n. prot. 242 del 9
agosto 1938). 28 ACS, Conf. Pol. Fasc. Pers. b. 216 f. Cassani Ernesto (Bo) documento della
Regia Prefettura di Matera, divisione P.S. n. prot. 981 del 3 settembre 1937. 29 ACS, Conf. Pol. Fasc. Pers. b. 530 f. Ieropoli Spartaco documento della
Regia prefettura di Matera, div. Gab. P.S. n. prot. 2791 del 29 agosto 1940. 30 ACS, Conf. Pol. Fasc. Pers. b. 563 f. Leonelli Aldo (Li) documento della R.
Prefettura di Matera, div. PS n. di prot. 2384 del 13 aprile 1938.
564
arrestato una prima volta ad Aliano il 18 giugno 1935, e in seguito
nuovamente fermato, con l’accusa di ubriachezza abituale e atti
osceni, e condannato a ventiquattro giorni di arresto nel carcere di
Stigliano e al pagamento di milleduecento lire di multa che, non
essendo in grado di pagare, fu commutata in ulteriori ventiquattro
giorni di arresto. Descritto dalla Regia Prefettura di Matera come un
perenne ubriaco, fu arrestato una terza volta in quanto, sotto l’effetto
dell’alcol, aveva oltraggiato il papa e detto che «Mussolini vuole
affogare l’Italia, io sono capace di affogare lui!»31
. Anche Giovanni
Vittone venne arrestato più volte: inizialmente segnalato per cattiva
condotta mentre era confinato a Stigliano, se ne chiedeva il
trasferimento ad Aliano dove venne ben presto accusato di offese alle
autorità. Si legge infatti nelle carte della Regia Prefettura di Matera
che:
anche qui il Vittone ha subito dato luogo a rilievi con il suo
comportamento ed, il 19 andante [19 aprile 1937, ndr] è stato tratto in
arresto per trasgressione agli obblighi di confino. […] La sera del 13
andante il podestà di Aliano richiamò, nel suo gabinetto, il confinato
politico Vittone Giovanni Battista di Luigi perché passeggiava in quella
via Roma in compagnia del figlio del confinato politico Babbini Mario,
e lo diffidò a non accompagnarsi più al ragazzo […]. Il Vittone, in tono
tutt’altro che remissivo, così rispose al podestà: “noi confinati veniamo
mandati in questi piccoli comuni, perché vi mancano delle industrie e
così non si ha modo di fare propaganda; e la propaganda vale più di una
schioppettata. Conducevo il bambino a casa mia per dargli da mangiare,
siccome non è giusto che debba morire di fame”. Il Vittone è smodato
nel bere […]32
.
31 ACS, Conf. Pol. Fasc. Pers. b. 669 f. Migone Domenico (Ge) documento
della Regia Prefettura di Matera, Divisione Gab. PS n. di prot. 558 del 1 febbraio
1936 e documento della Regia Prefettura di Genova, Divisione Gab. PS n. di prot.
1016284 del 30 novembre 1936 32 ACS, Conf. Pol. Fasc. Pers. b. 1074 f. Vittone Giovanni (To) relazione della
Regia Prefettura di Matera, div. PS, n. prot. 687 del 22 aprile 1937.
565
L’ultimo caso è infine quello di Mario Babbini contro il quale,
pur non procedendo all’arresto, vennero scritte molte relazioni
negative in cui si asseriva che egli, ad Aliano, si ubriacava spesso e,
«pur non dando luogo a rilievi colla condotta politica, non dà prova di
volersi ravvedere. Vive in ozio, col sussidio giornaliero, ostentando di
trovarsi a suo agio in sede di confino»33
.
Nel caso degli inviati a Eboli, invece, non si annoverano casi di
arresto ma si trovano due persone che, terminato il periodo di pena,
fecero domanda per poter risiedere in modo permanente nel comune
campano. Si tratta di Ettore Silvestri, che venne liberato dal confino in
occasione del ventennale (1942). Stando a quanto stabiliva il
regolamento, egli doveva ritornare a Genova, dove sarebbe stato
sottoposto a vigilanza. I bombardamenti alleati, però, avevano
distrutto la sua casa ligure e, trovandosi momentaneamente senza
dimora, il Silvestri chiese di poter rimanere nella cittadina
salernitana34
. Invece, Eugenio Baldassarri era riuscito, durante la sua
pena, a procurarsi alcuni contratti di lavoro che non voleva disattende-
re e, per questo, era deciso a rimanere35
.
In conclusione possiamo sostenere che il confino politico, che
interessò tra il 1926 e il 1943 tra le 12.000 e le 18.000 persone36
, fu un
terribile strumento punitivo ma, allo stesso tempo, dette anche modo a
molti perseguitati di incontrare e confrontarsi con culture diverse.
Seppur obbligati, gli uomini e le donne che vissero questa esperienza
di viaggio poterono apprendere sulla loro pelle la complessità della
realtà meridionale. Quello qui proposto è un piccolo contributo che
risente indubbiamente dei vincoli di spazio: uno spunto di studio,
33 ACS, Conf. Pol. Fasc. Pers. b. 46 f. Babbini Mario (Ms) relazione trimestrale
della Regia Prefettura di Matera n. prot. 01474 del 6.10.1937. Simili osservazioni si
ritrovano anche nella relazione trimestrale n. 01472 del 5.1.1938. 34 La domanda veniva accolta e la famiglia Silvestri si stabiliva quindi nella
sede di confino (ACS, Conf. Pol. Fasc. Pers. b. 951 f. Silvestri Ettore (Fi) lettera del
25.111942 all’On. Ministero degli Interni). 35 ACS, Conf. Pol. Fasc. Pers. b. 53 f. Baldassarri Eugenio (Mc) documento
della Regia Prefettura di Salerno n. 0424 di prot. PS del 2 dicembre 1942. 36 L. MUSCI, Il confino fascista di polizia: l’apparato statale di fronte al
dissenso politico e sociale, in A. DAL PONT e S. CAROLINI, op. cit., p. 7.
566
frutto di anni di ricerche su questo tema che rimane però, nonostante
gli sforzi compiuti, ancora largamente da scoprire. Ricostruire le
molteplici esperienze confinarie e capire come e in che misura queste
furono elemento formativo per la futura classe dirigente sono sfide
possibili e interessanti.
567