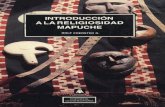GUINEA-BISSAU E ISOLE DI CAPO VERDE: PARTECIPAZIONE FEMMINILE ALLA LOTTA POLITICA
I mapuche: una etnia sempre in lotta
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of I mapuche: una etnia sempre in lotta
Alberto Trivero
I MAPUCHE: UNA ETNIA SEMPRE IN LOTTA
1. La nazione mapuche: storia di una resistenza
Quando nel XVI secolo gli Spagnoli invasero le Americhe, bastarono pochi an-ni e un limitato numero di soldati per abbattere con incredibile facilità grandi im-peri e storiche civiltà. Questa incapacità delle grandi cultura americane per affron-tare lo scontro militare con le truppe iberiche ha stupito da sempre gli storici e gli antropologi, che hanno dato interpretazioni diverse a questo fenomeno, spesso tra loro in contrasto. Il crollo dei popoli indoamericani davanti alla Conquista castel-lana presenta tuttavia una importante eccezione: la “nazione” mapuche, nel sud del Cile. Questo popolo, infatti, fu l’unico che seppe resistere con successo alle truppe ispaniche sin dai primi decenni del XVI secolo.
All’indomani dell’insediamento degli eserciti coloniali spagnoli in Cile (1536-1541), vittorie e sconfitte, inattese queste ultime per gli iberici, si alternano per en-trambi i fronti. Nel 1541 le truppe di Michimalonko distruggono la città di San-tiago, appena fondata, e nel 1554 lo stesso conquistador Pedro de Valdivia viene vinto ed ucciso da un esercito mapuche al comando di Leftraru1 e di Kolokolo. Leftraru volle muovere verso il nord, anzitutto per distruggere definitivamente Santiago e le altre città spagnole del Cile, ma anche poiché riteneva che bisognas-se cacciare gli spagnoli non solo dal Cile, ma anche dal Perù (e forse aveva contat-ti con emissari di quanto restava dell’impero incaico): tuttavia i mapuche non vol-lero accompagnarlo in una spedizione così lontana dai loro territori e lo abbando-narono. Gli spagnoli poterono così catturarlo: lo uccisero con i più atroci supplizi. Quindi ripresero la conquista del territorio mapuche, ora con apparente successo, creando numerosi forti e fondando città. Seppure grave, la sconfitta di Pedro de Valdivia parve essere solo un episodio isolato della conquista del Cile.
Tuttavia nel 1598 si produce una ribellione generale di tutti i clan mapuche, i quali, a Curalaba, sconfiggono ed uccidono anche lo stesso Governatore Generale, Oñez de Loyola.
1Leftraru, in spagnolo Lautaro, è una tra le figure storiche amerindie che ha maggiormente ispirato i movimenti libertari dell’America latina. Abbiamo scritto i nomi dei personaggi coerentemente al-la grafia della lingua mapudungún. Per maggiore chiarezza, riportiamo tra parentesi la grafia spa-gnola: Kolokolo (Colo-colo, che ha dato il nome ad una tra le più popolari squadre del futbol cile-no), Keupulikan (Caupolicán), Pelantraru (Pelantaro). Tutti questi eroi della Nazione mapuche mantengono un rilievo grandissimo nella memoria cilena, non solo in seno alla popolazione indi-gena, ma anche a quella di origine spagnola.
3
Fig. 2. Il ñidol toki Kolokolo. Fig. 3. Külapan. Fig. 4. Kallfükura.
Dapprima guidati dal ñidol toki2 Keupulikan e poi, dopo la sua morte, da Pe-
lantraru, in sette anni i mapuche conquistano e distruggono tutte le città fondate dagli spagnoli nel Cile meridionale e recuperano la loro libertà e la loro indipen-denza politica. Per gli spagnoli questa rappresenta la prima e l’unica reale sconfit-ta sostanziale e irreversibile subita nelle Indie, come ancora venivano chiamate. Fu così sconvolgente per la cultura iberica che i mapuche - che gli spagnoli chia-mavano Araucani - ispirarono tutti i principali poemi epici della loro letteratura, primo fra tutti “La Araucana”, di Alonso de Ercilla y Zúñiga, il capolavoro poetico del barocco castigliano.
Riconquistare la loro libertà costò ai mapuche circa 500.000 morti, ovvero un terzo di tutta la loro popolazione adulta. Caso unico nelle Americhe, non combat-terono solamente i guerrieri, ma anche i bambini e, talvolta, persino le donne. Una armata di bambini tra i 10 ed i 14 anni terrorizzò le truppe spagnole accampate a sud del Bío-bío, il fiume che si trasformò nella frontiera tra il territorio coloniale spagnolo e quello mapuche.
Durante tutta la prima metà del XVII secolo si impegnarono a fondo per con-quistare l’unico territorio delle Americhe ancora indipendente e ribelle. Per recu-perare i territori perduti, non esitarono ad impegnare gli eserciti ormai “disoccupa-ti” del Perù e del Messico: tuttavia ogni tentativo fallì. Numerose tra le massime autorità coloniale - governatori e condottieri spagnoli - morirono in guerra o furo-
2I mapuche non avevano (e tuttora non hanno) un sistema gerarchico di governo. Essi si suddivido-no in numerosissimi clan, su base familiare e totemica, ognuno dei quali al suo vertice ha il lonko, una sorta di giudice il cui potere, in linea di principio ereditario, si basa sulla autorevolezza ed è comunque piuttosto limitato, corrispondendo sostanzialmente a quello di un giudice. In tempo di guerra, il lonko assumeva la denominazione di toki (questo termine indica una ascia di pietra levi-gata e forata che portavano al collo), e in casi eccezionali, tutti i clan eleggevano un condottiero massimo, chiamato ñidol toki, per tutta la durata della guerra.
4
no fatti prigionieri. Dopo 91 anni di guerra ininterrotta, nel 1641 - e questa è la prima volta - la Corona spagnola prende atto che un popolo amerindio, a torto ri-tenuto marginale3, aveva sconfitto irrimediabilmente tutti gli eserciti che avevano mosso alla conquista del Mapu4. Il 6 gennaio 1641 a Quilín le massime autorità coloniali si incontrano con i principali toki e firmano un trattato di pace, dove si produce il reciproco riconoscimento e si stabilisce che il fiume Bío-bío avrebbe costituito la frontiera tra la nazione castigliana e quella mapuche.
Tuttavia gli anni della Colonia corrispondo ad un periodo dove i momenti di guerra si alternano a quelli di relativa pace. Questa situazione di belligeranza non dichiarata si conclude solamente alla fine del secolo XVIII, con la conferma da parte della Corona spagnola del riconoscimento dell’indipendenza mapuche e del fiume Bío-bío quale frontiera tra le due nazioni, con il reciproco scambio di amba-sciatori permanenti e con l’impegno dei mapuche di essere alleati dei Re di Spa-gna. I mapuche riuscirono a conservare la loro indipendenza sino agli ultimi de-cenni del secolo scorso.
E’ così che la nazione mapuche, oggi costituita da circa 1.500.000 persone qua-si tutte residenti in Cile dove costituiscono circa il 12% della popolazione5, rap-presentò l’unico popolo amerindio che seppe opporsi con successo alla conquista spagnola. Gli spagnoli morti nel tentativo di conquistare il territorio mapuche, rappresentano circa il 95% delle perdite subite da questi durante tutte le guerre co-loniali, sicché il territorio mapuche venne definito “cementerio de los castella-nos”.
2. La cultura mapuche La vita dei mapuche era povera e semplice, ma non selvaggia. Essenzialmente
sedentari, avevano la loro principale forma di sostentamento nella raccolta dei molluschi e dei frutti selvatici. Una agricoltura primitiva (patate, fagioli e mais) forniva una integrazione alla dieta quotidiana. I campi venivano ottenuti bruciando un tratto di bosco e quindi disboscandolo: la stessa cenere costituiva un buon ferti-lizzante. La ceramica era semplice e funzionale, ma non priva di elementi decora-tivi di buona fattura. Possedevano anche alcuni animali domestici - soprattutto il guanaco ed un tipo di gallinaceo ora scomparso e, occasionalmente, anche il cane - ma erano molto rari e, almeno per quanto concerne i camelidi, in possesso sola-mente delle persone più importanti: lonko, machi e ngenpin.
3Tuttavia già nel secolo XV i mapuche avevano sconfitto definitivamente gli Incas ed avevano bloccato la loro espansione verso le regioni meridionali. 4Mapu, in mapudungún, significa “terra”, ma anche “nazione”. Mapuche, pertanto, significa “po-polo della terra” (che signica uomo, e la desinenza -che sta ad indicare un popolo) e mapudungún “lingua della terra”. 5Una recente indagine clinica basata sui gruppi sanguigni e su altri aspetti, ha dimostrato che oltre il 50% della popolazione cilena è di origine prevalentemente indigena.
5
Fig. 5. Le bandiere dei principali gruppi che costituiscono la Nazione mapuche.
La nazione mapuche è sostanzialmente unitaria, sebbene essi si suddividano in
numerosi sottogruppi. Questi, tuttavia, non costituiscono delle diversità etniche, ma semplicemente delle suddivisioni basate dalla diversità geografica dell’area in cui vivono: williche (mapuche del sud), pewenche (mapuche della Cordigliera an-dina), lafkenche (mapuche del litorale), ecc.
Fig. 6. Donna mapuche davanti alla sua ruka intenta a tessere con il witral, il telaio orizzontale.
6
Fig. 7. Donna mapuche con i suoi tipici monili d’argento: la trapelakucha (pettorale), il tupu (spillone), i chaway (orecchini) ed il trarilonko (fascia frontale).
Fig. 8. Donne mapuche con il vestito tradizio-nale: si notino il trariwe (cinturone) tessuto al telaio e ricco di simbologia correlata alla ferti-lità ed alla femminilità.
Era molto diffusa la tessitura: con telai orizzontali di grandi dimensioni realiz-
zavano coperte, mantelli e poncho, mentre con quelli verticali, assai più piccoli, tessevano fasce per cingere i fianchi e la fronte. La donna vestiva una sorta di lun-ga tunica grezza e priva di decorazioni, annodata sulla spalla destra, in modo tale da lasciare libero e scoperto il braccio: una fascia coloratissima e dai disegni sim-bolici, il trariwe, le cingeva i fianchi; un mantello copriva le sue spalle. L’uomo indossava un tessuto triangolare a modo di ciripà ed un ampio poncho con decora-zioni geometriche che simboleggiavano la posizione sociale dello stesso in seno al clan. Uomini e donne cingevano la loro fronte con una stretta fascia tessuta, il tra-rilonko, e le donne portavano grandi orecchini di legno o di osso alle loro orec-chie, i chaway.
La capanna mapuche, la ruka, poteva essere tanto rettangolare quanto ovale, e spesso aveva grandi dimensioni. Veniva realizzata con una struttura portante di tronchi sottili e di rami e tanto il tetto quanto le pareti erano rivestiti di mannelli di paglia. Un ampio foro sulla sommità di una parete permetteva al fumo del focolare sempre acceso di uscire dalla capanna. Il fuoco, poi, non serviva solamente per ri-scaldare l’abitazione, ma anche e soprattutto per affumicare molluschi e pesci, co-sì da garantirne una lunga conservazione. Essi venivano appesi su un traliccio di-sposto al di sopra del focolare, costituito da un cerchio di grosse pietre, il fogón, sulle quali la famiglia sedeva a mangiare e a chiacchierare.
8
Ma è la religione a rappresentare l’aspetto più sostanziale della cultura mapu-che, una religiosità fondata sul culto degli spiriti ancestrali. Essi non rappresenta-no delle vere e proprie divinità, così come le intende la cultura occidentale, anche se generalmente la parola “Ngenechén” viene tradotta come “Dio”: questa inter-pretazione, tuttavia, è una forzatura che risale all’attività di conversione religiosa praticata dai Gesuiti tra il XVII ed il XVIII secolo, quando per rendere più com-prensibile (ed accettabile) il cristianesimo alle popolazioni mapuche, i missionari tentarono di ricondurre ad un linguaggio biblico un pensiero che, invece, se ne di-scosta profondamente.
Il pensiero religioso mapuche, nella sua versione più originale e quindi non in-fluenzata dal pensiero cristiano, può essere schematizzato nel modo seguente. A est esiste il mondo del bene, wenumapu, e a ovest quello del male, minchemapu. L’umanità, che, ma anche gli spiriti degli antenati, pillán, partecipano di entrambi i mondi, mantenendo l’equilibrio tra il bene ed il male. Vi sono degli spiriti mali-gni, chiamati wekufe o demoni, ma anche i pillán possono spesso agire come we-kufe, senza per questo convertirsi in demoni. Infine vi sono i ngen, ovvero gli spi-riti ancestrali primordiali che governano tanto i pillán, così come ogni altra cosa. La parola ngen è sostantivo e indica l’essenza di qualcosa, ma è anche desinenza (-nge) e precisa un modo di essere o una sua qualità del termine al quale è aggiun-ta; essa, infine, è anche verbo e in quest’ultimo caso assume il doppio significato di “essere” e di “generare”. Ngen, quindi, può anche essere tradotto come “ciò che è” ed esprime un senso di eternità.
Il ngen, dunque, rappresenta l’anima universale del mondo, tanto animato come inanimato, ovvero la “madre natura”. Lo scopo ultimo dell’essere umano è quello di percorrere una strada che gli permetta di acquisire la conoscenza e consapevo-lezza del suo essere, filew, grazie al rispetto dei principi fondamentali e della tra-dizione, admapu, divenendo così un pillán alla conclusione della sua vita terrena. Non esiste, dunque, una separazione assoluta tra spirito divino ed essere umano, non solo in quanto i secondi sono stati generati dai primi, ma anche perché, al termine di un lunghissimo percorso di crescita nel wenumapu, sono destinati a di-ventare essi stessi dei pillán. Da qui l’importanza centrale che assume il rispetto per i genitori e per i nonni all’interno del nucleo familiare mapuche-huilliche, primo tra tutti i doveri propri dell’admapu, rispetto e obbedienza che deve essere prioritaria su qualunque altra cosa.
Ma questo dovere non è a senso unico: l’anima di un essere umano, infatti, può convertirsi in pillán solamente se vi sono dei discendenti che possano onorarne la memoria. Avere dei figli e dedicare ad essi tutti i propri sforzi affinché a loro volta possano avere altri figli rappresenta lo scopo primordiale dell’esistenza di ogni es-sere umano. Questa assoluta centralità del rapporto famigliare era stata percepita ed apprezzata dai missionari gesuiti del XVII e XVIII secolo, che avevano studiato il modo di pensare mapuche senza le preclusioni e le chiusure ideologiche dei sa-cerdoti che li avevano preceduti. Non avere discendenza è il più grande dramma di un essere umano, perché in questo caso viene preclusa alla sua anima la possibilità di accedere al wenumapu e di iniziare quel percorso lunghissimo al termine del quale farà parte del mondo dei pillán.
9
La religiosità mapuche non si esprime per mezzo di templi o altre costruzioni, ma, al contrario, per mezzo di un intimo contatto con la natura: una radura tra gli alberi è il loro tempio più sacro e l’unica costruzione sacra che concepiscono è una sorta di scala ricavata scavando pochi alti gradini in un grosso tronco di cane-lo: il rewe. E’ soprattutto nel disegno riportato sul kultrun, il tamburo usato dai ngenpin e dai machi, che viene simbolizzata la loro concezione del sacro, ma an-che nelle decorazioni dei trariwe e dei poncho e nelle statue di legno dei loro ci-miteri, i mamülche.
Infine vi sono alcuni uomini (anticamente solamente maschi che indossano ve-sti femminili, in epoca successiva anche donne, e ora soprattutto donne) possiedo-no doni e doti particolari che li mettono in condizione di interpretare la volontà degli spiriti e di intermediare tra questi e gli altri uomini: sono i ngenpin, veri e propri sacerdoti, ed i machi, sciamani e medici alla volta che esercitano la magia bianca. Ma ve ne sono altri che, al contrario, si sono dedicati alle forze del male: essi sono i kalku, fattucchieri malvagi al servizio dei wekufe.
Gli spiriti ancestrali, e in modo particolare i pillán, intervengono nei confronti del mondo e degli esseri umani per mezzo del dominio sulle forze naturali, ma an-che ricorrendo all’aiuto di wekufe e di esseri viventi mitici con forme diverse. Essi premiano con i doni della natura la fedeltà all’admapu, ma castigano con la sicci-tà, le inondazioni, i terremoti, le tempeste, o anche in maniera più diretta, ogni al-lontanamento dalle tradizioni ancestrali. La celebrazione del nguillatún rappresen-ta il momento fondamentale della vita religiosa comunitaria del popolo mapuche.
Fig. 11. Rappresentazione schematica della religiosità mapuche.
10
Per i mapuche la terra è stata creata dalla prima donna, uno spirito ancestrale6 convertito in essere umano per divenire compagna per il figlio di Ngenechén e di Küyén. Essa, inoltre, è stata data in custodia agli esseri umani, discendenti di que-sta prima coppia divina. In questa cosmogonia è ben presente la disubbidienza del-la stirpe umana ed il castigo che ne consegue. La disubbidienza umana consiste nell’aver solcato la terra per introdurvi il seme; l’essere umano, dunque, viene ca-stigato per aver abbandonato le sue antiche abitudini di raccoglitore ed essersi tra-sformato in agricoltore. In altri termini, egli viene punito poichè è reo di avere ab-bandonato gli usi della antica società patriarcale, creando nuove abitudini, dove il peso della donna diventa dominante poichè ella è la depositaria dei segreti dell’incipiente agricoltura.
Gli spiriti ancestrali castigano la disubbidienza umana inviando una smisurata serpe, Koikoifilú, che smuove le acque dal loro alveo, facendo sì che esse coprano tutte le terre emerse. Ma gli stessi spiriti inviano anche un’altra serpe, Trentrenfi-lú, altrettanto immensa e forte, la quale solleva le terre per impedire che siano to-talmente sommerse dalle acque. E’ così che alcuni mapuche riescono a salvarsi, mentre la maggioranza affonda nelle acque del mare. Ma anche in questo caso non muiono tutti, ma vanno a costituire un nuovo popolo: i kawelche, ovvero il popolo dei delfini7.
Fig. 12. Cimitero mapuche con i mamülche (simulacri in legno dei morti) ed un machi (sciamano) intento a celebrare un rituale religioso.
6Si tratta di una wangülén, ovvero di una stella. 7Per i mapuche, e in modo particolare per i clan williche, i delfini sono esseri umani e non animali. Quanto al termine kawel, delfino, e kawelche, popolo dei delfini, esso è strettamente correlato a kawünche, uomo trasformato in altra cosa.
11
Nella mitologia mapuche, quindi, ritroviamo il ricordo di un antichissimo dramma culturale: il passaggio da una cultura patriarcale, nomade e basata sulla raccolta e sulla caccia ad una cultura matriarcale, sedentaria, basata sull’agricoltura.
3. I mapuche e la nascita dello Stato cileno La nascita dello Stato cileno (1810) rimette in discussione i trattati tra il Mapu
e la Corona spagnola e, quindi, la stessa indipendenza della nazione mapuche. Da un lato perché i padri fondatori del Cile ritenevano che i mapuche fossero una componente del nuovo stato: Bernardo O’Higgins, eroe della guerra di indipen-denza e primo capo del governo, nel 1819 dichiarava formalmente che i mapuche “devono essere considerati cittadini cileni, liberi come gli altri abitanti dello Stato, con i quali avranno uguale voce e rappresentanza”. Ma soprattutto perché nella prima metà dell’Ottocento la regione indigena non solo rappresentava una parte considerevole del territorio della neonata repubblica sudamericana, ma era anche quella più fertile e ricca: in una nazione dominata dal latifondismo più bieco, que-sti vasti territori agricoli suscitavano enormi ambizioni.
Durante le guerre sostenute dai cileni per indipendizzarsi dalla Spagna, i mapu-che si dividono in due partiti. Alcuni parteggiano per la neonata repubblica: i più, fedeli al loro impegno con la Corona, si schierano dalla parte della monarchia ibe-rica e combattono contro i cileni. Da qui che sin dagli inizi del secolo scorso si ac-cende una lotta cruenta tra cileni e mapuche che, dapprima episodica, successiva-mente si trasforma in una vera e propria guerra di frontiera.
Nel 1819 i toki Mangill e Marilwan conquistano Los Angeles, una importante città del Cile centromeridionale, e la incendiano. L’anno successivo, tuttavia, le truppe realiste sono sconfitte dagli indipendentisti e la Corona rinuncia a prosegui-re la guerra. I mapuche tentano di continuare da soli la guerra, ma nel 1825 Ma-rilwan accetta un tregua e riconosce lo Stato cileno, il quale occupa numerose zo-ne costiere del Mapu, massacrandone gli abitanti e spogliandoli delle loro terre. Mangill, toki dei clan pewenche, decide di resistere ad oltranza. Dall’altro lato della cordigliera andina, Kallfükura combatte contro ogni winka8, tanto realista quanto indipendentista, giungendo a minacciare tutta la pianura argentina, sino ai sobborghi della stessa Buenos Aires. Sconfigge ed uccide alcuni tra i toki che so-no venuti a patti con i cileni, tra i quali Koñoepan.
Tra il 1825 ed il 1851 tra cileni e mapuche vige una tregua, violata assai spesso da entrambe le parti, che ha come conseguenza principale quella di dividere pro-fondamente tra loro i clan che costituiscono la nazione mapuche, indebolendola ir-rimediabilmente. Ma nel 1851 la guerra si riaccende e i mapuche, comandati dal toki Mangill, passano al contrattacco: le città lungo il corso del Bío-Bío - Los An-geles, Nacimiento e Negrete - subiscono la rabbia indigena e quest’ultima viene
8Winka, straniero.
12
totalmente distrutta. Nel decennio del ‘50 le truppe cilene, comandate dal colon-nello Cornelio Saavedra, noto per la sua crudeltà, compiono numerose e profonde offensive nel cuore del territorio mapuche e sconfiggono ripetutamente Mangill, mentre gli altri lonko preferiscono mantenersi al di fuori del conflitto. Alla morte di Mangill, il figlio Külapan giura di continuare la lotta ad oltranza e di non de-porre mai le armi sino a quando il Mapu sarà totalmente liberato dai winka, oppu-re egli stessi e tutti i suoi saranno morti. Inizia la guerra finale, l’ultima grande guerra coloniale sul territorio americano.
4. Un avventuriero francese nel Mapu Nel 1858 un nobile avventuriero francese si dirige verso il territorio mapuche.
Si tratta di Orélie9Antoine de Tounens. Nasce nel 1825 a La Cheze de Chourgnac (Périgueux, Dordogne): è il secondogenito di una famiglia nobile ed illustre, ma economicamente venuta a meno, e sin da bambino i libri di storia sono la sua pas-sione. In modo particolare si entusiasma con il racconto della conquista spagnola dei grandi imperi americani: sogna di essere ora Atahualpa, ora si immedesima in Montezuma. A poco a poco nasce un sogno, ricostruire i grandi imperi precolom-bini, e questo sogno si converte in una ossessione. Ma all’ossessione si aggiunge una incredibile ambizione: essere lui stesso colui che fa rinascere questi imperi e, così, restituire lustro e splendore al suo casato. Quando compie 33 anni, il sogno e l’ambizione si sono uniti a generare un progetto più folle che temerario: creare una federazione di regni che a poco a poco riunisca tutte le nazioni indigene del conti-nente americano. Si dà, dunque, un primo obiettivo: impedire che scompaia anche quell’unica nazione indigena sopravvissuta alle conquiste coloniale europee: la nazione mapuche. Ben poco sa del Cile: raggiunge il porto di Coquimbo e si stabi-lisce a Valparaíso. Tuttavia attende due anni prima di raggiungere il Mapu: anni che dedica allo studio dello spagnolo e, soprattutto, degli usi e delle tradizioni del popolo mapuche. E’ talmente convinto di riuscire nel suo intento, che nel frattem-po predispone una bozza di costituzione monarchica e definisce la bandiera del fu-turo Regno di Arucania e Patagonia. Ha anche allacciato dei rapporti con alcuni lonko e con il loro aiuto nel 1860 raggiunge il toki Külapan, il nemico giurato del-la giovane nazione cilena.
Anche il toki ha un sogno: riprendere la guerra e liberare l’intero Mapu, ristabi-lendo l’antica frontiera del Bío-Bío. Infatti i cileni hanno occupato gran parte dei territori meridionali, popolati dai clan williche. Il toki più importante, Wentekol, è dovuto scendere a patti e molti lonko a Tukapel hanno accettati le dure condizioni imposte dai cileni: devono pagare una indennità di guerra di 25.000 pesos e, non possedendo dinero, il pagamento avviene mediante la cessione di vasti territori. Ma molti clan non lo appoggiano più: le crudeli sconfitte subite nel decennio testé
9Per ragioni ignote, il suo nome spesso assume la forma Orllie, anziché Orélie.
13
concluso sono ancora troppo dolorose e ritengono di non avere forze sufficienti per riprendere la guerra.
Külapan cerca alleati per combattere il Cile. Per mezzo dell’amico Kallfükura tenta di coinvolgere il governo argentino, ma inutilmente. Anzi, Buenos Aires sca-tena una guerra senza quartiere contro i mapuche. Viene a conoscenza dei progetti visionari di Orélie Antoine, il quale sostiene di avere l’appoggio dell’imperatore francese, Napoleone III, e di poter fornire armi e truppe. Nel cuore del toki nasce una speranza: l’aiuto della lontana potenza europea e decide di favorire un abboc-camento con questo strano e romantico avventuriero.
Orélie Antoine, accompagnato da un interprete che pone a sua disposizione lo stesso Külapan, e da due francesi ai quali aveva promesso un ministero nel suo re-gno, s’incontra con numerosi lonko, tra i quali anche il toki. Il francese cura parti-colarmente la sua presentazione personale, mescolando l’abbigliamento francese a quello tradizionale mapuche. La sua capacità oratoria è molto convincente. E’ cer-to di aver convinto numerosi capi, ma, più probabilmente, è l’astuto Külapan che ritiene di non aver nulla da perdere ma solo da guadagnare giocando la carta del francese. D’altra parte il sincretismo è proprio della cultura mapuche. Dopo il primo disastroso contatto con gli spagnoli, gli indigeni stravolgono tutta la loro strategia militare, creano tanto la falange, quanto la guerriglia, e mietono vittorie su vittorie. Forse ora - pensa Külapan - è giunto il momento di darsi una diversa struttura politica, più simile a quella occidentale, purché non venga messa in di-scussione la tradizione filosofica e religiosa mapuche. Se il francese vuole essere re, ebbene, che lo sia pure. Il beneplacito di Külapan diventa il beneplacito dei principali lonko, almeno di quelli che vogliono riprendere le armi contro i cileni, purché ci sia al loro fianco un alleato potente, quale appunto la Francia di Napole-one III.
Il 17 novembre 1860 il folle sogno di Orélie Antoine si compie: viene procla-mato il Regno di Araucania e lui viene acclamato re da tutti i lonko convenuti. La nuova Casa Reale è nata.
Viene illustrata la costituzione della nazione. Nonostante il contesto monarchi-co costituzionale, si ispira a principi di egualitarismo che, per l’epoca, erano ve-ramente coraggiosi e illuminati: tutti sono uguali di fronte alle leggi (anche il Re, al quale corrisponde il potere esecutivo); l’assemblea legislativa è eletta con suf-fragio universale e ad essa corrisponde la decisione circa il bilancio della nazione; la nobiltà è puramente onorifica10; la celebrazione delle nascite, dei matrimoni e dei funerali è uguale per tutti, anche per la famiglia reale, e assolutamente gratuita; vige la completa libertà religiosa. L’amico F. Desfontaines, che ha creduto in lui e lo ha accompagnato nel suo folle viaggio nel Mapu, è nominato Segretario di Sta-to.
10Art. 8. Il re assegna titoli di nobiltà secondo la sua volontà, ma essi non costituiscono una casta ne possiedono privilegi di sorta: i titoli sono esclusivamente onorifici.
14
Fig. 13. Orllie-Antoine I intorno al 1873, a Parigi.
Orllie-Antoine I distribuisce i ministeri tra i lonko convenuti (naturalmente a
Külapan tocca quello della guerra). Si preoccupa anche del futuro della dinastia e, essendo ancora scapolo, pensa di sposare la figlia di qualche lonko, forse dello stesso Külapan. Tre giorni più tardi, con un semplice decreto a seguito di una sup-posta richiesta dei lonko dei territori ad occidente della Cordigliera11 anche la Pa-tagonia viene incorporata al regno.
Orélie Antoine, che ora si fa chiamare Orllie-Antoine I, ritiene che il mondo in-tero debba essere messo al corrente della nascita del Regno di Araucania e Pata-gonia. Agli inizi del 1861 lo ritroviamo a Valparaíso, impegnato a tessere una fitta ragnatela di relazioni. Vuole stimolare l’attenzione di Napoleone III e ottenere l’appoggio delle sue armi e del suo tesoro: aggiunge dunque al Regno la denomi-nazione di Nouvelle France. Scrive al presidente del Cile ed ai suoi ministri, pre-sentandosi quale monarca. Non ottiene risposta alcuna: tutti lo ritengono un mil-lantatore o un pazzo. Da parte delle autorità cilene viene presa la decisione di non intervenire in alcun modo: le relazioni con la Spagna sono molto tese, quasi al li-mite della guerra, e la Francia potrebbe essere una alleata, dunque meglio non ar-
11In realtà non si tratta tanto della Patagonia, quanto delle provincie argentine tradizionalmente di cultura mapuche, ma Orélie Antoine non ha le idee molto chiare sull’argomento: infatti nel suo li-bro “Orllie-Antoine 1.er, Roi d’Araucanie et Patagonie: son avénement au trône e sa captivité au Chili” (Parigi 1863) confonde i pewenche (i mapuche della Cordigliera) con i patagoni, ormai pra-ticamente estinti a causa degli efferati massacri compiuti dai colonizzatori europei della Terra del Fuoco. Comunque così facendo Orélie Antoine avvia il suo sogno di una “federazione di regni a-mericani”.
15
recare offesa ad un cittadino francese. Orllie-Antoine interpreta questo atteggia-mento quale riconoscimento che il Cile non ha alcun diritto sul Mapu e, pertanto, non può immischiarsi negli affari interni di quella nazione12.
Il soggiorno a Valparaíso e Santiago è breve. Alla fine del medesimo anno (1861) rientra nel Mapu. Külapan organizza grandi festeggiamenti. Probabilmente non crede al francese, ma risulta utile per raggruppare tutti i lonko e riprendere la guerra contro l’invasore cileno, che continua a fondare città e occupare vaste re-gioni a partire dalla frontiera più meridionale, avanzando verso nord e stringendo d’assedio il territorio mapuche, progressivamente sempre più circoscritto. Aderi-sce il lonko Lefin. Aderiscono anche Leukon e Lefiu, non più in veste di lonko, ma di toki13. Külapan è soddisfatto: i suoi disegni cominciano ad avere successo. Orllie-Antoine I promette armi ed armati: pensa a mercenari francesi e ha anche preso contatti al proposito. Probabilmente è in buona fede: crede che veramente dalla Francia giungeranno aiuti a sostegno della causa mapuche e del suo Regno.
Ad ogni incontro con gruppi di mapuche, Orllie-Antoine I suscita grandi entu-siasmi: egli è un magnifico oratore, e la cultura mapuche ha un enorme rispetto ed ammirazione per l’arte oratoria14. Ne approfitta per farsi incoronare re da quei clan che ancora non lo avevano fatto. Si aggiunge Villamis e l’unico lonko che rifiuta di riconoscerlo monarca è Namunkura: tuttavia neppure frappone ostacoli alla sua attività.
Nel dicembre del 1861 si dirige a sud, nel territorio williche, quello che sta su-bendo la progressiva penetrazione cilena. Lì si abbocca con Wentekol, il toki più importante15, che organizza un incontro di grande portata. Vecchi e nuovi amici sono presenti e in quella occasione Orllie-Antoine I viene proclamato ñidol toki, generale supremo, e tutti i clan presenti celebrano i rituali che precedono la guerra. Trentamila guerrieri mapuche si uniscono al Re, pronti a combattere contro l’invasore cileno. Wentekol coglie l’occasione per tentare di inserire Orllie-Antoine I nei suoi dissidi personali e chiede al Re di allontanare il lonko Katrileo, un lonko molto potente, adducendo che questi si è alleato ai cileni ed ha permesso loro di entrare nel Willimapu16e di impadronirsi di vasti terreni. Ma le ragioni del-la rivalità non sono chiare ed il monarca è attento a non cadere nella trappola invi-schiandosi nelle lotte interne, e rimanda ogni decisione.
12Giuridicamente, il Mapu è una nazione riconosciuta dalla Corte spagnola in base al trattato di Quilín (1641), più volte ratificato in anni successivi. A Santiago, inoltre, risiedono quattro rappre-sentanti mapuche, ed altrettanti rappresentanti del Governo cileno risiedono nel forte di Tucapel, in Araucania, ciò che costituisce un vero e proprio scambio di rappresentanze diplomatiche e, quindi, del reciproco riconoscimento di sovranità nazionale. 13Cioé, indossando al collo l’ascia levigata, collocata come pendente ad una collana di cuoio, e portando la lancia di guerra. 14A tal punto che il figlio di un lonko non può succedere al padre se non è un buon oratore. 15La sua importanza è pari a quella di Külapan, ma il suo peso politico è maggiore, in quanto dota-to di maggiore realismo: anziché rifiutare qualunque rapporto con i cileni, tenta di raggiungere ac-cordi di vasta portata che salvaguardino per quanto possibile l’indipendenza del Mapu: i suoi pro-positi vengono presi molto sul serio dalle autorità della Repubblica, come dimostrano i numerosi carteggi tra Wentekol e lo stesso presidente della Repubblica. 16Willimapu: territorio del sud.
16
Fig. 14. La potente famiglia williche dei Katrileo intorno al suo lonko.
Külapan è felice, tanto più che ha sentore che i cileni stanno riunendo truppe
alla frontiera del Mapu17: capisce che la sua intuizione era stata giusta. Ora ha la bandiera di cui aveva bisogno e, allo stesso tempo, non si espone in prima perso-na. Infatti gli equilibri di potere tra i vari clan mapuche sono molto delicati e i clan stessi si sono combattuti per gran parte della loro storia. Lui stesso suscita timori di egemonia tra gli altri toki, sempre molto gelosi della loro indipendenza18, ma il francese è al di fuori delle parti e delle lotte intestine, quindi permette di riunire le forze senza suscitare gelosie.
Orllie-Antoine I decide di tornare alla frontiera del Bío-Bío, dove ottiene l’adesione del potente toki Meliu. Ora vuole schierare i suoi trentamila armati lungo le sponde del grande fiume: non vuole la guerra, ma ottenere il riconosci-mento dello stato cileno. Ma per farlo ha bisogno del consenso del lonko della re-gione, Trinte. E’ il 5 gennaio 1862.
Orllie-Antoine I è incamminato verso la casa del lonko. Ha rifiutato la scorta armata che gli era stata offerta: non ha alcun timore a viaggiare nei territori mapu-che, e lo fa in compagnia di un meticcio, Juan Bautista Rosales, che gli fa da in-terprete e da servitore. Non sa che i cileni si sono allarmati per i suoi movimenti e che il suo attendente lo ha venduto ad essi per 50 pesos. Lorenzo Villagrán, co-mandante militare di Nacimiento, una località nei pressi del fiume Bío-Bío, orga-nizza una incursione nel territorio mapuche: con sei soldati e con il capo della po-lizia, Quintana, lo catturano facilmente e lo conducono nella cittadina cilena. Due giorni più tardi viene condotto a Los Angeles, dove il monarca dell’Araucania viene rinchiuso in una cella: tuttavia non perde mai quel suo modo di fare che im-
17Effettivamente il 17 dicembre 1860 è stato dato l’avvio ad una spedizione militare destinata non tanto ad occupare il Mapu, quanto indurlo a fare importanti concessioni alla colonizzazione cilena. 18La tradizionale inesistenza di una massima autorità comune tra i mapuche è certamente una ra-gione di debolezza, ma anche di forza: infatti gli spagnoli non hanno mai potuto impadronirsi di un capo indiscusso (come avvenne con Atahualpa o Montezuma) e in questo modo dominare l’intera nazione.
17
pressiona i presenti per la nobile regalità che esprime. A Los Angeles lo attende il colonnello Cornelio Saavedra, colui che due decenni più tardi condurrà contro i mapuche una guerra di sterminio.
Mentre veniva condotto a Los Angeles per essere processato, il cavallo sul qua-le veniva condotto improvvisamente si rifiuta di proseguire. Il viaggio è lungo: è necessaria un’altra cavalcatura. Per fortuna c’è una grande hacienda proprio a due passi dal luogo dove si trovavano. Destino volle che il proprietario della tenuta fosse un certo Serrano, suocero del console francese a Concepción. Nel tempo ne-cessario per approntare un altro cavallo, Orélie Antoine ne approfitta per scrivere due lettere: una per il console francese, l’altra per l’incaricato di affari dell’ambasciata di Francia a Santiago. Serrano si offre di farle giungere a destina-zione e così avvenne.
Inizia il processo: è un farsa dove tutto va a rovescio di come dovrebbe andare. L’avventuriero francese non rinuncia a giocare il suo ruolo: al contrario. Tratta con sussiego lo stesso Saavedra, insiste nel dichiararsi legittimo Re di Araucania e Patagonia, dimostra ed elenca i fatti a sostegno della legittimità del suo titolo, esi-ge di essere trattato come si conviene a Vostra Altezza. La sua arte oratoria è stra-ordinaria, nonostante gli argomenti siano sconcertanti. Tuttavia la conclusione è quella scontata e Orélie Antoine finisce in una incomoda cella.
E’ certo di essere fucilato, ma non abbandona mai il ruolo che ha scelto. La sua figura è quella di un novello Chisciotte: del cavaliere ne ha tutta la folle passione, ma anche l’indiscussa grandezza morale. La sua avventura potrebbe concludersi con una farsa da operetta: invece assume i toni lirici di una grande opera. Redige il testamento: Noi, Orllie-Antoine I, per grazia di Dio e per volontà nazionale Re degli Araucani e dei Patagoni... Immagina di essere Luigi XVI di fronte al tribuna-le rivoluzionario19.
Ora si trova in cella, insieme ai delinquenti comuni, in condizioni estremamen-te dure. Ne approfitta per scrivere numerosi libri. Nel frattempo si svolge il pro-cesso davanti alla corte marziale. Non solo ribadisce di essere il legittimo Re dei mapuche, ma giunge ad invitare lo stato cileno ad aderire alla sua Federazione di nazioni, offrendo, con grande magnanimità, di fare di Santiago la sua capitale. Firma ogni verbale come Orllie-Antoine I Re. La sua situazione giuridica non può che peggiorare, tanto più che emerge che proprio mentre Orllie-Antoine metteva insieme i suoi trentamila kona20, Saavedra progettava di invadere il Mapu e già aveva ammassato le sue truppe alla frontiera. L’inatteso intervento del Re aveva fatto fallire i propositi del governo cileno.
Ma il console francese e l’incaricato di affari si sono mossi e la Corte di Appel-lo di Concepción derubrica l’accusa e trasferisce il processo a un tribunale civile. Il 1 maggio 1862 l’accusa chiede una condanna a 10 anni. Il 19 luglio 1862 il giu-dice, emette la sentenza: Monsieur Orélie Antoine de Tounens è folle e deve es-sere internato in una casa di cura dalla quale i suoi famigliari potranno farlo uscire
19Conosciamo bene i pensieri del nostro personaggio poiché ci sono pervenuti i suoi numerosi scritti. 20Kona, guerriero in mapudungún.
18
affinché possa rientrare in Francia ed essere curato nella sua terra. Dopo un breve soggiorno nel manicomio di Santiago, il 28 ottobre del 1862 viene imbarcato su una nave militare francese in partenza per Brest.
Raggiunta finalmente Parigi, si pone immediatamente all’opera per ottenere appoggi politici e finanziari per il Regno di Araucania e Patagonia. Poiché questi sono paraggi sconosciuti ai più, si dedica a scrivere libri, libelli ed articoli di ogni sorta. Gli giunge anche qualche soddisfazione. Scopre che il 10 aprile 1861 la Re-vue du Monde Coloniale ha sostenuto che “l’atto di proclamazione del regno da parte di Sua Maestà Orllie-Antoine I non è se non la consacrazione assolutamente legittima di ciò che egli ha conquistato con il suo valore”. Ma soprattutto lo stesso Napoleone III si interessa della vicenda, anche se non vi sono prove di un suo in-contro con l’imperatore. Tuttavia la cancelleria cilena in quegli anni mostra molta preoccupazione per le pretese coloniali francesi in America21. Tenta anche di eri-gere una sottoscrizione obbligazionaria, ma senza successo. Ottiene fondi, invece, con la vendita di titoli nobiliari e, in questo modo, la Corona mapuche guadagna una certa notorietà, e forse anche credibilità.
5. La fine di una nazione Nel frattempo nel Mapu regna una situazione molto tesa, con una continua bel-
ligeranza fatta di cruente incursioni da entrambe le parti. Perciò Külapan si impe-gna a mantenere viva la memoria del Re, agendo quale suo vicario e continuando nell’opera diplomatica tra i lonko mapuche affinché non si disperdi quell’unità co-sì fortunosamente costruita. Ma tra il 1868 ed il 1869 la situazione precipita. Il co-lonnello Cornelio Saavedra, infatti, ha condotto una campagna militare durissima contro i mapuche. Pubblicamente dichiara di aver conquistato la costa “con mucho mosto, mucha música y poca pólvora”, cioè organizzando grandi bevute di vino, grandi festeggiamenti e pochi spari. Ma quando l’opinione pubblica scopre la veri-tà, e cioè che la “pacificación della Araucanía” è una vera e propria guerra che ha come scopo lo sterminio dei mapuche, ormai è troppo tardi: oltre il 10% di tutti gli uomini vengono uccisi, le donne vengono stuprate in massa affinché nascano me-ticci, gran parte del Mapu viene saccheggiato e i mapuche, che sono soprattutto pastori, vengono depredati dei loro animali, condannandoli alla fame. Molte fami-glie lafkenche e williche fuggono verso le parti più nascoste della Cordigliera an-dina, trovando rifugio tra i pewenche; altre ancora emigrano verso Chiloé ed il suo arcipelago. Tutti i giornali sconfessano il colonnello e lo stesso parlamento lo met-te sotto accusa, sicché il governo è costretto a fermare Saavedra e intavolare tratta-tive di pace con i mapuche.
Sebbene manchino le prove documentali, pare che tra il toki ed il Re si siano mantenute aperte alcune vie di comunicazione. Di fatto egli si affretta ad allestire una spedizione per raggiungere il Mapu, sebbene tutta la vicenda rimane ancor
21La Francia è impegnata in una spedizione contro il Messico.
19
oggi molto oscura. L’8 febbraio 1869 un vascello militare francese, il D’Entrecasteaux, salpa (segretamente), diretto verso la costa meridionale cilena. A bordo c’è il sovrano del Mapu22 e forse vi sono anche armi e alcuni soldati.
Nel marzo del 1869 il Re sbarca a San Antonio, in territorio argentino: intende attraversare la Cordigliera e giungere così nel Mapu senza passare dal Cile. Ma i pwelche, la popolazione indigena della pampa settentrionale, è in piena ribellione contro gli argentini ed è proprio Orllie-Antoine I a farne le spese, essendo fatto prigioniero. In qualche modo si era mantenuto in contatto con i mapuche, poiché erano informati del suo arrivo. Infatti il lonko williche Lemunao, un alleato di Külapan, accorre prontamente in suo soccorso, lo libera e lo aiuta ad attraversare le Ande e ad entrare nel Mapu. Giunge così nella regione di Lonquimay, la terra del toki. Il ritorno del Re viene accolto con grandi festeggiamenti: ancor più quan-do egli fa sapere di avere armi ed armati, prossimi a giungere via mare. Un certo numero di clan pewenche e williche prendono le armi ed i loro lonko assumono il comando militare: tra di essi vi sono Montri e Külaweke. Non aderiscono, invece, i clan della costa, ormai di fatto incorporata nello stato cileno.
L’entusiasmo dei mapuche per il ritorno del loro monarca giunge alle orecchie di Saavedra, che teme che ciò possa dare loro animo per riprendere la guerra no-nostante la recente drammatica sconfitta. Riunisce numerosi lonko lafkenche e williche e li interroga, minacciando di riprendere la guerra di sterminio da pochi mesi sospesa. Tra i lonko convocati c’è anche Lemunao, il quale ammette che Or-llie-Antoine I è rientrato nel Mapu e che si trova a Lonquimay, presso Külapan. Allora il colonnello cileno offre una taglia enorme per colui che gli consegnerà il francese: due almudes23 di pesi d’argento. Ma non attende oltre: riunisce immedia-tamente l’esercito al suo comando e si prepara per dare l’avvio ad una nuova cam-pagna militare, tanto più che nella baia di Lebu, lungo la costa del Mapu, già da qualche tempo è ormeggiato un misterioso vascello militare francese.
L’inverno24 del 1869 è tremendo nel Mapu. Tra i mapuche la fame è enorme, poiché le loro mandrie sono state saccheggiate dalle truppe cilene. Ma la peggiore conseguenza della guerra di sterminio condotta dal Saavedra è una improvvisa e-pidemia di vaiolo, che decima i sopravvissuti. Per di più gli attesi aiuti francesi non giungono mentre il vascello D’Entrecasteaux salpa, altrettanto misteriosamen-te di quando aveva ormeggiato nella baia di Lebu25.
22Secondo altre fonti, Orllie-Antoine I viaggia su un’altra nave, la Oneide, con bandiera inglese. Ma è possibile che dietro l’intera vicenda ci sia Napoleone III, interessato a fare del Mapu un pro-tettorato francese, ma cauteloso prima di esporsi apertamente, non essendo affatto sicuro del fatto che i mapuche sostengano realmente l’autoproclamato monarca. 23Antica unità di misura che corrisponde a un decalitro. 24Da giugno a settembre (il Cile è nell’emisfero australe). 25Alcuni anni più tardi, il segretario del Consiglio di Stato di Napoleone III confida al diplomatico cileno Abdón Cifuentes che Napoleone riteneva che l’Araucania fosse uno stato indipendente e che l’autoproclamazione di Orllie-Antoine fosse legittimata dall’approvazione dei capi dei principali clan mapuche. Per queste stesse ragioni, l’Imperatore intendeva sostenere i tentativi del Re per in-sediarsi nel suo regno. Tuttavia la conclusione drammatica dell’avventura francese in Messico, con la fucilazione dell’imperatore Massimiliano insediato da Napoleone III, convinse questo a desistere dal sostenere Orllie-Antoine.
20
Külapan si convince che in quelle condizioni è impossibile muovere guerra ai cileni. Decide di intavolare trattative di pace ed il Parlamento di Santiago il 16 ot-tobre 1869 ratifica gli accordi di pace. Chiede a Külapan di consegnare Orélie An-toine a Saavedra, ma il lonko si rifiuta: ormai quello strano e ingenuo sognatore non è più uno strumento capace di rendere possibile il mantenimento di un Mapu libero e indipendente, tuttavia è nato un forte sentimento di amicizia tra il monarca ed il toki. Külapan, quindi, consiglia al francese di fuggire in Argentina e da là raggiungere la Francia e gli assegna una scorta.
Il Re comprende che non c’è più nessuna alternativa: accetta il consiglio dell’amico e la scorta. Ma prima di partire insedia un Consiglio di Reggenza, composto da Külapan, quale reggente e ministro della guerra, Mountret, ministro degli esteri, Marilwan, ministro dell’agricoltura, e Kallfükochi. Poi verso la metà del 1870 s’incammina verso Buenos Aires, dove giunge nel luglio del 1871. Passa a Montevideo, da dove salpa verso la Francia.
Nonostante che i mapuche stiano cercando un’intesa con i cileni per salvare almeno una loro autonomia all’interno dello stato cileno, che ormai sta soffocando il Mapu in una morsa inesorabile, nonostante che Napoleone III abbia abbandona-to ogni velleità di espansione coloniale, nonostante che la sua stessa famiglia gli volti le spalle e lo ritenga folle, tuttavia Orllie-Antoine non demorde. Egli è il Re dell’Araucania e della Patagonia e intende far valere le sue prerogative. Se nessu-no lo aiuta, egli andrà avanti da solo. Servono soldi e armi (e possibilmente anche soldati).
Nel marzo del 1872 lo ritroviamo a Marsiglia, dove fonda e pubblica Couronne d’Acier, organo ufficiale del Regno. Poi torna a Parigi dove crea un ordine caval-leresco e vende titoli nobiliari. Poi va a Londra dove ottiene l’aiuto di un banchie-re, Jacob Michaels, per realizzare un titolo obbligazionario che Orélie Antoine garantisce niente meno che con una ipoteca su vasti territori del Mapu! Il banchie-re è proprietario di due navi - il Pride of the Ocean e l’Almara - e le pone a dispo-sizione del monarca per realizzare una nuova spedizione verso il Cile. Poi torna a Parigi, dove ottiene anche l’appoggio di Marc Gérard, importante uomo d’affari, che gli apre molte porte nel mondo della finanza. Le cose sembrano andare meglio ed ora il Re crea una sorta di corte in esilio. Ma il regno per essere tale deve avere una bandiera, un inno ed una moneta. La bandiera esiste, l’inno anche: dunque Or-llie-Antoine I crea la moneta. Nel 1874 si rivolge ad una zecca di Berlino la quale conia monete d’argento da un peso e monete di rame da 2 centesimi26.
26Circa le emissioni monetarie di Orllie-Antoine I sussitono ancora incertezze, tanto in merito alla zecca, che secondo altre fonti potrebbe essere a Parigi o a Bruxelles, quanto ai tipi coniati, che po-trebbero essere più numerosi di quelli conosciuti. Si tratta di monete di grande rarità, che non sem-brano aver mai circolato nel Mapu (né da nessuna altra parte).
21
Fig. 15. Le monete del Reino del Mapu del 1874.
Ma la situazione precipita. Il prestito obbligazionario non trova acquirenti ed il
monarca, che ingenuamente fiducioso del buon esito dell’iniziativa finanziaria ha emesso alcuni assegni, si trova in gravi difficoltà legali. I banchieri rifiutano di darli ulteriore credito ed anche i suoi pochi possedimenti famigliari rischiano di essere alienati. Egli crede che il prestito non abbia successo poiché lui si trova a Parigi, anziché nel suo regno. Dunque nell’aprile del 1874 si imbarca sotto le mentite spoglie di Juan Prat, deciso a rientrare clandestinamente nel Mapu. Alla fine di maggio raggiunge Bahía Blanca, nella Patagonia argentina: ma colà il 17 luglio viene riconosciuto, arrestato e rapidamente rispedito in Francia.
Torna dunque a Parigi e in un modesto alloggio della Rue Lafayette stabilisce la sua Corte. Nomina ministri, concede udienze, riprende a vendere titoli nobilia-ri27. Ma tutto ciò non gli basta: vuole essere un re con un regno. Cosicché agli ini-zi del 1876 fa ancora un tentativo di rientrare clandestinamente in Cile. Ma a Bue-nos Aires si ammala gravemente e, dopo un intervento chirurgico, nel gennaio del 1877 si imbarca ancora una volta per tornare nella sua patria. Non torna a Parigi, ma va a Tortoirac, nella casa di un nipote, nei luoghi dove è nato. Sa di essere molto malato, di essere giunto al capolinea della sua avventurosa vita. Emette la sua ultima disposizione regale: poiché non ha discendenti, nomina quale suo suc-cessore il suo luogotenente generale, Achille Laviarde. Pochi giorni dopo, è il 19 settembre 1878, muore il Re della Araucania e della Patagonia.
Ma ormai anche l’indipendenza del Mapu sta per venire a meno. Nel 1878 c’è un primo accordo tra Cile e Argentina per stabilire lungo la Cordigliera delle Ande il confine tra le due nazioni: in quell’occasione il “problema indigeno” viene rite-nuto un problema comune ad entrambi i Paesi. Un anno più tardi il generale Roca, Ministro argentino della guerra, scatena una campagna di sterminio nei confronti delle popolazioni indigene dell’Argentina: mapuche, pwelche e tewenche. E’ lo sterminio totale: dopo due anni di “pulizia etnica” (chiamarla campagna militare sarebbe fare un onore alle armi argentine che non meritano!), ad occidente della Cordigliera sopravvive meno di un quinto della popolazione indigena. Gli uomini sono sistematicamente uccisi, i loro bambini e le loro donne, almeno quelle ancora
27Per tutta la durata del suo “regno”, Orllie-Antoine I vendette titoli nobiliari e forse questa fu la sua principale fonte di reddito. Tuttavia lo fece con una certa prudenza, curando la qualità delle persone ai quali concedeva tali titoli, che furono sempre persone degne e di cultura. In modo parti-colare vennero assegnati titoli nobiliari, spesso senza alcuna richiesta di denaro, a personaggi che si distinguevano negli studi relativi al mondo mapuche.
22
giovani, sono catturati quale “bottino di guerra”. I pochi gruppi di mapuche che non sono stati sterminati, vengono cristianizzati alla forza, sotto la minaccia di passarli per le armi28.
Il Cile, intanto, era impegnato nella guerra contro il Perù e la Bolivia (1879-81), conclusa con l’occupazione del grande deserto di Atacama, ricchissimo di ri-sorse minerarie. Ma nel 1881 Saavedra, ora fatto generale e nominato Ministro della Guerra, scatena una campagna violentissima per porre fine una volta per tut-te all’indipendenza del Mapu. In due anni, l’intera regione è occupata ed ogni ten-tativo di resistenza è represso senza misericordia. Inutilmente i clan mapuche si uniscono in una insurrezione generale (fine del 1881). La loro cavalleria, dotata di lance di legno dalla punta indurita al fuoco, affronta disperatamente le mitraglia-trici ed i cannoni dell’esercito cileno. Il 31 dicembre 1882 a Villarica si arrende anche l’ultimo gruppo mapuche che ancora resisteva, comandato dal toki Epulef: sono un centinaio di kona a cavallo. Il colonnello Urrutia, ora che il Mapu è “paci-ficato” vuole essere generoso ed offre loro di integrarsi nella nazione cilena. Ma Epulef prende la via della Cordigliera seguito da tutti i suoi compagni, e tutti scomparvero per sempre. Ormai il Mapu indipendente non esiste più.
6. I mapuche oggi: un popolo ancora in lotta Sebbene l’indipendenza della nazione mapuche sia venuta meno alla fine del
secolo scorso, tuttavia l’anelo a mantenere ben vive le proprie tradizione e la pro-pria identità etnica e per ottenere almeno una qualche forma di autonomia, non è mai cessato, sicché al momento attuale vi sono forti tensioni tra cileni e mapuche nel cuore dell’Araucania.
Oggi i mapuche “puri” sono poco più di un milione e rappresentano circa il 10% della popolazione del Cile. Sebbene ben oltre il 50% dei cileni abbia ascen-denza mapuche, tuttavia vi è scarsa memoria e sensibilità verso questa origine a-merindia. Gran parte dei mapuche vive nella periferia povera di Santiago, la capi-tale del Cile, mentre il cuore del territorio ancestrale a poco a poco si sta spopo-lando della popolazione originaria, sostituita da immigranti cileni ed europei, so-prattutto tedeschi. Questa vera e propria migrazione interna, avviata sin dai primi anni del ‘900 ma diventata impetuosa a partire dagli anni ‘70, costituisce il risulta-
28Don Costamagna, sacerdote salesiano al seguito delle truppe argentine, così scrisse a don Bodra-to, responsabile dell’Ordine religioso in Argentina: “qui io sto catechizzando alcune povere india-ne alle quali furono uccisi il padrone (cioè il lonko), il padre ed il marito! Non è da meravigliare, quindi, se talvolta armato della carità di Gesù Cristo gridi contro di questa civile barbarie! Né pos-so dirle tutto...”. [dal Bollettino Salesiano, agosto 1879, pag. 4]. A sua volta, don Bodrato scriveva a don Bonetti che ci si trovava a “battezzare e catechizzare i ragazzi indii ai quali i padri della ci-viltà moderna avevano ammazzato padre, madre e parenti! Così andavano avanti, sempre ucciden-do e sbaragliando le tribù che osavano lasciarsi vedere, in modo che barbaramente si aprivano il passo per prendere possesso di tutta la Pampa e una parte della Patagonia”. [da Pasquale Bellu, Al-cuni spunti per una storia della conquista della Patagonia, Università di Sassari 1991].
23
to voluto della politica cilena caratterizzata dal suo esasperato centralismo e dalla negazione di qualunque forma di autonomia.
La dittatura militare di Pinochet, secondo quanto afferma l’estrema destra, a-vrebbe avviato la “regionalizzazione” del Paese. In realtà la riforma amministrati-va attuata consiste nella suddivisione del Cile in dodici regioni dove tutte le auto-rità, senza alcuna eccezione, sono nominate dal Presidente della Repubblica. Non solo: la suddivisione territoriale non ha tenuto in nessun conto delle peculiarità storiche ed etniche di ogni area geografica, ma, al contrario, ha spaccato l’unità del territorio storico dei mapuche in modo tale che ora essi sono ovunque una mi-noranza. L’obiettivo rimane sempre lo stesso: cancellare l’identità mapuche per mezza di una “assimilazione” rapida e forzata nella società cilena, naturalmente riservando loro i ruoli più emarginati.
I mapuche chiedono alle autorità cilene che, in primo luogo, la loro esistenza sia riconosciuta giuridicamente, in quanto essa viene invece negata. Esigono, poi, che si ponga fine alla sistematica spogliazione delle loro terre, con artifizi giuridici più volte condannati dagli organismi internazionali, ad opera del grande latifondi-smo cileno e nordamericano29. Infine chiedono che venga loro data la possibilità di mantenere viva la loro lingua30 e di avere un sistema scolastico rispettoso della loro identità nazionale31. A queste richieste il governo cileno, tanto quello militare di Pinochet quanto quello “democratico” di Frei, hanno risposto con una repres-sione feroce e indiscriminata. E’ di questi ultimi giorni la notizia che nelle aree con più significativa presenza di popolazione mapuche sono stati di fatto soppressi i diritti umani fondamentali e, sulla base delle “legge per la sicurezza dello Stato” creata da Pinochet e mai abrogata, essi possono essere arrestati e detenuti dalle forse di polizia32 sino ad un massimo di 30 giorni, senza che venga formulata nes-suna accusa nei loro confronti e senza che ci sia necessità di alcuna autorizzazione della magistratura.
29Vi sono imprese forestali che hanno ottenuto dal governo di Pinochet centinaia di migliaia di et-tari di zone ad alta potenzialità agricola, tutte popolate dai mapuche, i quali sono stati scacciati con la forza dalle loro terre ancestrali: questo continua ad avvenire quotidianamente anche oggi, nono-stante il ritorno della democrazia (?) in Cile. 30La lingua mapuche non sembra avere relazione con nessun altro ceppo linguistico conosciuto. E’ di tipo polisintetico agglutinante. Sostantivi ed aggettivi sono pressoché invariabili, sebbene i suf-fissi che esprimono la natura grammaticale del sostantivo di fatto la assimilano ad una lingua de-clinata. Il verbo è estremamente complesso ed è costituito da una radice, alla quale si aggiungono uno o più fonemi che specificano il significato della radice, mentre altri fonemi esprimono il tempo ed il modo verbale, la positività o la negatività del concetto, la natura del complemento retto dal verbo e, infine, un suffisso indica persona e numero (singolare, duale e plurale, ma anticamente e-sistevano anche il triale ed il tetrale). Il suono del mapudungún è dolce, con prevalenza delle labiali (f), e delle dentali dolci (thr che è un suono intermedio tra la t e la c dolce). Tra le vocali predomi-na la ü (u francese). 31Formalmente esiste un piano di “educazione interculturale” in alcune aree rurali a maggioranza mapuche che prevede anche un insegnamento molto parziale della lingua mapudungún. Queste scuole sono limitate al ciclo elementare, sono poche decine sicché assistono meno dell’1% dei bambini mapuche, e sono completamente prive di mezzi economici. Lo scorso anno ho regalato ad alcuni insegnanti mapuche dei dizionari mapudungún-castellano, poiché non ne disponevano! 32Ed ora anche da quelle militari.
24
I mapuche godono della simpatia di buona parte dell’opinione pubblica cilena, soprattutto tra le classi sociali più colte, mentre spesso sono disprezzati dai settori più poveri e ignoranti, sebbene dal punto di vista etnico spesso queste stesse per-sone sono da ritenersi etnicamente mapuche33. Accademici ed antropologi dedica-no gran parte del loro tempo allo studio della cultura mapuche, ma molto spesso sono fortemente condizionati dai loro stessi pregiudizi e, comunque, i loro studi sono realizzati molto più “a tavolino” che sul campo34.
La posizione della Chiesa è ambigua. Sul campo tanto quella cattolica quanto quella evangelista35 è schierata a difesa dei diritti fondamentali dei mapuche in quanto uomini, ma assai meno in quanto nazione. La Chiesa è certamente autore-vole quando denuncia i soprusi di cui essi sono vittime, soprattutto da parte dei la-tifondisti e dei loro squadroni paramilitari, ma questo aiuto è fortemente compro-messo dalla volontà di proselitismo religioso e di conversione36.
Contrariamente al passato, ora i cattolici non ostacolano più la celebrazione dei riti tradizionali - sostanzialmente la celebrazione del ngillatún - ma li riconducono ad una mera celebrazione della propria identità storica e tradizionale, svuotandoli del loro contenuto religioso. Gli evangelisti dal canto loro, vanno ben oltre e proi-biscono tassativamente ai loro adepti di partecipare a qualunque forma di celebra-zione in seno alla comunità mapuche, compreso lo stesso gioco del “palín37”, una occasione di festa comunitaria vissuta sempre con grande partecipazione. Ne con-segue che attualmente la presenza evangelica costituisce una delle forme più gravi di disintegrazione dell’identità mapuche e della sua vita comunitaria38.
33Il cognome è assai poco significativo in quanto negli anni ‘30 moltissimi mapuche sono stati for-zati ad adottare cognomi spagnoli, oppure gli sono stati assegnati arbitrariamente dalle autorità ci-lene senza tenere in nessuna considerazione il loro cognome originale. 34La letteratura accademica relativa alla cultura mapuche, in tutti i suoi aspetti, è veramente sconfi-nata, assai più di qualunque altra cultura indoamericana. Un veloce sguardo a internet permetterà di comprovare immediatamente questa affermazione. 35Chiesa cattolica ed evangelista sono le due confessioni cristiane presenti nell’area mapuche, con un predominio netto e in costante crescita della seconda nei confronti della prima. La chiesa evan-gelica dispone di importanti finanziamenti da parte degli Stati Uniti e tanto il suo linguaggio quan-to la sua ritualità appare più consona al modo di essere dei mapuche. 36Tutt’ora gran parte dei mapuche che vivono nel contesto rurale sono fedeli alla loro religiosità tradizionale, che ha nella figura del machi il suo unico riferimento ideologico e la sua guida. 37Un gioco comunitario realizzato contrapponendo due squadre che con un lungo bastone ricurvo spingono un palla sino a farla entrare nella porta avversaria. Ognuna delle due squadre può essere costituita anche da alcune decine di giocatori e la dimensione del campo di gioco, un prato erboso più o meno pianeggiante, è definita in rapporto alla dimensione numerica delle squadre stesse. Non di rado le squadre coincidono con i clan e l’intera partita, giocata dall’alba al tramonto, è mescola-ta a numerosi momenti di celebrazione rituale anche di contenuto religioso. 38La figura del machi è messa fortemente in discussione dagli evangelici (al contrario dei cattolici che talvolta propongono forme di collaborazione), ma in questa maniera si pone in discussione uno degli elementi fondamentali della vita comunitaria mapuche e, quindi, della sua identità nazionale. Non a caso le autorità cilene tendono spesso a favorire il proselitismo e la diffusione degli evange-lici, in quanto consoni agli obiettivi di assimilazione forzata della comunità mapuche e di soppres-sione di ogni sua identità nazionale e sociale.
25
Fig. 16. Il gioco del palín.
Ai mapuche mancano alleati politici. La destra tradizionale, fortemente condi-
zionata dagli interessi del latifondismo che ne costituisce il nucleo centrale, li combatte ferocemente per spossessarli delle poche terre che ancora sono a loro di-sposizione. La destra più politica e liberista li vede come una minaccia ideologica, in quanto rifiutano il concetto di proprietà privata39, ed economica poiché propon-gono un modello di vita alternativo alla società di consumo e fortemente vincolato alla “comunione con la natura” ed al rispetto ecologico40. La sinistra, che a parole dice di volerli difende e sostenere, di fatto banalizza la loro lotta per una difesa et-nica della loro individualità e tenta di ricondurre il conflitto tra le comunità mapu-che e le autorità alla “lotta di classe”, di fatto negando implicitamente ogni loro ri-vendicazione nazionale.
La repressione attuata dalle autorità cilene nei confronti dei mapuche è stata ri-petutamente condannata dai massimi organismi mondiali, senza che vi siano stati miglioramenti sostanziali nella situazione quotidiana di questa etnia. E se non mancano i mapuche che hanno raggiunto una posizione professionale buona - giornalisti, avvocati, deputati - nei loro confronti è stata scatenata una repressione che va dalle intimidazioni alla violenza fisica ed alle minacce di morte ad opera di squadracce paramilitari41. In questo modo si mettono a tacere coloro che si stanno battendo, nel rispetto delle vigenti leggi, per difendere i loro fratelli di razza.
L’ombra di un etnocidio, perciò, è ogni giorno più incalzante. 39Soprattutto per quanto concerne il possesso della terra che per il mapuche può solo ed esclusiva-mente essere comunitario. 40Non a caso gli ecologisti sono i più sinceri e combattivi alleati della nazione mapuche. 41Quasi tutte le grandi imprese forestali dispongono di propri corpi paramilitari a “difesa” delle lo-ro proprietà terriere.
26
Nepey ñi güñüm piuke lapümü ñi müpü ina yey ñi peuma
rofülpuafiel ti mapu42.
Bibliografia
a) BACIGALUPO Ana Mariella, Variación del rol de machi dentro de la cultura mapuche, Revista Chilena de Antropología, Santiago
b) BARRETO Oscar, Fenomenología de la religiosidad mapuche, Ed. Abya-Yala, Quito 1996
c) BENGOA José, Historia del pueblo mapuche, Ediciones Sir, Santiago 1985
d) CARRASCO Hugo, Un mito mapuche anterior a Trentren y Kaikai, da “Estudios Filológicos”, n° 23, Universidad de la Frontera, Temuco 1988
e) DOWLING Jorge, Religión, chamanismo y mitología mapuche, Santiago, 1971
f) FARON Luois, Antüpaiñamko, moral y ritual mapuche, Ed. Mundo, Santiago 1997
g) FARON Louis, The mapuche indians of Chile, Waveland Press, Illinois 1986
h) FOERSTER Rolf, Introducción a la religiosidad mapuche, Ed. Universitaria, Santiago 1993
i) GREBE Maria Ester, El subsistema de los ngen en la religiosidad mapuche, Re-vista Chilena de Antropología, Santiago
j) MONTECINO Sonia, Sol viejo, sol vieja, Ed. Sernam, Santiago 1995
k) PARENTINI Luis C., Introducción a la etnohistoria mapuche, Centro de Investi-gaciones Diego Barros Araña, Santiago 1996
l) TRIVERO Alberto, Tentenvilú, Ed. La Ghisleriana, Mondovì 1993
m) TRIVERO Alberto, Trentrenfilú, cosmogonía mapunche, Università di Uppsala (Svezia), www.xs4all.nl/~rehue/art/triv1.html
42Si è svegliato il passero del mio cuore / aprì le sue ali / e si allontanò con i miei sogni / per ab-bracciare la terra (poesia di Leonel Lienlaf, traduzione di A. Trivero).