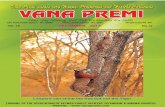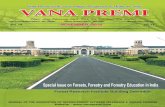Grazia Deledda, in A. Varni (coord. da), «I premi Nobel italiani», Bologna, SEPS (Segretariato...
Transcript of Grazia Deledda, in A. Varni (coord. da), «I premi Nobel italiani», Bologna, SEPS (Segretariato...
I PREMI NOBEL ITALIANIè il risultato di un lavoro di ricerca promosso dalSEGRETARIATO EUROPEO PER LE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
COORDINAMENTO SCIENTIFICO: Angelo I/arm'.COMITATO DI RICERCA: Ânclrea Battistini, Gilberto Poggioli, Ettore Verondini.COORDINAMENTO OPERATIVO: Federico Condello.AUTORI: Daniela Barbieri, Giorgio Bellettini, Silfoio Bergia, Ântonio Bertin, LauraCalza, Francesca Canale Gama, Paolo Capiluppi, Âlberto Casadei, Claudio Cumani,Gabriele Falciasecca, Alessandra Fanfani, Claudio Lorzgbi, Bruno Marano, PaoloMazzarello, Stefano Mengoli, Italo Pasqaon, Giulia Piccirilli, Giovanni Romeo,Beatrice Stasi, Riccardo Stracuzzi, Ferruccio Trifirò, Bart I/an den Bosscbe, MarcoVeglia, Umberto Zamiier.
INDICE DEL VOLUME I
PresentazioneFabio Rofoersi-Monaco
í Lee E E f IntroduzioneS I I S' l Âflgelo Wzrni
I O6 GIO _ -SEPS - SEGRETARIATO EUROPEO PER LE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 9 I _SUE CARDUCCI P1'€l'I110 Nübel per la LetteraturaMarco Wglm
Via Val d'Aposa 7 - 40123 Bologna II906 CAMILLO GOLGI - 'premio N b l ' '
Tel.: (+39) O51 271992 Paolo Mazzarello O 6 Per la MedlclnaFax: (+39) 051 265983 190 E T .
“Wvw`.ììPS.ìt@ . FraricbscaRGI:7::l: G:ø(:i:ORO MONETA _ premio Nobel Per la P3C€6-111211 . SCPS SCPSJÈ
© SEPS 1909 | GUGLIELMO MARCONI - premio Nobel erl F' 'Tutti i diritti riservati Gabriele F4/I-"1.615€C€d P a lslca
ISBN: 978-88-6923-O43-1 I926 | GRAZIA DELEDDA _ - N IRiccardo Stracuzzi premio Obel per la Letteratura
Stampa: Labanti e Nanni Industrie Grafiche (Crespellano, Bologna)1934 I LUIGI PIRANDELLO - rem' N b 1
Prima edizione: maggio 2015 Bear”-C8 Stan- P lo O 6 Per la Lettfiffifüfa
1 938 \ ENRICO FERMI - premio Nobel per la FìSìCaSilfoio Bergia
1 9 57 | DANIEL BOVET - premio Nobel per la MedicinaGiulia Piccirilli
_ - 1 L tt tu1959 | SALVATORE (EASIMODO premio Nobel per a e era raBart I/an den Bosscbe
9 59 | EMILIO G SEGRE - premio Nobel per la FisicaI . u
Paolo Capiluppi, ƒllessandra Fanƒam
Profili dei Curatori
Prgíli degli Autori
PRESENIHZIONE
Fabio Roversi-MonacoPresidente del SEPS
Il SEPS - Segretariato Europeoper le Pubblicazioni Scientyticbe, che ebbil'onore di fondare assieme al Professor Giuseppe La Loggia, è un'as-sociazione italiana senza fini di lucro costituita nel 1989 da istituzioniuniversitarie di livello europeo, in occasione del IX Centenario dell'U-niversità di Bologna e della firma della Magna Cbarta Unifoersitatumnel settembre 1988. Dal 1993 il SEPS è dotato di status consultivopresso il Consiglio d'Europa.
Obiettivo del SEPS è la diffusione della cultura attraverso un soste-gno economico alle traduzioni di opere scientifiche e di saggistica dielevata qualità, per le quali riceve ed esamina, attraverso un'articolatavalutazione scientifica, richieste provenienti da editori di tutto il mondo.
Il Segretariato ha nel proprio mandato un forte impegno a sostegnodella cultura italiana, allo scopo di promuovere iniziative di ampio re-spiro internazionale, scientificamente rilevanti ed inedite.
Il SEPS ad oggi ha riconosciuto il proprio contributo alla pubbli-cazione di quasi 900 opere, collaborando con più di 400 editori prove-nienti da oltre 40 Paesi ed è in contatto grazie alla sua Newsletter concirca 6.000 editori ed istituzioni culturali internazionali.
Il SEPS, richiamando la storia del nostro Paese nel quadro di quel-la della cultura europea, ha costantemente posto tra i suoi principaliobiettivi il sostegno alle espressioni culturali e scientifiche più rile-vanti in Italia, mediante la concessione di contributi per la traduzione
ef--1 - ;›› ._ -V † ._..~
- J 1 .' '¦` I-._'=; =,-
'_,
À* I
5f
fi ãt
1E°=
”3.=';› 11€ ..._›,_.~ ai,.; _» .:;-
.-.=›~. ››
J;=:.~-: if,
.qb
ii'i
lu
'€-ai .,«.
:iii -':'...r>` '~'.*yz -,Af;'Z-.-- ,A
L”-,=r{›.` 'K'I- f..,« ~, =. _' §';›,-›.'=*,¬' -,~»:-.-.›-.-..'
ii:-':- _' i J" '153 I, je *2'
re :~.=
1#2~=°.
3-
V ' I. _ ._ R;É. .
1». _ 'If;«'»I-,<-I-!›«
._.-;.=:-A"-51, ,,-,
'› \:_«,:
f"`.É-'tf-__ É.
'La
: 1.
...L
» ,.'.- ' › `.^__
ii _ ,›ii,-. ›;:--_`.¬e'f'*; ,
1" I ,“ ' _
'=: . . = i__»,
:';"J^` `
5
I1
-av
il›
'I*A _
k
__;
J\.*_,›_I*..€=~I-_-›“3 _
«E1 . " .22:1:"j`-›._,.¦,¬,~.,.,_1',_i _,
.>~=› '›- 5
GRAZIA DELEDDA
Riccardo Stracuzzi
1. Originali e bizzarri costumi
La scena è in un viottolo di montagna - tra arbusti, rovi e pietre - a stra-piombo sul mare, in prossimità di una cittadina sarda: è luglio, c'è caldoafoso nell”aria, e insieme nebbia che vapora dalla costa. Ela, ragazza forsedi venti o ventuno anni, ha appena pugnalato a morte Lorenzo, promes-so sposo della sorella Maria, e si è sbarazzata del cadavere spingendoloin mare. Che ne sarà ora di Ela, assassina per gelosia?
Molti dicono che rifugiatasi a Cagliari, presso lo zio, dopomolti anni si marito sotto falso nome con un figlio di esso, -altri assicurano che si fece monaca, mai più conchiudono conuna parola oscura, degna essa sola di una storia inverosimile eleggendaria come questa: Mìsteroll
Si conclude cosi la prima opera pubblicata da Grazia Deledda: è l”8luglio del 1888, e la novella esce sulla rivista “L'Ultima Moda” delle-ditore Perino. Grazia non ha ancora compiuto diciassette anni (è nata
1 Si cita da G. Deledda, Kerri e prose giovanili, a cura di A. Scano, Milano, Treves,1938, p. 117.
Grazia Deledda
il 27 settembre 1871, a Nuoro)2, e la novella risente per questo di unacerta ingenuità, tanto nello stile quanto nella struttura narrativa. Ma lesbavature enfatiche del racconto, e il lessico incerto tra voci popOlareg~gianti e registro iperletterario, non sono aspetti sui quali valga la penadi soffermarsi. Più conta il titolo, invece, che è Sangue sardo. Titolotematico, senzlaltro, ma in due direzioni differenti e insieme comple-mentari: da un lato il “sangue”, e dunque il delitto; dall'altro l'ambien-tazione sarda, che comporta Pevocazione di certi paesaggi, di certi co-stumi; insomma, di un certo esotismo (tale risultava, in quel 1888, per illettore continentale), su cui la giovane scrittrice ha già scelto di fondareil suo discorso narrativo.
Ai nostri occhi di posteri, il fenomeno del regionalismo deleddia-no appare addirittura scontato. E tale risulta proprio perché, sin daisuoi esordi, Deledda decide strategicamente di legare il suo marchio discrittrice alle immagini della Sardegna, e a quanto di esotico se ne puòtrarre. Ne fanno testo proprio i titoli delle sue novelle e dei suoi volumi,che nei primi anni battono e ribattono sull°indicazione regionale: dopoil Sangue sardo del 1888, di cui si è detto, si incontra il romanzo Fiordi Sardegna (1892) e, nello stesso anno, la novella Sulle montagne sarde.Storie di Banditi. Del 1894 sono la raccolta di novelle Racconti' sardi; eTradizionipopolari di Nuoro in Sardegna, lungo saggio sul folclore cheAngelo De Gubernatis ha richiesto alla scrittrice3. La serie conta an-cora un titolo, Paesaggi' sardi (1897), messo in testa all'unica raccolta diliriche che Deledda, nella sua carriera, avvii alla stampa.
Già da questi indizi si può avvertire che il progetto “sardo” è sceltaconsapevole sin dagli esordi della carriera di Deledda: non si tratta - Oalmeno, non si tratta soltanto - di una comprensibile inclinazione versoquei luoghi e quegli ambienti che meglio conosce. Lo spiega lei stessain una lettera del 1892 a Maggiorino Ferraris - giornalista e letteratoche di lì a poco dirigerà la “Nuova Antologia” - a proposito di Fior diSardegna:
2 Per le notizie biografiche su Deledda, qui e altrove, si rinvia tacitamente adA. Pellegrino, Grazia Deledda, in Dizionario biografico degli italiani, Roma, Istitutodell'Enciclopedia italiana, vol. XXXVI, 1988, pp. 491-496.
3 Su cio, vd. le lettere di Deledda a De Gubernatis, in F. Di Pilla (a cura dì),Grazia Deledda premio Nobelper la letteratura 1926, I\/Iilano, Fabbri, 1966, in partic. pp.393-496.
.,
mi_
åëåfi . 13.
__ _i.§*.-:,';_ ~_»,i3_¬.._.
ì:.«-'__..-,;5
-..Y..
I .Ã'›'4.f'›.«r -_ .-›.5 ,. --›..i_ ¬
__,,_,
:~.= IQ
-.is=_¬' Â"'\'¢=
3- ¦¬ I -CEP
x _ ' _-" 5.I-L -
~. -' 1_-V __
lìI
_L_L*
Z ~›
5 1ß›
.
K
-li.
I lo«I
i.r 1'
-L- I
iz'. _ _Pt-ih
=._¢__ E_ _ ,
:--- _.af"if'_-
,._ .~ 4- .,_is -f._,_9. ..ig-: i
:È'jå'._ I -¦'
,ip _=,. /~¬; .J\›â'_¦, -1
_ 'eflisi.
_=. e¢~:›`-*
$< -«
.*_›.. «s«›1.*-"›;)«':.,'~.'!«,.›~_ _ ._ ›
'.ä}i'›<`i'%:«'
Qt.)._'ì_$-ir..; .__,í.!
_;,-_; ,›.i HL.-92
I-.':- _-“'=“_›; _-;-____›;.ft
-1..7'l«. 'V
,-.-'1,=“l'«'./"al-' -'
f_).° É›=:.:=.›-_ ;_..
f_› ._ .,,. 0_› I
.;,†°.«'.>._-fa1" , ';,, . 5: -
li*.>_ _“___
_I' 1 L"._. ,ts
1,' *_À
-`›`3.*'.'J'
.`_'-r; Il __;.;,?.»._- 3',-_ :_
i
. _,IH i~
--" . -')`.,_<_ ..
frliši .._
È":Iai
'__
3" alii
Premio Nobelper la Letteratura 1 926
La scena di questo mio romanzo e in Sardegna, in una pic-cola città e si svolge parte fra i monti e parte in riva al mare.
Descrivo fedelmente i nostri originali e bizzarri costumi,gli splendidi sconosciuti paesaggi, gli usi, le passioni, i tipi,tutto il meglio insomma che può essere di attrazione per ilpubblicof _
È questo il mezzo che la giovane scrittrice individua as_s_ai precocemen-te per ottenere credito presso i “mercati continentali del ro1_rIanzo°:usare la Sardegna per intercettare i gusti di un pubblicofin de szècle cheama l'esotico e il “primitivo”, e che per ciò è particolarmente incline adapprezzare novelle e romanzi nei quali coesistano sguardo folcloristicoe romanzo d'appendice6. L'esito corrisponde perfettamente alla strate-gia, come testimonia il largo successo di vendite e traltltl?/10111 dl C111godranno, nel volgere di pochi anni dopo l”esord1o, I libri di Deledda Eciò anche a costo di quell”aura di banalità o di mediocrità che la critica- esemplare e tempestivo, in questo senso, il giudizio di Serra” - vi haintravisto da sempre.
D°altronde, che la formula dell'arte deleddiana risieda in questa“scoperta della Sardegna” è cosa che registra assai presto Euigi Ca-puana, nell'articolo che dedica alla Via del male, il primo tra 1 romanzidi Deledda a ottenere significativa eco nazionale, uscito nel 1896 epoi - ogni volta con revisioni - nel 1906 e nel 1916. Capuana ne_ scrivequando esce la prima edizione, e chiudendo l”articolo Invia alla giovanecollega un cenno d'approvazione che, tra le righe, è anche un avver-timento: “La signorina Deledda fa benissimo di non uscire dalla suaSardegna e di continuare a lavorare in questa preziosa miniera, dove hagià trovato un forte elemento di originalità”.
4 G. Deledda, Versi e prose giovanili, cit., pp. 13-14. _ _ _5 F. Masala, Intervento, in G. Petronio et al., Convegno nazionale di studi deleddianz
(Nuoro, 30 settembre 1972), Cagliari, Fossataro, 1974, pp. 272-273. _5° Vd. E. De Michelis, Grazia Deledda e il decadentisrno, Firenze, La Nuova Italia,
1938, pp. 12-28. _ _7 R. Serra, Le lettere (1914), introduzione e commento a cura di G. Benvenuti,
Bologna, Clueb, 2006, p. 111. _H L. Capuana, Grazia Deledda, Alfredo Panzini, in Gli “isrni” contemporanei. Ve-
risrno, Sirnbolisrno, Idealisrno, Cosmopoli'tismo ed altri saggi di critica letteraria ed arttsltffl(1898), a cura di G. Luti, l\lilano, Fabbri, 1973, p. 97.
176 177
Grazia Deledda
2. La scoperta della Sardegna
E proprio questo, in fondo, l'argomento cui ricorre Henrik Schück, inuna relazione di alcuni anni dopo (settembre 1920) nella quale proponeche il premio Nobel di quell'anno sia assegnato a Deledda. Storico del-la letteratura, docente dell'Università di Uppsala da poco in pensione,membro dell Accademia di Svezia e proprio a partire da quell”anno ~in seno all'Accademia - anche della Commissione Nobelg, Schück èpersuaso che Deledda appartenga a quella ristretta cerchia di scrittoriche meritano il Nobel, e svolge per questo un intenso lavoro di convin-cimento in suo favore presso i colleghi accademici.
_ Ora, in questo settembre del '20, Deledda è giunta alla sesta can-didatura. Proposta una prima volta nel 1913, la scrittrice è poi nellarosa dei candidati quasi ogni anno, con l'eccezione del 1916 e del 1919Anche in questa occasione, come già in passato, il suo nome non attiraparticolare consenso da parte dei membri della Commissione, che le
° , ° 1 .preferiscono senz altro Knut I-Iamsun. Unico oppositore di Hamsun,e insieme unico difensore di Deledda, è proprio Schück, che affida il_suo dissenso a una relazione ufficiale. La scrittrice, ai suoi occhi, ha ilmerito indiscutibile” di aver i
scoperto e presentato una terra nuova Ha scoperto laSardegna. E come pittrice della sua natura ella e del tuttoinsuperabile. (luesta natura, il gioco delle luci durante le di-verse ore del giorno,-il mutare delle stagioni, tutto questo èreso con una concretezza di cui ho trovato pochi eguali. Al-trettanto poetiche sono le sue immagini della popolazione,le descrizioni delle processioni religiose, dei mercati, dellefunzioni nelle chiese dei villaggi e sulle alture, e così via. E itipi che ci vengono incontro nei suoi romanzi sono vivi e cidànno Yimpressione di una verità incontrovertibilew.
La__relazione prosegue elogiando le virtù psicologiche e la “marmo-re_a sobrieta linguistica della scrittura di Deledda, nella quale si rileva,d altronde, mediocre abilità nella costruzione del racconto. Da queste
9 Cfr. E. Tiozzo, IlNobel svelato. Segreti, errori e verdetti delpremioper la letteratu-ra, Torino, Nino Aragno, 2013, pp. 87-88.
1° Ibidern, p. 88.
178
Premio Nobelper la Letteratura 1926'
pecche, in compenso, sono esenti i due romanzi che Schück proponea1l'attenzione dei colleghi commissari, La via del male ed Elias Portulu(1903). Donde, la conclusione generale:
Su tutto quello che Grazia Deledda ha scritto si stende largoil velo della poesia, della nobiltà, della umanità malinconicae della compassione per gli esseri umani. Più di alcuni altriscritti proposti per il premio, i suoi romanzi d'ambiente sardorispondono alla richiesta, da parte di Nobel, di una direzione“ideale”“.
Schück, dunque, apprezza più di tutto che Deledda abbia intrapresouna sorta di esplorazione letteraria della Sardegna; il che coincide so-stanzialmente con quanto, al riguardo, annota Karl August Hagberg,in quegli anni consulente dell'Accademia per le letterature spagnola,portoghese e italiana, e in questa veste più volte interpellato sull°operadi Deledda. Nelle sue perizie, infatti, egli discorre di “descrizioni dellanatura”, di rappresentazione “delle superstizioni e degli usi e costumidel popolo [sardo]”, e della modesta riservatezza di una scrittrice ideal-mente radicata nella sua terra”.
Malgrado il parere positivo del consulente, la perorazione di Schückrimane inascoltata. I sostenitori di Deledda, d'altronde, non demor-dono, e la candidatura è ripresentata - con la sola eccezione del 1926- negli anni successivi. Si arriva così al 1927: anno difficile, come ilprecedente, per la Commissione Nobel e per l'Accademia di Svezia.Già nel '26, infatti, il premio non è stato assegnato per penuria di can-didati meritori (secondo il parere dei giurati), e così lmistruttoria” e lavotazione del ”27 dovrebbero indicare due premiati: uno per il 1926, euno per l'anno in corso. _
Riguardo a quest'ultimo, ancora una volta, ci si attesta su un nulladi fatto: le candidature pervenute, infatti, non sono giudicate idonee.Resta da assegnare il premio del '26, sul quale tuttavia la posizione di
“ Ibidern, p. 89. Il riferimento conclusivo e al metro di valutazione che AlfredNobel, nel suo testamento (trad. in E. Tiozzo, La letteratura italiana e il ,orernio Nobel,Storia, critica e documenti, Firenze, Olschkì, 2009, p. 37, n. 1), aveva indicato per Yasse-gnazìone del premio alla Letteratura, da attribuire “a chi nella letteratura ha prodottola cosa più eccellente in direzione ideale”.
12 E. Tìozzo, La letteratura italiana e il premio Nobel, cit., pp. 150, n. 10, e pp.144-145 n. 83._ s
179
Grazia Deledda
Per Hallström, presidente della Commissione, non cambia: i nomi pro-posti, per una ragione o per l”altra, non paiono soddisfare i parametri“ideali” del Nobel. E tra questi candidati, agli occhi di Hallström, nonfa eccezione Grazia Deledda: La fuga in Egitto (1925), il suo ultimoromanzo, gli appare debole per l'intreccio, sfocato nelfambientazione- che non è sarda - e privo di valore psicologico nella delineazione deipersonaggi. La chiusa della relazione di Hallström, in questo senso,suona irrevocabile: “Per chi fin dall”inizio ha trovato impossibile attri-buire alla narrativa della Deledda un valore abbastanza alto da soste-nere un premio Nobel, non sussiste motivo per cambiare punto divista a causa del suo prodotto più recente”l3.
(luesta volta, però, è l°opinione del presidente a finire in minoranza.Con Schück, che vota a favore di Deledda, si schierano Anders Oster-ling ed Erik Axel Karlfeldt. (liesfultimo, segretario permanentedell'Accademia e futuro destinatario “interno” - nel 1931 - del Nobelper la Letteratura, firma un parere largamente elogiativo nei confrontidella scrittrice italiana. Ed è così che - ribaltata la situazione creatasinel 1920, e dopo il voto plenario dei soci dell'Accademia, che ratificala proposta di Schück, Osterling e Karlfeldt - si giunge ad assegnarea Grazia Deledda, nel novembre del 1927, il premio. Il 10 del mesel'Accademia diffonde un comunicato stampa - rilanciato in Italia, nel-la notte, dall°Agenzia Stefani - con la motivazione:
Premio Nobel per la Letteratura 1926: Grazia Deledda. Per lasua opera, ispirata da un grande idealismo, che con chiarezzaplastica ha rappresentato la vita sullisola nativa e con profon-dità di calore ha trattato dei problemi universali de1l'uomo14.
Un mese più tardi, il 10 dicembre 1927, si tiene a Stoccolma, nel Palazzodei Concerti, la cerimonia della consegna dei premi. A tenere il discorsoufficiale è proprio Henrik Schück, che nella circostanza articola più lar-gamente gli argomenti sui quali, in nuce, era basata la sua relazione delsettembre 1920. Di Deledda, non senza qualche accento di benevolenzapaternalistica, e raccontata la vicenda di provinciale che ascende agli
U lbidern, p. 191, ri. 96.14 D. Marcheschi (a cura di),Alloro di Svezia. Carducci, Deledda, Pirandello, Qua-
simodo, Montale, Fo_ Le rnotivazioni del ,orernio Nobel per la letteratura, Parma, IVIUB20o7,p.77.
180
Premio Nobelper la Letteratura 1926
onori della letteratura italiana ed europea”. E da questa vicenda Sì U'21€spunto per caratterizzare il suo profilo di scrittrice, di Cui sono m6SS@ inluce le qualità con numerosi riferimenti e citazioni dalle opere (Sanguegarda, Cenere, Elias Portulu, Lìedera, Lafuga in Egitto, Tradizionipopolaridi Sardegna) e dalle lettere private della scrittrice.
Ma il punto focale del discorso, ancora una volta, riguarda la “sco-perta della Sardegna”, terra ideale e “romantica”, per Schück: dunqueprimitiva, selvaggia, e quasi biblica:
Più che in altri romanzi, in quelli di Grazia Deledda l'uomoe la natura formano un”unità. Si potrebbe quasi affermare chegli uomini siano piante che germinano nella stessa terra sar-da. La maggior parte di questi sono semplici contadini, consensibilità e modi di pensare primitivi, ma con qualcosa in sedello splendore naturale dellambiente sardo. Alcuni di lororaggiungono quasi la statura delle figure monumentali delVecchio Testamento Grazia Deledda e maestra nell'artedi fondere il realismo con l'idealismo16.
Dopo la conclusione del discorso di Schück, la scrittrice scende “conapparente calma e prudente lentezza” la piccola scalinata che separa lazona in cui siedono i premiati dal palco degli oratori. Giunta al palco,scambia sottovoce qualche parola con il re di Svezia, che le consegnail premio: “(lualcuno credette di sentirla mormorare “Viva la Svezia!Viva l'Italia!', ma questo e tutt'altro che confermato”17.
15 “In questa piccola città [Nuoro], cosi poco influenzata dal resto della penisolaitaliana, è cresciuta Grazia Deledda, circondata da un ambiente naturale di selvaggiabellezza e da gente ancora in possesso di una certa grandezza primitiva, in una casache aveva un'aria di biblica semplicità. La scrittrice non ha avuto Yopportunità diricevere un'educazione superiore e, come gli altri figli del ceto medio nella zona, ha fre-quentato soltanto la scuola locale. La ragazza, però, amava studiare e a soli dicias-sette anni scrive un racconto eccentrico ma tragico, Sangue Sardo (1888), che riesce a farpubblicare su un giornale romano. I Nuoresi non gradiscono per nulla questo sfoggiod'audacia, dal momento che si pensava che le donne dovessero dedicarsi unicamentealle faccende domestiche. Ma Grazia Deledda non si adatta a questo ruolo e si dedica,invece, alla scrittura di romanzi” (ibidern, pp. 80-81).
16 Ibidenz, pp. 84-85. Interessanti, in questo passaggio, la riduzione dei popolanisardi a organismi vegetali e l'indugio sul carattere “impressionistíco” della scrittura diDeledda.
17 M. Giacobbe, Grazia Deledda a Stoccolma, in U. Collu, Grazia Deledda nella
181
Grazia Deledda
3. Una questione a parte (ma non troppo)
La “Sardegna”, il “realismo”, l'“idealismo”: sono questi i temi chiaveanche dell'articolo non firmato che, all'indomani del comunicato stam~pa dell'./Ãccademia di Svezia, saluta su “il Resto del Carlino” il premioa Deledda. La mezza colonna abbondante che l”anonimo pubblica hacarattere eminentemente informativo, ma non si esime da una valuta-zione circa le ragioni del premio. E infatti, dopo aver discorso dell'inti-ma vocazione “sarda” della scrittura di Deledda - nella quale la rappre-sentazione di un “mondo un po' uguale e limitato, ma intenso in tantavanità e sfarfallio della letteratura circostante”18 costituisce la motiva-zione primaria - osserva che le ragioni più profonde della scrittrice nonsono da cercare nell'ambiente sardo dei suoi racconti, né in un qualcheregionalismo (0 “vago naturalismo”) dal quale sarebbe afflitta. Deleddatroverebbe il suo ubi consistam, invece, in “contrasti universali, veritàeterne sulla vita e sul destino, in un elevato clima poetico”. Donde, laconclusione: “Grazia Deledda scendeva così dalla sua terra di Sarde-gna agli orizzonti dell'umanità interiore; la sua arte umanizzandosi, siuniversalizzava”. La scoperta della Sardegna non è, insomma, il fruttodi un lavoro folcloristico o mimetico, ma acquisizione ideale: e dun-que collocazione, nello spazio immaginario della cultura europeafin desiecle, di un nuovo territorio letterario.
Su ciò sono sostanzialmente concordi coloro che, in questo novem-breedicembre 1927, commentano la notizia del secondo Nobel let-terario (dopo quello a Carducci) toccato all°ltalia. Sui giornali, com'ècomprensibile, si dedica discreto spazio alle reazioni ufficiali suscitatedall'annuncio19, alle reazioni di Deledda e al resoconto della sua car-riera”, alle notizie e agli approfondimenti che riguardano il Nobel e il
cultura contemporanea, Atti del Seminario di studi “Grazia Deledda e la culmra sarda tra'800 e '900” (Nuoro, 25-27 settembre 1986), Nuoro, Consorzio per la pubblica lettura“S. Satta”, 1992, vol. II, p. 431.
18 Ilpremio Nobel conferito a Grazia Deledda, “il Resto del Carlino”, 11 novembre1927, p. 2. ' '
19 La ripresa dei larioriparlamentari. Lomaggio della Carnera a Grazia Deledda, “ilResto del Carlino”, 2 dicembre 1927, p. 1; La Sardegna sijørepara ajesteggiare il ritornadi Grazia Deledda, “ll Popolo d'ltalia”, 15 dicembre 1927.
2° Come la Deledda lia accolto la notizia, “Corriere della Sera”, 11 novembre 1927;CP., I suoi romanzi, “La Stampa”, 11 novembre 1927, p. 3; Poesia efamiglia. GraziaDeledda parla della .ma -vita e della sua arte, “il Resto del Carlino”, 12 novembre 1927.
Premio Noåelper la Letteratura 1926
viaggio di Deledda attraverso l'Europa21 Non mancano poi i “ritratf”. _ _ ° › 1p di Deledda, per disegnare i quali sono convocati scrittori e ,gior-nalistí
É culturali di solida fama (è il caso, per esempio, de “il Resto del Carlino”9
-¬ '.›.¬"¬ ~` '' 1.- ;'1*- ----.o».-
“ che il 16 novembre pubblica un articolo di Arnaldo Frateili o de “LaJ. - - E ,
” Stampa”, Chfi per la bisogna si aflìda - il 12 dicembre - a Giuseppe Ra~' ve nani) 0 ma ari firme d' ' ' -' “ -g _ › _ 8 1 Vero prestigio. il Corriere della Sera”, per
esempio, ricorre a Pietro Pancrazi (13 novembre) mentre “Il P0p010Ègf 1,.g dqtalia” chiama in causa Margherita Sarfatti. La quale dopo la pub-<*,<¬._;.__. 5,
-f xj.t blicazione italiana di Dax - “biografia autorizzata” di Mussolini con3
Yi refazione d' t” ' › . _, _. P 1 (11168 Ultimo, apparsa nel 26 per Mondadori - e tra gh-›;,-.,_., :=. ,-- ¬¬: -. ff.: ' intellettuali non solo più influenti, ma anche più rinomati del regim
. e.illjarticolo di Sarfatti, sotto tutti i punti di vista, non è diverso dagli
altri che escono in questi giorni: spunti, argomenti elementi bio. . . ra-fici menzionati, elogi e tenui riserve sono riconducibili per ese g'
. ., . . . __ › ITIPIO. a quelli gia citati di Schuck e dell'anonimo articolista de “il Resto del,Carlino”. Ma “ll Popolo” è il quotidiano politico fondato da Mussolini
§ e quindi anche il premio per Deledda deve essere ricondotto più cheI I ,
. i si riesca a ' ' - - - . . . , una buona notizia per il regime. L°impegno di Sarfam Inl 1 questal direzione è ammirevole: ma il risultato non convince. Vi si sen-` 2 te ma ra - - . ., › _g 90 fUFf0› 10 Sf01°Z0. Certo, l'articolista non si esime da recisei = asserzioni in chiave politica, come per esempio-
. Sšìlãgaclìlšltìdåìå :E: tgpêgåipšsqtã, una dohnna italiana. Per .C1L_1eT
P 0 lbperosa figura della donna italinc a-nl” l”mAm“““m'“ B““im““che nessuno nomina di cui nes ana. a -avonlmce Sllemilosa› suno mostra di accorgersi ma
9 che è - - ° - . . ,veramente il perno e il nucleo della nostra civiltail lii italiana.li
1 _ 1- -
M L “1 Ilpremio: 720. 000 lire. Prirfa della Deledda non leolie altro Italiano che Carducci@ H Sr , ii _ , ›ampa novembre 1927, Sono contenta per l Italia e per la Sardegmf 1-bidem;
ll Premia Noa-z aa Da/ma - ”3 _ a con erzto c ' ' -\ Il “ _ f ori footo unanime [il che, come ora sappiamo, non, SpOnd I ai _pì S e a vero], Corrlerß della Sfifë-1 › 12 n0V€mbf€ 1927; Grazia Deledda andrà a
. t0CC0lmg j _ “ , _ n
gna delpremio Nooel a Graziia Dlilr12/26 fllllaiì Sera , 8 dicembre 1927; La solenne come-_ G _ I ` e ua, . 1 esto del Carlino , 11 dicembre 1927, p. 5;i Tazza Deledda rzcefoe dal Re dz Szie,-2:14 zi1 premio Noåelper la letteratura “Corriere della
`“ Sera”, 11 dic b 1927- L ~ - °g “Il ,em .re ., a cerimonia della consegna delpremio Nobel a Grazia DglgddaPopolo d Imi ,11 d b 1927 - . ›
Carlino”, 18 dicdilnbre 19(2”7”i1P.rÉ. , P' 1, Gmzm D““““”“““ “Om” Z" Im'/ia, “il R€St0 del
_¬.›5,_'-1.«ggn:F!.;2:..Ø
Grazia Deledda
Che Deledda sia “tipicamente” italiana, e dunque italiana nel modoe nei termini che il regime va, un po' per volta, tipizzando, È: proprioquello che diflicilmente si potrebbe sostenere. ll che vale anche neicasi, com°è questo di Ârmalena Bilsini (l'ultimo romanzo di Deledda,uscito proprio nel 1927), in cui la vicenda narrativa non sia ambientatain Sardegna. Se Sarfatti tenta di trasporre Deledda in chiave fascista,lo fa - occorre notarlo - un po' di sfuggita, solo nel penultimo capo-verso dell'articolo, come si trattasse di dovere d'uflicio. E d'altronde lastessa sensazione suscitano le reazioni ufficiali del capo del governo allanotizia del Nobel deleddiano. ll “Corriere della Sera”, “La Stampa” e
«~e~'fl.éí-:1;i›',=ì;~=aifigirif-ff«;_=:aLf4”
.,_«.;___'” _<"C.,-.
“il Resto del Carlino” (quest°ultimo a p. 7), come altri quotidiani, il 12novembre 1927 si limitano a pubblicare una nota dell°Agenzia Stefani:
Le congratulazioni dell°on. Mussolini | Roma, 11 novembre,notte. l Appena giunta la notizia delliassegnazione del Pre-mio Nobel per la letteratura a Grazia Deledda, il Capo delGoverno ha così telegrafato: | “Vogliate, vi prego, gradire lemie congratulazioni, in quest'ora in cui il mondo consacra lavostra gloria di scrittrice italiana” l Grazia Deledda ha ri-sposto col seguente telegramma: | “Gloria ambita sopra ognigloria è in quest'ora per me la parola di V.E., che solleva lamia volontà di onorare l'ltalia e il suo Duce." | ll Capo delGoverno ha fatto anche pervenire all'illustre scrittrice un fa-scio di fiori.
Al sobrio scambio di telegrammi, la “Gazzetta del Popolo” del 26 no-vembre e “ll popolo d°ltalia” del giorno dopo aggiungono una nota dicolore: in entrambi i quotidiani, infatti, è pubblicata una corrisponden-za di Bruno Carocci che riferisce della visita di Deledda a Mussolini.L'incontro, nel salone della Vittoria di Palazzo Chigi, è denso di emo-zione e ossequio reciproco, secondo le parole dell'articolista. Mussolinibacia la mano della scrittrice, e Deledda “è turbata dall'atto”: “Sente ilcuore darle un balzo. Vorrebbe dir qualche cosa. Vorrebbe trovare unaparola sola, grande, comprensiva, ma non trova che un gesto. Trattienela sottile e diafana mano del Duce e vi stampa sopra un bel bacio-ne, di quelli che solo le mamme sanno dare e che non si dimenticanomai”. Nella conversazione che segue, Mussolini parla a Deledda “conardore e foga” del popolo italiano. La scrittrice, commossa, gli notificala propria condizione di “mezzo romagnola” e, alla sorpresa di lui, spie-. ,›ga che trascorre “da tempo immemorabile sei mesi dell'anno a Cervia .
_- - .vg`S_*^
-la . .~.: Vmv. ..-i,í'=_ ›- ~É ___", '_.i-¢;e=.'ç¬:`^
'r' _›
-_¬, « j =.É-”“,;¢. .
1.' 1 C\31;', _ --.:;.`' .-551-._,w
-=,-:~. -¬
Sw.
.A ~?¬..!- * V
f.=;-'ivi-.;'<.' ''S (levi:-
« 2;;1:.
'-7'* '”›È.'_.›“i››'~“ ..3 V~,i:_n kí1:-8'» ,›.^-*%.-;._'.-2-_' ..« .›-' '›
Y*'
"ÉÉÃ _? -W~ 1-i" +«'.';'art' f';_
-;'_'› ›'.1 }~:e__;;;¬I¢ :_ore
'=Pra:-1;-.ri fi»
;s;,¢:=,_ )¬_._',,§:', :
:f-›f;:=†.+›:Ø
,_ _,_, .,..1 ii: -è-1:;ii-'zfš-` ,
'åv
-É” -. ; .F --.¬ ii- _, _ N _.iu
-5,:4,
ar H'
4 1..ir
r aida
“-kasìn
É
2^- “ii .
É ._
li.._:-.,_ -:~ .=;¬ - --'. t.
1.-1 ."ÉI.«
Il
` __". _ .-;'_': 3'1 _. ~;-.ii -_._ .i
'=* _ §__..,-,
=›1,'›=,_ __.: -,
.Z
J «,, ¢4_F..\
*Zam ›-
' ^-“-..<.-.›- av..ÉÉPÉ›.1,Lj.-2-'_ .,~"ir” f.› &§__,§¦ì;- _
_›_,i› «,F:;._-___;¢_
_,irIn`_;_..`;~;_» V -,:";.1i,.çapf-*_
'1:.“ '. J›fi'›'«~›.1'I '
_ :_-._{;š_;
'.ir=<} ._.vi _. '
__1« ff :I ',-. __
- ti--tra sr? _›Ir _«-1.» .:
a›'
Premio Nobelper la Letteratura 1926
Poi il capo del governo dona a Deledda una sua fotografia, in corniced'argento, con dedica (“'A Grazia Deledda - con profonda ammirazio-ne - Roma, 25 novembre 1927 - Vl - Benito Mussolini'. Tluegto 5; 11" b l ' ' ' ° › . .pit; le premìio che io) potessi desiderare , commenta la scrittrice, e nella
g0 fl 3 Voce e trema )- Dfilfiddfi, H quel punto, gli presenta il marito e ifigli, e sulla nota famigliare, finalmente, la visita ha termine: “Di fuori,quandol uscio si è chiuso, io ho provato un profondo smarrimento. Latesta IT11 b1'UC12lV21. H0 sentita l'impressione di svenire, cosa che nellamia vita non avevo mai provato”.
_ ìlån ffl'-1nCafl0› Sì \te_de_, turbamento, batticuore, trepidazione, e cosìvia. . a-c e. qualcosa di irrimediabilmente freddo, ossia di “pre-Stampa-to , in simili corrispondenze o cronache. Lo si avverte particolarmen-te Ogglilìlopo molti d€C€f11'1i› 1.1121 npn appartiene solo a un effetto deltempo. a propaganda di regime, infatti, è strutturata anzitutto sulla
` et' ' ° - - _ _ _rip ttizipneíì su 211 replica standardizzatae.incessante degli enunciati,P111 OS 0 C 6 SU Singolo atto propagandistico. ln questo caso, tuttavia,la ripetizione manca: la maggior parte dei giornali non diffonde la cor-rispondenza, e si limita invece a menzionare il dono della foto (incor-niciata), spedita però a casa della scrittrice. La quale, interrogata da ungiornalista svedese sul capo del governo italiano, durante il soggiornoa Stoccolma, risponde con imbarazzo: '“E Mussolini? - domanda 11giornalista. “E una questione a parte' - risponde Grazia Deledda”-22.
ln.questo imbarazzo, e nell°incertezza con la quale il regime si ap-propria del premio, non c°è ragione di spingersi sino a vedere un larvatodissenso di Deledda nei confronti del fascismo, né - dalla parte opposta" Uiåaqualche speciale diflidenza del regime allindirizzo della scrittri-ce. .iu semplicemente, in questo momento, entrambi gli attori stannoSfudiandosi, e ancora devono decidere quale sia la strategia miglioreper intrattenere, rispettivamente, un proficuo rapporto. ll che induce aãlåãrire qualche dubbio intorno a una certa vulgata memoriale, moltod uente su biografi e studiosi, secondo la quale il fascismo per Deled-
a Éfcbbfi per l appunto, una “questione a parte”.di d H Scrihttrice - sostengono un po” tutti gli studiosi, anche a distanzaC a :cenni dalla -morte - vive appartata rispetto al bel mondo letterario
g 1 @V€11'f1 lfilllflfll del SUO tempo. C'è addirittura qualcuno che rin-
zz I . ( _ _ _Cit Domandå 9 fephcd 51 leggonfì H1 M. Giacobbe, Grazia Deledda a Stoccolma,
10|?
Grazia Deledda
traccia, nella narrativa deleddiana, una sconfessione implicita ma noncasuale della cultura patriarcale italiana: “nella vita come nella lette-ratura, Deledda contraddisse sia lo stereotipo tradizionale della don-na scrittrice, sia una politica fascista della cultura intesa a segregare laproduzione culturale femminilem. Se non tutti gli studiosi giungono aconclusioni così nette, è in ogni caso comune e diffusa - negli apparatibiografici che si vanno progressivamente sistematizzando dopo la mor-te e dopo la definitiva canonizzazione - l'immagine di una scrittriceschiva, che conduce la propria esistenza “nella abituale riservatezza enell'assiduità del lavoro”24, e dunque appartata anche rispetto al regime.
È tuttavia difficile che uno scrittore, soprattutto se occupa una posi-zione ben rilevata nel mercato delle lettere, non sia toccato dalle vicen-de politiche del suo tempo. Nel 1925, per esempio, Deledda - da tempocollaboratrice del “Corriere della Sera”- è tra coloro che interromponoil loro rapporto con il giornale a causa della brusca rimozione di LuigiAlbertini dalla direzione. La cosa non piace a Ugo Ojetti, chiamato daMussolini in persona per “riallineare” il quotidiano alle posizioni delregime. E così, scrivendo nel marzo del '26 a uno dei redattori del gior-nale, Ojetti rifiuta bruscamente una nuova proposta di collaborazioneda parte di Deledda, che intanto sta cercando di tornare sui suoi passi:
Caro Bottazzi, I Non posso accettare la proposta di GraziaDeledda, e devo francamente dirti che il modo con cuiha voluto abbandonare il Corriere e poi quasi accusarci diaverla noi condotta ad abbandonarci, mi fa dolore, anzi, ira.
lo ho per la scrittrice, una altissima stima: questa stimanon muterà. Ma l'offesa che deliberatamente ella vuol fareal giornale da me diretto, né la tollero, ne la dimentico. I lldanno maggiore non sarà per il Corriere”.
ljintransigenza di Ojetti pare granitica, come testimoniano una seconda lettera inviata al redattore Bottazzi, e una alla stessa scrittrice”. La
uale erò nel novembre del '27 ha ricevuto il Nobel ed è divenutaq › 1 1 _ Deledda S d M ' . ._ __ _ 7 _ , ar us adesani, allora trentenne e, di li a poco, autore di due raccolte di
23 R. Pickering-lazzi, Deledda, Grazia, in V. De Grazia, S. Luzzatto (a cura dì),Dizionario delfascismo, vol. l, Torino, Einaudi, 20052, p. 407.
24 A. Dolfi, Grazia Deledda, cit., p. 171.25 Cfr. il Carteggio Deledda-Ojetti, in lVl. Ciusa Romagna (a cura di), Onoranze (1
Grazia Deledda, Cagliari, Società poligrafica sarda, 1959, p. 92.2° Ibideni, pp. 92-93.
Premio Nobelper la Letteratura 1 926
- sulla scena internazionale - una gloria d'Italia. Ojetti, a quel punto,cambia parere: le invia le sue congratulazioni, e le fa sapere da altri chepuò riprendere a pubblicare, se vuole, sul “Corriere”. Deledda, rispon-dendogli il 16 novembre 1927, non manca di festeggiare l'assoluzionefinalmente ricevuta: “La sua lettera, giunta contemporaneamente adun telegramma del Comm. Tumminelli che mi annunzia il perdonodel Corriere della Sera, mi riempie di gioia. È il più bel fiore della miafesta”27.
Messa su]1>avvi_so del fatto che con il regime, in qualche modo, occorrecollaborare, un paio d anni dopo Deledda accetta senz'altro di compilarela sezione delle Letture del Lioro della terza classe elementare (Pig 4) pub-
. _ _ ° 1blicato a Roma dalla Libreria dello Stato nell'anno IX, ma effettivamentestampato nelle officine Mondadori, a Verona, prima del 29 ottobre 1930(il coloplaon reca la datazione fascista “1930 -- Vlll”). Ora, questa “c0m_pilazione” non è episodio irrilevante: l'introduzione del testo unico perla scuola elementare - sancita e regolata da un decreto nel marzo 1928e da una legge del gennaio 1929 - costituisce, per il fascismo, uno degliStrumenti importanti con i quali nazionalizzare le masse” E Deledda
. . 7nel momento delbisogno - dopo che i nomi di Ada Negri e Dante Dini,per differenti ragioni, sono stati accantonatizg - risponde alla chiamata.b A questo scopo scrive, o almeno firma3°, un racconto a struttura
ozzetpstica elaborato sostanzialmente sul modello deamicisiano diå'”u0f'€3l_› Che lfla per protagonisti due scolari: Sergio, ragazzo studioso,
1 ° ' ' - ccbscipainato, ascistissimo e figlio di un severo professore”, e Cheru-ino, tanto somaro quanto presuntuoso”32. Le vicende di Sergio, Che-
É: Iliidem, p. 92.29 iÈ.fi'l`ìiráq:L1i1iâiliIiI,1ìS:Zol:}z!aFdella culturajascista, Bologna, ll Mulino, 2011, pp, 71-75 _
tmd. it. di L. šer O Bür ,I ašczsmo e sšuola. Lapolitica scolastica del regime (1922-1943),
30 M 'King Gmzg_¢›D- Zlšlšutpí, lirenze, La Nuova Italia, 20012, p. 401.C n. 496 a\'ranZagì,i ia he eu a. ,egendary lfz, Leicester, Troubador, 2005, p. 201
potesi c e il vero autore di queste pagine sia il primogenito di
11 l.l .Naå:år:1930íte d estate del Czreneo, Milano-Como, Cavalleri, 1934; e La gazza, ibzdein,
31 L_ F ' ' - ci - . .,, . T ,Nowarü Rob aim?? Fflšiššmv e ruralismo nei testi unici dz Grazia Deledda, Ângiolo Silfuio, er o orges avanzati, Bologna, Alfa, 1975, pp. 15-33_
32 G~D<~=1¢dd=i ei ef., I/lieu aaa ami eau fzfmmfafe Romi La iibfe' d 11sai,.IX29 b 193- - '_ “econi- Éetìure šompfiptarfãa G10aZi218Ipäpåiåe l(l)131l, P. 13. là testo e diviso in cinque sezio_' i 21, 1 ustrazioni i Pio Pullini, pp. 3-151; Reli-
Grazia Deledda
rubino, dei loro genitori, dei loro compagni e del loro maestro sonointervallate da ispirati capitoletti in forma di parabola: il racconto di
l d' M solini (“È una di quelle povere ma pit-Ilfìãl V1Sl'Efi alla C383. nata 6 1 USn u u c 0 0 n b
toresche casette dai muri scrostati ma a noi quei gradini sem ranoI 1 G d t
quelli davanti ad una chiesa, e con vera religione, dopo aver guar a ola orticina chiusa penetriamo nella camera dove Egli nacque”, p.)P l f ` ll Guccio che nell otto-11)° la rievocazione dell'eroico gesto de anciu o9
bre del '22 - durante la marcia su Roma - ruba legna ai contadini co-munisti per riscaldare una camicia nera ferita (ed è cosi che i comunisti
` ' e nel via io verso Roma,si convertono, e si uniscono alla camicie ner gg29-4O)33' la visita della regina ai fanciulli ammalati, in un ospedalePP- -›
(“ella era la Regina d'ltalia, e alle Regine buone come lei Dio concedeo ni grazia” p. 66); la storia del ragazzino Giovanni Battista Perassog ›detto Balilla che, nella Genova del 1746, incita i concittadini a ribellar-si agli invasori austriaci (pp. 75-78)”, e cosi via.
Insomma, se nel 1927 il regime è ancora titubante nell”appropriar-si di Deledda e del Nobel che l°Accademia svedese le ha conferito,tre anni dopo la decisione è presa: la scrittrice è diventata una dellepiù autorevoli voci della cultura nazionale, e impiegarla per la di-vulgazione scolastica della nuova “idea totalitaria è gesto senz°altroconveniente.
153-208' Storia, compilata da Ottorino Bertolini, pp. 209-328, eografia, co pPP- ›' ` ' 372 A it etic com ilata da Gaetano Scorza,dal professor Luigi de Marchi, pp. 329- e r m a, p
pp. 373-445.' ' ` ' ' ' ` ti?:“- lo ho33 Come spiegare agli scolari di terza elementare chi siano 1 comunis
h siano - disse Cherubino. \ Sergiosentito parlare dei comunisti, ma non so c e cosae Anselmuccio si misero a ridere er Yin enuita del loro com a no. - I comunistiS P g
` ttano l'ordine,- s ie ò con dolcezza il signor Goffredo - sono persone che non rispeP 8
` d ll” d' 'd ma anche della società umana: e so-il quale e il benessere non soltanto e in ivi uo,pratutto non comprendono i diritti altrui conquistati con il sacrificio. I - Non capisco
' " ` ' '_ \- F conto: tu copi il- disse Cherubino che aveva un po lanimo del comunista aproblema di aritmetica che ha svolto Sergio con fatica. Il maestro ti chiama e con faccia
a 0 0 I h O n
averlo fatto tu. Fai una bella figura con la fatica di Sergio. Ecco c e sei utosta dici d”po” comunista” (ibidem, p. 32 _
34 Un refuso, a p. 77, proietta i gi1846.
alfa? 2.9' «'-.'«;~= 1-. '. .s~
i›¬.-;:«1;`- _›''†-_«.
giane, compilata da Monsignor Angelo Zammarchi e dal Reverendo Cesare Angelini,` ' ' ' ` ° G m ilata
'l 'ovane Balilla avanti di un secolo, nel dicembre. ¬-F ..-
.- » -_› . _. 1
Premia Nobelper la Letteratura 1926
4. Vera gloria?
Di queste titubanze, e di questi gesti ritardati del regime no b'0 q . Il
stupirsi. Grazia Deledda, nel 1927, è una scrittrice o ol , . lsogna2 .allestero; ma il suo è un successo pluridecenna1 E P are, in patria e. _ e ° ›talia umbertina prima, e fiorisce nel quindicen , › É clåefmoglia nell I-. nio °
e la Prima guerra. La società alla quale la SC ,tt fa hinizioldel secolo. _ ri rice a par ato con isuoi .romanzi e le sue novelle, non è facilmente convertibile in quelfim-
magine di palingenesi che il regime ha promosso ne 1. . dascesa, e che ora sta brutalmente appligando H lg 1 aqni ella sua
. _ _ a area tà itaia ,la prima candidatura di Deledda al Nobel è avanzata in un na getto,in cui cultura e politica si intreccia ' am lente110, ma siamo nel 1913 e i fi °› rmataridi quella proposta appart 11 . .deniltaha postunitarìa neílììììouatílanälìåãë dirlgcnte che e espressione
A candidare inizialmente D l - - . ,do Martini: docente di Dírittš ìddtatsono Lpigi Luzzatti e Ferdinan_os i uz -
S€I121f0r€, ministm 3 Presidente del COnSi1g(ìi1f:l(e› íìcfflomistíl, deputato,- . _ . _ io ne 1enn` 1 _il pršmo, il secondo giornalista, scrittore deputato senot 910 19.11)'Sti-O3 . A 101,0 danianno su _ _ .7 - › il Offi C IT11111-
Plomatico svedese di stanziìclíìisdií, Sliumclsce 11 barone Carl Bildt, dì*H 011 1'aepoiaRoma d 1membro dell'Accademia di S ' ' 1 6 a 1901_ vezia. Sicché a t' ddldatum di Deledd . . › Pfif IIC al 1914, la can-21 S1 giova della pi-0 “ ›› -. . . posta esterna di du 'uomini di Stato e intellettuali ' ' ' 6 autorevoliit l - .candidature al NObe1_ Secondo 5 1i:ni1(che hanno titolo ad esprimere
rispettivamente soci dell'Accademiag(d Smfiilto F161 årcmlo _ in Cluanw5- el lnce °quella < mtema” di un accademico Svedese i e ella Crusca), e di
Ma da arte itali ° - 1abbastanzaI1“freddam3e1iìi2ieí)C<-È(df:il:tiii›1riil), ll nome di Deledda è avanzatorl n c 0
d°P0 sol0 quattro re l' h 1 l e Épmposte ufliclah S1 arrestan-0»deSi_ . _ P IC ei 3 1918. Dall anno successivo sono li sve-prima Bildt da solo, e in seguito anche Schückßf, _ ai mamegnere la
ss Per una prima introdu ' 11vpcl a loro dedicate dal Dz_zz_0níz_:ì?0 ia gm; C1; olauzzatti e. Martini, sono da vedere ledi P. Pecorari e P.L. Ballini (vol. LXåI ]21Ã(}J07€g1 2162126-:inz7,?›Cfit.: rispettivamente a firma
1 2008, pp' 216_223)” con bíbllogfaifia di riååimento. ), 6 dl R' Romanelli (V01-36 Uifeccezione è costi 'tuita dalla candidatura d91 1921, avanzata da BildÈ maSoffüscritta anche da diciassett ° - - . _ _ ,S ,_ _ _ _ .e accademici italiani (tra i quali Isidoro Del Lungo)
1111 intermittente nomznat d D -Set i Zifiemíur. Nomineriflgaíaoršb Ltlåìììdúìì ìlglšlpbpš, Silíìnslën (a cura dì)› Nobêfiirz-_
" › TOC 0 rn, Svenska Academíen
Grazia Deledda
scrittrice tra i candidati del Nobel letterario. ll che sembra consuonarecon le indiscrezioni che circolano già all'indomani del comunicato uf-ficiale dell°Accademia di Svezia del 10 novembre 1927: nella conversa-zione con un anonimo giornalista - che ne riferisce sul “Corriere dellaSera” del giorno successivo - è la stessa Deledda a ricordare che
dieci o dodici anni fa, quando i suoi romanzi erano già cono-sciuti e diffusi all'estero, alcune persone straniere, che ammi-ravano llarte sua, vollero interessarne l°Accademia svedese. Atale scopo fecero preparare una relazione, che, dovendo por-tare per le disposizioni che regolano la Fondazione Nobel lefirme di due membri di accademie, fu firmata da Luigi Luz-zatti e Ferdinando Martini. Per qualche tempo ella non ebbealtre notizie, ma nel 1918 lesse sui giornali che era stata postala sua candidatura al premio. Poi di nuovo silenzio.
Sulle notizie circolate intorno alla sua candidatura, tuttavia, Deleddanon racconta tutto quello che effettivamente sa. La scrittrice è a co-noscenza, infatti, di un episodio risalente al 1917 che testimonia diun certo interesse, a suo favore, all'interno della stessa Accademia. Ri-chiesto numerose volte di aggiornare la sua perizia sulla produzionedeleddiana, Hagberg, consulente della Commissione Nobel, si rivolgea Dino Provenzal, docente di Italiano, scrittore, critico letterario edestensore di fortunati commenti scolastici dei classici italiani”. ll 15aprile, dunque, Hagberg scrive a Provenzal per chiedergli “si GraziaDeledda (que ƒadmire beaucoup) a publié quelques livres ces trois der-nières années et si on a écrit quelque chose d'importance à sujet d'elledans le pays”. E aggiunge: “]e n'ai guère besoin de vous dire que je seraisbien heureux si un jour quelque auteur italien moderne pourrait rem-porter le prix Nobel de littérature”38.
och Norstedts Akademiska Förlag, 2001, vol. I, 1901-1920, pp. 285-398; e ll, 1921*1950, pp. 3-91.
37 Su Provenzal (Livorno, 27 dicembre 1877 - Voghera, 11 aprile 1972), la piùesauriente nota bio-bibliografica è costituita dalla scheda compilata dai curatori dell°íI¬rventario ordine dell°Archivio storico di Voghera: <http://wwwilombardiabeniculturaliit/archivi/so etti- roduttori/ ersona/MIDCOOOBO8/› (ultimo accesso, 13 aprile 2015)88 P P
38 Lettera di Karl August Hagberg a Dino Provenzal, datata “Stockholm defl15/4/1917”, su carta intestata della “ Svenska Akademiens Nobelbiblìotek I Barnhusga"tan 18”. La corrispondenza di Deledda a Dino Provenzal (comprensiva di 17 lettere C
Premio Noåe/per la Letteratura 1 926
Letta la richiesta di Hagberg, Provenzal scrive a Deledda per averenotizie da inoltrare a Stoccolma. La scrittrice, con la risposta del 18aprile 1917, dà indicazione degli ultimi romanzi su cui attirare l'atten-zione del consulente svedese (Marianna Sirca, del '15, e la terza edizio-ne de La foia dei ma/e, del '16); e aggiunge, in un post scriptum: “S'Ellacrede può pure scrivere al prof. Hagberg che tanto di Marianna Sircacome della ristampa della Via del male la critica italiana s”è occupatadiffusamente e benevolmentew. La lettera, tutto sommato, è moderata:Deledda fornisce notizie alquanto generali sulla propria opera, e tutt”alpiù invita Provenzal a segnalare all°esperto svedese due recenti articolia lei dedicati (rispettivamente di Bellonci e di Tozzi), ma non si sforzatroppo di giostrare - per interposta persona - una campagna a propriofavore.
E tuttavia, gli approcci di Hagberg nei confronti di Provenzal, ilsuccessivo conferimento del Nobel a Deledda, e in genere le modalitàstessa della sua canonizzazione nella letteratura del Novecento, sem-brano dipendere dal successo che la scrittrice incontra, ancor più che inItalia, nel resto d'Europa (e non solo). Già nel primo quinquennio delsecolo, infatti, è tradotta in Francia, in Germania, in Russia e in Suda-merica, ma anche in Spagna, in Polonia, in Olanda e nelle Fiandre”.
r E dall'estero che il credito di Deledda rimbalza in Italia, doveuneditore prestigioso come Treves decide di acquisire in esclusiva1 diritti della scrittrice, per stampare quanto di nuovo produce, e ri-stampare quanto già era edito. Del resto, sono proprio questi gli anni
gåclcãsšåíìtpline postali) è qeppsitata presso la Biblioteca Labronica di Livorno. Colgoraiuto che pìqrxringraziãre a ott.ssa A. Stoppa, e tutto il personale della biblioteca, per
39 3 e stato o erto nella consultazione del carteggio._, . ` Dellepisodio, Provenzal ha lasciato memoria pubblica in alcuni articoli, tra1 quali e da vedere soprattutto Retroscena del “Nobei” a Grazia Deledda “Frontiera” 51972, pp. 7-s. ' ' ”
40 . . . . .dì) Gmzljaogìçeåaircosåanzipte, al riguardo, nei saggi che si leggono in U. Collu (a curatclå Grazia D; dg ne éz cu taçiícontemporanea, cit.,'vol. ll, e specialmente: R.Tagliala-
Terza Le o ti Z ii 6- gwgeƒ ereilef N0t€.`m.w.1 epismlarw mgdm' pp' 33341; D' Della› pere e e diane a/I estero: itinerari di ricezione, pp. 313-332; A. Chiclana Car-d - - _Cålšgl. Lßcšriäazoione delle opere de/la Deledda in Spagna, pp. 343-348; K. Zaboklicki,
a E 5 4' W P0!0mfl› Pp. 355-364; W. Hirdt, La fortuna di Grazia Deledda neiJglfsi di /inguü ffdffffli pp. 365-377; H. Boersma, Storia della ricezione de//'opera di Grazia
I ' _ . .3;9'ì'ífÉa3f†;Cl?Éa”ãflßPP- 3k79T3ìi0› Dondero Costa, Grazia Deledda in Russia, pp.› - €43 fi f0UC › fa 14210728 E dßßologia de//opera deleddiana ne//e Fiandre, pp.
391-398; Maslanka, Grazia Deledda in Polonia pp, 435-442
4'.
Grazia Deledda
(1909-1911) in cui Luigi Pirandello scrive e pubblica Suo marito, unromanzo satirico che ruota intorno al personaggio di Silvia Roncella,giovane scrittrice tarantina da poco salita agli onori delle cronacheper il successo mondiale di cui improvvisamente gode. La Roncella- mera trasposizione satirica di Grazia Deledda - è “letterata di po-chi libri”, scrittrice “nativa” che vorrebbe godere della scrittura comeespressione interiore e privata, e che tuttavia il marito spinge a forzasul proscenio del bel mondo letterario”“. La testimonianza di Piran-dello, della quale non si può tacere l'impronta maschilistica, è per noituttavia preziosa: vi si intravede quale dovesse essere, presso molti deipiù noti colleghi di Deledda (e magari presso alcuni dei prestigiosiscrittori che Treves pubblicava: Capuana, De Roberto, D'Annunzio,Verga, De Amicis, Gozzano ecc.), il giudizio sulla scrittrice. Qtiellodi un “corpo estraneo” che gli editori si contendono anzitutto perragioni commerciali.
Il Nobel, in tutto ciò, cade come una sorta di ulteriore conferma:come marchio di un'autorevolezza fino ad allora non effettivamenteposseduta, ma allo stesso tempo - e in certo senso - accessoria. Lo sivede nelle vicende della fortuna post niorteni di Deledda: la sua per-manenza tanto nel mercato editoriale, quanto nel canone scolastico enel campo della comunicazione di massa (cinematografica e televisiva),risente del Nobel - questo è certo - ma più ancora delle ragioni percosì dire “endogene”, direttamente conseguenti alle vicende storichedell'industria culturale.
La canonizzazione editoriale di Deledda, per esempio, si presta afacili rilievi: autrice di punta di Treves, entra dal 1940 nel catalogo diGarzanti, lleditore che rileva la casa Treves, le cui attività sono intantocessate con la promulgazione delle leggi razziali”. Dopo un anno, Gar-zanti vende a Mondadori - che ha effettivamente occupato il ruolo diTreves nel mercato - l°esclusiva dei diritti di Deledda. Cosi, tra il 1941e il 1959 escono, a cura di Emilio Cecchi e nella collezione “Omnibus”,i cinque volumi di Romanzi e novelle, primo esemplare di una largaedizione antologica, al quale seguono tre ulteriori selezioni mondado-
°“ L. Pirandello, Sao marito, in Tutti i romanzi, a cura di G. Macchia, M. Costan-zo, Milano, Mondadori, 1973, vol. I, pp. 587-873; e cfr. la nota al testo, pp. 1048, per lastoria redazionale ed editoriale del romanzo.
*2 Cfr. D. l\/lanca, “I..'Edera” e il doppiofinale tra letteratura, teatro e cinema, “Bol-lettino di studi sardi”, Ill, 2010, pp. 106 e 114-115.
7--f:;_›,~__ 4
I' 2 '~:~`-
-i Rsi
›.__si1
È.5ß "_ _
3i\ ,;_.:.f-
=P
'l'-5 _*-;"›r-.`:1':.›`f›-inì
' ›_='-;_~__.W_ _:»f.
<. :L -'i_I;,__1f'!'_ ',,'
,“ si.-1-'›' -,_':_-?_ -"À ._;._,;f;f:?$ --. .,, ì
__~_,§_,'
._._.,
-..ii _¬ V.. -ff. 'ile
a_š1;9-:È.:-_;- 33-;v._7?`.}':`f“=_-›~' in .i
_,:,iE._. ;,-`-›.
'J _.'=;-¦« \ 9-.- =-i-.¬- 1_ .,.,_
ifzr"':}i'šÃ1*'5 '
=.`-=".¦"',:t `*'~'- .'111-` wp, ,_.-. .HE
. 54(--.
ii›«_ == _ '; , _
-' 'f.._:*.-* _W
'!r^
_ , ,. _ _ ,v 'fi-ffff
,§~*-›i-.-
` 3'..
'~:f_ ,ii -_ ,,,›._.i_~=.-«H-1
_¬7.åf` -1;:-:_É
gi
I'
fs_«__ . ftt:
.¬.~ ':_i.r': :iv ,,1-__-V
nia*-ii' _,_- -'1`.<*'-5'i-.___., -.»--_- -~ 4-- -_
*S-.,'›^. 3'› -äit1? :ií:L- ›`_›.»=f«= iv' -Q- .¬_,
1:-\ ›'-
__ A.
.^›_*;l~ t'›'§,...-.`i1-.ati Y. .
_ _”. .
Preinio Nobelper la Letteratiim 1926
riane43; oltre a ciò, dal 1944, Mondadori prende anche a sta '. m arevolume singolo un buon numero di testi deleddiani44. P in
Dnìlltronde, la lunga permanenza di Deledda nel catalogo di Mon-dadori (in collane di “classici” e in uelle e ' h ~._ . . <1 Conomic e), cosi come lasua piu intermittente comparsa nei cataloghi di Garzanti (num
. _ . eristampe nel biennio 1939-1940, poi un lungo silenzio e la ri r mä”eCanne al vento dal 1994), Rizzoli (una sola stampa di 'Canne P! Sa É 1_ . anel 2008), si intreccia senz'altro con la sua collocazidne mar in fm 0,
_ _ aSffibllfì _ 1161 C21I101'1e scolastico. Nel quale occorre dirlo Deleãd 6 Ii-na
. . 7 H,d'imperio nello stesso anno della morte' nel 1936 infaiti Att`l` €l\IlIra
. . _ ° › 1 10 O-migliano le dedica un buon numero di pagine della Sua Stgria letterariaper le scuole. Ai suoi occhi, la scrittrice non ha nulla a che fare con lecorrenti letterarie del suo tempo e proprio per questo è da ll .
. _ 7
vertici della letteratura italiana di Otto e Novecento' “N CO OC:-6 alil M . _ _ . - . - CSSUHO OPO, anzoni ha arricchito e approfondito come lei, in una vera operad arte, il nostro senso della vita”45.
Ora tanto lav l t ' ` › .t 1 › _ . a u azione cosi favorevole dell opera deleddiana,quan-o a sua definizione ideale in opposizione o alternativ 1a con ua un ue
tendenza enerale dell ' ' ' - q qC Realísmš regíonalìstigonarrativa italiana tra Verismo, Deçadennsmola di M . l_ _ , sono aspetti specifici di una posizione, qu¢1_
Omlg 121110» C116 ln quanto tale non fa scuola. Anzi - chiamato
43 G. Deledda Opere scelte a cura di E D '. _ , ' › - Michelis (coll “I cla ` 'rane, ltahan-n), .tà G. D 1 _ 9 U - ssici contempo-1 ci e edda, Romanzi e novelle, a cura di N. Sapegno (coll. “I me-ridiani”), cit.; G. Deledd R ' ° . . - - _(C01l.“l meridianí”), 1981ll Omanzz Sara”, (1 Cum di V' Sp1naZZ01a›M11flfl0, Mondadori,
44 N@1i944,1z 4 › - - _Z?). 1 ' segreto ell aonio solitario (prima Trev:es,1921,ora coll.“R0man_› ne 1947, C , , ,,osiina (prima Trexes, 1937, ora collana Il ponte ); nel 1950 Can-
ne al vento ( ` T 19 ii _ _ _” ›prima reves 13, ora coll_ La medusa degli Italiani ), Líedera (primaTreves, 1906 H «B.b1.Tr ora co . ioteca moderna lVlondadori ) e Marianna Simi (prima
evesi 1915, ora ll. “B bl .,, ` _co i ioteca moderna Mondadori ), e cosi via. Tra il '44 e il2000 se› nza contare le tre s ° ` ' ¬ - _. ¢1€Z10I11 Hntologiche sopra menzionate, l'editore stampa e“Stampa 48 volte Grazia Deledd ' ' 'H. N l ' ' - \ ci . ,,. _ eg 1 ultimi anni, fattasi sempre piu fgglduale laP051Z10ne di Deledda tr ` ' '_ a i classic ' ' - - - . _i novecenteschi italiani, la sua diffusione editorialeS1 affida anzitutto ` ' ` 'a iniziative sarde. D' l` ' - - - _i a dalle ristampe in collezioni econommhe deigrandi editori (ormai rare) ` 'si se nal - - - _M 1 _ _ 3 › _ g ano imprese come quelle degli editori nuoresi llaestra e o llisso . quest ultimo f' 3 par mi dal 1996› hil 1'1S'E11mpato in 6 voll. tutte leNovelle e 1 ' ' °, a tri 55 titoli, tra romanzi raccol ` '. te d ' - - - .di Nuoro in Sardegna. l 1 novelle 6 Il Sagglo Tmdzmomllofü/ari
45 A.Momiglian ,St ` dj] - -cipat0,1936,Pp_576_ O and E algfffmfuffl1f¢1l2flna,vol.lll,Messina-l\/Iilano,Prin-
Grazia Deledda
in causa e discusso radicalmente dal volume di Eurialo De Michelische esce tre anni dopo““' - Momigliano è destinato a restare, con rareeccezioni, una voce isolata. Fa scuola, però, e soprattutto grazie a lui,l'assunzione di Deledda a classico narrativo (nel '38, sulle orme di Mo-migliano, anche Sansone accoglie Deledda in un manuale scolastico)47.
Da questa posizione essenzialmente “relativa”, ossia orientata opiuttosto dis-orientata rispetto ai due grandi filoni della narrativa tardoottocentesca e primo novecentesca, Deledda non si muove: soprattut-to perché gli specialisti della sua opera, particolarmente influenti sugliautori della manualistica scolastica, sono a loro volta autori di manuali.Ciò vale senz'altro - dopo Momigliano - per Sapegno, Russo e Petro-nio48, il cui modello critico è in fondo recepito, con poche variazioni,dalla gran parte delle storie letterarie e delle antologie scolastiche, apartire dall'inizio degli anni (luaranta e sino a oggi.
In questa tradizione, il richiamo al Nobel deleddiano per il 1926 etanto un obbligo quanto un profiirrna: la ripercussione esiste, ma comese il premio in quanto tale appartenesse a una sfera tutta esteriore. Equalcosa di molto simile si intravede anche nella vicenda delle trasposi-zioni cinematografiche e televisive dei romanzi di Deledda. La vicendaha inizio nel 1916 con il film Cenere, interpretato da Eleonora Duse;e prosegue, tra 1916 e 1989, con un buon numero di episodi”. Ma alla
46 E. De Michelis, Grazia Deledda e il decadentisino, cit., in part. Conclusione, pp.270-277.
47 M. Sansone, Storia della letteratura italiana ad uso delle scuole medie superiori,Napoli, Loffredo, 1938, pp. 583-584.
48 N. Sapegno, Compendio di storia della letteratura italiana, vol. III, Firenze, LaNuova Italia, 19893 (1“ ed. 1947), pp. 247-248; Id., Disegno storico della letteratura ita-liana, Firenze, La Nuova Italia, 19732 (1” ed. 1949), p. 719; L. Russo, Compendio storicodella letteratura italiana, Messina-Firenze, D'Anna, 1961, pp. 767-768; G. Petronio,L'attivita letteraria in Italia. Storia della letteratura, Palermo, Palumbo, 19642, p. 847; G.Petronio, V. Masiello, Produzione efruizione. Ântologia della letteratura italiana, vol. III,parte II, Palermo, Palumbo, 1989, pp. 258-264.
49 Le trasposizioni sono undici in tutto. Sette, quelle cinematografiche: 1) Cenere,di F. Mari, Italia, b/n, 1916; 2) La grazia, di A. De Benedetti, Italia, b/n, 1929; 3) Levie delpeccato [dalla novella Dramma (1916)], di G. Pastina, Italia, b/n, 1946; 4) L'edera(Delitto per amore), di A. Genina, Italia, b/n, 1950; 5) Âinore rosso [da Marianna Siria(1915)], di A. Vergano, Italia, b/n, 1952; 6) Proibito [da La inadre (1920)], di M. Moni-celli, Italia-Francia, colore, 1954; 7) Il segreto dell 'uomo solitario, di E. Guida, Italia, co-lore, 1989. Sono quattro, poi, le trasposìzioni televisive: 1) Canne al vento, di M. Landi,RAI, 1958; 2) Marianna Sirca, di G. Morandi, RAI, 1965', 3) Lìedera, di G. Fina, RAI,
Premio Nobelper la Letteratura 1926
adice di ' “' ' -- ~› - _:nato mfiguestta levidente ridulpibilita' di Deledda per la scena, cine-a o e ero ' : - . _“ _d b_l_W 1 manzata C 6 S1fi›_€ ,Con tutta evidenza la primaria
ri uci i ita per a scena teatrale, cui lautrice stessa partecipa” (Fig5). E infatti, se a Cenere Deledda non partecipa in alcun modo - pro-lITš1b111`I1ÃI1'E<; Elntìhe pfi un certo scetticismo verso la sceneggiatura che
use m rosio e ' - ~, . _ ari såavano congegnando (il film sara, tra l'altro,un sostanziale insuccesso) - cio non significa che il nuovo linguaggionarrativo non le interessi: nello stesso 1916 stende un soggetto origina-le per la.Tiber Film di Roma, che poi non sarà realizzato”.
Negli anni (luaranta e Cinquanta, il cinema italiano è attraversatoda tendenze neodecadenti, ossia neorealistiche in direzione solamente“scenografica": da ciò, l'interesse per l'opera di Deledda nella quale e
facile rintracc'a ` ' - - 'al t d IN1 re motivi a sfondo rurale e folcloristico, da adattare poigus o e . eorealismo. Sara la televisione, semmai, tra fine anni Cin-
qìl21:l'£21_€ primameta dei Settanta, a ricorrere a Deledda come a uno deigqoriosi capitoli della letteratura europea, sancito come tale proprio dal
obel. M ' ' _ - _RAI íldquesiå 3VV1€1'1€ in quella sorta di campagna letteraria che la, a sa a gui a democristiana, conduce con l'intenzione neorísor-
° - rc . . . _gimentale di fare gli Italiani". E in questa campagna, come nel Canoneetterario italiano D l ` ' ° - ~ __ _ , e edda e uno dei tanti lemmi, in mezzo a ManzoniBacchelli, Nievo e così via.
. Si può dire, insomma, che la fortuna di Deledda, da un lato, e il pre-1å§rqdNobel che le e assegnato id-all'Accademia di Svezia, dall'altro, con-
ano origine e ragioni; e risultino così, in un certo senso, fenomeni
)
è9ã:{:g4%ííí1;glí1;1éf21ttcšEldallorponima novellapubblicata in Cliiaroseuro, del 1912], di C.ragiolåate in é Ou. ( quesda materia, assai utili Filniografia e Videogriyëa, entrambe
Teleroinaiizi La Deleilldiliuiiii T')›' miSardi' at" pp' 155-200' ma CIT anche A' Piras'Storia indiscmƒa della sceneggiaå,7201: š£:z1,app_l1/È1-š3ã; e O. De Fornari, Telerornanza.
50 Supra n- Deledda _' nel (Tn 3-1:11, ¬`
Guastalla, della riduzione in libretto d'o er d' 6 am e Cfjaumce' mslfme con (Tludioin Racconti Sardi, del 1894) Poi musicapo 3 gfuna P1ì0pi;g/ìnovella (Di notte, pubblicata
R0ma nel marzo del '23 e da essa È tratto nell 19'2I9€l'MO I "Chen" LOFT” va m Scena avd_D_1\/lancaj «L›Ed€m,i€ il dgppiofinaie tr I ti Omonimo film, di De Benedetti:
5' Cfr.A.Cara “Cenere"di Grazia D:l :'ldemtum'.Émƒm_€T/'6lma'C't"pp' 109-111'› «U e a nelle_figurazioni di Eleonora Duse, Nuo-1°0›1S'Eitut0 Superiore regionale t fi 1934(a Cura di), Scenari Sardi, Cit-9 P; Ippgriìógo, › PP. 57, n. 88 e PP. 114-116; e G. Oila
52 '' Vd. F. Cordova, G ' D ldd ' ' - - -co, in G. Olla (a cura di), šišiiizri :aídiaCítFešlÉa.1ÉÉšoiíäsíoria di un soggetto czneinatogm_
104
Grazia Deledda
. - ~ ' he 'lll terali ll premio influisce senz”altrO, Come S1 9 V1St0, Sul fatto c .1C0 a ' . . _ ' l ia nazionale- rn
e ime fascista decrda d1 usare Deledda divenuta 8 of _I g amo a1pf0Pflsanda;<:0Sì come iflfi“iSC@› “men” In Pam*quänto ãcrum' della scrittrice tra i classici letterari del N0V€C€m0-su a co ocazione _ _ _ a. _D”altronde è il Nobel stesso a essere 11 risultato dr una campagna in
' le” che Deledda ha saputo pianificare e real1zzare.ll premio,temazlona ` 1” ff tto di circostanze accidentali, né il f1'11'Et0 dl unadunque, T1011 9 9 9 _ - . 1 - C1'
- ' ' ione del borsrno letterario. a r1CerC21 1qualdãc e'nFIä:eve(l1Èt)1`1e fliibtluíšso di Deledda perfettamente C0ì1'1Cìd@una i entita 1 scrrt nce, ›
- - - ` Nobel oi ratifica.con le ragioni di un successo che 1l › P 1
Preni io Nobelper la Letteratura 1926
Bibliografia
, L. Capuana, Grazia Deledda, Âfredo Panzini, in G. Luti (a cura di), Gli “ismi contemporanei. Wrisrno, Sirnlrolismo, Idealismo, Cosmopolitisnio ed
altri saggi di critica letteraria ed artistica (1898), Milano, Fabbri, 1973.,-- _-. x-.. ;,;;..†.;; wi;"'w -- . m
._ 1;-._ '- , x..« 1...- 1-.«__»-t :. A. Cara, “Cenere” di Grazia Deledda nellefigurazioni di Eleonora Duse,
t <1, Nuoro, Istituto superiore regionale etnografico, 1984.
¬.fiì.s Charnítzky, Fascismo e scuola. La politica scolastica del regime (1922-1. .›.=: -
1943), trad. it. di L. Sergo Bürge, l. Pízzuto, Firenze, La Nuovaf f* - 2” 1tal1a, 2001 _
_ .r È_:7.-:É-;.:_rg_1 -_!f s
3 - -$-if» . .t-=:-:,:a›r_-:~"'- »-_ , .,,_-to -. -ai
M. Ciusa Romagna (a cura di), Carteggio Deledda-Ojetti, Onoranze a\
,Ea-_ ¬ r ,._ ìj-.
_.|.._ -. Grazia Deledda, Cagliari, Societa poligrafica sarda, 1959.\2
,JK
1 ,-.
U. Collu (a cura di), Grazia Deledda nella cultura contemporanea, Atti del"È Seminario di studi “Grazia Deledda e la cultura sarda tra '800 e '900”
W, (Nuoro, 25-27 settembre 1986), Nuoro, Consorzio per la pubblicaI
H.,p lettura “S. Satta”, 1992.;._†_.., 1,:;;v';_,¦___._ 1-.¦ ...nr-,:;:= p.:: ;,-.=š›,-1 -__ .._. :Q É.-ri; FE:-1 ai-La.'!'.<' »:=
O. De Fornari, Teleronianza. Storia indiscreta dello sceneggiato Tv, Mila- no, Mondadori, 1990.
IM
HP
*i..f.. ur G. Deledda et al., Il libro della terza classe elementare, Roma, La libreria
-..1"»~.¦.. ., . k
_ d€llO SUJIO, 1 O .
.› 'É .I _T.,._ A...
. 1 . .G. Deledda, Opere scelte, a cura di E. De Mrchelrs, Firenze, La NuovaItalia, 1938.
4 kw. gr?.›..;= <;*:;,j _4'-as', . ' '
1ti-
d0f1,19s7.-.<..›a»v V
G. Deledda, Romanzi e novelle, a cura di N. Sapegno, Milano, Monda-
-'-fw:-› I-'
.¬~.;,.,_ _,..,_a,....` ti ›-1'..
G. Deledda, Romanzi sardi, a cura di V. Spinazzola, Milano, Monda-dori, 1981.
s _ G. Deledda, Versi e prose giovanili, a cura di A. Scano, Milano, Treves,1938.
Grazia Deledda
E. De Michelis, Grazia Deledda e il decadentismo, Firenze, La NuovaItalia, 1938.
F. Di Pilla (a cura di), Grazia Deledda premio Nolvel per la letteratura1926, Milano, Fabbri, 1966.
A. Dolfi, Grazia Deledda, Milano, Mursia, 1979.
L. Faenza, Fascismo e ruralismo nei “testi unici” di Grazia Deledda, Ân¬giolo Silvio Novaro, Roberto Forges Davanzati, Bologna, Alfa, 1975.
M. Giacobbe, Grazia Deledda a Stoccolma, in U. Collu (a cura di), Gra-zia Deledda nella cultura contemporanea, Atti del Seminario di studi“Grazia Deledda e la cultura sarda tra '800 e '900” (Nuoro, 25-27settembre 1986), Nuoro, Consorzio per la pubblica lettura “S. Satta”,1992, vol. II, p. 431.
M. King, Grazia Deledda. A legendary life, Leicester, Troubador, 2005.
S. Madesani, La gazza, Milano-Como, Cavalleri, 1934.
S. Madesani, Notte d 'estate del Cireneo, Milano-Como, Cavalleri, 1934.
D. Manca, “L”Edera” e il doppio finale tra letteratura, teatro e cinema,“Bollettino di studi sardi”, III, 2010, pp. 107-124.
D. Marcheschi (a cura di), Àlloro di Svezia. Carducci, Deledda, Piran-dello, Quasimodo, Montale, Fo. Le motivazioni delpremio Nooelper laletteratura, Parma, MUP, 2007.
F. Masala, Intervento, in G. Petronio et al., Convegno nazionale di studideleddiani (Nuoro, 30 settembre 1972), Cagliari, Fossataro, 1974,pp.271-273.
A. Momigliano, Storia della letteratura italiana, vol. III, Messina-Mila-no, Principato, 1936.
G. Olla (a cura di), Scenari sardi, Grazia Deledda tra cinema e televisione,Cagliari, Aipsa, 2000.
1I'\O
Premio Nooelper la Letƒgmmm 1926
A. Pellegrino, Grazia Deledda, in Dizionario oiografico degli italianiRoma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, vol. XXXVI 1988 I491-496. ' ' PP'
G. Petronio, Ifattività letteraria in Italia. Storia della letteratura Paler-mo, Palumbo, 19642. l
G. Petronio, V. Masiello, Produzione efruizione. Ântologia della lettera-tura italiana, vol. III, parte II, Palermo, Palumbo 1989_
R' PíCkefín8`IaZZí› Dfffddß Gmzia, in V. De Grazia S. Luzzatto (acura di), Dizionario delfizscismo, vol. I, Torino, Einaudi 20052 p407. I ” '
L. Pirandello, Suo marito, in Tutti i romanzi a cura di G Macchia M› . , _Costanzo, Milano, Mondadori, 1973, vol. I pp. 587-873
D. Provenzal, Retroscena del “Nobel” a Grazia Deledda “Frontiera” 51972, pp. 7-8. , ' '
L. R C ' ' - - . .usso, ompendio storico della letteratura italiana, Messina-Firenze,D Anna, 1961.
M. S ' - - .ansone, Storia della letteratura italiana ad uso delle scuole medie supe-†'i0?'1'› Napoli, Loffredo, 1938.
N' S3PIÈgn0› Compendio di storia della letteratura italiana, vol. III, Firen-Ze, a Nuova Italia, 19893 (la ed. 1947).
N. Sa D' ' - . _pegno, :segno storico della letteratura italiana, Firenze, La NuovaItalia, 19732 (la ed. 1949).
R. Serra, Le lettere (1914), introduzione e commento a cura di G Ben-venuti, Bologna, Clueb, 2006. l
B. Svensé - . . . .9 (a CU1"f1 dl), Nüåeljívrzset z lztteratur. Nomznerzngar oc/2 utlåtan-d _ _en 190? 1959 St99kh01m› SV€r1Sl<a Academien och NorstedtsAkademrska Forlag, 2001_
1(\f`l
Grazia Deledda
A. Tarquini, Storia della culturafascista, Bologna, Il Mulino, 2011.
E. Tiozzo, La letteratura italiana e ilpremio Nobel, Storia, critica e docu-menti, Firenze, Olschki, 2009.
E. Tiozzo, IlNobel svelato. Segreti, errori e verdetti delpremio per la lette-ratura, Torino, Nino Aragno, 2013.
Articoli di giornale
La cerimonia della consegna delpremio Nobel a Grazia Deledda, “Il Popo-lo d'Italia”, 11 dicembre 1927, p. 1.
Come la Deledda ba accolto la notizia, “Corriere della Sera”, 11 novembre1927.
Grazia Deledda andrà a Stoccolmaper il conjerimento del Premio Nobel, “IlPopolo d”Italia”, 23 novembre 1927.
Grazia Deledda a Stoccolma, “Corriere della Sera”, 8 dicembre 1927.
Grazia Deledda riceve dal Re di Svezia ilpremio Nobelper la letteratura,“Corriere della Sera”, 11 dicembre 1927.
Grazia Deledda torna in Italia, “il Resto del Carlino”, 18 dicembre 1927,p. 5.
C. P., Isuoi romanzi, “La Stampa”, 11 novembre 1927, p. 3.
Poesia efamiglia. Grazia Deledda parla della sua vita e della sua arte, “ilResto del Carlino”, 12 novembre 1927, p. 7.
Premio Nobel alla Deledda conjerito con voto unanime, “Corriere dellaSera”, 12 novembre 1927.
Il premio Nobel conferito a Grazia Deledda, “il Resto del Carlino”, 11novembre 1927, p. 2.
Premio Nobelper la Letteratura 1926
Ilpremio: 720.000 lire. Prima della Deledda non l 'ebbe altro Ital` 1;Cafduffå “Lil Stampa”, 11 novembre 1927 p 3 mm C 6
La rioresa dei lavorz-Parlamentari Lbmaggio della Camera G _ D' cl 711121261 e-ledda, “il Resto del Carlino”, 2 dicembre 1927 P 1
La Sflfdfigflfl Sijfirepara afesteggiare il ritorno di Graz' D› . ,, _ ldd ,“I _P010 d Iaia ,15 (membra 1927. la E “ ” IPO
La 0! d I _ ' cc -11“Sana f É [”_[ n cc ,,19Pen3aper ta za eper la Sardegna , La Stampa , 11 novembre
Sitograƒia
htt ://www.l b ' ° -- . . _:Ong/MIgåìoãåc]ä1ålåj.n1cultural1.1t/archivi/soggett1-produttori/p@1~_
_._ 1*-J"
vw,-_-*_!~1°'J¬
g5
0P“ggf%`|'P`-1.
1'-r§
._¬`-“gl-.-...,;,-.
__.:..
'mr~`í\T'°":::rI
¬p1- '-
/'.___ L ` A.. -_ ._ 1.-I
›.“?"-7'?'7717
I' 1ì
›\'
› .ç_;- ;f='<.ã?i›:,›[›i:
J
›
'Q"_\. ._0_.I
s'l
¬›ÃI.fí";›-f_“\”;-znf...,-.;.N.
-_..._-›«--l:.._&Piuefa!"' i¬¬...L.r-.J'i›._-.-0-c'.l_k«-1:-l
, _
v
,l1
nu.
Grazia Deledda
I.*.°_-'Èff-§_-`.'-
1 ø
I
Ivr-'-D_._:ìlvja-.vv -t-E.-.-1-e›»§"~.'.~:RJes-››¬I*.IFFr»
Iriz,ff*
ig 2 Jef game na rorzsegnata a Grazia Drledda durante la cerimonza zi/fienile delpre-mio Noli(/(Storto//2111. 10 duembre I 92/ _._
Fig. 1: Ritratto giovanile di GraziaDe/edda.
_ _ __, _ _- -_ V...--,H
. ._ ; ' '
¬, - vÈ' _ *_ , «_In -__, ¬ _ I «` ___ L, . ,
I I
I I .
..._-..,__1...
1.
`v~t'\~\-"'”(`1"^`
1 O À. ;.
11,'¢'è'"›'f""°°J'?"._¬_fiL"2»,-`~il,. __
.._-....-.«..¬_._Ft--1_!vy_1'°v
w--oo-"_Yvlflr*
Q.vQ
r-4`*¬/'
'|
\':
ilI'.
I.,_
J
I
I
ll.-
_'.l
I
HE
I
Premio Nobelper la Letteratura 1926
Fig. 3.' Giuseppe Biasi, Caricatura diGrazia Deledda, “l'Âvanti della Do-menica”, 2ó_ƒebbraio 1905.
Fig. 5: Frontespizio de/libretto di accompagna-mento delfilm “La grazia "(-7929), tratto dalla no-vella “Di notte ” di GraziaDeledda.
EDIZIONEA›Dl-Amm
A\/TCI FilC,H1i€TT;)I'?f
*' fr L_ r A .\.- › -~ -~.^\f-§b()(`1,°.7I_^ \| ' - "sr-
íaålšåšåìåßfiååg>rzo>rAGgcA¬_rs:|s.»†r›; CARAÈ1 E N BO NI "
. «¬ _... _ V ~I' ' 'i '
Jr/I_.-av-"_
_.-.
libro dellarza classesélementarøß-;..¬:;,~..»”ì”.»
gig _3\.aw;§zr;,a,si'
uN.` ' A _ W., . _; ' '.
li; .”Æ'I"I'*' -;-fl”.. `I I n n n 1 A n E L x. o a 'r A 1' o _ ^:onu a xux .
,ga ._ . NJ- ._1-_-__ ~., . - . li
D
Fig. 4.' Copertina (Pio Pallini) di G. Deledda etal., “Il libro della terza classe elementare ", Roma,La libreria dello Stato, I 930-1931.
' PRODVZIONEINTERNAIIOMU.
kl 11
<1' __", A
\
\ _' )\
_ ` I
i \/.
fx) \` \-._ V
\
I
` \
~ ›\ I
\_, \' .-
I\`/
., - ..
" \'I ii.,. - \,
PIHII 'grub9r2>_.