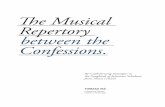FOI 055-1617 document 5 - Therapeutic Goods Administration ...
Góngora opinionista: le "décimas" dal 1617 al 1625
Transcript of Góngora opinionista: le "décimas" dal 1617 al 1625
BiBlioteca di Studi iSpanici
a cura di
Giuseppe Di Stefano (Pisa), coordinatore
Giovanni Caravaggi (Pavia), Antonio Gargano (Napoli), Alessandro Martinengo (Pisa), Norbert von Prellwitz (Roma),
Maria Grazia Profeti (Firenze), Aldo Ruffinatto (Torino), Tommaso Scarano (Pisa), Emma Scoles (Roma)
Carlos Alvar (Ginevra), Ignacio Arellano (Pamplona), Aurora Egido (Zaragoza), José Lara Garrido (Málaga),
José Manuel Lucía Megías (Madrid, Complutense)
Segreteria di redazione: Elena Carpi e Valentina Nider
(Pisa)
La Edad del Genio:España e Italia en tiempos
de Góngoraa cura di
B. Capllonch, S. Pezzini, G. Poggi, J. Ponce Cárdenas
Edizioni ETS
© Copyright 2013EDIZIONI ETS
Piazza Carrara, 16-19, I-56126 [email protected]
DistribuzionePDE, Via Tevere 54, I-50019 Sesto Fiorentino [Firenze]
ISBN 978-884673831-8
La pubblicazione del volume è stata finanziatadal Gobierno de España / Ministerio de Economía y Competividad,
Proyecto de Investigación «Todo Góngora II» [I+D+I FFl2010-17349] Universitat Pompeu Fabra (Barcelona),
con un contributodell’Università di Pisa, Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica
indice
MercedeS BlancoLas «Soledades» a la luz de la polémica 7
rafael Bonilla cerezoEl «Teatro de la vida humana desde que amanece hasta que anochece»de Agustín de Salazar y Torres 41
M. criStina caBani e Giulia poGGiLe «Soledades» e «Lo stato rustico»: una traccia da seguire 87
Ma doloreS caMpoS Sánchez-BordonaLos retratos de Góngora y la verdadera imagen del poeta 111
enrica cancelliereIl mitema dell’Anadiomene dal platonismo a Góngora 135
BeGoña capllonch«Sentido» y «referencia» en algunas imágenes de las «Soledades»:del cincel al cristal de azogue 149
daria caStaldoSull’«imitatio» nelle «Solitudini». Góngora e Claudiano 163
antonio J. díaz rodríGuezEl mundo eclesiástico de don Luis de Góngora 179
laura dolfiEl mundo metafórico de la «Soledad primera»:contenidos y finalidades 201
aurora eGido«Mañana serán miel». Labores poéticas y metapoéticasdel Góngora abeja 219
franceSco ferrettiPeregrini erranti. La «Gerusalemme liberata» nelle «Soledades» 253
6 LA EDAD DE GENIO: ESPAÑA E ITALIA EN TIEMPOS DE GÓNGORA
antonio GarGano«Il cantar novo e ’l pianger delli augelli». Góngora e l’usignolo 279
BeGoña lópez Bueno Soledades polifónicas. Pedro Espinosa vs. Góngora 295
Juan MataS caBalleroLas «Soledades» a la luz de los sonetos:la prefiguración del peregrino 317
JoSé María MicóDante y Góngora. Una aproximación 331
antonio pérez laSheraSGóngora y la poesía aragonesa del siglo XVII 343
Sara pezziniGóngora opinionista: le «décimas» dal 1617 al 1625 359
JeSúS ponce cárdenaSSobre el paisaje anticuario: Góngora y Filóstrato 375
ineS ravaSiniÉfire, Filódoces e i «prodigiosos moradores del líquido elemento».La caccia marina della «Soledad segunda» 397
enrique Soria MeSaGóngora judeoconverso. El fin de una vieja polémica 415
Sara pezziniUniversità di Pisa
GónGora opinioniSta: le décimaS dal 1617 al 1625
She pushed through the parted folds. Another hall, another door. T. Capote
Un altro Góngora
Nel primo tomo del manoscritto Chacón, subito dopo le Soledades, sono raccolti sessantadue componimenti di varia lunghezza e tonalità. Catalogati dall’estensore del manoscritto sotto l’etichetta di décimas, furono ignorati dai commentatori dell’epoca di Góngora che riservarono loro il trattamento de-stinato a tutta la poesia ottosillabica.
In effetti, alla stregua delle letrillas e dei romances, Salcedo Coronel escluse le décimas dal suo commento dell’opera del cordovese con la sola eccezione, quasi casuale, di Tan ciruelo a san Fulano, citata integralmen-te per commentare un sonetto dal significato alquanto oscuro che condivide con essa la stessa intenzione satirica1. Pedro Díaz de Rivas, José Pellicer e Andrés Cuesta, per citare solo i più illustri tra i primi esegeti dell’opera di Góngora, non si interessarono mai alle décimas e Baltasar Gracián, che mo-strò nell’Agudeza una predilezione spiccata per la poesia gongorina, ne citò solo due (Tropezó un día Dantea e Caballo que despediste) come esempio di «ponderación misteriosa»2.
Del resto il pregiudizio verso la poesia del cosiddetto Góngora “minore” si è protratto fino ai nostri giorni. Le parole di Jorge Guillén – secondo il quale il Góngora autore di décimas è quello «más próximo a la singularidad de la circunstancia histórica», il «Góngora menos gongorino», e addirittura il «peor Góngora» – ne sono una sintesi particolarmente icastica3 e, a ben ve-dere, riflettono una reticenza generale, forse ancora non del tutto scomparsa, ad ammettere altre possibili facce del poeta tra i più sublimi della modernità.
Il forte ritardo sulla ricezione delle décimas si deve soprattutto allo statuto di poesia d’occasione al quale esse sono per la maggior parte riconducibili. Se, come Robert Jammes è tornato a sottolineare, «las intrusiones de la reali-
1 Lugar te da sublime el vulgo ciego. Cfr. Salcedo Coronel 1644: 591. 2 Gracián 2004: 200 e 229.3 Guillén 2002: 34.
360 LA EDAD DEL GENIO: ESPAÑA E ITALIA EN TIEMPOS DE GÓNGORA
dad – muchas veces en forma festiva o burlesca – corresponden a un rasgo de su personalidad [la de Góngora] que sus contemporáneos admitieron difícil-mente4», la rappresentazione di una realtà non idealizzata, lo spazio accordato al contingente e all’aneddotico, la tonalità volentieri satirica e burlesca, carat-teristiche di questo metro breve, finiscono per situarne il corpus agli antipodi del Góngora preferito dai poeti del Novecento, in altre parole del Góngora delle Soledades5.
L’interesse di Góngora per la décima espinela, strofa nata intorno agli anni ’90 del Cinquecento dal talento poligrafo di Vicente Espinel e tra quelle «más características y feraces de la literatura en español»6, coincide con il momento in cui questa è promossa, tanto nel repertorio del teatro come in quello della lirica, a metro indipendente7. Nella produzione di décimas gongorine, pertan-to, si distinguono due epoche.
La prima, che risale al periodo compreso tra il 1600 e il 1608, risente del carattere ancora sperimentale che la strofa mostra agli inizi del secolo. Ad essa appartengono lunghi componimenti polistrofici come, ad esempio, No os diremos como al Cid, elogio delle damas de palacio ammirate con gli occhi del marqués de Guadalcázar, che costituisce la prima e anche la più lunga testimonianza del corpus8 (ben sedici strofe). A questo lungo decalogo cor-tigiano, datato dal manoscritto Chacón al 1600, seguono tre anni più tardi le décimas liriche De un monte en los senos, donde9. Sia le quattro strofe inter-calate da un estribillo polimetrico di questo componimento che l’estensione del precedente confermano il carattere ancora poco formalizzato della déci-ma. In effetti, questi primi esempi ne affermano sì l’autonomia ma, al tempo stesso, ne denunciano la continuità con la struttura e i contenuti tipici di altri metri ottosillabici. Continuità confermata dalle dieci décimas satiriche datate al 1606 (Musas, si la pluma mía10) che formulano un elenco dei vizi secondo il procedimento, ravvisabile in tante letrillas, della sátira de estados. Di fatto
4 Jammes 2012: 29. 5 Solo in tempi molto recenti le décimas hanno suscitato un primo e significativo interessa-
mento da parte della critica: Góngora y el epigrama. Estudios sobre las décimas, Matas Caballero, Micó, Ponce Cárdenas (eds.) 2013 è la prima monografia sull’epigramma gongorino, frutto di due giornate di studio tenutesi presso l’Universitat Pompeu Fabra di Barcellona nell’ambito del gruppo di ricerca Góngora I. Chi scrive sta lavorando all’edizione critica e al commento di questo corpus, il solo all’interno della produzione del cordovese ancora privo di uno studio ecdotico e interpretativo.
6 Micó 2008: 73. 7 Sulla genesi, la cronologia e le caratteristiche metriche della décima espinela rimando ai fon-
damentali studi di Clarke (1936), di Millé (1937) e all’esauriente introduzione alle Obras completas di Vicente Espinel a cura di Garrote Bernal (1993, in particolare pp. 298-304), oltre che al già citato articolo di Micó.
8 Góngora 2008: I, 183. Citerò sempre da questa edizione (= OC: I e OC: II). 9 OC: I, 218.10 OC: I, 247.
GÓNGORA OPINIONISTA: LE DÉCIMAS DAL 1617 AL 1625 361
la vicinanza tra le prime décimas gongorine e le letrillas di combinazione rimica abbaaccdde, indusse in errore anche i primi lettori, tanto che l’esten-sore del manoscritto Chacón, seguito da altri copisti, finì per includere tra le décimas satiriche la letrilla Ya de mi dulce instrumento e, fra le burlesche, la letrilla Una moza de Alcobendas11.
Tuttavia, già a partire dal 1604, iniziano a delinearsi alcune delle carat-teristiche stilistiche e formali che diverranno una sorta di marchio distintivo del corpus: contingenza, concettosità, brevità. Risale a questo anno la prima décima monostrofica: De puños de hierro ayer. I giochi linguistici, condensati per la prima volta nello spazio dei dieci versi, sono finalizzati a commentare un fatto del tutto privato e prosaico quale la restituzione di un prestito di de-naro12. Le décimas in cui una trovata sagace, un gioco di parole o una poin-te forbita sono riferiti a fatterelli minimi legati alla biografia quotidiana del poeta diverranno sempre più frequenti dopo il 1608. Si pensi alla serie delle sueltas riconducibili alla vita di Cordova: i biglietti salaci inviati ad anonime monache, oppure le saporite bromas tra canonici dove ormai, in maniera di-rei definitiva, «la brevedad contribuye a la eficacia del concepto que salva lo anodino del incidente»13.
Delle tre décimas che prenderò in considerazione, le prime due, El más insigne varón e Al cardenal mi señor sono considerate gongorine a tutti gli effetti, anche se la prima non appare in Chacón; la terza, Atrevida confianza, nonostante non sia attestata né da Chacón né da nessuna delle edizioni mo-derne, a mio parere può entrare di diritto nel corpus per una serie di motivi che spiegherò.
L’abito della ferocia
A partire dal suo trasferimento a Madrid, il poeta mostra un’affezione particolare per la décima. In effetti, quasi la metà dell’intero corpus risale
11 In una delle tre possibili combinazioni della letrilla gongorina, quella con schema rimico abbaaccdde, la vicinanza con la décima risulta particolarmente evidente. In effetti, le due forme differiscono dal punto di vista metrico unicamente per la rima del decimo verso che, nella décima, è identica a quella del settimo e dell’ottavo, mentre nella letrilla lega con il verso successivo. In altre parole, la differenza sancisce il carattere chiuso proprio dell’espinela, in contrapposizione alla strut-tura aperta ad libitum della letrilla. Prima che Robert Jammes nella sua introduzione alle letrillas gongorine (1980) mettesse a fuoco i caratteri formali che distinguono una letrilla da un romance o da un componimento in décimas, era diffusa tra i gongoristi la tendenza, confermata in quasi tutte le antologie, a inglobare sotto l’etichetta di letrilla anche la décima. Questa ambiguità terminologica, oltre a ignorare le peculiarità metriche dell’espinela gongorina, è da leggersi anche come conseguen-za della sua sfortunata ricezione.
12 OC: I, 235.13 Blanco 2013: 48.
362 LA EDAD DEL GENIO: ESPAÑA E ITALIA EN TIEMPOS DE GÓNGORA
agli otto anni trascorsi nella capitale e più della metà delle 18 décimas a lui attribuibili sono riconducibili allo stesso periodo. Si intuisce, insomma, che la décima gongorina si specializza lentamente in senso mondano, come se la sua vocazione a rappresentare il contingente, già mostrata in precedenza, finisse per raggiungere la piena maturazione proprio grazie alle sollecitazioni che gli offriva la corte.
Da qui la scelta di scrivere di un Góngora “opinionista”, termine anacroni-stico per l’epoca del poeta e che tuttavia mi permette di insistere sul rapporto del tutto peculiare – nutrito dell’atmosfera di corte e spesso caratterizzato da punte satiriche – che nelle décimas Góngora istituisce tra poesia e, come dice Guillén, «singularidad de la circunstancia histórica».
Prendiamo uno dei molti componimenti di tonalità satirica esclusi dal manoscritto Chacón: El más insigne varón, décima suelta databile al 1624, dove il neo cappellano forgia un piccolo ma sofisticato cammeo dell’ambizio-ne sfrenata respirata negli ambienti della corte. Il destinatario dei versi è un frate, Gregorio Pedrosa:
El más insigne varónde su orden, el que yaa san Jerónimo hadejado por el León,su celo, su devoción 5ni a la cogulla ni al mantoperdonan, y no me espantoque su modestia hoy no quieravestir la piel de la fierasobre el hábito del santo.14 10
Appartenente all’ordine dei Geronimiti, membro della cappella reale e, dal 1609, investito del prestigioso ruolo di predicatore del re grazie all’appoggio di Rodrigo Calderón, Pedrosa non incontrava le simpatie del poeta. Nel 1621 si mostrò pietoso dinnanzi alla folla che assisteva all’esecuzione del valido di Lerma e accompagnò il condannato fino al patibolo. In verità, durante le fasi del lungo processo, il frate predicatore aveva abilmente negato appoggio e conforto al marqués de Siete Iglesias che, ormai in disgrazia, rappresentava un’amicizia tutt’altro che conveniente. Góngora, testimone attento della con-troversa vicenda, aveva messo l’accento sull’atteggiamento ambiguo di Pedro-sa in un passo del suo epistolario:
[Rodrigo Calderón] Invió el otro día a pedir al padre Jerónimo de Florencia le hiciese merced y caridad de venirle a consolar en aquel trance, donde tenía que consultarle cosas de su conciencia: respondió que le perdonase. Hizo la misma diligencia con el padre fray
14 OC: I, 654.
GÓNGORA OPINIONISTA: LE DÉCIMAS DAL 1617 AL 1625 363
Gregorio de Pedrosa, amigo tan suyo antes, que le debía, a pesar del duque, la autoridad y puesto que hoy tiene: respondiole lo mismo.15
Per di più, la predilezione del poeta, tra la nutrita schiera di predicatori reali, per l’amico Hortensio Paravicino fece di Pedrosa un bersaglio satirico ideale. Nel 1624 il frate predicatore fu proposto da Filippo IV per la carica di vescovo di León, carica che rivestí effettivamente fino al 1633, anno in cui si trasferí a Valladolid dove avrebbe risieduto fino alla morte16.
La décima sfrutta innanzitutto la bisemia del termine León, toponimo del-la destinazione episcopale di Pedrosa, asceso alla carica di vescovo della città spagnola nel ‘24 e, al tempo stesso, nome della belva tradizionalmente asso-ciata all’iconografia di San Girolamo. Mi riferisco al leone al quale il santo aveva tolto una spina dalla zampa e che la tradizione raffigura ammansito al suo fianco. I primi quattro versi, dunque, enunciano l’occasione del componi-mento, mentre i restanti sei contengono il giudizio, tutt’altro che innocente, sul comportamento del frate.
È Mercedes Blanco che per prima ha proposto questa lettura ironica e sibillina del testo, connessa all’atteggiamento “politico” e, è il caso di dirlo, “voltagabbana”, mostrato da Pedrosa. Ad essa è tuttavia possibile aggiungere un ultimo tassello, indispensabile a mio avviso per comprendere appieno la sua pointe.
Noteremo che la prima parte della décima non allude, come tenta di spie-gare un’epigrafe17, al fatto che il futuro vescovo avesse conservato il prece-dente abito da frate predicatore (ni a la cogulla ni al manto/ perdonan) ma, in maniera traslata, alle cariche ecclesiastiche progressivamente da lui “rive-stite”. Tanto più che l’esplicito riferimento alla duplice “veste” indossata dal frate trova il suo rovesciamento nell’azione dello “svestire” suggerita dalla pointe. Insomma, il geronimita si “riveste” delle sue tante cariche a differenza del fondatore del suo ordine, il quale, come si sa, se ne “svestì” tanto da venire rappresentato, sia scrivente che penitente, nudo e vicino al cappello cardinali-zio simbolo della sua rinuncia18.
15 Madrid, 20 luglio 1621, a don Francisco de Corral (OC: II, 389). La segnalazione del passo si deve a Mercedes Blanco che di recente ha preso in considerazione questa décima come esempio di “satira ambigua” (Blanco 2012a: 151-172, poi in Blanco 2012b: 187-188).
16 Cfr. la nota di Millé in Góngora 1932: 1134.17 Si confronti ad esempio l’epigrafe del ms. B 23/3/6 (Biblioteca della Fundación Bartolomé
March, Palma de Mallorca, f. 123v): «A fray Gregorio Pedrosa de la orden de San Jerónimo, pre-dicator del rey, electo obispo de León, que no quiso quitarse el hábito de su orden por el episcopal sino traérselo ambos juntos».
18 Rimando a due celebri rappresentazioni del santo.
364 LA EDAD DEL GENIO: ESPAÑA E ITALIA EN TIEMPOS DE GÓNGORA
Pontormo, San Girolamo penitente 1529-1530 circa.
GÓNGORA OPINIONISTA: LE DÉCIMAS DAL 1617 AL 1625 365
Caravaggio, San Girolamo scrivente 1607.
Solo così è possibile capire l’ironia del poeta, il quale non si meraviglia (no me espanto) che il frate non voglia spogliarsi di nessuna delle sue cariche, quella di predicatore suggerita dalla cogulla e quella di vescovo cui allude il manto19.
La catena semantica vestire-rivestire-svestire che percorre tutta la décima trova così il suo compimento nel sintagma che la suggella. È per modestia – falsa, è ovvio – che il frate predicatore rinuncia all’hábito del santo, tanto più che il suo comportamento crudele nei confronti del marqués de Siete Iglesias lo rende un rovescio speculare di San Girolamo. Se quest’ultimo, in segno di penitenza e di distacco dal mondo, aveva coperto con la nudità (la piel de la fiera) la sua santità, l’ambizioso predicatore aveva coperto con un falso abito da santo la sua ferocia.
Insomma, non c’è da stupirsi se Chacón, fedele agli intenti dichiarati nel
19 In effetti la cogulla (ossia la cocolla, dal latino cuculla) «è un abito specificatamente mona-cale e consiste in una grande veste con ampie maniche, cui si aggiunge un cappuccio, attaccato al collo o sciolto […] il colore è bianco o nero secondo le Congregazioni monastiche che l’usano» (En-ciclopedia Cattolica 1949: III, 1907). Il manto, ossia la cappa episcopale munita di lungo strascico sorretto dal chierico chiamato caudatario, è, tra i paramenti episcopali, il più distintivo e solenne (cfr. Lesage 1958: 132-137).
366 LA EDAD DEL GENIO: ESPAÑA E ITALIA EN TIEMPOS DE GÓNGORA
suo manoscritto, decise di escludere una décima che stigmatizza il doppio comportamento di Pedrosa. Il potente filtro dell’ironia, già presente nel super-lativo del primo verso (el más insigne varón) e nelle negazioni dei versi 5 e 6 (ni…ni /…/ no me espanto), culmina magistralmente nella pointe che realizza «un modello di comunicazione indiretta, dove la partecipazione all’atto di parola dell’altro, del destinatario, è più che mai evidente»20.
Promesse non mantenute
Sempre in ambito religioso, ma con distinta tonalità, Góngora ci restitu-isce un altro spaccato dell’atmosfera di corte, questa volta ritagliata nel suo côté mondano, in una décima del 1625, l’ultima che Chacón trascrive nel suo manoscritto:
Al cardenal mi señorsirve el que, en lo que prometeuna copia es, con bonete,del conde de Villaflor.Callo el nombre por su honor, 5si bien, a lo cortesano,cuanto ha prometido en vanocanónigo de Toledo,que lo cumple decir puedode Madrid arcedïano.21 10
I versi poggiano su un’informazione a metà tra il pettegolezzo e la verità condivisa. Il loro destinatario, secondo il suggerimento delle epigrafi che li accompagnano, è un certo Coloma, punzecchiato perché non ha recapitato al poeta un regalo che gli aveva promesso22. Ma anziché nominare direttamente Coloma, uomo al servizio del cardinale infante, il poeta vi allude attraver-so una definizione che chiama in causa una terza persona. Si tratta di Luis Enríquez de Villaflor, nobile portoghese assiduo frequentatore della corte, che Góngora aveva già attaccato in un sonetto del 1621 (El conde mi señor se fue a Cherela) in occasione di alcuni denari perduti al gioco e che mai gli erano stati restituiti23.
Fra il sonetto e la décima in questione lo stesso conte riappare in un’altra décima dove Góngora lo rimprovera per non avergli fatto recapitare una em-panada che gli aveva promesso (1624):
20 Mizzau 1984: 9.21 OC: I, 603-604.22 «De don Antonio Coloma, canónigo de Toledo y arcediano de Madrid, camarero del serenísi-
mo infante don Fernando, tardándose en enviarle un regalo que le había prometido».23 OC: I, 560.
GÓNGORA OPINIONISTA: LE DÉCIMAS DAL 1617 AL 1625 367
Un conde prometedorque Portugal dio a Castilla(tal conociera su Villacomo conozco su Flor) me remite a vos, señor, 5
para que me deis en pan y en adobo un Florïán,
süavísimo bocón, si le visten al capón sotana de mazapán.24 10
Giocando sul nome del conte prometedor venuto dal Portogallo, il poeta si rammarica di non conoscere la sua villa come conosce il suo flor (sinonimo di engaño nel lessico del marginalismo e di trampa in quello delle carte25). Come dire che l’inadempienza di Villaflor, uno specialista secondo la testimo-nianza del poeta nel contrarre debiti (di gioco e non solo), è una sorta di tor-mentone del repertorio burlesco gongorino. Le due décimas sono strettamente legate tra loro e per di più la definizione che nella prima il poeta dà di Coloma (copia con bonete) permette di alludere anche alla doppia rendita catastale (las copias) di cui quest’ultimo godeva26.
In definitiva, l’esempio mostra come le décimas del periodo madrileno ten-dano a ritrarre anche le personalità più illustri in un quadro di familiarità quo-tidiana. E come attraverso una di esse particolarmente giocosa il poeta arrivi a stilare da un’insolita angolatura la cronaca di un episodio della vita di corte.
Un amore tramontato
La décima gongorina, quindi, pur mantenendo alcuni punti di contatto con i sonetti satirico-burleschi, tende a restituire, in maniera differente e più sistematica rispetto ad essi, un ritratto vivo del poeta, in quanto legato agli avvenimenti, agli umori, agli scandali di cui si mormorava al suo tempo. Em-blematica in questo senso la décima Atrevida confianza finora considerata di dubbia attribuzione:
24 OC: I, 595. 25 Per la specializzazione del termine flor nel lessico del gioco, e la sua ricorrenza nella lette-
ratura del Cinquecento e del Secento, cfr. Etienvre 1987: 182-193.26 Vi allude l’epigrafe che accompagna la décima in uno dei mss. Foulché Delbosc (Biblioteca
Nacional de la República Argentina, Buenos Aires, n. 262, f. 125r): «A don Antonio Coloma, ca-marero del serenísimo Ferdinando cardenal infante que dejó de enviar a don Luis un regalo que le había ofrecido, como el conde de Villaflor la empanada referida en la décima pasada. Es don Antonio canónigo de Toledo y arcediano de Madrid, pero goza la renta de la canongía y del arcedianado sólo el título porque entrega las copias a don Rodrigo Enríquez que la cobra por habérsele dado a pensión en esta forma».
368 LA EDAD DEL GENIO: ESPAÑA E ITALIA EN TIEMPOS DE GÓNGORA
Atrevida confianzagirando con paralelosemulación de los cielossublime proeza alcanza;fija en nivel la balanza 5con efeto fugitivofulgor de mancebo altivo,que para casos supremosOrientes une, si extremosde Amor, el Ocaso vivo. 27 10
Di cosa parlano questi dieci versi? A cosa si riferiscono? In altre parole, quale è l’occasione da cui scaturiscono? Una risposta convincente è quella indicata dall’epigrafe del manoscritto Rennert:
A la venida de Carlos, príncipe de Gales, hoy rey de Inglatera, a Madrid a ver y pedir en casamiento a la serenísima María, hermana del rey nuestro señor don Felipe IV. No tuvo efecto su pretención y volvióse a su tierra.28
La vicenda storica è nota. Nel giugno del 1623, il principe inglese Carlo, accompagnato dal duca di Buckingam, partì in incognito dall’Inghilterra per trattare a Madrid le nozze con l’infanta Maria Anna di cui si diceva fosse invaghito. Le peripezie diplomatiche e le questioni teologiche non impedi-rono di ufficializzare la promessa di matrimonio nel luglio del 1623. Alcuni relacioneros dell’epoca sono generosi nel trasmetterci i dettagli dei fasti con i quali la corte intrattenne i promessi sposi per la breve durata del fidanza-mento. Tra questi Gascón de Torquemada e Almansa y Mendoza, autore del più aggiornato resoconto di questo improbabile accoppiamento29. Oltre alla cronaca della spedizione dei due inglesi in terra iberica, ci rimangono anche le descrizioni dei festeggiamenti connessi alla loro venuta che, per esempio, fanno capolino dietro le 33 ottave sui giochi dei tori organizzati a Madrid nell’agosto del 1623 in onore del principe e del suo accompagnatore30. In ef-
27 Né i fratelli Millé né Carreira, che peraltro la cita tra i componimenti attribuiti a Góngora nello studio del 1994 (p. 331), includono la décima nell’edizione delle opere complete. Trascrivo il testo della décima già da me stabilito nella tesi di dottorato (Le «décimas» di Luis de Góngora: edizione, introduzione e note discussa presso l’Università di Pisa nel dicembre 2012 e consultabile on-line al seguente indirizzo: http://etd.adm.unipi.it) con l’eccezione del verso 2 (non “por paralelos” ma “con paralelos” come da mss. Estrada e Rennert).
28 Ms. Span. 37 conservato presso la Biblioteca dell’Università della Pennsylvania (fol. 180), studiato da Antonio Carreira (1992: 12-19). L’epigrafe si trova nell’indice del ms. (fol. ¶¶ 3).
29 Gascón de Torquemada 1991: 165-169 e Almansa y Mendoza autore di un noto Discurso político y relación de la venida y entrada del príncipe de Gales en nuestra ciudad (2001: 329-354).
30 Si tratta di un Elogio descriptivo composto dal poeta di corte Alarcón y Mendoza e portato alla luce di recente da Rafael Iglesias (2001), al quale si aggiungono altri componimenti encomiastici sul medesimo tema (Lope de Vega, Antonio Solís, López de Zárate, Villamediana e Miguel Venegas de Granada). D’altronde, l’evento fuori dal comune di un sovrano che viaggia per l’Europa sotto
GÓNGORA OPINIONISTA: LE DÉCIMAS DAL 1617 AL 1625 369
fetti, per quasi due mesi i due inglesi parteciparono freneticamente alla vita della corte spagnola, fino al 9 settembre, quando la promessa di fidanzamento venne sciolta e il principe se ne ripartì per l’Inghilterra con un nulla di fatto31.
Che l’epigrafe del manoscritto Rennert sia attendibile lo fa pensare il le-game tra questa décima e il sonetto encomiastico composto per il medesimo evento: Undosa tumba da al farol del día del 162332. Ambedue i componi-menti ricorrono al campo semantico dell’astronomia, ma mentre il sonetto se ne serve per celebrare il fidanzamento regale, la décima per commentare il suo fallimento. Epilogo inglorioso che spinse con ogni probabilità Chacón a escludere gli ottosillabi dal suo manoscritto. È molto plausibile che entrambi i testi siano stati scritti nel 1623: il primo durante i mesi della permanenza di Carlo alla corte, il secondo subito dopo la sua partenza.
Ma torniamo al testo. Ciò che lo rende così denso e difficile a decifrarsi è la presenza di tre piani diversi su cui si costruisce: storico-referenziale, figura-le e ironico. Del piano storico-referenziale abbiamo già parlato. Ad esso si so-vrappone quello figurale che chiama in causa, a mio avviso, un mito assai fre-quentato dalla poesia lirica e dalla letteratura emblematica del tempo: quello di Fetonte. Me lo fa credere, prima di tutto, l’insistere sul motivo dell’audacia attraverso termini come atrevida, proeza, altivo associati al campo semantico dell’astronomia (paralelos, cielos, Orientes, Ocaso). Inoltre il sintagma man-cebo altivo richiama immediatamente l’audaz mozuelo del sonetto giovanile amoroso (Verdes hermanas del audaz mozuelo del 1582) ispirato al paragone fra l’audacia dell’amante e quella del figlio di Apollo, del resto chiaramente indicato nell’osado Faetón di un altro sonetto, il parallelo Gallardas plantas, que con voz doliente33. Siamo insomma di fronte a una delle «immagini di sconfinamento nella sfera dell’aria, presenti nelle numerose citazioni gongo-rine dei miti di Icaro e Fetonte», dai quali, come vedremo, la décima rise-mantizza il motivo della caduta attraverso un gioco di doppi sensi sfumati e particolarmente concentrati34.
I versi mobilitano tuttavia anche un terzo piano, che ho definito ironico, e che suggerisce un rovesciamento tendenzioso di quello figurale. All’incipit enfatico, in cui l’ironia appare ancora leggera (emulando i cieli il principe ha attraversato paralleli per giungere dall’Inghilterra alla Spagna) seguono due
mentite vesti per chiedere in sposa l’infanta non poté che sollecitare la penna di alcuni tra i maggiori ingegni dell’epoca, oltre a stimolare la fantasia dell’opinione pubblica.
31 Per la ricostruzione storica della vicenda che coinvolse i reali di Spagna e quelli di Inghil-terra, tra le più controverse degli anni del valimiento di Olivares, rimando al classico contributo di Elliot (1990: 213-250).
32 OC: I, 590. 33 OC: I, 39 e OC: I, 50. Per l’importanza e il significato del mito di Fetonte (e di quello di
Icaro) in Góngora risultano di consultazione imprescindibile due articoli di Prellwitz (1997a: 19-35 e 1997b: 219-228).
34 Prellwitz: 1997b: 219.
370 LA EDAD DEL GENIO: ESPAÑA E ITALIA EN TIEMPOS DE GÓNGORA
periodi di tre versi ciascuno dove entra direttamente in questione Fetonte, pu-nito e folgorato da Giove per la sua eccessiva audacia. Tale punizione, di cui viene dato un primo chiaro indizio al v. 7, da leggere in stretta connessione con il v. 5, ha la funzione di ristabilire l’ordine: l’incendio che ha folgorato l’audace giovanotto ( fulgor de mancebo altivo) ha riequilibrato la sua hybris (fija en nivel la balanza).
Fin qui il ricorso a Fetonte esprime un commento partecipato del poeta e una trasposizione mitica dei fatti, motivo per cui i copisti dell’epoca, con raris-sime eccezioni, catalogarono la décima tra quelle liriche. Ma ecco che al v. 6 compare il suo vero nucleo: la locuzione con efeto fugitivo, riferita, da un lato, alla caduta del mancebo audace come Fetonte, dall’altro alla partenza, ben più prosaica, del principe Carlo (e in questo senso la rima fugitivo - altivo non è di certo innocente). Se poi intendiamo gli ultimi tre versi della décima come una spiegazione di quanto affermato a proposito dell’intervento sul mancebo altivo, ci rendiamo conto del significato politico – para casos supremos – che assume il mito. Ancora più iperbolica di quella del figlio del sole, la caduta (e vien da chiedersi: per mano di quale Giove?) del principe aspirante alla mano di Maria ha il potere di unire due orienti, ossia due amori appena nati e subito tramontati. E che si tratti di amore ce lo dice l’ambigua relazione biunivoca che si viene a creare fra orientes de amor ed extremos de amor (vv. 9-10)35. Relazione che, connessa con i casos supremos del v. 8, rende patente l’ironia sul fallito progetto matrimoniale. Se già la caduta di Fetonte indica quella del sole e dell’amante troppo ardito, quando l’amore investe le alte sfere l’incendio assume proporzioni cosmiche.
In tutta la décima, quanto più è marcata l’insistenza sui termini che ri-conducono al campo semantico dell’alto – atrevida, cielos, sublime, altivo, extremos, supremos – tanto più cresce lo scarto con l’apparente lettura eroica della vicenda. D’altronde, nonostante che l’accento sia portato sull’asse verti-cale dell’ascesa e della caduta, i suoi versi centrali (Fija en nivel la balanza/ con efeto fugitivo, con una catena di allitterazioni che approda in fulgor) pon-gono la sua seconda parte sotto il segno piuttosto dell’orizzontalità. Inoltre, il contrasto fra la trasposizione mitologica che struttura la décima e la sua sottile ironia sembra riflettere un altro contrasto extra-testuale: quello tra i fasti profusi durante il soggiorno del principe alla corte madrilena e la sua partenza improvvisa.
Nel giro di dieci ottosillabi il poeta riesce a combinare una serie di signifi-
35 Il tema dell’ambizione spropositata di ascesa, al quale si lega quello dell’inesorabile e fatale caduta, centrale anche nei miti di Icaro e Prometeo, godette di particolare fortuna durante il Seicen-to. Sempre in ambito controriformista, la lettura cristiana di questi miti, emblemi dei limiti dell’am-bizione di conoscenza in nome di una remissione assoluta al piano divino, si estende anche alla sfera politica e ai doveri del buon cittadino. Sull’argomento cfr. Ginzburg 1986: 107-132 (in particolare pp. 110-117 del saggio).
GÓNGORA OPINIONISTA: LE DÉCIMAS DAL 1617 AL 1625 371
cati storici, politici, mitologici, e a commentare da un’angolatura non ufficiale e con toni apparentemente lirici, un evento della grande storia. Dando voce all’opinione più o meno nascosta di chi fu testimone diretto di quelle vicende.
Una «hermana menor»
Il ritmo serrato e la densità semantica delle décimas più mature, che Gón-gora abbina a soggetti effimeri e a una tonalità scherzosa quando non pro-priamente satirica, ricordano la concentrazione del sonetto, in particolare di quello burlesco, tanto che si è parlato della décima come una hermana me-nor del più celebre metro italiano36. Come avrebbe notato Millé37, l’espinela diventa una delle strofe più adatte ad esaltare le virtù dell’ottosillabo, verso che suggestivamente García Lorca aveva definito «alado» in contrapposizione all’endecasillabo che invece indosserebbe un «guante perfumado»38.
Di fatto, ognuna delle tre décimas esaminate trova corrispondenza con uno o più sonetti. Al caso evidente della décima rivolta al conte di Villaflor, personaggio già evocato in un sonetto di poco precedente, può aggiungersi quello altrettanto evidente di Atrevida confianza, décima di cui il sonetto Un-dosa tumba da al farol del día costituisce una sorta di rovescio encomiastico. Da notare inoltre come il sonetto riproponga nelle quartine la stessa dialettica fra Oriente e Occidente che regge, con gli effetti ironici che abbiamo visto, la décima, e nelle terzine quella nord-sud allusiva della cosmogonia politica e religiosa suscitata dall’evento.
Infine anche la malcelata critica nei confronti del Padre Pedrosa, spietato osservatore dell’esecuzione capitale di don Rodrigo Calderón, trova per con-verso il suo riscontro in due sonetti precedentemente composti. Mi riferisco a Sella el tronco sangriento, no lo oprime e Ser pudiera tu pira levantada (1621)39 in cui il poeta, a differenza del frate predicatore, mostra tutto il suo ac-corato cordoglio in occasione di uno degli avvenimenti più cruenti del secolo.
Gli esempi portati finora mostrano come non si possano analizzare i testi gongorini separatamente ma in relazione l’uno con l’altro. Solo così la loro apparente oscurità viene ricondotta all’oggettiva difficoltà di una poesia in cui sentimenti e opinioni possono intuirsi dietro alla densità concettosa che regge queste e molte altre décimas40.
36 Cfr. Carreira, 1994: 26. 37 Millé 1937: 40 (che come farà Carreira, aveva alluso anche al parallelismo tra i due metri:
«La décima representa, respecto del metro popular, lo mismo que el soneto e italianizante ende-casílabo para el erudito»).
38 García Lorca 1960: 86 e 67.39 OC: I, 557 e 558.40 Non è azzardato estendere alle décimas gongorine, e più in generale all’opera di don Luis,
372 LA EDAD DEL GENIO: ESPAÑA E ITALIA EN TIEMPOS DE GÓNGORA
Se la forma del sonetto, insomma, mostra in genere il Góngora eroico e convenzionale, dietro le singole vicende stilizzate con ambigua lucidità dalle décimas, non solo affiora il volto più intimo e in qualche modo sincero del poeta, ma trapelano anche aspetti sconosciuti di una società bizzarra e impie-tosa, indagata in tutte le sue ipocrisie, malizie e contraddizioni.
Bibliografia
alarcón y Mendoza, Juan Ruiz de, Elogio descriptivo escrito con motivo del famoso juego de toros y de cañas celebrado en Madrid en agosto de 1623, ed. de R. Iglesias, Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2000 [www.cervantesvirtual.com]. Consultato il 3 novembre 2013.
alManSa y Mendoza, Andrés de, Obra periodística, ed. y estudio de H. Ettinghausen y M. Borrego, Madrid, Castalia, 2001.
Blanco, Mercedes, «Doble sentido y alusión en la sátira de Góngora», en «Difícil cosa no escribir sátiras». La sátira en verso en la España de los Siglo de Oro, dir. A. Gargano, eds. M. D’Agostino, F. Gherardi, Vigo, Academia Editorial del Hispanismo, 2012a, pp. 151-172.
Blanco, Mercedes, Góngora o la invención de una lengua, León, Universidad de León, 2012b.
Blanco, Mercedes, «Bajo el signo de la agudeza: el arte epigramático de las décimas de Góngora», en Góngora y el epigrama. Estudios sobre las décimas, eds. J.M. Caballe-ro, J.M. Micó, J. Ponce Cárdenas Madrid-Frankfurt, Iberoamericana Vervuert, 2013, pp. 43-78.
carreira, Antonio, «Los poemas de Góngora y sus circustancias: seis manuscritos re-cuperados», Criticón, 56, 1992, pp. 7-20 (poi in Gongoremas, Barcelona, Península, 1998, pp. 95-118.)
carreira, Antonio, Nuevos poemas atribuidos a Góngora, prólogo de R. Jammes, Bar-celona, Sirmio Quaderns Crema, 1994.
clarKe, Dorothy C., «Sobre la espinela», Revista de Filología Española, 23, 1936, pp. 293-304.
elliot, John H., El conde-duque de Olivares. El político en una época de decadencia, trad. castellana de T. de Lozoya, Barcelona, Editorial Crítica, 1990 (The Count-Duke of Olivares. The Statesman in an Age of Decline, Yale University, New Haven y Lon-dres, 1986).
la distinzione che fa Fortini – e che ha ripreso di recente Guido Mazzoni – tra oscurità e difficoltà poetiche. La poesia moderna, così come quella di Góngora per secoli accusato di essere “oscuro”, è difficile perché «accetta anzi esige l’interpretazione e la parafrasi», in opposizione alla poesia postromantica, simbolista o surrealista, oscura poiché intenzionalmente indecifrabile (cfr. Fortini 1991: 87 e Mazzoni 2005: 167-168).
GÓNGORA OPINIONISTA: LE DÉCIMAS DAL 1617 AL 1625 373
enciclopedia cattolica, dir. Mons. P. Paschini, Città del Vaticano-Firenze, Sansoni, 1949, vol. III.
etienvre, Jean-Pierre, Figures du jeu, Madrid, Bibliothèque de la Casa de Velázquez, 1987.
fortini, Franco, «Oscurità e difficoltà», L’asino d’oro, II, 3, 1991, pp. 84-88.
García lorca, Federico, La imagen poética de Góngora, en Obras Completas, Madrid, Aguilar, 1960, pp. 65-88.
Garrote Bernal, Gaspar, «Estudio preliminar», en vicente eSpinel, Obras completas, Málaga, Diputación Provincial de Málaga, 1993, vol. II, pp. 11-395.
GaScón de torqueMada, Gerónimo, Gaçeta y nuevas de la corte de España desde el año 1600 en adelante, ed. facsímil de A. Ceballo-Escalera y Gila, Madrid, Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, 1991.
GinzBurG, Carlo, «L’alto e il basso», in Miti, emblemi e spie, Torino, Einaudi, 1986, pp. 107-132.
GónGora, Luis de, Letrillas, edición, introducción y notas de R. Jammes, Madrid, Ca-stalia, 1980.
GónGora, Luis de, Obras Completas, recopilación, prólogo y notas de J. y I. Millé y Giménez, Madrid, Aguilar, 1932.
GónGora, Luis de, Obras Completas, ed. de A. Carreira, Madrid, Biblioteca Castro, Fun-dación J. A. de Castro, 2000, 2 vols.
Gracián, Baltasar, Agudeza y arte de ingenio, ed. de C. Peralta, J. M. Ayala, J. M., An-dreu, Zaragoza, Larumbe, 2004, 2 vols.
Guillén, Jorge, Notas para una edición comentada de Góngora, edición, notas y acota-ciones A. Piedra y J. Bravo, prólogo J. M. Micó, Valladolid, Fundación Jorge Guillén, Universidad de Castilla-La Mancha, 2002.
JaMMeS, Robert, La obra poética de don Luis de Góngora y Argote, trad. de M. Moya, Ca-stalia, 1987 (Études sur l’œuvre poétique de Don Luis de Góngora, Bordeaux, Institut d’Études Ibériques et Ibéroamericaines de l’Université, 1967).
JaMMeS, Robert, «Góngora, poeta para nuestro siglo», en Góngora: la estrella inextingui-ble, magnitud estética y universo contemporáneo, J. Roses, Madrid, Sociedad Estatal de Acción Cultura, (2012), pp. 17-29.
iGleSiaS, Rafael, «La estancia en Madrid de Carlos Estuardo, Príncipe de Gales, en 1623: crónica de un desastre diplomático anunciado», Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2001 [www.cervantesvirtual.com]. Consultato il 3 novembre 2013.
leSaGe, Roberto, Oggetti e vesti liturgiche, trad. di C. Amadei, Catania, Edizioni Paoline, 1958 (Objets et habits liturgiques, Paris, Fayard, 1957).
Mazzoni, Guido, Sulla poesia moderna, Bologna, Il Mulino, 2005.
Micó, José María, «En los orígines de la espinela. Vida y muerte de una estrofa olvidada: la novena» en Las razones del poeta. Forma poética e historia literaria de Dante a Borges, Madrid, Gredos, 2008, pp. 73-86.
374 LA EDAD DEL GENIO: ESPAÑA E ITALIA EN TIEMPOS DE GÓNGORA
Millé y GiMénez, Juan, «Sobre la fecha de la invención de la décima o espinela», Hispa-nic Review, V, 1937, pp. 40-51.
Mizzau, Marina, L’ironia. La contraddizione consentita, Milano, Feltrinelli, 1984.
prellwitz, Norbert von, «Góngora: el vuelo audaz del poeta», Bulletin of Hispanic Stu-dies, LXXIV, 1997a, pp. 19-35.
prellwitz, Norbert von, «Il poeta e la bussola. Il periplo di Góngora», in G. Poggi (ed.), Da Góngora a Góngora, Pisa, ETS, 1997b, pp. 219-228.
Salcedo coronel, García de, Las obras de don Luis de Góngora comentadas [Primera Parte], Madrid, Imprenta Real, 1644, vol. I.
Edizioni ETSPiazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa
[email protected] - www.edizioniets.comFinito di stampare nel mese di dicembre 2013