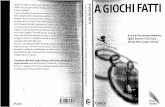Gender is videogaming. Esperienze di Altro genere nei giochi elettronici
-
Upload
uniromatre -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Gender is videogaming. Esperienze di Altro genere nei giochi elettronici
/.roì.."4r_...
§,:ò;'..t'o/2'/>u'--+
TGRANI)lplr'r'oll
L incontro con I'Altro, che fa ormai pat'lc tlt'llit ttrrrlt tt
esperienza quotidiana, è da lungo tctttpo o1i1lt'llo rll
riflessione da parte delle scienze socilli. ( )p.pi, lrtlln
via, sembra quanto mai opportuno rilìrrtttttlittc t lrtmini dell'indagine teorica poiché I'altcritir ttott l)ttnessere più tanto facilmente distirrta dtll'irlcrrtitti rh'l
Sé. Oltre a ciò, l'inevitabilità dell'inconlt() t'ott l'Altro spinge ad una rinnovata riflessitllte stti tottt'clll rll
identità e di diversità.I contributi raccolti in questo volumc, pttr'pittk'ttrhr rlttprospettive diverse e approdando ucl csili rlillctcttll,hanno un unico filo conduttore: mosllirr'(' lc itttpltlrtzioni che le diverse ricostruzioni dell'Altlo lxl\\olt(ravere per l'identità del Sé.
r sBN 88- 73',t 3 I /(; X
A.l,'lllris / l,'. l'crrucci / Il. Giomi( l. Mad«lalcrra / Iì M«rnceri / S. Schimada
a
Ie
=BE
ÈFo
IMMAGINIDELYATTROIdentità e diversità a confrontoa cura di Flavia Monceri
eltililililtiltilililtiltilil
@ copyright.2006Edizioni LavoroRomavia Lancisi 25
copertina di Fausto Bonaseraimmagine di Fausto Bonasera
composiziqne: Typeface, Cervetèri (Roma)finito di starnpare nel luglio,2006dalla tipolitografia EmpographVillaAdriana (Roma)
Sommario
Prefazionedi FlaviaMonceri
Identità e alterità.Una prospettiva filosoficadiAdriano Fabris
La disabilità: differenza e alteritàfra natura e culturadiFabio Feruacci
Gender is videogaming. EsperienzediAltro genere nei giochi elettronicidiElisaGiomi
Cometi chiami di nome?di Giovanni Maddalena
L' impermanenza dell' ordine.Appunti sulla diversitàcome problemapoliticodi FlaviaMonceri
15
51
99
r43
t'75
Gender is videogaming.Esperienze diAltro generenei giochi elettronicidiElisaGiomi
L'Altro,i media,i nuovi media.
La realtà delle esperienze virtuali
«Là fuori c'è qualcosa che non sono io, qualco-sache non èdi miaproduzioneed è al di fuori delmio controllo: qualcosa di distinto, diverso, di 1à
dal mio campo di azione e che pure occupa ilmio tesso spazio, il mio stesso panama sociale>> .
Così Roger Silverstone inizia la sua riflessionededicata all'Altro in un libro significativamen-te intitolato Perché studiare i media? (Silver-stone 2002). Se alcuni non si sono mai posti se.riamente questa domanda, certo per molti altriessa suonerà persino retorica: i media sono im-portanti, centrali, anzi, nella vita sociale e cul-turale contemporanea; oggetti, agenti e proces-
si allo stesso tempo, che intervengono ovunquegli esseri umani si aggreghino e comunichino,si divertano o imparino, all'interno di spazi vir-tuali o reali. Sono importanti perché profonda-
99
mente radicati nel tessuto della nostra vita quo_tidiana e del senso comune, a cui danno forma eda cui sono plasmati.Una delle dimensioni in cui si maxifestano lapervasività dei media e il rapporlo dialettico cheessi instaurano con l'esperienza vissuta, indivi_duale e collettiva, è, appunto,l,«alterità». Sem_pre più l'Altro ci arriva oggi solo attraverso lerappresentazioni dei media, che tutti confrontia_mo con la nostra espeienzadiretta e integriamonel nostro bagagtio conoscitivo. Se a questaconstatazione, certo non nuova, aggiungiamoche la vita associata, la vita con altri, è, per defi_nizione, una vita morale <<perfino nellasua im_moralitàoccasionale o cronic»>, si pone con for-za il problema dell'eticità dell'operato dei me_dia. Silverstone la affronta in relazione a dueaspetti: la distanza e la soggettività. Nel primocaso i media possono agire in modo da annulla_re I'Altro, negandogli il diritto alla rappresenta_zione tout coltrt, o al contrario, avvicinandolo atal punto da produrre una sorta di strabismo, cheimpedisce di riconoscerne la differenza e la spe_cificità.Silverstone riflette quindi sulla frammentazionedel soggetto contemporaneo, che, differenziatoe nomade, si muove per il mondo come un ca_maleonte. <<lJomo al mattino, donna al pomerig_gio e magari qualcosa di completamente diversodopo ceno>; i suoi gusti, i suoi stili, Ia suaperso_
700
na possono cambiare a ogni momento di consu-mo. Questo processo è sempre mediato,riflesso,testimoniato dai media e reso possibile dalla lo-ro presenza, che pone quindi una minaccia allavita morale: la moralità si fonda sulla relazionefra il Sé e I'Altro, ed entrambi richiedono un cer-to grado di integrità. Laconclusione è che <<i me-dia sono strutturalmente amorali, non immorali:la distanza che creano e mascherano come vici-nanza, le connessioni che operano mentre ci ten-gono separati,la loro vulnerabilità alla dissimu-lazione (dall'alterazione delle immagini dei do-cumentari al mascheramento delle identità in in-ternet) riducono la visibilità e la vividezza del-l' Altro>> (S ilverstone 2002, p . 21 5) . La tecnolo-gia può frammentare la nostra identità, disper-dendola; può annullare o isolare l'altro, e senza
l'altro siamo ugualmente perduti.Nonostante il riferimento al <<mascheramento
delle identità in interneb>, è evidente come la tec-nologia cui si riferisce Silverstone qui sia quelladi tipo broadcasting, che identifica cioè i mediatradizionali come radio, televisione e stampa. Ilproblema dell'Altro assume però contomi e va-lenze inedite nel contesto dei nuovi media, i me-dia, cioè, nati dallo sviluppo dellaTci,la tecnolo-gia della comunicazione e dell'informazione.Un terreno di analisi parlicolarmente produtti-vo, a cui è dedicato questo lavoro, affiora inquei prodotti che consentono all'utente di im-
101
mergersi in ambienti artificiali tramite un suoalter ego digitale -l'<<avatar>> -con cui muover_si e compiere azioni (virtuali) di varia natura.Tali ambienti possono essere elaborati attraver_so la computer graphic, come nel caso dei vi_deogiochi, oppure evocati da descrizioni scrit-te, come nel caso dei Mud basati su testo, matutti posseggono le caratteristiche attribuite allerappresentazioni mediali in genere: non costi_tuiscono, cioè, spazi simbolici totalmente auto_referenziali, in cui la realtà empirica è negata,sostituita da una iperrealtà in grado di offriresolo riproduzione e simulazione; al contrario,sono <<luoghi>> in cui si consumano esperienze(estetiche, cognitive, sensoriali) concrete, epertanto destinate a intervenire profondamentesui nostri atteggiamenti, valori e comportamen-ti, sul modo in cui ci posizioniamo nel mondo eci rapportiamo agli altri nella vita reale.Un sostegno a questa posizione ci viene da To-m6s Maldonado, il cui Reale e virtuale,sebbe-ne datato, rappresenta ancora una lettura impre-scindibile per gli studiosi del settore. Dopo averesaminato i rischi di alienazione connessi al-l'immersione in questi ambienti illusori cheprendono il nome di cyberspazio,l,autore ne ri_vela la profonda ambivalenza: riflettendo sulvalore conoscitivo delle immagini, afferma chequelle complterizzate e ad alta fedeltà propriedel cyberspazio sono persino in grado di arric-
102
chire Ia nostra esperienza, anzi, di fornirci ptù
esperienza di quella che avremmo potuto rac-
cogliere, senza la mediazione dell'immaginale,in un rapporto empirico con la realtà. Certo, <<1e
realtà virtuali spezzano il nostro legame con ilmondo delle cose e dei corpi, assottigliano sem-
pre di più la nostra possibilità di esperienza con
l'universo della fisicità, ma questi costrutti ico-nici sono stati elaborati sulla base della nostra
esperienza passata e presente con quel mondo e
con quell'universo>> (Maldonado 2005 ,p .61) .
Interagire in ambienti artificiali e immersivi si-
gnifica dotarsi di strumenti e conoscenze utili an-
che per muoversi nella realtà fisica. La spiega-
zione risiede nella profonda analogia tra le due
dimensioni e nel modo in cui esse sono percepite
dall'osservatore, le cui strutture neurali e di cate-
gorizzazione gliele fanno awertire come se fos-
sero identiche, anche se non lo sono. Maldonado
opera però una distinzione tra gli ambienti aftifi-ciali elaborati per mezzo della computer 7rq-phic: datnlato vi sarebbero modelli informaticiche simulano larealtà e consentono di aumentar-
ne la cono sc enza, dall' altro i video ga me, ryezzidi intrattenimento informatico, destinati a un uso
esclusivamente ludico. Qui proponiamo un in-terpretazione altemativa, nella convinzione che
anche i videogame, seppur non progettati allo
scopo di fornire schemi di interpretazione e crite-
ri di intervento sul reale, implichino forme di in-
L03
terazione dotate dello stesso valore conoscitivodei primi. Bisogna specificare che coloro che, adifferenza di Maldonado, collocano esplicita_mente i videogiochi in una dimensione di <<iper_realtà» si riferiscono non tanto al grado di verosi_miglianza assunto da rappresen tazioni grafichecreate con tecnologie sempre più sofisticate,quanto alla presenza di «regolepiù reali del rea_/e, nella misura in cui offrono la possibilità di es_sere seguite o aggirate senza che ciò comportiparticolari sanzioni e immediate conseguenze>>(Carzo, Centorrino 2002,p. 60). Tuttavia, vedre_mo come in alcuni casi la situazione ludica deivideogiochi consenta di sviluppare un bagaglioesperenziale molto ricco e articolato, utile so_prattutto alla nostra relazione con l,Altro: benlungi dall'essere cancellato o <<opacizzato>>, essopotrebbe persino risultare più nitido.r
Esperienze di Altro genere
L Altro a cui ci riferiamo in questa sede è l,altrodanoi in terminidi genere.Il genere, siaperdona_to il gioco di parole, non è certo un concetto neu_tro: all'interno del dibattito femminista esprime
l.Con questo non vogliamo minimizzareipotenziali effefti negativi dell'uso di videogiochi, ben iocumentati inValleur, Matysiak (2004).
104
infatti precise posizioni teoriche, politiche e cul-turali, distinte da quelle veicolate invece da cate-gorie come sesso o differenza sessuale. Viene uti-Tizzatoper <<indicare I'insieme di caratteri che de-
finiscono l'essere donna e l'essere uomo, intesicome identità personale o di gruppo, caratteri ap-presi e non innati». Il termine denota in primoluogo il rifiuto del determinismo biologico, e si
oppone ai precedenti che invece <<connotano dasempre I'elemento fisso, immutabile, del femmi-nile e del maschile (Boccia2001,p.4).
Questo approccio, sviluppato in area anglosasso-ne e noto con il nome di Gender Studies, nega che
Ie forme sociali e culturali dei rapporti fra sessi
abbiano un fondamento essenzialista, owero che
siano riconducibili a una differenza individuatanella funzione biologica e nella riproduzione del-la specie: il genere è una costruzione culturale equindi interamente arbitraria, scrive Joan Scottdenunciando «le origini interamente sociali delleidentità soggettive di uomini e donne»,così comedelle idee circa i ruoli più adeguati agli uni e allealtre (Scott 1996, p. 3 14). Secondo l'approcciodeiGender Studles, se si luole spezzare il legametra natura, identità e ruolo, è necessario sottopor-re il genere ad una sistematica decostruzione.Decostruire il genere, svincolarlo da una pre-sunta radice anatomica, consente di comprende-re come tra i due poli che la nostra cultura tradi-zionalmente codifica come maschile e femmini-
L05
le si collochi un'insieme di configurazioni inter-medie, identità «ambigue>>, perché non ricondu-cibili, come evidenzia bene la Queer Theory, asemplici opposizioni binarie; fluide e sfuggenti,inaffenabili attraverso le etichette comunemen-te usate per definire orientamenti e pratiche ses-
suali o attraverso i modelli di ruolo imposti dal-la nostra società ai diversi soggetti sessuati.2
Larealtà virtuale si offe come interessante teffe-no in cui mettere in atto strategie di decostruzio-ne del genere, che consentono di assumere ruoli<(altri>> da quelli previsti dal contesto culturale incui viviamo e che spesso producono effetti an-
che nel mondo reale. <<Pratiche di appropriazio-ne e sovversione>>, come le definisce Judith But-ler in un capitolo di Corpi che contano (1996),a
2 Parafrasando la posizione di Judith Butler, intendo la no-zione di <<queeD> e <<queerness>) come qualcosa che si col-loca in definitiva oltre il genere; un'attitudine non ricon-ducibile, o non semplicemente limitabile, al paradigmadelle opposizioni binarie come maschile/femminile o ete-rosessuale/omosessuale, quest'ultima cosffuita come <<na-
turale» esteirsione della prima (Butler 1998). Dato che iltermine verrà utilizzato soprattutto in riferimento alle rap-presentazioni e alla fruizione della cultura popolare, ri-mando adAlexander Doty per una discussione delle diver-se definizioni di queer e queerness in questo contesto(Doty 1993,p. XVIII).3 Il capitolo in questione è «Il genere brucia. Questioni diappropriazione e sovversione>> («Genderis buming. Que-stions of appropriation and subversion>>).
106
cui si richiama il titolo di questo lavoro.3 Sherry
Turkle, cui si deve una delle prime e più comple-te indagini su identità e internet (Turkle 1996),4
osserva che tutta la rete è da considerarsi un
grande laboratorio sociale ove sperimentare l'e-sperienza della costruzione e ricostruzione del
sé. Questa funzione emerge con forza soprattut-
to all'interno delle applicazioni basate sul gio-
co, come i Mud, Multi-U ser Domains f comuni-tà virtuali in cui è possibile incontrarsi, conver-
sare, e, naturalmente, giocare,
Per muoversi in questi ambienti e interagire congli altri giocatori, l'utente si crea un proprioavatar (attraverso un nickname e una descrizio-ne, nel caso di Mud basati sul testo, o anche con
un'icona grafica, nei molti Mud che utilizzano imotori grafici dei videogame). Protetti dall'a-nonimato, molti scelgono di cambiare sesso:
provare 7a differenza, sperimentare I'altro ver-
sante sono le loro motivazioni, ma anche esplo-
4 La letteratura sull'argomento è ormai vasta, ma un'ap-profondita riflessione sul tema dell'identità di genere ininternet si ffova anche in StoneAllucquère (1995) e, natu-
ralmente, nella produzione del cyberfemminismo, corren-te del pensiero femminista che qui possiamo solo accen-nare (per una dettagliata illustrazione, cfr. Vy'olmark
1999).5 Inrealtà,come gli appassionati ben sanno, la definizioneoriginale è Multi-User Dungeons,la cui etimologia pro-viene dal popolare gioco di ruolo fantasy Dungeons andDragons.
107
rare aspetti del proprio io che nella vita di tutti igiorni rimangono inespressi, perché li si ritienepreclusi dall'appartenenza a un determinato ge-nere o in contrasto con essa, o perché si pensache le stesse attitudini e modalità di relazione,se associate al genere opposto, assumano nuovee più positive connotazioni. Dietro ogni proces_so di travestimento, ogni maschera - digitale oconcreta - c'è sempre e comunque un bisognoossessivo di far coincidere ciò che si è con l,i_dentità desiderata e progettata. Mascherandosi,insomma, si è più simili a se stessi.I1 genere è sempre una <<performance>>, comesostiene Butler, e anche nei Mud abitare provvi-soriamente i panni dell'Altro richiede una com_plessa operazione di mimesi, densa di impor-tanti conseguenze. Al contrario di quanto so-stiene Silverstone, che vede nel mascheramen-to delle identità e nella possibilità di essere uo_mo al mattino e donna al pomeriggio il rischiodi una disintegrazione della soggettività e di unoffuscamento dell'Altro (quindi, una minacciaalla vita morale che è per definizione vita asso-ciata), 1l cros s -dre s s ing in internet (travestirsiin modo da passare per una persona del sessoopposto) consente di sviluppare una maggioreconoscenza di se stessi e una relazione più em_patica con l'Altro, sperimentando i problemi egli svantaggi associati alla sua condizione e airegimi di potere che la costruiscono.
108
Naturalmente, le modalità di costruzione e ne-goziazione delle identità di genere riflettono, inquesti contesti, il modo in cui iI genere operanel mondo reale: proprio perquesto il cyberspa-zio può divenire un ulteriore luogo di riprodu-zione di asimmetrie e stereotipi ben noti, che,ben lungi dallo scardinare le categorie binariedell' etero ses s ualità, al contrario natur alizzanola norma e ne rafforzano I'azione prescrittiva. Èquesta profonda ambivalenza che ci accingia-mo a mettere in luce attraverso l'analisi dei vi-deogame, un caso abbastanza diverso da quellodei giochi on line.
I videogame, il sé e l'Altro(sempre lo stesso, in realtà)
A differenza dei Mud, nei videogiochi6 non vi èla possibilità di costruirsi un proprio avatar:nella maggior parte dei casi la scelta è limitata aun certo numero di personaggi fissi.Come ogni artefatto mediale, specie se di tipopopolare, i videogame sono realizzatientro strut-ture di produzione,forze economiche e relazionidi potere profondamente inserite nella società,
6 Utilizziamo indistintamente il termine «videogiochi» tan-to per le consolle domestiche, che si collegano normalmen-te al televisore (la PlayStation della Sony o il GameBoydella Nintendo, per esempio) quanto per i giochi per pc.
109
del cui ordine simbolico inevitabilmente reca-no traccia. Ora, in una società ancora rigidamen-te eterosessuale e patriarcale, in cui la mascolini-tà è la norma invisibile,l'Altro, quell'Altro «di-stinto e diverso che sfugge al mio controllo>>, è,per definizione, la donna: essa significa la diffe-renza.T L equivalenza ttala donna e l'Altro di-viene ancor più forte, fino quasi a far coinciderei concetti, all'interno dell'industria dei videoga-me, profondamente maschile (maschilista) sianell'apparato produttivo che nella composizionedel pubblico e, naturalmente, nell'universo nar-rativo dei videogame stessi. Un breve excursusstorico aiuterà a chiarirsi Ie idee.8
Uno studio del 1991 realizzato su un centinaiodi videogame mostra come il 92 per cento noncontenga neppure un personaggio femminile,del restante 8 per cento la maggioranza (6 per
7 Come sottolineano le teoriche che si riconoscono nel fem-minismo della differenza, questo avviene perché la nostrasocietà e la nostra cultura hanno da sempre assunto il ma-schile aparadigmadell'umano in quanto umano,producen-do un Aras inossidabile, noto come universalismo indebito eben segnalato dalla pratica linguistica («esseri umani»).Così,ladifferenza sessuale, tradizionalmente, non viene in-tesa come differenza che divide gli esseri umani in uomini edonne, cioè come una differenza tra due esseri, ma come ildifferire delle donne dagli :uomini, una «differenza secon-daria, derivata, specifico> (Boccia 2001).8 Per una ricostruzione dell'evoluzione del videogiocomolto più dettagliata e attenta anche all'aspetto tecnologi-co, cfr. Carzo e Centorrino (2o02,capitolo2).
170
cento) include donne nel ruolo della damigella
che deve essere salvata dal protagonista e solo il2 per cento vantapersonaggi femminili attivi; diquesti, però,la stragrande maggioranza non so-
no umani (Ms. Pacman, Mama Kangeero ecce-
tera, Cassell, Jenkins 1999,p.7). I vertici delle
maggiori aziende di videogame, fino alla metà
degli anni Novanta, si difendevano affermando
che i giochi sono concepiti per un pubblico ma-
schile perché questo rappresenta il loro core tar-get'. dei 10 bilioni di dollari incassati dalle ven-
dite, una percentuale compresa tra il 75 e l'85per cento proviene da acquirenti maschi.
Dalla metà degli anni Novanta in poi si registra
un cambiamento, con il lancio nel1994 del pri-mo videogame espressamente indirizzato a un
target femminile (Hawaii High: The Mystery ofthe Tiki), altri ne seguono, ma nessuno ottiene
successo, almeno fino all'arrivo, nel 1995, diBarbie FashionDesign.Nel frattempo, va affer-
mandosi un vero e proprio movimento, il GirlGame Movement, costituito da piccole aziende
(Herlnteractive, Girl Games, Girltech, Purple
Moon) guidate da donne e costituite da staffpre-valentemente al femminile, decise a raggiunge-re il duplice obiettivo di trasformare le relazioni
fra generi all'interno della cultura americana e
conquistare un nuovo pubblico. Analizzandogusti e preferenze femminili attraverso ricerche
di mercato, progettano giochi solo per bambine,
177
con una grafica che ne riflette la presunta sensi-bilità estetica e intrecci meno centrati sull'azio-ne e più sui personaggi e sulle relazioni interper-sonali.Parte della critica ha accusato questi prodotti dirinforzare concezioni stereotipate del genere,naturalizzando la già forte polarizzazione dellacultura del gioco e contribuendo alla ghettizza-zione del mondo femminile. Si riprodurrebbe,cioè, la percezione della bambina (ragazza,donna) come I'Altro, portatrice di uno scartodalla norma, di una cultura separata, fatta di de-sideri e interessi assolutamente diversi da quel-li dei ragazzi, chiaramente distinguibili perchéattinenti esclusivamente alla sfera personale (lamoda, le fantasie romantiche, le relazioni so-ciali, l'emotività) e omogenei, perché indagatia partire da una presunta uniformità della cate-goria che, a sua volta, poggia sull'assunto es-senzialista: maschi e femmine vogliono cosediverse perché sono diversi, ovvero un'applica-zione del determinismo biologico al consumodei media digitali. Contemporaneamente, fuoridal terreno dei videogame only for girls, conti-nuano a proliferare indefesse le rappresentazio-ni sessiste: le donne sono invariabilmente vitti-me da salvare o persino antagonisti contro cuiesercitare violenza; di nuovo, l'Altro, diverso,distante, vicario, strumento dell'affermazionemaschile.
LL2
Invece di produrre forme di intrattenimento che
replicano l'esistente - lamenta una parte dellecritica femminista - sarebbe necessario elabo-
rare formati e software nuovi, in grado di riflet-tere la complessità e la varietà della vita delledonne, di promuovere una gamma quanto piùvasta possibile di identità di genere e di inter-pretazioni del femminile, del maschile e di tut-to ciò che c'è nel mezzo.Insomma, non inse-
gnare alle bambine a comportarsi come ci si
aspetta dalle bambine, ma offrire loro gli stru-
menti per divenire <<altro>> da se stesse.
Questo il dibattito in corso negli ambienti del-l'industria, dell'università e della critica quan-
do, nel 1996,è arrivata Lara Croft, protagonistadella fortunata serie di videogame Tomb Raider:rampolla dell' aristocrazia inglese, bellissima e
bellicosa archeologa con il gusto dell'avventu-ra, che salta, piroetta, spara, uccide, passando dilivello in livello senza che le si scomponga mail'acconciatura o che le sue voluttuose forme in3D risentano minimamente della forza di gravi-
tà. Una ricetta, secondo gli autori, che funzionaper entrambi i generi: è una donna forte e nelruolo di protagonista, ma iragazzi la adorano; se
e s s i s ono stati 1l c o r e t a r g e t della campag na pub-
blicitaria del videogame,Laraè presto diventa-ta un fenomeno di culto anche tra le rugazzu perloro, anzi, ha rappresentato un nodo di accesso
al dominio discorsivo dei videogame di main-
113
stream. La novità è stata tale da giustificare losviluppo, anno dopo anno, di una letteratura cheriflette sulla formazione delf identità di genereall'intemo dei videogame,e diTomb Raider inparticolare, ancora in una prospettiva prevalen-temente femminile/femminista, ora denuncian-do il carattere oppressivo della suaprotagonista,ora celebrandone la valenza sovversiva nei con-fronti dei ruoli di genere (Cassell, Jenkins 1999;Schleiner 200 1 ; Flanagan 2002;Kennedy 2002;Mikula 2003; Fantone 2003).Il risultato è che l'analisi dei significati connes-si al consumo diTomb Raider daparte di gioca-tori maschi è rimasta un po'in ombra, a dispet-to dell'evidenza: in via teorica, la comparsa dipersonaggi femminili forti e nel ruolo di prota-gonista unico, nel repertorio figurativo di vi-deogame non destinati aragazze,configura so-prattutto per i giocatori del sesso opposto unospazio di sperimentazione,in cui vivere identi-ficazioni cross-gender e vestire i panni dell'Al-tro per eccellenza.
Tbmb Raider/Media RaiderlNude Raider...l'instabilità di Lara Croft
Il primo gioco per computer della seie TombRaider,lanciato nel 1996 dalf inglese Core De-sign (proprietà della Eidos Interactive), dopo
114
due mesi aveva già venduto 500 mila copie, e
l'anno seguente Lara Croft appariva in quaran-ta riviste, partecipava al tour degli U2, posavacome modella per Gucci e registrava un singo-lo con l'ex chitarrista degli Eurythmics DaveStewart. Nel 1999 il numero delle copie com-plessivamente vendute dalle ormai tre serie diTomb Raider era salito a 17 milioni, incremen-tando in modo esponenziale la vendita dellaPlayStation della Sony e di schede video percomputer in 3D (Taylor 1999, p. 78). L indu-stria del merchandisingimpazzisce: bambole aforma di Lara, caramelle targate Lara, una lineadi abiti firmati da lei in Inghilterra, calendari,cancelleria, statuette... senza contare le incur-sioni multimediali: due film al suo attivo, cam-pagne televisive per il gioco stesso, svariatispot pubblicitari (per la Nike, per le automobiliSeat, per il drink Lucozade), fumetti e, natural-mente, infiniti siti web, ufficiali, ma soprattuttonon ufficiali, creati dai suoi fan. Non male, perqualcuno che, in fin dei conti, non esiste.Secondo Bob Rehak (2003), che analizzailfe-nomeno Lara Croft come esempio del funziona-mento dello star systeme delfandomall'intemodi ambienti digitali, arenderla una vera epropriaicona culturale è stata la sua capacità di migrareda una piattaforma mediale all'altra, capacitàche dipende in primo luogo dalla natura conver-gente dei media stessi: una convergenza econo-
115
mica (l'industria del cinema, quella della fv, del_la pubblicità, dei videogame sono componentidi un unico sistema dell,intrattenimento) e tec_nologica (basata sulla digitalizzazione dellaproduzione e distribuzione mediale).La possibilità offerta dai Mud di giocare libera_mente con le proprie autorappresentazioni,creando identità fittizie con cui muoversi all,in_terno del cyberspazio, in apparenza sembrerebbetotalmente preclusa in Tomb Raider: qui l,utentedispone di un unico alter ego preconfezionatocon cui proiettarsi sullo schermo del computer.Ma alcune considerazioni mostrano come non visia poi molta differenza tra le due situazioni ludi_che. Lara è divenuta un prodotto crossmedialegrazre anche a quella che è stata definita una«perversione>> polisemica, una capacità di risi_gnificarsi continuamente a seconda del contesto,che, a sua volta deriva dalla relativamente bassarisoluzione grafica del videogame (soprattuttonelle prime serie): Lara è una pura astrarìor", u,conglomerato di linee stilizzate,di segni senzareferente. La sua <(vuotezzarr, la sua man canzadidettagli caratterizzanti consentono la proiezionepsicologica daparte di giocatori femminili e ma_schili.Sebbene dotata di una forma estetica precisa, di_segnata dai suoi autori, Lara possiede quindi tuttal' instabilità semiotica propria dell, avaìar: conte_nitore da riempire, vuoto involucro che può esse_
176
re indossato come un guanto da chiunque (Rehak2003, p. 48 l). Insomma, l'eroina di Tbmb Raiderè un <<testo aperto» per eccellenza, bisognoso del-la cooperazione interpretativa del lettore/gioca-tore. E non solo del giocatore: vi è una complessarete di attività <<extra-gamiche», messa in operadai fan attraverso siti internet, mailing list e quan-t'altro, volta ad aumentare la <<risoluzione>> dellastar digitale nell'immaginario popolare, dotan-dola di una biografia, attribuendole gusti musica-li, misure ben precise e persino un gruppo sangui-gno, nonché organizzando concorsi dibellezzaon line dedicati alle sue sosia (umane).Il fatto che dal 2003, con il lancio di Angle ofDarkness,la definzione graftca sia aumentatamoltissimo non cambia le cose: Laraè virtuale eubiqua, e i fan hanno bisogno di assicurarle un'e-sistenza coerente, così da arricchire il mondonarrativo diTomb Raider e rendere più piacevo-le l'identificazione con la protagonista. Tuttepratiche, naturalmente, che contribuiscono alsuo successo, facendo la felicità della casa diproduzione: quest'ultima tuttavia, come vedre-mo tra breve, è sempre stata restia a incarn ar e La-ra attraverso un modello umano ufficiale.L instabilità semiotica di Lara e la sua disponibi-lità a essere <<indossata> da giocatori di sesso egenere diverso risiedono anche nella sostanzialeambivalenza estetica del personaggio: il suo cor-po è un ibrido, che comprende i tratti della butch
117
(pistole, cinturone, occhiali da sole, stivali mili-tai,forzafisica) e dellafemme (seni enormi, vi-ta esilissima, maglietta e short aderentissimi,grandi occhi, bocca a cuore eccetera). Un similemix non rappresenta certo una novità, anzi,evi-denziailforte debito di Lara nei confronti dell'i-conografia di diversi generi mediali.La compresenza di tratti maschili e femminili,sebbene declinati in altra forma, caratterizzamolte celebri eroine della cultura popolare au-diovisiva (si pensi aXena, principessa guerrie-ra e a Buffi I'ammaTT.avampiri, protagonistedelle omonime serie televisive, o alla PamelaAnderson di Barb Wire, solo per citarne alcune)ma, data la diretta derivazione dell'estetica deivideogame da quella dei fumetti,e è qui che le<<madri putative>> di Lara devono essere indivi-duate: WonderWoman, Batgirl o Elektra.Attri-buti sessuali da pin-up ed esagerata forza fisicarendono queste eroine <<trasgressive e perver-se>>, dove <<perverso)> significa un <<allontana-mento dal padre, un rifiuto del normale svilup-po della (etero)sessualità e del ruolo restrittivoche questa impone>> (Tasker 2002,p.30).La coesistenza di tratti femminili e maschilisembrerebbe dunque offrire interpretazioninuove e sovversive dell'essere donna, capaci di
e Non a caso Lara, nelle sue migrazioni mediali, approderàanche ai fumefti. Per un'analisi cfr. Seveso (2000).
118
minacciare i sistemi patriarcali di controllo e re-golazione.Altri non la pensano così: dopo averesaminato la galleria di bad girls rappresentatein più di cinquanta fumetti, Sherrie Inness con-clude che la ragione della loro popolarità è pre-sto detta: il sesso. I fumetti <(usano spesso la fi-gura delTa t ou gh w oman, della ragazzatosta, so-lo'per perpetuare gli stereotipi, disegnandolacome feticcio, bomba sexy e incontrollabile»(Inness 1999,p.139).Tutti gli attributi delle eroine dei fumetti risulta-no persino iperbolici, quasi caricaturali, nel casodi Lara per viadel suo look sintetico e tridimen-sionale, che la rende un improbabile concentratodi erotismo high tech. Tuttavia, focalizzarsi solosull'elemento visivo, considerando Lara comeoggetto della rappresentazione, non dice molto:per comprenderne il potenziale di scardinamen-to dei tradizionali ruoli di genere è necessarioanalizzare il personaggio nel contesto del video-game e del tipo di interazione che offre al gioca-tore. Anche quest'ultima si è prestata a interpre-tazionidi segno diametralmente opposto.
Oltre 1o spettacolo: f interazionernTomb Raider
Affronteremo la questione da un punto legger-mente periferico, ovvero le strategie di marke-
1.19
ting messe in atto dalla Eidos,l'azienda che haprodotto il videogame, e che in alcune occasio-ni ha scelto di incarnare Lara Croft attraversomodelle di volta in volta diverse: da Natalie Co-ok, Lara Weller e Rohna Mitra fino ad AngelinaJolie, protagonista dei film Tomb Raider (2001)eThe Cradle of Ltfe (2003). Prima della Jolie, laEidos è sempre stata riluttante a dare a Lara unalter ego in carne e ossa ufficiale: mantenereLara digitale consentiva un pieno controllo suisuoi movimenti e sulla sua personalità (RohnaMitra venne licenziata proprio perché invece diparlare interza persona parlava a nome di La-ra), senza contare che, come dicevamo, propriola sua virtualità e l'indeterminatezza che ne
consegue contribuiscono a fare di Lara un<<guanto>> indossabile da tutti.r0Secondo alcune interpretazioni vi sarebbe unprofondo contrasto tra il gioco di sguardi che lamodella di una pubblicità normalmente ingag-gia con 1o spettatore e il dispositivo che organiz-zainvece il punto di vista all'interno del gioco.Simon Ward racconta di essere rimasto sconvol-
10 È possibile infatti che la scelta di Angelina Jolie comemodello ufficiale, che ha uguagliato la popolarità dellaLara digitale, sia dovuto alla ambivalenza della Jolie stes-sa, apertamente bisessuale. Tra l'altro questa «stabilizza-zione» di Lara attraverso unapersonificazione unica inter-viene proprio nel momento in cui la Eidos smette di pro-durre videogame Tomb Raider.
120
to alla vista di una fotografia della modella LaraWeller nei panni di Lara Croft che lo fissava ne-gli occhi e gli puntava due pistole contro: unaprofonda contraddizione, secondo il critico,perché l'eroina di Tomb Raider diviene così unospettacolo sessuale e una rivolta contro lo spet-
tacolo al tempo stesso (Ward 2000).In altri ter-mini, mentre le diverse incamazioni di Lara,protagoniste di spot pubblicitari di ogni tipo otestimonial delle campagne di marketing per
l'azienda stessa, restituiscono Io sguardo dellospettatore e dimostrano così la loro consapevo-lezza di esserne l'oggetto, il funzionamento tec-nico e simbolico della Lara digitale escludecompletamente questa possibilità.Nei giochi ditipofirst-person shooter l'avatar è
invisibile per il giocatore, ma visibile agli altri,se sono previsti più utenti (ad esempio, nel cele-bre Doom, tra i primi attilizzare questa formu-la, si vedono solo le mani del personaggio).Tbmb Raider invece è w third-person shootergame,un gioco interuapersona, in cui cioè ilgiocatore può vedere l'avatar muoversi sulloschermo. La modalità di costruzione della pro-spettiva in Tbmb Raider è presa in prestito dalcinema: il punto di vista del giocatore è total-mente disancorato da quello di Lara e funzionapiuttosto come una cinepresa, i cui movimentiegli può in buona parte controllare come se fos-se un regista invisibile che varia di volta in vol-
121
ta le inquadrature, zoomando su un punto dietroalle spalle di Lara (fino quasi a far coincidere ilsuo punto di vista con quello di lei) o piuttosto
ricorrendo a primi piani e campi lunghi.In que-
sto senso, la modalità di rappresentazione delcorpo femminile in Tomb Raider differisce da
quella del cinema solo per l'interattività dello
schema e per la complessa architettura di posi-
zionamenti che offre al giocatore (Poole 2000,p. 133): non a caso, per i videogame di questo ti-po si parla di <<cinema interattivo>> (Friedman
1995,p.77).tlInquadrata da angolazioni di volta in volta di-verse, che consentono di apprezzare la sua vo-luttuosa femminilità, Lara non guarda mai inmacchina, per così dire, e quindi non è consape-
vole di essere guardata. Questo meccanismo laqualifica come perfetto oggetto di contempla-zione erotica, dato che il piacere voyeuristico ò
determinato, appunto, dal guardare senza esse-
re visti.r2 Si tratta di una possibile componentedell' esperienza estetica di Tomb Raider, ma che
non esaurisce la varietà delle posizioni sogget-
I I Secondo alcuni, Ia caratteristica interattiva dei videogameimpedisce di assimilarne I'esperienza estetica a quella delcinema, perché nel primo caso è il giocatore che detta tem-pi ed eventi mentre nel secondo gli effetti emotivi dipendo-no proprio dalla continuità del tempo e dall'impossibilità dibloccare o modificare l'azione (Conti 2002, p.486).12 Mi richiamo al ben noto articolo di Laura Mulvey (1978).
122
tive e dei percorsi narrativi resi possibili dallastruttura del gioco e, soprattutto, non tiene con-to della complessa modalità di interazione conl'avatar.In realtà, c'è un modo in cui Lara mostra la con-sapevolezza dello spettatore, dell'Altro: se ten-ti di farle fare movimenti sbagliati, dice no e si
ferma, ansimando. Tomb Raider, infatti, richie-de che il giocatore impari come muovere Lara,come farla saltare, rotolare, sparare, insomma,che impari a «essere>> Lara. Lo schema non pro-gredisce finché egli non è in grado di controlla-re Laralse stesso nello spazio tridimensionaledel videogame; solo quando acquisisce pienapadronanza di tasti e comandi, Lara diviene una<<seconda pelle>>, i suoi movimenti divengonoquelli del giocatore e viceversa, senza cesure eresistenze: un rapporto di «fluida interconnes-sione, che sembra mettere l'avatar e il giocato-re nello stesso corpo, così che non si capisce piùquale è l'origine delle performances>>.In que-sto modo il giocatore àncora la sua soggettivitàa quella di Lara ed esperisce attraverso di lei ilpiacere del gioco.Tornando alle riflessioni di Tasker circa le prota-goniste dei film di azione e dei fumetti,la studio-sa nota come vi sia una tensione, una contradd!zione tra «immagini femminili costruite, dise-gnate per essere contemplate in pose statiche e illoro essere allo stesso tempo inserite in dinami-
723
chedi azione» (Tasker 1998,p.70).Come abbia-
mo visto,le incursioni multimediali di Lara (dai
fumetti, ai disegni, ai siti intemet, agli spot pub-
blicitari, al cinema) configurano fenomeni simi-li: anche la LaralAngelina Jolie protagonista dei
due film è contemporaneamente l'eroe (quindi,
soggetto attivo) e l'eroina (da contemplare, quin-
di oggetto passivo); agente e spettacolo al tempo
stesso. Ma quando Lara è l'avatar di un video-gioco la contraddizione diventa eclatante, fino arisolversi in una dinamicaben precisae differen-te da quelle che ne caratteizzail consumo attra-
verso altri supporti mediali. Giocare <<nei suoi
panni>>, muoverla./muoversi con un joystick, in-staurare con lei iltipo di interazione che abbiamo
descritto, consente al giocatore di fondersi con ilpersonaggio, e questo distrugge la relazione tra
spettatore e spettacolo, tra soggetto e oggetto, tra
attivo e passivo.
Tecnologie del desiderio, tecnologiedi controllo
Gli effetti di una tale dissoluzione possono di-venire paradossali. Secondo Ward, il giocatore
diviene Lara,Lara diviene il giocatore, e <<an-
che se lei incorpora la mia banalità,la mia ordi-narietà, rimane bellissima. Ne deriva uno stra-
no corto circuito tra lo sguardo che desidera e
L24
1'esibizione: sguardo ed esibizione sono unasola cosa, avviluppati entro una narcisistica re-lazione molto più sicura e simmetrica di qual-siasi cosa Leopold von Sacher-Masoch avrebbemai potuto immaginare» (Ward 2000).Indos-sando l'avatar Laru Croft, il giocatore (ma-schio) si trova dentro di lei, e dato che lei è sola,è solo anche lui: così, giocare conTomb Raidersignifica divenire l'oggetto del desiderio ses-
suale di se stessi, un gioco interamente autoero-tico, perché non c'è da fare i conti con il piace-re di nessun altro.Anzi, nonc'è,tout court,pre-senza dell'Altro, che è stato completamentesussunto in sé come risultato dell'aver impara-to a padroneggiare iljoystick.Simili interazioni giocatore-avatar stroncanoogni valenza dei videogame come terreni peruna attiva riconfigurazione delle identità di ge-nere: 1'ancoraggio della soggettività maschile a
significanti femminili non si risolve in una oc-casione per sperimentare la differenza ma inuna pratica volta a netilralizzarla, approprian-dola e quasi assorbendola in sé, per poi cancel-larla nell'autoerotismo.
Questa risposta costituisce probabilmente unaderiva interpretativa rispetto alla lettura preferi-ta degli autori del videogame, che tuttavia per ilgiocatore maschio ed eterosessuale prevede ilconsumo di Laraproprio come oggetto del desi-derio. Essi affermano di aver scaftato la più faci-
725
le opzione di due distinti avatar (uomo e donna),nella convinzione che Lara avrebbe funzionatoper entrambi i generi, offrendo alleragazze unmodello di ruolo positivo ed esercitando sui ra-gazzitn'alttazione erotica. Tuttavia, il modo incluri Tomb Raider viene pubblicizzato mostrachiaramente quale sia il lettore/spettatore mo-dello e in che modo esso sia interpellato: nellacampagna di lancio di Tomb Raider 11, ad esem-pio, sotto 1l claim <<dove sono iragazzi>r, si mo-strano diversi luoghi pubblici tradizionalmentemaschili, come toilette per uomini, sale da bo-wling, night club, tutti interamente deserti. Unaversione iniziale del sito ufficiale diTomb Rai-der,inoltre, conteneva un link al leggendarioNude Raider, patch che consente di giocare conuna Lara nuda o di farle fare lo spogliarello. Nel2001 oltre un milione di siti di fan richiedevanoquesto patch o mostravano schermate dello stes-
so (Schleiner 2001 ,p.225).Alcuni commentatori non hanno dubbi che ilpubblico maschile aderirà senza problemi allalettura dominante e che miri a un puro coinvol-gimento feticistico: l' interattività del videoga-me incoraggia a possedere Lara, <<divenendo>>
lei attraverso l'identific azione avatariale, cosìche il software costituisce la naturale evoluzio-ne delle forme di rappresentazione del classicofilm hollywoodiano (Flanagan 1999 ,p.79).Dr-versamente dalle icone femminili dei film, che
126
possono essere solo contemplate, le star digita-li come Lara Croft possono essere addiritturaagite, e i loro corpi si offrono alla proiezione difantasie di conquista e possesso.
Quando l'appropriazione di Laradaparte di gio-catori maschi e eterosessuali segue questa dina-mica, la pralicadragr3 si svuota di ogni valenzasowersiva, producendo piuttosto l'effetto di<<r e-ide alizzare iperbol iche norrne etero s es s ual idi generer> (Butler 1996,p.115) e rafforzare laloro auto-immagine. Insomma, un antidoto altemuto declino del soggetto maschile propriodella modernità: divenire Lara per controllarla,conffollare l'Altro per controllare se stessi.
Ragazziche diventano Lara Croft
Tomb Raider, in quanto gioco che prevede unsolo utente, è molto diverso dai Mud: non con-sente al giocatore di misurarsi con i concretifeedback di altri, risposte sociali che nei giochidi ruolo on line contribuiscono in modo essen-
ziale alla perfornance dell' identità di genere.
TutLavia, altre interpretazioni sottolineano il po-tenziale dei videogame che offrono avatar fem-
t3 ll drag, come il cross-dressing, è il travestimento conabiti tipici del sesso opposto, che viene adottato anche nelmondo dello spettacolo.
127
minili in terza persona affermando che questi
funzionano come una lacaniana ed estemalizza-ta immagine allo specchio del soggetto (Schlei-
ner 2001 ,p .223): in effetti, tutti i videogame, inquanto sistemi che coinvolgono il corpo (occhi,
orecchie, mani), un monitor, un cd, un interfac-cia di gioco - il joystick - e una macchina che
legge il cd e manda informazioni al monitor, co-
stituiscono un sistema di visione e di azione e,
allo stesso tempo, un dispositivo che consente divedersi agire, come allo specchio, appunto.
Nel corso del gioco, l'utente può <<riconosce-
re>) come se stesso l' avatar che si muove sulloschermo, riconoscimento consentito dalla si-multaneità e dalla connessione dei suoi movi-menti con quelli di Lara.I rigidi confini del genere nella vita reale ven-gono così ammorbiditi e il giocatore maschiopuò sperimentare il fenomeno del gender-cros-
sing tipico dei Mud. Indossando l'avatar LaraCroft, il suo corpo si fonde con quello iperfem-minile e digitale di lei, originando nuove identi-tà queer,che potenzialmente sovvertono la sta-
bilità delle distinzioni tra identificazione e desi-
derio e quindi la rigida polarità tra soggettivitàfemminile e maschile.Il giocatore può naviga-re la voluttuosa femminilità di Lara attraverso
l'architettura cavernosa del gioco nello stesso
modo in cui una drag queen <<naviga>> la sua
forma ultrafemminile su una passerella, con
1"28
finti seni poligonali puntati indefessamenteverso l'alto, short mozzafiato e commenti: <<ah
ah!>> esclamaLaru ogni volta che lei/lui trovaqualcosa. In questo caso I'eccesso degli attribu-ti sessuali diLara assume una funzione diversada quella di mero richiamo erotico per il pubbli-co maschile eterosessuale, divenendo, comenel caso del drag, un modo per <<mettere in ri-salto ciò che dopo tutto è determinato solo in re-lazione all'iperbolico: la qualità sottointesa, da-ta per scontata, della performatività eteroses-suale>> (Butler 1996,p.179). Il drag svelalanorma; è una citazione, che rende possibile, an-che se non automatica,la sowersione.È evidente la disponibilità di Lara a essere tra-sformata da parte di giocatori maschi ed etero-sessuali in oggetto di desiderio: e le storie, i di-segni e le immagini di Lara pubblicate dai fansui siti internet ben lo dimostrano. Tuttavia, an-che se i ragazzi inizialmente sono attratti daqueste bad girls come da puri feticci, man ma-no che il gioco si sviluppa, chiaramente finisco-no per identificarsi. Spes so, anzi, i r agazzi sc el-gono di giocare nei panni di avatar femminili ocostruirsene di autonomi perché ciò restituisceuna più ampia gamma di emozioni. La popola-rità+diTomb Raider sarebbe quindi il segnale diuna maggiore flessibilità del genere e un inco-raggiamento a sperimentare identità alternativeanche nella vita reale.
L29
La possibilità di provare sensazioni più artico-late e complesse quando si vestono i panni del-l'Altro è stata osservata nel contesto di generimediali diversi. L identificaz ione c ro s s - g e nde rdei giocatori maschi di Tomb Raider vienespesso paragonata a quella degli spettatori deifilm horror anni Ottanta - gli «slash movie>) -analizzata da Carol Clover. Lara Croft sarebbecioè la controparte digitale dell'eroina di questifllm,lafinal girl,unica a sopravvivere ai mas-sacri di Texas Chiansaw Massacre 2, Hallo-ween, Venerdì l3 o Scream. In entrambi i casi,tuttavia, la scelta del protagonismo femminilenon appare funzionale tanto ad attirare leragaz-ze quanto a consentire airagazzi -tradizional-mente principali consumatori di entrambi i ge-neri - di fare l'esperienza della vulnerabilità e
del rischio, arricchendo quindi la fruizione diun brivido in più. L analisi è in parte supportatadalle previsioni della Core Design, che ha svi-luppato Tomb Raider: l'azienda si aspetta cheLara conquisti il giocatore maschio suscitandoin lui non solo una risposta sessuale, ma ancheil desiderio di <<essere con lei in un ambienteostile, proteggerla e assicurarsi che ce la fac-cia>>.la
ra Intervista a Jeremy Smith, direttore delegato della CoreDesign, tratta dalla sezione <<Contenuti speciali» del dvddel film Tomb Raider.
130
Secondo Cassell e Jenkins c'è però una diffe-rerza.Lefinal girls sono in genere figure an-
drogine, identificate da nomi unisex e dai trattifisici e/o caratteriali del tomboy - il <<maschiac-
cio>> - così ricorrente nel mainstream dell'avdiovisivo statunitense: una modalità di costru-zione dell'eroina, secondo Clover, che serve a
neutr alizzar e le re s i s ten ze a un' i dentifi c azionecross-gender da parte degli spettatori maschidei film horror (Clover 1992).Laraesibisce unaprorompente femminilità, ma anche i tratti del-la butch; il suo stesso ruolo di protagonista, chesi muove peraltro in spazi tradizionalmentemarcati come maschili, sono sufficienti a ren-derla perfettamente «indossabile>> anche dagiocatori dell'altro sessors. Ma come spiegareallora l'identificazione da parte delle ragazzecon un personaggio così costruito?
Dal Game Girl Movement alle Game Grlz
Se la perfezione digitale del corpo di Lara puòrappresentare un modello oppressivo per le don-
15 lJ analogia con il tomboy emerge con forza se guardiamoalle modalità di costruzione del personaggio di Lara comeprotagonista deLfilmTomb Raider (Giomi 2005): diversesul piano fisico, Ie due figure assumono un identico valo-re simbolico, perché entrambe protagoniste di una <<narra-
tiva edipica» (Tasker 1998, p. 69).
1.31
ne, il personaggio nel suo complesso introducenelf immaginario dei videogame elementi diforte rottura, situandosi nel solco della tradizio-ne delle tough girls già presenti in altre popolari
forme mediali. Lara, come Thelma e Louise, laprotagonista del fumetto Tank Girl o l'eroinadella serie tv Xena, per non citare che alcuniesempi, si muove in uno spazio altamente ma-
scolino - il deserto, gli scenari della fantascien-
za, dellabattaglia vagamente mitologica o tom-be, miniere e altre ambientazioni da Indiana Jo-
nes - e così facendo sottolinea la totale alteritàdel femminile rispetto ad esso, ma si pone anche
in polemica con lo stereotipo che confina la fem-minilità al dominio privato e domestico: questo
è in sé e per sé trasgressivo. Tbmb Raider offrecosì una risposta non solo ai giochi concepitiprevalentemente per tagazzi, ma anche a quelliprodotti dal Game Girl Movement e accusati diaccrescere la polarizzazione dei generi e la ghet-
tizzazione femminile. Lara non è la principessa
da salvare dei primi, ma nemmeno I'aspirantestilista di Barbie Fashion Design o la creatura
interessata esclusivamente a fantasticherie ro-mantiche dellaPurple Moon: è un modello alter-nativo, donna istruita, avventurosa, capace, si-
cura di sé e abile in compiti e situazioni che ri-chiedono le stesse abilità sviluppate attraverso ivideogame. Identificandosi con lei, le ragazzepossono vedersi rappresentate in ruoli attivi e
732
positivi, sperimentando fantasie di onnipotenzae i piaceri dell'esplorazione e dell'awentura as-
senti nel mondo reale (Kennedy 2002,p.6).La portata del fenomeno Croft si estende oltre inaturali confini diTomb Raider, insinuandosiin altri contesti e pratiche della subcultura delvideogioco : Lar a ha favorito I' emergere, al suo
interno, di una comunità specificamente fem-minile dedicata a <<de-essenzializzare le identi-tà di genere attraverso pratiche sowersive diappropriazione>>. Le sue esponenti agiscono co-me <<hacker culturali, che manipolano strutturetecno-semiotiche preesistenti volgendole ad al-tri fini>> (Polski 2001, par. 7): se il patch NudeRaider,di cui abbiamo parlato, costituisce unarisignificazione di Lara come oggetto di desi-derio, la mostra on line «Cracking the Maze:Game Patches as Hacker Ar1>>, ad esempio, pre-sentava una Lara con baffi e pizzelto ,realizzataattraverso un patch dal significativo nome di<<Gender-ben ding To mb Rai d e r>> .
Ir hacker elaborano patch che consentono di in-tervenire praticamente su ognuno degli eroi deivideogame più popolari. Spesso il classico ma-schio adulto viene eliminatotout court errmpiaz-zato con buffi animaletti dell'immaginario infan-tile o con figure femminili dalle fattezze più di-verse, ma nettamente contrastanti con gli idealiin vigore nel mondo reale e con i canoni esteticidei loro colleghi maschi e delle aziende di video-
133
game commerciali. Attraverso questi alter ego
virtuali, chiamati <<skin>>, donne e ragazze colo-nizzano l'universo monosex del cyberspazio e
danno vita a clan dediti a giochi di ruolo su inter-
net basati su videogame di combattimento.r6 I1
movimento delle Game Grlzcreaavatar in cui al-
la tradizionale iconografia femminile vengono
sostituite immagini belliche, mente le Crack
Whores, che giocano al popolare Quake,rove'sciano , appropriandosene, i topoi della pomogra-
fia per creare personaggi con attributi supersexy:
in linea con le Riot Girls a cui si richiamano, ri-vendicano il controllo sul proprio corpo e il dirit-to al piacere sessuale, polemizzando contro ilperbenismo della critica femminista anti-porno-grafta.t1 Così, attingendo ai repertori visivi piùdiversi, hacker e giocatrici divengono guerriere,
zombie, mutanti, arnazzoni, cyborg... creature
ibride, non umane, postumane, asessuate o trans-
gender, nate da un bricolage di caratteri etnici,
t6 Solo alcuni esempi: Die Valkarie, Clan Pms, Psycho-
Men Slayers e Coven. Queste ultime, che giocano a Gem-
stone III, per limitare le «infiltrazioni>> stabiliscono che lapartecipazione è limitata esclusivamente a giocatrici bio-logicamente femmine (compiendo così una certa scivola-ta verso una definizione essenzialista di identità di gene-
re !). Le Kelles, che giocano a EverQuest, sono invece piùrelativiste: possono partecipare anche i maschi, però de-
vono riuscire a convincere tutte le giocatrici di saper ben
interpretare il ruolo di una femmina (Polski 2001,par' 13).
r7 L'enfasi sul sesso come dimensione di espressione indi-
L34
biologici, tecnologici e antropomorfi che am-pliano la gamma delle immagini femminili al-
f interno dei giochi elettronici.
Conclusioni. Oltre l'eterosessualità
Gli studi sulla ricezione mediale hanno dimo-strato ormai da tempo la fallacità della nozione dideterminismo testuale e del suo assunto sul pote-
re del testo di costruire posizioni/percorsi di let-tura fissi e ineludibili. Lo scarto tra il lettore mo-dello e il lettore sociale indtrizza verso una con-
cezione del consumo dei media come pratica in-terdiscorsiva, tanto più nel caso dei videogame,che sono intrinsecamente (nelle loro strutture
tecnologiche, produttive e testuali) interattivi.Non diversamente da quello che ancora fannomolte analisi, f industria dei videogame e quel-la dei media popolari in genere, tendono a co-
viduale e sulla libertà sessuale come chiave dell'emanci-pazione femminile caratteizza ciò che negli Stati Unitiviene definito «Third Wave Feminism» (per altri «post-. :.femminismor). E importante notare come queste istanze,sebbene prive della stessa carica antagonista che assumo-no nella cultura hacker, siano filtrate anche all'interno digeneri mediali di largo consumo: serie televisive come §ex
and the City o The L Word ne sono un esempio (Giomi2005). Tra le virago delle Crack Whores e le mannequinetero o lesbo della fiction televisiva, naturalmente, c'è unabisso, ma tutte assieme ampliano la gamma delle imma-gini femminili offerte dai media.
13s
struire il lettore/spettatore/giocatore implicito -maschile o femminile che sia-come invariabil-mente eterosessuale. Delineano così processi diricezione e interazione incapaci di cogliere lafluidità delle forme di identificazione e deside-rio proprie di ogni esperienza di fantasia e diogni incontro con l'Altro.Gli effettivi lettori sociali spesso non sono ricon-ducibili alle categorie dicotomiche del genere e
della eterosessualità, e non lo sono di conseguen-zalerelazioni che essi instaurano con gli artefat-ti mediali; ma neppure la semplice etichetta digay, lesbica o bisessuale a volte basta arenderneconto. Il termine queer rivela in questo caso tuttail suo valore euristico, indicando ciò che mi sono
sempre rappresentata con l'immagine incorag-giante dell'obliquo. La dialettica tra questo ter-mine e i suoi contrari diviene potente nel caso
della nozione inglese di s/raight, che,significati-vamente, vuol dire <<dritto>>, ma anche <<conven-
zionale>>, <<giusto>> ed <<eterosessuale>>: una cate-
na in tutti i sensi, in cui si esprime al massimo laforza coercitiva dell'ordine simbolico. Queerpuò essere una proprietà dell'autore, del testo,del lettore o dello stesso processo di consumo:definisce posizioni, piaceri, letture non eteroses-
suali, proprie di persone che non condividono 1o
stesso orientamento sessuale articolato dal testo(il gay che prova un piacere queer in una sitcomlesbica, ad esempio) o che non si identificano co-
136
me lesbiche, gay o bisessuali (Doty 1993, p.XVm). Queerptò essere anche la posizione del-le giocatrici di Tbmb Raider. Le esperienze difantasia basate sulla violenza e sulla mostruositànon sono necessariamente un dominio esclusi-vamente maschile: come mostra l'esperienzadelle Game Grlz, anche le ragazze possono in-dulgere a questi piaceri «abietti». Le skin che co-struiscono, infatti, risultano grottesche, mo-struose, difficilmente accettabili nei domini rap-presentativi dei media di mainstream, se non co-me significanti di una perversione. Il mostruosoè stato spesso u:tllizzato nel cinema horror holly-woodiano per marcare il confine tra coloro cheassumono un appropriato ruolo di genere e colo-ro che non lo fanno, nettralizzando così la mi-naccia postada questi ultimi alla stabilità dell'or-dine eterosessuale: lo scarto dalla norma implicaun ingresso nel perverso, ecco cosa ci dice il mo-struoso (Creed 1986). Ma nei giochi di ruolo online, grazie all'interattività e alla maggiore liber-tà espressiva del medium, figure mostruose e de-dite a occupazioni come combattere, squaftarenemici e distruggere oggetti ampliano la gammadelle possibili incarnazioni della femminilità.l8Emerge così l'opportunità di sperimentare im-magini non stereotipate del proprio corpo e iden-tità radicalmente altre: <(come giocatrice - scrive
r8 Sull'argomento cfr. anche Haraway (1992).
1.37
Laura Fantone - mi piace l'azione e mi rendo
conto che posso dare sfogo a desideri che nonposso esprimere nella mia vitareale [. . .]. Mi pia-ce muoveffni nei panni di un mostro, avere I'op-portunità di distruggere palazzi, spaventare tutticon le mie potenti urla e il mio aspetto terrifican-te» (Fantone 2003,p.61).Anche nel mondo im-maginario di Tomb Raider l'abietto può rove-sciarsi di segno, trasformandosi da repulsione ineccitazione e aprendo per il giocatore femminiletnavia queer al piacere. Così, da Lara come au-
toma femminile, aLaracome drag queen,aLaracome modello empowering per le ragazze finoa77a qu e e r b ambola con pistola, s i rendono di spo-
nibili nuove pratiche di appropriazione e sower-sione, che scardinano le categorie del genere
adattandole alle diverse sensibilità e identità diuomini, donne eAltri. Giocare con il genere, in-soflìma. O meglio, <<videogiocare>> con il genere.
Riferimenti biblio grafici
Boccia M. L. (2001), Nominare il genere, in <<Iten>,
n.12,pp.4-9.Butler J. (1989), Gender Trouble. Feminism and the
Subversion of lderzdry, Routledge, Londra-New York.Butler J. (1996), Corpi che contano. I limiti discor-s ivi de I << s e s s o »,F e7trinelli, Milano.
I
138 139
CarzoD., Centorrino M. (2002), Tomb Raider o i/destino delle passioni. Per una sociologia delvideo-gio co, Guerini, Milano.Cassell J., Jenkins H. (a cura di,1999),From Barbieto Mortal Kombat: Gender and Computer Game,
Massachusetts Institute of Technology Press, Cam-bridge,MA.Clover C. (1992), Men, Women and Chain Saws:
Gender in the Modern Honor Film,Princeton Uni-versity Press, Trenton.Conti F. (2002), L'informatica e i giochi elettronici,in Morcellini M. (a cura dl) , Il Mediaevo . Tv e indu-stria culturale nell'ltalia del XX secolo, Carocci,Roma,pp. 419-481.Creed B. (1986), Horror and the Monstrous-Femini-ne: An Imaginary Abjection, in Thonrham S. (a curadi, 1999), F e mini s t F i lm The ory. A Re ader, New YorkUniversity Press, New York.Doty A. (1993), Making Things Perfectly Queer. In-terpreting Mass Culture, University of MinneapolisPress, Minneapolis.Fantone L. (2003), Final Fantasies. Virtual Wome-
n's B o die s, in «Feminist Theory», v ol. 4, pp. 5l -1 2.
Flanagan M. (1999),Mobile ldentities, Digital Starsand Post-cinematric Selves, in <<Wide Angle», 21,pp.76-93.Flanagan M. (2002), Hy p e r b o di e s, Hyp e r know I e d -
ge: Women in Games, Women in Cyberpunk, andStrategies of Resistence, in Flanagan M., Booth A.(a cura dr), Reload: Rethinking Women and Cyber-culture ,MitPress , Cambridge.Friedman T. (1995), Making Sense of Sofnnare:
Computer Games and Interactive Textuality, in Jo-nes S. (a cura di), CyberSociety: Computer-media-ted Communication and Society, Sage, ThousandOaks-Londra-Nuova Deli.Giomi E. (2005) , Lara Croft: Ein neues Vorbild fìirActionheldinnen und Frauen?, in <<tv diskurs», 34,pp.44-49.Giomi E. (2005), Sex and the City, in Monteleone F.
(a cura di), Cult Series . Le grandi narrazioni medialine ll' Amer ica di fine s e c o lo, Audino, Roma, pp. 5 -27 .
Haraway D. (1992),The Promises of Monsters: ARegenerative Politics for Inappropriated Others, inWolmark J. (a cura di, 1999), Cybersexualities. AReader in Feminist Theory, Cyborg and Cyberspa-ce, Edinburgh University Press , Edimburgo.Inness S. (1999), Tough Girls: WomenWarriors andWonder Women in Popular Culture, University ofPennsylvania Press, Philadelphia.Kennedy H.W. (2002), Lar a C r oft : F e min i s t I c o n o rCyberbimbo? On the Limits of Textual Analysis, in«Game Studies», vol. 2, 2. Disponibile on linewww.gamestu dies.orgl}2}Zlkennedy/ ( I
o dicembre200s).Maldonado T. (2005), Reale e virtuale, Feltrinelli,Milano.Mikula M. (2003), Gender and Videogames: the Po-liticalValency of Lara Croft,in «Journal of Media &Cultural Studies», vol. 17, I, pp. 79-88.Mulvey L. (1978), Piacere visivo e cinema narrati-vo, in «Nuova dwf. Quaderni di studi internazionalisulla donna», n. 8, luglio-settembre.Polsky A.D. (2001), Skins, Patches, and Plug-ins:
L40
Becoming Woman in the New Gaming Culture, in«Genders», autunno 2001. Disponibile on linehttp : / /www.lib .ute xas,edu/ indexe s / s -w omens st u-dies.html (1" dicembre 2005).Poole S. (2000), Trigger Happy: Videogames andEntertainment Revolution, Arcade, New York.Rehak B. (2003), Mapping the Bit Girl. Lara Croftand New Media Fandom, in «Information, Commu-nication and Sociefy», vol. 6, 4, pp. 477 -496.SchleinerA.M . (2001), Does Lara Croft Wear FakePolygons? Gender and Gender-Role Subversion inComputer Adventure Games, in «Leonardo», vol.34,3 ,pp.22l-226,Scott J.W. (1996), I I << I enere » : un' ut ile c ate gor ia dianalisi siorica, in Di Cori P. (a cura di), Altre storie.l,a critica femminista alla storia, Clueb, Bologna,pp.307-347.Seveso G. (2000), Fumette: Valentina, Eva Kant,Inra Croft e le altre,Unicopli, Milano.Silverstone R. (2002), Perché studiare i media,llMulino, Bologna.StoneAllucquère R. (1995), Desiderio e tecnologia.Il problema dell' identità nell' era di internet,Unico-pli,Milano.Taylor C. (1999), The Man behind Lara Croft:Adrian Smith's well-endowed Computer Heroine isBack-better, Brainier and Bustier than Ever,in r<Ti-
me>>, vol. 154,23,p. 7 8.Tasker Y. (2002), Spectacular Bodies : Gender, Gen-re, and the Action Cinema,Sage, Londra.TaskerY. (1998),Working Girls: Gender and Sexua-lity in Popular Cinema,Routledge, Londra.
141
Thompson B.J. (1998), Mezzi di comunicazione e
modernitò. Una teoria sociale dei media,il Mulino,Bologna.Turkle S. ( 199 6),Lavita sullo schermo. Nuove iden-tità e relazioni sociali nell'epoca di internet, Apo-geo, Milano.Valleur M., Matysiak J .C. (2004), S e s s o, p a s s io ne e
videogiochi. Le nuove forme di dipendenza,BollatiBoringhieri, Torino.Van Dijk T. (2002), Sociologia dei nuovi media, ilMulino,Bologna.Ward S. (2000),Being ktra Croft, or,We Are All Sci
Fl, disponibile on line www.popmatters.com./featu-
res/000 1 l4-ward-trtml ( l" dicembre 2005).Wolmark J. (a cura di, 1999), Cybersexualities. AReader in Feminist Theory, Cyborg and Cyberspace ,
Edinburgh University Press, Edimburgo.
L42