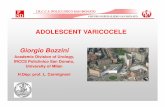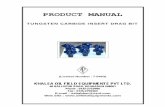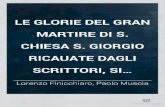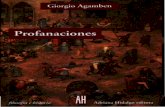Galileo nelle lettere di Giorgio Raguseo
Transcript of Galileo nelle lettere di Giorgio Raguseo
Michele caMerota
GALILEO NELLE LETTERE DI GIORGIO RAGUSEO
ESTRATTOda
GalilÆaNa
STUDIES IN RENAISSANCE AND EARLY MODERN SCIENCE
Anno XI - 2014
Leo S. Olschki Editore Firenze
GALILÆANAJournal of Galilean Studies
Galilæana approfondisce lo studio di tutti gli aspetti connessi alla figu-ra, all’opera, alle acquisizioni scientifiche e alla fortuna di Galileo Galilei.Promossa dal Museo Galileo, e pubblicata sotto gli auspici delle Universitadi Firenze, Padova, Pisa e Domus Galilæana, e ha una periodicita annuale.
Galilæana ha una significativa appendice – Galilæana on-line – sul sitoweb del Museo Galileo (www.museogalileo.it/galilaeana.html). Oltre agliindici cumulativi della rivista, Galilæana on-line pubblica la documentazio-ne integrativa (testi manoscritti e a stampa, testi digitali e materiale icono-grafico) citata negli articoli a stampa e indicata con il simbolo
Galilæana searches into all of the aspects concerning the figure, work,scientific findings and fortunes of Galileo Galilei. Promoted by the MuseoGalileo, Galilæana, is published annually under the auspices of the Univer-sities of Florence, Padua, Pisa and Domus Galilæana.
The significant Galilæana appendix – Galilæana on-line – can beconsulted at the Museo Galileo web site (www.museogalileo.it/galilaeana.html). In addition to the journal’s cumulative indexes, Galilæana on-linealso publishes supplemental documents (manuscript and printed texts,digitalised copy and iconographic material) cited in its published articlesand indicated with the symbol
GALILÆANAStudies in Renaissance
and Early Modern Science
As indicated by its new subtitle – Studies in Renaissance and Early Modern Science – the objective of Galilaeana is to publish studies on the life and work of Galileo, as well as research not directly pertaining to Gali-leo, but which nevertheless focuses on related figures and themes from the early modern period. Galilaeana is sponsored by the Museo Galileo and is published annually under the auspices of the University of Florence, the University of Padua, the University of Pisa, and the Domus Galilaeana.
An index of all past issues of Galilaeana, including the tables of con-tents of the articles published, lists of the accompanying source material and documentation (manuscripts and printed works, iconographic material), and links to digitalized copies of the material in this archive, may be accessed at the website of the Museo Galileo www.museogalileo.it/galilaeana.html
GALILÆANAJournal of Galilean Studies
Galilæana approfondisce lo studio di tutti gli aspetti connessi alla figu-ra, all’opera, alle acquisizioni scientifiche e alla fortuna di Galileo Galilei.Promossa dal Museo Galileo, e pubblicata sotto gli auspici delle Universitadi Firenze, Padova, Pisa e Domus Galilæana, e ha una periodicita annuale.
Galilæana ha una significativa appendice – Galilæana on-line – sul sitoweb del Museo Galileo (www.museogalileo.it/galilaeana.html). Oltre agliindici cumulativi della rivista, Galilæana on-line pubblica la documentazio-ne integrativa (testi manoscritti e a stampa, testi digitali e materiale icono-grafico) citata negli articoli a stampa e indicata con il simbolo
Galilæana searches into all of the aspects concerning the figure, work,scientific findings and fortunes of Galileo Galilei. Promoted by the MuseoGalileo, Galilæana, is published annually under the auspices of the Univer-sities of Florence, Padua, Pisa and Domus Galilæana.
The significant Galilæana appendix – Galilæana on-line – can beconsulted at the Museo Galileo web site (www.museogalileo.it/galilaeana.html). In addition to the journal’s cumulative indexes, Galilæana on-linealso publishes supplemental documents (manuscript and printed texts,digitalised copy and iconographic material) cited in its published articlesand indicated with the symbol
INDEX
Editorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. V
FIVE QUESTIONS ON THE SCIENTIFIC REVOLUTION
Pietro Corsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3
Paula Findlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 11
isabelle Pantin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 17
eileen reeves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 23
robert s . Westman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 29
STUDIES
Paolo Galluzzi, “Spotted felines and the spotted sun”. The Lincei and Galileo’s Istoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 37
FranCo GiudiCe, Galileo’s cosmological view from the Sidereus Nuncius to Letters on Sunspots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 49
serGio landuCCi, L’obiezione di Hobbes e la risposta di Cartesiosulla mente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 65
Pietro daniel omodeo, Polemiche astronomico-astrologiche nella Torino di Giovanni Battista Benedetti (1581-1590) . . . . . . . . » 73
martin Frank, Dating Federico Commandino’s Teaching Activity in Urbino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 105
TEXTS & DOCUMENTS
miChele Camerota, Galileo nelle lettere di Giorgio Raguseo . . . » 121
miChele Camerota, Due inedite questioni meccaniche di Giovannidi Guevara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 135
8 INDEX
NOTES & GLEANINGS
adele PoCCi, Aggiunte e correzioni all’indice alfabetico dei nomi delle Opere di Galileo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 157
OBITUARY
maurizio torrini, Il Galileo di Antonio Beltrán Marí . . . . . . . . » 167
ESSAY REVIEWS
Ferdinando abbri, L’opera in musica incontra la storia della scien-za: Galileo Galilei, Kepler e Philip Glass . . . . . . . . . . . . . . . . » 177
andrea Gualandi, Nuove stelle, scienza e società alla vigilia del-la Guerra dei Trent’anni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 191
Chiara Protasi, Gli anni dell’incertezza e delle contraddizioni: dal Concilio Vaticano II alla Commissione di studio galileiana » 199
Galilæana, XI, 2014, pp. 121-133
TESTI & DOCUMENTI / TEXTS & DOCUMENTS
Michele caMerota
GALILEO NELLE LETTERE DI GIORGIO RAGUSEO
Il 6 maggio 1622, Lorenzo Pignoria informava Galileo della recente scomparsa del filosofo Giorgio Raguseo, soggiungendo che la sua cattedra allo Studio di Padova era stata assegnata a Fortunio Liceti.1
Benché questa rappresenti l’unica occorrenza del nome di Raguseo nell’epistolario di Galileo, tuttavia essa documenta inequivocabilmente che i due si conoscevano e, pur nelle differenze di impostazione e di sensi-bilità culturale, avevano avuto occasione di frequentarsi e di interloquire. Certo, Giorgio Raguseo era uno dei tanti, zelanti e (quasi sempre) litigio-sissimi esegeti del verbo aristotelico che affollavano le università italiane del tempo, e ben poco aveva a che spartire con l’impeto innovatore gali-leiano. Nondimeno, come vedremo, egli coltivava interessi astronomici, e fu questo, oltre alla generale tendenza di Galileo a mantenere buoni rapporti con i professori dell’Ateneo patavino, che dovette favorire le re-lazioni tra i due.
Chiamato alla seconda cattedra di Filosofia nel 1601, in sostituzione di Cesare Cremonini, promosso in primo loco, il dalmata Raguseo, originario di Dubrovnik (Ragusa), insegnò a Padova fino alla morte.2
Come spesso avveniva nelle università della prima età moderna – strut-ture nelle quali la competizione tra docenti della stessa disciplina rappresen-
Università di Cagliari, Dipartimento di Pedagogia, Psicologia e Filosofia: [email protected]
1 Cfr. OG, XIII, p. 87.2 Sulla vita di Raguseo, cfr. arnolfo Bacotich, Giorgio Raguseo da Ragusa. 1580?-1622.
Filosofo, teologo, medico, oratore, «Archivio storico per la Dalmazia», XX, 1935, pp. 397-408; cesare Preti, Giorgio da Ragusa (Raguseo), in Dizionario Biografico degli italiani, LV, 2001; Marko JosiPovic, Il pensiero filosofico di Giorgio Raguseo (+ 1622) nell’ambito del tardo aristote-lismo padovano, Milano, Massimo, 1985, pp. 31-54; da integrare con le indicazioni di Giovanni Pellizzari, Cesare Cremonini e Giorgio Raguseo, «Atti e memorie dell’Accademia patavina di scienze, lettere ed arti», CX, 1997-98, pp. 17-32: 22-25.
122 MICHELE CAMEROTA
tava una costante, favorita com’era dagli stessi ordinamenti accademici –3 la carriera di Raguseo fu segnata dalla rivalità con il più celebre Cremonini. I motivi del contendere vertevano soprattutto sul tema delle forme degli elementi, che Cremonini aveva specificamente trattato con uno studio del 1605,4 a cui il meno insigne competitor pensò bene di replicare con uno scritto, le Peripateticae disputationes, uscito a stampa nel 1613.5
Nel suo libro, Raguseo polemizzava con un «Novus Autor» (Cremoni-ni, appunto), la cui ostinata, stolida difesa delle posizioni dei commentatori greci e la parallela, continua irrisione nei confronti dei «Latini philosophi», rappresentavano un iniquo oltraggio («iniusta contumelia») nei confronti di tanti «celeberrimos viros de Philosophia Peripatetica optime meritos».6 Il filosofo dalmata contestava quindi decisamente la tesi alessandrista – ri-affermata da Cremonini – secondo cui la forma degli elementi si identifi-cava con le “qualità prime” (caldo, freddo, secco, umido). Di contro, egli sosteneva che le primae qualitates costituivano dei meri accidenti ed erano perciò prive di ogni carattere sostanziale. Pertanto, le formae elementorum andavano più propriamente intese come principi intellegibili, inaccessibili ai sensi, che si univano alla materia in ottemperanza ai peculiari canoni dell’ileomorfismo peripatetico.7
Forte di un superiore prestigio, Cremonini non ribatté esplicitamen-te alle critiche. Si limitò a sbeffeggiare l’antagonista in una commedia di
3 Gli Statuti dello Studio di Padova, ad esempio, sancivano che i professori si impegnassero in pubblici confronti (disputationes) almeno due volte l’anno, prima e dopo le vacanze di Pasqua. Analoghe prescrizioni erano contenute negli ordinamenti di pressoché tutte le università italiane del Cinque-Seicento. L’affiancamento di concorrenti su diverse cattedre della medesima disci-plina, insieme all’obbligo delle disputationes e ad un sistema di reclutamento e trattamento sti-pendiale incentrato sulla reputazione del docente (conseguenza anche della perizia nelle dispute pubbliche) contribuiva assai spesso ad innescare un clima di acceso antagonismo tra i professori.
4 Cfr. cesare creMonini, De formis quatuor corporum simplicium quae vocantur elementa disputatio, Venetiis, apud Io. Baptistam Ciottum, 1605.
5 GiorGio raGuseo, Peripateticae disputationes, in quibus difficiliores Naturalis Philosophiae Quaestiones examinantur. Praecipua obscurioraque Aristotelis loca illustrantur [...], Venetiis, Apud Petrum Dusinellum, 1613.
6 «Ego vero libentissime ab hac disputatione abstinuissem, atque ab hoc labore superse-dissem, nisi Novus quidam Autor Graecorum doctrinae, atque potissimum Alexandri [d’Afro-disia], professor, me quodammodo ad disputandum impullisset. In libello, enim, quem is nuper edidit de formis elementorum, Graecorum sententiam non novam ille quidem, sed iam tritam et pervulgatam, satis commode explicat. Verum quoniam in Latinos philosophos adeo acerbe et contumeliose invehitur, ut eos plane negligere et, si Deo placet, etiam irridere videatur, ideo ut celeberrimos viros de Philosophia Peripatetica optime meritos ab iniusta hac contumelia vindi-carem, ego quoque eandem disputationem aggressus sum; cum praesertim ipsemet, in sui libelli peroratione, locum aliquem etiam superventuris hospitibus se reliquisse affirmaverit». Ivi, p. 250.
7 Cfr. part. ivi, pp. 257-268. Sulla questione cfr. JosiPovic, Il pensiero filosofico di Giorgio Raguseo, cit. nota 2, pp. 136-148; anche MariJa Brida, La polemica tra Cesare Cremonini e Giorgio Raguseio sulle forme degli elementi (Scuola Padovana), «Abruzzo», XXI, 1983, pp. 79-90.
123GALILEO NELLE LETTERE DI GIORGIO RAGUSEO
chiara ispirazione aristofanea, Le Nubi, rappresentandolo alle prese con i motteggi e le vivaci contestazioni di un gruppo di sfrontati studenti.8
Lo sprezzante atteggiamento del più celebre collega dovette esacerbare non poco l’animo di Raguseo. Della sua irritazione troviamo una probabile eco in un brano dello stesso Galileo, che, nel Saggiatore, ricorda:
un lettor di filosofia a mio tempo nello Studio di Padova, il quale essendo, come talvolta accade, in collera con un suo concorrente, disse che quando quello non avesse mutato modi, avria sotto mano mandato a spiar l’opinioni tenute da lui nelle sue lezzioni, e che in sua vendetta avrebbe sempre sostenute le contrarie.9
È impossibile stabilire con certezza se il personaggio in questione vada identificato proprio con Raguseo, come pure riteneva Antonio Favaro.10 In ogni caso, l’ostilità tra i due aristotelici fu davvero sentita, anche perché era alimentata da un contrastante temperamento religioso: al “miscredente” Cremonini, sostenitore della mortalità dell’anima e più volte oggetto di at-tenzione da parte degli organismi inquisitoriali, si contrapponeva il devoto Raguseo, che aveva preso i voti, dedicava le sue Diputationes Peripateticae alla Vergine Maria e riteneva la verità filosofica coincidente con quella cristiana.11
A dispetto del professato fideismo, Raguseo sembra tuttavia attribuire una piena autonomia alla ricerca, rifiutando le interferenze teologiche nell’in-dagine del mondo fisico. Così, in una delle Epistolae morales, dialecticae et mathematicae contenute nel manoscritto Add. 10810 della British Library di Londra,12 egli disconosce il valore in naturalibus dei pareri teologici, e invita
8 Cfr. uGo Montanari, L’opera letteraria di Cesare Cremonini, in Cesare Cremonini (1550-1631): il suo pensiero e il suo tempo, Cento, Centro studi “G. Baruffaldi”, 1990, pp. 125-247 (il testo della commedia alle pp. 151-224). Cfr. anche Pellizzari, Cesare Cremonini e Giorgio Raguseo, cit. nota 2, part. pp. 17-21, 31-32.
9 OG, VI, p. 228.10 Cfr. antonio favaro, Galileo Galilei e lo Studio di Padova, Padova, Antenore, 1966, II,
p. 23, nota 3.11 «Si [...] verum vero non adversatur, et quae fides nostra Catholica nos docet vera sunt, ut
nulla ratione dubitandum est, sequitur ut nec vera philophia catholicae fidei, nec catholica fides verae philosophiae principiis adversetur». raGuseo, Peripateticae disputationes, cit. nota 5, p. 465.
12 Il codice consta di 159 lettere, distribuite in tre libri di lettere morali, sette libri di episto-lae dialecticae, e cinque libri di epistolae mathematicae. Per un indice dei contenuti, cfr. JosiPovic, Il pensiero filosofico di Giorgio Raguseo, cit. nota 2, pp. 42-48. D’ora in avanti citeremo il ms Add. 10180 della British Library con la sigla: Epistolae.
Va ricordato che i libri quarto e quinto della parte matematica delle Epistolae uscirono a stampa a Parigi, nel 1623; cfr. G. raGuseo, Epistolarum mathematicarum seu de divinatione libri duo, Parisiis, Sumpt. N. Buon, 1623. Il volume, che tratta di materie attinenti alle scienze occulte e sviluppa un atteggiamento critico nei confronti delle pratiche divinatorie e dell’astrologia giu-diziaria, è dedicato al cardinale Scipione Cobelluzzi, e fu curato dal giurista Charles-Annnibal Fabrot. Questi ricevette l’incarico di occuparsi del libro da Peiresc, a sua volta interpellato in merito da Paolo Gualdo. Cfr. Lettere d’uomini illustri che fiorirono nel principio del secolo XVII,
124 MICHELE CAMEROTA
a metter da parte «miracula et Theologorum auctoritates» e a considerare le questioni naturaliter.13 Né, a suo avviso, l’indipendenza della ricerca si deve affermare solo in relazione alle pretese del sapere religioso, ma anche nel dominio filosofico, non sottostando all’egemonia intellettuale di eventuali auctoritates, acriticamente assunte. In tal senso, nella premessa al lettore del-le Disputationes Peripatheticae, dichiarava di esporre il pensiero aristotelico senza infingimenti e, soprattutto, senza sentirsi (orazianamente): «obbligato a giurare fedeltà alle parole di un maestro» («Nullius addictus iurare in ver-ba magistri»).14 E, in una delle Epistolae manoscritte, asseriva analogamente di dover, come filosofo, aderire «alla dottrina più probabile, e che è sostenu-ta dalle ragioni più valide e più in sintonia con la verità, senza pensare a chi, Aristotele, gli astronomi o qualche altro autore, la proponga».15
Nonostante queste illuminate prese di posizione, il pensiero di Ragu-seo rimane del tutto all’interno del campo peripatetico, sia per ciò che ri-guarda gli argomenti esaminati, sia relativamente alle soluzioni avanzate.16 Le pagine delle sue opere riportano minuziosamente le opinioni dei vari commentatori, greci e latini, precisano il senso del testo aristotelico, danno conto delle diverse tesi a confronto, e tutto secondo il consueto schema di sviluppo delle quaestiones: presentazione del problema; esposizione delle varie sententiae e delle relative obiectiones; solutio magistralis.
Venezia, Baglioni, 1744, pp. 317-326. Su alcuni aspetti dei De divinatione libri duo, cfr. la re-cente analisi di anthony ossa-richardson, The Devil’s Tabernacle. The Pagan Oracles in Early Modern Thought, Princeton University Press, Princeton, 2013, pp. 118-21.
13 «[...] theologorum auctoritates in rebus ad fidem pertinentibus maximi quidem ponde-ris esse; at in naturalibus nihilo plus aestimandas quam cuiuslibet philosophi; cum praesertim multa illis de eisdem disserentibus interdum exciderint quae si ad doctiorum hominum trutinam expendatur, vix (ut Cicero ait) in aurificum statera consistent. Relinquamus nunc igitur miracula et Theologorum auctoritates, remque, si placet, naturaliter perscrutemur». Epistolae, c. 412v. Il riferimento a Cicerone attiene al passo del De oratore in cui si afferma che i retori debbono provare gli argomenti non con il bilancino dell’orefice, ma con una bilancia d’uso comune («non aurificis statera, sed populari quadam trutina»). Cfr. De oratore, II, 38, 159.
14 «Aristotelis sententias puras, synceras, nec ullo modo fucatas reperies; quibus tamen in rebus arduis adiecta semper erit veritas Catholicae Fideis, ut simul quid vere scias et quid veri Aristoteles docuerit, Doctores varios, Graecos, Arabes, Latinos, tam veteres quam recen-tiores, disputantes audies; quorum sententiae modo approbantur, modo improbantur, necnon etiam novae interdum adiiciuntur; hincque ingenii aciem non parum exacues, et liberam philo-sophandi rationem addisces, iuxta illum Horatianum: Nullius addictus iurare in verba Magistri». raGuseo, Peripateticae disputationes, cit. nota 5, Praefatio.
15 «[...] si Philosophus sum, sententiam illam me amplecti debere quae probabilior est, quae validioribus rationibus fulcitur, quaeque magis cum veritate consentit, cuiscumque tandem, sive Aristotelis, sive Astronomorum, sive alterius autoris, ipsa fuerit». Epistolae, c. 426r.
16 Nelle Peripateticae Disputationes, Raguseo sintetizza così il suo giudizio su Aristotele: «Si quis est inter philosophiae cultores qui Aristotelem suspiciat, me certe, fateor, maximum illius ingenii aestimatorem esse; veruntamen tantum illi laudis, et nihil plus, tribuendum esse censeo, quantum ipse vere promeritus est». raGuseo, Peripateticae disputationes, cit. nota 5, p. 463.
125GALILEO NELLE LETTERE DI GIORGIO RAGUSEO
Più interessanti appaiono gli spunti di carattere astronomico, che di-mostrano una certa sensibilità al nuovo, ai temi in discussione nel dibatti-to scientifico dell’epoca, e che rivelano curiosità e passione per lo studio dei fenomeni celesti. Ricordiamo che Raguseo aveva studiato l’astrolo-gia con Francesco Barozzi e che la sua prima opera a stampa era stato un Discorso volto a formulare delle previsioni meteorologiche per l’anno 1590.17 Ancora, tra i manoscritti della Biblioteca Ambrosiana di Mila-no si conserva, incompleta, una sua Expositio super Sphaeram Ioannis de Sacrobosco, contenente diciotto lezioni su temi cosmografici.18 Numerosi sono poi gli spunti astronomici sparsi nelle altre sue opere; l’intero Liber secundus delle Epistolae mathematicae, ad esempio, è dedicato a trattare problemi quali «Il numero, l’ordine e il movimento delle sfere celesti», «Il moto di trepidazione dell’ottava sfera», «Il numero delle stelle fisse», «Le eclissi lunari e solari», «Perché la Terra stia immobile al centro del mondo».19
A proposito di quest’ultima quaestio, Raguseo si oppone con decisione alla nuova teoria di Copernico, che, peraltro, ritiene sia stata avanzata in ter-mini puramente ipotetici («ad servanda quaedam phoenomena, vel, ut aiunt, apparentias»). In particolare, assume un certo interesse la sua discussione di un argomento pro-copernicano diretto a rintuzzare il rilievo che in una Terra in movimento i gravi non cadrebbero ai piedi di colui che li lancia per aria.20 A ciò i sostenitori del moto terrestre risponderebbero osservando che, sebbene la Terra si muova assai velocemente, nondimeno la pietra lanciata in alto scende direttamente ai piedi del proiciente in quanto l’aria ambiente è trascinata dal rivolgimento della Terra. Il caso sarebbe analogo a quello di chi, posto in un carro o in una barca in movimento, sputasse per aria: anche in questa circostanza la «eiecta saliva» ricadrebbe ai suoi piedi. E lo stesso avviene quando si lascia cadere un sasso (lapillum) da un albero di una nave spinta dal vento: il grave non cade fuori bordo, ma alla base dell’albero.21 A
17 Cfr. GiorGio raGuseo, Astronomico et filosofico discorso [...] sopra l’anno MDXC calcula-to al Meridiano dell’inclita città di Venetia, Venetia, Appresso G. Perchacino, 1590.
18 Biblioteca Ambrosiana, Milano, Ms N. 207 Sup.; il trattatello consta di 24 fogli.19 Cfr. Epistolae, cc. 399r-428r.20 Già Aristotele aveva argomentato l’impossibilità del moto terrestre sulla base dal fatto
che i gravi scagliati verso l’alto ricadono ai piedi del lanciatore; cfr. De caelo, 396b 21-25.21 «[...] quamvis Terra velocissime moveatur nihilominus lapidem sursum proiectum ad
pedes proiicientis directe descendere, quia ad motum Terrae eadem quoque velocitate ducitur aer, qui tanquam medium descendentem suapte natura lapidem ad pedes proiicientis necessario defert. Exemplum afferre solent de iis qui in curru vel cymba spuunt. Dum enim currus vel cym-ba velociter feruntur, deberet eiecta saliva, deorsum decidens, ad spuentis corpus adhaerere, et nihilominus descendet ad pedes. Experentia similiter se asserunt comperisse dum navis magno ventorum impetu pellitur; si quis in mali summitate existens, lapillum deiiciat, non eum quidem
126 MICHELE CAMEROTA
tali argomentazioni filo-copernicane il nostro filosofo obietta a questo modo: un conto è l’aria presente all’interno del carro e della barca, per cui non è assurdo ritenere che il contenuto (contentum corpus) si muova al moto del continens; un altro immaginare che la conversione terrestre inneschi il mo-vimento del mezzo aereo, il quale, come «rarus et naturae dissipabilis», è interamente cedevole, e contiene la Terra più che esserne contenuto.22
Difficile dire a chi precisamente Raguseo pensasse quando esponeva la tesi appena illustrata. Non è improbabile però che si trattasse proprio di Galileo, il quale affermava appunto che «una palla tirata in su a perpendico-lo [...] ritorna nell’istesso luogo, muovasi la nave o stia ferma»,23 e ne forni-va una spettacolare prova all’amico Francesco Stelluti, allorché, trovandosi in barca sul lago di Piediluco, lanciò in aria una chiave e, come racconta Stelluti, «se bene la barca era trascorsa per otto o dieci braccia avanti, con tutto ciò cadde la chiave fra lui e me, perché oltre l’andare in alto haveva dal moto della barca acquistato l’altro, d’andare col movimento di essa e seguitarla come fece».24 Se si tiene presente la circostanza che lo scienziato pisano doveva aver elaborato (e divulgato) il principio della composizione dei moti fin dal tempo del soggiorno veneto, l’ipotesi che Raguseo abbia ri-preso un argomento galileiano non è affatto da scartare. Ricordiamo, infatti, che il gesuita Andrea Eudamon-Ioannes narrava di aver sentito lo scienziato pisano avanzare già «in Padova» l’argomento secondo cui «un corpo lascia-to cadere perpendicolarmente dalla gaggia di nave cadeva rasente e a piè dell’albero, tanto se si movesse come se stesse ferma la nave».25
extra navim sed ad mali pedes consistere. Istorum autem et similium effectuum causa in aeris motum putant esse referendam». Epistolae, c. 410v.
22 «Sed illud animadverto: aerem intra currum et cymbam contineri, nec absurdum existi-mo contentum corpus ad continentis motum adduci. Dum etiam navis ventorum impetu fertur, malus aerem velociter pellit, in cuius locum continuato motu sufficitur, et eadem velocitate, ne detur inane spatium, pars aeris proxima illi succedit; hinc fit ut demissus lapillus ad pedem mali subsistat. Iam vero cum Terram in orbem et cum ea simul aerem moveri dubitant, aut putant aeris motum Terrae conversionis consequi, aut utriusque agitationem a primi mobilis revolutione pendere. Primum dari non potest: aer enim, cum sit rarus et naturae dissipabilis, facile cedit; nec a Terra, veluti a cymba vel curru continetur, quin potius ipsam continet. Si alterum admittamus, in gravius absurdum incidimus: fateri enim cogimur, non solum primam aeris regionem, sed totum aeris elementum, continuo hoc velocissimoque motu attritum, ingenti ardore torrere, cum tamen secus res habeat. Ad omnia igitur isthaec incommoda evitanda, melius est ut cum com-muni schola dicamus Terram immobilem in centro mundi quiescere». Epistolae, cc. 410v-411r.
23 Cfr. OG, VII, p. 200.24 Cfr. lino conti, Francesco Stelluti, il copernicanesimo dei Lincei e la teoria galileiana
delle maree, in carlo vinti (a cura di), Galileo e Copernico. Alle origini del pensiero scientifico moderno, Assisi, Porziuncola, 1990, p. 231. Conti identifica il destinatario della lettera in Fabio Colonna; in realtà, come si evince chiaramente da un passaggio del testo che menziona la discus-sione meccanica del problema della “ruota”, la missiva era diretta a Giovanni di Guevara.
25 Cfr. la lettera di Mario Guiducci a Galileo del 13 settembre 1624 (OG, XIII, p. 205).
127GALILEO NELLE LETTERE DI GIORGIO RAGUSEO
Il nome di Galileo appare comunque esplicitamente in altre delle let-tere di Raguseo rimaste manoscritte alla British Library e che, nelle inten-zioni del loro autore, avrebbero dovuto esser pubblicate a stampa, proprio come quelle poi confluite nell’opera Epistolarum mathematicarum seu de divinatione libri duo. Così, in una missiva del 13 maggio 1601, l’aristotelico si rallegrava che il fratello Giovan Domenico Raguseo e l’amico Trojan Ra-dulovich avessero cominciato a studiare l’astronomia «sub Galilaeo, Ma-thematico excellentisismo».26
In un’altra Epistola, datata 10 agosto 1610, Raguseo rispondeva a Fran-cesco Pigna, che gli chiedeva una spiegazione delle macchie sulla Luna e di altri fenomeni «insolita et admiranda» da lui osservati con il telescopio («Galilaei conspicillum»).27 Il dalmata riportava varie opinioni sulle macu-lae lunari, soffermandosi anche a delineare il parere di Galileo che, sulla base di reiterate ispezioni telescopiche, compiute con uno strumento da lui stesso preparato e potenziato («ab se nuper reperto, vel instaurato potius atque amplificato conspicillo»), rappresentava la superficie lunare come scabra e ripiena di cavità ed eminenze, ribadendo la sentenza dei Pitagorici secondo cui la Luna era «quasi un’altra Terra» («cum veteribus Pythagori-cis sentit Lunam esse quasi alteram Terram»).
È interessante notare che Raguseo cita ad verbum la descrizione della morfologia lunare fornita nel Sidereus Nuncius,28 segno che aveva letto con attenzione il libro.
Nella stessa lettera, egli rimanda anche alla Istoria e dimostrazioni intorno alle macchie solari, notando che «neque vero Luna tantum, sed etiam Sol huiusmodi partes dissimiles habet». Si tratta, con tutta evidenza, di un’aggiunta posteriore (estranea certamente alla stesura originaria del maggio 1610), forse annessa durante la preparazione del volume epistolico che il filosofo aveva in animo di pubblicare.29
In ogni caso, la citazione testimonia ulteriormente l’attenzione raguse-ana per le opere di Galileo e, al tempo stesso, il suo interesse nei confronti degli sviluppi più recenti ed innovativi del dibattito astronomico. In una lettera del 10 gennaio 1611, discutendo del numero delle stelle, egli rin-viava ancora al Sidereus Nuncius, richiamandone i riscontri relativi alla Via Lattea, e alle nebulose di Orione e del Presepe,30 al fine di corroborare la
26 Cfr. infra, Doc. 1.27 Cfr. infra, Doc. 2.28 Cfr. infra, Doc. 2, note 44, 46, 48.29 Cfr. infra, Doc. 2, nota 50.30 Cfr. infra, Doc. 3.
128 MICHELE CAMEROTA
propria convinzione che le stelle siano molte di più delle 1022 attestate da alcuni studiosi.
Raguseo nutriva quindi una fervida passione per lo studio dei cieli e, come risulta da una lettera a Francesco Contarini del 5 febbraio 1611, si impegnò anche a compiere osservazioni telescopiche. Nel raccomandare all’interlocutore (il Contarini, appunto) di ripetere l’esperienza, non esi-tava inoltre a fare l’elogio dello strumento, esaltandolo come una risorsa decisiva per la risoluzione delle dispute scientifiche. Ecco le sue parole:
[...] un telescopio costruito con maestria mostrerebbe chiaramente il fenomeno [la Via Lattea], appianando tutta la controversia che da gran tempo tormenta le menti di molti filosofi. Se anche tu, come ho fatto io, userai questo dispositivo e lo punterai verso il candore della Cintura di Orione, riscontrerai con la certezza propria della visione (oculata certitudine) che quella luce che ti sembrava in prima istanza continua, è in realtà discreta, e deriva dalla concentrazione di piccole stelle (exiguarum stellarum multitudinem) che, in questa parte del cielo, si trovano vici-nissime le une alle altre.31
Anche in questo caso, Raguseo attingeva al Sidereus: nel discutere della
Via Lattea, Galileo la aveva, infatti, identificata con una «congerie di innu-merevoli stelle disseminate a mucchi» («innumerarum Stellarum coacer-vatim consitatum congeries»), con la sostanziale presenza di una «exigua-rum [stellarum] multitudo». Non solo, ma, quasi con le medesime parole poi adoperate da Raguseo, aveva sottolineato il valore e l’utilità del per-spicillum nello sciogliere, con «la certezza propria della visione» (oculata certitudine), le altercationes che «per tanti secoli tormentarono i filosofi»: «perspicilli beneficio adeo ad sensum licet intueri, ut et altercationes om-nes, quae per tot saecula philosophos excruciarunt, ab oculata certitudine dirimantur».32
Come si può constatare, dunque, a dispetto del profilo del tutto tra-dizionale della propria impostazione culturale, l’aristotelico dalmata co-nosceva e utilizzava estesamente l’“annuncio celeste” del collega matema-tico, di cui aveva un’altissima considerazione. Non a caso, dopo averlo ricordato con gli appellativi di «mathematicus excellentissimus» e «cele-
31 «[...] cum affabre constructum perspicillum rem plane commonstret, et controversiam om-nem dirimat, quae diu multorum Philosophorum ingenia torsit. Si tu quoque, ut ego feci, hoc instru-mento uteris, et ad cingulum seu candorem direxeris, oculata certitudine reperies lumen illud quod prius continuum tibi videbatur re vera discretum esse, idque ob exiguarum stellarum multitudinem quae in ea firmamenti parte sibi invicem proximae sunt. [...]». Epistolae, c. 429v (corsivi miei).
32 Cfr. OG, III, p. 78.
129GALILEO NELLE LETTERE DI GIORGIO RAGUSEO
berrimus»,33 Raguseo celebrava Galileo come «nostrae tempestatis mathe-maticorum nemine secundum»:34 qualifiche che non lasciano dubbi sulla stima nutrita nei confronti di colui che, di fatto, lavorava alacremente e con grande efficacia alla demolizione del vecchio, fatiscente edificio del cosmo aristotelico.
33 Cfr. infra, Doc. 1; e Doc. 2, nota 43.34 Cfr. infra, Doc. 4.
130 MICHELE CAMEROTA
DOCUMENTI
1.GiorGio raGuseo a tROJAN RADULODICH [in Padova]
Napoli, 13 maggio 1601
British Library, London, Add. Ms. 10810, cc. 399r-401r: 399v. – Bella copia di mano di copista.
[...] Gaudeo te cum Joanne Dominico35 fratre meo bene valere, vosque ambo simul sub Galilaeo Mathematico excellentissimo Astronomiae operam navare. [...]
2.GIORGIO RAGUSEO a FRANCESCO PIGNA36 [in Sant’Elena, presso
Padova37]Padova, 10 agosto 1610
British Library, London, Add. Ms 10810, cc. 421r-426r: 421r, 421v-422v, 425v-426r. – Bel-la copia di mano di copista. – Parzialmente pubbl. in M. JosiPovic, Il pensiero filosofico di Giorgio Raguseo (+ 1622) nell’ambito del tardo aristotelismo padovano, Milano, Massimo, 1985, p. 72 nota 16.
[...] Tu autem, neglectis hoc tempore iis quae in hoc inferiore mundo aguntur, ad caelestia te transfers, cupidus scire quid agatur in Luna. Si Socratem audisses,38 certe hoc labore supersedisses, cui familiaris erat haec sententia: quae supra nos, nihil ad nos.39 At Galilaei conspicillum, nuper in lucem editum, causaris, quo in-solita quaedam et, si Deo placet, admiranda in Luna aspexisti; praesertim diversi generis maculas quarum causam velles, ut tibi paucis per literas explicarem. [...]
Pythagorici,40 cum viderent Lunam alieno lumine lucere, ne ipsam turpe atque deforme astrum appellare cogerentur, pulchram atque formosam terram nuncupa-
35 Giovan Domenico Raguseo.36 Giureconsulto, fu uno dei fondatori dell’Accademia dei Ricovrati di Padova. Amico del
Querenghi, fece parte di una commissione che doveva giudicare in merito alla polemica sollevata dai Dubbi proposti da Ridolfo Modeschino nei confronti dell’impresa scelta dai Ricovrati per la loro Accademia. Faustino Summo gli dedicò il sesto dei suoi Discorsi poetici (Padova, Appresso Francesco Bolzetta, 1600).
37 La località del destinatario si desume da quanto Raguseo scrive nelle prime righe della let-tera: «Siccine, Pigna, adeo inclementer mecum agis, ut vel ardente Sirio vacare me Philosophiae et Mathematicae patiaris? Nondum fortasse ad tuam istam S. Helenae Villam Augusti Kalendae pervenerunt?». British Library, London, Add. Ms. 10810, c. 421r.
38 In margine: «Socratis sententia».39 Sentenza attribuita a Socrate da lattanzio, Divinae Institutiones, III, 20, 10.40 In margine: «Pythagorici».
131GALILEO NELLE LETTERE DI GIORGIO RAGUSEO
re maluerunt. Cum praesertim Terrae, quam incolimus, valde similis atque cogna-ta sit, et ambae ab eadem re, nempe a Sole, eodem modo afficiantur.
Idem ferme senserunt Platonici,41 qui mundum in tres partes diviserunt. Qua-rum primam quatuor corporeis elementis; secundam quatuor prioribus orbibus, tertiam reliquis ascripserunt. Ideo Lunam terram aetheriam ausi sunt nominare.
In hanc quoque sententiam visus est irrepsisse Nicolaus Cardinalis de Cu-sa,42 qui ut Terram fulgidum astrum ita Lunam splendidam Terram appellare non dubitavit. Quoniam igitur Luna est terrenae naturae, ideo ipsam in profunda sui corporis parte Solis radios non recipere asseveravit, sed tenebrosam manere; in extima vero parte, quam ad Solem convertit, illuminatam esse.
Sententiam hanc, quae iam abiecta et obsoleta erat,43 recens suscitavit et quasi postliminio renovavit Galilaeus Galilaeus, huius almae Academiae Mathematicus excellentissimus, qui ab se nuper reperto, vel instaurato potius atque amplificato conspicillo, frequenti Lunae macularum inspectione, animadvertit eius superficiem non esse perpolitam, aequabilem et exactissimae sphaericitatis (ut eius verbis utar), sed inaequabilem, asperam, cavitatibus tumorisque confertam, non secus ac telluris faciem, quae montium, iugii, valliumque profunditatibus hinc inde distinguitur.44 Ita-que, cum veteribus Pythagoricis sentit Lunam esse quasi alteram Terram, cuius pars lucidior terrenam superficiem, obscurior vero aqueam magis congrue representet.
Omnes igitur hi auctores, et quicunque Terram nostram diurno motu circumvol-vi dixerunt,45 Lunam alteram esse Terram existimarunt.46 Pulchritudines locorum admirabiles in se habentem, montes flammantes, at cingula purpurea, aurum et ar-gentum, non in profunda dispersa, sed quae in planitiebus copiose efflorescant, aut in levibus collibus circumferantur: quorum deinde simulacra ad nos per umbram varie deferat continentis aeris mutatio. Illic sinus magni vastaeque profunditates aquam et caliginosum aerem continent,47 in quas Sol suo quidem lumine non penetrat, sed eas deserens reflexionem dissipatam facit. An non, inquiunt, et in Terra nostra circa Solis exortum consimilem aspectum habemus, dum valles nondum perfusas lumine, montes vero e Solis diametro illas circumdantes, iam iam splendere fulgentes intue-mur? An non terrestrium cavitatum umbrae, Sole sublimiora petente, imminuuntur? Sic igitur et Lunae maculae, eiusdem luminosa parte crescente, tenebras amittunt.48
41 In margine: «Platonici».42 In margine: «Nicolaus Card. De Cusa, lib. 7 excitationum». Si riferisce forse a questo
breve passaggio del libro VII degli Excitationum libri X: «Luna enim terrenae naturae, Solarem radium non recipit in profundo, ideo manet tenebrosa et in superficie quae ad Solem convertit est illuminata». N. cusanus, Opera, Basileae, Ex Oficina Henricpetrina, 1565, p. 589.
43 In margine: «Galilaeus Galilaeus mathematicus celeberrimus».44 Sono parole del Sidereus Nuncius; cfr. OG, III, pp. 62, lin. 30-63, lin. 3.45 In margine: «Explicatio illius sententiae quae Lunam Terram esse decernit».46 Così Galileo nel Sidereus Nuncius: «si quis veterem Pythagoreorum sententiam exsusci-
tare velit, Lunam scilicet esse quasi Tellurem alteram». OG, III, p. 65, lin. 16-18.47 Nel manoscritto: «continentet»48 Il passo, da consimilem aspectum a tenebras amittunt, riprende verbatim, volgendolo in
forma interrogativa, quanto espresso nel Sidereus Nuncius. Cfr. OG, III, p. 63, lin.18-64, lin. 3.
132 MICHELE CAMEROTA
[...] Iam vero quod de Solis substantia dictum est id ipsum de substantia Lu-nae pronunciandum. Non enim terrestris, sed caelestis est, suique generis densita-tem habens. Hocque tantum discrimine a Sole distat quod id lucem habet innatam et insitam, illa vero externam et adventitiam.
Quod vero ad maculas attinet iam conspicillo deprehensum est,49 eius super-ficiem non esse politam atque adeo velleris instar eminentiores ac depressiores partes habere, in raritate et densitate dissimiles. In partibus densis lumen Solis commode recipitur, in raris non item. Hinc illae maculae, ut explicatum est ante.
Neque vero Luna tantum sed etiam Sol huiusmodi partes dissimiles habet,50 et nuper audivi in Sole maculas a Galilaeo fuisse observatas. His videor me tuis quaesitis iam satis respondisse: utinam tibi satis.
Vale Francisce mi, et ubi te ruri caelestibus contemplationibus impleveris, Pa-tavium redi: valde enim me piget tuis colloquiis icundaque consuetudine tamdiu carere. Iterum vale
Patavii, IV Idus Augusti 1610
3.GIORGIO RAGUSEO ad AURELIO ONIGO51 [in Treviso]
Padova, 10 gennaio 1611
British Library, London, Add. Ms 10810, cc. 408r-409v: 408r-408v. – Bella copia di mano di copista.
[...] Dum inquiunt Mathematici Solem maiorem esse Terra centies sexagies quinquies, totum Terrae ambitum, ex recentiorum sententia, complecti milliaria 19080, crassitudinem caeli Lunae continere milliaria 109056, et id genus alia, li-benter illis assentior. Malo enim in sua arte peritis credere quam tempus in dime-tiendo vel numerando consumere. Dum vero in firmamento asserunt tantummodo 1022 stellas visibiles reperiri, 48 imaginibus comprehensas, ab illis omnino dissen-tio potiusque visui, innumeras propemodum percipienti, quam eorum demonstra-tionibus fidem habendam esse arbitror. [...]
Non puto me tam acrem oculorum aciem habere ut in videndo caeteris ante-cellam. Hoc certe scio, dum nocte serena ab uno latere domus per fenestram caeli
49 In margine: «Maculae quae videntur in Luna, unde oriantur».50 In margine: «Maculae item in Sole conspicilli auxilio nuper observatae sunt. Vide
Galilaeum, lib. de maculis Solis». Questo chiaro riferimento alla Istoria e dimostrazioni intorno alle macchie solari, stampata nel 1613, dimostra che il passo venne interpolato successivamente, nell’am-bito del lavoro di preparazione di un’opera destinata a contenere tutte le Epistolae del Raguseo.
51 Nato a Treviso da Giulio, giureconsulto e senatore, fu eletto nel 1589 priore di S. Maria Mater Domini. Nel 1595 fu inviato come rappresentante della città di Treviso a portare le con-gratulazioni al nuovo doge, Marino Grimani. Appassionato di letteratura, fu animatore di vari circoli culturali trevisani. Morì nel 1613.
133GALILEO NELLE LETTERE DI GIORGIO RAGUSEO
partem suspicio, me tot videre stellas ut numerare nequeam. Dum ab opposito latere per aliam fenestram oculos elevo, videre totidem. Dum summo mane super tectum ascendo, alias quoque plures perspicere, cum earum multae quas prius videram occiderint, earum vero quas nondum videram ortae sint: volvitur enim vel stellarum caelum primi mobilis nutu, ideo stellae omnes, praeter eas quae prope polum sunt, oriuntur et occidunt. [...]
[in margine:] Proderit hic notare quae a Galilaeo conspicilli beneficio obser-vatae sunt in circulo lacteo, in nebulosa Orionis et nebulosa Praesepae.52
4.GIORGIO RAGUSEO a FLAVIO QUERENGO53 [in Padova]
Pernumia, 4 luglio 1613
British Library, London, Add. Ms 10810, cc. 388r-390r: 389v-390r. – Bella copia di mano di copista.
[...] intermissis paulisper historiae studiis, quibus, intelligo, te in his praesertim ardoribus maxime addictum esse, hac quoque scientia,54 quam Philo mathemati-carum metropolim appellavit,55 te obsecro exornare. Habes isthic56 Galilaeum,57 nostrae tempestatis mathematicorum nemini secundum. Habes Orlandinum,58 qui me etiam superioribus annis in Geometricis instituit, cuius opera multo fortas-se commodius uti poteris. Habes Julium Zabarellam Comitem,59 quem quotidie visere poteris, dum in Avantium ad Contarenas aedes,60 relaxandi animi gratia, te transfers. Peritissimus ille est, et eius sola familiaritas te geometram faciet. [...]
52 Cfr. OG, III, pp. 76-79.53 Nato a Padova intorno al 1580, compì i suoi studi a Roma, Parma e Perugia. Tornato a
Padova, ottenne un canonicato nella cattedrale, ma fu poi chiamato a Roma da Gregorio XIV, che lo nominò cameriere d’onore. Eletto vescovo di Veglia, rifiutò la mitra preferendo tornare nella sua patria. Nel 1624 successe al canonico Belloni nell’insegnamento della filosofia morale nell’Università di Padova. Versato nella filosofia e nelle belle lettere, era stato aggregato all’Acca-demia degli Innominati di Parma e nel 1601 accolto in quella dei Ricovrati di Padova. Nel 1639 lasciò in eredità la sua biblioteca ai padri di San Domenico. Morì nel 1647 e fu sepolto nella Certosa di Vigodarzere.
54 Intendi la geometria.55 La fonte probabile è L. caelius rhodiGinus (ludovico ricchieri), Lectionum antiqua-
rum libri XXX, VII, 30: «Verum Geometriae adest hoc in primis iuxta Philonem, quae initium est, et tanquam caeterarum metropolis».
56 Probabilmente la lettera è stata scritta prima del 1613, poiché, a quell’altezza temporale, Galileo non era più a Padova da quasi tre anni.
57 In margine: «Galilaeus mathematicus celeberrimus».58 Giovanni Battista Orlandini.59 Giulio Zabarella.60 Riferimento ad una casa dei Contarini localizzata a Vanzo, una frazione di Padova.
FINITO DI STAMPARE
PER CONTO DI LEO S. OLSCHKI EDITORE
PRESSO ABC TIPOGRAFIA • SESTO FIORENTINO (FI)
NEL MESE DI OTTOBRE 2014