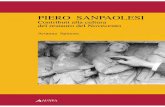Francesconi S. (2006), “Maps sliding”: la narrazione dello spazio in Alice Munro” in...
Transcript of Francesconi S. (2006), “Maps sliding”: la narrazione dello spazio in Alice Munro” in...
This essay has been published in Locatelli, C., Di Blasio, F. (eds), Spazi/o. Teoria, rappresentazione, lettura, Trento, Editrice Università degli Studi di Trento, pp. 183-190, ISBN: 9788884431660.
1
“MAPS SLIDING”: LA NARRAZIONE DELLO SPAZIO IN ALICE MUNRO
SABRINA FRANCESCONI
No, in fact it is the river, the Meneseteung, that is the poem
– with its deep holes and rapids and blissful pools under the summer trees
and its grinding blocks of ice thrown up at the end of winter
and its desolating spring floods.
Alice Munro, “Meneseteung”1
Plus d’un, je vous demande pardon,
il faut toujours être plus qu’un pour parler,
il y faut plusieurs voix…
Jacques Derrida, Sauf le nom2
1. La narrazione dello spazio canadese
Nel panorama narrativo canadese assumono portata prioritaria le strategie testuali atte alla
rappresentazione dello spazio, e, in particolare, di quell’incombente entità geografico-
territoriale a lungo percepita e riduttivamente etichettata in quanto wilderness. Già nel
volume The Bush Garden (1971), Northrop Frye aveva individuato nell’interrogativo
“Where is here?” quell’orizzonte, apparentemente di esclusivo interesse tematico, che
delinea le possibilità autocognitive e autoespressive della scrittura canadese stessa.3 In tale
contesto, il dato empirico territoriale, here, implica solo inizialmente una localizzazione
fisica che si evince dall’hic et nunc del suo manifestarsi geografico.
Da tale problematica pionieristica, “Where is here?”, si articola il più recente e non meno
significativo lavoro di W. H. New, Land Sliding: Imagining Space, Presence, and Power in
Canadian Writing (1997), dedicato all’analisi delle implicazioni testuali e discorsive di
quelle che vengono definite “configurations of land”.4 “Nella scrittura canadese”, spiega
1 “No, anzi, è il fiume, il Meneseteung, che è la poesia –con le sue buche profonde e le rapide e le pozze
paradisiache sotto gli alberi d’estate, e i blocchi di ghiaccio che si staccano alla fine dell’inverno, e le desolanti
inondazioni primaverili.” Alice Munro “Meneseteung”, Selected Stories, op. cit., pp. 492-514, qui p. 511.
Traduzione di Gina Maneri e Anna Rusconi, Alice Munro, “Alla foce del Meneseteung,” Stringimi forte non
lasciarmi andare, La Tartaruga, Milano 1998, pp. 66- 94, qui p. 91 2 “Più d’uno, scusatemi, bisogna sempre essere più d’uno per parlare, ci vogliono più voci.” Jacques Derrida,
Sauf le nom, Galilée, Paris 1993, p. 15. Traduzione mia. 3 Cfr. Northrop Frye, The Bush Garden: Essays on The Canadian Imagination, Anansi, Toronto 1971.
4 W. H. New, Land Sliding: Imagining Space, Presence, and Power in Canadian Writing, University of
Toronto Press, Toronto 1997, p. 5.
This essay has been published in Locatelli, C., Di Blasio, F. (eds), Spazi/o. Teoria, rappresentazione, lettura, Trento, Editrice Università degli Studi di Trento, pp. 183-190, ISBN: 9788884431660.
2
New, “lo spazio va letto come tropo, non come semplice referente verbale.”5 Si vanno in tal
modo a delineare i termini di un discorso solo preventivamente finalizzato ad una
“designation of locality,” attuato secondo procedure rappresentative di ordine descrittivo e
legittimato da presupposti estetici essenzialmente mimetici. Esso innesca piuttosto un
processo di riconcettualizzazione dell’istanza spaziale attraverso una sua plurima dis-
locazione e ri-locazione in quella che è la spazialità testuale. Pertanto, esplorazione del
territorio geografico e esplorazione dello spazio testuale si configurano come operazioni
intersecante. Ne consegue che l’articolazione testuale dell’istanza spaziale origina un vero e
proprio “language of land,” per New dotato di proprie forme rappresentative, discorsive, e
tropiche, funzionanti come coordinate di ordine epistemico e imprescindibili per ogni lettura
della testualità dello spazio in generale e del presente discorso in particolare.
Il tentativo di comprendere tali dinamiche testuali, di mapparne dunque le condizioni e le
modalità di emergenza, non può prescindere dall’assunzione dell’apertura sostanziale delle
stesse a nuove, plurime ridefinizioni. Ed è precisamente tale processo di continuo slittamento
definitorio ciò a cui il titolo stesso del lavoro di New, Land Sliding, fa riferimento. In sintesi,
Land Sliding suggerisce la delineazione di un orizzonte mobile, non sfuggente ma mutevole,
che si compie nell’apertura relazionale allo spazio dell’otherness, nell’accezione più ampia
del termine. Sliding è un movimento fluido che traccia percorsi interni all’economia testuale,
per sbordare nel terreno intertestuale e extratestuale, e per poi sconfinare nello spazio di
incontro tra articolazione e ricezione testuale.
In tal senso, il momento della lettura, da intendersi nel senso performativo iseriano di act
of reading, si configura come impedimento sostanziale e monito concettuale alla
fossilizzazione dei limiti testuali, nella misura in cui decostruisce e sovverte l’aprioristica
unificazione del darsi, e conseguentemente del farsi, del testo.
L’applicazione di tale paradigma interessa la presente analisi ad almeno tre livelli: ad un
primo livello formalista relativo alle strategie stilistiche e retoriche di codificazione
dell’istanza spaziale; ad un livello delle significazioni attribuite allo spazio; ad un livello
post-strutturalista della testualità spaziale, dove lo spazio -testuale appunto- viene percepito
come luogo di negoziazione delle forme e del senso stesso di tali termini.
5 “Land has to be seen as a verbal trope in Canadian writing, not simply as a verbal referent” Ibidem.
Traduzione mia. Corsivi miei.
This essay has been published in Locatelli, C., Di Blasio, F. (eds), Spazi/o. Teoria, rappresentazione, lettura, Trento, Editrice Università degli Studi di Trento, pp. 183-190, ISBN: 9788884431660.
3
2. “Maps sliding”
Figura discorsiva di difficile circoscrivibilità teoretica e applicativa, la metafora viene
tuttavia impiegata in modo significativo nel panorama letterario canadese -sia esso riferito al
creative o al critical writing- nella misura in cui consente una sintesi di modalità
rappresentative di ordine verbale e visuale. Si configura come “atto linguistico indiretto,” per
dirla con Searle,6 che non trascende mai l’esperienza, e che tuttavia traduce tale esperienza
dal letterale al figurativo, in un irriducibile gioco di rinvii.
Emblematica è a tal proposito la metafora della mappa, ponte discorsivo tra identità,
spazialità, e testualità, in altri termini tra testo e contesto. Presa a prestito dall’ambito
disciplinare cartografico, tale tipologia rappresentativa del territorio propone una
codificazione normativa e prescrittiva dello spazio e rimanda a pratiche coloniali e
imperialiste di delineazione di rigidi confini. Se traslata su un discorso narratologico, essa va
a indicare espressioni narrative mimetiche passivamente rappresentative, finalizzate al
riproporre un’immagine neutra e asettica del reale. Tale procedura ben risponde alla logica
della “garrison mentality”, formula coniata da Northrop Frye a esprimere la tendenza ad una
chiusura auto-protettiva tipica dello scenario letterario canadese precedente gli anni Sessanta
del Novecento.7
Per uscire da tali prospettive anguste, e rivitalizzare conseguentemente il concetto di
mappa, si è reso necessario (rin)tracciare quelle mappe letterarie che lo scrittore Hugh
Maclennan auspica per la definizione e canonizzazione di un’identità culturale e artistica
canadese, attraverso l’adesione a specifiche coordinate teoriche e empiriche. Non si tratta di
conformismo, quanto piuttosto di riconoscimento e esplicitazione di un’appartenenza, di
rivendicazione di una specificità relazionale. Come spiega Helen Buss, il mapping è
procedura discorsiva prettamente contestuale:
Anche se le abilità di mapping che portiamo con noi possono esserci d’aiuto, è il territorio su cui ci
spostiamo a dettarci le mappe da tracciare.8
6 Cfr. John Searle, “Metaphor”, in Ortony, A., ed., Metaphor and Thought, Cambridge University Press,
Cambridge 1979, pp. 92-103 7 Questa formula è stata inizialmente proposta da Northrop Frye nelle sue “Conclusions” alla Literary
History of Canada: Canadian Literature in English a cura di Carl F. Klinck, (University of Toronto Press,
Toronto, 1965) poi ristampate nel volume The Bush Garden: Essays on The Canadian Imagination (Anansi,
Toronto 1971). 8 “Although the map-making skills we bring with us can aid us, it is the territory over which we travel
which will dictate the map that we produce.” Helen M. Buss, “Canadian Women’s Autobiography: Some
This essay has been published in Locatelli, C., Di Blasio, F. (eds), Spazi/o. Teoria, rappresentazione, lettura, Trento, Editrice Università degli Studi di Trento, pp. 183-190, ISBN: 9788884431660.
4
Non a caso, Mapping Our Selves è il titolo del significativo lavoro che la studiosa dedica
alla scrittura autobiografica femminile canadese, in cui emerge il tentativo di inscrivere la
scrittura femminile in una prospettiva dialogica, di confronto con istanze identitarie plurime,
sincroniche e diacroniche, socio-culturali e politiche, nazionali e di gender.9 Lo stesso New
sottolinea la differente accezione del termine nei sistemi linguistici occidentali e aborigeni,
mostrando come esso sostanzi antitetici modelli di pensiero, antitetici codici culturali:
Le differenze tra procedure europee di mapping (che miravano a stabilire dei confini e a sostanziare delle
verità empiriche) e il mapping delle First Nations (che sovente veniva accompagnato dal canto per scandire la
connessione spirituale tra individuo e terra) sottolineano il divario tra i due sistemi culturali.10
Tracciare delle mappe, siano esse territoriali, siano “mappe letterarie”, identitarie, siano
ancora mappe concettuali jamesoniane, significa tracciare un orizzonte epistemico su cui
aprire dei percorsi conoscitivi. Lo spazio viene inscritto in una dimensione relazionale, nella
quale scoprirsi, darsi come “spazio altro”, nuovo, differente e differenziale.
L’utilizzo trasversale di tali metafore, “Maps Sliding”, attualizza un tentativo di
comprensione della complessa, ineluttabile incombenza dell’istanza spaziale, evitando il
rischio di processi definitori stereotipati. Con la recente istituzione del territorio del Nunavut,
ad esempio, il Canada non solo infatti accetta di ridefinire i suoi confini politico-territoriali,
di ri-tracciare la propria mappa geografica, ma rintraccia le origini plurime della sua
memoria più profonda e autentica.11
Il mapping non è quindi la chiusura di uno spazio, né un
marchio di possesso. Si tratta piuttosto di un’apertura dialogica, che si sostanzia nella
politica inclusiva di valorizzazione della différance.
Critical Directions” in Shirley Neuman and Smaro Kamoureli, eds., A Mazing Space: Writing Canadian
Women Writing, Newest, Longspoon 1986, pp. 154-164. Traduzione mia. Corsivi miei. 9 Helen Buss, Mapping Our Selves: Canadian Women's Autobiography in English, McGill-Queen's
University Press, Montréal 1993. 10
“Differences between European mapping (which was intended to determine boundaries and fix empirical
truths) and Aboriginal mapping (which was often sung, charting person’s spiritual connection with the land)
further emphasize the disparity between traditional cultures” W. H. New, Land Sliding: Imagining Space,
Presence, and Power in Canadian Writing, op. cit., p. 31. Traduzione mia. 11
Il territorio del Nunavut, precedentemente incluso nei territori del Nordovest, è stato istituito con legge
federale il 1 aprile 1999. L’estensione geografica è doppia rispetto a quella della provincia dell’Ontario, la
popolazione è di 23.000 individui e la lingua ufficiale è l’Inuktitut. Tale atto politico segna il riconoscimento e la
valorizzazione della specificità socio-culturale e linguistica del popolo Inuit, componente imprescindibile della
storia e dell’identità canadese.
This essay has been published in Locatelli, C., Di Blasio, F. (eds), Spazi/o. Teoria, rappresentazione, lettura, Trento, Editrice Università degli Studi di Trento, pp. 183-190, ISBN: 9788884431660.
5
Il rifiuto di rigide procedure di codificazione e de-codificazione dello spazio consente
un’apertura discorsiva non oppositiva agli spazi altri, dell’esterno, nell’adesione a
quell’aesthetic of connection che per Georgeann Murphy è estetica fondante e chiave
interpretativa dell’opera della scrittrice contemporanea canadese Alice Munro.12
Munro, che pubblica regolarmente su importanti riviste letterarie come “The New
Yorker”, ha all’attivo tredici raccolte di racconti, genere narrativo al quale si è dedicata in
modo esclusivo dagli anni Sessanta fino a oggi.13
Il favore riscontrato presso un pubblico
non solo canadese è testimoniato dalla considerevole diffusione dell’opera munroviana nei
paesi di lingua inglese e non, grazie alle sempre più frequenti traduzioni in lingua straniera.14
L’unanimità del giudizio favorevole espresso dalla critica letteraria non trova tuttavia
corrispettivo in una sintesi univoca e concorde dell’estetica della rappresentazione spaziale
propria dell’opera della scrittrice canadese.
3. Le mappe della Huron County
Il paesaggio insistentemente ricorrente nei racconti di Alice Munro è la Huron County,
zona sud-occidentale dell’Ontario bagnata dalle acque del lago Huron, la rappresentazione
narrativa della quale è stata variamente e contraddittoriamente etichettata dai critici come
realista, tardo modernista, postmoderna, regionalista.
Ad una prima lettura infatti, emerge come Munro stenda sulla tela dei suoi racconti delle
pennellate di colore locale, che sono assolutamente efficaci nel ricreare i tratti caratteristici
12
Cfr. Georgeann Murphy, “The Art of Alice Munro: Memory, Identity and the Aesthetics of Connection” in
Pearlman, Mickey, ed., Canadian Women Writing Fiction, University Press of Mississipi, Jackson 1993, pp. 12-
27. Per un approfondimento sulla metafora della mappa nella scrittura di Alice Munro si vedano Coral Ann
Howells, Alice Munro: Contemporary World Writers, UP of Manchester 1998 e Beverly J. Rasporich, Dance of
the Sexes, Art and Gender in the Fiction of Alice Munro, UP of Alberta 1990. 13
In seguito a Dance of The Happy Shades, pubblicata nel 1968 dalla casa editrice di Toronto Ryerson Press,
sono apparse Lives of Girls and Women, nel 1971 (New American Library, New York), Something I’ve Been
Meaning to Tell You, nel 1974 (McGraw-Hill Ryerson, Toronto), Who Do You Think You Are? nel 1979 (The
New American Library of Canada, Winnipeg), The Moons of Jupiter nel 1982 (McMillan Canada, Toronto) The
Progress of Love, nel 1987 (Penguin Books, Markham). Le raccolte più recenti sono state pubblicate dalla casa
editrice McClelland & Steward, anch’essa di Toronto: Friend of My Youth nel 1990, Open Secrets nel 1994, The
Love of a Good Woman nel 1998, Hateship, Friendship, Courtship, Loveship, Marriage nel 2002 ed infine
Runaway nel 2004. McClelland & Steward ha inoltre pubblicato due selected stories collections, la prima nel
1996, la seconda nel 2003, entrambe con un’introduzione dell’autrice. 14
Le traduzioni italiane dell’opera munroviana, in ordine cronologico, sono: Il percorso dell’amore (Serra e
Riva, Milano 1989, di Chiara Spallino Rocca), La danza delle ombre felici (La Tartaruga, Milano 1994 e 2001,
di Gina Maneri), Chi ti credi di essere? (Ediz. E/O, Roma 1995, di Anna Rusconi), Stringimi forte non lasciarmi
andare (La Tartaruga, Milano 1998, di Gina Maneri e Anna Rusconi), Segreti svelati (La Tartaruga, Milano
2000, di Marina Premoli), Il sogno di mia madre (Einaudi, Torino 2001, di Susanna Basso), Nemico, amico,
amante… (Einaudi, Torino 2003, di Susanna Basso), In fuga (Einaudi, Torino 2004, di Susanna Basso).
This essay has been published in Locatelli, C., Di Blasio, F. (eds), Spazi/o. Teoria, rappresentazione, lettura, Trento, Editrice Università degli Studi di Trento, pp. 183-190, ISBN: 9788884431660.
6
della regione: il “paesaggio del bush,” “i cortili spogli,” “le strade impolverate,” “le case di
mattoni grezzi rossi.”15
A tali tratti fisici si intrecciano particolari antropologici, dove i ritmi
di vita ripetitivi, la chiusura mentale e il conservatorismo ideologico della piccola comunità
provinciale sono intrisi della polvere che si alza dalla strade. E se per realismo descrittivo si
intende la capacità di elaborare una versione narrativa del reale ad alto potenziale
referenziale, gli elementi appena citati hanno valenza metonimica, porzione di un tutto che
rappresentano riassumendone fedelmente i tratti distintivi, mantenendo con esso un rapporto
quantitativo. Pertanto, le varie cittadine di Hanratty, Jubilee, Gilmore, le case che le
popolano, la strade che ne collegano i meandri costituirebbero una mise en abyme della
county canadese.
Altri invece hanno sottolineato la valenza simbolica delle pennellate, evidenziandone il
potere evocativo di una realtà altra, di un paesaggio archetipico, intriso di celate e ataviche
significazioni. Tessendo tra le trame narrative le fila di esperienze letterarie quali quelle dei
magic realists, con i tratti gotici della scrittura di Eudora Welty, o ancora con le esperienze
pittoriche dei magic realists, Munro fa trasparire i toni propri della sfera dell’immaginario e
del mistero, di quella tensione affettiva che vitalizza la neutralità di soluzioni cromatiche
pure.
Nel racconto “Walker Brothers Cowboy” –incluso nella raccolta Dance of the Happy
Shades del 1968- lo sguardo infantile della protagonista scorre il paesaggio, ne arricchisce e
rielabora i tratti contingenti con tinte inusuali e inaudite, investendoli di un alone magico e
misterioso:
La strada è ombreggiata, in qualche punto, dagli aceri, le cui radici hanno spaccato e sollevato il
marciapiede e si sono insinuate, come coccodrilli, negli spogli cortili.16
Come molti critici che si sono occupati della scrittura della Munro hanno osservato,
precisi dettagli coesistono accanto a tratti misteriosi, creando una tensione continua.17
La
15
In ordine: “the bush landscape”, “the bare yards”, “the dusty roads”, “the red brick unpainted houses.”
Traduzione mia. 16
“The street is shaded, in some places, by maple trees whose roots have cracked and heaved the sidewalk
and spread out like crocodiles into the bare yards.” Alice Munro, “Walker Brothers Cowboy”, in Selected
Stories, Penguin, Toronto 1996, pp. 3-18, qui p. 3. Traduzione di Gina Maneri, op. cit., p. 7. 17
Si vedano tra gli altri A. Heble, The Tumble of Reason: Alice Munro’s Discourse of Absence, UP of
Toronto, Toronto 1994; C. A. Howells, Alice Munro: Contemporary World Writers, UP of Manchester,
Manchester 1998 e Contemporary Canadian Women’s Fiction: Refiguring Identities, Palgrave Macmillan, New
York 2003; W. R. Martin, The Strange and the Familiar in Alice Munro, «Studies in Canadian Literature», 7/2
This essay has been published in Locatelli, C., Di Blasio, F. (eds), Spazi/o. Teoria, rappresentazione, lettura, Trento, Editrice Università degli Studi di Trento, pp. 183-190, ISBN: 9788884431660.
7
scrittrice stessa, in un’intervista alla sua biografa Catherine Sheldrick Ross, osserva come
tale formula le consenta di trascendere una rappresentazione paesaggistica di tipo oggettuale
e di attingere piuttosto al potenziale estetico e evocativo della scrittura:
Quando decido di ambientare i miei racconti nella Huron County non credo di delimitare la mia scrittura.
Anzi, è quasi il contrario. Non credo di scrivere di questo posto. Spero di scriverlo e attraversarlo. 18
4. I nomi sulle mappe
Una delle strategie per focalizzare l’estetica dello spazio nell’opera di Munro è l’analisi
della funzione dei toponimi nella sua opera. È, in altri termini, l’analisi de “l’emploi du
mot”, come viene suggerito dal titolo del quadro di Magritte, posto sulla locandina della
nostra giornata di studi.19
Magritte solleva dunque la questione della funzione del segno
linguistico all’interno dello spazialità estetica, presupponendo una necessaria riflessione
circa le implicazioni utilitaristiche del livello semiotico della lingua.
Negli ultimi decenni, la convergenza di notevoli sforzi provenienti da ambienti sia
accademici che governativi ha evidenziato una crescente consapevolezza del valore plurimo
dei toponimi, dietro a cui si nascondono antichi sistemi di vita e di pensiero, alternativi
metodi di approccio allo spazio dell’alterità. Basti citare, tra gli altri, il diffusissimo William
Hamilton, The Macmillan Book of Canadian Place Names20
e l’ente Geographycal Names
Board of Canada/ Commission de Toponymie du Canada.21
Interrogare i significati, le
significazioni, la storia dei toponimi consente quindi di intraprendere un percorso su più
fronti, storico e antropologico, indubbiamente, ma anche meta-letterario nella misura in cui
emerge spesso una matura consapevolezza del processo attuato.
(1982), pp. 247-54; J. Miller (ed.), The Art of Alice Munro: Saying the Unsayable: Papers from the Waterloo
Conference, UP of Waterloo, Waterloo 1984; K. E. Smythe, Figuring Grief: Gallant, Munro, and the Poetics of
Elegy, McGill-Queen’s UP 1992. 18
“When I write about something happening in this setting, I don’t think that I’m choosing to be confined.
Quite the opposite. I don’t think I’m writing just about this life. I hope to be writing about it and through it.”
Catherine Sheldrick Ross, Alice Munro: a Double Life, ECW, Toronto 1992, p. 17. Traduzione mia. Corsivi
miei. 19
La locandina è disponibile in formato elettronico sul sito web del Dottorato in Narratività e letterature
comparate del Dipartimento di Scienze Filologiche e Storiche dell’Università degli Studi di Trento. Colgo
l’occasione per ringraziare la coordinatrice, prof.ssa Carla Locatelli, e il collegio docenti del dottorato per aver
offerto a noi dottorandi l’opportunità di confrontarci in modo critico in occasione della giornata di studi e di
partecipare con i nostri contributi a questo volume. 20
William Hamilton, The Macmillan Book of Canadian Place Names, Macmillan of Canada, Toronto 1978. 21
Il comitato cura la pubblicazione semestrale della rivista Onomastica Canadiana e offre un accurato sito
web http://geonames.nrcan.gc.ca/ che consente di effettuare la ricerca on-line di etimologia e accezione
semantica dei toponimi canadesi.
This essay has been published in Locatelli, C., Di Blasio, F. (eds), Spazi/o. Teoria, rappresentazione, lettura, Trento, Editrice Università degli Studi di Trento, pp. 183-190, ISBN: 9788884431660.
8
Tornando a Munro, come si esplica la funzione di designazione spaziale? A partire dai
racconti di Dance of the Happy Shades fino a Hateship, Friendship, Courtship, Loveship,
Marriage, la scrittrice colloca sulla mappa narrativa della Huron County delle cittadine dai
nomi fittizi come Hanratty, Jubilee, Gilmore, Dalgleish. Si tratta di toponimi anglofoni, che
riecheggiano sulla carta i tratti della cittadina di Wingham, dove Munro è nata, cresciuta e
ritornata da qualche anno. In realtà la scrittrice ha dovuto far fronte per anni alle proteste
degli abitanti del piccolo centro dell’Ontario, che si sentivano offesi dai toni critici e
disincantati della narrazione come anche dalle rappresentazioni talvolta grottesche degli
scorci di vita quotidiana e dei tratti di alcuni personaggi. La lettura operata da tale porzione
di pubblico, falsata dall’incapacità di cogliere il valore estetico e non referenziale della
scrittura, riflette la tendenza diffusa tra tanta critica di inscrivere l’opera di Munro in una
prospettiva prettamente regionalistica.22
Le letture di tale operazione sono molteplici, in riferimento alle prospettive critiche da cui
vengono attuate. In primo luogo, l’impiego di toponimi privi di immediata e univoca
referenza geografica può definirsi come tentativo di appropriazione delle possibilità stesse
del naming, da parte di soggetti che tradizionalmente ne erano stati privati. Se sulle mappe
geografiche del territorio canadese non è difficile trovare reduplicazioni di toponimi del
Regno Unito, -come London, Windsor, Hamilton- secondo logiche e procedure imperialiste
di tradizione coloniale, sulle mappe narrative di Alice Munro i toponimi fantasiosi assumono
assai probabilmente valenza emancipativa. La narratrice decide di svincolare il processo
stesso di nominazione da intenti utilitaristici e egemonici: anziché imporre un rapporto
gerarchico di subordinazione, il nome fittizio conferisce allo spazio una propria autonomia
funzionale e alla procedura del naming una valenza estetica anziché politica.
L’impiego di tali toponimi può assumere, in secondo luogo, una funzione concettuale.
Consente infatti di dare vita a luoghi archetipici, simboli di un altrove che poco ha a che
vedere con confini geografici. Consente dunque di delineare un orizzonte altro – ricordando
che proprio Horizon di Sinclair Ross è una delle cittadine immaginarie della letteratura
canadese. Si tratta di quello che per Margaret Atwood costituisce uno spazio esclusivamente
22
A tal proposito va ricordato l’intervento di Linda Hutcheon in The Canadian Postmodern. A Study of
Contemporary English-Canadian Fiction (Oxford UP, Toronto 1998, p. 19) che riscatta la scrittura regionalista
risolvendone l’apparente contraddizione con l’estetica postmoderna. Hutcheon osserva che, nella letteratura
canadese, la rappresentazione della specificità regionale traduce, a livello concettuale, il concetto derridiano di
différance.
This essay has been published in Locatelli, C., Di Blasio, F. (eds), Spazi/o. Teoria, rappresentazione, lettura, Trento, Editrice Università degli Studi di Trento, pp. 183-190, ISBN: 9788884431660.
9
psicologico, una “geography of the mind”.23
Ma la rielaborazione psichica degli spazi
geografici trova compimento solo nella spazialità testuale.
Ad un livello narratologico, tale operazione evita il puro autobiografismo. Pur non
trascendendo dalla specificità del proprio vissuto, Alice Munro si emancipa da vincoli
emozionali e ribadisce che la “sua” Huron County perviene ad uno spazio sottratto alla
contingenza.
L’utilizzo di toponimi fittizi va piuttosto letto come tentativo di trascendere spazi angusti
e confinati, aumentando a livello esponenziale il potere evocativo della scrittura e della
testualità del paesaggio letterario canadese. Attraverso i toponimi, in altri termini, è possibile
intraprendere un viaggio a ritroso nella memoria storica e letteraria del Canada, alla ricerca
di quei topoi che Barbara Godard chiama “universal mythic patterns,”24
cardini
epistemologici fondanti degli archetipi letterari canadesi. Custodi ancestrali delle trame della
memoria storica canadese, essi emergono sotto le spoglie di un palinsesto, tracce
scompostamente sovrapposte dalle origini molteplici, confuse, talvolta scomode. Alla
letteratura il compito di interrogare continuamente tali segni, di decostruire e disseminare la
monolangue, per Derrida lingua della singolarità e dell’egemonia, o, meglio, de l’homo-
hégémonie.25
La creazione dei toponimi, in tal senso, procede rifacendosi a modelli linguistici
alternativi a quello anglofono; non va dimenticato il significativo impiego di toponimi
ispirati alle lingue aborigene. Celebre è Manawaka, immaginaria regione del Manitoba che
costituisce sia settino del ciclo di opere –da The Stone Angel (1968) a The Diviners (1974)–
che ha consacrato il ruolo fondante di Margaret Laurence nel panorama letterario canadese.26
23
Atwood spiega: “Quando una persona si perde ha bisogno di una mappa del luogo, su cui sia segnata la sua
posizione, in modo che possa vedere dove si trova in rapporto a tutto il resto. La letteratura non è solo uno
specchio, è anche una mappa, una geografia della mente. La nostra letteratura è una mappa di questo tipo, se
sappiamo imparare a leggerla come la nostra letteratura, come il prodotto di chi e dove siamo stati.” See
Margaret Atwood, Survival: A Thematic Guide to Canadian Literature, Anansi, Toronto 1972. Traduzione mia.
Corsivi miei. “What a lost person needs is a map of the territory, with his own position marked on it so he can
see where he is in relation to everything else. Literature is not only a mirror; it is also a map, a geography of the
mind. Our literature is one such map, if we can learn to read it as our literature, as a product of who and where
we have been.” 24
Barbara Godard, “Notes from the Cultural Field: Canadian Literature from Identity to Hybridity”, Essays
on Canadian Writing, Winter 2000: 72, pp. 209 – 247, qui p. 213. 25
Cfr. Jacques Derrida, Le monolinguisme de l’autre, Galilée, Paris 1996, pp. 55, 56. 26
Si veda a tal proposito Oriana Palusci “It haunts my Imagination”: Margaret Laurence and the Wounds of
Manitoba”, in Liana Nissim e Carlo Pagetti, Intersections: la narrativa canadese tra storia e geografia,
Cisalpino, Bologna 1999, pp. 57-82.
This essay has been published in Locatelli, C., Di Blasio, F. (eds), Spazi/o. Teoria, rappresentazione, lettura, Trento, Editrice Università degli Studi di Trento, pp. 183-190, ISBN: 9788884431660.
10
O, ancora, la cittadina di Mariposa dove si intrecciano le avventure dei Sunshine Sketches of
a Little Town (1912) di Stephen Leacock.
Nel racconto di Alice Munro “Alla foce del Meneseteung” -pubblicato inizialmente su
“The New Yorker” (gennaio 1988), poi incluso nella raccolta Friend of my Youth (1990) e
infine nelle Selected Stories (1996)- la protagonista tenta di ricostruire la storia di una
poetessa dell’Ottocento, Almeda Roth, la cui figura dai tratti introversi e sfuggenti è
circondata da un alone di intrigante mistero. Ripercorrendone le offuscate vicende
biografiche, si imbatte in alcune immagini fotografiche e in componimenti poetici -che
vengono riportati fedelmente nelle pagine del racconto- indugiando successivamente in
considerazioni di carattere retorico. In un affascinante gioco di rimandi prospettici, la voce
narrante si sovrappone alla voce della poetessa, per poi distaccarsene, rendendo in tal modo
labile, quasi impercettibile, il confine tra le diverse istanze narrative. Il tentativo di
recuperarne la figura della poetessa, improntato inizialmente nella ricerca di curiosi e
intriganti aneddoti sul giornale locale di natura scandalistica, non può prescindere
dall’indugiare sui suoi versi, che trovano ripetutamente spazio tra gli interstizi dello spazio
narrativo, in epigrafe ai sei paragrafi di cui il racconto si compone.
Come l’istanza narrativa si sostanzia nell’intersecarsi di voci plurime, anche il genere
narrativo della short story, forma espressiva privilegiata dell’autrice, si apre in un dialogo
con il genere lirico, modello scelto invece dalla poetessa ottocentesca. Ne risulta una formula
ibrida, informe, difforme; ed è questa la scelta della narratrice, soluzione stilistica che le
consente di ascoltare, apprendere e articolare linguaggi altri.
Tale procedura viene esplicitata nella scelta del titolo, operazione che prende
progressivamente forma narrativa scorrendo tra le pagine, rompendo gli argini delle istanze
testuali. “Meneseteung”, come spiega la voce narrante, è il nome di un fiume da cui è tratto il
titolo sia della poesia di Almeda Roth che del racconto stesso:
La poesia si intitolerà –si intitola- “Il Meneseteung”. Il titolo della poesia è il nome del fiume. No, anzi, è il
fiume, il Meneseteung, che è la poesia –con le sue buche profonde e le rapide e le pozze paradisiache sotto gli
alberi d’estate e i blocchi di ghiaccio che si staccano alla fine dell’inverno, e le desolanti inondazioni
primaverili.27
27
“The name of the poem will be –it is- “The Meneseteung”. The name of the poem is the name of the river.
No, in fact it is the river, the Meneseteung, that is the poem –with its deep holes and rapids and blissful pools
under the summer trees and its grinding blocks of ice thrown up at the end of winter and its desolating spring
floods.” Alice Munro “Meneseteung”, Selected Stories, Penguin, Toronto 1996, pp. 492-514, qui p. 511. Trad. di
This essay has been published in Locatelli, C., Di Blasio, F. (eds), Spazi/o. Teoria, rappresentazione, lettura, Trento, Editrice Università degli Studi di Trento, pp. 183-190, ISBN: 9788884431660.
11
I versi della poesia, le pagine del racconto si sostanziano riflettendo il percorso sinuoso
del fiume, le rapide e le pozze. La negoziazione di istanze proprie dei piani fenomenologico
e estetico avviene all’interno dello spazio semiotico. Perché il nome “Meneseteung”
nemmeno compare sulle mappe, è piuttosto il nome altro, il nome indiano, dalle remote
origini, del fiume Maitland. Munro in questo frangente non inventa un toponimo: sostituisce
il nome anglofono esistente con quello indiano preesistente reso invisibile dalle procedure
imperialiste che hanno drasticamente obliterato il sostrato linguistico autoctono.28
La mappa
narrativa del racconto non rispecchia dunque le mappe geografiche convenzionali e
codificate, ma suggerisce le mappe che ancora vanno tracciate. Sono tracce linguistiche da
riesumare, sono segni da riconoscere, sono soprattutto nuove mappe da delineare, nuovi versi
e nuovi periodi da scrivere. Sono le mappe possibili, i nomi possibili a delineare le
possibilità stesse degli spazi narrativi. E la sfida delle procedure di rappresentazione dello
spazio sta precisamente nell’individuare questo scarto.
Non a caso, altro ossessivo leitmotiv del racconto, sul quale lo stesso si chiude, è il
nomignolo della poetessa: non il nome ufficiale ed altisonante che compare nell’incipit,
Almeda Joynt Roth, nemmeno quello un po’ più fruibile con cui viene designata nel
racconto, Almeda Roth, ma un nome dimesso, domestico, come compare in un verso della
poesia “Children at Their Games” o sulla pietra tombale, “Meda”. Nella prima sezione,
indugiando sui versi della poetessa, la voce narrante arresta per qualche istante il ritmo della
narrazione, e, in un inciso posto tra parentesi, riflette: “Forse Almeda veniva chiamata Meda
Gina Maneri e Anna Rusconi, Alice Munro, “Alla foce del Meneseteung,” in Stringimi forte non lasciarmi
andare, op. cit, pp. 66- 94, qui 91. 28
In questo campo di ricerca convergono interessi storici, linguistici, e letterari. Si veda ad esempio il
contributo di André Lapierre, “Mapping Linguistic Realities: the Case of Aboriginal Toponymy in Canada” in
The Canadian Vision 5/ La vision canadienne, A. Anastasi, G. Bonanno e R. Rizzo, eds, Edizioni Officina
Grafica, Villa San Giovanni 1997, pp. 141-154. Per Lapierre, l’impiego di toponimi da parte delle First Nations,
cronologicamente anteriore rispetto all’arrivo degli europei, traduce specifiche visioni cosmologiche della natura
e specifiche percezioni della spazialità. Il canale orale per la trasmissione di tale ricchissimo bagaglio culturale e
linguistico ne ha enfatizzato la debolezza rispetto alla forma prevalentemente scritta attraverso cui le lingue
europee si sono affermate in Nord America. Conseguentemente a tale incontro, la nomenclatura geografica
canadese di origine autoctona ha registrato fenomeni di adattamento, traduzione e sostituzione a vantaggio di
espressioni europee. La valorizzazione del sostrato linguistico autoctono per la comprensione della specificità
del Canadian English è evidente nel capitolo di William Mackey “The Foundations” nel volume di Edwards su
Language in Canada (CUP, Cambridge 1998).
This essay has been published in Locatelli, C., Di Blasio, F. (eds), Spazi/o. Teoria, rappresentazione, lettura, Trento, Editrice Università degli Studi di Trento, pp. 183-190, ISBN: 9788884431660.
12
in famiglia, o forse si era inventata un diminutivo a scopi poetici.”29
In conclusione, scopre la
pietra tombale e osserva l’incisione:
Il nome era tutto lì –Meda. Era dunque vero che in famiglia era chiamata così. Non solo in poesia. O forse
aveva scelto di far incidere sulla propria lapide il suo nome poetico. 30
Nuovamente, la valenza empirica del nome viene negata in una serie di collocazioni e
significazioni plurime, e possibili, che ne disseminano e ne disperdono l’origine. Anzi è lo
spazio testuale –della poesia prima e della pietra tombale poi – a stabilire i termini stessi del
nome. Il nome abita uno spazio: Almeda si rivolge ad esso per tracciare i segni della propria
identità, la protagonista del racconto –senza nome- si rivolge ad esso per rintracciare le fila
della memoria della poetessa. La famiglia, la poesia, la pietra consentono tuttavia di
ri(n)tracciare il segno ma non il senso del nome: conservano la traccia del suo negarsi, del
suo sottrarsi allo sguardo. “Non avete niente da dire?” chiede un verso di un frammento
poetico della Roth: provocatorio rimando all’altro, alla voce e alle parole dell’altro.31
O
forse, nessuna provocazione ironica, solo il bisogno di sentire altre parole, come ricorda
Derrida: “bisogna sempre essere più d’uno per parlare, ci vogliono più voci.”32
Lo spazio
della scrittura è luogo d’incontro di tali voci.
In conclusione, nelle procedure di rappresentazione spaziale la scrittura di Alice Munro
non prescinde da soluzioni stilistiche precedenti. Si inserisce piuttosto in una consolidata
tradizione di scrittura al femminile -rappresentata da voci autorevoli come quelle di Margaret
Laurence, Mavis Gallant, Coral Shield, Margaret Atwood- che sapientemente riesce a tessere
nelle fila narrative istanze politiche, sociali, culturali, linguistiche, dando visibilità letteraria
ad un paese che sta dinamicamente negoziando la propria identità nazionale nella sintesi
delle varie componenti linguistiche e culturali.
29
“Perhaps Almeda was called Meda in the family, or perhaps she shortened her name to fit the poem.” Alice
Munro “Meneseteung”, Selected Stories, op. cit., pp. 492-514, qui p. 511. Traduzione di Gina Maneri e Anna
Rusconi, op. cit., p. 68 30
“That was all the name there was –Meda. So it was true that she was called by that name in the family.
Not just in the poem. Or perhaps she chose her name from the poem, to be written on her stone.”
Ibidem, p. 514. Traduzione di Gina Maneri e Anna Rusconi, op. cit., p. 94 31
“Have you no word to say?” Alice Munro “Meneseteung”, Selected Stories, op. cit., pp. 492-514, qui p.
512. Il frammento, di cui ho riportato l’ultimo verso, recita: “Vi sogno la notte/ Vengo a trovarvi di giorno.
Padre, Madre/ Sorella, Fratello,/ Non avete niente da dire?” Traduzione di Gina Maneri e Anna Rusconi, op. cit.,
p. 92 32
“…il faut toujours être plus qu’un pour parler, il y faut plusieurs voix…“ Jacques Derrida, Sauf le nom, op.
cit., p. 15. Traduzione mia.
This essay has been published in Locatelli, C., Di Blasio, F. (eds), Spazi/o. Teoria, rappresentazione, lettura, Trento, Editrice Università degli Studi di Trento, pp. 183-190, ISBN: 9788884431660.
13
Munro si discosta tuttavia sia da prospettive socio-politiche che da soluzioni stilistiche
estreme: come si è visto nell’esempio relativo ai toponimi, si instaura un gioco tra
conformismo e violazione della norma. La violazione non è incombente norma
programmat(ic)a ma segno differenziale che destabilizza, dall’interno, l’economia
autolegittimante della scrittura canonica.