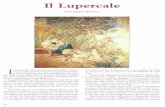Forma urbis
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Forma urbis
131
I nuclei abitati, della collina, possono essere datati ai tempi della con-
quista romana del Canavese. Ma è probabile che una vita organizzata
esistesse già molto tempo prima.
Per capire il tessuto urbano dei nuclei abitati (borghi) è necessario lo
studio del tipo edilizio storico scelto per la costruzione degli edifici.
Di fatto la progettazione di un edificio colloca una precisa tipologia
edilizia all’interno di una morfologia urbana esistente o prevista.
Il rapporto tra le due strutture (borgo ed edificio) è un rapporto reci-
proco: la ripetizione e la disposizione di un tipo determina certi aspetti
morfologici del borgo.
Nei borghi possiamo riscontrare almeno tre tipi edilizi storici:
1. edificio attestato lungo la via principale
(tipo palazzotto di città ad uso prevalentemente residenziale);
2. edifico a ballatoio
(di solito posto dietro la cortina di case che affacciano sulle via
principali);
3. edifico a doppio affaccio e corte interna
(con cortile interno ad uso agricolo).
Il modello di casa rurale più diffuso in Canavese è quello organizzato
in due parti: la casa di abitazione con il granaio nel sottotetto e la stalla
con sopra il fienile. Il tetto può essere unico per l’abitazione e il rustico,
oppure questi due elementi possono semplicemente essere accostati.
Davanti alla casa si trovava l’aia. La disposizione interna dei locali pre-
vedeva la cucina e un altro locale al piano terra, le camere da letto al
piano superiore, al quale si accedeva tramite una scala interna. Parte
essenziale della dimora contadina di collina era la cantina, general-
mente posta sotto la cucina.
Il tessuto e il tracciato urbano dei borghi c.2
132
Tipo edilizio1, fronte compatto, edifici attestati lungo la via principale(edificio tipo palazzotto di città ad uso prevalentemente residenziale).
Tipo edilizio 2, edificio con ballatoio (di solito posto dietro la cortina di case che affacciano sulle via principali).
134
Il tipo edilizio: l’esempio di Cossano Canavese3. Edifico a doppio affaccio e corte interna ad uso agricolo
Sottoportico per penetrazione viaria laterale.
Schema tipo edilizio 3.
Via Via
Corteinterna
Corteinterna
Corteinterna
Corteinterna
3
136
La morfologia urbana
Asse viario principaleAsse viario a supporto tipologia con doppio affaccioDirezione sviluppo urbano
Chiesa posta a quinta scenografica
Piazza
Castello
Porta
Legenda
BorgomasinoTracciato preordinato
Chiesa posta a quinta scenografica lungo la via:
Cappella del Nosello.
Castello di Borgomasino, si hanno notizie attraverso documenti che ne testimoniano
l’esistenza fin dall’XI secolo.
Il nome di Borgomasino deriva dalla dominante bulgaro-longobarda: Bulgarum (così lo menziona, già nel 1170, un diploma di donazione, insieme al suo castello denominato Castrum Bulgari). - I Longobardi invadono l’Italia e si insediano anche a Borgomasino, 568 d.C..- Necropoli barbarica.- Probabile zona fortificata (castrum) nel luogo in cui sorge l’attuale castello.- Chiesa di San Martino XIII sec. Il suo nome compare in un documento del 1272.- Castello anno 1369.
138
CaravinoTracciato lungo le vie di comunicazioneEspansione ramificata
Chiesa posta a quinta scenografica lungo la
via: San Rocco.
Caravino, municipio.
Asse viario principaleAsse viario a supporto tipologia con doppio affaccioDirezione sviluppo urbano
Chiesa posta a quinta scenografica
Piazza
Castello
Porta
Legenda
Il nome di Caravino compare scritto in atti pubblici, a partire dal 1024, sotto le seguenti dizioni: Cadravinum (quadratino, accampamento romano), Cadravino, Ca-ravinum, Caravino.- Ricetto (memoria).- Torre porta (Gravellino).- 1392, Facino Cane occupa Caravino ma non il Castello di Masino. - Campore, Campo del Re, dove nel 1641 si accamparono le truppe a servizio del principe Tommaso durante la lotta per la reggenza tra Maria Cristina di Francia ed i suoi cognati.- 1800, L’occupazione militare napoleonica porta Caravino a divenire Capoluogo di Cantone e sede di Giustizia del Dipartimento n. 109 della Dora.
140
CossanoTracciato lungo le vie di comunicazione
Chiesa posta a quinta scenografica lungo la
via: Invenzione di Santo Stefano.
Cossano Canavese, panorama.
Asse viario principaleAsse viario a supporto tipologia con doppio affaccioDirezione sviluppo urbano
Chiesa posta a quinta scenografica
Piazza
Castello
Porta
Legenda
Il nome di Cossano compare per la prima volta nel 1070 in una pergamena con-servata nel castello di Masino con il nome di “Cosano”. Il nome deriva dai toponimi: Cottianus, Coceanum, Coseanum, Cofsano, Coxano, Cossano.- Vallo romano.- Probabile fortificazione alle pendici del costone nord della valletta. - Assoggettata ai signori di Masino dal 1070 fino al1797.- Frazione Francia, toponimo di derivazione: occupazione di truppe francesi.- Rossetto, ricetto, zona elevata e spianata dove sorgeva un’area fortificata.- Lucenta, dal latino locus: bosco sacro.- Valera, dal latino vallara, vallis: valle.- Bric (dal celta luogo elevato) delle barricate, altura dove nel 1391 gli abitanti si opposero a Facino Cane.- Braia, dal longobardo braida, zona pianeggiante (forse campo d’arme).
142
MaglioneTracciato lungo le vie di comunicazione con espansione ramificata
Chiesa posta a quinta scenografica lungo la
via: San Grato.
Maglione, opere del MACAM.
Asse viario principaleAsse viario a supporto tipologia con doppio affaccioDirezione sviluppo urbano
Chiesa posta a quinta scenografica
Piazza
Castello
Porta
Legenda
Il toponimo è attestato sin dal X secolo come castro Malione, con le varianti Ma-glonus (1224) e Loco Mallioni (1229). Le prime notizie risalgono al 999 quando il borgo è nominato in una donazione di terre dell’imperatore Ottone III al vescovo di Vercelli.- Vercelli lo infeudò, nell’anno 1208, al ramo dei conti di Valperga detto di Masino.- Castello anno 1209 (memoria). - Torre del Castello ora campanile del Cimitero. - Nel 1652 la roccaforte capitolo’ e fu distrutta.
144
MasinoTracciato lungo le vie di comunicazione
Chiesa posta a quinta scenografica lungo la
via: San Rocco.
Torre del castello.
Asse viario principaleAsse viario a supporto tipologia con doppio affaccioDirezione sviluppo urbano
Chiesa posta a quinta scenografica
Piazza
Castello
Porta
Legenda
Castello anno 1195.
146
Settimo RottaroTracciato preordinato con espansione ramificata
Chiesa posta a quinta scenografica lungo la via:
Trinità.
Settimo Rottaro, Chiesa Parrocchiale
Asse viario principaleAsse viario a supporto tipologia con doppio affaccioDirezione sviluppo urbano
Chiesa posta a quinta scenografica
Piazza
Castello
Porta
Legenda
Prime tracce archivistiche di Settimo risalgono ad un documento del 1227 in cui si affermava la potestà della chiesa di Ivrea. Il nome deriva dalla distanza di Settimo da Eporedia (Ivrea).- Castello (memoria). - Influenza dei marchesi del Monferrato che infeudano i loro signori prediletti del Canavese: i Valperga di Masino.
148
VestignèTracciato preordinato con espansione a fuso
Chiesa posta a quinta scenografica lungo la via:
Trinità.
Vestignè, Casa della Cella, XI sec.
Asse viario principaleAsse viario a supporto tipologia con doppio affaccioDirezione sviluppo urbano
Chiesa posta a quinta scenografica
Piazza
Castello
Porta
Legenda
Alcuni studiosi, fra i quali il Bertolotti, sostengono che Vestignè sia di fondazione celtica; l’antico toponimo Vestiniacus, come tutte le parole composte col suffisso celtico –acus.- Nell’XI secolo, queste terre entrano nella sfera d’influenza di Umberto Biancama-no, e, quindi, dei Savoia.- Casa della Cella, anno 1000.- Dal 1074, il comune viene infeudato ai potenti Valperga.- Nel XIV secolo ci sono costruzioni di ingenti opere idrauliche che coinvolgono il territorio; soprattutto l’apertura del naviglio di Ivrea che è fondamentale per lo sviluppo dell’eporediese. Il canale attira l’attenzione di Leonardo.
150
Il ricetto di Caravino
Le difese collettive del contado dell’anfiteatro morenico d’Ivrea nel me-dioevo: “receptum”.
“Nel XIII e XIV secolo gli abitanti dispersi per le campagne si riunirono in piccoli borghi o si serrarono in luoghi cinti da mura fortificate per di-fendersi dalle scorrerie, dagli assalti e proteggere così i prodotti delle loro derrate. Questi luoghi si chiamarono ricetti” (Riccardo Brayda,Prima definizione di ricetto: “Passeggiata artistica nel Canavese”, To-rino, 1908, pg 4)
Il territorio dell’anfiteatro morenico è caratterizzato da piccoli nuclei cittadini e da un paesaggio agrario disseminato di segni: di questi nu-clei, il ricetto ha molto spesso rappresentato il primo atto del processo insediativo.Ricetto deriva dal latino recéptus, asilo, rifugio, ricovero, luogo fortifi-cato. Costruzioni raggruppate all’interno di una cinta muraria, munita di torre d’ingresso, torre d’angolo e di cortina, costituiti fra il sec. XII e il XV. Il ricetto era un rifugio, luogo cinto da mura e fortificato. In esso, duran-te il medioevo e in caso di allarme, gli abitanti delle campagne tene-vano i raccolti e le loro famiglie al sicuro dalle scorrerie e dagli assalti. L’allarme veniva dato da uomini di guardia, appostati su varie torri, che controllavano il transito di persone, segnalando eventuali presenze ar-mate lungo le principali vie di comunicazione. Quando veniva dato l’al-larme (con suono di corno o campana) la gente fuggiva dalle povere abitazioni poste in pianura, nelle campagne, e si rifugiava nel ricetto.
Benché i ricetti si presentino assai numerosi sul territorio, ancora oggi non c’è una buona conoscenza di questo bene culturale creato dall’uo-mo, che andrebbe invece studiato e conservato attentamente.Denunciarlo, il sapere che esiste, portarlo in superficie è già un primo ed importante obiettivo; questo permetterebbe di inserirlo all’interno di un sistema di rivalutazione che gli restituirebbe il suo giusto valore, facendo risaltare le bellezze di un paesaggio troppo spesso deturpato da interventi che non tengono conto della valenza storica delle costru-zioni più antiche.
151
La struttura portante verticale, in laterizio, era in comunione tra celle adiacenti e indipendenti sui fronti. La struttura orizzontale era compo-sta da travi in legno molto spesso con presenza di rompitratta. Negli esempi più antichi era d’uso la pietra mentre in quelli più tardi i laterizi.Tra le fasce contigue dei fabbricati c’erano le riane, spazi liberi, con la funzione di raccogliere le acque piovane.Le coperture presentavano due falde una scaricava verso la via pub-blica e l’altra verso la riana.
Il ricetto sfruttava l’accidentalità del terreno per una migliore difesa.Non esiste una preciso impianto urbanistico preordinato del ricetto, ma esiste l’uso di manufatti che vengono realizzati nelle loro parti co-stitutive. Il tessuto edilizio era caratterizzato dalla compatezza delle isole edilizie: Cellaria.
I Ricetti possono essere classificati come:
A) Ricetti che nascono come borgo nuovo o insediamenti preesistenti fortificati, con assetto organicamento definito, nati su terreno libero. Veniva dimensionato secondo le necesstà e molto spesso prevedendo eventuali espansioni. (Piverone)
B) Ricetti come parti integrate al castello signorile e possono essere:
- Nucleo a “guscio”, lungo la fortificazione perimetrale si allinea no le celle, forma circolare, quadrata o rettangolare. A Vivero- ne tra le mura e le celle correva un passo d’uomo. (Dorzano)
- Nucleo ad impianto ortogonale ed a schema allungato e/o a “fuso”, presenza di vie chiamate “lizza” o “corsera” che indica- no la presenza di una “via di ronda”(Magnano, Caravino, Bol- lengo e Vialfrè)
(Estratto da: Micaela Viglino Davico, I Ricetti, EDIALBRA,1978)
c.5
152
Sezione tipo del ricetto.
I ricetti dell’anfiteatro morenico, censiti da Micaela Viglino Davico (I Ricetti, EDIALBRA,1978).
153
Prospetto tipo: l’accesso al piano terra avveniva attraverso un portale ad arco.
Spaccato assonometrico Ricetto tipo.
c.5
154
Il Ricetto di Candelo, la via era formata da ciottoloni inclinati verso la mezzeria per permettere il deflusso delle acque piovane
(Micaela Viglino Davico, I Ricetti, EDIALBRA,1978).
Brano di tessuto edilizio tipo a doppia manica con la presenza della riana tra le due parti. Le dimensioni delle singole celle variavano da mt 3,00x6,50 a
10,00x7,50, per un’altezza di circa mt 7,50 (Micaela Viglino Davico, I Ricetti, EDIALBRA,1978).
155
Le muraCiottoli lavorati verso l’esterno a spina di pesce (opus spicatum).
Si riscontrano mura alte mt 3,00 con spessori fino a mt 1,00, ridotti al cammino di ronda (Micaela Viglino Davico, I Ricetti, EDIALBRA,1978).
La riana (Micaela Viglino Davico, I Ricetti, EDIALBRA,1978).
c.5
156
Ricostruzione del ricetto di Caravino
“Caravino fu feudo dei conti di Masino, che risiedevano nel castello del borgo omonimo, divenuto oggi frazione di Caravino. Del riccetto, co-munemente indicato come “castello”, sulla scorta di quando scrittone dal Casalis è attestata l’esistenza dagli statuti del 1480.Per sanare vertenze sorte tra il signore Ludovico Valperga Masino e la comunità viene siglato un accordo, a conferma di un pubblico stru-mento precedentemente redatto “nella città di Caravino, nella pubblica via fuori e presso il Revellino di questo luogo”. Seguono, nel “tenor Ca-pitulorum” la rubrica contro i ladri “nel ricetto e nel paese di Caravino” per i quali la pena è raddoppiata rispetto a quanto previsto di norma e quella contro le bestie ritrovate a pascolare nei fossati “Caravini vi-dilicet recepti”. Viene classificato da Vigliano come ricetto di cui non permangono testominianze (G. Vigliano, “Beni culturali…” pag. 108). Dalla mappa francese si leggono la struttura del nucleo, la perimetra-zione delle fortificazioni, con torreporta e rampa di accesso. Il ricetto era localizzato su di un colle, a nord del borgo. Il sito è difendibile na-turalmente; tutto il perimetro a fuso della metà verso il paese presenta uno strapiombo, variabile dai dieci ai tredici metri. In questi tratti non esistono mura, la cui funzione veniva assolta dalle difese naturali. Nel-le altre zone il dislivello minimo è di m. 2,50.La cortina difensiva è conservata in tutto il tratto nord (dallo spigolo sulla particella 406 a quello estremo est, al di là della torre nord).E’ costituita da muratura a doppia cortina di ciottoli, posti con regolari-tà a spina di pesce, per uno spessore complessivo di cm 85. La torre porta, alla sommità della rampa di accesso è oggi distrutta, era sita in mezzeria del lato sud-ovest (“a mezzanotte si vedono notevoli avanzi di un antico assai forte Castello, di cui la gran porta d’ingresso ed il ponte levatoio furono atterrati nel 1812” G. Casalis). La struttura del nucleo, che parrebbe la risultanza di un ampliamento delle due isole ovest su di un impianto primitivo a fuso, allungato nella zona maggior-mente difesa, è articolata in sei isole, interrelate da un sistema viario NE-SO, con una sola trasversale. Pressoché tutta l’area del ricetto è oggi terreno libero, coltivata ad orti. In zona sud vi sono degli edifici che hanno inglobato o sostituito quelli del ricetto. Unicamente in due casi (mappali 495 e 503) rimangono elementi delle cellule antiche, co-stituiti da murature in pietra a spina di pesce, a livello di rudere.”
(Estratto da: Micaela Viglino Davico, I Ricetti, EDIALBRA,1978)