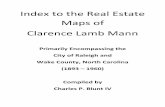Flaubert, Turgenev and Mann in Verga or Dante in Quasimodo. The chapter Verga and Thomas Mann is a...
Transcript of Flaubert, Turgenev and Mann in Verga or Dante in Quasimodo. The chapter Verga and Thomas Mann is a...
Copyright © MMVIIIARACNE editrice S.r.l.
via Raffaele Garofalo, 133 a/b00173 Roma(06) 93781065
ISBN 978-88–548–1558–7
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.
Non sono assolutamente consentite le fotocopiesenza il permesso scritto dell’Editore.
I edizione: gennaio 2008
Indice
7
Ringraziamenti Ringrazio molto vivamente Simona Albani, Gabriella Alfieri, Gio-
vanni Bonfadini, Paola Bozzi, Margherita Breccia, Richard Brütting, Marina Cometta, Fabrizio Conca, Davide Conrieri, Davide Di Maio, Franz Haas, Hella Kaiser, Claudio Milanini, Marco Modenesi, Giulia-na Nuvoli, Paolo Panizzo, Donato Pirovano, Carla Riccardi, Salvatore Riolo, Emanuella Scarano, Arno Schneider, Giuseppe Velli, Sergio Zatti, il personale tutto della Bayerische Staatsbibliothek di Monaco di Baviera, della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma e della Bibliote-ca Universitaria di Catania
9
Indice Premessa ................................................................................... 15
PARTE PRIMA
Giovanni Verga e la letteratura europea
Capitolo I Echi di Madame Bovary in Verga,
con una questione di datazione 1. Verga lesse Madame Bovary tra la fine del 1873 e gli inizi
del 1874? ............................................................................. 25 2. Madame Bovary e La chiave d’oro ...................................... 29 3. Aspetti dell’influenza di Flaubert sull’intera narrativa ver-
ghiana ................................................................................. 33 4. Violette e gelsomini in Madame Bovary e in Eva .................. 40
Capitolo II Echi di Turgenev in Verga,
con particolare riguardo ai personaggi femminili 1. Turgenev nei romanzi mondani di Verga del periodo fioren-
tino–milanese ...................................................................... 45 2. Fumo, Acque di primavera ed Eros ...................................... 48 3. Acque di primavera e Tigre reale ......................................... 52
Indice
10
4. Un nido di nobili, Fumo, Eva, Tigre reale e Il marito di Ele-na: le donne e la terra natale in Verga e in Turgenev ............. 56
5. Un nido di nobili, Alla vigilia, Acque di primavera e il bova-rismo del Marito di Elena .................................................... 61
6. L’ambra e l’esotismo: Madame Bovary, L’Éducation senti-mentale, Acque di primavera e Il marito di Elena ................. 65
7. Aspetti onomastici in Acque di Primavera e nel Marito di E-lena ..................................................................................... 67
8. Appendice: struttura e contenuti di Tigre reale e di Acque di Primavera ........................................................................... 69
Capitolo III Il Verga verista nel giovane Thomas Mann
1. L’Italiano Thomas Mann ...................................................... 75 2. Una finestra sull’onomastica dei Buddenbrook ..................... 82 3. Due scalette tematiche a confronto: a) quella dei Malavoglia 88 4. La seconda scaletta tematica: b) I Buddenbrook .................... 90 5. Altre risonanze e movenze dei Malavoglia nei Buddenbrook . 92 6. L’influenza di altre opere narrative italiane sul “gran roman-
zo” tedesco .......................................................................... 101 7. Rosso Malpelo e la Knabennovelle (la storia di Hanno) ......... 111
PARTE SECONDA
Alla ricerca dello stile per le novelle veriste e per I Malavoglia
Capitolo I Appunti sulle stampe di Rosso Malpelo
1. La stampa abusiva di Rosso Malpelo e i problemi filologici
da essa sollevati ................................................................... 127
Indice
11
2. Dalla stampa in rivista all’opuscolo, alla princeps di Vita dei campi e alla edizione di lusso: primo quadro ......................... 138
3. Ancora sulle tipologie di intervento dell’ignoto correttore: secondo quadro .................................................................... 145
4. Interventi del correttore ignoto e reazioni dell’autore: terzo quadro ................................................................................. 155
5. La stampa abusiva e gli interventi dell’autore: ultimo quadro 161 6. Conclusioni ......................................................................... 167
Capitolo II Lo stridore e l’armonia.
Jeli il pastore tra Rosso Malpelo e I Malavoglia 1. I suoni come livello fondamentale dello stile nel Verga verista 169 2. La lingua dei Malavoglia e la mimesi del dialetto siciliano–
catanese ............................................................................... 175 3. Sulla lingua dei Malavoglia come impasto splendido di ar-
monia e di stridore ............................................................... 179 4. Alcuni criteri di registrazione degli effetti fonetico–sonori .... 183 5. Conversazioni nei luoghi frequentati da uomini .................... 185 6. Armonia e stridore, con speciale riferimento alle donne ........ 189 7. Sensazione e realtà del naufragio nel livello fonetico–sonoro 192 8. Le donne, la disgrazia, la follia e il tessuto fonetico–sonoro
cangiante ............................................................................. 195 9. Le tonalità lievi come maschera ........................................... 197 10. Suoni melodiosi e sentimenti teneri, patetici, dolenti ............. 199 11. La novella verista antecedente I Malavoglia in cui è stata
primamente cercata e conseguita la dolcezza fonica .............. 201 12. Il tessuto fonetico–sonoro di Jeli il pastore ........................... 206 13. Per il conseguimento della dolcezza fonica ........................... 209 14. I testi che hanno fornito ausilio all’eufonia e le contraddizioni
di Jeli il pastore ................................................................... 213 15. Un capolavoro nato dalla discordia: soavità dei suoni e a-
sprezza dei contenuti ............................................................ 215
Indice
12
Postilla I. Notti estive e firmamento in Rosso Malpelo ................ 221 1. Luperini, le stelle e la luna. Una replica ................... 221 2. Appendice (con i riscontri dalla LIZ 4) .................... 243
Postilla II. Lettura cristologica dell’Asino di San Giuseppe ......... 251
PARTE TERZA
L’Apocalisse, l’amore, la natura e i giardini edenici in Quasimodo
Capitolo I La poesia ermetica di Quasimodo: letture essoteriche
1. L’influenza dei classici e della poesia italiana medievale ....... 265 2. Atteggiamenti giocosi nei confronti di Petrarca e di Leopardi 268 3. Atteggiamenti innocenti e giocosi nei confronti della Bibbia . 274 4. La notte, il sogno, il rinnovamento della dolcezza perduta ..... 275 5. Letture essoteriche da Acque e terre ..................................... 281 6. Letture essoteriche da Òboe sommerso ................................. 285 7. Dopo il ritorno della dolcezza: l’innocenza e il paradiso per-
duto ..................................................................................... 299
Capitolo II Il giovane Quasimodo, la Bibbia e il Purgatorio:
letture esoteriche 1. La chiave che conduce al Purgatorio di Dante: Dormono sel-
ve ........................................................................................ 301 2. Altre letture esoteriche: le isole al plurale (la Sicilia e il pur-
gatorio) ................................................................................ 309 3. I miti biblici e l’isola estatica alle origini di Ed è subito sera . 318 4. Unione del principio e della fine dei tempi: Di fresca donna . 321 5. La lezione di Stazio e la virtù attiva del seme in Quasimodo . 325
Indice
13
6. Il ritrovamento della “dolcezza” ........................................... 329 7. Gli amori, il parto, la nascita, le doglie della natura ............... 331 8. Il Purgatorio, la Genesi, l’Apocalisse e la poesia matura di
Quasimodo .......................................................................... 339
15
Premessa L’insularità è stata spesso considerata come una sorta di speciale
collante tra esponenti della narrativa e della poesia i quali se non fosse possibile applicare loro l’etichetta “Sicilia, un piccolo continente a sé stante ancorché facente parte dell’Italia” semplicemente sem-brerebbero tra loro pressoché estranei, privi di retroterra comune e di affinità concreta. Ciascuno dei due artisti qui considerati, si sa, ha in-fuso nella propria opera un immenso sentimento di amore nei confron-ti della piccola patria comune, ma a questo eminentemente si riduce la somiglianza che li lega. Non voglio neppure provarmi a forgiare im-probabili legami organici, eccezion fatta per l’appartenenza alla mede-sima piccola patria, tra un puro narratore e scrittore per il teatro di fine Ottocento e un puro poeta, critico e saggista appartenente al cuore del Novecento, al secondo quarto e alla prima metà del terzo quarto di tale secolo. A dire il vero, la produzione quasimodiana detta poesia narra-tiva e civile, successiva alla fine della seconda guerra mondiale, reca tracce non cospicue ma neppure irrilevanti del magistero di Giovanni Verga e di Luigi Pirandello. Nel presente volume però, è studiata pre-cipuamente la poesia quasimodiana della prima stagione, confluita nella raccolta Ed è subito sera (1942). Allora, se qui neppure si tenta una sorta di studio in parallelo dei due autori, perché riunire in un solo volume le due monografie invece che pubblicare ciascuna di esse in un volumetto a sé stante?
Si crede ancora, comunemente, che Verga nelle sue opere veriste abbia dato della terra natale una raffigurazione cui è sottesa verosimi-glianza autentica. La Sicilia riprodotta da Verga e apprezzata dai più è la Sicilia degli “umili”, delle plebi contadine e dei pescatori, in genere abitanti di paesetti piccolissimi in cui sovrane regnano la miseria e passioni che spesso assumono (come prevede la temperie culturale na-
Premessa 16
turalistica) tratti esasperati e anche patologici. La miseria è talvolta di-gnitosamente sopportata; molte volte essa genera nei più spregiudicati un istinto di sopraffazione che porta ad accumulare o “la roba” o il denaro attraverso lo sfruttamento illecito, illegale (il prestito a usura), accanito, dell’altrui debolezza e dell’altrui disgrazia; altre volte essa è sconfitta a prezzo di grave sacrificio personale e con apparente suc-cesso da persone più dotate e più capaci degli altri. Per altro verso si crede che Quasimodo, specie nella poesia intenzionalmente ermetica, quella della prima stagione, avrebbe trasfigurato liricamente, per usare il lessico critico–estetico di Croce, il proprio tenace attaccamento alla Sicilia, a esso donando qualche volta ma non sempre espressione e so-stanza etica universale.
La poesia quasimodiana non si sottrae in effetti a una certa retori-ca, che rispecchiava bene, nel secondo quarto del Novecento, il com-plesso di inferiorità di alcuni Siciliani nei confronti delle regioni conti-nentali del Nord, allora assai più progredite di quelle meridionali dal punto di vista economico, tecnico e anche scientifico. Quasimodo in-carnò all’inizio della sua carriera, senza esserne ben consapevole, il senso di rivalsa culturale, e umanistico, nel quale la Sicilia migliore cer-cava conforto e soprattutto incoraggiamento a fronte della coscienza del proprio ritardo e delle proprie carenze strutturali. Egli si sentì chiamato a esser cantore del mito di cui parlano tante pietre, tanti monumenti e tanti toponimi della Sicilia; e gli parve di farsi con ciò portavoce di una sorta di carattere quintessensiale ed eterno della sua isola.
Egli fu dunque profondamente partecipe dello stereotipo gentile che esaltava la Sicilia come terra in cui fiorì un’antica nobile civiltà, intimamente imparentata con la più colta tra le civiltà antiche. Questa retorica, la quale oggi suona un poco fastidiosa ed è stata negli ultimi decenni dai Siciliani fortemente ridimensionata, aveva, pur nolente il poeta, carattere duplice: per certi versi, come si è detto, era fonte di incoraggiamento e orgoglio costruttivo; per altri versi contribuiva a velare i mali che, or sono alcuni decenni, affliggevano pesantemente l’isola. Il sacrificio di alcuni tra gli Italiani e Siciliani migliori (per tut-ti cito Giovanni Falcone) e la modernizzazione economica non sono ancora riusciti a sconfiggere del tutto quei mali, complice la tenace, trasversale resistenza di ampie zone della classe politico–burocratica della regione, soprattutto lì dove si trova la sede del potere.
Premessa 17
Sia il ritratto di Verga che quello di Quasimodo rievocati nel se-condo capoverso contengono una parte di verità, naturalmente, ma molti loro aspetti sono già stati sfatati, e le nuove verità si stanno fa-cendo strada lentamente. Anche il presente volume tenta di offrire un contributo alla delineazione di un ritratto più aggiornato e più adegua-to dei due autori, a partire, forse, dalla cultura che hanno respirato, che li ha influenzati e di cui si sono avvalsi. Nel caso di Verga sono stati esaminati aspetti dell’impressione prodotta su di lui da opere narrative della letteratura europea tardo–romantica: sia da opere mediocri (Du-mas figlio) sia da opere di altissimo livello (Flaubert, Turgenev); poi sono stati messi in luce anche alcuni modi ed esiti della profonda im-pressione che la sua produzione verista ha esercitato sulla narrativa giovanile del maggiore autore del Novecento, Thomas Mann. Si è scritto quindi intorno al simbolismo cristologico verghiano. Infine so-no stati illustrati aspetti fondamentali della ricerca verghiana dello sti-le per la narrativa verista: in particolare per l’assetto fono–linguistico di alcune novelle e dei Malavoglia. Tutto ciò spiega il titolo del volu-me, titolo che non abbisogna di altre spiegazioni perché queste si tro-veranno leggendo i capitoli e le postille che seguono questa premessa. Ho però da rimproverarmi, forse, il fatto che l’aggettivo “europeo” non includa a sufficienza la potente ispirazione biblica e dantesca, fi-nora poco o punto avvertita, della poesia di Quasimodo.
Non ho ancora dato una risposta precisa alla domanda circa le ra-gioni per cui le due monografie sono state riunite in un medesimo vo-lume. Come si vedrà, esistono numerosi aspetti di omogeneità tra di esse, quali la fortissima attrazione, di segno diverso, provata sia da Verga che da Quasimodo nei confronti delle sacre scritture ebraico–cristiane. Alcuni di codesti aspetti sono curiosi: per esempio quello consistente nella forte influenza che un ben preciso romanzo di Ga-briele D’Annunzio esercita sia su Thomas Mann lettore di Verga, sia su Quasimodo.
Ma il motivo per cui l’indagine su Verga e quella su Quasimodo sono state riunite è che si voleva smentire anche un altro cliché, tetro, che grava sulla cultura siciliana e che trova forse la prima origine nella narrativa di Verga. Circa la sostanza assolutamente negativa e imme-dicabile del pessimismo verghiano non vi sono dubbi. Da Hegel a Freud a Croce sono stati però ribaditi più volte e in modo scientifica-
Premessa 18
mente convincente il carattere spontaneamente profetico della grande letteratura e le ragioni di esso. Il pessimismo di Verga, se lo si solleva al di sopra della sua insularità trasfigurando l’insularità, ovviamen-te, non certo dimenticandola e lo si considera come un aspetto della cultura europea del secondo Ottocento, resta sì cupo, ma lascia balena-re anche tratti genialmente profetici.
Vi è in Verga, non senza una buona dose d’intesa con Flaubert, l’intuizione dell’inquietudine profonda attraversata dall’istituto fami-gliare fin dall’età romantica e dell’incipiente affacciarsi o prorompere, nel mondo occidentale, di nuovi modelli socio–antropologici femmini-li e di nuove forme dell’istituto famigliare. Del pari vi è in lui l’in-tuizione costitutiva del verghiano bellum omnium contra omnes in cui consiste la sostanza antropologica e sociale della vita della im-possibilità ineluttabile di ordinamenti politici puramente socialisti e comunisti. Al totale fallimento di essi e al loro crollo per implosione nel terzo quarto del Novecento tutti abbiamo assistito. A questa intui-zione “profetica” si accompagna in Verga, come in Flaubert, la raffi-gurazione impietosa dei mediocri pseudo–intellettuali e demagoghi che aspiravano a divenire dirigenti e dittatori degli ordinamenti politi-ci fondati sull’impossibile egualitarismo puro. Il pessimismo di Verga è uno strumento di “conoscenza disinteressata” grandioso purché ven-ga posto a confronto con la temperie culturale (ma anche socio–politica) europea.
Di contro, quando il pessimismo di Verga viene calato tutto nella insularità, emerge e si impone l’“anima inferiore” di esso, il suo essere quasi (o senza il “quasi”) una conseguenza dell’arretratezza della Sici-lia, del senso di inferiorità dell’isola, dell’inclinazione di questa al-l’immobilismo. Allora quel pessimismo diventa, purtroppo, il princi-pale, il più alto e prestigioso punto di partenza letterario ottocentesco della diffidenza dei Siciliani nei confronti del cambiamento, diffiden-za che è stata senza dubbio il principale ostacolo alla modernizzazione oltre che un terreno fertile per la “cultura mafiosa” e clientelare. Il pessimismo puro, sia chiaro, non è per se stesso foriero dell’ordine po-litico autocratico o totalitario. Nessun contributo, infatti, è venuto dal-la Sicilia né al fascismo né al comunismo, il che eventualmente è pro-va ulteriore della atavica diffidenza siciliana (terra di conquista, trop-po spesso) nei confronti dei cambiamenti radicali di cui si è scritto. Un
Premessa 19
certo pessimismo, ancor più dell’ottimismo puro, è anzi alla radice della mentalità liberale, la quale non diffida solo del potere ma anche della capacità degli uomini di perseguire disinteressatamente il cosid-detto bene comune o la piena reciproca solidarietà.
La linea pessimistica, anti–moderna e profondamente diffidente nei confronti di ogni cambiamento, si snoda in Sicilia, dopo l’Unità d’Ita-lia, da Verga a Sciascia passando attraverso De Roberto, Pirandello e naturalmente Tomasi di Lampedusa. Per questa ragione mi è parso giusto abbinare alla monografia su Verga quella su Quasimodo: Qua-simodo non ha certo la statura del conterraneo e neppure la straordina-ria virtù profetica di questo, che è propria appunto dei grandissimi. Egli rappresenta però una corda profonda dell’anima siciliana, una corda gentile, costruttiva ancorché in bilico tra la retorica passatista della celebrazione di antiche grandezze e la fiducia nella possibilità (della poesia, nella fattispecie) di “costruire”, cioè di migliorare mo-ralmente l’uomo. Peraltro la celebrazione delle antiche grandezze fa parte assai più della biografia mitizzata del poeta, delle interviste, del-le dichiarazioni da lui rilasciate che non della sostanza della sua poesia matura.
In Quasimodo, nella sua mentalità di uomo e poeta faber, nella sua capacità di non lasciarsi mai attrarre dal pessimismo puro, sta l’altra Sicilia, la Sicilia dei più, ricca essa pure di contraddizioni e tuttavia ricca soprattutto di affetti che generano operosità, sacrifici costruttivi, lavoro duro e tenace attaccamento a esso e ai suoi frutti. Quasimodo non porge alcun appiglio ai fautori della diffidenza nei confronti del cambiamento; fortissimo è in lui non solo il sentimento del valore del-la vita umana e quello della pari dignità di ogni uomo, ma anche l’ane-lito alla costruzione di una vita di cui tali valori siano principi propul-sivi. I frutti del lavoro, di cui dianzi si parlava, non sono solo “la roba” alla Mazzarò (pure “la roba”, certo, l’accumulazione, al Sud come al Nord): sono anche opere d’amore, valorizzazione non selvaggia di tut-te le risorse dell’isola e perciò cultura e innalzamento di civiltà.
Nondimeno Quasimodo sa e propugna che il compito del poeta è di far poesia, che la poesia, se è poesia, è anche dignità umana e che un mondo in cui la poesia e l’arte non siano sentite come beni supremi e irrinunciabili non sarà più un mondo vivibile per l’uomo. La parola poetica crea un uomo e un mondo migliori: questa verità apparente-
Premessa 20
mente tanto banale va oggi riscoperta e propugnata più intensamente che mai. La parola poetica ha trovato e trova allora in Sicilia, effetti-vamente, un humus particolarmente fertile. La Sicilia, dunque, non è Verga e basta; e non è riconducibile alla linea Verga De Roberto
Pirandello Lampedusa Sciascia, grandi che siano i primi due autori e colossale addirittura il terzo. Il contraddittorio peculiare con-tributo della Sicilia alla costruzione del mondo moderno si deve legge-re su una retta che includa come suoi punti sia Verga che Quasimodo.
Tutta la parte prima del volume, e non solo il capitolo III di essa, è stata redatta grazie a Thomas Mann. Ho già dimostrato in altri lavori che il sommo scrittore tedesco si imbatté nella narrativa verghiana ambientata nel gran mondo; non a torto, essa gli parve goffa e comple-tamente priva di quella sobrietà ironica nella quale il prossimo autore di Tonio Kröger scorgeva la cifra della letteratura di gran classe. Così Mann si divertì a deridere nelle sue novelle precedenti la stesura dei Buddenbrook sia i contenuti sia aspetti dello stile e della tecnica com-positiva propri dei romanzi verghiani fiorentino–milanesi. D’altro can-to, frequentando, com’è ovvio, la letteratura europea degli anni prece-denti il proprio esordio, Mann si avvide dell’influenza esercitata da Flaubert su Turgenev e da entrambi questi autori su Verga. La circola-zione di nuclei tematici o anche di movenze relativamente semplici dall’uno all’altro autore Verga essendo beninteso l’ultimo, crono-logicamente, della triade (ma in questa vicenda è implicato anche, in grazia della Dame aux camélias, Alexandre Dumas figlio) stimolò Mann a compiere quei giochi d’indole intertestuale quasi prodigiosi, dei quali credo egli sia rimasto l’artefice inarrivabile. Chi scrive, leg-gendo sulla scia di Mann le opere di Flaubert e di Turgenev (e in su-bordine anche il più noto romanzo di A. Dumas figlio) più apprezzate da Verga, ha trovato e dato conto, ovviamente, di diverse situazioni e reminiscenze, da Mann trascurate, le quali trapassano direttamente da Flaubert in Verga e da Turgenev in Verga.
Lo scrittore tedesco, mentre rifaceva con sarcasmo il verso alla prosa enfatica del Verga di Eva e del Marito di Elena, si divertì a in-castonare nelle sue novelle tutte o quasi le reminiscenze di Flaubert in Turgenev che Verga ricontestualizza nell’opera propria. Si crea così nelle novelle di Mann (der Zauberer: il mago dell’ambiguità espressi-va in ogni sua forma) una stratificazione giocosa e ben mascherata G.
Premessa 21
Flaubert I. S. Turgenev G. Verga T. Mann. Queste risonanze sono qualche volta oppure sovente banali e insipide, perché nell’ulti-mo trentennio dell’Ottocento erano entrate a far parte dell’arma-mentario più tipico dell’esotismo tardo–romantico, e tuttavia Mann sa rivitalizzarle magistralmente e con sarcasmo feroce. Di esse ho già trattato altrove; spero tuttavia di riuscire a portare a termine la mia ri-cerca sulla letteratura italiana in T. Mann e di dar loro ulteriore siste-mazione nella speciale monografia sull’argomento. Per essere precisi, mi sono applicata allo studio di Verga, all’incirca a partire dal 1998, solo dopo essermi resa conto che il giovane Mann aveva tratto impul-so creativo rilevante dalla lettura della narrativa verghiana. Dell’in-fluenza di altra importante letteratura italiana su Mann, a prescindere da Nievo e da D’Annunzio, ho ancora da scrivere. Il mio primo obiet-tivo è stato di rendermi sufficientemente esperta dell’autore siciliano, al fine di poter tracciare il parallelo tra le opere sue che hanno im-presso in quelle di Mann un’orma relativamente profonda e le opere di questo che in Verga hanno variamente trovato ispirazione e alimento.
Mann studiò dunque con grande attenzione le opere di Verga che facevano al caso suo e parallelamente lesse parecchia altra letteratura italiana della quale si avverte traccia cospicua nella sua produzione giovanile, arrivando tra l’altro a notare reminiscenze verghiane utiliz-zate da G. D’Annunzio nei propri romanzi; lo scrittore tedesco si compiacque naturalmente di contaminare per i suoi giochi espressivi i segmenti di testo verghiani con i corrispettivi tratti dannunziani. Se-nonché dalla lettura della produzione verghiana ambientata nel mondo elegante fu giocoforza, fu cioè naturale per uno scrittore giovane, cu-rioso e dal grande talento, di passare alla lettura della produzione ver-ghiana verista. Non sarebbe giusto parlare di coup de foudre: Mann ha sempre amato farsi sentire ironico, distaccato, compassato e anche o-stile nei confronti della letteratura, propria e altrui. Enunciando con la dovuta freddezza e la dovuta distanza ciò che accadde basti dire che due opere appartenenti al primo verismo verghiano, Rosso Malpelo e I Malavoglia, sono tra i testi che stanno all’origine dei Buddenbrook. È parso non pure opportuno ma anzi doveroso raccontare brevemente nel presente volume, per l’esattezza nel capitolo III della prima parte, la strutturazione espressiva di questo momento della letteratura euro-pea di fine Ottocento.
Premessa 22
Mi corre l’obbligo di dichiarare che senza il sostegno e l’aiuto della collega Paola Bozzi, del Dipartimento di Germanistica della Universi-tà degli Studi di Milano non sarei riuscita a cominciare la mia ricerca su T. Mann e Verga.
Alcuni capitoli del presente volume erano stati anticipati, o pubbli-
cati parzialmente, spesso in veste diversa, come articoli su rivista, e segnatamente: nella Parte prima un frammento minimo del capitolo I, dal titolo Echi di Madame Bovary in Verga, con una questione di da-tazione, è stato letto al X Congresso dell’ADI, in Portogiardino di Ba-ri, 12–16 settembre 2006, pubblicato negli Atti, Lecce, Pensa 2008; il capitolo II costituisce la rielaborazione, assai sviluppata, dell’articolo Echi di Turgenev in Verga, pubbl. su «Italianistica», XXXVI, 1–2, 2007, pp. 113–120; il capitolo III trae spunto lontano dalla comunica-zione, inedita, Le manipolazioni di Antonio. La narrativa verista di Verga e I Buddenbrook, letta al Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche, Pisa, 31 maggio–1° giugno 2007; nel presente volume ci si è però allontanati dal terreno dell’onomastica per studiare in pa-rallelo I Buddenbrook e la narrativa italiana e soprattutto verghiana a essi sottesa. Nella Parte seconda: il capitolo I riproduce abbastanza fe-delmente l’articolo Ancora sulle stampe di Rosso Malpelo, pubbl. sul-la «Rivista di letteratura italiana», XXII, n. 1, 2004, pp. 157–184. Il capitolo II e le due postille sono inediti. Parte terza: il capitolo I è ine-dito; il capitolo II si riallaccia al saggio La centralità di Dante in Qua-simodo. Una interpretazione finora mai adombrata della quasimodia-na prima epoca, su «Italianistica», XXXIV, n. 1, 2005, pp. 11–32, del quale costituisce per un verso un rifacimento e per altro verso la pro-secuzione.
25
Capitolo I
Echi di Madame Bovary in Verga, con una questione di datazione
1. Verga lesse Madame Bovary tra la fine del 1873 e gli inizi del 1874?
Gli interventi critici dedicati all’influenza di Gustave Flaubert su
Verga sono relativamente numerosi1. Ripercorrendoli si vede che sono animati essenzialmente da tre ordini di interessi2: quello volto a scan-
1Abbreviazioni e sigle: Eva: G. VERGA, Eva, in G. V., Tutti i romanzi, a cura di E. Ghidet-
ti, Firenze, Sansoni 1983, vol. II; Eros: G. V., Eros, ibidem; TR: Tigre reale II, edizione criti-ca a cura di M. Spampinato Beretta, Firenze, Le Monnier 1993 (Edizione Nazionale delle ope-re di Giovanni Verga, vol. VI); Mal: G. V., I Malavoglia, (pubbl. nel febbraio 1881 e precedu-to dalla pubblicazione, nel gennaio 1881, di un solo episodio sulla «Nuova Antologia»), edi-zione critica a cura di F. Cecco, Milano, Edizioni Il Polifilo 1995; MdE: G. V., Il marito di Elena, in Id., Tutti i romanzi, cit., vol. III; Cd: G. V., La chiave d’oro, (1883), in Id., Tutte le novelle, Introduzione di C. Riccardi, Milano, Mondadori 1997 (XIV ristampa Oscar classici), vol. II; MB: G. FLAUBERT, Madame Bovary, (1857), Préface et Notice de M. Nadeau, Paris, Gallimard 1972; ÉS: G. F., L’Éducation sentimentale, (1869–1870), Préface d’A. Thibaudet, Notice et notes de S. de Sacy, Paris, Gallimard 2005; CartVC: Carteggio Verga–Capuana, a cura di G. Raja, Roma, Edizioni dell’Ateneo 1984.
2 Bibliografia essenziale: P. ARRIGHI, Le vérisme dans la prose narrative italienne, Paris, Boivin & Cie 1937; R. RAMAT, Etica e poesia nei romanzi giovanili del Verga, (1933), in Id., Ragionamenti morali e letterari, Città di Castello, Macrì 1985, pp. 43–87; V. LUGLI, Lo stile indiretto libero in Flaubert e in Verga, in Id., Dante e Balzac, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane 1952, pp. 221–239 e V. L., Bovary italiane, in Id., Bovary italiane ed altri saggi, Cal-tanissetta–Roma, Sciascia 1959, pp. 19–25; G. RAGONESE, Verga e Flaubert, (1940), in Id., Interpretazione del Verga. Saggi e ricerche, Palermo, Manfredi 1965, pp. 110–136 e G. R., L’epilogo de «I Malavoglia» e l’epilogo di «Madame Bovary», (1981), in Id., Da Manzoni a Fogazzaro, Palermo, s. e. (stampato nell’ottobre 1983 dalla Società Grafica Artigiana s. n. c., via Remo Sandròn 5, Palermo), pp. 111–142; A. MOMIGLIANO, Giovanni Verga narratore, in Id., Dante, Manzoni, Verga, Messina–Firenze, D’Anna 1955, pp. 213–274 (è uno studio anco-ra importante perché Momigliano, forse unico tra gli studiosi insigni, pronunzia giudizi limi-tativi, assai discutibili e assai intelligenti, intorno alla tecnica compositiva del Verga verista:
PARTE PRIMA – Giovanni Verga e la letteratura europea
26
dagliare le tappe della speciale elaborazione verghiana del discorso indiretto libero; quello che oggi si direbbe narratologico e che si va in-corporando il primo (Verga apprenderebbe in larga misura da MB la tecnica consistente nella pluralità e alternanza delle voci narranti); il terzo ordine di interessi, più tradizionale e artigianale, consiste nell’affastellamento e nello studio delle affinità in senso lato temati-che. Ovviamente le tre questioni sono correlate in maniera organica, ma il presente studio è guidato prevalentemente dall’ultimo ordine di interessi.
Fino a oggi il momento a partire dal quale Verga ebbe sicuramente tra le mani MB era parso oscillare tra gli ultimi giorni del 1873 e i primi giorni di gennaio del 1874. Questa persuasione era fondata su due lettere di Verga a Capuana.
Nell’una, da Catania, datata 14 dicembre 1873, Verga prega l’amico di inviargli Il tesoro di Donnina e i volumi di Balzac (senza specificare quali: CartVC, p. 28)3. Con la successiva lettera da Cata-nia, del 14 gennaio 1874, Verga rimanda a Capuana «Madame Bovary e Donnina»; loda la magistrale sorveglianza stilistica di Flaubert; ma avanza severe riserve sul sensualismo puro di cui sarebbe a parer suo impregnato il realismo del romanzo francese (ivi, p. 29).
cfr. in particolare le pp. 268–274); G. BERARDI, Mito dei primitivi e coerenza storica in «Ti-gre reale», «Studi letterari» pubblicazioni del Collegio Ghislieri in Pavia, s. II, vol. II, 1957, pp. 344–383; I. FRANGES, La critica stilistica ed il barocco letterario, in Aa.Vv., Atti del se-condo Congresso Internazionale di Studi Italiani, Firenze, Le Monnier 1958, pp. 104–120; M. DILLON WANKE, Il marito di Elena ovvero dell’ambiguità, «Sigma», X (1977), n. 1–2, pp. 113–136; L. FAVA GUZZETTA, La difficile collocazione del «Marito di Elena» in Ead., La ma-no invisibile. Costruzione del racconto nel Verga “Minore”, Soveria Mannelli (Catanzaro), Rubbettino 1981, pp. 67–94, L. F. G., Flaubert e Verga, in Quaderno verghiano. Appunti di analisi narratologica, Messina, Edizioni del «Prometeo» 1984, pp. 5–30 e EAD., Verga tra Manzoni e Flaubert, «Lettere italiane», XLI (1989), n. 3, pp. 334–355; AA.VV., Famiglia e società nell'opera di G. Verga, a cura di N. Cacciaglia, A. Neiger, R. Pavese, Firenze, Olschki 1991 (Atti del Convegno nazionale, Perugia, 25–26–27 ottobre 1989); L. Sozzi, De Flaubert à Verga: la poétique de l’impersonnalité, in Aa.Vv., Attualità dell’antico. 3, a cura di M. G. Vecchini, Aosta, Tipografia valdostana 1992, pp. 257–266; A. DI BENEDETTO, Flaubert in Verga, (1981), in Id., Verga, D’Annunzio, Pirandello. Studi e frammenti critici, Fògola Edito-re, Torino 1994, pp. 13–32; M. MUSCARIELLO, Percorsi del bovarismo in Verga, (1994), in Ead., Gli inganni della scienza. Percorsi verghiani, Napoli, Liguori 2001, pp. 99–113; B. ANGLANI, Con gli occhi della mente. Verga tra Zola e Flaubert, «Studi francesi», XLVIII (2004), fasc. I, pp. 33–53.
3 Per una lieve svista Verga scrive Il segreto di Donnina in luogo di Il tesoro di Donnina, l’allora noto romanzo di S. FARINA, Milano, Tipografia Editrice Lombarda 1873.
CAPITOLO I – Echi di Madame Bovary in Verga 27
Dalle due lettere si desume in modo certo solo che Capuana inviò all’amico alla fine del 1873 Il tesoro di Donnina. A metà dicembre Verga non aveva chiesto MB. Lionello Sozzi e lui soltanto tra tutti coloro che hanno studiato la questione “Flaubert in Verga” dal 1940 in poi riporta in un suo saggio del 1992 un ampio stralcio di un’altra lettera di Capuana a Verga. È la lettera con cui Capuana accompagna l’invio del proprio esemplare di MB4. Sozzi però non indica né la data né il luogo di collocazione di codesta lettera. Quasi certamente Verga, dunque, ricevette MB prima della metà di dicembre e lo restituì poi in-sieme al Tesoro di Donnina. La lettera di Capuana non è stata inserita e neppure menzionata da Gino Raya nel CartVC. Ho parlato con Soz-zi; egli, molto cortesemente, ha frugato tra le sue carte, ma non ha ri-trovato le fotocopie o gli appunti desiderati. Egli mi ha dato però al-cuni suggerimenti per ritrovare la lettera5. Non sono riuscita a conse-guire tale scopo per la comunicazione dal titolo Qualcosa su Madame Bovary nella narrativa verghiana da me letta al Congresso dell’ADI in Portogiardino di Bari, 13–16 settembre 2006, ove ho potuto solo dare notizia della lacuna, ravvisata appunto mentre preparavo il mio testo. Successivamente sono riuscita a risalire al tassello mancante. Tale tassello, come prevedevo, non riserva sorprese6. Sozzi nel proprio
4 «Il [Capuana] l’avait accompagné [MB] d’une lettre dans laquelle on lit, entre autre: “Mi
dispiacciono in Madame Bovary le minutezze esteriori, quello che dicono realismo ed è realtà giacché mi sembra che tra queste due parole ci sia una bella differenza. Il realismo mi pare che dovrebbe essere la realtà un poco idealizzata, cioè la realtà che deve entrare nel dominio dell’arte senza che possa far dire: è di troppo. Troverai nel volume sottolineate tutte le cose minute, guardate per così dire con la lente”» (L. SOZZI, op. cit., p. 263).
5 Sozzi mi ha consigliato, in particolare, di riscontrare la Storia de “I Malavoglia”, pub-blicata in due puntate da Lina e Vito Perroni sulla «Nuova Antologia» nel 1940. L. PERRONI e V. PERRONI, Storia de “I Malavoglia”, «Nuova Antologia», CDVIII–(marzo–aprile) 1940, fasc. 1632 (16 marzo), pp. 105–131 e «Nuova Antologia», CDVIII–(marzo–aprile) 1940, fasc. 1633 (primo aprile), pp. 237–251: trattasi di un gruppo di lettere di Giovanni Verga a Emilio Treves e a Luigi Capuana (assai più cospicuo il carteggio con questo secondo corrispondente) scritte tra il 21 settembre 1875 e il settembre del 1882, cui si aggiunge una lettera senza data, scritta alla fine di un anno imprecisato, che contiene auguri per l’anno nuovo e saluti per la Signora Ada. Le lettere sono commentate dai Perroni e in entrambe le puntate esse sono pre-cedute da una premessa dei curatori (pp. 105–110 nel fasc. 1632 del 16 marzo e p. 237 nel fasc. 1633 del primo aprile).
6 Lionello Sozzi mi ha spiegato che il suo testo De Flaubert à Verga è privo di note per-ché, come suole accadere, la curatrice e l’editore avevano gran fretta di fare uscire gli Atti del congresso; l’insigne studioso è stato pertanto pregato di consegnare il testo ch’egli aveva letto così com’era, senza note, la redazione delle quali avrebbe richiesto qualche tempo. Se Sozzi,
PARTE PRIMA – Giovanni Verga e la letteratura europea 28
articolo ha raggruppato, come se si trattasse di un breve blocco episto-lare unico, tre delle quattro citazioni tolte da Lina Perroni a una lettera di Capuana a Verga; citazioni dalla Perroni riferite in un suo articolo dal titolo Verga, Flaubert, Brunetière (con una lettera inedita di G. Verga), comparso nel mensile «Lunario Siciliano» nell’aprile del 19297. La Perroni non riporta la data della lettera di Capuana; la lettera di Verga, da lei pubblicata per la prima volta, integralmente e con da-ta, è quella del 14 gennaio 1874. Sulla effettiva esistenza della lettera di Capuana, invece, null’altro per ora possediamo che la predetta te-stimonianza della Perroni. Naturalmente è da auspicare che quest’ul-tima lettera venga ritrovata, perché potrebbe forse donare lumi, fiochi o vividi che siano, per la datazione del momento a partire dal quale, con sicurezza, Verga ebbe tra le mani il capolavoro di Flaubert. De hoc satis; occorre adesso procedere oltre.
studioso espertissimo, acuto e rigoroso, avesse avuto tra le mani la missiva originale, e datata, con cui Capuana accompagnava l’invio di MB a Verga, non avrebbe certo omesso di riferirne la data; peraltro una eventuale distanza temporale rilevante e accertata tra l’invio del romanzo di Flaubert a Verga e la restituzione del volume a Capuana avrebbe avuto ripercussioni sulla interpretazione dello stesso Sozzi.
7 «Lunario siciliano», Periodico letterario, Roma, aprile 1929, VII [anno II. Numero 1]. Il mensile ha un formato da giornale o da gazzetta da due fogli; il fascicolo succitato è monogra-fico e ha come tema (riportato in alto a grandi lettere): Il caso Verga. Contiene interventi di Ardengo Soffici, Emilio Cecchi, Camillo Pellizzi, Aurelio Navarria, Silvio D’Amico, Rodolfo De Mattei e Lina Perroni, oltre a brevi lettere al direttore di Riccardo Bacchelli, Corrado Pa-volini, Berto Ricci e altri. Il catalogo nazionale on line dei periodici contiene informazioni er-rate circa l’ubicazione di questo mensile divenuto rarissimo. Irreperibile nelle Biblioteche si-ciliane e in quelle dell’Italia centro–settentrionale, il «Lunario siciliano», per fortuna in ottime condizioni, si trova nella Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. Riferisco, restituendo loro la esatta punteggiatura, le quattro citazioni dalla lettera di Capuana recate da Lina Perroni: «Quello del Flaubert è un gran libro»; «mi dispiacciono in esso le minutezze esteriori, quello che dicono realismo ed è realtà; giacché mi sembra che tra queste due parole ci sia una bella differenza»; «Il realismo mi pare dovrebbe essere la realtà un poco idealizzata cioè la realtà che deve entrare nel dominio dell’arte senza che possa far dire: è di troppo!»; «Troverai infatti nel volume sottolineate tutte le cose minute guardate per dir così, colla lente, e segnate di fianco le cose che mi paiono notevoli e belle. Dimmi se saremo d’accordo. Del resto troverai cose stupende, ed una larghezza di linee che dà quasi nell’epico». La Perroni rinvia a questo suo articolo dell’aprile 1929 sul « Lunario siciliano» nella nota 1, p. 237 della premessa alla seconda puntata della succitata Storia de “I Malavoglia”. Ampi stralci dell’articolo della Per-roni sul «Lunario siciliano» vennero poco dopo pubblicati, con il titolo Verga, Flaubert, Bru-netière sul «Giornale dell’isola», Catania, 24 aprile 1929 e su «L’Ora», Palermo, 8 maggio 1929 (l’articolo sull’«Ora», da me consultato nella biblioteca ex Nazionale e ora Regionale Centrale di Palermo è firmato dalla medesima studiosa; vi sono riportate le prime tre citazioni dalla lettera di Capuana riferite nel «Lunario»).
CAPITOLO I – Echi di Madame Bovary in Verga
29
2. Madame Bovary e La chiave d’oro
Nella citata missiva del 14 gennaio 1874 Verga scrive, a esemplifi-cazione della scettica e quasi cinica impassibilità di Flaubert (la voce narrante veniva dallo scrittore italiano senz’altro identificata con la concreta, empirica personalità dello scrittore francese): «Due righe del libro, quando il giovane dello speziale va a piangere sulla tomba della Bovary, ed il sacrestano sait à quoi s’en tenir sur le vol des choux rie-pilogano forse meglio di altro il pensiero francese di cui il Flaubert personifica tutte le debolezze di oggi» (CartVC, p. 29). Poi Verga scrive Fanny invece di Emma e subito aggiunge l’inciso: « si chia-ma così? »; quindi chiede all’amico se egli ricordi il tratto in cui la donna adultera «pensando a Léon, in una notte insonne si rivolta pel letto, e messasi supina, si stira le braccia?» (ibidem). Come ha notato Lionello Sozzi la prima reminiscenza è inesatta, poiché in MB (p. 430) si legge invece che «Lestiboudois […] sut alors à quoi s’en tenir sur le malfaiteur qui lui dérobait ses pommes de terre». La seconda remini-scenza non si trova né in MB né nella Fanny di Ernest Feydeau. Sozzi ritiene che codeste sviste denotino «Confusion, bien sûr, mais volonté inconsciente, aussi, sans doute, de se montrer peu attiré, peu entraîné, par un roman qui cause à Verga quelques problèmes: on fait semblant d’oublier ou de confondre, parfois, le nom des personnes qu’on n’aime pas ou qui nous causent de la gêne»8. Quelli di Verga non sono meri errori di distrazione, questo è certo. Mi trova d’accordo anche l’opinione che Verga ora e sempre, non solo dopo la prima lettura di MB «fait preuve d’incompréhension vis-a-vis des passions d’Emma, de son insatisfaction perpétuelle, de la véritable nature de ses désirs». Tuttavia non mi pare molto probabile che nel giro di anni in cui scriveva Eva, TR, Eros, Verga respingesse Emma, per una sorta di meccanismo di rimozione, quasi impedendole di entrare in modo cosciente e criticamente riflesso nel proprio patrimonio culturale, per-fino come creatura e personaggio che desta repulsione.
In Eva, in TR, in Eros, Verga narra e descrive basandosi emi-nentemente su modelli francesi ma non su di essi soltanto, come ve-dremo nel capitolo successivo , la vita delle maliarde del demi–
8 L. SOZZI, op. cit., p. 265. Il corsivo nella prima citazione riferita nel testo è in CartVC.
PARTE PRIMA – Giovanni Verga e la letteratura europea
30
monde e delle adultere del gran mondo a queste donne ostinata-mente negando, a differenza di Alexandre Dumas figlio e anche di Giuseppe Verdi ogni possibilità di positiva maturazione etica e di redenzione grazie ad amore vero. Emma gli appare forse come una nuova forma della temuta, pericolosa e irredimibile sensualità femmi-nile che si oppone al modello positivo di donna riconducibile al siste-ma di valori fondato sulla famiglia al cui centro si trovi la coppia di coniugi, e quindi sulla maternità e le cure femminili per mariti, figli, nipoti e casa. Cesare, in MdE, vendicherà anche Charles Bovary. Si prendano in considerazione di nuovo, brevemente, le sviste contenute nella lettera a Capuana del 14 gennaio 1874. I giudizi di Sozzi citati all’inizio del presente studio sono fondati sull’idea che la lettura di MB, alla data suddetta, fosse molto recente o recentissima. Ma di ciò non esistono prove certe. Quelle sviste sono sì spia di una lettura di MB alquanto affrettata, ma forse anche, chissà, già abbastanza distante nel tempo rispetto al momento della restituzione a Capuana della co-pia da questo inviata in prestito. Di più: la seconda reminiscenza, in effetti inesistente così come la porge Verga, è tuttavia riconoscibile. Vi si riconosce la deformazione, senza dubbio assai forte, dell’unico luogo di MB in cui Emma, nelle notti insonni in camera sua, nella casa coniugale, sogna l’amore, fa reagire il proprio corpo e i propri sensi dilatati alle carezze della natura notturna, e pensa a Léon9. Quanto alla prima reminiscenza, da Sozzi giustamente dichiarata inesatta, essa non è il frutto di una lettura distratta di MB, e neppure di una lettura im-prontata ad antipatia. Si rilegga per esteso il tratto del romanzo di Flaubert cui Verga si riferisce:
Sur la fosse, entre les sapins, un enfant pleurait agenouillé, et sa poitrine, bri-sée par les sanglots, haletait dans l’ombre, sous la pression d’un regret im-mense, plus doux que la lune et plus insondabile que la nuit. La grille tout à coup craqua. C’était Lestiboudois; il venait chercher sa bêche qu’il avait ou-bliée tantôt. Il reconnut Justin escaladant le mur, et sut alors à quoi s’en tenir sur le malfaiteur qui lui dérobait ses pommes de terre. (MB, p. 430)
9 «Ou, d’autres fois, brûlée plus fort par cette flamme intime que l’adultère avivait, hale-
tante, émue, tout en désir, elle ouvrait sa fenêtre, aspirait l’air froid, éparpillait au vent sa che-velure trop lourde, et, regardant les étoiles, souhaitait des amours de prince. Elle pensait à lui, à Léon. Elle eût alors tout donné pour un seul de ces rendez–vous, qui la rassasiaient» (MB, p. 369).
CAPITOLO I – Echi di Madame Bovary in Verga 31
Lestiboudois, becchino e custode del cimitero, oltre che sacrestano, aveva seminato patate in una porzione di terreno del cimitero origina-riamente quasi vuota di tombe, tanto che « Vous vous nourrissez des morts, Lestiboudois! Lui dit enfin, un jour, M. le curé» (MB, p. 111). Verga scambia le patate per cavoli, non c’è dubbio, ma trattasi di svista o amnesia “veniale”. Il giudizio verghiano per cui alla rea-zione di Lestiboudois e ai suoi pensieri sono sottesi solo cinismo e cu-pido desiderio di salvaguardare ciò che colui ritiene appartenergli (le patate) è esatto. Trattasi di un cinismo e di una cupidigia che alcuni anni dopo contrassegneranno, nei Malavoglia, ogni pensiero, parola e opera di personaggi come lo zio Crocifisso e il sensale Piedipapera. L’errore di valutazione di Verga è d’altra natura ed è duplice: consiste per un verso nell’attribuire senz’altro alla persona concreta di Flaubert una sensibilità affine a quella di Lestiboudois; per l’altro verso nel non riconoscere che la cupidigia e il cinismo di Lestiboudois trovano e-spressione e spicco potenti per contrasto, perché cozzano con il dolore profondo, spontaneo, lacerante del giovanissimo Justin, un dolore del tutto disinteressato, se mi si passa la formula. Tuttavia, mentre Verga mette per iscritto a Capuana quel giudizio tanto parziale, la sua perso-nalità poetica prende ad accarezzare e coltivare lo spunto flaubertiano.
Il frutto più pregevole di quel lavorìo e le patate resteranno per sempre cavoli sarà la novella Cd, che fa parte della raccolta Vaga-bondaggio, ma si collega idealmente (per la lingua, lo stile e la menta-lità che vi è sottesa) alle Rusticane (1882–1883)10: il Canonico, al fine di salvaguardare la propria roba ha assunto come guardiano delle sue proprietà il feroce Surfareddu. Questi, una sera dopo cena, sorprende nel frutteto alcuni ladruncoli e, rispondendo a una loro schioppettata, spara, ferendone gravemente uno. Tutti odono i colpi di schioppo. Il campiere si presenta subito al Canonico e gli racconta l’accaduto. Il Canonico intima a Surfareddu di mettersi in salvo e sebbene questi abbia detto che l’uomo ferito quasi certamente è vivo , il Canonico rimane barricato in casa fino al mattino insieme alle donne con le qua-li stava recitando il rosario al momento della sparatoria. Al mattino il
10 Già edita nel «Momento letterario, artistico, sociale», Palermo, 31 luglio 1883 e l’11
novembre nella «Domenica letteraria». CD fu poi inserita nella raccolta di novelle G. VERGA, Drammi intimi, Roma, Sommaruga 1887.
PARTE PRIMA – Giovanni Verga e la letteratura europea 32
Canonico, accompagnato dalla sua gente, si reca nel frutteto ove trova il ladruncolo ancora vivo e agonizzante; i complici di questo lo hanno abbandonato, ma hanno portato via con sé i sacchi pieni di frutta ruba-ta. Il Canonico impartisce al ladruncolo la benedizione e questi muore dissanguato. L’uccisore viene rimesso molto presto in libertà, mentre «nel frutteto, sotto l’albero vecchio dove è sepolto il ladro delle ulive, vengono cavoli grossi come teste di bambini» (ivi, p. 438).
In luogo del modesto e affettivamente arido becchino e sagrestano di MB vi è qui un Canonico cupido della “roba”, spietato e moralmen-te responsabile di omicidio. Verga ha creato un bozzetto magnifico ma privo, diversamente che in MB, di chiaroscuri e perfino di manichei-smo etico elementare: vi sono in esso solo persone o malvagie o com-plici dei malvagi; il tipo opposto non c’è. L’effetto perseguito si limita al paradosso topico per cui “il più cattivo” è colui che dovrebbe inse-gnare agli altri la carità, la fede, la speranza e di esse dare testimonian-za esemplare o almeno concreta. Codesto pessimismo assoluto conse-gue magistralmente, nel caso specifico, lo scopo di suscitare l’orrore del lettore e la sua pietà nei confronti del ladruncolo. Nondimeno, la maestria con cui Flaubert fa scaturire, dal luogo che si è tolto a esame, il contrasto tra patetica gentilezza dei sentimenti e cinismo puro ha profondamente e indelebilmente impressionato lo scrittore italiano, e questi consegue talvolta nella narrativa verista di ambiente siciliano e popolare effetti analoghi mediante procedimenti analoghi11. Egli ri-
11 Nel luogo citato di MB si trascorre bruscamente dal punto di vista della voce narrante
che descrive in maniera partecipe («sous la pression d’un regret immense») il dolore stra-ziante di Justin e che qui lascia trasparire la presenza dell’autore implicito, lontanissimo dalla impassibilità e dall’atteggiamento volterrianamente sarcastico tipici del narratore flaubertiano in MB a quello di Lestiboudois. Rosso Malpelo è probabilmente il racconto in cui Verga mette per la prima volta a frutto, nella tecnica compositiva e narrativa, la le-zione congiunta di Voltaire e di Flaubert. Esso è scritto per antifrasi, alla Candide, e sebbe-ne la voce narrante sia quella, pseudo–popolare, di un coro che coincide con tutta la comu-nità paesana cui Malpelo era appartenuto, si registrano nel racconto diversi inserti di indi-retto libero, trapassi dal punto di vista della voce narrante a quello di Malpelo e intrusioni dell’autore implicito.«Per un raffinamento di malignità [Malpelo, N.d.A.] sembrava aver preso a proteggere un povero ragazzetto, venuto a lavorare da poco tempo nella cava, il quale per una caduta da un ponte s’era lussato il femore, e non poteva far più il manovale. Il poveretto […] arrancava […], così che gli avevano messo nome Ranocchio; ma lavoran-do sotterra, così ranocchio com’era, il suo pane se lo buscava; e Malpelo gliene dava anche del suo, per prendersi il gusto di tiranneggiarlo, dicevano». Il narratore pseudo–popolare, ostile a Malpelo, ritiene che Malpelo sia di sostegno a Ranocchio non per affetto vero ma
CAPITOLO I – Echi di Madame Bovary in Verga
33
nunzia in Cd a quei procedimenti narrativi, eppure sente il bisogno di prendere esplicitamente le distanze, in quanto autore implicito, dalla insensibilità spietata di tutti i personaggi del bozzetto e dalla impassi-bilità della voce narrante.
Egli raggiunge tale fine in due modi, uno dei quali è sommamente efficace mentre l’altro pare a me espressivamente stiracchiato. Stirac-chiato è l’espediente di inserire tra i personaggi una figura di fanciullo ancora “innocente”, le reazioni emotive del quale si vorrebbe far con-trastare in modo spiccato con quelle di tutti gli altri. Oltre all’ombra di Lestiboudois è introdotta nel bozzetto anche l’ombra di Justin. Il detto contrasto non si crea, da un lato perché il fanciullo è mosso eminen-temente da curiosità morbosa e dall’altro perché lo spettacolo scon-volgente non produce in lui alcun effetto catartico, neppure velato: al mattino, «appena fuori del cortile si trovarono fra i piedi Luigino, che era sgattaiolato tra la gente. portate via questo ragazzo gridò lo zio canonico. No! Voglio vedere anche io! strillava costui. E do-po, finché visse, gli rimase impresso in mente lo spettacolo che aveva avuto sotto gli occhi così piccolo» (Cd, p. 436). Sommamente efficace è invece il fatto di fare pronunziare al moribondo, nelle ultime, ele-mentari e strozzate parole che questi rivolge agli astanti, un giudizio etico di implicita radicale condanna del male che è stato commesso: « Ah! Signor canonico biascicò il moribondo. Per quattro uli-ve m’hanno ammazzato!» (ivi, p. 437).
3. Aspetti dell’influenza di Flaubert sull’intera narrativa verghiana
Il romanzo Eva, che Verga aveva iniziato a scrivere nel 1869, uscì nell’estate del 1873. Parallelamente, nello stesso 1873, Verga lavo-
per una sottile forma di cattiveria: il contrasto tra l’atteggiamento crudele del narratore e l’agire di Malpelo induce il lettore a simpatizzare intensamente con quest’ultimo; fa capoli-no anche l’autore implicito, che prende quasi insensibilmente le distanze dalla comunità e dal coro dei compaesani («dicevano»): G. VERGA, Rosso Malpelo, (1878), in Id., Tutte le novelle, cit., vol. I, p. 167. Per approfondimenti cfr. il primo capitolo (Reminiscenze dante-sche in Rosso Malpelo) del mio vol. Dai suoni al simbolo. Memoria poetica, relazioni ana-logiche, fonosimbolismo in Giovanni Verga dalle opere ultra–romantiche a quelle veriste, Pisa–Roma, Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali 2002, p. 38.
PARTE PRIMA – Giovanni Verga e la letteratura europea 34
rava ai due romanzi TR e Eros (inizialmente intitolato Aporeo). En-trambi questi romanzi uscirono nel 1875. È in essi due che gli stu-diosi della questione “Flaubert in Verga” sono proclivi a rintracciare i primi indizi sicuri della efficacia della lezione flaubertiana: sia per la presenza di echi tematici che per l’insinuarsi del metodo della im-personalità tra narratore e personaggio. In Eros si avvertirebbe in particolare l’influenza di MB; in TR si avvertirebbe in particolare l’influenza di ÉS. In verità, la sicurezza che Verga abbia tenuto conto dei due capolavori di Flaubert la forniscono eminentemente se non esclusivamente gli echi tematici. Non sono state ancora fornite, in-somma, prove certe; se si preferisce, non sono stati mai addotti ar-gomenti forti a sostegno del fatto che Flaubert fu l’autore il quale principalmente influì sulle prime attuazioni stilistiche verghiane dell’indiretto libero, poi sulla messa a fuoco (focalizzazione) dei vari momenti del “narrato” nelle novelle di Vita dei campi (1880: per nar-rato si intende la produzione complessiva di diverse voci narranti) e infine sulla elaborazione di quella scrittura corale mediante cui si re-alizza il canone della impersonalità nei Mal (la voce narrante si sdoppia: oltre a un narratore pseudo–popolare anonimo racconta l’intera comunità di Aci Trezza, o coralmente, o mediante pensieri di individui riferiti con indiretto libero).
A differenza del narratore flaubertiano, impassibile o volterriana-mente sardonico, il narratore delle novelle veriste verghiane e quelli dei Mal non sono mai distaccati, non sono mai impassibili, sono sem-pre anzi in qualche modo profondamente partecipi di quel che avvie-ne; eventualmente sono ostili nei confronti di uno o più personaggi e si uniformano al modo di sentire e di giudicare di altri personaggi (co-me nella novella Rosso Malpelo, raccontata per antifrasi da un narra-tore pseudo–popolare anonimo). Con il che non si nega certo, questo va da sé, che vi sia stata una certa influenza di Flaubert sulla tecnica della narrazione e sull’indiretto libero malavoglieschi. Personalmente, ritengo che l’influenza di ÉS, romanzo fortemente piazzaiolo e a suo modo corale, in cui il susseguirsi dei personaggi che prendono la sce-na e che parlano è talvolta frenetico e di difficile comprensione alla prima lettura, sia almeno pari a quella di MB nella strutturazione nar-rativa dei Mal (ancorché forse più fievole quanto all’elaborazione del-l’indiretto libero).
CAPITOLO I – Echi di Madame Bovary in Verga 35
Si riducano alla mente gli echi tematici più evidenti di Flaubert in Verga: l’episodio della malattia del bambino in TR (cfr. pp. 88–89 e pp. 101–108, le quali ultime corrispondono all’intero cap. 14) trae in parte spunto da quello della malattia del figlio di madame Arnoux in ÉS (cfr. ivi in particolare le pp. 306–307). Entrambi questi episodi so-no collocati nel momento in cui i due protagonisti percepiscono e vi-vono la passione; le malattie dei bambini in diversa misura inibiscono l’espansione di essa, specie in ÉS (madame Arnoux, angosciata per il figlioletto, si dimentica dell’appuntamento con Frédéric, mentre La Ferlita, pur tentennante, va a trovare Nata). Una elaborata immagine la quale, in Eros, è il frutto della contaminazione di una movenza ricon-ducibile a ÉS con un’ampia reminiscenza turgeneviana verrà messa a fuoco e illustrata nel capitolo successivo. In Eros (p. 344) la contessa Armandi si presenta un mattino alle 8 a casa del giovane marchese Alberti velata e tutta rincantucciata in un fiacre. Il primo rapporto ses-suale tra Emma e Léon avviene a Rouen su un fiacre, condotto da un normale e ignaro vetturino. Ciò che più conta è che Alberti e l’assai più anziana contessa si conoscono carnalmente per la prima volta, una notte, su di una barca della quale sono i soli occupanti, al largo sul la-go di Como (ivi, pp. 352–353). Questa moda dei rapporti sessuali so-pra mezzi di locomozione e trasporto più o meno privati o più o me-no pubblici incontrò non poca fortuna nella narrativa italiana tra ve-rismo e simbolismo: come non ricordare l’amplesso tra i due amanti clandestini del dannunziano Trionfo della morte, sullo scomparti-mento di un treno ove in qualsiasi momento si sarebbe potuto pre-sentare il controllo?12
MdE fu ideato e forse abbozzato da Verga prima dell’estate 1880, mentre lo scrittore attendeva alla composizione dei Mal, fu composto nel 1881, e fu pubblicato nel 188213. Verga, programmaticamente, in-
12 Cfr. G. D’ANNUNZIO, Trionfo della morte, Milano, Mondadori 1995 (prima edizione
Oscar) pp. 45–46. Una gustosa rassegna delle occasioni (talvolta mancate) di incontri sessuali su carrozzette a nolo si legge in A. DI BENEDETTO, op. cit., p. 13 e p. 18.
13 Nel periodo finale della correzione del manoscritto dei Mal, cioè nell’estate 1880, Gio-vanni Verga scrive ai familiari che sta per cominciare a dedicarsi alla stesura di una comme-dia e a quella di un romanzo (sicuramente quello di Cesare ed Elena) da concludere assoluta-mente entro la fine di quello stesso anno 1880. Cfr. le lettere di Verga al fratello Mario da Mi-lano, 27 giugno 1880 e 2 luglio 1880 (si leggono in G. GARRA AGOSTA, La biblioteca di Gio-vanni Verga, Catania, Greco 1977, p. 207 e p. 208; sezione lettere del volume); nella lettera
PARTE PRIMA – Giovanni Verga e la letteratura europea 36
tendeva qui fare scaturire l’azione romanzesca dalla sensibilità e dalle reazioni di Cesare, il marito della donna adultera, talché gli altri per-sonaggi dovevano essere raffigurati soprattutto, seppure non esclusi-vamente, a partire dalle forme della loro relazione con lui. Ciò si av-verte fin dal titolo: Il marito di Elena. Egli, Cesare, secondo che è sta-to giustamente osservato, vi sta come una proprietà e per estensione come uno schiavo e per estensione ulteriore come una vittima della moglie14. In MB, programmaticamente, la protagonista è lei e tutto ruota intorno a lei, anche dopo la sua morte. Non solo. Nei due ro-manzi d’autori francesi che più hanno colpito la sensibilità di Verga e
allo stesso corrispondente da Milano, 10 luglio 1880 lo scrittore dichiara: «In ottobre, novem-bre e dicembre poi condurrò a termine un altro romanzo» (ivi, p. 209); e nella successiva let-tera a Mario da Milano, del 14 luglio 1880 si legge: «Sono molto preoccupato dell’ultima ma-no da dare al romanzo [Mal, N.d.A.] che comincia a stamparsi fra un 15 giorni […]. Da qui a dicembre bisogna che io abbia scritto la commedia e un altro romanzo, oltre a licenziare per le stampe l’attuale, […] e ci son dei momenti […], che lo scoraggiamento mi vince» (ivi, p. 210). Dalle lettere di Verga a Capuana da Milano del 29 maggio, del 3 giugno e del 28 giugno 1881 si evince che lo scrittore è immerso nella stesura di MdE: nella terza missiva dichiara anzi che il romanzo sarà pienamente coronato tra 15 giorni (Cartvc, pp. 120, 121 e 125; infine scrive allo stesso corrispondente da Milano, il 30 luglio 1881: «Intanto, per pagare la casetta dove sto, do mano a terminare quel cornuto Marito di Elena» (ivi, p. 129).
14 Cfr. M. MUSCARIELLO, op. cit, p. 65. Alcuni studiosi ritengono che l’inizio della com-posizione del romanzo sia da retrodatare in modo consistente, e cioè al 1879: così, per ragioni sia stilistico–linguistiche sia di contenuto; cfr. L. FAVA GUZZETTA (La difficile collocazione …, cit., pp. 77–78 e Verga tra Manzoni e Flaubert, cit., pp. 345–346, nota 45) e Carmelo Mu-sumarra (Verga e la sua eredità novecentesca, Brescia, La Scuola 1981), il quale fonda il suo convincimento su una lettera di Verga a Treves datata 9 gennaio 1879, in cui lo scrittore «co-munica all’editore milanese di avere cominciato a scrivere Il marito di Elena, che dovrebbe essere un romanzo diverso dagli altri perché mostra un uomo il quale, per amore, scende a uno a uno tutti i gradini della scala morale e “si abitua a tutte le viltà, per un sentimento gene-roso, in fondo”» (ivi, p. 153). Verga però aveva l’abitudine di credere e cercare di far credere che lavori ancora confusamente concepiti, al massimo delineati in modo provvisorio e som-mario, si trovassero a uno stadio di elaborazione assai più avanzato. La lettera prova solo che Verga era ormai profondamente attratto da MB e si proponeva di scrivere un romanzo in cui il protagonista fosse un uomo che accetta di essere una vittima del “bovarismo femminile”. Non ci è dato sapere con sicurezza se Verga, a partire dal periodo al quale appartiene la lettera prodotta da Musumarra, avesse cominciato a concentrarsi nella lettura e nelle varie riletture di MB al fine di trarne spunto per la tecnica compositiva dei Mal (ma da quella lettura e dalle ri-letture sarebbe sorta anche, prepotente, l’esigenza di scrivere un romanzo bovaristico e anti–bovaristico); o se invece la lettura e la rilettura di MB (sicuramente già letto entro il 1874) fos-sero compiute da Verga perché egli accarezzava il progetto del romanzo bovaristico e anti–bovaristico, poi accantonato per qualche tempo al fine di redigere i Mal (nei quali allora si troverebbero risonanze cospicue di MB a causa del progettato e temporaneamente accantonato MdE).
CAPITOLO I – Echi di Madame Bovary in Verga 37
la sua personalità artistica, al centro del quadro vi sono le donne, Mar-guerite ed Emma; tutti gli uomini che interagiscono con loro, perfino quelli animati dalle migliori intenzioni, come il duca nel romanzo di Dumas e Charles in quello di Flaubert, non sono mai figure a tutto tondo positive. V’è in loro, nei loro atteggiamenti, qualcosa di poco nobile e di esasperante, nonostante la loro sincera bontà di fondo e il loro rispetto per la donna della quale credono di prendersi cura. Tutti gli altri personaggi maschili dei due romanzi che entrano in diretta e reciproca relazione con Marguerite e con Emma sono dal più al meno o egoisti o meschini o tutt’e due le cose.
L’autore italiano vuole compiere la rivalutazione della sensibilità maschile, vuole attuare il ribaltamento dei valori morali che contras-segnano la figura maschile. Questo vale per Eva, in cui vi è imitazio-ne–competizione con La dame aux camélias e vale ancora di più nel caso di MdE, che si contrappone a MB frontalmente, mentre a suo modo la imita. La contrapposizione viene sviluppata da Verga nel ro-manzo del 1882 anche sul terreno della tecnica narrativa. In altri ter-mini, mentre il narratore impersonale flaubertiano è impassibile e a tratti volterrianamente cinico, Verga tenta un esperimento curioso, il quale pare farsi strada dopo che è stata compiuta la stesura dei primi capitoli: lo scrittore siciliano adotta in modo intenzionale e studiato una voce narrante impersonale sì, ma la quale prende vivissima parte, dal punto di vista emotivo, a ciò che racconta. Essa apertamente si schiera dalla parte di Cesare; palesa la propria commozione per i pa-timenti da questo subiti e la propria forte ostilità nei confronti della moglie responsabile di quei patimenti; giustifica il raptus omicida fi-nale del marito.
La sovraesposizione della voce narrante giunge all’apice nel capito-lo 14 ma diviene nitida a partire dal capitolo 7, cioè dal ritorno dei due coniugi a Napoli dopo la breve permanenza in Sicilia, nella infruttuosa campagna di Cesare. Ivi i due erano stati devoti l’uno all’altra e il ma-rito aveva potuto godere dell’amore di Elena, malgrado le preoccupa-zioni di indole economica che lo affliggevano. Trattasi di una tecnica compositiva radicalmente antitetica sia a quella adottata in Rosso Malpelo sia a quella dei Mal, tra loro diverse ma entrambe fortemente sperimentali. In MdE sono buttati alle ortiche sia il narratore popolare che filtra la vicenda secondo il punto di vista della comunità di paese
PARTE PRIMA – Giovanni Verga e la letteratura europea
38
sia il “coro paesano”. In luogo di ciò la voce narrante impersonale pa-ladina di Cesare, spesso larmoyante, pronunzia una condanna costante e severa nei confronti della comunità di paese (in Sicilia) e della socie-tà (napoletana) di cui i coniugi fanno parte o sono entrati a far parte; e in maniera aperta e fastidiosa invita il lettore a provare i medesimi sentimenti e a condividere gli stessi giudizi da essa espressi15.
Le ragioni di questo “terzo” esperimento, gli obiettivi che Verga spe-rava di raggiungere dal punto di vista compositivo ed espressivo in larga misura ancora ci sfuggono: l’indagine di essi è quasi interamente da compiersi. È nondimeno possibile affermare che l’esperimento è immatu-ro, affrettato, inefficace. In particolare, anche in MdE tutta l’azione, mal-grado le intenzioni dell’autore, scaturisce a partire dalla donna, dai suoi desideri, dai suoi gusti, dai suoi atti: il marito si limita a reagire da perso-na debole, immatura, disillusa eppure illusa, alle iniziative e ai movimenti affettivi della capricciosa e viziata consorte. Ciò autorizza perfino il so-spetto che la sovraesposizione del narratore e la sua spiccata partigianeria siano un estremo tentativo di porre Cesare al centro del quadro:
La gente, quando vedeva passare il marito un po’ triste, ma calmo, come un uomo in lutto, accanto alla bruna e fiera beltà, gli gettava dietro il suo scherno, li seguiva cogli sguardi sfacciatamente curiosi, con un senso di de-siderio e quasi di ammirazione per la donna, col cinico egoismo della folla, col sarcasmo feroce che getta il fango a due mani, senza cercare chi, fra la donna che inganna e l’uomo che è ingannato, sia realmente ridicolo. (MdE, pp. 113–114)
15 Si considerino anche questi passi: «Il marito della greca donna seppe in tal modo, un
mese dopo, lo scempio turpe che si era fatto del suo onore. Ma allorquando tentò di lavare la macchia in una maniera qualsiasi, con un colpo di sciabola o di pistola, non trovò per assister-lo un solo di quegli amici che gli stringevano la mano, che gli lasciavano il loro nome alla porta, venendo a far visita a sua moglie, che gliela avrebbero nascosta colla loro persona s'egli l'avesse sorpresa fra le braccia del suo amante, e che in cambio gli avrebbero fatto da testimo-nio s'egli avesse dovuto battersi per una ballerina o per una cortigiana» (MdE, pp. 112–113). «Quando il marito offeso non schiaccia la donna sotto il tacco, al primo momento, non ha al-tro di meglio a fare che prendere il cappello e andarsene. Se la donna ha il tempo di dire due parole, di spargere una lagrima, di fare un gesto, il marito perdona, e nove volte su dieci si rassegna. Elena sarà caduta ai piedi di lui di un sol colpo, coi due ginocchi per terra, le braccia aperte, il viso disfatto, dicendo: Uccidimi! […]. Poscia ancora tutte le debolezze dell'a-more che non siete riescito a soffocare completamente, tutti i languori del desiderio che vi si inspira, tutte le fiacchezze dei lieti ricordi che vi disarmano, tutte le tentazioni dell'egoismo che vi si insinuano» (ivi, pp. 114–115).
CAPITOLO I – Echi di Madame Bovary in Verga 39
Egli l’avrebbe riconquistata colla generosità, coll’abnegazione, coll’affetto, rendendole lieta e facile l’esistenza. Sì, l’amava ancora il disgraziato! Era geloso al modo dei deboli, senza aver la forza di rompere la sua catena, col-la vaga speranza che non osava confessare a se stesso di riconquistare il suo affetto a furia di generosità, di devozione, di rassegnazione persino! Sì, una viltà! Ma non è la peggiore delle disgrazie esser vile? Se cercate bene, in ogni marito offeso che si vendica, allorché non vendica soltanto il senti-mento sociale, c’è un residuo d’amore, il bisogno di rialzarsi agli occhi stessi della traditrice, il rimpianto dei giorni lieti dovuti a lei, delle sue at-trattive rubategli. (ivi, p. 115)
Essendo MB quasi passato al setaccio in MdE oltre che assunto
ivi come irriducibile obiettivo polemico, si deve supporre che Ver-ga avesse tenuto con sé a mo’ di livre de chevet il capolavoro di Flaubert per diversi mesi e sicuramente durante i mesi antecedenti il compimento del proprio romanzo scritto con intenti antagonistici rispetto a quello.
Questa banale considerazione è ancora una volta l’elemento principale a favore della tesi secondo cui la speciale tecnica della impersonalità nei Mal, con la congiunta, rilevante quantità e mobi-lità delle voci narranti e dei loro angoli prospettici risenta della le-zione flaubertiana. Non moltissime ma ben nitide sono in effetti le figure e le situazioni malavogliesche che arieggiano personaggi ed elementi tematici del romanzo francese. La risonanza principale, come tutti hanno notato, sta nella rielaborazione della coppia anta-gonistica Homais–Bournisien, rispettivamente farmacista e abate del villaggio di Yonville: loro filiazione nei Mal è la coppia di fe-roci ed inseparabili rivali costituita dal parroco di Aci Trezza Don Giammaria e dallo speziale repubblicano Don Franco. Un’altra ri-sonanza evidente sta nella rielaborazione verghiana dell’espediente adottato in MB dal commerciante e usuraio Lhereux. Questi cede 700 franchi del debito di Emma al prestanome M. Vinçart, che ha diritto di esigerli anche ricorrendo al tribunale e alla legge (cfr. MB, p. 364; la cosa è ribadita a p. 374). È lo stesso espediente posto in essere dallo zio Crocifisso quando finge di vendere il proprio credi-to al sensale Piedipapera.
A integrazione di quel che è stato scritto finora aggiungerei un paio di movenze: Mme Bovary madre predice che a furia di debiti e di spe-
PARTE PRIMA – Giovanni Verga e la letteratura europea
40
se inutili il figlio e la nuora finiranno all’ospizio (MB, p. 353)16: sarà la sorte che occorrerà a Padron ’Ntoni, colui il quale aveva contratto il debito dei lupini, personaggio sommamente positivo dei Mal. Ancora: il tribunale invia a Emma la ingiunzione di pagamento della somma di 8000 franchi entro ventiquattro ore, trascorse le quali si procederà al sequestro esecutivo (MB, p. 373). Due giorni dopo l’arrivo della in-giunzione, e all’indomani del colloquio infruttuoso di Emma con Lhe-reux, a casa Bovary arriva l’usciere, con due testimoni, per fare l’inventario dei beni pignorabili (ivi, p. 377). Il suo arrivo sancisce la certezza dell’avvenuta rovina, per una Emma disperata, la quale anco-ra si dibatte vanamente al fine di non soccombere. L’usciere diventerà lentamente, nell’immaginario collettivo degli abitanti di Aci Trezza, da sinonimo di ricorso alle vie legali (per lo zio Crocifisso) una specie di uomo–simbolo, di parola–simbolo, di immagine vivida del pigno-ramento, e dunque della rovina economica della famiglia Malavoglia. Il termine ricorre ventiquattro volte nel romanzo di Verga, contro le cinque occorrenze di MB.
4. Violette e gelsomini in Madame Bovary e in Eva
Occorre soffermarsi su Eva. Questo romanzo fu pubblicato nell’estate del 1873, otto anni prima dei Mal. Un critico di Verga tra i più autorevoli vi ha riconosciuto piccoli echi di ÉS, ma essendo questi alquanto generici, oltre che piccoli, potrebbero essere forse incidentali o di non diretta matrice flaubertiana17. Aggiungerei che Eva è il primo
16 In ÉS, p. 264, Mlle Vatnaz giura che riuscirà a ridurre in miseria e a fare morire all’o-
spedale dei poveri la vittoriosa rivale in amore Rosanette. 17 «Anche alcuni tratti realistici dell’Éducation sentimentale ritornano nei libri giovanili
del Verga. Alcune più tipiche sensazioni del vagabondare di Federico per le strade di Parigi saranno le stesse quasi di quelle del vagabondare per le strade di Firenze del protagonista di Eva: “il se sentait grand’–faim”; “mi rammentai che non avevo mangiato dal giorno innanzi”. La delusione di Federico nel rivedere Madame Arnoux lontana dall’ambiente di mondanità e di arte in cui l’aveva per la prima volta vagheggiata, è il profilarsi di un motivo che troveremo con insistenza nel Verga della Storia di una capinera e di Eva: “ne retrouvant plus Mme Ar-noux dans le milieu où il l’avait connue, elle lui semblait avoir perdu quelque chose, porter confusément comme une dégradation, enfin n’être pas la même. Le calme de son cœur le stu-péfiait”. “Sai tu che cosa sarei senza la mia gonnellina corta e le mie scarpine di raso?”» (G.
CAPITOLO I – Echi di Madame Bovary in Verga 41
testo narrativo verghiano in cui ricorra il francesismo fiacre (quattro volte, sempre nei primi capitoli), di sicura provenienza flaubertiana, o da MB o da ÉS18; esso ricorrerà poi nuovamente una volta in TR, per vezzo e senza assumere il ruolo di parola–chiave, e quattro volte in Eros, tra il capitolo 28 e il capitolo 38. In Eros il fiacre sarà segnale di relazione adulterina: quella tra la matura contessa Armandi e il giova-ne scapolo Alberto, relazione di cui il fiacre marca gli albori e la chiu-sura. Il termine francese assume dunque in questa specifica ripresa connotazioni intensamente bovaristiche. In Eva il fiacre è segnale di liaison erotica, di libero amore tra persone non sposate, dunque di clandestinità almeno relativa, con aroma di scandalo, almeno relativo.
Fino a oggi si è ritenuto che Eva fosse stato scritto in tempi antece-denti l’influenza di MB. Ricordo che questo romanzo di Verga ha co-me suo testo di riferimento principale ed esibito La dame aux camé-lias di Alexandre Dumas figlio. In un certo senso si può dire che Eva stia alla Dame aux camélias come Il marito di Elena sta a MB. Ale-xandre Dumas racconta di una giovane e bellissima cortigiana, in-somma di una prostituta di alto bordo, la quale si redime per amore fi-no al sacrificio della propria vita: sacrificio non determinato ma certo accelerato dalla egoistica mancanza di comprensione dell’uomo che ella ama. Verga scrive un pasticcio perché si invischia in una specie di quadratura del cerchio. Nella prima parte del romanzo una splendida giovane artista, la prima ballerina della Pergola, la quale certo non è una verginella ma neppure è una prostituta, lascia la ribalta, il succes-so, lo stuolo di ammiratori nobili e ricchissimi che la coprono di pre-ziosi regali per ridursi a vivere in povertà con uno pseudo–pittore squattrinato suo coetaneo, privo di ogni spirito di iniziativa e di ogni senso di responsabilità. Nella seconda parte lei diviene leggera, frivola e capricciosa, una autentica maliarda che compie azioni le quali nulla hanno a che fare con la giovane innamorata disposta a ogni sacrificio della prima parte del libro.
RAGONESE, Flaubert e Verga, cit., p. 121).
18 «Quando il nostro fiacre passò accanto ad un bellissimo legno, che stava fermo» (Eva, p. 92); «e il lampione di un fiacre che si riverberava sull'invetriata del vestibolo» (ivi, p. 108); «Anzi fai così: m'aspetterai in fiacre, in piazza Santa Maria Nuova. Verrò a trovarti io stessa. Prendi il fiacre numero nove; mi piace il numero nove» (ivi, p. 122).
PARTE PRIMA – Giovanni Verga e la letteratura europea 42
Il pittore, come i classici eroi al maschile dei romanzi di lusso ver-ghiani, non prova più attrazione quando si sente sicuro del possesso. Non appena il possesso gli sfugge, il desiderio prende a tormentarlo nuovamente. Torna a morire presso la sua famiglia di origine, sulle falde dell’Etna, consumato dalla tisi e dalle conseguenze della ferita ricevuta nel duello, da lui provocato, in cui ha potuto ferire a morte l’amante di Eva. Sia nella donna che in Enrico convivono una accoz-zaglia di personalità tra loro inconciliabili.
Quel che s’è detto può spiegare in certa misura come mai il roman-zo Eva non sia mai stato accostato a MB. Non ho elementi sufficienti per affermare che mentre attendeva a Eva Verga avesse sicuramente già letto o stesse leggendo MB. Posso provare soltanto che in Eva vie-ne rielaborato in modo pregnante e originale uno spunto di sicura a-scendenza flaubertiana. Occorre allora ammettere che di MB Verga aveva, al più tardi fin dalla primavera del 1873, una conoscenza se non diretta almeno indiretta, mediata.
Mi provo a mettere a fuoco la rielaborazione dello spunto anzidetto. In Eva, la sorella di Enrico, d’intesa con la madre e il padre di lui,
raccoglie per il fratello dei gelsomini profumati, i fiori da lui preferiti (Eva, p. 165): ciò accade proprio alla fine del romanzo, mentre si rap-presentano l’agonia e la morte del giovane durante la calda estate sici-liana. Alla ballerina e maliarda Eva manca, apparentemente, un preci-so contrassegno floreale. In un resoconto in discorso diretto, tuttavia, Enrico informa che egli non spendeva nulla per la bella donna, all’inizio della loro storia d’amore, che egli non le aveva mai regalato neppure un mazzolino di viole (ivi, p. 124). Le viole sono in questo caso presenza di un’assenza. Un cespuglio di gelsomino con rami sen-za foglie è testimone, in MB, di un incontro d’amore tra Rodolphe ed Emma, in inverno, nel primo periodo, il più appassionato, della loro relazione. L’amplesso avviene sopra la stessa panca di legni marciti «où autrefois Léon la regardait si amoureusement, durant les soirs d’été» (ibidem, p. 226).
Dopo il suicidio di Emma, Charles trova le lettere inviate a sua moglie dai due amanti, le prove di quegli adultèri che non aveva mai voluto vedere. Diventa dapprima folle di dolore e di furore, poi si ras-segna, si chiude in se stesso, diviene una sorta di barbone: muore una sera d’estate mentre è seduto sulla panca accanto al gelsomino, il qua-
CAPITOLO I – Echi di Madame Bovary in Verga 43
le emana effluvi amorosi che al cuore sembrano soffocanti (ibidem, p. 440). Il gelsomino è, al contempo, freddo compagno dell’adulterio di Emma con Rodolphe, e testimone profumato, intenso, dell’angoscia e della morte di Charles. In entrambi i casi il gelsomino — per volontà dell’autore — non è partecipe e non è adeguato alle circostanze. Quanto alle viole, Léon, quando sta per divenire il secondo amante di Emma, compra un mazzo di violette per lei mentre si reca al loro pri-mo convegno d’amore (ivi, p. 310): Emma porta con sé a Yonville il mazzo di violette e Charles lo nota in casa propria (ivi, p. 326).
In MB il gelsomino e le violette sono complici muti e involontari delle relazioni extraconiugali Emma–Rodolphe ed Emma–Léon; e so-no anche testimoni della esistenza di un classico triangolo: con en-trambi i fiori Charles entra primamente in contatto mentre la moglie è viva e si dedica alle relazioni adulterine. I fiori non svolgono una fun-zione allusiva: sono sì segnali indicatori, dal valore però non speciale. Forse è maggiore il valore semantico–simbolico della panca di legni marciti. Il gelsomino marca un luogo ben preciso e due tempi diversi con antitesi forse ricercata. V’è quella precisa panca, in quel preciso posto della piccola proprietà: in inverno, mentre Emma si trova nel ri-goglio della vita dei sensi, il gelsomino è secco; in estate, mentre Charles muore, il gelsomino è al culmine della propria vitalità. Se si tiene conto dei ricordi di Emma, generici e imprecisi, circa l’amore re-ciproco e allora non confessato che era nato tra lei e Léon all’arrivo dei Bovary a Yonville, il gelsomino marca perfino tre tempi diversi. Flaubert forse avrebbe potuto scegliere altri fiori in luogo di questi: si dice forse perché nella scelta dei fiori egli ha quasi certamente rielabo-rato uno spunto offertogli dal Mèdecin de campagne di Balzac (e an-che, non è improbabile, dai Secrets de la princesse de Cadignan, del medesimo autore).
Nel romanzo di Verga la presenza di una assenza quella delle violette, fiore virtualmente relazionale perché avrebbe potuto essere (ma non era stato) oggetto di un piccolo dono di lui a lei segnala due aspetti antitetici tra loro e perciò stesso adeguati alla incoerenza del romanzo: 1) che l’amore tra Enrico ed Eva è disinteressato e a suo modo onesto (entrambi sono liberi da vincoli matrimoniali e anche da impegni verso altre persone); 2) che, in modo conforme alla simbolo-gia onomastica della Traviata, non si possono abbinare alla non redi-
PARTE PRIMA – Giovanni Verga e la letteratura europea 44
mibile Eva viole o violette. Il gelsomino marca invece l’amore del so-lo Enrico e la sua morte come vittima della maliarda (in realtà come pretesa vittima, malgrado le opposte intenzioni delle voci narranti e dell’autore: l’uomo si comporta sempre da egoista e basta).
Legittimo pare il dubbio che a Verga non fosse nota la presenza del gelsomino durante l’incontro di Emma e Rodolphe, e che egli dunque ignorasse la contiguità tra il gelsomino e la panca. Nel romanzo italia-no vengono infatti rispettati limitatamente alla morte di Enrico i valori cronologici di MB, molto meno quelli topografici: lo scenario dell’agonia di Enrico è sì il giardino di una proprietà privata durante un’estate piena e tarda; per l’esattezza egli giace su una poltrona sotto uno dei due bellissimi castagni i quali danno ombra alla spianata della casa dei suoi, vicina al mare. Non si sa però dove siano precisamente i cespugli di gelsomino, che di certo sono nelle vicinanze, non si sa neppure se si trovino dentro la proprietà: il gelsomino perde la funzio-ne di segnale che identifica un luogo ben circoscritto e determinato.
In conclusione, i modi dell’inserimento in Eva delle violette e del gelsomino, di chiarissima ascendenza flaubertiana, la funzione ristret-ta per un verso e pregnante per un altro che essi vi svolgono recano due distinte testimonianze: confermano che il primo contatto di Verga con MB non fu né profondo né intenso, come diverrà invece poco me-no di dieci anni dopo; danno testimonianza dell’interesse o almeno di un qualche interesse subito manifestato da Verga nei confronti di MB e velato forse eccessivamente nella lettera a Capuana. Certo è però che i modi dell’inserimento delle violette e dei gelsomini in Eva conduco-no a non escludere che il periodo o il giro di mesi in cui Verga entrò direttamente in contatto con MB sia da retrodatare; rendono necessario un più preciso accertamento cronologico del termine a quo, finora sempre fissato al gennaio del 1874.
45
Capitolo II
Echi di Turgenev in Verga, con particolare riguardo ai personaggi femminili
1. Turgenev nei romanzi mondani di Verga del periodo fiorentino–milanese1 L’influenza di Turgenev sulla narrativa verghiana procede in paral-
lelo rispetto a quella di Flaubert. Ciò forse non è casuale ma neppure implica che Verga ritenesse tra loro affratellate le produzioni artistiche degli altri due illustri scrittori, tra loro ben diverse. Più verosimile è che la fama della grande amicizia stretta da Turgenev con Flaubert ab-bia spinto il loro confratello italiano a leggerli e a rileggerli nei mede-simi archi di tempo. Lo scrittore italiano trasse sicuramente impulso e spunto fecondi da quello russo; ben maggiori furono però, specie sul piano della “inventio”, i paralleli stimoli e suggerimenti di Flaubert accolti da Verga nell’opera propria. In questa sede verranno messi in luce ed esaminati brevemente figure, nuclei tematici ed echi ricondu-cibili ai romanzi Rudin (1856), Un nido di nobili (1858), Alla vigilia
1 Abbreviazioni e sigle (cfr. nota 1 al capitolo I per tutti i dati bibliografici seguiti da cit.): Eros: G. VERGA, Eros, cit.; TR: G. V., Tigre reale II, cit.; Mal: G. V., I Malavoglia, cit.; MdE: G. V., Il marito di Elena, cit.; CartVC: Carteggio Verga–Capuana, cit.; MB: G. FLAUBERT, Madame Bovary, cit.; ÉS: G. F., L’Éducation sentimentale, cit.; Rudin: I. S. TURGENEV, Ru-din, trad. di E. Lo Gatto, in I. S. T, Tutti i romanzi, a cura di E. Lo Gatto, Milano, Mursia 1959; NdN: I. S. T, Un nido di nobili, trad. di M. Miro, ivi; AV: I. S. T, Alla vigilia, trad. di M. de Monticelli, ivi; Fumo: I. S. T, Fumo, trad. di E. Bazzarelli, ivi; PrA: Primo amore, in I. S. T., Primo amore. Il canto dell’amore trionfante, con trad. e a cura di E. Bazzarelli, Milano, Rizzoli (BUR) 2004; AdP: I. S. T., Acque di primavera, in Id., Fumo. Acque di primavera. Romanzi russi di Ivan Turghenieff, con Prefazione di D. Ciàmpoli e traduzione di S. De Gu-bernatis–Besobràsof, Milano, Treves 1889: in assenza di traduzioni molto recenti e in ogni ca-so di traduzioni novecentesche autorevoli si è prescelta l’ultima ristampa della traduzione di AdP procurata da Sofia De Gubernatis perché questa traduzione era stata approvata da Turge-nev, buon conoscitore della lingua italiana.
PARTE PRIMA – Giovanni Verga e la letteratura europea 46
(1860), Fumo (1867), al romanzo breve Acque di primavera (1872) e al racconto Primo amore (1860). AdP è una variazione e uno sviluppo dell’idea centrale di Fumo, ma in questo è profusa maggiore attenzio-ne al mito e al mondo politico–morale concreto dei Russi fuori dalla Russia.
Reminiscenze significative della narrativa di Turgenev si percepi-scono nitidamente nei romanzi verghiani riconducibili al periodo fio-rentino e ambientati nel cosiddetto “mondo di lusso”: soprattutto in Eros e in TR, ma se ne avvertono già in Eva. In Fumo la giovanissima e affascinanate Irina Pàvlovna, figlia di un grande aristocratico ridot-tosi quasi alla miseria, inaspettatamente fa capire allo studente Grigo-rij Michàjlovi Litvinov di essersi innamorata di lui; ella convince i propri genitori ad approvare il fidanzamento tra lei e lo studente, il quale aveva sempre creduto di non essere da lei contraccambiato; ella, però con il fidanzato prende tempo, adducendo a motivo l’età ancora acerba di entrambi. Volubile e capricciosa, ma anche risoluta, appas-sionata, determinata a essere fedele alla parola data, Irina si oppone con tutte le proprie forze al desiderio del padre principe Osinin che vuole condurla a un gran ballo in onore dei sovrani. La giovane avver-te di avere in se stessa qualcosa di pericoloso per sé e per gli altri; il debutto nell’alta nobiltà moscovita potrebbe esercitare su di lei un ef-fetto corruttore, perché ella detesta la miseria in cui vive. Su istanza del principe, Litvinov espone ingenuamente alla fidanzata tutte le buo-ne ragioni per cui ella deve consentire a recarsi al ballo. Irina cede da-vanti all’insistenza del fidanzato, che non ha compreso il combatti-mento interiore di lei e l’ha così liberata da ogni scrupolo, e gli impo-ne di non prendere parte a questo debutto di lei in società. A partire dalla sera del ballo Irina prova nostalgia per gli ambienti lussuosi ed esclusivi cui erano appartenuti i suoi avi. Tronca il fidanzamento con Litvinov, si trasforma in una seduttrice scaltrita, sposa Ratmirov, un ufficiale che è riuscito a dare con successo la scalata all’alta società. Diversi anni dopo, Irina incontra nuovamente il suo antico fidanzato a Baden, e lo ammalia e lo seduce fino al punto che Litvinov abban-dona la sua tenera e devota fidanzata Tat’jana Petrovna estova per fuggire con Irina. Solo allora Irina pare destarsi alla realtà e rifiuta di seguire Litvinov pur offrendogli di essere la sua amante (e la sua pa-drona).
CAPITOLO II – Echi di Turgenev in Verga 47
In Fumo lo studente Litvinov, uscendo un giorno dall’Università, corre a trovare la fidanzata Irina. Questa, calcando su ogni parola, gli dice anzitutto: « Ma voi non avete i guanti! » (p. 603) e «subito aggiunse Pfu! Che razza di tipo, siete. Un vero studente! […] … siete un vero studente … ripeté lei vous n’êtes pas distingué» (ibi-dem). In Eva Enrico Lanti racconta che egli, subito dopo aver visto per la prima volta comparire Eva sul palcoscenico della Pergola, aveva provato «mostruosi desideri» e «un amaro rammarico di trovarmi in quel meschino posto di platea e senza guanti» (Eva, p. 103). E come non pensare al bisogno frenetico, quasi maniacale, di essere sempre elegantissimo, provato da Enrico non appena è certo dell’amore di Eva per lui2?
Io non spendevo un soldo per Eva, nemmeno per regalarle un mazzolino di viole, ma provavo mille nuovi bisogni: avevo comperato degli abiti nuovi, avevo bisogno di essere elegante, di lavarmi le mani con acqua di Colonia, di essere bene alloggiato, di desinare da Doney, di portar dei guanti e tutti questi nonnulla sono enormemente dispendiosi per un pensionato del Comune a cencinquanta lire». (Eva, p. 124; il corsivo è mio) Si sono riferite dianzi con una certa larghezza le vicende di Fumo
perché Turgenev delinea con tocco lieve, naturalezza e verosimiglian-za uno sviluppo che è anche parziale metamorfosi del personaggio: da giovane fidanzata innamorata e ben decisa a mantenersi virtuosa e fe-dele, la quale lotta da sola contro le prepotenti tendenze volubili e ca-pricciose che intuisce nel suo stesso carattere, a maliarda che non esita per mero capriccio a sedurre e rovinare l’antico e onesto fidanzato. Codesta metamorfosi può contribuire a spiegare la stravagante meta-morfosi di Eva nel romanzo omonimo di Verga: una metamorfosi nel-la quale la “macchina narrativa” del romanzo si inceppa, e il perso-naggio, come si è già notato nel capitolo precedente, si sdoppia senza in ciò dispiegare, a differenza di Irina, alcuna coerenza interiore del carattere.
2 Il fatto che Irina Pàvlovna avesse istituito una tanto stretta relazione tra signorilità (ele-ganza) e guanti ha impressionato molto Verga, che attribuisce in modo insistito a Enrico la preoccupazione di esser privo di guanti: «Degli uomini poi ce n’erano così bellini […] e istin-tivamente mi nascondevo le mani nude sotto il cappello» (Eva, p. 102).
PARTE PRIMA – Giovanni Verga e la letteratura europea 48
2. Fumo, Acque di primavera ed Eros A Eros Verga lavorò certamente a partire dal 1873 mentre at-
tendeva anche all’abbozzo e alla stesura di TR e forse già in tempi antecedenti. Entrambi i romanzi uscirono nel 1875. Sono a-rieggiati in Eros, mi pare, tratti della virtù al contempo ardita, ge-nerosa e modesta di Gemma Roselli (AdP), appartenente al novero di quei personaggi di Turgenev che si suole efficacemente chiama-re creature della luce. Risonanze dell’affettività oblativa e dell’altezza d’animo della predetta fanciulla si riscontrano nel principale rivale in amore di Alberto, il suo compagno di scuola e poi medico affermato Gemmati e anche in Adele, la delicata cugi-na e poi moglie di Alberto. In Eros il giovanissimo Alberto dà ap-puntamento ad Adele di notte per parlarle d’amore. Come era stato convenuto, Alberto bussa tre colpi alla finestra della cugina. I due innamorati parlano a lungo, lui d’amore e basta e lei di amore, ma-trimonio e figli; «giusto quando Alberto stava per sciorinare tutta la sua teoria dell’amore puro, poetico e senza figliuoli, si udì star-nutire alla finestra di sopra, ch’era quella dello zio Bartolomeo» (Eros, p. 289). Verga ha contaminato una piccola movenza di ÉS con un più ampio passo di AdP. In ÉS Frédéric è tornato alla casa materna in provincia allo scopo di corteggiare Louise Roque, sen-sibile, delicata, molto ricca; egli è incoraggiato dalla propria madre e dal padre di Louise. Un giorno la fanciulla, molto innamorata del corteggiatore, gli chiede: « Veux–tu être mon mari? Mais…, répliqua Frédéric, cherchant quelque réponse. Sans doute… Je ne demande pas mieux. A ce moment la casquette de M. Roque appa-rut derrière un lilas» (ÉS, p. 279). Turgenev aveva amplificato la movenza proveniente da ÉS. Dal cespuglio di lilla che nasconde la panca su cui Gemma e Sanin siedono furtivi, parlando a bassa voce del loro amore, sbuca un viandante il quale, scorgendoli, si mette a tossire rumorosamente con sfacciataggine marcata (AdP, p. 103). L’estrazione sociale degli amanti di Eros essendo elevata, come lo è quella degli amanti di ÉS, Verga evita ad arte, come Flaubert, di inserire nella descrizione a suo modo giocosa note popolaresche e grassocce; ne inserisce invece Turgenev, senza stonature e con moderazione, perché i casti amanti di AdP sono entrambi di estra-
CAPITOLO II – Echi di Turgenev in Verga 49
zione sociale modesta e tale è anche lo scenario in cui all’origine si muovono3.
Gemmati deve rinunziare a vantaggio di Alberto sia a Velleda che, soprattutto, alla dolce Adele, della quale è profondamente innamorato: il gioco onomastico Gemma–Gemmati marca l’affinità tra il perso-naggio di Turgenev e quello di Verga. Da segnalare, per continuare a percorrere brevemente il terreno dell’onomastica, che la cagnetta della contessina e maliarda Velleda si chiama Gemma. La contessa Emilia Armandi, maliarda matura ed esperta, ovviamente sposata, è la prima amante che coinvolga Alberto in una relazione appassionata e inten-samente sensuale. Il cognome Armandi ci riconduce ad Armand Du-val, l’amante della eroina da feuilleton tanto vagheggiata da Verga, Marguerite Gautier; ma Emilia ci riconduce al giovanissimo fratello minore di Gemma Roselli, Emilio appunto.
Turgenev, com’è notissimo, visse per un periodo non breve a Ba-den (1863–1870), e si compiacque di ambientarvi parti più o meno e-stese delle proprie opere narrative. Si reca per l’estate a Baden l’adultera di NdN; i coniugi Polosoff di AdP Maria Nikolaievna (nata Kaliskin) e Ippolito Sidori , al momento della seduzione di Dimitri Pavlovi Sanin da parte di lei, si trovavano a Wiesbaden (corsivo mio, N.d.A). Soprattutto, le vicende narrate in Fumo si svolgono quasi per
3 Piacciono a Verga le allusioni sboccate, e ne inserisce anche nei romanzi mondani, ove
vi sia la possibilità di ambientare parti dell’azione in un contesto popolare. Se quella di cui si è discorso nel testo è reminiscenza certa di AdP (e di ÉS), non è impossibile che questa abbia parzialmente contribuito a suggerire, unitamente a un’altra reminiscenza da AdP, la rappre-sentazione, in MdE, del contegno sfrontato di un ciabattino che funge da portinaio nello stabi-le in cui abita il poetastro di moda Fiandura. In AdP Gemma e Sanin, mentre si recano a casa di lei dopo il colloquio segreto, incontrano il volgare signor Kluber, il fidanzato che Gemma ha appena lasciato. Questi li guarda in modo sprezzante e poi, ammiccando borbotta tra i den-ti: «“Il solito fine della canzoncina!”» (p. 231). Dopo essersi lasciata ammaliare dalle parole di Fiandura, una mattina Elena, guardinga e velata da una mantiglia, si reca da lui, ovviamente per un convegno d’amore, che poi, a dire il vero, non viene “consumato”: «Il ciabattino lercio che faceva da portinaio si fece ripetere due volte il nome del suo inquilino, guardandola sfac-ciatamente, canticchiandole dietro una canzonaccia oscena, che accompagnava picchiando del martello sulla suola» (MdE, p. 107). La situazione scabrosa di MdE viene arieggiata giocosa-mente da Matilde Serao nel racconto La virtù di Checchina, del 1884. La protagonista picco-lo–borghese, con sensibilità bovaristica infatuata piuttosto che innamorata di un marchese, batte in ritirata ancor prima di raggiungere il vagheggiato amante che l’attende; a metterla in fuga basta lo sguardo sfacciato dell’irsuto e volgare portinaio dello stabile in cui abita il marchese.
PARTE PRIMA – Giovanni Verga e la letteratura europea
50
intero a Baden. In Eros il conte Armandi, dopo aver sorpreso Alberto quasi in flagranza di adulterio con la propria moglie, parte con lei per Baden, che la voce narrante definisce «il baccanale della babele euro-pea estiva» (Eros, p. 376). È questa una vera e propria ripresa da Fu-mo (p. 586), per l’esattezza dal primo colloquio tra Sozont Ivany Po-tugin (il quale pone la domanda) e Litvinov (il quale, più che rispon-dere, commenta l’enunciato insito nella domanda): « vi è piaciuta la nostra torre di Babele? È proprio una torre di Babele! Vi siete e-spresso ottimamente».
Riprendo ad affastellare artigianalmente le affinità tematiche: il giovane marchese Alberto è debole nel carattere, è privo di volontà ri-soluta, come Sanin (AdP) e come Litvinov (Fumo); come costoro, egli si lascia sedurre da donne fatali che lo distolgono dall’amore vero e lo usano quasi egli fosse uno zimbello. La contessina Velleda, piena di fascino, di disinvoltura e di sicurezza del proprio ascendente sugli uomini ricorda molto la fresca principessina Zinaida di PrA. Velleda e Zinaida calamitano, letteralmente, i giovanotti, con una sorta di mali-zia ingenua e spontanea; Verga rappresenta ciò in maniera talvolta as-sai simile a taluni effetti espressivi turgeneviani. Si considerino queste due immagini:
Velleda stava presso l’étagère, circondata dai più eleganti giovanotti, come una cerbiatta attorniata da una muta di cani; ma la cerbiatta teneva testa da tutte le parti, col brio, col sorriso, con una parola, con un gesto, spiritosa, caustica, leggiadra e impertinente. (Eros, p. 296)
Nel salotto si sentivano delle voci allegre. Aprii la porta e fui preso da stu-pore. In mezzo alla stanza, su una seggiola, stava in piedi la principessina e teneva davanti a sé un berretto maschile; cinque giovanotti si affollavano intorno alla seggiola. Cercavano di prendere il berretto ma lei lo alzava e lo scuoteva forte. (PrA, p. 44)
Alberto abbandona Adele, alla quale aveva promesso amore e ma-
trimonio, per la seducente, frivola e incostante Velleda. Poi questa la-scia Alberto per sposare il prestigioso e ricchissimo principe Metellia-ni. Dopo alcuni anni Alberto incontra nuovamente Adele, che gli è ri-masta sempre fedele, e la sposa per amore vero. Frattanto Velleda si trasforma in una maliarda professionale ed esperta, ancorché priva di
CAPITOLO II – Echi di Turgenev in Verga 51
fascino genuino. Trattasi di vicende assai somiglianti a quelle narrate in AdP e soprattutto in Fumo. La principessa Metelliani non tollera che Alberto, palesemente, sia innamorato della moglie. Velleda riesce a sedurre il debolissimo Alberto e ad allontanarlo spiritualmente da Adele per sempre: questo gusto della conquista, eccitato dal fatto che la vittima è affettivamente legata in modo intenso a una partner molto gentile e amabile (a una creatura della luce modellata su quelle di Turgenev), ricorda molto da vicino la necessità di sedurre per mero capriccio della maliarda Irina Pàvlovna di Fumo: di sedurre, nella fat-tispecie, un uomo di cui era stata la prima tenera fidanzata, e che lei stessa ha lasciato per potere entrare nella più alta società; e ricorda an-che il bisogno di ridurre gli uomini in schiavitù della ninfomane mo-glie di Polosoff, il cedimento di Sanin e il definitivo abbandono della leggiadra Gemma da parte di questo.
Non so dire quanta fortuna abbia avuto nella letteratura dell’Otto-cento l’idea che quando un giovane è innamorato, proprio innamorato e basta, si getterebbe senza esitazione nel vuoto a rischio della propria vita se glielo comandasse l’amata. Di certo era un motivo ricorrente nella narrativa di Turgenev. In PrA il giovanissimo protagonista si butta senza esitazione da un muro alto oltre quattro metri perché ciò gli ha ordinato per mero capriccio Zinaida4. Anche in AdP il motivo ricorre in modo accentuato: «Se essa [Gemma] gli avesse detto in quel momento: “Buttati nel mare vuoi?” essa non avrebbe potuto termi-nare l’ultima parola, ed egli sarebbe volato nell’abisso» (pp. 227–228; il corsivo è di Turgenev, N.d.A). In Eros Alberto, mentre è in boccio la sua prima storia d’amore con Velleda, si butta dal primo piano per non farsi sorprendere nella camera della fanciulla dalla madre di questa. La contessa Emilia Armandi intuisce l’accaduto esattamente (Eros, pp. 331–332). Alcuni mesi dopo, mentre Alberto e la contessa sono in barca sul lago di notte, ella gli chiede, prima dell’amplesso, se egli sa-rebbe disposto a buttarsi nel lago qualora ella glielo ordinasse. Egli ri-
4 « Che cosa fate, lassù, così in alto? mi chiese con uno strano sorriso. Ecco,
continuò, affermate sempre di amarmi, allora saltate giù verso di me, sulla strada, se effetti-vamente mi amate. Zinaida non era riuscita a finire la frase, che io già volavo giù, come se qualcuno mi avesse spinto dietro. Il muro era alto circa due sa eny. Arrivai a terra con i piedi, ma l’urto era stato così forte che non potei trattenermi: caddi e per un attimo persi la coscien-za» (PrA, pp. 70–71).
PARTE PRIMA – Giovanni Verga e la letteratura europea
52
sponde di sì e par che la barca oscilli per un movimento di lui (ivi, pp. 353–354). Emilia lo ferma e gli si dà, dicendogli che occorre fare le cose evitando di cominciare dalla fine (ivi, p. 354). All’indomani, mentre sta vagando in preda ai ricordi euforici, Alberto si domanda perché la donna gli abbia fatto quella domanda e perché dopo l’amore non gli abbia dato il comando di buttarsi; egli ipotizza che forse la donna intuiva la viltà di lui, il fatto che egli non si sarebbe buttato (ivi, p. 356). Alberto non comprende che alla contessa era ben noto che e-gli si era buttato giù dal primo piano al fine di non compromettere Velleda. Lo spunto turgeneviano viene rielaborato da Verga in modo pregnante: il buttarsi giù con rischio serio per la propria incolumità indica, piuttosto che la soggezione, la dedizione assoluta all’amata. Va da sé, beninteso, che la vicenda della relazione tra il giovane marchese e l’assai più matura contessa è stata suggerita soprattutto dalla Fanny di Ernest Feydau e in certa misura dal Monsieur de Camors di Octave Feuillet (ma si avvertono anche echi di MB).
3. Acque di primavera e Tigre reale Non è possibile non domandarsi se Verga si sia ricordato di Maria
Nikolaievna e di Irina Pàvlovna anche per la raffigurazione di Nata. Si è ricordato della prima e non di lei soltanto in verità (anche della mol-to bizzarra e molto infelice principessina Zinaida di PrA) ma non della generalessa Ratmirova, perché le vicende narrate in TR (e i loro per-sonaggi) sono del tutto diverse rispetto a quelle narrate in AdP5. Poi-
5 Anche Zinaida, già ventunenne ma nubile, è una civetta consumata. Bellissima, maesto-
sa, dal portamento assai elegante, ella vive con la madre (il principe Zasekin, suo padre, è morto da tempo, lasciando le congiunte quasi nell’indigenza) donna volgare, di estrazione po-polare. Il sedicenne Vladimir Petrovi si innamora perdutamente di lei subito dopo che le Za-sekin vengono a vivere in un modesto alloggio vicino alla dacia signorile dei genitori di “Vol’demar”. Dopo qualche tempo gli amici della principessina intuiscono che ella ha un cruccio segreto, che si è innamorata di un uomo il quale non può impegnarsi con lei. Infine Vladimir e sua madre apprendono da una lettera anonima che la principessina è diventata l’amante del padre di Volodja, un uomo ancora giovane e molto bello. Zinaida è innamoratis-sima di quest’uomo egoista, il quale approfitta di lei senza ritegno alcuno e arriva a colpirla in modo violento con la frusta (Volodja assiste non visto e inorridito a questo fatto). Quattro an-ni dopo la morte del padre (e quasi sei anni dopo l’inizio della breve e intensissima relazione di suo padre con la principessina) Vladimir apprende che Zinaida, malgrado il suo onore fosse
CAPITOLO II – Echi di Turgenev in Verga 53
ché questo romanzo breve di Turgenev è divenuto rarissimo in versio-ne italiana ed è di conseguenza, che io sappia, poco conosciuto, mi è parso opportuno dar conto in modo semplicissimo della struttura e dei contenuti di TR e di quelli di AdP in appendice al presente capitolo.
Nata è una “tigre reale”, una “mangiatrice di uomini” aristocratica; in verità è una tigre quasi in pensione, al momento dell’incontro con Giorgio, giacché la malattia la consuma inesorabilmente. La seducen-te, cinica e sventurata contessa è ancora una civetta consumata ma è soprattutto una donna innamorata, moribonda, sommamente infelice per il fatto che presto dovrà morire e non potrà più innamorarsi e fare innamorare di sé. La vera tigre, nel pieno dell’attività, quasi una no-vella Circe o maga Armida, è Maria Nikolaievna, una tigre però non reale. Maria è la bellissima unica figlia rimasta contadina nel tem-peramento e tutt’altro che gran signora nel contegno , di una sorta di mastro–don Gesualdo russo, il quale le ha lasciato un immenso pa-trimonio. Anche Maria è malata, probabilmente è tisica, come Nata, e soggiorna a Wiesbaden per seguire la cura che le è stata consigliata, ancorché la sua malattia non paia grave e secondo lei medesima non sia grave (cfr. AdP, p. 240 e pp. 256–257).
Nata ha occhi grigi, quasi verdastri, duri e splendidi come i dia-manti della sua corona. Maria ha ella pure due grandi occhi grigi, mol-to chiari, sereni e penetranti. Come Maria, Nata è bionda, e spesso quando è in casa i capelli biondi le cascano intrecciati dalle due parti
pesantemente macchiato, è riuscita a sposarsi con un giovane appartenente all’antica cerchia degli adoratori e si trova attualmente a Pietroburgo, ove egli vive ormai da tempo. Vladimir decide di andare a trovare l’antica “passione” ma lascia trascorrere del tempo, e quando fi-nalmente si reca da lei apprende che pochi giorni prima ella è morta di parto. Quando il sedi-cenne Vladimir (personaggio e narratore) si accorge d’essersi perdutamente innamorato della principessina di cinque anni più anziana, egli riferisce così la propria percezione di lei: «Del resto, non ero l’unico a essere innamorato di lei: tutti gli uomini che visitavano la sua casa, impazzivano per lei, e lei li teneva tutti come avvinti ai suoi piedi. La divertiva destare in essi ora speranze, ora paure, farli girare secondo il suo capriccio (ciò che lei chiamava farli cozza-re l’uno contro l’altro), ed essi non pensavano neppure a ribellarsi e volentieri le si sottomet-tevano. In tutto il suo essere, di creatura viva e bella, c’era una non so quale mescolanza affa-scinante di furberia e di spensieratezza, di artificio e di semplicità, di calma e di vivacità; in tutto ciò che ella faceva, diceva, in ogni suo movimento, c’era un fascino sottile, lieve, in tutto si esprimeva una forza particolare, originale, giocosa. Il suo volto si mutava continuamente, giocava persino: esso esprimeva quasi nello stesso tempo scherno, malinconia pensosa e pas-sione. I sentimenti più disparati, lievi, rapidi, come ombre di nubi in un giorno assolato di vento, scorrevano di volta in volta nei suoi occhi, sulle sue labbra» (PrA, pp. 56–57))
PARTE PRIMA – Giovanni Verga e la letteratura europea 54
del capo (cfr. AdP, 248; il ritratto di Maria è abbastanza simile a quel-lo di Irina, salvo che questa ha fisionomia e atteggiamento aristocrati-ci). Il narratore ripete insistentemente che sia il tratto fisico sia l’espressione di Maria sono selvaggi, a causa della sua modestissima origine: «traccie [sic, N.d.A] della sua nascita plebea» sono «il naso un po’ camuso e rialzato», la fronte «bassa» (ivi, p. 249), il fatto che ella parli sempre russo, quello «moscovita, popolare, plebeo» (ivi, p. 253); «selvaggi» sono o diventano soprattutto gli occhi (cfr. ivi, p. 279). Questa mancanza di finezza, però, non toglie e anzi conferisce incanto a un corpo ben fatto, «tra il russo e lo zingaresco» (ivi, p. 249). Sia Maria che Nata hanno spirito dispotico ed energia virili, mentre Sanin e La Ferlita hanno personalità fiacca con debolezze muliebri. La ple-bea ricchissima veste abitualmente, nelle occasioni eleganti, come Na-ta, abiti di seta ornati di merletti e porta splendidi brillanti al collo, alle braccia, alle orecchie (AdP, p. 248: Nata, a differenza di Maria, porta anche un diadema di brillanti, come si addice a una aristocratica, mo-glie di un gran signore, un generale che è amico personale dello czar).
Nata ha le avidità, le bizzarrie e le impazienze di una natura selvag-gia e di una civiltà raffinata. Boema, cosacca e parigina, Nata è tutta nervi e capricci, è una donna che pare trasformarsi a ogni momento. Giorgio più volte si accorge che le guance di Nata sono solcate di la-crime (in particolare quando la separazione tra i due è imminente), ma la contessa riprende subito la sua maschera fredda e altera. Atteggia-menti simili contrassegnano anche la principessina Zinaida di PrA: quando ella comincia a nascondere il suo segreto, capita al suo giova-nissimo innamorato di sorprenderla mentre il volto di lei è solcato di la-crime. Subito ella prende a comportarsi con crudele e rabbiosa ironia (cfr. PrA, p. 69). Zinaida del resto, come si è ricordato, ha ella pure in-dole mista, «altezzosa» e selvaggia, ed è volubile, capricciosa, impa-ziente. Similmente, Maria ha cambiamenti di espressione e di umore repentini, ancorché spesso essi sembrino e probabilmente siano cercati ad arte, simulati; ella passa dal riso allegro e provocante, al modo di una monella, alla tristezza e quasi alle lacrime (cfr. ivi, pp. 252–253, p. 262 e p. 272); abbassa timida gli occhi, è capace di dolcezza, tenerezza e di modestia (cfr. ivi, p. 258) e son questi i momenti in cui è più perico-losa a detta di chi la conosce bene (cfr. ivi, p. 273) e poi subito ha movenze da adescatrice.
CAPITOLO II – Echi di Turgenev in Verga 55
Nata ha irritazioni sorde e contenute, e molte sono le occasioni in cui irrompe la sua natura selvaggia. Quest’indole selvaggia, su cui Verga insiste moltissimo echeggiando Turgenev, si deve al fatto che ella ha sangue tartaro. Sanin percepisce con sgomento il fascino sel-vaggio di Maria: «Quegli occhi bigi, quasi feroci, quelle fossettine sul-le guancie, quelle treccie simili a serpenti tutto ciò si è dunque pro-prio appiccicato a lui» (ivi, p. 263). Se le trecce di Maria paiono a Sa-nin simili a serpenti, la treccia di Nata, allentata e quasi disciolta, sembra un giorno a Giorgio serpeggiare sulla spalliera della sedia. Quando egli aveva conosciuto Nata, gli era parso che «l’eleganza della veste stretta e increspata sulle anche» avvolgesse la donna «con ab-bracciamenti serpentini» (TR, p. 11). Sia Nata che Maria vengono pa-ragonate a più riprese a bestie feroci o selvatiche: Nata a una leonessa (ivi, pp. 9, 13 e 42) a una pantera (ivi, p. 60: ella medesima si parago-na a questo animale), a una fiera, a una lupa (ivi, p. 93); Maria a uno zibellino (AdP, p. 254), a un serpente (ivi, p. 272), a un avvoltoio che nel trionfo e nella sazietà della conquista stringe un uccello tra gli ar-tigli (ivi, p. 283). La pupilla e lo sguardo di Maria possono diventare felini.
Giorgio paragona l’amore che lo unisce a Nata a quello che univa Romeo a Giulietta (TR, p. 43) e Nata si appropria ironicamente di quel paragone (ivi, p. 43); è questa un’eco del confronto, sottilmente vena-to di sarcasmo, istituito da Maria tra l’amore di Enea e Didone e l’in-timità che lei stessa viene creando tra sé e Sanin (cfr. AdP, in partico-lare alle pp. 268, 269, 282 e 283). Nata, in un momento sentimental-mente intenso, chiede a Giorgio il quale desidera proteggerla dal gran freddo di andarle a prendere lo scialle e se lo incrocia sul pet-to. Maria Nikolaievna all’uscita dal teatro, quando è certa di avere ammaliato o quasi Sanin, lo prega di coprirla con lo scialle «e non si mosse punto mentre egli avviluppava con dolce tessuto le spalle di lei, veramente degne d’una regina» (AdP, p. 274). Una sera a teatro «Giorgio l’aiutava [Nata, N.d.A] a mettere il cappuccio nel fondo del palchetto; ella lasciava fare e lì, nella semi oscurità, ritta e palpitante, gli afferrò all’improvviso le tempia, e pallida, seria, risoluta, coll’oc-chio luccicante, senza dire una parola, gli appoggiò lungamente sulle labbra le labbra umide e calde» (TR, p. 54). In questa movenza, oltre al ricordo di AdP, potrebbe esservi anzi vi è quasi certamente ,
PARTE PRIMA – Giovanni Verga e la letteratura europea
56
anche il ricordo di una capricciosa iniziativa semi–erotica della princi-pessina Zinaida di PrA nei confronti del giovanissimo innamorato che ella non ama (è in segreto l’amante del padre di lui) ma con il quale si compiace di civettare: «Zinaida si voltò rapidamente e, allargando le braccia, abbracciò la mia testa, e mi baciò, con forza e ardore» (PrA, p. 101).
4. Un nido di nobili, Fumo, Eva, Tigre reale e Il marito di Elena: le donne, il lavoro e la terra natale in Verga e in Turgenev MB, com’è risaputo, fu il testo narrativo che esercitò la massima in-
fluenza, per imitazione e per contrasto, su MdE. Non intendo portare in questa sede alcun diretto contributo alla delineazione del parallelo MB–MdE. Mi preme invece di lumeggiare l’influenza di Turgenev su questo intenso episodio di bovarismo verghiano. Le due opere narrati-ve dello scrittore russo di cui si avverte la risonanza in MdE sono NdN e AdP. Nel tratto dal capitolo 12 al capitolo 16 di NdN la voce narran-te racconta, con procedimento di flash back, il corteggiamento, il ma-trimonio e la breve vita in comune di Fëdor Ivany Lavreckij e Vàrva-ra Pàvlovna Koròbina. Tale vita è contrassegnata fin dall’inizio dalla strenua ricerca di eleganza e di mondanità della donna; poi dall’adulterio di lei, dallo strazio di lui e dalla separazione dei due co-niugi. Naturalmente anche Turgenev ha tratto spunto da MB, tenendo-si però lontanissimo dal cosiddetto “bovarismo”, al quale MdE è da ascrivere per intero, fatta salva l’originalità della rielaborazione ver-ghiana6. Le vicende riconducibili alla intera estensione di MB (e di MdE) e dunque all’intera storia ivi narrata, sono concentrate tutte bre-vemente in NdN nel tratto dal capitolo 8 al capitolo 16.
Anche Turgenev, come poi il Verga di MdE, è animato da intenti antagonistici, nello scavo psicologico, nello sviluppo delle dinamiche affettive e perfino nella tecnica narrativa adottata, rispetto a quelli per-seguiti e conseguiti da Flaubert7. Sul piano tematico sia Turgenev che
6 Cfr. le note 13 e 14 al capitolo precedente. 7 Manca ancora uno studio puntuale delle forme, delle ragioni e degli esiti
dell’antagonismo Verga–Flaubert, anzi MdE–MB: cfr. per ora il paragrafo 3 del capitolo pre-cedente.
CAPITOLO II – Echi di Turgenev in Verga 57
Verga guardano ai mariti, ancorché Verga, a differenza di Turgenev, non riesca a imperniare l’azione sul protagonista maschile: entrambi gli autori motivano e seguono la parabola dell’amore riposto dai pro-tagonisti maschili, per ingenuità e per inesperienza, in donne frivole e superficiali; raccontano inoltre le reazioni dei mariti offesi e i loro svi-luppi a fronte delle ferite inferte loro dalle mogli. In MdE questa è la cellula espressiva la quale, crescendo e giungendo a compiuta pienez-za, coincide con l’intera storia narrata o quasi. Invece Lavreckij trova subito la forza di lasciare la moglie, malgrado l’ami e inizialmente speri in una sorta di sincero ravvedimento di lei a fronte del quale egli la perdonerebbe; e trova anche la forza di sopravvivere, sebbene riten-ga, per lunghi anni, che la parte migliore di sé sia stata distrutta per sempre. La storia principale raccontata in NdN, a prescindere dalle frequenti prolessi e analessi del racconto, comincia dopo questi nume-rosi anni trascorsi da Fëdor Ivany in solitudine fuori dalla patria. La personalità dell’uomo tradito matura in modo per lui inatteso a contat-to della sua terra e delle persone care ritrovate, fino ad aprirsi all’amo-re per una creatura questa volta della luce, la quale ricambia i suoi sentimenti. La vicenda avrà un esito triste, perché Vàrvara, che il ma-rito credeva morta, giungerà a dividere Lavreckij e Liza (Elizaveta Michàjlovna).
Autore ormai esperto dei segreti dell’arte Verga, a dire il vero, ave-va tentato di evitare in MdE la polarizzazione manichea dei due uni-versi di valori. A tal fine aveva raffigurato nei capitoli iniziali una E-lena ancora virtuosa la quale apprezza la dedizione del marito e difen-de l’onore suo e di Cesare per poi lasciarsi corrompere lentamente e sempre più profondamente dalle tentazioni della grande città e dalla frivolezza imperante negli ambienti salottieri e mondani. Verga aveva affiancato alla bella donna due altre figure femminili, molto legate a lei eppure da lei molto diverse: donn’Anna e Camilla, la madre e la sorella maggiore di Elena. La prima è tipo popolaresco sotto parvenze piccolo–borghesi; desiderosa di trovar marito alle figlie prive di dote è disposta, per conseguire lo scopo, a mettere da parte (d’accordo con il marito), la fedeltà alle virtù e al decoro piccolo–borghese: il rispetto di queste convenzioni sociali ha nociuto in fondo a Camilla (cfr. in MdE il dialogo tra donn’Anna e don Liborio alla fine del capitolo primo). Questa, ubbidiente e rassegnata al ruolo di eterna fidanzata, forse in-
PARTE PRIMA – Giovanni Verga e la letteratura europea 58
somma di zitella, non è in fondo dissimile dalle sorelle di Cesare, sal-vo che nell’educazione ricevuta, signorile e non piccolo–borghese–ru-sticana; non a caso le sorelle di Cesare, brutte, povere e perciò destina-te a non poter contrarre matrimonio, durante le sere a casa in compa-gnia della mamma e dello zio canonico fanno la calza, e Camilla, mentre tiene silenziosamente compagnia ai genitori e all’eterno fidan-zato, fa la trina, o ricama, o lavora ai ferri.
Viene insinuato il dubbio che Cesare sia divenuto remissivo e ne-vrotico a causa dell’educazione claustrale cui era stato sottoposto dal-lo zio. Analogamente, la voce narrante di NdN racconta la prima gio-vinezza di Lavreckij in modo tale da generare nel lettore il dubbio che l’immaturità del giovane (e dunque la scelta matrimoniale sbagliata) sia stata provocata dalla rigida, quasi sadica educazione pseudo–illu-ministica cui quegli era stato sottoposto dal padre.
Il ritorno alla terra natale, vero e proprio grembo materno portatore del sistema di valori al cui centro si trova la madre, è sempre “regres-sivamente” desiderato dall’eroe di Verga che si sia lasciato “irretire” da una maliarda. Quel ritorno costituisce per il protagonista maschile il momento della resa dei conti: l’ammissione del proprio fallimento (l’aver lasciato e l’aver tradito l’ordine sociale e affettivo “buono”) e la ribellione contro la seduttrice, ora sentita come un ostacolo o addi-rittura odiata. Costei rappresenta l’antitesi al sistema di valori incen-trato sulla madre, è anzi la pericolosa e attiva sorgente di un disordine sessuale capace, potenzialmente, di scardinare la famiglia fondata sul-l’indissolubile legame matrimoniale di coppia e anche, di conseguen-za, l’ordine sociale fondato su siffatto istituto familiare.
La bellissima e aristocratica Narcisa di Una peccatrice accetta di tornare con Pietro per il quale ha abbandonato il marito e il gran mondo , nella terra natale di lui, ma resasi conto che egli non si sen-te in grado di conciliare l’amore irregolare per lei con quello per la madre si uccide. Pietro, lungi dal riprendere e continuare il lavoro di scrittore per il teatro che gli aveva procurato il successo, la celebrità e l’amore di Narcisa, continuerà a vivere in modo mediocre e semi–ozioso. Enrico Lanti muore a casa dei genitori, maledicendo con odio quasi estremo, fino all’ultimo istante, Eva, la splendida donna dai co-stumi liberi, il nuovo amante della quale egli, subito prima del ritorno alla terra natale, ha ucciso con ferocia in duello. Eppure quella donna,
CAPITOLO II – Echi di Turgenev in Verga 59
che Enrico stesso, de facto, aveva spinto ad andare via dalla misera casa in ella viveva con lui; e che egli stesso aveva spinto tra le braccia dell’uomo che poi, per un senso di gelosia e di rivalsa patologici, le uccide: quella donna non gli aveva serbato rancore, e di null’altro era stata responsabile che di avere ingenuamente e lealmente giocato al-l’amore con Enrico. Eva non poteva sapere che avrebbe suscitato in lui un desiderio tanto acre e profondo quanto patologico e ambivalen-te, perché in ogni istante agiva, nella personalità del giovane, un attac-camento morboso alla madre e alla famiglia di origine, che non avreb-bero potuto approvare il legame con la ballerina. Cesare Dorello, ulti-mo personaggio importante della schiatta, colpisce la seduttrice di pu-gnale. In definitiva, il sistema di valori incarnato dalla terra natale e dalla madre non è più in grado di conseguire vittoria autentica contro la “donna irregolare” e di recuperare colui che si è lasciato disviare. Quel sistema e la madre conseguono una vendetta carica anche per lo-ro di dolore, non la vittoria.
Fa eccezione, come spesso è stato notato, il ritorno alla terra grem-bo–materno di Giorgio La Ferlita in TR. La seduttrice, moribonda, lo insegue, in qualche modo, e per un breve istante riesce nuovamente a farsi amare. Ma ancor prima che Nata muoia, Giorgio torna, pentito, in seno alla propria famiglia, dalla moglie e dal figlioletto. Anzitutto è da osservare che in questo romanzo manca del tutto la madre. Giorgio l’ha persa quando era un bimbo piccolissimo ed è stato allevato da un padre molto energico. Non par lecito equiparare il potere esercitato sul marito da Erminia, la moglie di Giorgio (casta ma soggetta ella pure a tentazioni) a quello, oscuro, concrezione straordinaria del pericoloso “regno delle madri”, che viene esercitato negli altri romanzi succitati dalle madri sui figli maschi. E tuttavia spetta senza dubbio a Erminia di fungere da continuazione diretta, naturale, priva di incrinature vi-stose, del sistema di valori famigliari incarnato dalla diade madre–terra natale. Direi che sulla chiusa di TR hanno agito in modo prepo-tente quella di Fumo e in certa misura anche quella di AdP.
Turgenev è assai poco sensibile all’importanza delle madri. Nel suo universo ha semmai peso determinante, com’è notissimo (e come reci-ta fin dal titolo il suo romanzo più noto: Padri e figli) il mondo morale legato alla figura del padre. Ma due pure e gentili figure di donna da ultimo attirano nuovamente a sé gli sviati (dalle maliarde) Litvinov e
PARTE PRIMA – Giovanni Verga e la letteratura europea 60
Sanin. Esse costituiscono il nerbo e l’esaltazione della coppia mono-gamica che mette al mondo figliuoli, li alleva con dedizione e già per questo contribuisce al sano sviluppo della società. Verga è stato attrat-to da queste situazioni, ma in TR non ne ha sviluppato in modo origi-nale alcuna potenzialità. Turgenev, a differenza del Verga di TR, è ben lontano dall’adesione a qualsivoglia cliché o stereotipo, e si muove con grande libertà tra le femminili creature della luce. Tat’jana Petro-vna contribuirà in maniera determinante alla redenzione dell’ex–fidan-zato, e lo aiuterà anche nell’intento, da lui perseguito, di modernizzare il lavoro agricolo e di elevare le condizioni di vita dei contadini. Sanin
il quale, lo si ribadisca, fornisce suggerimenti soprattutto per il per-sonaggio del marchese Alberti , invece, non potrà più sposare né Gemma né la figlia di lei: il suo “riscatto” è da lui medesimo solo va-gheggiato: mai si saprà se il viaggio per raggiungere Gemma e la sua famiglia gli darà quel che cerca (e forse egli non sa bene cosa cercare).
Il ritorno in patria più importante, nei romanzi di Turgenev, è quel-lo di Fëdor Ivany Lavreckij, personaggio sommamente tradizionale e fortemente innovatore. Il protagonista di NdN dovrà rinunziare all’a-matissima Liza, ma riuscirà a non perdersi d’animo e anzi a condurre, pur da persona celibe e sostanzialmente sola, una vita socialmente uti-lissima, tutta spesa in favore della modernizzazione del lavoro agrico-lo nelle grandi estensioni di territorio coltivabile e della emancipa-zione dei contadini da condizioni equiparabili a quelle dei servi della gleba.
L’osservazione del rapporto donna–famiglia–lavoro quale caratte-rizzava la vita delle plebi siciliane, e anche la consapevolezza del pro-blema acquisita mediante le letture sullo sfruttamento del lavoro fem-minile e minorile, fecero sì che Verga riproducesse artisticamente quel rapporto con uno sguardo dall’intelligenza profetica superiore, forse, rispetto a quella di Flaubert, di Turgenev e perfino di T. Mann. Quan-to a Turgenev però, occorre notare che Maria Nikolaievna è anche una donna dalla grande abilità nella gestione del proprio patrimonio e nell’accrescimento delle proprie ricchezze, così come lo è l’alquanto ambigua Odincova di Padri e figli.
Nel mondo rusticano di Verga qualche volta comandano gli uomini e a loro è affidata l’iniziativa e l’intraprendenza economica. Spesso in-vece, molto spesso, all’interno della famiglia comandano le donne, e
CAPITOLO II – Echi di Turgenev in Verga 61
tengono in soggezione i mariti (specie nei Malavoglia: si pensi alla Si-gnora moglie dello speziale, alla Vespa, alla Zuppidda moglie di ma-stro Turi, alla Mangiacarrubbe) e i figli maschi (così anche la madre di Rosso Malpelo). Esempi di formidabile intraprendenza economica le-gata a sicura capacità di tutela dei propri beni e interessi sono la baro-nessa madre di don Peppino in MdE e la baronessa Rubiera nel Ma-stro–don Gesualdo. Tutte le donne dei contadini e dei pescatori o qua-si tutte, però, oltre che attendere alle faccende domestiche e allevare la prole, lavorano più o meno duramente e industriosamente per contri-buire al bilancio famigliare: dalla madre del pastore Jeli alla Lupa alle donne di casa Malavoglia alla cugina Anna e alla Nunziata dello stes-so romanzo alla Rossa e a Lucia di Pane nero. Alcune donne forse non lavorano altrettanto ma sono economicamente indipendenti, come la Vespa, che è proprietaria di un piccolo fondo agricolo. Verga (l’io lirico verghiano) genialmente intuisce che il cambiamento antropolo-gico–strutturale della famiglia e della donna è connesso sia alla ca-pacità di questa di produrre reddito sia alla necessità che ciò avvenga (la triste sorte di Camilla sorella di Elena e delle sorelle di Cesare in-segnano…); e raffigura con geniale talento espressivo la detta intui-zione.
5. Un nido di nobili, Alla vigilia, Acque di primavera e il bovarismo del Marito di Elena Sia Vàrvara Pàvlovna Koròbina che Elena Dorello hanno avuto ge-
nitori privi di statura morale solida e propensi al calcolo utilitaristico, i quali hanno in qualche modo contribuito a far sì che nel cuore delle due giovani si annidasse la tendenza alla corruzione. I coniugi di NdN provengono da un ambiente sociale più elevato rispetto a quello da cui provengono i coniugi Dorello; tuttavia le due mogli sono creature di città mentre i loro mariti hanno origini campagnole. Fëdor Ivany e Cesare (diversamente da Charles Bovary) assecondano le inclinazioni delle mogli: le due coppie vivono prevalentemente in grandi città, ove le signore, grazie ai mariti (Vàrvara grazie alla consistente rendita di Fëdor Ivany , Elena grazie al duro lavoro di Cesare), possono vivere nel lusso e diventare lentamente regine della mondanità. Esse ottengo-
PARTE PRIMA – Giovanni Verga e la letteratura europea 62
no dunque con relativa facilità quel che la ex–contadina Emma arden-temente desidera e non riuscirà mai ad avere, con la sola eccezione del ballo nel castello dei marchesi d’Andervilliers. Grazie al loro straordi-nario “savoir faire” e al loro innato senso della eleganza, Vàrvara ed Elena riescono a compiere una vera e propria scalata sociale, talché i loro salotti vengono frequentati infine dalla più alta ed esclusiva ari-stocrazia oltre che da ogni sorta di avventurieri e pseudo–artisti alla moda. Entrambe commettono per la prima volta adulterio con uomini che appartengono a questa seconda categoria di professionisti della mondanità. Dopo la separazione da Vàrvara, Lavreckij per un certo periodo di tempo si tiene informato intorno alla vita di sua moglie me-diante la lettura di giornali e gazzette: «In seguito circolarono voci sempre più brutte; finalmente passò con chiasso per tutti i giornali una storia tragicomica, in cui sua moglie faceva una parte poco invidiabi-le» (NdN, p. 163); questo luogo ha probabilmente contribuito a sugge-rire l’idea della romanza insultante e sarcastica scritta dal poeta Fian-dura per vendicarsi di Elena (MdE, p. 112). La romanza viene pubbli-cata per tre facciate su uno di quei giornalacci da un foglio che in genere nessuno legge, ma che tutti leggono quando vi si tratta di una persona nota in vita. Un mese dopo anche Cesare Dorello viene a conoscenza «dello scempio turpe» che si era fatto del suo onore (ivi, p. 113).
Entrambe le protagoniste di AdP e i loro dialoghi e rapporti con Dimitri forniscono suggerimenti per il ritratto fisico e morale di Elena e per i suoi rapporti con il marito o con un amante. Produco solamente tre piccole variazioni verghiane: in AdP Gemma, durante una colazio-ne all’aperto in trattoria, viene a un certo punto trattata con insolenza da un ufficiale alticcio. Questi prende dalla tavola la rosa dirimpetto a Gemma, rosa che era stata colta dalla fanciulla; poi l’ufficiale torna verso i suoi e dà a fiutare la rosa a ciascuno: «Gemma dapprima si me-ravigliò; poi si spaventò e impallidì orribilmente… alla fine il suo spavento si mutò in isdegno; arrossì tutta, fin ai capelli i suoi occhi direttamente fissati sull’offensore, nell’istesso tempo si oscurarono e pigliarono fuoco, si riempirono di tenebre, si accesero della fiamma di una collera indomabile» (AdP, p. 188). Turgenev si sofferma in modo minuzioso sulle visibili ancorché silenziose reazioni indignate di Gemma. L’episodio viene ricontestualizzato in una zona di MdE in cui
CAPITOLO II – Echi di Turgenev in Verga 63
la donna è ancora una sposa casta ma, a causa della sua bellezza e dei suoi modi disinvolti da gran dama, riceve dal barone don Peppino le prime avances, da lei respinte con fermezza:
Una sera, nella vasta pianura già velata di ombra, […], egli raccolse un fio-re campestre che le era caduto dal petto, e se lo portò alle labbra. Elena ag-grottò le ciglia, e per tutta la sera fu di un umore orribile. Suo marito non le aveva mai visto quegli occhi sotto quelle sopracciglia aggrottate e quasi congiunte; né aveva mai sospettato quanta violenza di malumore ci potesse essere in quel carattere. (MdE, p. 51) La rosa è diventata un fiore di campo ma Verga descrive in modo
tanto accentuato quanto Turgenev la intensissima seppur silenziosa re-azione collerica della donna a fronte dell’oltraggio al suo pudore e al suo onore. Peraltro la trasformazione della rosa in un fiore di campo si deve forse alla influenza di un luogo di Rudin. Penso al punto in cui Pandalevskij, dopo aver riferito ad Aleksandra Pàvlovna che la comu-ne amica Dar’ja Michàjlovna intende presentarle un barone di Pietro-burgo, soggiunge galantemente: «Permettetemi di offrirvi questo splendido fiore di campo» (Rudin, p. 9); senonché «Aleksandra Pà-vlovna prese il fiore, ma fatto qualche passo, lo lasciò cadere»; l’uomo tace ma si sente «leggermente offeso dalla sorte del fiore da lui offer-to» (ibidem).
La protagonista di AdP, Maria Nikolaievna, viene costantemente raffigurata da Turgenev come una donna seducente e armoniosa ma anche forte, energica e possente: tali sono sia il suo corpo che la sua personalità: è molto alta di statura (AdP, p. 258), anzi d’una statura straordinaria per una donna (ivi, p. 249); il suo corpo ben fatto è al contempo incantevole e potente (cfr. ibidem e ivi, p. 253). Tutti sanno che Maria è «forte e potente» (ivi, p. 273). Ingenuamente e un pochino goffamente Verga si prova a donare a una Elena ancora vergine, e in-corrotta o quasi, le qualità cui Turgenev aveva dato risalto per la sua Circe fatale e letale. L’aspetto di Elena appare possente e implicita-mente invincibile alla madre di Cesare, mentre questa sta tentando, in-vano, di dissuadere il figlio dal proposito di sposare la giovane: «In quel momento le cadde sotto gli occhi il ritratto di Elena, inchiodato a capo del letto, nella sua bella cornice dorata, colle labbra e le soprac-ciglia possenti sul volto color d’ambra» (MdE, p. 31). Occorrerà sof-
PARTE PRIMA – Giovanni Verga e la letteratura europea 64
fermarsi nel prosieguo del presente studio su codesti colori, quello dell’ambra e quello dell’oro. AdP fornisce almeno in parte lo spunto elaborato in chiusura di
MdE: l’idea di mettere tra le mani di Cesare il pugnale con il quale questi, da ultimo, vibra molti colpi dopo avere afferrato saldamente la moglie adultera per un braccio. La maliarda e ninfomane Maria sta parlando a Sanin di una profezia che le è stata fatta da una zingara; se-condo la profezia ella, Maria, morirà di una non precisata morte vio-lenta. Maria protesta di non credere in queste superstizioni e commen-ta: «Si figuri Ippolito Sidori con un pugnale!…» (AdP, p. 268). Maria non riesce a immaginare per sé altra morte violenta che quella di peri-re assassinata per mano del marito. Alla pronta replica di Dimitri che si può morire anche di altra morte violenta, senza pugnale, ella ribatte infatti soltanto che egli, Dimitri, è un superstizioso, mentre lei non lo è affatto. Ippolito Sidori ha liberamente scelto di farsi mantenere lau-tamente dalla moglie ninfomane, capricciosa e autoritaria. Nondime-no, talvolta, raramente, manifesta qualche segno di insofferenza nei confronti di Maria.
La memoria poetica ha offerto probabilmente a Verga anche un luogo di AV. La giovane Elena Nikolàevna Stachova, quando comin-cia a innamorarsi del patriota bulgaro Dmitrij Nikanorovy Insarov annota nel suo diario «“Questa notte l’ho visto col pugnale in mano. E mi diceva: Ti ucciderò e mi ucciderò” Che sciocchezze!» (AV, p. 318). In verità Elena Nikolàevna e Insarov si sposeranno clandestinamente, ma il loro immenso amore reciproco verrà spezzato dalla morte di lui per tisi. Quando la malattia di Insarov si manifesta in tutta la sua gra-vità, il medico che gli presta le prime cure sentenzia: « Dopo la cri-si? I casi sono due: aut Caesar aut nihil» (ivi, p. 348).
La madre del personaggio femminile romantico di Turgenev si chiama Anna Vasìl’evna; anche la madre della protagonista di MdE si chiama Anna. Elena Nikolàevna, vera antitesi di Elena Dorello, dopo la morte del marito scompare nel nulla; si sa da voci confuse che rag-giunge la Bulgaria e che si dedica con eroismo e totale sacrificio di sé alla causa bulgara. L’alternativa aut Caesar aut nihil che nelle paro-le del medico pare significhi o vita o morte potrebbe aver suggerito il nome di battesimo del marito di Elena Dorello, chiamato in un pri-mo tempo, credo scherzosamente, don Menelao dall’editore Treves
CAPITOLO II – Echi di Turgenev in Verga 65
nella sua corrispondenza privata con Verga8. I due corni dell’alternati-va sono dialettizzati da Elena Nikolàevna in un esito sintetico: lei scompare a suo modo nel nulla come suo marito ma per continuare da persona viva l’opera di lui. L’alternativa si ripresenterà a Cesare Do-rello come interrogativo schiettamente passionale: egli sceglierà la morte per la moglie e forse anche per se stesso (una morte inferta per pugnale, in modo conforme al sogno di Elena Nikolàevna), piuttosto che separarsi da Elena ed eventualmente lasciarla a un altro uomo. Si tenga presente che MdE si chiude con questa scelta, che è e non è frut-to di un raptus, ma che di certo è priva di premeditazione riflessa; Ce-sare vibra più colpi con il pugnale: così si chiude il romanzo. Si tratta a rigore di una chiusa aperta (non è espressamente constatata né la morte di Elena né quella di suo marito).
6. L’ambra e l’esotismo: Madame Bovary, L’Éducation sentimentale, Acque di primavera e Il marito di Elena È da prendere ora in considerazione il valore espressivo del colore
dell’ambra e di quello dell’oro. Come Elena, anche la fresca fidanzata di Dimitri in AdP, Gemma, ha un incarnato pallido color dell’ambra9. L’attribuzione del colorito ambrato (o diafano e pallido, o dorato) alle belle donne è un luogo comune nei romanzi soprattutto francesi del-l’Ottocento, fa parte dell’armamentario dell’esotismo imperante lungo tutto il secolo. A questo gusto dell’esotico Turgenev e Verga fanno largo spazio nei loro romanzi imperniati su maliarde e donne fatali. Verga è l’autore italiano che si incorporò in maggior misura quel gu-sto, lasciando che si insinuasse perfino nelle novelle d’ambito rustica-no10. Anche di Emma il narratore scrive che le sue spalle nude aveva-
8 Su ciò cfr. M. DILLON WANKE, op. cit., p. 116, nota 11. 9 «Il viso liscio come avorio è chiaro come un’ambra, il lucido ondulante dei capelli ricor-
da la Giuditta dell’Allori ch’è al Palazzo Pitti» (AdP, pp. 162–163). 10 Verga paragona la bellezza di Mara, la figlia di massaro Agrippino, a quella della rosa.
Lo scrittore siciliano si avvale inoltre del connubio tra l’ambra e la carnagione femminile, an-corché ne mascheri l’origine esotica e lo adegui alle esigenze del verismo: «Mara era bella e fresca come una rosa, con quella mantellina bianca che sembrava l’agnello pasquale, e quella collana d’ambra che le faceva il collo bianco» (G. V., Jeli il pastore, in Id., Tutte le novelle, cit., vol. I, pp. 155–156, corsivi miei).
PARTE PRIMA – Giovanni Verga e la letteratura europea
66
no colore d’ambra (MB, p. 342); ciononostante in MB Flaubert si ap-plica a tenere a freno la propria forte nostalgia dell’esotismo. Conscio del fatto che questa si addice agli ambienti delle città, non agli am-bienti dei paesetti, egli lascia che essa abbia assai maggiore oggettiva-zione espressiva in ÉS, romanzo parigino, nel quale perfino alla sobria e materna protagonista femminile, Mme Arnoux, viene attribuita una carnagione ambrata e dorata.
L’adultera regale dell’epica omerica, Elena, come in certa misura anche l’omonimo personaggio di Verga, si era scelta seguendo la pro-pria inclinazione il marito da lei successivamente abbandonato. A suo modo Elena Dorello diventa ella pure una creatura regale, la regina dei salotti più esclusivi, l’amante di aristocratici dal gran nome. Ma soprat-tutto Elena Dorello, dagli occhi e dai capelli scuri, è contrassegnata, come dice il cognome, dal colore dell’oro. Perfino la sua pelle è dorata, sia per dono di natura sia grazie allo scintillio delle luci durante le serate mondane: «La padrona di casa, più bella di tutte nel suo pallore color d’ambra, sembrava volesse eclissarsi nel fondo della poltrona, colla fronte sulla palma, il bel braccio ignudo dorato dai riflessi di tutta quella luce» (MdE, p. 105). Ancora: «Ella era realmente felice, […] mentre andava pei suoi viali, nella sua vigna, nel suo podere, […] al braccio di suo marito, il padrone, che le si inginocchiava ai piedi, dietro la siepe, e le baciava gli stivalini di pelle dorata» (ivi, p. 35). «La baronessa soleva stare in una cameraccia […] ingombra di mobili dorati, di specchi» (ivi, p. 45); «In questo tempo Elena era occupatissima […] a ricever visite nel suo salottino color d’oro» (ivi, p. 61); «mentre ella rideva e folleg-giava in un salone tutto oro» (ivi, p. 64); «Nel salotto dai fiori azzurri tornava ad esser di lui, gli parlava guardandolo nello specchio […], mentre si svestiva lentamente, al lume delle candele che dorava la bian-chezza pallida delle sue spalle» (ivi, p. 63); «Nel salottino color d’oro, alla luce tranquilla della lampada, Elena, inginocchiata sul tappeto, si trastullava colla sua bambina» (ivi, p. 99); «Avrebbe voluto […] avere anche lei per la sua bimba una balia dal costume pittoresco, colle spalli-ne d’oro, tutta ricami e gale di nastri» (ivi, p. 101). «Il poetuccolo, […], aveva scritto una satira furibonda contro di lei. […] Ti rammenti, nel salotto color d’oro?» (ivi, p. 112)11. Degno di nota è il fatto che il salotto
11 Tutti i corsivi sono miei.
CAPITOLO II – Echi di Turgenev in Verga 67
color oro sia quello in cui la moglie si allontana progressivamente dal marito e il salotto dai fiori azzurri sia quello in cui al marito è possibile godere ancora di un poco di intimità con sua moglie. Il color dell’oro marca anzitutto, è ovvio, la tendenza di Elena verso il lusso, il suo culto delle apparenze, la frivolezza smodata e pagana.
7. Aspetti onomastici in Acque di Primavera e nel Marito di Elena Un cenno breve meritano i sistemi onomastici implicati in AdP e in
MdE, e la simbologia che a essi è sottesa o connessa; l’onomastica, si sa, è fondamentale per capire se un testo abbia stretto relazione con un altro testo e anche per intendere la qualità della relazione in oggetto. Il cognome Dorello è una sorta di calco dal cognome di Gemma (Rosel-li). La rosa è il fiore da cui Gemma è costantemente contrassegnata, il fiore che ella ama e dona a colui che ama. Il nome di battesimo della giovane allude sia al bocciolo o al fiore nascente sia, in modo impreci-sato, alla pietra preziosa. Il nome Gemma Roselli marca il fatto che il personaggio è una fanciulla nella primavera della vita, un bocciolo gentile, che ama le rose; il nome Elena rende ovvia, anche agli occhi degli altri personaggi di MdE, la somiglianza tra l’adultera di Verga e quella dell’antica epica greca a causa della quale si accese guerra tra Achei e Troiani. In questo quadro trova senso anche il nome della so-rella di Elena, Camilla. La principale Camilla della letteratura univer-sale è una vergine pagana. Verga apprezzò entrambe le connotazioni insite in questo nome proprio, la verginità (perché la sorella della im-pudica Elena è una eterna e castissima fidanzata) e la marca semantica di sutura tra civiltà greca e civiltà latino–romana (da Elena a Cesare). In AdP, tra l’altro, la ninfomane Maria cita spesso l’Eneide, e segna-tamente il momento dell’abbandono ai sensi da parte della regina Di-done e del principe troiano. Il contrassegno di una regalità essa pure pagana e addirittura imperiale, esercitata solo nell’ultimo fatto narrato, viene impresso per via onomastica anche sul marito di Elena, Cesare. È questo un nome poco diffuso in Sicilia, specie nel mondo rusticano. Cesare è pure il primo legittimo detentore del cognome Dorello. Ele-na, grazie a Cesare, può appagare la propria inclinazione al lusso e ac-quistare il crisma di una simbolica regalità, appunto una regalità
PARTE PRIMA – Giovanni Verga e la letteratura europea
68
d’accatto, se si vuole, della quale è insegna il colore dell’oro: «Sì, era stata educata come una principessa, don Liborio l’aveva detto. Aveva bisogno di vivere a quel modo, ciò la rialzava nella sua stima stessa, l’avrebbe resa più fiera e invulnerabile, rialzava anche lui, il marito che gliene dava il mezzo» (ivi p. 105)12.
In MdE, nel livello più superficiale, è rappresentato, come in tante opere narrative di Verga, un universo femminile scisso, mani-cheo: da una parte sta la madre, divinità tutelare della famiglia, da-trice di amore vero, capace di sacrificio assoluto per il figlio ma-schio e a rigore titolare del diritto che questi, nelle scelte importanti della vita, si comporti secondo il codice etico che da lei promana; dall’altra parte sta la seduttrice (Elena), capace di amare solo se stessa e di mirare alla soddisfazione della propria vanità e dei pro-pri piaceri puramente edonistici: il lusso, l’ammirazione degli uo-mini alla moda, “l’amore” di uomini altolocati, ricchi, ambiti o così parrebbe da tutte le donne della più elegante società. Di sif-fatte donne la narrativa di Turgenev della quale si è toccato è piena. Ma l’antitesi loro sono le femminili creature della luce, dalle quali promana un fascino delizioso, puro, quasi salvifico: creature che qualche volta vengono travolte dal passato dell’uomo che amano e che le ama (Lisa in NdN, in minor misura anche la giovanissima Natat’ja Alekséevna Lasùnskaja in Rudin), altre volte ricostruisco-no in modo ricco di frutti la loro vita, malgrado il dissesto in essa a un certo punto apportato dall’uomo amato, debole e indegno (Gemma in AdP), talora riaccolgono l’amante che, dopo essere ca-duto vittima della maliarda, si è sinceramente pentito; e cominciano con lui una vita coniugale che è anche una vita di lavoro, animata da ideali e progetti di vasto respiro, economicamente e socialmente innovativi (Tat’jana Petrovna in Fumo).
12 Si tratta di fantasticherie del marito, il quale inutilmente sogna che Elena si renda conto
di quel che egli fa per lei: «Cesare che l'amava come ella voleva essere amata, che viveva solo per lei, pel lusso in cui la faceva brillare, per le gioie che le procurava» (MdE, p. 105).
CAPITOLO II – Echi di Turgenev in Verga 69
8. Appendice: struttura e contenuti di Tigre reale e di Acque di Primavera a) Tigre reale: il primo capitolo è un prologo in cui un narratore al
corrente di tutto ciò che è accaduto, il quale è amico di Giorgio ed è anche un personaggio, ricorda e dà avvio a tutte le storie che saranno raccontate: queste appartengono tutte al passato e sono tutte già con-cluse al momento (presente) in cui egli racconta. Egli lascia intravede-re che le due storie principali sono quella dell’approdo di Giorgio al matrimonio e a una vita coniugale sostanzialmente felice e quella dell’amore infelice e senza speranza di Nata per Giorgio; a esse il nar-ratore aggiunge quella della passioncella adolescenziale (e ricambiata) di Erminia moglie di Giorgio per il cugino Carlo. Nel prologo ove le vicende sono accennate senza che venga rispettato l’ordine tempo-rale secondo cui accaddero il narratore fornisce le notizie essenziali sull’infanzia e sulla giovinezza del protagonista, fino al duello, alla partenza per Napoli e al ritorno a Firenze di Giorgio e sulle qualità e-stetiche e patrimoniali della sposa da lui sceltasi; al centro del prologo v’è il racconto–resoconto del matrimonio di Giorgio. Nelle ultime proposizioni il prologo diventa un epilogo; il narratore torna al presen-te da cui egli ricorda e racconta; egli lascia capire di aver conosciuto la “tigre reale”, già moribonda, e ora morta e forse dimenticata da tutti salvo che da lui, il narratore, il solo che ancora provi pietà di lei. Dal secondo al settimo capitolo viene raccontata la bizzarra e già un poco macabra vicenda della relazione sostanzialmente platonica tra Nata e Giorgio, fino alla partenza di lei da Firenze insieme al marito. Dall’ottavo all’ultimo capitolo (il diciottesimo) si racconta la vita co-niugale di Giorgio ed Erminia dopo la nascita del loro bimbo, Gianni-no, e fino alla morte di Nata. Questa seconda storia è intersecata da due vicende, che creano in essa degli sconvolgimenti brevi e destinati a non intaccarne la sostanziale quiete: la vicenda della presenza di Na-ta all’Albergo dei Bagni di Acireale, ove ella è venuta per morire vici-no a Giorgio, il quale è riafferrato da una passione nei confronti di lei che egli per primo avverte come insana, morbosa, lugubre ; e quella del rinascere di un’amicizia amorosa tra Erminia e il cugino Carlo. Questa seconda vicenda vale a bilanciare in qualche modo l’infedeltà di Giorgio, talché moglie e marito potranno tornare l’uno
PARTE PRIMA – Giovanni Verga e la letteratura europea
70
nelle braccia dell’altra con i conti a posto e in pareggio. La malattia che per un brevissimo periodo riduce quasi in fin di vita Erminia dopo che il piccolo Giannino è guarito, e mentre Nata è alla fine , vale (agli occhi dell’autore e, si presume, dei lettori) come espiazione e purificazione di Giorgio. Questi non cede più alle sirene, assiste a-morevolmente la moglie mentre quasi non si era curato dello stato del figlioletto per incontrarsi con Nata , e si riabilita così in modo definitivo.
b) Acque di primavera: Il primo capitolo è un prologo, in cui una
voce narrante impersonale e onnisciente narra di un signore cinquan-taduenne il quale una sera riflette con profondo pessimismo e disin-canto sulla vita fino a quando non gli capita tra le mani una piccola croce di granati; la crocetta induce il personaggio a ricordare un tempo molto remoto, fatti accaduti trenta anni prima. Dal capitolo 2 al capi-tolo 31 è raccontata la prima delle due storie principali. Un giovane russo, Dimitri Pavlovi Sanin, sta tornando in patria dopo aver visitato l’Italia. Durante una breve sosta a Francoforte reca per caso soccorso al fratello minore di una fanciulla italiana dolce e casta, Gemma Ro-selli, di modesta estrazione sociale (è figlia di confettieri). Gemma è fidanzata con un commerciante a nome Carlo Kluber. I Roselli, molto riconoscenti nei confronti di Sanin, lo trattengono a Francoforte per alcuni giorni. Durante una gita alla quale partecipa il fidanzato di Gemma, questa viene insolentita da un ufficiale alticcio. Kluber lascia correre; Sanin, invece, sfida a duello l’ufficiale. Gemma lascia il fi-danzato, che in fondo non ha mai amato e dal quale non si sente ama-ta. Sanin si innamora appassionatamente e teneramente di Gemma ed è da lei riamato. Egli le promette eterno amore e ottiene la promessa di matrimonio dalla madre di lei, vedova. Sanin decide di vendere la ter-ra che possiede in patria e di impiegarsi come diplomatico per poter vivere con Gemma e la famiglia di lei in Germania.
I capitoli 32 e 33 fungono da raccordo tra le due storie. Casualmen-
te Sanin incontra a Francoforte un antico compagno di scuola, Ippolito Sidori Polosoff, uomo fisicamente grasso, brutto e goffo il quale è riuscito a sposare la splendida e ricchissima Maria Nikolaievna, e conduce ora un’esistenza di gran lusso e priva di ogni preoccupazione.
CAPITOLO II – Echi di Turgenev in Verga 71
Sanin espone a Polosoff i propri disegni e questi accetta di condurlo da sua moglie, la quale si trova a Wiesbaden, affinché ella decida se acquistare o meno le terre di Sanin. Con l’assenso di Gemma, Sanin è costretto a separarsi per qualche giorno dalla fidanzata. Dal capitolo 34 al capitolo 43 è narrata la seconda delle due storie principali. A Wiesbaden Sanin prende alloggio nel medesimo albergo in cui dimo-rano i coniugi Polosoff e viene presentato a Maria Nikolaievna, la quale si rivela subito come una maliarda; Sanin, però, è certo di resi-sterle. Maria mostra interesse nei confronti del negozio che Sanin le propone e gli chiede di trattenersi un paio di giorni a Wiesbaden. Egli non comprende tempestivamente di avere a che fare con una vera e propria Circe la quale, con la complicità del marito, trae il massimo piacere dal fatto di sedurre carnalmente e ridurre in condizioni di schiavitù psicologica gli uomini che entrano nella sua cerchia. Il cini-co ruolo di Polosoff è appunto quello di procurare a Maria uomini at-traenti da ammaliare.
La seduzione del giovane fidanzato di Gemma, tanto innamorato di questa, costituisce per Maria una sfida particolarmente eccitante. Pri-ma che i pochi giorni da lui previsti per il soggiorno a Wiesbaden ab-biano fine, il giovane cade in potere della donna ninfomane, lascia con propria vergogna e disonore la fidanzata e parte con Maria e con Polo-soff per Parigi, sopportando tutte le umiliazioni e i supplizi di uno schiavo. Gli ultimi due capitoli, il 44 e il 45 fungono da epilogo. La mente di Sanin, trenta anni dopo, rammenta che egli fu buttato via da Maria al modo di un abito vecchio, che egli ritornò in patria e vi con-dusse una esistenza amarissima, priva di ogni affetto e ricca solo di pentimento per gli errori commessi. Il ritrovamento della crocetta do-natagli da Gemma trenta anni prima induce Sanin a cercarla. Egli si reca a Francoforte, riesce a sapere che Gemma si è sposata e si è tra-sferita con la famiglia di origine a New York. Egli le scrive ed ella gli risponde con una lettera affettuosa e pacata informando l’antico inna-morato che ella è moglie e madre felice di cinque figli. Da ultimo Gemma augura a Sanin di trovare la serenità che non ha avuto dopo la separazione da lei e dichiara che sarebbe molto felice di rivederlo seb-bene comprenda che ciò è molto improbabile. Gemma acclude alla let-tera un ritratto di sua figlia, che sta per sposarsi. La giovane è identica alla madre quale Sanin la ricorda. Questi invia a Marianna la crocetta
PARTE PRIMA – Giovanni Verga e la letteratura europea
72
di granati legata da una preziosa collana di perle come regalo di nozze, vende tutti i propri beni e parte per l’America.
In AdP Turgenev si scosta dalla verosimiglianza e fa rivivere miti antichi. Verga in TR persegue come di consueto l’effetto della verosi-miglianza. Ciò posto, egli in TR ha istituito una struttura palesemente e intenzionalmente chiastica rispetto a quella di AdP. Il prologo è an-che un epilogo in cui tutte le conclusioni sono tratte e nessun avveni-mento rimane aperto e suscettibile di sviluppo. L’incontro di Giorgio con la “mangiatrice di uomini” e la relazione di reciproco bizzarro amore tra i due cronologicamente avvengono prima del fidanzamento e del matrimonio di Giorgio con Erminia, la donna degli affetti dome-stici, lieti e puri. La “mangiatrice di uomini” si insinua in questa se-conda storia principale, contigua alla prima, e ottiene di procurare a Giorgio un momento di vertigine e di sbandamento, ma Giorgio si “ravvede” ancor prima che Nata muoia. L’addio contenuto nel tele-gramma di Nata che Giorgio riceve da ultimo è un addio per sempre, un “a non più rivederci”. L’autore si era infatti preoccupato di far di-re a Nata, in un colloquio con Giorgio nella prima storia, che ella lassù, nell’aldilà, non sarà più quel che è ora, sarà qualcosa di total-mente altro.
In AdP il prologo lascia comprendere che sono accadute sia vicen-de gentili sia vicende molto dolorose in un passato ormai lontano; ma sebbene sia prolettico rispetto alle due storie principali esso apre e ba-sta, non chiude nulla. Nella prima storia il protagonista incontra la donna deliziosa che desidera essere sua sposa devota (Gemma ritiene proprio dovere quello di abbracciare la religione di Sanin) innamorata e fedele e madre dei suoi figli; nella seconda storia il protagonista è ammaliato dalla donna fatale e letale e abbandona la fidanzata. Gem-ma non si insinua direttamente in questa seconda storia ma solo fug-gevolmente e per via epistolare. Ella risponde in modo conveniente ma senza il calore che Sanin probabilmente desiderava a una lettera che egli le invia da Wiesbaden mentre è ospite dei Polosoff; Sanin for-se sperava che ella gli avrebbe fornito con le proprie parole l’antidoto atto a liberarsi dall’influenza di Maria. L’epilogo impedisce qualsiasi sutura. Tutto è ancora aperto. Non sembra possibile che Gemma ab-bandonerà suo marito, ma certo ella accoglierà con affetto e dolcezza l’antico innamorato (laddove in TR Erminia ha dovuto mandare via il
CAPITOLO II – Echi di Turgenev in Verga 73
suo); quanto a Sanin, in lui vi è ancora l’inquietudine e la debolezza che ha rovinato la sua vita. Egli ritiene probabilmente che la sua ani-ma troverà pace solo accanto a Gemma e forse alla famiglia che ella si è formata, con particolare riguardo alla figlia di Gemma, identica alla giovane donna che Sanin aveva amato (Gemma ha inviato a Sanin il ritratto di Marianna). Ma Turgenev, straordinario pittore degli animi fiacchi e delle tentazioni morbose, insinua indirettamente e con mae-stria nel lettore l’idea che il viaggio di Sanin sia motivato soprattutto dal desiderio di conoscere la “reincarnazione” di Gemma, la figlia di lei, prossima al matrimonio con un giovane apprezzato dalla famiglia. AdP si trova al limite estremo del realismo ottocentesco, ma non in di-rezione del simbolismo sibbene della forma letteraria denominata let-teratura fantastica.
75
Capitolo III
Il Verga verista nel giovane Thomas Mann
1. L’Italiano Thomas Mann1 È ancora vivo il convincimento, caro purtroppo, tra fine anni Cin-
quanta del Novecento e albori del terzo millennio, soprattutto agli stu-
1 Abbreviazioni e sigle: Budd: T. MANN, Buddenbrooks. Verfall einer Familie, Frankfurt
am Main, Fischer Taschenbuch Verlag 1996, prima ediz. in questa collana: novembre 1989 (versione italiana: I Buddenbrook, traduzione di E. Pocar, Milano, Mondadori 2000, quarta ediz. nella Collana Oscar Classici moderni); Tr: T. M., Tristan. Novelle, mit einem Nachwort von R. K. Goldschmit–Jentner, Stuttgart, Philipp Reclam Jun., 1984 (versione italiana: Tri-stano, traduzione di E. Castellani, in T. M, Romanzi brevi, a cura e con Prefazione di R. Fer-tonani, Milano, Mondadori 1977, edizione Oscar Grandi Classici); TK: T. M., Tonio Kröger, in Id., Tonio Kröger. Mario und der Zauberer, Frankfurt am Main, Fischer Taschenbuch Ver-lag, prima ediz. in questa collana: luglio 1973 (versione italiana: T. M, Tonio Kröger, Milano, Rizzoli 1954, collana Biblioteca Universale); Mal: G. VERGA, I Malavoglia, cit. (cfr. nota 1 al capitolo I); RM3: G. V., Rosso Malpelo, in Id., Vita dei campi, a cura di C. Riccardi, Firenze, Le Monnier 1987, vol. XIV della Edizione nazionale delle Opere di Giovanni Verga (il rac-conto è qui citato secondo il testo base della edizione Riccardi, che è quello della editio prin-ceps della raccolta, Milano, Treves 1880); Conf: I. NIEVO, Le confessioni di un italiano, Mila-no, Garzanti 19762, 2 voll.; TrM: G. D’ANNUNZIO, Il trionfo della morte, cit. (cfr. nota 13 al capitolo I). Ho naturalmente sempre tenuto d’occhio, oltre a diverse altre traduzioni dei Budd, quella recentissima e assai reclamizzata procurata da S. Bortoli e M. Carbonaro e pubblicata nel 2007, per la Collana I Meridiani, dalla Casa Editrice Mondadori. Tutte le traduzioni dei Budd in lingua italiana sono per fortuna molto belle e fedeli allo spirito del romanzo, oltre che, nei limiti del possibile, alla lettera di esso. La traduzione che a me pare di gran lunga più riuscita ed efficace, sia per il suo valore estetico–espressivo che per la capacità di riprodurre in modo fedele alle intenzioni dell’autore (e dunque talvolta in modo parafrastico) il “gran romanzo” tedesco è quella fornita da A. Rho per gli editori Einaudi e Feltrinelli. Ho deciso tuttavia di utilizzare la versione di Pocar sia perché è quella la quale ha avuto la maggior dif-fusione negli ultimi decenni sia perché è quella più conosciuta dagli “italianisti” (“generalisti” o meri “contemporaneisti” che siano) e dagli studiosi italiani di letterature comparate che han-no origini disciplinari italianistiche: a questo insieme di studiosi il presente volume è destinato in maniera precipua. Ho citato Budd secondo la versione italiana di E. Pocar, ma nel testo non ho sempre riferito compiutamente i corrispettivi passi dell’originale tedesco. Ciò ho
PARTE PRIMA – Giovanni Verga e la letteratura europea 76
diosi italiani, secondo cui la letteratura italiana non suscitò mai in Thomas Mann interesse alcuno o quasi2: Eppure la vita di Mann tra il
fatto al solo fine di non appesantire troppo questo capitolo. Ogniqualvolta la traduzione di Po-car non riproduce in modo a parer mio del tutto adeguato il testo di Mann, ho inserito nel testo tra parentesi quadre i segmenti ed espressioni dubbi secondo l’originale tedesco all’interno della citazione in lingua italiana riportata tra virgolette basse e subito dopo le parti di tradu-zione che a quei segmenti si riferiscono. Com’era giusto, ho esteso questo criterio a tutti i testi di Mann citati nel presente capitolo.
2 Bibliografia essenziale: E. LÄMMERT, Thomas Mann–Buddenbrooks, in Aa.Vv., Der deutsche Roman. Vom Barock bis zur Gegenwart. Struktur und Geschichte, Band 2, heraus-gegeben von B. von Wiese, August Bagel Verlag, Düsseldorf 1963, pp. 190–233; P. SCHER-
RER–H. WYSLING, Quellenkritische Studien zum Werk Thomas Manns, Francke Verlag, Bern und München 1967, erster Band (fondamentali le pp. 7–22); I. JONAS, Thomas Mann und Ita-lien, Universitätsverlag Carl Winter, Heidelberg 1969; S. TYROFF, Namen bei Thomas Mann in den Erzählungen und den Romanen Buddenbrooks, Königliche Hoheit, Der Zauberberg, Bern, Lang 1975; B. MAYER, Die Briefe Thomas Manns. Regesten und Register, Band I, 1899–1933, Frankfurt am Main, S. Fischer Verlag 1976–1977, pp. 45 ss.; N. HAMILTON, The brothers Mann: the lives of Heinrich and Thomas Mann: 1871–1950 and 1875–1955, New Haven, Yale University press 1979 (tr. it.: N. H., I fratelli Mann, Milano, Garzanti 1983); H. LEHNERT, Thomas Mann: Buddenbrooks (1901), in Aa.Vv., Deutsche Romane des 20. Jahr-hunderts. Neue Interpretationen, herausgegeben von P. M. Lützeler, Königstein/Ts., Athä-neum Verlag GmbH 1983, pp. 31–50; M. BELLER, Thomas Mann und die italienische Litera-tur, in Aa.Vv., Buddenbrooks–Handbuch, herausgegeben von H. Koopmann, Stuttgart, Alfred Kröner Verlag 1995, pp. 243–246; P. DE MENDELSSOHN, Der Zauberer. Das Leben des deut-schen Schriftstellers Thomas Mann, 3 Bände, Frankfurt am Main, Fischer 1991 (specie Band 1, pp. 339 ss.); M. MAAR, Geisterbeschwörung. Thomas Manns und Andersens Märchen, «Merkur» (Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken), XLIX, Heft 2, Februar 1995, n. 551, pp. 108–119; J. VOGT, Thomas Manns »Buddenbrooks«, Wilhelm Fink Verlag, München 1995 (2., redivierte und ergänzte Auflage); H KURZKE, Thomas Mann. Das Leben als Kunstwerk, München, C. H. Beck 2000 (tr. it.: H. K., Thomas Mann, La vita come opera d’arte, Milano, Mondadori 2005, specie pp. 101–146); N. BADE, In search of Morten. Liter-ary Precursors of a Character in Thomas Mann's Buddenbrooks, «Journal of the Australasian Universities Language and Literature Association», 97, may 2002, pp. 39–50; L. K. WORLEY, Girls from Good Families: Tony Buddenbrook and Agathe Heidling, «German Quarterly», LXXVI–2003, n. 2, pp. 195–211; P. GAY, Nello specchio del romanzo: Dickens, Flaubert, Thomas Mann, Roma, Carocci 2004; H. KOOPMANN, Thomas Mann–Heinrich Mann: die un-gleichen Brüder, München, Beck 2005; Id, Thomas Mann e l’Italia in una nuova prospettiva, «Belfagor», LX–2005, fasc. IV, pp. 373–392; M. FRESCHI, Thomas Mann, Bologna, Il Mulino 2005 (è un buon manuale d’indole introduttiva); M. G. RICCOBONO, Gabriele D’Annunzio nel mondo incantato. Onomastica e altro in Thomas Mann, «Il nome del testo», VIII–2006, pp. 651–660; Ead., Verga e i suoi autori nel giovane Thomas Mann. Nomi, gioco, parodia in Lui-schen e in Anekdote, ivi, IX–2007, pp. 247–254; Ead., Verga nel Thomas Mann esordiente, (il testo è stato letto al XIX Congresso AISLLI, 19–24 settembre 2006; è in corso di stampa nei volumi degli Atti, ma lo si può leggere nell’archivio air.unimi all’indirizzo: http://air.unimi.it/; esso verte precipuamente sui rapporti tra il romanzo di A. DUMAS figlio La dame aux camé-lias, la novella di Mann Gefallen e l’Eva di G. Verga); P. PANIZZO, Ästhetizismus und Dema-gogie: Der Dilettant in Thomas Manns Frühwerk, Würzburg, Königshausen & Neumann
CAPITOLO III – Il Verga verista nel giovane Thomas Mann 77
1895 (quando aveva 20 anni) e il 1902 fu contraddistinta da un intenso e quasi frenetico alternarsi di soggiorni in Italia e di periodi a Monaco. Egli trascorse in Italia, o da solo o in compagnia del fratello Heinrich, almeno ventiquattro mesi, diciotto dei quali, tra l’ottobre 1896 e la fi-ne di aprile 1898 in maniera ininterrotta, senza soluzione di continuità. Si è sempre notato che diverse tra le prime prove letterarie (tutte no-velle) di Thomas Mann sono ambientate in Italia; che il primo gran romanzo, I Buddenbrook (1901), totalmente ambientato in Germania, fu concepito, avviato e in larga misura scritto tra Roma e Palestrina; che diversi capolavori “brevi”, successivi al gran romanzo, come Der Tod in Venedig (La morte a Venezia: 1912) o Mario und der Zauberer (Mario e il mago: 1930) sono ambientati in Italia; che uno dei tre pro-tagonisti dello Zauberberg (La montagna incantata: 1924) è l’italiano e meridionale Settembrini, portavoce dell’anima latina, umanistica, il-luministica e tollerante dell’Europa; che quest’anima italo–latina si scontra nel romanzo, vittoriosamente, con l’anima germanica, intolle-rante e per certi aspetti barbarica del continente, incarnata da Leo Na-phta; che nel Doktor Faustus (1947) compare a Palestrina sopra Roma nientemeno che il diavolo.
Questi dati di fatto avrebbero dovuto indurre la più viva diffidenza nei confronti dell’acritico convincimento secondo cui Thomas Mann non si interessò mai di letteratura italiana e men che meno durante la giovinezza. Invece tra il 1950 e la fine del secondo millennio transitano di premessa in premessa alle traduzioni in lingua italiana e di saggio cri-tico in saggio critico sulla narrativa manniana parole come queste, che si leggono nella introduzione, redatta da una molto fine conoscitrice della cultura tedesca, a una autorevolissima traduzione italiana dei Budd: 2007. Ovviamente il principale strumento bibliografico per informazioni e aggiornamenti sui con-tributi critici circa l’autore del Novecento forse più studiato del nostro pianeta è la Banca dati MLA International Bibliography. Fondamentale anche GERMANISTIK, la rassegna bibliografic trime-strale, supporto cartaceo, degli studi sulla lingua, sulla letteratura tedesca e sulle discipline affini, pubblicata da Niemeyer dal 1960. Sitografia essenziale: http:// www. fischerverlage.de (al cui in-terno un intero link è riservato al sommo scrittore); http:// www.thomasmann.de/thomasmann/home; http://www. ub.uni–duesseldorf.de/home/ueber_uns/son der/mann/virtbib; http://www.bibliothek.uni–augsburg. de/fachinformation/-germanistik/sondersamml/jonas/bibliogr; http://www.ub.fu–berlin.de/internet quel-len/fachinformation/germanistik/autoren; http://www.tmfm.de/frames.htm; http://www.tho mas–mann–haus.de; http://corpus.en.kyushu–u.ac.jp; http://webtext.library.yale.edu/xml2html/ beine-cke.manncon.html; http://www.bibilint.de/germanistikbibliographie.html.
PARTE PRIMA – Giovanni Verga e la letteratura europea
78
giovane di poco più di vent’anni […], alla morte del padre, […] Mann decide di godersi la «libertà sociale» e la possibilità di «stare ad aspettare» che il modesto assegno di cui è beneficiario gli consente. Di qui la risoluzione di raggiungere il fratello Heinrich in Italia, un paese che per Mann non è quello dove fioriscono i limoni ma soltanto un nascondiglio per la sua situazione di transfuga borghese3. I pregiudizi sono tenaci, tenacissimi4. Codesto giudizio o pregiu-
dizio, poi, si è radicato in modo particolarmente profondo per due ragioni tra loro indipendenti e disparate: 1) Perché fino a non molti anni or sono gran parte della critica letteraria italiana ha letto Tho-mas Mann attraverso le lenti deformanti fornite dal modesto e gra-fomane filosofo marxista Giörgy Lukács. Nei Buddenbrook, a pre-scindere dalle intenzioni dell’autore attratto dall’idea del pro-
3 T. MANN, I Buddenbrook, Milano, Garzanti 1983, traduzione di Furio Jesi e di S. Spe-
ciale Scalia, con prefazione di C. Magris e introduzione di A. Giubertoni, pp. XX–XXI. 4 Nell’ambito della disciplina denominata Letteratura italiana l’atto di morte della tetra
“critica sociologica” e della “zuppa” (il sempre–uguale giudizio storico) a essa strutturalmente sottesa, è stato pronunziato a Napoli, nel settembre 2007, durante il Congresso annuale dell’Associazione Degli Italianisti, per bocca di Amedeo Quondam e di Marco Santagata, i quali spiritosamente si sono espressi in modo lievemente allegorico: è stato asserito che oc-corre superare il modo desanctisiano di pensare la storia letteraria, ma il nome di De Sanctis velava appena quello di Gramsci, oggetto reale della polemica. È stato asserito altresì che per decenni si è voluto far credere che i frutti splendidi dell’intera letteratura italiana siano deca-denza, e che tale sia la letteratura in genere quando non è espressione del gusto delle masse; contro questa credenza è stato rivendicato il valore dello “specifico letterario” come valore che è in rapporto intimo con il mito, quasi il contrario della decadenza. È stato infine asserito che pensare la storia letteraria significa raccontare la letteratura. Questo ha fatto per decenni il principale studioso di estetica e critico letterario del Novecento, cioè Benedetto Croce. Mi piace ricordare che quando ero studentessa io, la tetra “zuppa”, il sempre–uguale preteso giu-dizio storico veniva proposto per illustrare ogni secolo della letteraratura italiana: vi era sem-pre, nell’età di Dante, poi in quella di Petrarca e Boccaccio, poi in età umanistica, poi in età rinascimentale e su su fino a quella risorgimentale una borghesia in ascesa che lottava contro una classe feudal–nobiliare in decadenza e che tentava, con esito sostanzialmente vittorioso, di conquistare l’egemonia (non ho mai capito come la classe “superiore” e avversa alla bor-ghesia rientrasse poi di nuovo sempre in scena). Dopo il 1848 e il Risorgimento, cioè dopo che l’egemonia a quanto sembrava era stata davvero conquistata dalla borghesia, questa si trovava subito a fronteggiare la nuova e palingenetica classe in ascesa: il proletariato. Per sconfiggerlo essa creava fascismi, nazismi e altri orrori. Lo sterminio sistematico delle genti (finora ben più che cento milioni di morti accertati), organizzato, per sopravvivere, dai corrot-tissimi ordinamenti politici comunisti nati dopo la rivoluzione bolscevica e fondati sul terrore di massa, era invece doloroso sì ma necessario ai fini della definitiva vittoria del proletariato e della instaurazione nel mondo di una società senza classi in cui chissà perché dominerebbe la piena solidarietà.
CAPITOLO III – Il Verga verista nel giovane Thomas Mann 79
gressivo infiacchirsi, quasi patologico, di una stirpe che era stata per lungo tempo capace di produrre ricchezza e di accrescere e afferma-re il proprio prestigio sociale , sono celebrate l’operosità di tutti i ceti produttivi e anche, malgrado la forte riluttanza della concreta persona dell’autore, la mobilità sociale che contrassegna le demo-crazie liberali avanzate o in procinto di avanzare. Molte vicende di declino di commerci un tempo floridi e di ascesa di nuove imprese commerciali sono adombrate nel gran romanzo. Viene raccontata doviziosamente, in particolare, l’ascesa dei parvenus Hagenström, i quali alla fine della storia acquistano la lussuosa casa sulla Men-gstraße, che era stata il simbolo della compiuta affermazione socio–economica dei signorili Buddenbrook (signorili anche grazie a una avveduta politica di matrimoni e relazioni famigliari, che pure gli Hagenström sapranno perseguire accortamente). Lukács e con lui tutti coloro che a lui si sono accodati, in particolare nei paesi a re-gime comunista e, duole dirlo, in Italia ma non certo nella Germania libera ha scorto, incredibilmente, nel romanzo della operosità di tutti i ceti produttivi e della inevitabile, necessaria mobilità sociale, corrispettiva alla quasi–democrazia politica e alla libertà economica, il romanzo della ineluttabile decadenza della borghesia tedesca, che rappresenterebbe in sostanza l’ineluttabile decadenza della borghe-sia tout court (!!!). 2) Perché il succitato pregiudizio fu accreditato da Mann medesimo: «Almeno io», ha affermato Thomas Mann «ci vivevo [in Italia, N.d.A] non per amore del mezzogiorno, al quale in fondo non volevo bene, ma soltanto perché in patria non c’era posto per me»5. Caute ma intelligenti riserve intorno a questo banalissimo ma sempre efficace luogo comune di matrice romantica (l’artista per qualche motivo è un esule, non può stare in patria!), apparentemente ricco di suggestione e nella fattispecie privo di senso, sono state e-spresse a mia conoscenza, fino agli albori del terzo millennio, solo da studiosi di area anglosassone; anche, fortunatamente, dal più noto biografo di Mann. Questi, Nigel Hamilton, di madrelingua inglese, ha commentato così le espressioni del Contributo autobiografico che si sono citate: «Era una strana confessione da parte di un uomo
5 Cfr. T. MANN, Saggio autobiografico, in Id., Scritti minori, Milano, Monda-
dori, 1958, p. 70.
PARTE PRIMA – Giovanni Verga e la letteratura europea
80
che più tardi sarebbe diventato famoso anche per La morte a Vene-zia»6.
Gli studiosi dovrebbero sapere che gli artisti amano dare di se stessi biografie mitizzate; e nondimeno ancora troppo spesso le di-chiarazioni degli artisti vengono assunte come elemento di prova. Numerosissime sono le affermazioni di Thomas Mann relative ai rapporti tra la sua narrativa, la sua vita reale e i “suoi” autori che so-no state smentite nel corso dei decenni dall’acribia degli studiosi te-deschi. Anche nel caso dei rapporti tra la narrativa giovanile di Mann e l’Italia a smentire la tesi che lo scrittore soggiornasse in Italia quasi incidentalmente, senza mai accostarsi alla cultura italiana coeva, anzi come un turista appartato che null’altro ammirava se non i monu-menti del paese ospitante, e perfino quelli in modo relativamente di-staccato (Tonio Kröger stesso dice a proposito dei monumenti dell’architettura e dell’arte figurativa italiana che tale “bellezza” or-mai lo rende nervoso): a smentire tutto questo sono i soli fatti accer-tabili, accertati e che davvero contino, cioè le opere narrative com-poste dal sommo scrittore durante la sua gioventù (e anche oltre, a dire il vero). Peraltro, tra le ammissioni circa i suoi rapporti con l’Italia formulate da Thomas Mann nella sua vecchiaia vi fu quella che in gioventù egli capiva abbastanza bene la lingua italiana7. Per-ché a questa dichiarazione non si è attribuita l’importanza che meri-tava? Occorre tentare l’impresa di ristabilire il vero anche in ordine ai rapporti tra Thomas Mann e la cultura italiana, pur sapendo che il tentativo di sradicare i pregiudizi richiede infinita pazienza e procura spesso reazioni astiose da parte di chi, a vario titolo, nel pregiudizio si è adagiato e vi trova un certo tornaconto.
L’esame della produzione narrativa di Thomas Mann fino al 1900 e oltre ha già mostrato che l’incontro con la letteratura e cultura italiana fu assai fecondo: la novella Gefallen (Perduta), del 1894, dunque an-tecedente il primo viaggio di Thomas Mann in Italia, è una riscrittura molto concisa, oscillante tra il serio e il faceto, del romanzo di Gio-vanni Verga Eva (e si avvertono echi di un altro romanzo di Verga,
6 N. HAMILTON, I fratelli Mann, cit., p. 81. 7 In una lettera scritta nel 1948 all’editore Mondadori. Cfr. T. MANN, Lettere a italiani,
con introduzione e commento di L. Mazzucchetti, Milano, Il Saggiatore 1962.
CAPITOLO III – Il Verga verista nel giovane Thomas Mann 81
MdE); le novelle Luischen (1900) e Anekdote (1908) sono parodie di Eva e del Marito di Elena costruite attraverso un raffinato e molto complicato gioco intertestuale con i testi della letteratura francese e russa che più erano implicati nei romanzi di Verga; l’importante rac-conto lungo Tristan (1900–1903) è una parodia incantevole del ro-manzo di Gabriele D’Annunzio Le vergini delle rocce. Questo è lo sfondo da tener presente8.
Vorrei anche precisare che qui non si ambisce a perseguire una Quellenforschung, sebbene la presente ricerca possa forse dare qualche stimolo e qualche dato ulteriore a coloro che conducono la Quellenforschung. Non si mettono mai in discussione, nel presente studio, i risultati cui filologi e critici eminenti sono giunti, non sen-za esplicite ammissioni di Thomas Mann, in ordine alle cosiddette “fonti” della narrativa di questo. Ho sempre trovato riscontro ai ri-sultati raggiunti da quei valorosi critici e filologi. Non vi è dubbio, per esempio, che il romanzo Ein Mahlstrom abbia fornito ai Budd un importante evento iniziale: l’arrivo di una dura lettera al padre da parte di un figlio ribelle9. È altresì molto verosimile che l’antroponomastica del romanzo norvegese abbia influenzato quella dei Budd. I tasselli ulteriori che qui sono offerti non si trovano dunque in competizione con i risultati or ora detti. Essi si aggiun-gono a quei risultati e li affiancano. Der Zauberer, il mago, è tale appunto perché un medesimo nome, una parola, un’espressione ri-mandano a una fitta quantità di eventi e occasioni della vita reale, della storia e soprattutto della letteratura universale. Da questo in-tricato e geniale reticolo di rimandi trae precipuamente origine, tra l’altro, il modo della manniana creazione e complessa disposizione
8 Cfr. nota 1. 9 J. LIE, Ein Mahlstrom, Leipzig, Druck und Verlag von Philipp Reclam jun. [s. d. ma
1888, N.d.A.]. Giustamente il maggiore biografo di Mann fa battere l’accento sul fatto che Lie racconta «die Geschichte vom Verfall einer reichen und angesehenen Kauffmannsfamilie» (ma i modi di questo tracollo, va pur detto, son da addebitare precipuamente all’anziano, cini-co e vizioso capofamiglia) e che «die Schwester der Hauptfigur dieser Erzählung heißt Anto-nie, und ihr Gatte ist Konsul Grüner, und diese beiden Namen blieben Thomas Mann haften» (P. DE MENDELSSOHN, op. cit., p. 394 (Band 1). Thomas Mann medesimo si compiacque di indicare nella narrativa scandinava a lui di poco anteriore e da lui letta in traduzione tedesca la fonte principale dei Budd.
PARTE PRIMA – Giovanni Verga e la letteratura europea
82
espressiva dell’insieme dei significati nel cosiddetto testo dalla “struttura a strati”10.
2. Una finestra sull’onomastica dei Buddenbrook Nella narrativa giovanile di Mann parecchi antroponimi sono ricor-
renti. Gerda Arnoldsen è il nome della moglie olandese di Thomas Buddenbrook; si chiama Kaj Mölln il migliore e unico amico di Han-no. Anche prima di leggere i pregevoli scritti di Michael Maar sulla relazione tra la narrativa manniana e le fiabe di Hans Christian Ander-sen avevo ben compreso che mediante i nomi di battesimo Gerda e Kai si allude corposamente alla fiaba La regina delle nevi; che il co-gnome Arnoldsen ricorda da vicino quello di Andersen; che non per caso lo stravagante fratello di Thomas e zio di Hanno si chiama Chri-stian. Gerda è però anche il nome di battesimo della crudele signora von Rinnlingen di Il piccolo signor Friedemann; Johannes è il nome del deforme e sventurato signor Friedemann; il vecchio e imperioso nonno Buddenbrook si chiama Johann — e questo nome ricorre già tra i suoi antenati, secondo che è scritto nel libro di famiglia —, suo figlio Jean e il loro rispettivamente pronipotino e nipotino, figlio di Thomas, è un altro Johann, da tutti chiamato Hanno; Friederike, Henriette e Pfiffi sono le sorelle del signor Friedemann ma recano gli stessi nomi in Budd le figlie di Gotthold, il ribelle figlio di primo letto di Johann Buddenbrook. Christian è il nome di battesimo anche del timidissimo avvocato Jacoby, marito della malefica Amra in Luischen; del pari il cognome Kröger è quello della famiglia di origine della signora Elisa-beth Buddenbrook, madre di Thomas, Christian, Tony e Klara e nonna paterna di Hanno. Numerosi altri esempi si potrebbero citare.
Nei Budd (1901) e in TK (1904) si svolgono due dialoghi a sfondo onomastico assai simili tra loro. Nel gran romanzo la signorina Tony Buddenbrook non ha compreso quale sia il nome di battesimo del fi-glio maggiore della coppia Schwarzkopf, presso cui ella è ospite pa-
10 Sulla questione cfr. in particolare il bel libro di L. SAARILUOVA, Nietzsche als roman.
Über die Sinnkonstituierung in Thomas Manns »Doktor Faustus«, Tübingen, Max Niemeyer Verlag 1996.
CAPITOLO III – Il Verga verista nel giovane Thomas Mann 83
gante per una vacanza a Travemünde, sul Baltico. Ella intuisce vaga-mente che non si tratta di un normale nome tedesco e chiede esplici-tamente delucidazioni al giovanotto (Budd, p. 128; tr. it. pp. 120–121). Nel romanzo breve Tonio ama un giovane adolescente suo compagno di scuola, Hans, che non ricambia però i sentimenti dell’altro. Hans vuol conoscere le ragioni del nome esotico e strano dell’amico, non senza lasciare intuire che quel nome così poco tedesco marca una dif-ferenza di gusti e di sensibilità profonda tra loro due (TK, pp. 14–15; tr. it. pp. 19–20). Dal primo colloquio si apprende che il giovane Schwarzkopf porta il nome Morten in onore di un nonno che aveva sangue norvegese, dal secondo che a Tonio è stato dato il nome di uno zio materno della madre, Antonio. La madre di Tonio, apprendiamo poi dalla voce narrante, si chiama Consuelo. Antonio è nome sia spa-gnolo sia portoghese (e dunque latino–americano) sia italiano. Con-suelo è nome spagnolo ma non portoghese né italiano. Le origini di Tonio, all’inizio del racconto, rimangono dunque incerte, legate a un generico meridione o ispanico o latino–americano.
I due nomi, quello sommamente nordico e quello meridionale ven-gono qualificati nei due testi mediante formule o almeno attraverso aggettivi identici: esotico («ausländisch») e particolare o speciale («besonderer»). Nei suoi aspetti più evidenti, dunque, il sistema antro-ponomastico interno al gran romanzo tende a rinsaldare il legame tra le città anseatiche tedesche e il settentrione in direzione della Scandi-navia. Pare un sistema compatto, quasi una gabbia. Nondimeno, pres-soché in tutta la narrativa giovanile di Mann molti antroponimi recano una forte dose di ambiguità: anche quando sono squisitamente tede-schi hanno in sé, più o meno mascherato, il proprio sosia “latino” o i-taliano senz’altro (la Irma di Gefallen, la Anna Margarethe Rosa Amalie di Luischen, la Gabriele di Tristan, il Tonio di TK, la Angela di Anekdote e via dicendo). Quanto a TK, il protagonista pronunzia e poi mette in scena concretamente, recandosi a trascorrere un periodo di vacanza in Danimarca, l’apologia del settentrione scandinavo in e-splicita contrapposizione alla stucchevole Italia, alla quale secondo lui nulla o quasi deve l’eccellenza artistica che egli, giovane appena tren-tenne, ha già conquistato11.
11 «L’Italia mi è completamente indifferente! [Italien ist mir bis zur Verachtung gleich-
PARTE PRIMA – Giovanni Verga e la letteratura europea 84
La contrapposizione Italia Danimarca (più Scandinavia) e Sud Nord dell’Europa senza dubbio trae alimento dal fatto che nelle vene del protagonista scorre anche un poco di sangue latino o almeno ispanico. Insomma, la scelta del nome Antonio e del diminutivo Tonio sono determinate dalla volontà che il nome iberico (spagnolo, porto-ghese e latino–americano) corrisponda perfettamente alla sua versione italiana, sia fonicamente che graficamente, il che non sarebbe accadu-to se lo zio di Tonio, il fratello di Consuelo, si fosse chiamato José o Pedro o Miguel o Ignacio o Cornejo. La scelta onomastica rinvia all’Italia. Peraltro Thomas Mann, quando concepì e scrisse TK, tenne un atteggiamento esattamente opposto nei confronti dell’Italia rispetto a quello espresso dal suo personaggio. Alla fine di settembre del 1902, infatti, egli lasciò in modo improvviso e quasi precipitoso Monaco di Baviera, piantando in asso lo stampatore, i suoi racconti brevi che sa-rebbero dovuti uscire in volume entro quell’autunno con il titolo di Tristan e l’editore Fischer. Venne in Italia, si installò a Riva del Garda e lì, durante alcune settimane di intenso fervore creativo, scrisse TK.
Nei Budd non vi è mai polemica nei confronti del mondo latino. Thomas e Gerda Buddenbrook compiono in Italia, fino a Firenze, il loro lungo viaggio di nozze, a dire il vero senza che il lettore li segua. Thomas Buddenbrook prende ad apprezzare l’Italia o almeno certi suoi aspetti: per esempio la religione cattolica, il suo clero e i suoi riti sembrano allo scettico ultimo capo della dinastia di commercianti di Lubecca più attraenti che non la religione luterana dei suoi padri. Budd è un romanzo privo del conflitto tra le due anime dell’Europa, quella latina e quella germanica, il Sud e il Nord, conflitto che verrà
gültig!] passato il tempo in cui mi figuravo che quello fosse il paese per me [dorthin zu ge-hören]. Arte, nevvero? Cielo di velluto azzurro, vino generoso e dolce sensualità… A farla breve non mi va. Rinuncio. Tutta quella bellezza mi rende nervoso. E poi non posso soffrire quegli uomini tremendamente vivaci, laggiù, col loro sguardo scuro d’animale. Dagli occhi di quei latini non traspare la coscienza… No, ora vado un po’ in Danimarca. […] Sì, e m’aspetto del buono. Per caso, non sono ancora mai arrivato fin lassù, pur essendo stato tanto vicino alla frontiera danese durante tutta la giovinezza; e tuttavia conosco e amo il paese da sempre. Questa inclinazione per il settentrione deve venirmi da mio padre, poiché mia madre, vera-mente, era più portata per la bellezza […]. Ma prenda i libri che vengono scritti lassù, quei li-bri profondi, puri e pieni di umorismo, Lisaveta: per me non c’è niente che li superi: li amo. […]. Prenda pure soltanto i cognomi, i nomi, dei quali si orna la gente di lassù e che sono già diffusi da noi: un suono come “Ingeborg”, un arpeggio della più pura poesia» (TK, pp. 41–42: le espressioni in tedesco si leggono a p. 41; tr. it. pp. 48–49).
CAPITOLO III – Il Verga verista nel giovane Thomas Mann 85
messo a tema nello Zauberberg e che in TK è superficialmente abboz-zato. Il Meridione è in Budd rappresentato eminentemente da Monaco di Baviera, città regale ma pigra, nella quale l’ambiente dei commer-cianti non è formato da persone distinte e raffinate; anche a cagione di ciò la gran signora borghese Tony Buddenbrook non riuscirà ad am-bientarvisi.
L’antroponomastica diciamo latina si affaccia in verità nel gran romanzo per via femminile e vi ha un ruolo importante ancorché un pochino camuffato. Si può dire che il nome Antonio e le sue varianti nelle diverse lingue europee, costituisca il caso forse più importante e interessante (in competizione con Johannes e le sue varianti) di ricor-renza frequente di un determinato nome nella narrativa di Mann com-presa all’interno di un limitato giro di anni. Troviamo nel gran roman-zo madame Antoinette Duchamps, moglie del vecchio Johann Bud-denbrook, la quale da parte di suo nonno ha una origine mezzo latina, svizzera francese: il nome Antoinette (in italiano Antonietta), è dal marito ridotto al vezzeggiativo affettuoso Nette (Budd, p. 58; tr. it. p. 52). Nello stesso romanzo la nipotina della signora, la figlia del console Jean Buddenbrook e di Elisabeth Kröger si chiama Antonie (in italiano Antonia). Fin da piccola e poi per sempre dai familiari e dagli intimi Antonie è chiamata con il vezzeggiativo affettuoso Tony: codesto ipo-coristico è una maschera efficacissima, perché toglie, almeno grafica-mente, al vezzeggiativo ogni esplicito sapore latino. Ancora nel gran romanzo tra i camerieri della famiglia vi è il fidato Anton, figura scialba ma priva di ogni macchia, alieno da ogni lite o contrasto con i suoi da-tori di lavoro, a differenza di quasi tutti gli altri membri della servitù. Anton lavora dapprima per Jean e la sua famiglia e poi passa al servi-zio di Thomas e Gerda. In Tr (1901–1903) si chiamano Anton Klöter-jahn il marito della protagonista femminile e il bimbetto lattante nato da quella unione. Ci imbattiamo poi in Antonio Kröger, da tutti, e da se medesimo per primo, chiamato Tonio, diminutivo invero un pochino goffo. Quanto all’altro nome presente in modo assiduo nella narrativa giovanile manniana, esso viene dall’autore variamente manipolato, ma senza che mai esso sia riconducibile all’Italia: Giovanni–Gianni non ri-corre, né ricorrono suoi ipocoristici; abbondano le sue versioni francesi e tedesche: Johannes Friedemann; Johann Buddenbrook (dagli antena-ti omonimi); Jean Buddenbrook; Hanno Buddenbrook e così via.
PARTE PRIMA – Giovanni Verga e la letteratura europea 86
Vi è qualcosa di comune tra coloro il cui nome di battesimo è ri-conducibile a una manipolazione di Antonio, e anche ai suoi corrispet-tivi maschili e femminili nelle diverse lingue? La prima superficiale risposta è che i personaggi in questione sono tutti care persone, figure simpatiche o addirittura simpaticissime agli occhi del narratore e dei lettori, vuoi quando sono sommamente leggiadre e aggraziate (Anto-nie Buddenbrook) vuoi quando sono sgraziate e volgari (Anton Klö-terjahn). Qualcosa di analogo si può dire per il nome Johann e le sue varianti morfologiche. Il personaggio meno simpatico è Tonio, il qua-le però è una figura assolutamente positiva per il narratore ed è, in-sieme ad Hanno, la figura prediletta dall’autore. Tonio–Antonio, lo si ricordi, ammicca esplicitamente all’Italia. Mi sono dunque posta la domanda se dal punto di vista meramente antroponomastico ammicchi a qualche personaggio della coeva letteratura italiana o a qualche scrit-tore di casa nostra. Un Italiano che sappia di lettere, udendo il diminu-tivo Tonio, pensa subito al personaggio omonimo dei Promessi Sposi; ma non ci sono echi distinti del gran romanzo italiano nella narrativa giovanile di Mann; se partendo da Antonio teniamo conto di tutte le manipolazioni dal nome subite nei testi giovanili dello scrittore tede-sco ci viene in mente che vi sono degli Antonio molto noti nella lette-ratura italiana di fine Ottocento, per i quali un artista competente po-teva facilmente prevedere la celebrità e l’immortalità: padron ’Ntoni e ’Ntoni di padron ’Ntoni.
Dal punto di vista fonico il diminutivo Tony con cui viene costan-temente chiamata Antonie Buddenbrook è pressoché identico ai dimi-nutivi con cui son da tutti conosciuti i due protagonisti dei Mal. La cri-tica letteraria tedesca discute da sempre circa lo statuto di personaggio proprio di Tony Buddenbrook: è una protagonista vera e propria o è una deuteragonista? Probabilmente Tony è il nome più fittamente ri-corrente nel romanzo ed è certo che il personaggio corrispondente a quel nome è il solo a stare in scena dalla prima all’ultima pagina di es-so: dunque per tutta la durata sia dell’azione che della narrazione, vuoi a livello mimetico che a livello diegetico. Questi dati ci aiutano a comprendere la grande simpatia manifestata da Mann nei confronti del nome Johann e dei suoi diversi esiti e anche il fatto che lo scrittore te-desco abbia cura di non mettere mai quel nome in rapporto con il Sud: è il nome di battesimo di Giovanni Verga. Perfino il nome della mo-
CAPITOLO III – Il Verga verista nel giovane Thomas Mann 87
glie di Thomas Buddenbrook, Gerda, alla luce di questa interpretazio-ne acquista una connotazione in più, senza beninteso perdere nessuna delle altre: in lingua tedesca la verga è die Gerte.
Trattasi di giochi onomastici che ormai sono a tutti famigliari: la protagonista femminile di Tr, la moglie del signor Klöterjahn si chia-ma Gabriele, con il nome sceltosi da D’Annunzio; il protagonista ma-schile dello stesso romanzo breve si chiama Spinell, con marcata omo-fonia rispetto al cognome del più noto personaggio maschile di D’Annunzio, Sperelli. Il cognome di Gabriele da nubile è Eckof, che fu il cognome del principale esponente settecentesco dell’arte dram-maturgica germanica: dunque l’unione del nome Gabriele con il co-gnome Eckof rinvia alla relazione, già leggendaria negli ultimi anni dell’Ottocento, tra D’Annunzio ed Eleonora Duse.
La malefica protagonista femminile della novella Luischen viene da tutti chiamata Amra, con riferimento alla parola italiana ambra (la resina con cui si fabbricano monili), perché tutte le principali protagoniste femminili della narrativa di Flaubert e di Turgenev da Verga echeggiata nell’opera propria hanno pelle color dell’ambra e così pure le corrispettive eroine di Verga (e successivamente la Ip-polita di TrM). Ernst Becker, protagonista maschile di Anekdote (ove Mann si prende gioco appunto dei romanzi fiorentini–milanesi di Verga, una concentrata riscrittura sarcastica dei quali aveva già attuato in Luischen) si chiama così perché l’ambra, in lingua tedesca, è der Bernstein12. Per altro verso Ernst significa in lingua italiana “serio”, e questo è il tratto fisico e morale forse dominante di Cesare Dorel-lo, il marito di Elena. Nelle parodie dello stravagante romanzo di Verga, Mann contrappone al mondo mitico–greco e romano–pagano, da cui sono tratti i nomi di Cesare e di Elena, nomi prele-vati dal mondo giudaico–cristiano: Christian Iacoby (come dire: Cristiano di Giacobbe) e Angela (moglie di Ernst Becker e alter ego di Elena).
Si pongano ora a confronto questi due schemi, relativi l’uno ai Mal e l’altro ai Budd. Gli schemi sono stati tracciati a partire dalla catena evenemenziale dei Mal, molti anelli o punti di snodo cruciali, insom-ma diversi fatti e avvenimenti della quale sono presenti, salvo che non
12 Cfr. il mio articolo Verga e i suoi autori nel giovane Thomas Mann… cit.
PARTE PRIMA – Giovanni Verga e la letteratura europea
88
sempre si è potuto rispettare l’ordine cronologico interno alla storia. La seconda catena evenemenziale è proposta in modo incompleto e in ogni caso in funzione della prima, cioè sono stati prelevati dal roman-zo di Mann solo gli anelli corrispondenti a quelli costitutivi della cate-na verghiana.
3. Due scalette tematiche a confronto: a) quella dei Malavoglia
1) La stabilità e capacità della famiglia di soddisfare dignitosamente i suoi bisogni elementari ha il proprio segno concreto e materiale nel possesso della casa del nespolo.
2) Tutti i membri della famiglia sono disposti al lavoro e al sacrificio, tranne uno, svogliato e poi scapestrato (il nipote maggiore ’Ntoni).
3) Padron ’Ntoni cerca di combinare il matrimonio di Mena, figlia di suo figlio Bastianazzo, con Brasi Cipolla, ritenuto un partito eco-nomicamente vantaggioso.
4) Mena ama, ricambiata, il poverissimo e dignitoso compare Alfio; i due si confessano questo sentimento, ma Mena sa che non può contrastare le decisioni della famiglia e accetta il fidanzamento con Brasi.
5) In un periodo di particolare ristrettezza economica padron ’Ntoni accetta l’affare, di per sé non del tutto trasparente, del carico di lu-pini (i lupini sono in parte avariati), affare propostogli dall’usuraio zio Crocifisso con la mediazione del losco sensale Piedipapera.
6) A causa di una burrasca improvvisa, la barca dei Malavoglia af-fonda con il carico di lupini nel mare in tempesta. Muore nel nau-fragio il più abile al lavoro della famiglia, Bastianazzo. La perdita del carico provoca l’indebitamento della famiglia perché i lupini erano stati comprati a credenza dall’usuraio zio Crocifisso.
7) Muore successivamente nella battaglia di Lissa, mentre sta pre-stando servizio obbligatorio di leva, Luca, giovane di ottimo ca-rattere e validissimo lavoratore: dei figli il più somigliante a Ba-stianazzo.
8) Il forte declino economico e sociale della famiglia viene sancito dalla perdita della casa del nespolo, ceduta dai Malavoglia all’usuraio creditore il quale è aiutato dal losco sensale Piedipapera.
CAPITOLO III – Il Verga verista nel giovane Thomas Mann 89
9) Viene rotto per volontà di padron Cipolla il fidanzamento di Brasi con Mena, rimasta priva di dote; questo tema viene duplicato nel-la fine dell’idillio, che stava per sfociare in fidanzamento, tra Barbara figlia degli Zuppiddi e ’Ntoni Malavoglia, ritenuto ormai troppo povero.
10) Dopo che altri rovesci economici e tribolazioni morali hanno col-pito la famiglia, muore di colera Maruzza, vedova di Bastianazzo. I legami che stringono vicendevolmente i membri della famiglia si allentano. In particolare, il giovane e scapestrato ’Ntoni se ne va; dapprima cede al miraggio dei facili guadagni e al desiderio di ozio e parte per luoghi lontani, poi torna da pezzente e si mette a vivere da dissipato13.
11) ’Ntoni si dedica a traffici illeciti. Infine, reo d’aver ferito di coltel-lo il brigadiere che lo aveva sorpreso a far contrabbando, viene processato e condannato alla galera. L’esperto avvocato difensore di ’Ntoni segue una linea di difesa odiosa a tutta la famiglia, per-ché ritenuta disonorevole.
12) La minore dei nipoti di Padron ’Ntoni, Lia, debole e incline a la-sciarsi irretire, abbandona il paese e diventa una prostituta in città.
13) Per non gravare sulla famiglia, padron ’Ntoni si fa portare all’ospe-dale, insomma all’ospizio dei poveri prospettiva che aveva sem-pre respinto con estrema angoscia ritenendola ciò che di peggio gli potesse accadere e muore fuori di casa sua.
14) Mena, pur essendo ancora innamorata di Alfio Mosca, il quale ne ricambia i sentimenti, decide di rinunziare al matrimonio e si de-dica completamente alla famiglia di origine e ai nipoti che avrà dal fratello Alessi.
15) Alessi, il più giovane dei nipoti di padron ’Ntoni e il più simile al nonno, da ultimo riesce a ricomprare a prezzo di tenaci sacrifici la casa del nespolo.
13 Questo punto trova corrispondenza nel punto 4 della scaletta tematica dei Budd al para-
grafo successivo. Thomas Mann mantiene il ruolo calamitante esercitato dalla madre sul figlio scapestrato; però, mentre ’Ntoni abbandonerà la famiglia solo dopo la morte della madre, l’allontanamento desiderato dallo scapestrato Christian viene favorito dal padre. Alla morte di questo, diversi anni dopo la partenza di Christian, la madre richiamerà il figlio lontano, che continuerà in modo imperterrito a comportarsi da dissipato, ma rinunzierà, fino alla morte di lei, a compiere scelte propriamente disonorevoli per la famiglia.
PARTE PRIMA – Giovanni Verga e la letteratura europea
90
16) Quando esce di galera, ’Ntoni torna a casa per rivedere la famiglia e le stanze in cui è cresciuto; dopo essersi trattenuto pochissime ore se ne va per sempre.
17) Quasi tutti i membri della famiglia, sia quelli mossi da una finan-co ostinata volontà buona sia quelli scapestrati e disonesti sono destinati al fallimento, sono dei vinti.
4. La seconda scaletta tematica: b) I Buddenbrook14
1) L’ascesa della famiglia e la sua capacità di accrescere o mantenere la propria opulenza ha come segno concreto e materiale l’acquisto e il possesso di una lussuosa casa patrizia sulla Mengstraße. Questo tema verrà duplicato nella costruzione di una prestigiosa dimora nella Fischergrube voluta per sé e la sua famiglia da Thomas Bud-denbrook, successore del nonno Johann e del padre Jean, a simbolo della sua personale ascesa economica e della considerazione otte-nuta presso i concittadini (egli è eletto senatore).
2) Tutti i membri della famiglia hanno vivissimo sia il senso della dignità del lavoro sia quello della rispettabilità e del decoro della famiglia: tutti, tranne uno, svogliato e scapestrato (il nipote mi-nore di Johann e figlio di Jean, Christian Buddenbrook).
3) Il console Jean cerca in ogni modo di spingere la figlia Antonie, detta Tony, a sposare il commerciante Bendix Grünlich, ritenuto da Jean un partito economicamente molto vantaggioso. Tony Buddenbrook soffoca il proprio romantico (e contraccambiato) amore per lo studente Morten Schwarzkopf e accetta di compiere il proprio dovere nei confronti della famiglia sposando Grünlich.
4) Christian dopo aver lavorato per qualche tempo a Londra come impiegato parte per il Sud America nella speranza di potervi condurre una vita comoda e dissipata. Resterà a El Paraiso otto
14 Considero qui solo i membri della famiglia che nelle pagine iniziali del romanzo vivono
o nascono a Lubecca nella sontuosa dimora patrizia nella Mengstrasse. Non considero la so-rella di Jean e figlia di Johann il vecchio e di Antoinette che vive a Francoforte ed è stata li-quidata e neppure Gotthold (e la sua famiglia), figlio di primo letto di Johann, che si è messo in conflitto con il padre e da tempo, quando l’azione si inizia, è estraneo alle attività commer-ciali del padre.
CAPITOLO III – Il Verga verista nel giovane Thomas Mann 91
anni; infine tornerà a Lubecca, subito dopo la morte del padre, per volontà della madre, che desidera avere vicini a sé tutti i suoi figli15.
5) Sotto la gestione di Jean si erano avvicendate perdite consistenti e altrettanto consistenti incrementi del capitale dell’azienda. Dopo la morte di Jean, Thomas Buddenbrook, in un periodo in cui la sua attività commerciale ha preso a declinare e conosce veri e propri rovesci, accetta di comportarsi da usuraio acquistando in erba a metà prezzo dal nobile ma economicamente rovinato signor von Maiboom il raccolto della ipotecata tenuta di Pöppenrade.
6) Una imprevedibile grandinata estiva distrugge il raccolto della te-nuta di Pöppenrade. La perdita del raccolto toglie a Thomas Bud-denbrook, ammalatosi di depressione, l’ultima speranza circa la possibilità di riprendere la sua brillante ascesa iniziale.
7) Ancora prima del calamitoso fatto di Pöppenrade era morta la più giovane dei figli di Jean, la pia e austera Klara: prima di morire ella si era fatta promettere per iscritto dalla madre che la quota di eredi-tà cui avrebbe avuto diritto se la madre fosse morta prima di lei ver-rà egualmente corrisposta a suo marito. Ciò contribuisce ulterior-mente a depauperare le non più floridissime sostanze della famiglia.
8) Tony Buddenbrook, dopo il fallimento del suo primo matrimo-nio con Grünlich e il fallimento del secondo matrimonio con A-lois Permaneder si riduce a condurre una vita molto ritirata nella città natale, tutta dedita alla figlia Erika Grünlich, alla madre, al fratello Thomas e al figlio di questo Hanno.
9) Il Direttore Weinschenk, genero di Tony Buddenbrook, viene processato per truffa aggravata, riconosciuto colpevole e condan-nato alla carcerazione. Weinschenk si era fatto difendere da un famoso e abile avvocato forestiero che la famiglia giudicava però inadeguato al còmpito.
10) Alla morte di Elisabeth Kröger Buddenbrook la prestigiosa casa sulla Mengstrasse viene venduta, per il tramite del mediatore Gosch, al ricchissimo Hermann Hagenström, appartenente a una famiglia di parvenus in piena ascesa.
15 Cfr. la nota 13 al paragrafo precedente.
PARTE PRIMA – Giovanni Verga e la letteratura europea
92
11) La morte di Elisabeth e la cessione della casa sulla Mengstrasse sanciscono la fine della unità familiare al modo di un clan dei Buddenbrook.
12) Thomas Buddenbrook all’uscita dallo studio del dentista che non è riuscito a estrargli un dente malato, stramazza un giorno dal marciapiede sulla strada coperta di fango, e muore in un modo in-fame per una persona piena di dignità e di senso del decoro quale egli è.
13) Lo scapestrato e debole Christian, sceglie come compagna una prostituta e alla morte della madre e di Thomas la sposa.
14) Quando esce di prigione, il Direttore Weinschenk torna a casa, dalla moglie, dalla figlia e dalla suocera, si trattiene presso di loro pochissimi giorni, e poi sparisce per sempre.
15) La ormai irreversibile decadenza della famiglia viene sancita, alla morte di Thomas, dalla vendita–svendita della casa sulla Fischer-grube e dalla liquidazione della ditta.
Questo schema, ça va sans dire, non sorprende certo Thomas Mann
nell’atto di abbozzare i primi lineamenti della struttura dei Budd. Lo schema ci fornisce meramente l’elenco, incompleto e provvisorio, dei nuclei tematici malavoglieschi, piccoli e non piccoli, che più si im-pressero, se è lecito dir così, nella mente dello scrittore tedesco per es-sere poi echeggiati nel gran romanzo borghese. Trattasi del livello dell’ossatura, ricoperto da una polpa di natura completamente diversa rispetto a quella dei Mal; per usare un’altra espressione figurata pos-siamo dire che trattasi del nudo tronco con i suoi nudi rami. Le chiome e il fogliame dei due alberi saranno molto diversi tra loro. Nel livello della polpa, o delle fronde e del fogliame dei Budd, è però possibile spigolare diverse piccole movenze malavogliesche.
5. Altre risonanze e movenze dei Malavoglia nei Buddenbrook Nei Mal la voce narrante racconta a proposito del carattere di Ba-
stianazzo e del suo matrimonio con la Longa: «così grande e grosso com’era filava diritto alla manovra comandata, e non si sarebbe soffia-to il naso se suo padre non gli avesse detto “soffiati il naso” tanto che
CAPITOLO III – Il Verga verista nel giovane Thomas Mann 93
s’era tolta in moglie “la Longa” quando gli avevano detto “pigliate-la”»; e a proposito del matrimonio tra Jean ed Elisabeth: «Per esser sinceri, quell’unione non era stata proprio quel che si chiama un ma-trimonio d’amore. Suo padre gli aveva battuto una mano sulla spalla e aveva richiamato la sua attenzione sulla figlia del ricco Kröger, che portava alla Ditta una dote cospicua; lui era stato cordialmente d’accordo e, da allora, aveva venerato sua moglie come la compagna affidatagli da Dio…» (Budd, p. 54; tr. it. p. 49).
Nei dialoghi tra i coniugi comare Venera detta «la Zuppidda» e suo marito Turi, genitori della graziosa Barbara di cui è innamorato ’Nto-ni, avviene un trapassare di atteggiamenti di pensiero e di abiti mentali di testa in testa e di espressioni di bocca in bocca, e chi se ne appro-pria crede di averli sempre posseduti. Nei Mal leggiamo:
La Zuppidda era sempre stata con tanto di muso, e borbottava che ora tutta la famiglia rimaneva sulle braccia di ’Ntoni! Questa volta una ragazza ci penserà prima di pigliarselo per marito. Cosa ci hai con quel povero giovane? Domandava mastro Turi. Voi tacete chè non sapete nulla; gli gridava la moglie. I pasticci non mi piacciono! Andate a lavorare che non sono affari vostri: (p. 155) E successivamente: «Allora, diceva la Zuppidda: “’Ntrua, ’ntrua!
Ciascuno a casa sua”. E suo marito le ripeteva: Te l’avevo detto che a me i pasticci non mi piacciono! Voi andatevene a lavorare! rispondeva lei, che non sapete nulla» (ivi, p. 164). Si ripete qui ciò che già era accaduto per parole di Piedipapera fatte proprie dallo zio Cro-cifisso. Nel caso degli Zuppiddi solo il marito, sottomesso alla consor-te sgarbata e autoritaria, fa proprie parole della moglie: «i pasticci non mi piacciono». Thomas Mann sviluppa la movenza duplicandola, cioè dotandola di reciprocità. Jean ed Elisabeth Buddenbrook ogni tanto si scambiano i punti di vista; vi è cioè qui un doppio trapassare di atteg-giamenti di pensiero e di abiti mentali. Proprio al contrario degli Zup-piddi, Jean ed Elisabeth fanno ciò per una forma di riguardoso affetto reciproco. Nei Budd leggiamo: «“Ma, Tony! Che modo di giudicare!” [«Tony! Mein Gott! Was für ein Urteil!»] esclamò sua madre un po’ indignata. “Un giovane di sentimenti così cristiani!” “Un uomo di mondo così educato! [«Ein so wohlerzogener und weltläufiger Mann!»] completò il console. “Non sai quel che dici.”» (Budd, p. 98;
PARTE PRIMA – Giovanni Verga e la letteratura europea
94
tr. it. p. 91). Commenta la voce narrante: «Accadeva qualche volta che in questo modo i genitori si scambiassero per cortesia i loro punti di vista; così erano più sicuri di essere d’accordo [dann waren sie desto sicherer, einig zu sein]» (ibidem). Particolarmente significativo e inte-ressante è il fatto che in entrambi i romanzi questo trapasso del punto di vista dall’uno all’altro avvenga mentre si commentano virtù e difetti dei pretendenti delle rispettive figliole.
Di ascendenza e sapore schiettamente malavogliesco sono i due più importanti motti che si leggono nei Budd, borghese l’uno e popolare-sco l’altro. Il motto o sentenza borghese è una buona esortazione per la discendenza, in cui il lettore si imbatte fin dalle pagine iniziali e che ritrova poi spesso; l’esortazione è stata scritta dal fondatore del com-mercio di granaglie sul quaderno nel quale da generazioni sono regi-strati gli eventi di famiglia: «“Figlio mio, dedicati con ardore agli af-fari durante il giorno, ma combina soltanto quelli che ti consentano di dormire tranquillamente di notte”» (Budd, p. 56; tr. it. p. 51: il corsivo è del traduttore). Come non pensare ai proverbi snocciolati dal narra-tore e da lui attribuiti a padron ’Ntoni al fine di presentarne ad apertu-ra della storia la personalità: «Padron ’Ntoni sapeva anche certi motti e proverbi che aveva sentito dagli antichi: “perchè il motto degli anti-chi mai mentì”: “senza pilota barca non cammina” “Per far da papa bisogna saper far da sagrestano” oppure “fa il mestiere che sai, che se non arricchisci camperai” “Contentati di quel che t’ha fatto tuo padre; se non altro non sarai un birbante” ed altre sen-tenze giudiziose» (Mal, p. 8; il corsivo è dell’autore). Il motto popola-resco «“fa il mestiere che sai, che se non arricchisci camperai”» è il più somigliante a quello, borghese, scritto sul quaderno di famiglia dei Buddenbrook.
Non vi è certo bisogno di riprodurre i moltissimi proverbi marina-reschi di padron ’Ntoni; nei Budd uno ve n’è che pare uscito dalla bocca sua: «le reti si buttano ogni giorno, ma non ogni giorno si pren-de il pesce! [Fischzug ist alle Tage, aber nicht alle Tage Fangetag!]» (p. 111; tr. it. p. 104). A esprimersi in questo modo popolaresco, del tutto inconsueto per lui, è il console Jean, mentre parla con la moglie della opportunità che Tony superi la propria avversione o repulsione per il pretendente e sposi Grünlich.
All’inizio dei Mal, com’è notissimo, il narratore spiega che secon-
CAPITOLO III – Il Verga verista nel giovane Thomas Mann 95
do la filosofia di padron ’Ntoni la famiglia prospera se coloro che la compongono sono come le dita della stessa mano. Quando Tony torna a casa da Travemunde e sfoglia il quaderno di famiglia trova che esso è ispirato all’idea che ogni membro della famiglia, nel corso delle ge-nerazioni, è come un anello in una catena e porta grande responsabilità personale nei confronti della famiglia e di tutta la storia di essa («Wie ein Glied in einer Kette, hatte Papa geschrieben…»: Budd, p. 158; tr. it. p. 148); l’idea ispiratrice della cronaca familiare è ormai un luogo universalmente noto: è uno dei motivi più ricordati non solo dei Budd ma della letteratura di tutti i tempi.
Anche alcuni motti di spirito presentano singolare affinità, specie se si tien conto della profonda somiglianza delle situazioni alle quali si riferiscono (la supposta ricerca di ordinamenti politici repubblicani). Il comico demagogo portavoce di quasi eversive idee democratico–repubblicane, lo speziale (e pseudo–“intellettuale”) don Franco vana-mente incita i compaesani a scacciare gli attuali membri del consiglio comunale e il sindaco e anzi a fare senz’altro la rivoluzione: « Siete asini che vi manca soltanto la coda! Con gente come questa cosa vole-te fare? e si contentano di mastro Croce Giufà, perché il sindaco è sta-to sempre lui; e sarebbero capaci di dirvi che non vogliono la repub-blica perché non l’hanno mai vista!» (Mal, pp. 209–210; corsivo mio). Il console Jean Buddenbrook, nel 1848, durante una goffa rivol-ta di popolo, cui partecipa una sparuta minoranza dei lavoratori ma-nuali della città, esce dalla sala ove avrebbe dovuto aver luogo una se-duta del consiglio comunale e affronta i rivoltosi, rivolgendosi in par-ticolare a un giovanotto che conosce bene: «“Smolt, che cosa volete veramente? Dillo un po’ tu!” [“Smolt, wat wull Ji nu eentlich! Nu seggen Sei dat mal”]” “Signor console, dico soltanto questo: noi vo-gliamo la repubblica, così dico… [“Je, Herr Kunsel, ick seg man bloß: wie wull nu ’ne Republike, seg ick man bloß…”]” “Stupidone che sei, la repubblica l’avete già!” [“Öwer du Döskopp…Ji heww ja schon een!”] “Sì, signor console, ma ne vogliamo un’altra ancora.” [“Je, Herr Kunsel, denn wull wi noch een”]» (Budd, p. 191; tr. it. p. 179; i corsivi sono miei); allora «tutta la folla dei repubblicani si trovò a fare le più matte risate» (ivi, p. 192; tr. it., p. 179).
Il mediatore Gosch, durante le trattative per fissare, dopo la morte della Signora Elisabeth, il prezzo di vendita della casa sulla Mengstra-
PARTE PRIMA – Giovanni Verga e la letteratura europea 96
ße, ha parole che ricordano quelle in analoghe circostanze profferite dallo zio Crocifisso o dal sensale Agostino Piedipapera e che ricorda-no anche il modo di esprimersi del narratore pseudo–popolare dei Mal. Esclama lo zio Crocifisso a proposito dei lupini, rivolto a padron ’Ntoni: «Eh? Non vi conviene? Lasciateli! Ma un centesimo di meno non posso, in coscienza! Che l’anima ho da darla a Dio!» (Mal, p. 15). Nei Budd la voce narrante comincia a riferire così il colloquio tra il mediatore Gosch e Thomas Buddenbrook: «Ciò richiese parecchio tempo perché l’offerta di ventottomila talleri fatta dal signor Gosch sembrava troppo bassa al senatore, mentre il mediatore dichiarava che aggiungere a quella somma un solo marco d’argento sarebbe stata una follia e tanto valeva vendere l’anima al diavolo [während der Makler sich zur Hölle verschwur, wenn, dieser Summe auch nur einen Silber-groschen hinzuzufügen, nicht eine Tat des Wahnwitzes wäre]» (p. 593; tr. it. p. 556). Sia lo zio Crocifisso che il signor Gosch intendono dire: “vi parlo sapendo che se mentissi dovrei renderne conto al Si-gnore, il quale potrebbe giudicarmi indegno di essere ammesso nel-l’aldilà tra le anime salve”16.
16 Il mediatore Gosch, personaggio–macchietta, è una simpaticissima caricatura dell’usu-raio zio Crocifisso e del sensale Agostino Piedipapera (il che nulla, proprio nulla, toglie alla possibilità che sia adombrata altresì nel personaggio qualche figura di Lubecca). Gosch, sca-polo, naso adunco, mento appuntito e sporgente, è uno spirito bizzarro ma è anche, secondo che la voce narrante tempestivamente informa il lettore, l’uomo più onesto e più buono del mondo. Egli ha una rispettata agenzia di compravendita e ha velleità letterarie (oltre che com-porre, cerca di tradurre il grande teatro di Lope de Vega). Senonché Gosch ama esibire e-spressioni e atteggiamenti cupi, malvagi, diabolici e intriganti. Recita, con efficacia alla quale egli soltanto e i bambini possono credere, favorito dal “phisique du rôle” (cfr. Budd, p. 180; tr. it. p. 169). Thomas Mann si prende gioco della malvagità che qualifica i grossolani personag-gi di Verga: una malvagità per molti aspetti ottusa ma soprattutto compatta, monolitica, del tutto priva di ogni sfumatura che implichi affetto o interesse verso qualcosa che non sia il de-naro o la roba. Così, p. e., durante la lunga discussione con Thomas Buddenbrook, «Gosch ebbe l’occasione di manovrare tutti i registri della sua arte dialettica. Recitava, per così dire, due parti e faceva l’impostore malvagio. “Accetti, senatore, mio giovane e generoso amico… 84000 marchi… È l’offerta di una persona anziana e onesta!” diceva con voce melliflua recli-nando la testa, costringendo il viso devastato dalle smorfie a un sorriso di ingenua tenerezza e tenendo la mano bianca e larga dalle dita lunghe e tremule. Ma era menzogna, era tradimento. Un bambino avrebbe potuto penetrare quella maschera d’impostura dalla quale ghignava orri-bilmente l’intima furfanteria di quell’uomo» (Budd, p. 594; tr. it. p. 557). Gosch se ne esce anche in esclamazioni che ricordano da vicino i «Santo diavolone»! o i «Satanasso»! o «san-gue del diavolo!» dei Mal. Piace proporne una che è contenuta in un inserto di indiretto libero modellato su quello del romanzo di Verga:«Dormissero pure. Di giorno Gosch non dormiva di certo; era lieto se poteva conquistarsi di notte qualche oretta d’incoscienza. Non stava bene
CAPITOLO III – Il Verga verista nel giovane Thomas Mann 97
Ancora: lo zio Crocifisso sposa da ultimo (cfr. Mal, capitolo 13) la figlia di suo fratello, la Vespa, solo per incamerare tra i propri beni la chiusa della nipote: il paese intero ride perché la donna riuscirà a sot-tomettere lo zio, ma nessuno in sostanza, neppure il prete, ha nulla da ridire circa la stipula di un legame coniugale tra persone legate da stretta consanguineità. Hermann Hagenström, l’acquirente della casa sulla Mengstraße, conversando con Thomas e con Tony, racconta che sua figlia sta per sposare, con vantaggio di entrambi, un cugino di primo grado. Come chiarisce la voce narrante, i matrimoni di conve-nienza tra consanguinei si usavano, e nessuno ci trovava da ridire (cfr. Budd, p. 603; tr. it. p 565).
Non mi addentro in questioni stilistiche, Dio ne guardi; mi limito a ricordare che in entrambi i romanzi, Mal e Budd, è adottata con effica-cia la cosiddetta tecnica del contrappunto. A Thomas la notizia della perdita del raccolto di Pöppenrade giunge nel momento in cui la città intera sta festeggiando l’apogeo dei Buddenbrook, vale a dire il cente-nario della fondazione della ditta (cfr. Budd, pp. 493–494; tr. it. pp. 462–464). L’espediente tra stilistico e narrativo proviene con palmare evidenza dall’analoga situazione verificatasi in casa dei Malavoglia, nel giorno in cui essa è piena di gente perché si festeggia il fidanza-mento di Mena con Brasi Cipolla. I Malavoglia paiono essersi rimessi in carreggiata, e questo fidanzamento è il primo e di gran lunga più lieto tra gli eventi accaduti dopo la morte di Bastianazzo. A festa inol-trata e ben riuscita giunge però improvvisa la notizia, destinata a rive-larsi esatta, che probabilmente Luca è tra le numerose vittime della battaglia navale di Lissa (cfr. Mal, capitolo 9); ciò implica che la fa-miglia ha perduto il suo più valido sostegno maschile.
Una movenza importante è da Thomas Mann ricontestualizzata, dopo un’accurata rielaborazione, in TK invece che nei Budd, ove a-vrebbe dato troppo nell’occhio: l’identificazione della casa di famiglia amatissima con un albero da frutto, un albero domestico, verrebbe da dire, il quale sta nel cortile o nel giardino. Esso funge da calamita del-
e […] quel tremito delle membra che… Maledizione! Non riusciva neanche a reggere il bic-chiere del grog e, corpo del demonio! Assai raramente riusciva ormai a scrivere [Es ging ihm nicht gut. […] das Zittern in seinen Gliedmaßen… verflucht! Er konnte kaum noch das Grog-glas halten, und teuflischer! er konnte nur selten noch schreiben]» (Budd, p. 665; tr. it. pp. 623–624).
PARTE PRIMA – Giovanni Verga e la letteratura europea
98
le connotazioni intensamente patetiche legate alla perdita o alla cessio-
ne della casa. La perdita dolorosa subita dai personaggi pare coagular-
si in quei simboli ben definiti: il nespolo nei Mal e il grande albero di
noce («der Walnußbaum») in TK. I due alberi sono utilizzati con effi-
cacia dai due scrittori per rendere i lettori emotivamente compartecipi
della perdita della casa. Incastonando l’albero nella propria opera, e
per molti aspetti ricreando l’originalissimo e intensissimo pathos pri-
mamente creato da Verga, Thomas Mann dimostra, finemente, delica-
tamente, ma senza reticenze, la propria ammirazione nei confronti del-
lo scrittore siciliano.
Si avverte abbastanza distintamente in un episodio dei Budd l’eco
della novella di Verga Primavera17. Il “contenuto generale” delle due
storie è banale, fa parte dell’esprit du temps; è la raffigurazione in chia-
ve intenerita e dickensiana di due fanciulle povere e laboriose le quali
si danno per amore a due giovani attraenti e seduttivi pur sapendo fin
dal primo istante che i due non potranno sposarle. I due personaggi
femminili sono antitetici o quasi ai tipi della grisette e della lorette; lo
è in particolare la giovane di Budd, perché quella di Primavera aveva
accettato senza entusiasmo regali dal “primo” cui si era data. In Pri-
mavera si racconta della passione tra un giovane aspirante musicista
spiantato e una graziosa e delicata cucitrice, la quale lavora presso una
modista e proviene da una famiglia poverissima e assai perbene; en-
trambi gli innamorati sono consapevoli del fatto che i casi della vita li
separeranno. I temi elaborati rappresentativamente con la maggiore at-
tenzione non sono né il sorgere dell’amore né il suo rafforzamento,
sebbene essi occupino le prime due pagine del racconto; la descrizione
verte invece, in modo minuzioso e delicato, sull’angoscia e sulla piena
rassegnazione di lei a fronte della imminente separazione dal giova-
ne amato. Egli parte perché ha avuto un’offerta di lavoro vantaggio-
sa, aderente alle sue concrete capacità professionali, ancorché lonta-
na dai suoi sogni di giovane idealista ed entusiasta. Egli accetta l’of-
ferta di lavoro perché è capace di distinguere tra sogni e realtà e di
comportarsi con sicuro istinto pratico (il narratore raffigura invece que-
17
G. VERGA, Primavera, (1874), in Id., Tutte le novelle, cit., vol. 1; l’episodio del com-
miato di Thomas Buddenbrook dalla piccola fioraia si colloca immediatamente dopo il rac-
conto della partenza di Tony per Amburgo, in seguito al matrimonio con Grünlich.
CAPITOLO III – Il Verga verista nel giovane Thomas Mann 99
sto temperamento virile con un certo sforzo, quasi vagheggi, a diffe-renza del personaggio, che i sogni si avverino). Paolo sa che la sua ra-gazza è già stata innamorata di un altro, e per questo motivo i suoi sensi di colpa sono tenui o inesistenti. La fanciulla, detta La Principes-sa, dolce, fiera, limpida, onesta (tanto più onesta in quanto per chi ama rinuncia per la seconda volta alla castità) gode quella porzione di amo-re che la vita può concederle e al contempo, rassegnata, avverte fin dall’inizio della relazione che la gioia di quell’amore, che è parte di lei, le sarà tolta. Probabilmente dopo il primo amante e dopo Paolo al-tri ne arriveranno, giacché ella è nata per l’amore, ma la vita le impe-disce o le rende particolarmente difficile di sposare l’uomo che ama. Il narratore conclude che Paolo tornerà, e constaterà il cambiamento av-venuto nella Principessa che aveva amato: ella sarà sfiorita e ingrassa-ta e Paolo non potrà più parlarle del passato, dell’antico amore, che el-la non comprenderebbe. Del resto egli medesimo, Paolo, non sarà più giovane, né povero, né sciocco, né entusiasta né visionario come lo era stato allora, da giovane.
Il tema principale di Primavera è ripreso e variato da Thomas Mann nell’addio che il giovanotto Thomas Buddenbrook va a dare a una delicata e modesta commessina che lavora come fioraia; ella me-desima gli ricorda un poco trasognata che egli è stato il primo e unico uomo cui ella non abbia “negato niente”. Entrambi hanno sempre sa-puto che egli, prima o poi, avrebbe dovuto abbandonare la fanciulla molto innamorata di lui. Thomas prende definitivo congedo da lei per-ché è in partenza per Amsterdam, ove farà un apprendistato presso un commerciante. La fioraia, dalle sembianze orientaleggianti (ma anche meridionali) porta uno di quei nomi in bilico tra mondo latino e mon-do germanico, uno di quelli che ammiccano fortemente al Sud del-l’Europa: Anna. La voce narrante descrive in modo minuzioso la tri-stezza del distacco, soprattutto quella di lei. La rappresentazione è so-bria ma non è priva di note patetiche. Thomas conforta la ragazza e le raccomanda di non buttarsi via, insistendo sul fatto che finora non si è buttata via. Ella è stata cioè l’amante solo di Thomas e si innesta qui la volontà dell’autore di distinguere la fanciulla del Nord dalla troppo appassionata creatura femminile di Verga e secondo il gio-vane Buddenbrook questo è un fatto non disonesto, tale da non com-promettere la possibilità di lei di diventare una sposa onesta. I due ex–
PARTE PRIMA – Giovanni Verga e la letteratura europea 100
amanti si rivedranno molti anni dopo. Anna e suo marito infatti hanno un negozio da fiorai sulla Fischergrube, di fronte alla nuova casa di Thomas. Mann inverte quella che era stata la chiusa del narratore ver-ghiano. Lei è ancora una creatura sensibile e delicata, ancorché sia sfiorita a causa delle numerose gravidanze (e la “vitalità” di Anna, di suo marito e dei numerosi figlioli contrasta con l’assai scarsa vitalità di Gerda, di Thomas e della loro creatura). Si comprende ch’ella cu-stodisce nel suo cuore con dolcezza e rimpianto il ricordo dell’antico amore tra Thomas e lei, laddove egli, ormai interiormente deluso, in-debolito, inaridito, par diventato del tutto indifferente a quel ricordo, e anzi quasi immemore. Anna poi vorrà anche sostare, in brevissimo raccoglimento, e con un certo struggimento interiore, al cospetto della salma di Thomas. Sia Paolo che Thomas malgrado l’atteggiamento ambiguo di entrambi gli autori a fronte dei due personaggi maschili si comportano da adolescenti egoisti, capaci assai più di prendere ciò che le due ragazze possono loro offrire che non di dare alle innamora-te, se non calore vero, almeno una certa sicurezza.
Torno ai due romanzi naturalisti. Entrambe le catene evenemenzia-li, sia quella dei Mal sia quella del gran romanzo tedesco, sono state dianzi riassunte in modo assai lacunoso, ma molto più lacunosa appare quella dei Budd. Non si è fatta menzione né di Gotthold, figlio di pri-mo letto del patriarca Johann, né della sua famiglia composta di sole donne; e neppure del cospicuo risalto accordato da Mann al combatti-mento interiore di Tony prima di risolversi ai due fidanzamenti senza amore; e neppure delle tormentate vicende matrimoniali di lei, quasi catastrofiche nel caso del primo matrimonio. Non s’è dato spicco alla prestigiosa ascesa di Thomas Buddenbrook nella vita politico–ammi-nistrativa della piccola città–stato sul Baltico (Thomas diventa senato-re), né al suo fidanzamento e alla sua insoddisfacente vita matrimonia-le; e neppure alla rivalità tra i Buddenbrook, prestigiosa famiglia anti-ca, e i parvenus Hagenström, che al termine di una quasi irresistibile ascesa economica diventano forse la prima famiglia della borghese Lubecca. Balza tuttavia agli occhi, mettendo a raffronto le due scalette tematiche di cui ai paragrafi 3 e 4, che alla seconda manca, in partico-lare, il lungo e importante epilogo del gran romanzo, ove si narra della breve, malaticcia, ipersensibile e nevrotica esistenza di Hanno, unico figlio di Thomas Buddenbrook.
CAPITOLO III – Il Verga verista nel giovane Thomas Mann 101
Nei Budd sia il patriarca Johann, dal temperamento determinato, volitivo, allegro e pieno di vitalità sia suo figlio il console Jean, pio, prudente, un poco ingenuo, muoiono in modo tranquillo, senza assiste-re alla decadenza della famiglia, decadenza che Jean in qualche modo prepara a causa della sua mancanza di audace spirito di iniziativa e di sana diffidenza. Sia Alessi nei Mal sia Thomas Buddenbrook riescono ad acquistare la casa che desiderano; però, mentre quello di Alessi è un acquisto stabile, sul quale getta la sua ombra tragica il dolore pro-vocato dal disfacimento della famiglia, Thomas acquista la propria ca-sa quando la decadenza della famiglia si sta iniziando e non è ancora avvertita pienamente come tale, sicché questo acquisto pare recare conferma ulteriore del prestigio raggiunto dai Buddenbrook e del suo sempre progrediente consolidamento. Alla morte di Thomas, poi, la sua casa viene, più che venduta, svenduta, come tutti i beni della ditta.
6. L’influenza di altre opere narrative italiane sul “gran romanzo”
tedesco Limitatamente ai Mal la scaletta tematica fornita sopra abbraccia
tutta la storia (e il tempo cronologico interno alla finzione); Alessi si sposa, mette al mondo parecchi bambini, ricompra la casa del nespolo. Invece, la scaletta tematica relativa ai Budd si arresta alla morte di Thomas, al punto cioè della divaricazione completa tra le due storie, quella di Johann, di Jean e soprattutto di Thomas e quella di Hanno. Lo schema ha cioè toccato il capitolo 7 incluso della parte decima, e ha saltato del tutto l’ultima parte, l’undicesima. Di più: non ha preso in nessuna considerazione la vita e le vicende del protagonista dell’ul-tima parte del gran romanzo, insomma la storia di Hanno. Hanno na-sce nella primavera del 1861, poco dopo la metà della narrazione complessiva, e 26 anni dopo l’inizio della storia (ottobre 1835). Parec-chi degli anelli ricordati nella scaletta relativa ai Budd sfiorano la sua vita pur senza con essa intrecciarsi. Con la morte dell’ultimo erede maschio della famiglia (primavera 1876) termineranno la narrazione e la storia; il brevissimo epilogo, un colloquio tra le sole superstiti, tutte donne, si svolge nell’autunno 1876. Al ruolo di coprotagonista, insie-me al padre Thomas, Hanno assurge all’inizio del capitolo 7 della par-
PARTE PRIMA – Giovanni Verga e la letteratura europea 102
te ottava, quando Thomas guarda con sempre maggior sospetto e viva delusione al carattere e alle tendenze del piccolo. Johann jr. assume però un ruolo importante fin dal punto in cui nella storia, improvvisa-mente, entra e subito assume importanza Kai, con il quale Hanno stringe amicizia fin dai primi giorni di scuola e che rimarrà sempre l’unico coetaneo con cui Hanno instauri un rapporto intenso e pro-fondo.
Prima di delineare il parallelo tra la storia di Hanno e una importan-te novella italiana pubblicata pochissimi anni prima dei Budd è da no-tare che diverse altre opere celebri della narrativa italiana dell’Ottocento, com’è naturale, hanno offerto a Thomas Mann sugge-rimenti che gli sono piaciuti e dei quali si è avvalso per il suo “gran romanzo”. Un giorno, forse, con il concorso di studiosi giovani, si riu-scirà a censirle quasi tutte. Mi limito per ora a fornire alcuni riscontri certi. Mann ha tratto dalle Conf (ha fatto a Ippolito Nievo l’onore di trarre dalle Conf) qualche movenza gentile: ne ha riprese alcune man-tenendone lo spirito originario, mentre di altre inverte il timbro emoti-vo. Mann, secondo un gusto che gli è proprio e congeniale, riporta quel che vi è di eccezionale e titanico in Conf titanismo ed ecce-zionalità trattati con superiore e sia pure intenerita ironia anche dall’io narrante del romanzo italiano alla misura della esperienza comune e quotidiana. Presumo che Conf abbia suscitato l’attenzione e forse l’ammirazione di Mann sia per la spiccata qualità epicizzante di una narrazione la quale tratta vicende e casi personali che si distendono per diversi decenni di storia recente fino a giungere alla contempora-neità in senso stretto sia per la magica, incantevole ironia con cui l’io narrante filtra ciò che racconta. A ciò aggiungerei la circostanza, pale-se per un lettore attento di Turgenev, che tra il personaggio della prin-cipessina Zinaida di Primo amore e quello della contessina Pisana po-co più che bambina, appena ragazzina, vi sono somiglianze quasi sconcertanti.
Il solo uomo di cui Tony Buddenbrook davvero si innamori, in mo-do assolutamente casto, come s’è già scritto, quando è ancora fanciul-la, è lo studente di medicina Morten Schwarzkof. Tony è ospite pa-gante dei genitori del giovane nella località balneare di Travemünde. Morten, che professa idee accesamente democratiche, nello stesso pe-riodo prepara gli esami a casa dei suoi. Nel tempo libero egli accom-
CAPITOLO III – Il Verga verista nel giovane Thomas Mann 103
pagna Tony, con discrezione, senza mai mischiarsi all’alta borghesia in vacanza alla quale si unisce qualche volta la giovane Buddenbrook. Tutti pensano che Morten non oserebbe mai fare la corte a una giova-ne d’estrazione sociale di tanto più alta della sua. Morten si innamora di Tony, e riesce a ottenere l’amore della fanciulla e la promessa che ella non sposerà nessun altro uomo: Tony aspetterà ch’egli, dopo es-ser divenuto medico, sia in grado di offrirle un matrimonio onorevole.
Nelle Conf lo studente di medicina Lucilio Vianello, figlio del me-dico di Fossalta, giovane dalle idee politiche accesamente democrati-che, si innamora della contessina Clara, la sorella maggiore della Pi-sana; Clara è una giovinetta sì religiosissima, ma anche molto dolce, dall’indole deliziosa e incline a sentimenti teneri e romantici. I due giovani si frequentano intensamente perché Lucilio, tenace e avvedu-to, riesce a diventare il visitatore prediletto della nonna di Clara. Nes-suno tra i conti genitori (e nonna) di Clara e tra i parenti di lei presta la minima attenzione all’amicizia amorosa tra i due giovani, tutti es-sendo saldi nella convinzione che mai una persona di rango tanto in-feriore potrebbe aspirare a Clara e che mai la aristocratica giovinetta verrebbe meno alle superbe regole del suo casato. Finalmente la forza della consuetudine instauratasi tra Lucilio e Clara, infermiera della nonna, guadagna al giovane il cuore puro della fanciulla e la promes-sa che ella non sposerà mai altri che lui (Conf, vol. I, pp. 67–80 e pp. 161–174).
Il modo con cui Morten Schwrzkopf ottiene da Tony l’assicura-zione che ella ricambia il suo amore e la promessa che ella non spose-rà mai altri che lui arieggia l’analoga situazione tra Lucilio e Clara nelle Conf; vi è per un verso imitazione e per l’altro verso rappresen-tazione di atteggiamenti (attribuiti a Morten) che, secondo l’io narran-te di Conf, sono a Lucilio del tutto estranei.
Lucilio un giorni riesce a rimanere solo con la giovane amata, alla quale è devoto da anni, e la esorta ad aver fede nell’amore, che solo impedisce all’anima umana di inaridirsi (Conf, p. 164). Clara accoglie senza stupore e con intensissimo piacere le «ardenti parole del giova-ne; e mentre cercava ritrarre la propria mano dalla sua, fu costretta an-zi a cercarvi un appoggio perché si sentiva venir meno da un deliquio di piacere» (Conf, p. 164). La fanciulla non risponde, ma sorride all’amato in modo tale che egli comprende di avere per sé il cuore di
PARTE PRIMA – Giovanni Verga e la letteratura europea 104
lei; il giovane, assapora «con tutti i sensi dell’anima le delizie del trionfo» (ivi, p. 166); «Ad altri avrebbero tremato in cuore gratitu-dine, devozione e paura; a lui la superbia ritemprò le fibre d’una gioia sfrenata» (ibidem; corsivo mio); e l’io narrante commenta: «Io forse, e mille altri simili a me avremmo ringraziato con le lagrime agli occhi; egli ricompensò l’ubbidienza di Clara con un bacio di fuoco» (ibidem; corsivo mio). Infine Lucilio, mentre accompagna Clara, le chiede:
Mi amerai sempre? […] Sempre!… rispose ella. […] E quando
la tua famiglia ti profferirà uno sposo? soggiunse con voce dolorosa e stri-dente Lucilio. Uno sposo! sclamò la giovinetta chinando il mento sul petto. Sì, riprese il giovane, vorranno sacrificarti all’ambizione, vor-ranno comandarti in nome della religione un amore, che la religione ti proibi-rà in nome della natura! Oh io non veggo che voi! rispose Clara quasi parlando con se stessa. Giuralo per quanto hai di più sacro! […] Sì, lo giuro! Disse tranquillamente la Clara. (ivi, pp. 166–167)
Morten Schwarzkopf quando la villeggiatura di Tony volge al
termine, interroga la ragazza sulla natura dei rapporti di lei con Grünlich. Dopo avere appreso con sollievo che la ragazza prova ri-pugnanza nei confronti di questo corteggiatore gradito alla famiglia Buddenbrook, accusa tuttavia la fanciulla di avere il cuore freddo (Budd, p. 142; tr. it. p. 134). Tony, ferita, ribatte: «“No, Morten, Come può credere una cosa simile?…Non deve pensare così di me.” “Non lo penso affatto!” esclamò Morten con una risata nella quale si udivano la commozione e la gioia a stento repressa» (ivi, p. 143; tr. it. p. 134). Il giovane prende tra le sue una mano di Tony e con deli-catezza le lascia capire di amarla. La fanciulla gli dice che ha già compreso ciò: «“Lo sa? E lei… lei, signorina Tony» (ibidem; tr. it. p. 135). La giovane dichiara di voler bene a Morten più che a tutti gli altri che conosce. Morten allora prova esattamente la reazione che l’io narrante di Conf considera naturale e normale negli amanti (tra essi mettendo se medesimo): la reazione che Lucilio, tessitore paziente della strategia per giungere all’obiettivo e amante tenace, eccezionale, titanico, non aveva avuto. Morten «ebbe uno scatto, mosse le braccia e non sapeva che fare. Balzò in piedi, ricadde vi-cino a lei e disse con una voce che tremava, s’interrompeva e si fa-
CAPITOLO III – Il Verga verista nel giovane Thomas Mann 105
ceva sonora di felicità: “Oh, grazie, grazie! Vede, ora sono felice come mai nella mia vita!…”. E prese a baciarle le mani» (ibidem; tr. it. p. 135). Identica è però la viva preoccupazione dei due giova-nissimi uomini:
Poi [Morten, N.d.A.] disse abbassando la voce: «Presto, Tony, lei ritornerà in città e tra due settimane le mie vacanze saranno terminate… e dovrò ritornare a Gottinga. Ma vuol promettermi che non dimenticherà questo pomeriggio qui sulla spiaggia finché sarò ritornato… e sarò dottore… e potrò, per quanto possa essere difficile, presentarmi a suo padre e implorare per noi? E che nel frattempo non ascolterà nessun Grünlich?… Oh, non ci vorrà molto tempo, vedrà, lavorerò come un… Non è affatto difficile…» «Si, Morten» disse lei felice e assente guardandolo negli occhi, guardandogli le labbra, le mani che tenevano le sue… Egli si portò la mano di lei sul petto e domandò con voce smorzata: «E per questo non vuole… non potrei… darle una conferma?…». Ella non rispose, non lo guardò nemmeno, spinse soltanto il busto un po’ ver-so di lui e Morten la baciò lentamente e a lungo sulla bocca. (ivi, pp. 143–144; tr. it. p. 135) Né Tony né Clara sposeranno mai il loro unico amore. Tony viene
sacrificata dalla famiglia, soprattutto dal padre, e sposa senza amore Bendix Grünlich, commerciante di Amburgo, uomo a lei ripugnante. La fanciulla conforma però la volontà sua a quella della famiglia, alle cui tradizioni e al cui prestigio è tenacemente attaccata. Clara invece, pur di non sposare il barone Alberto di Partistagno, cui viene destinata per volontà della propria famiglia, e per mantenersi fedele alla parola (e al perdurante amore) data a Lucilio rifiuta Partistagno e si fa mona-ca18. In onore di questo grandioso e retrivo personaggio femminile di Nievo (o anche in onore di esso) Thomas Mann assegna il nome Klara alla caparbia e autoritaria figlia minore di Jean ed Elisabeth Budden-brook, la quale, diversamente dai tre fratelli maggiori, è e sempre sarà una creatura devota, pia (nella religione luterana), sommamente auste-
18 In realtà le due situazioni non sono affini. Il sentimento che lega Morten e Tony è sì au-tentico e puro, ma si innalza appena al di sopra della passioncella adolescenziale. Clara e Lu-cilio, invece, sono entrambi dotati di personalità titanica, ancorché siano tanto diversi l’uno dall’altra. Li lega dunque un amore immenso, destinato a durare per sempre, ma anche a non poter trovare mai il proprio coronamento, perché Clara, presa la decisione di entrare in mona-stero, rifiuterà poi sempre di tornare su questa sua decisione e di sposare l’uomo tuttora ama-to, anche quando ciò, grazie alle nuove leggi repubblicane e al fatto ch’ella non ha ancora pronunziato i voti, sarebbe possibile.
PARTE PRIMA – Giovanni Verga e la letteratura europea
106
ra. Per tale ragione l’avveduta madre Elisabeth incoraggia il matrimo-nio di Klara con il pastore Sievert Tiburtius di Riga. Si può far men-zione di un piccolo aspetto curioso e simpatico. Come suole accadere, la voce narrante descrive l’aspetto fisico di Morten non appena questi entra in scena. Egli ha occhi azzurri, è di media statura, scarno, bion-dissimo e ha una pelle straordinariamente chiara. Di Lucilio Vianello, personaggio che nelle Conf è in scena dal primo all’ultimo capitolo, apprendiamo dal narratore anzitutto che è un giovane pallido e tacitur-no (ivi, p. 32) e successivamente, quando il narratore fornisce la raffi-gurazione fisica del personaggio, ch’egli ha fronte ampia, lineamenti regolari, statura medio–piccola e corpo asciutto ed elastico (cfr. ivi, p. 76). Nulla mai nelle Conf si dice intorno al colore degli occhi (che so-no infossati e abbaglianti) e soprattutto a quello dei capelli (finissimi) di un deuteragonista tanto importante (cfr. ibidem). Codeste omissioni non son cosa che possa sfuggire a un lettore avveduto e curioso del personaggio.
Non si conosce neppure il colore “naturale” dei capelli del dottor Sperandio Vianello, padre di Lucilio. Si apprende però che Sperandio «portava un parruccone di lana o di crine di cavallo, nero come l’inchiostro» (ivi, p. 68). Il patronimico di Morten, Schwarzkopf (che, come ognun sa, significa testa nera), rinvia forse con intento faceto al capo del padre di Lucilio. I colori della testa di questo, del rimanente, sono per forza sospesi tra il tono biondissimo di Morten e il tono ne-ro–inchiostro del parruccone di Sperandio; ogni intermedia sfumatura di colore sta tra queste due: il biondo scuro, il ramato, il castano. Di più: la contessina Pisana chiama Lucilio «il signor Merlo» (ivi, p. 76), che in tedesco si può rendere con la parola Schwarzdrossel (der Dros-sel, letteralmente, è il tordo); è anche questa un’allusione, del resto in-sita pure nel romanzo italiano, a un piumaggio e dunque a una capi-gliatura nerissimi.
Movenze importanti Mann ha tolto al dannunziano TrM. È già stato molto autorevolmente osservato che la parafrasi fastosa e superba del Tristan und Isolde di Wagner procurata da D’Annunzio alla fine del succitato suo romanzo, forse quello suo migliore, «si ricongiunge» di-rettamente sia alla parafrasi della medesima opera offerta da Mann al-la fine di Tristan sia all’antecedente parafrasi dei «Maestri Cantori e del Lohengrin attuata nei Buddenbrook» (ancor sempre alla fine del
CAPITOLO III – Il Verga verista nel giovane Thomas Mann 107
romanzo)19. Credo che l’affinità più importante risieda però nel ritratto dello sparuto, gracilissimo, sempre spaventato nipotino di Giorgio Au-rispa, Luchino, figlio dell’amata sorella di Giorgio, Cristina. Luchino offre lo spunto forse principale per la delineazione del fisico malatic-cio e della personalità ipersensibile di Hanno da bambino:
Il bimbo chinò la testa pesante in grembo alla madre. Egli aveva la fragilità d’uno stelo; pareva che portasse a fatica la testa sul collo. La sua cute era così tenue che tutte le vene trasparivano, sottili come fili di seta azzurrina. I capelli erano così biondi che quasi eran bianchi. Gli occhi erano dolci e u-midi come quelli di un agnello, cerulei fra le lunghe ciglia chiare. (TrM, pp. 90–91)20 Cristina, molto preoccupata per la sua creaturina debole e priva di
ogni vigore vitale, anche nell’indole, racconta al fratello: «Non parla, non ride, non gioca, non si rallegra mai, non fa quello che fanno tutti gli altri bimbi…. Io non so che abbia. E mi pare che mi voglia tanto bene, che mi adori! Non si stacca mai da me, mai mai» (ivi, p. 91); anche perché «tutto gli fa paura» (ivi, p. 87). Luchino sente per caso che Giorgio racconta a Cristina di un cane sconosciuto il quale ha pre-so l’abitudine di salire ogni sera la scala del palazzo in cui ella e il fi-glio abitano; Giorgio deve subito interrompersi «vedendo gli occhi aperti e sbigottiti del bimbo che stava per rompere in un pianto» (ivi,
19 T. MANN, Racconti, con Prefazione di I. A. Chiusano, Profilo critico di V. Santoli e No-ta alle traduzioni di F. Saba Sardi, Milano, Bompiani 1984: le parole riferite nel testo tra vir-golette basse si leggono nel Profilo critico di V. Santoli, intitolato L’opera di Thomas Mann.
20 Il ritratto è perfezionato da D’Annunzio con la consueta precisione scientifica; Giorgio apprende che ogni graffio, ogni taglietto tarda assai a chiudersi e a cicatrizzare nella pelle di Luchino. Lo zio è colto da «un bisogno desolato di veder sorridere quel povero bimbo soffe-rente, di vedergli apparire su le gote almeno una volta un rossore fuggevole, il più lieve rosso-re del sangue sotto la pelle diafana» (TrM, p. 102); «Un sorriso tenue apparve su la bocca pal-lida del bimbo; e, come egli chinò la testa, le lunghe ciglia chiare s’illuminarono di sopra e gli misero la loro ombra palpitante su le gote smorte. Allora Giorgio lo sollevò tra le sue braccia, provando una pena profonda nel sentire sotto le dita la gracilità di quel petto infantile dove il cuore aveva un battito così debole» (ibidem); «Il collo era sottile e floscio come uno stelo ap-passito; lo sterno, le costole, le scapule sembravano trasparire a traverso la pelle rilevati anche più dall’ombra che empiva gli spazii cavi; le ginocchia ingrossate avevano la forma di due nodi; il ventre un po’ gonfio dava risalto alla magrezza acuta delle anche, segnato da un om-belico sporgente» (ivi, p. 104); «Come il bimbo sollevava le braccia […] quelle piccole ascel-le gracili […] parevano rivelare pur in quel semplice atto la pena d’uno sforzo contro il lan-guore letale ove la tenue vita stava per estinguersi» (ibidem); «Una gravità funebre era in ogni cosa. Quel bimbo pareva già un morticino, nella sua lunga camicia bianca» (ibidem).
PARTE PRIMA – Giovanni Verga e la letteratura europea
108
p. 103); e quel pianto «non somigliava a nessun altro pianto infantile perché pareva che la povera creatura vi si disfacesse» (ibidem). L’ipersensibilità di Giorgio (da questo ereditata dal raffinato zio De-metrio, morto suicida) torna come acuita a dismisura nel gracilissimo nipotino. Giorgio e Cristina, dopo che il bimbo si è addormentato, sie-dono insieme al suo capezzale per un tempo indefinito: «D’improvviso il bimbo gittò un grido di spavento, spalancò gli occhi sollevandosi dal guanciale, come atterrito da una visione truce. Mamma! Mamma! Che hai? Che hai, amor mio? Mamma!
Che hai, amor mio? Sono qui. Scaccialo! Scaccialo!» (ivi, p. 105). In TrM il tema dell’angoscia e del terrrore durante il sonno not-turno viene duplicato. Ne soffre anche Ippolita: a questi attacchi se-guono risvegli improvvisi, spesso carichi di sofferenza morale ma privi di ogni ricordo inerente il contenuto del sogno (cfr. ivi, pp. 177–178).
Hanno è egli pure fin dalla più tenera infanzia mentre suo padre Thomas viene aggredito da malinconia e sfiducia in se stesso tali da sprofondare nella depressione un bambino gracile, ipersensibile, nel cui volto spiccano ciglia molto lunghe. Egli si rivela fin da quando è piccolissimo una creatura dalla salute molto cagionevole21. Lo stesso si può dire delle sue energie emotive. La zia Tony apprende dalla go-vernante e bambinaia Ida che il piccolo piange molto spesso e a dirot-to, come se lo commuovessero nel più profondo dell’animo storie o si-tuazioni in cui gli altri nulla scorgono di doloroso: «“[…]. Piange tan-to facilmente e quando ci si mette non la finisce più… [Er gerät so leicht ins Weinen, das Jungschen, und kann dann lange nicht aufhö-ren… ]” “Ma che cosa vi è di doloroso in quella poesia?” “Che ne so io?” Quando la recita non riesce mai a passare oltre l’inizio, quello che lo faceva singhiozzare anche ora nel sonno… E poi ha pianto anche per il carrettiere che si alza dal giaciglio alle tre…» (Budd, p. 464; tr.
21 «Il ragazzo era sempre stato delicato di salute. Specialmente i denti gli avevano causato
fin dal principio guai e disturbi dolorosi. La prima dentizione, con accompagnamento di feb-bri e convulsioni, gli era quasi costata la vita, e poi le gengive avevano sempre avuto tendenza a infiammarsi e a formare ascessi […]. Ora, alll’epoca della seconda dentizione, le sue soffe-renze erano ancor maggiori. Subentrarono dolori che andavano quasi al di là delle forze di Hanno, il quale passava intere notti insonni gemendo e piangendo, con una febbriciattola che non aveva altra origine se non quegli stessi dolori.» (Budd, p. 512; tr. it. p. 480).
CAPITOLO III – Il Verga verista nel giovane Thomas Mann 109
it. p. 436). Anche Hanno, come Luchino, soffre nel sonno «di crisi di angoscia» (ivi, p. 465; tr. it. p. 436), definite dal medico di fami-glia“pavor nocturnus”:
Non compì [Tony, Nd.A.] neanche il gesto della mano e si volse spaventata verso il lettino donde era venuto un grido che aveva interrotto la sua chiac-chierata, un grido di angoscia che dopo un istante si ripeté con un’espressione ancor più tormentata, ancor più atterrita, e risuonò poi rapi-damente tre, quattro, cinque volte: «Oh! Oh! Oh!» come […] un urlo d’orrore di fronte a qualche cosa di raccapricciante che accadeva o s’era mostrato. Nello stesso momento il piccolo Hanno si rizzò sul letto e, balbet-tando parole incomprensibili, spalancò gli occhi, quegli occhi così singo-larmente bruno–dorati. (ivi, p. 462; tr. it. p. 434)22 Non passava notte senza che il piccolo Hanno si alzasse di soprassalto una o due volte, torcendosi le mani, coi sintomi di un indicibile terrore, e implo-rasse aiuto o pietà, come se fosse in mezzo alle fiamme o in pericolo di es-sere strangolato o di fronte a qualche cosa di spaventevole. La mattina dopo non ricordava più niente. (ivi, p. 514; tr. it. p. 482) Il padre di Hanno percepisce, con estrema preoccupazione, che il
fanciullo si sente assai più affine alla madre che a lui; di Gerda il pic-colo condivide i gusti (in particolare la fortissima inclinazione per la musica) e la finezza, e da lei si sente amato e soprattutto apprezzato; Thomas «non era d’accordo col carattere e con lo sviluppo del piccolo Hanno» (ivi, p. 508; tr. it. p. 476), e disapprovava vivamente «quella debolezza sognante, quel pianto, quell’assoluta mancanza di energia e di freschezza giovanile» (ivi, p. 512; tr. it. p. 480), che il senatore at-tribuiva alla passione di Hanno per la musica; «il ragazzo, l’erede atte-so per tanto tempo invano […], doveva forse appartenere interamente alla madre?» (ivi, p. 508; tr. it. p. 477). Thomas «era davanti a un tempio dalla cui soglia Gerda lo scacciava con un gesto spietato… e,
22 In ogni atteggiamento Hanno è assai simile a Luchino: «Il piccolo stava appoggiato al
pianoforte […], le gambe sottili incrociate, la testa un po’ reclinata in un atteggiamento di grazia timida e inconsapevole. […] Egli teneva le labbra un po’ contratte e le palpebre abbas-sate di modo che le lunghe ciglia brune si disegnavano sull’ombreggiatura azzurrina degli oc-chi. Sapeva già dove sarebbe andato a finire. Avrebbe pianto, per le lagrime non avrebbe po-tuto giungere alla fine della poesia […] … Avrebbe pianto, come accedeva sempre quando […] si mettevano alla prova, come piaceva al babbo, le sue capacità e la sua presenza di spiri-to» (Budd, pp. XXX; tr. it., pp. 454–455).
PARTE PRIMA – Giovanni Verga e la letteratura europea
110
con accoramento, la vedeva entrare portando con sé il figliolo» (ivi, p. 510; tr. it. p. 478).
Senza dubbio, sia Luchino che Hanno sono creature di stampo niet-scheano: appartengono al tipo dell’anti–eroe debole, malato e “malri-uscito” che discende da una stirpe di “signori” un tempo dominatori predaci e gagliardi; per varie ragioni col tempo la stirpe si indebolisce e si infiacchisce fino a dare rampolli siffatti. Questo tema fu elaborato e variato da D’Annunzio soprattutto nelle Vergini delle rocce (1896), romanzo di cui, come si è ricordato, Mann ha fatto una parodia gioco-sa, a tratti sarcastica, e tuttavia non priva di accenti serissimi, nell’im-portante racconto lungo Tr23. Checché sia di ciò, TrM, come fu benis-simo percepito da Vittorio Santoli, è tra le opere dannunziane che più influenzano Thomas Mann. Mentre intensa e seria è l’influenza di TrM sui Budd, ove a tratti Mann compete in modo serrato (la para-frasi di Wagner) con l’odiato collega italiano, il romanzo di D’Annunzio è oggetto esso pure, come Le vergini delle rocce, di pa-rodia giocosa in Tr24.
23 Cfr. il mio articolo D’Annunzio nel mondo incantato …, cit. sopra, alla nota 2. 24 Mi limito a segnalare in questa nota temi e movenze di TrM che, pur essendo da Mann
utilizzati prevalentemente in Tr sono accolti e rielaborati con prudenza anche per Budd. Ippo-lita, la bellissima donna amata da Giorgio Aurispa, pare a lui tanto più affascinante, eterea e pura da contrassegni di appartenenza al mondo materiale quanto più ella, che ha carnagione assai pallida, diventa esangue e bianca. Ella assume allora una «pallidezza quasi mortale, pro-fonda, cupa» e piena di ombre: quella segnata dai cigli sotto gli occhi, quella che vela il lab-bro superiore. Giorgio, contemplando l’amante, pensa che «nella malattia e nel languore» «la sua bellezza si spiritualizza»; egli l’aveva notata e si era sentito da lei attratto perché una ma-lattia l’aveva resa «la donna che non aveva una goccia di sangue»; a parere di lui, «morta ella raggiungerà la suprema espressione della sua bellezza. Morta! E s’ella morisse? Ella di-venterebbe materia di pensiero, una pura idealità» (TrM: le prime quattro citazioni si leggono a p. 168 e la quinta alle pp. 168–169; il corsivo è di D’Annunzio; cfr. anche ivi, p. 36). Nel pieno fulgore della sua grande bellezza Gerda Arnoldsen, fidanzata di Thomas Buddenbrook, ha occhi «circondati di lievi ombre azzurrine» (Budd, p. 291; tr. it. p. 273) e «viso bianco» (i-vi, p. 292 e anche p. 303; tr. it. p. 273 e p. 284), «dalla fronte nivea immacolata» (ibidem; tr. it. p. 273); e il petto, sotto la scollatura, pare di marmo (ivi, p. 305; tr. it., p. 286). Nel corso del romanzo Mann insisterà sempre sul fatto che la bellezza di Gerda appare «un po’ malata» (ivi, p. 343; tr. it. p. 321) e che il pallore di lei contrasta spesso col colore rosso scuro dei suoi capelli abbondanti (cfr. ibidem; tr. it. p. 321). Ancora parecchie settimane dopo il difficile par-to e la nascita di Hanno, Gerda è pallidissima, e «stranamente bella nel suo pallore» (ivi, p. 397; tr. it. p. 371). L’attribuzione insistita di un pallore supremo, di un aspetto esangue, di ombre fitte sul volto (specie sotto gli occhi) a una donna tisica molto bella (Gabriele Eckof) è invece condotta con registro prevalentemente burlesco e sarcastico in Tr. La raffigurazione fi-sica del marito di Gabriele, Anton Klöterjahn, deliziosa parodia del ritratto (eseguito da Leo-
CAPITOLO III – Il Verga verista nel giovane Thomas Mann 111
7. Rosso Malpelo e la Knabennovelle (la storia di Hanno) La critica ha notato da sempre che Budd par nascere da due ispira-
zioni diverse, corrispettive a due blocchi narrativi distinti: due ispira-zioni e due blocchi narrativi che l’autore riesce a fondere, ma non del tutto. In particolare, il tratto narrativo successivo alla morte di Thomas e la lunga descrizione di una angosciosa giornata di Hanno a scuola, preludio della malattia e della morte del giovinetto, sono come un cor-
nardo da Vinci) di un antenato di Claudio Cantelmo, trae alimento dalla raffigurazione del pa-dre e del fratello di Giorgio Aurispa, tra loro molto somiglianti: «il fratello mangiava con vo-racità, senza levar mai la faccia di sul piatto, occupato nella bisogna. Non aveva ancóra vent’anni; ma era tarchiato, ingrossato già da un principio di pinguedine, acceso di colore. I suoi occhi piccoli e grigiastri, sotto la fronte bassa, non mostravano alcun lampo d’intelligenza; una lanugine fulva gli copriva le gote, le mascelle forti, gli ombrava la bocca tumida e sensuale; la stessa lanugine gli appariva su le mani dall’unghie poco nette […]. Giorgio pensò: “È un bruto. […]”» (TrM, pp. 82–83); quanto al padre, libidinoso e infedele: «Pingue, sanguigno, possente, quell’uomo pareva emanare dalle sue membra un perpetuo ca-lore di vitalità carnale. Le mascelle assai grosse; la bocca tumida e imperiosa, piena d’un sof-fio veemente; gli occhi torbidi e un po’ biechi; il naso grande, palpitante, sparso di rossore; tutte le linee del volto portavano l’impronta della violenza e della durezza. Ogni gesto, ogni attitudine aveva l’impeto d’uno sforzo, come se la muscolatura di quel gran corpo fosse in continua lotta con l’adipe ingombrante» e Giorgio «notò che all’angolo di ciascun occhio, su la tempia, aveva un fascio di rughe e sotto ciascun occhio un gonfiore, una specie di borsa violacea. Notò il collo corto, gonfio, rossastro, apopletico» (ivi, p. 83 e p. 84). Ecco la raffigu-razione di Anton Klöterjahn: «Era di media statura, tarchiato, vigoroso e corto di gambe; nel viso pieno e rubizzo gli occhi, […], erano di un azzurro acquoso, le narici larghe e le labbra umide. […]. Soprattutto gli piaceva mangiare e bere bene e abbondantemente: […] ottimo in-tenditore di cucina e di vini, […] intratteneva con gran fervore gli altri ospiti sui pranzi che si davano nella sua cerchia di conoscenze in patria, nonché su descrizioni di pietanze prelibate e lì sconosciute. Nel discorrere di ciò i suoi occhi si socchiudevano affettuosamente e […] leg-geri grugniti di voracità gli salivano dalla gola. Che poi non fosse intimamente alieno da altre gioie terrestri, venne assodato una sera, quando un ospite de La Quiete […] lo vide nel corri-doio scherzeggiare in guisa alquanto disdicevole con una cameriera» (Tr, p. 9; tr. it., p. 12; corsivi miei). Dalle due raffigurazioni dannunziane trae alimento anche quella di Alois Per-maneder, il volgare e bonaccione secondo marito di Tony Buddenbrook: «Poteva avere qua-rant’anni. Corpulento, con le estremità corte, portava una giacca aperta di panno marrone, il panciotto chiaro a fiorami che seguiva dolcemente la curva del ventre […] i calzoni di un in-distinto colore grigioverde erano troppo corti. I baffi biondi, […] conferivano alla sua testa sferica, col naso grosso e i capelli piuttosto radi e scomposti, un che della foca. […]. Le guan-ce erano straordinariamente grasse e gonfie e risalivano in certo qual modo fino agli occhi che erano ridotti a due fessure sottili e azzurre, ai cui angoli si formavano le zampe di gallina. Di sotto al mento una riga diritta scendeva verso la sottile cravatta bianca, la linea di un collo quasi gozzuto che non avrebbe tollerato il colletto. E non c’era quasi passaggio tra il mento e il collo, fra l’occipite e la nuca, fra le guance e il naso: tutto era un po’ informe e imbottito» (Budd, p. 324; tr. it. p. 304).
PARTE PRIMA – Giovanni Verga e la letteratura europea 112
po rimasto quasi estraneo rispetto alla cronaca familiare e aziendale. Stando a quanto si è messo in luce finora, dunque, parrebbe che se l’opera letteraria che maggiormente aiuta Thomas Mann nella costitu-zione dello scheletro del suo gran romanzo è Mal, quest’ultimo testo, da un certo punto dello stesso scheletro in poi prende a esercitare una influenza minore e da ultimo cessa di esercitare qualsivoglia influen-za. Occorre ritornare alla biografia dello scrittore.
Dall’ottobre 1896 fino alla fine di aprile del 1898 Thomas Mann abita ininterrottamente in Italia, cambiando spesso residenza, ma al-ternando per lo più soggiorni a Roma e villeggiature estive a Palestri-na. Si suole fare risalire il primo forte impulso alla stesura di un ro-manzo vero e proprio, dal respiro non amplissimo ma più ampio ri-spetto a quello dei racconti da lui composti fino a quel momento, a una lettera datata 29 maggio 1897 inviata dall’editore Samuel Fischer all’esordiente e promettente scrittore. Fischer butta lì, ma in maniera sicuramente intenzionale, che pubblicherebbe volentieri qualcosa di più lungo e impegnativo dei racconti, un romanzo, magari non troppo voluminoso. A partire dal momento in cui riceve la lettera di Fischer, Thomas Mann trova il coraggio necessario — basti pensare che può contare su un editore e su un compenso — e si mette al lavoro. Il 20 agosto 1897 scrive all’amico Otto Grautoff che sta preparando un ro-manzo, un grosso romanzo; e soggiunge che ha appena trovato (“sco-perto”, «entdeckt», secondo l’espressione sua) una materia, un conte-nuto che gli è molto congeniale e a cui desidera vivamente dare forma espressiva. Tutt’altro che improbabile, dunque, è che lo abbia trovato in Italia, nei mesi tra la primavera e l’estate del 1897.
Il romanzo, nella prima intenzione dell’autore, doveva essere una “Knabennovelle”, il racconto delle esperienze e del vissuto di un ra-gazzino, forse di un adolescente: insomma, Budd, quello che sarebbe diventato il romanzo epico–naturalistico più ampio e importante della letteratura tedesca, era originariamente circoscritto alla breve vicenda umana di Hanno, l’ultimo dei Buddenbrook, destinato a morte precoce dopo una vita strozzata e angosciata.
Quali eventi culturali, ai quali Mann, intenzionalmente o casual-mente, poté prestare viva attenzione, accaddero entro l’estate del 1897 in Italia? Tenuto conto del fatto che tra il 1894 e il 1900 l’autore italia-no con il quale Mann principalmente intrattiene un complesso e frut-
CAPITOLO III – Il Verga verista nel giovane Thomas Mann 113
tuoso commercio intertestuale è Giovanni Verga; e tenuto conto altresì del fatto che lo scheletro o il nudo tronco e i nudi rami di circa tre quarti dei Budd trovano corrispondenze nel nudo scheletro dei Mal e che qualche riscontro si trova anche nella polpa e nell’epidermide, in-somma nel livello più visibile, la prima domanda da porsi è: poté forse Mann trovare in qualche testo di Verga lo spunto per la Knabennovel-le, per la storia di Hanno? Nel 1897 l’editore milanese Emilio Treves fece uscire una ristampa di lusso, sorvegliata dall’autore, della raccolta di novelle Vita dei campi. Giovanni Verga apportò alle sue novelle correzioni talvolta radicali rispetto alla princeps del 1880: le accorciò e ne semplificò la sintassi. I testi di Vita dei campi secondo questa rara edizione illustrata del 1897 sono di assai più agevole lettura e com-prensione rispetto a quelli della princeps.
Tra le novelle di Vita dei campi una ve n’è che dette lo spunto prin-cipale alla Knabennovelle: Rosso Malpelo. Si badi: l’esame della pro-duzione giovanile manniana fino a Budd induce a credere che lo scrit-tore tedesco avesse letto anche le Rusticane e quasi certamente tutte le raccolte di novelle pubblicate da Verga entro il 1883. Dunque ci si trova davanti a un ampio ventaglio di possibilità: può darsi che edi-zioni conformi alla princeps di Vita dei campi fossero capitate nelle mani di Thomas Mann (caso propiziato forse da suo fratello Heinrich, già ottimo conoscitore della lingua italiana) nei primi mesi del sog-giorno in Italia; può darsi che la notizia della ristampa 1897 di Vita dei campi attirasse per la prima volta l’attenzione di Thomas Mann sulle novelle veriste di Vita dei campi ma che egli se le procurasse secondo un’edizione conforme alla princeps (assai più facilmente reperibile); può darsi che l’edizione del 1897, di assai più agevole comprensione linguistica e soprattutto sintattica che non la princeps, spianasse pri-mamente la strada alla lettura delle novelle veriste tutte di Verga e poi alla lettura dei Mal. Tutto questo insieme di ragioni mi spinge a tener sott’occhio sia la versione 1880 sia la versione 1897 della novella di Verga qui messa in parallelo con la storia di Hanno, ma a citare (e pre-ferire) sempre secondo l’edizione 1880.
È pressoché certo o è certo che la lettura del romanzo di padron ’Ntoni e di ’Ntoni lettura linguisticamente ardua anche per qual-siasi Italiano munito di decorose basi umanistiche fu condotta a termine felicemente da Thomas Mann solo dopo che questi ebbe let-
PARTE PRIMA – Giovanni Verga e la letteratura europea
114
to e riletto le novelle: non a caso il romanzo di Hanno fu concepito prima del romanzo di Johann, di Jean e di Thomas. Allo scetticismo di coloro ai quali codesta familiarità di Mann con il Verga dei Mal non sembrerà credibile in sostanza perché Mann, com’è più che naturale, mai ne ha fatto menzione è da dire: 1) che i pregiudizi indubbiamente si indossano volentieri, come un abito confortevole, ma in genere rendono pessimi servigi al progresso del sapere; 2) che Thomas Mann, il massimo scrittore del Novecento, ha portato a compimento imprese ben più ardue che non quella di leggere la nar-rativa verista e non verista di Giovanni Verga, da lui sicuramente let-ta con grande attenzione e con atteggiamento fortemente ambivalente (non a torto: a stento si può credere che l’autore dei Mal sia lo stesso autore di Eva).
Torno a RM3. Mann viene attratto eminentemente da due nuclei tematici: il primo è quello, basilare, per cui il ragazzino Malpelo, fin da quando è un bimbetto, avverte come infernale la propria vita e precocemente accarezza pensieri di morte, intesa questa come nullificazione totale. Il secondo nucleo risiede nell’amicizia tra Malpelo e Ranocchio. Ranocchio è l’unico amico di Malpelo; que-sto rapporto intenso e coinvolgente si conclude con la morte di Ranocchio, quando i due amici non sono più propriamente bambi-ni, ancorché non venga espressamente scritto che essi si trovano alle soglie della pubertà. Nel romanzo di Mann questa amicizia di-venterà la cellula generatrice di ampie porzioni del tessuto figura-tivo e sarà elaborata in chiave delicatamente omoerotica. Negli an-ni della scuola elementare Kai e Hanno, per iniziativa del primo, si tengono per mano durante le ore di ricreazione. Durante la pubertà la loro amicizia appare addirittura sospetta a insegnanti ed educa-tori:
Da gran tempo quell’amicizia era ben nota in tutta la scuola. I maestri la tolleravano a malincuore perché vi sospettavano qualcosa di sporco e di ri-voluzionario [weil sie Unrat und Opposition dahinter vermuteten], e i com-pagni, incapaci di scoprirne la natura, si erano abituati ad accettarla con una certa timida antipatia [sie mit einem gewissen scheuen Widerwillen gelten zu lassen] e a considerare i due amici come outlaws e come strani originali che bisognava lasciar stare. Del resto il conte Kai Mölln godeva un certo ri-
CAPITOLO III – Il Verga verista nel giovane Thomas Mann 115
spetto per la sua libera e selvaggia insubordinazione. (Budd, pp. 719–720; tr. it. p. 675: il corsivo è del traduttore) L’afflato morale informatore della novella di Verga, consistente in
una dickensiana e filo–liberaleggiante descrizione dello sfruttamento del lavoro minorile e della importanza fondamentale, per i bambini e gli adolescenti, della guida di genitori amorevoli, non tocca corde sen-sibili dell’anima di Thomas Mann, peraltro allora appena venticin-quenne. Nondimeno gli occhiali con cui Mann, se così si può dire, legge la vicenda dell’amicizia tra Malpelo e Ranocchio sono perfetta-mente autorizzati dalla lettera del testo italiano: «Ogni volta che a Ra-nocchio toccava un lavoro troppo pesante, e Ranocchio piagnuccolava a guisa di una femminuccia, Malpelo lo picchiava sul dorso e lo sgri-dava: Taci pulcino! e se Ranocchio non la finiva più, ei gli dava una mano, dicendo con un certo orgoglio: Lasciami fare; io sono più forte di te» (RM3, p. 59); Malpelo stesso, tra serio e scherzoso, at-tribuisce apertamente all’amico un’indole piuttosto femminile che ma-schile: «Allora Malpelo si grattava il capo, e sorridendo gli faceva un certo verso da monellaccio malizioso che la sa lunga. “Tua madre ti dice così perché, invece dei calzoni, tu dovresti portar la gonnella”» (ivi, p. 69). Immenso è l’affetto, amore e amicizia insieme, di Malpelo nei confronti di Ranocchio25.
È doveroso distinguere i due inferni, quello di Malpelo e quello di Hanno. L’inferno di Malpelo è la gigantesca, buia, labirintea cava di rena rossa in cui egli lavora. Questa è anche una proiezione del male di vivere del fanciullo, al quale, dopo la morte di suo padre, nessuno più vuole bene. Perfino la madre e la sorella lo sfruttano, lo maltratta-no, e da ultimo lo abbandonano. Così, quando chi comanda nella cava
25 Quando Ranocchio si ammala, Malpelo, alla sera «si caricava Ranocchio sulle spalle, e
gli faceva animo alla sua maniera, sgridandolo e picchiandolo» (RM3, p. 70); senonché «Ra-nocchio non guariva e seguitava a sputar sangue, e ad aver la febbre tutti i giorni. Allora Mal-pelo rubò dei soldi dalla paga della settimana [che aveva il dovere di consegnare tutta alla madre, N.d.A.], per comperargli del vino e della minestra calda, e gli diede i suoi calzoni quasi nuovi che lo coprivano meglio» (ivi, p. 71); le condizioni di Ranocchio si aggravano inesora-bilmente: «Malpelo se ne stava zitto ed immobile chino su di lui, colle mani sui ginocchi, fis-sandolo con quei suoi occhiacci spalancati […] e allorchè lo udiva gemere sottovoce, e gli ve-deva il viso trafelato e l’occhio spento […] gli borbottava: È meglio che tu crepi presto! Se devi soffrire in tal modo è meglio che tu crepi! » (ibidem).
PARTE PRIMA – Giovanni Verga e la letteratura europea 116
gli chiede di partire per esplorare una galleria sconosciuta, a rischio di smarrirsi nelle viscere della terra, Malpelo partirà, ben consapevole dei rischi che corre, e non tornerà mai più. Pure Hanno è afflitto dal male di vivere, in maniera assai più raffinata ma anche deterministi-co–biologica (e in ciò si sente tra l’altro l’influenza di TrM): egli per-cepisce se stesso come una persona del tutto incapace di costruire qualcosa, di perseguire e di conseguire obiettivi. Il suo talento musica-le, effettivo, concreto, non è però robusto abbastanza da consentirgli di diventare un musicista di professione. Hanno si sente — lo confida a Kai — un essere del tutto privo di volontà, un debole e un fallito; e-gli non è alieno dal dar ragione al professore che vede in lui l’ultimo esemplare di una specie degenerata.
Al di là delle varie sofferenze fisiche e degli attacchi di panico o di angoscia (il «pavor nocturnus») Hanno soffre terribilmente nel perce-pire che Thomas, suo padre, si sforza con irritazione di rendere più ro-busta la sua tempra ipersensibile e tenta di infondergli interesse per la professione di commerciante. Alla fine del romanzo, dopo che Tho-mas è morto già da alcuni mesi, il lettore viene condotto direttamente all’interno del male di vivere di Hanno. Ciò avviene mediante la de-scrizione minuziosa di una giornata di paura e disperazione intensis-sime a scuola, una scuola che per il giovinetto è un inferno, retta da un direttore che ha introdotto i più severi e autoritari principi della disci-plina prussiana. È, quest’ultima parte, quella che quasi si stacca dal tronco principale del romanzo. L’angoscia di quella giornata rivela de-finitivamente a Hanno che per lui la soluzione migliore è morire.
Lo scrittore tedesco scompone l’insieme di qualità che contrasse-gnano Malpelo e l’insieme di qualità che contrassegnano Kai. Egli mescola tutto insieme e poi separa nuovamente in due insiemi diversi; egli così compone la personalità di Hanno attribuendo a essa caratteri-stiche proprie sia dell’indole di Ranocchio sia di quella di Malpelo. Altrettanto fa con Kai. Vediamo: Hanno fin dalla nascita è un bimbo infermiccio, ipersensibile, debole nel corpo e nello spirito; esattamente questo è, a parere di Malpelo, l’amico Ranocchio. Hanno è assai mite di carattere ed è praticamente indifeso a fronte delle prepotenze di chi è più forte di lui. Ranocchio è contrassegnato da identici aspetti. Han-no è precocemente preda di angosce tremende e vive quasi costante-mente in preda all’ansia e alla paura. Questi sono tratti propri di Mal-
CAPITOLO III – Il Verga verista nel giovane Thomas Mann 117
pelo (da lui non confessati). Kai e Ranocchio, invece, hanno un’indole serena e fiduciosa nei confronti della vita. Kai è coraggioso e risoluto nello spirito e gagliardo e robusto nel corpo: queste sono qualità pro-prie anche di Malpelo. Kai ha tempra marcatamente virile: egli prende senza esitazione l’iniziativa di stringere amicizia con Hanno, il quale ha temperamento muliebre ed è un poco effeminato nell’aspetto26. Kai si comporta all’inizio nei confronti dell’amico quasi come un corteg-giatore e poi sempre lo aiuterà e lo proteggerà. Anche l’amicizia tra Ranocchio e Malpelo si annoda per iniziativa di questo e anche Mal-pelo, come si è già constatato, si sente un uomo vero, e aiuta e proteg-ge l’amico, il quale ha un temperamento muliebre, fino a compiere da ultimo per Ranocchio sacrifici eroici.
Kai è un affabulatore: egli inventa, racconta a Hanno e da ultimo anche scrive storie fantastiche, talvolta fiabe vere e proprie, a lieto fine (cfr. Budd, p. 520; tr. it., p. 488). Anche Malpelo è un affabulatore, ama raccontare a Ranocchio storie dal contenuto lugubre e macabro. Hanno si interroga con vivissima preoccupazione il padre Thomas
«doveva forse appartenere completamente alla madre? [so ganz und gar dieser Mutter gehören?]» (Budd, p. 508; tr. it. p. 477); «il se-natore infatti non si nascondeva che la continua tutela femminile non era la più adatta a stimolare e sviluppare in lui qualità virili [daß die beständige weibliche Obhut, unter welcher der Junge stand, nicht eben
26 «und ohne die rücksichtslose Initiative des kleinen Kai wären die Beiden einander wohl
fremd geblieben. Ja, das leidenschaftliche Tempo, mit dem Kai sich ihm genähert, hatte den kleinen Johann anfangs sogar erschreckt. Dieser kleine, verwahrloste Gesell hatte mit einem Feuer, einer stürmisch aggressiven Männlichkeit um die Gunst des stillen, elegant gekleideten Hanno geworben, der gar nicht zu widerstehen gewesen war» (Budd, p. 518); «e senza l’iniziativa spregiudicata di Kai i due ragazzi sarebbero rimasti certo estranei l’uno all’altro. Anzi, da principio la fretta e la passione mostrata da Kai nell’avvicinarlo gli aveva persino fatto paura. Quel ragazzino così negletto aveva cercato di conquistarsi il favore di Hanno, il ragazzo silenzioso e vestito elegantemente, con un ardore, con un’aggressività così impetuosa e virile che l’altro non aveva saputo resistere» (tr. it. p. 486). A Hanno il narratore non solo at-tribuisce una costituzione delicatissima e temperamento passivo e pauroso, ma anche, aperta-mente, sembianze quasi femminili: «seine Beine in den schwarzen Strümpfen und seine Arme in den dunkelblauen, bauschigen und gesteppten Ärmeln waren schmal und weich wie die ei-nes Mädchens» (Budd, p. 620); «le sue gambe, vestite di calze nere, e le braccia dentro quelle maniche turchine gonfie e ricamate erano morbide e sottili come quelle d’una fanciulla» (tr. it. pp. 582–83); ma quelle di Hanno sembrano e sono braccia da fanciulla («Mädchenarmen») anche quando egli è immerso in costume nell’acqua della piscina (cfr. ivi, pp. 624–625; tr. it. p. 586).
PARTE PRIMA – Giovanni Verga e la letteratura europea 118
geeignet war, die Eigenschaften der Männlichkeit in ihm anzureizen und zu entwickeln]» (ivi, p. 521; tr. it. p. 488); secondo il Rosso, Ra-nocchio «era sempre stato debole e malaticcio» (RM3, p. 72) e per questa ragione «la madre […] l’aveva tenuto come quei marmocchi che non si slattano mai» (ibidem).
Hanno ha due grandi passioni, le quali gli procurano intenso piace-re: l’una è la musica, e gliela ha trasmessa sua madre. Egli suona con trasporto il pianoforte ancorché ciò non gli apporti né serenità né equi-librio ma solo ebbrezza, e vi sia del feticismo nel desiderio di ascolta-re musica che rapisce. L’altra sua passione risiede nella contemplazio-ne dello spazio infinito pieno del sussurrio lieve e grandioso del mare durante le villeggiature a Travemünde sul Baltico. Anche Malpelo ha due principali passioni: l’una, feticistica, patologica, per gli arnesi e le scarpe di suo padre, dopo la morte di questo ereditate dal Rosso. La seconda passione è quella per la natura all’aria aperta, bella, infinita; i soli momenti di pieno abbandono da parte di Malpelo risiedono nella contemplazione del cielo notturno fiammeggiante di stelle durante le notti estive senza luna.
Manca ogni riscontro sia in Hanno che in Kai al temperamento di-venuto asociale e molto aggressivo di Malpelo. Mann introduce questo riscontro in modo indiretto, all’interno del cono d’ombra ambiguo che sapientemente ha appreso a evocare mediante i giochi onomastici (nel-la fattispecie quello legato alla coppia Gerda–Kai e al cognome Ar-noldsen). Nella seconda delle sette storie raccontate nella fiaba di An-dersen La regina delle nevi accade che un frammento dello specchio del demonio giunga al cuore del piccolo Kaj, l’amichetto di Gerda, sorprendendolo al limite estremo dell’infanzia, prima che si inizi la metamorfosi adolescenziale. Kaj muta carattere, diventa una persona spiacevole e irritante. Esattamente la medesima cosa è accaduta anche al Rosso. Poiché dopo la morte del padre nessuno più gli ha dimostra-to né affetto né comprensione, a eccezione di Ranocchio, e anzi tutti, in paese e all’interno della cava di rena rossa, lo deridono e lo maltrat-tano, Malpelo diviene certe volte vendicativo e crudele. Si è detto che Kai è un affabulatore. Questo talento si desta e si nutre in lui perché, frequentando casa Buddenbrook ha occasione di ascoltare spesso le fiabe dei fratelli Grimm, che la governante–bambinaia Ida legge a Hanno. Tra queste vi è quella dal titolo Il re dei ranocchi («Froschkö-
CAPITOLO III – Il Verga verista nel giovane Thomas Mann 119
nig»: Budd, p. 520)27. In questo modo Thomas Mann introduce nel gran romanzo il nome dell’amico di Malpelo, e ve lo introduce preci-samente nel capitoletto in cui Hanno e Kai fanno conoscenza.
Lasciamo il terreno dell’indole dei personaggi e giungiamo a quello dei riscontri oggettivi, delle risonanze tematiche. Il protagonista del racconto di Verga è da tutti chiamato Malpelo perché ha i capelli ros-si, prerogativa, secondo la credulità popolare, delle persone cattive e possedute dal demonio (cfr. RM3, p. 50 e p. 56). Il piccolo conte de-caduto Kai Mölln ha i capelli rossi (cfr. Budd, p. 516; tr. it. p. 484; la menzione dei capelli rossi del piccolo conte è frequente nel romanzo). Malpelo «era sempre cencioso e lordo di rena rossa» (RM3, p. 50); analogamente Kai era sempre abbigliato di «un misero vestito di colo-re indefinibile al quale mancava qualche bottone e che mostrava una gran toppa sul fondo dei calzoni. Le mani che gli sbucavano dalle ma-niche troppo corte erano come impregnate di terra e di polvere e d’un colore immutabilmente grigio [mit einem ärmlichen Anzug von unbe-stimmter Farbe bekleidet, an dem hie und da ein Knopf fehlte, und der am Gesäss einen grossen Flicken zeigte. Seine Hände, die aus den zu kurzen Ärmeln hervorsahen, erschienen imprägniert mit Staub und Erde und von unveränderlich Hellgrauer Farbe]» (Budd, p. 516; tr. it., p. 484). Il gran romanzo di Thomas Mann raffigura l’operosità e i traf-fici delle solide imprese che operano e commerciano sul Baltico, la lo-ro ascesa e il loro declino. Esso trova il proprio prolungamento ideale, al di fuori della città, non già nello spazio naturale costituito dalla campagna (e dalla vita umana che vi si svolge), bensì nei paesaggi marini sul Baltico, luoghi di villeggiatura ma anche di lavoro alacre sul mare. Grazie al racconto delle condizioni di vita in cui è cresciuto e cresce Kai, nel gran romanzo cittadino e signorilmente borghese ir-rompono per un breve tratto, in modo assai insicuro e stilizzato, la campagna e la vita rustica, agreste, contadina (tanto per dirne una, nel-lo scalcinato poderetto vi è un letamaio ma non vi sono né vacche né cavalli)28.
27 Erroneamente nella traduzione italiana qui seguita (p. 487) si legge invece Pollicino. 28 Il misero e scalcinato fondo agricolo in cui vivono il conte Eberhard e suo figlio si rag-
giunge andando «fuori le mura a nord della città [gen Norden durchs Burgtor hinaus]» (Budd, p. 516; tr. it. p. 484); « Laggiù infatti, alquanto lontano, nei pressi del primo villaggio c’era una piccola masseria, una minuscola proprietà quasi senza valore che non aveva neanche un
PARTE PRIMA – Giovanni Verga e la letteratura europea
120
Il padre di Kai è un aristocratico, un conte, ma, rimasto privo di mezzi, vive e lavora da contadino, tutto dedito ad allevar cani e polli e a coltivare ortaggi. A Thomas Mann certo non era sfuggito che nella lingua italiana le parole contadino e conte sono etimologicamente le-gate in modo intimo.
Nelle novelle di Vita dei campi gli uomini vivono in simbiosi con gli animali. Di conseguenza il carattere di Malpelo e anche atteggia-menti di altri personaggi sono descritti dalla voce narrante pseudo–popolare mediante paragoni con il comportamento degli animali. Sulla scia di Verga anche nel romanzo di Mann, sono insistiti sia l’analogia tra il modo di vivere di Kai e quello degli animali sia l’uso dell’aggettivo selvaggio o selvatico (wild) per qualificare l’indole e l’aspetto di Kai: «Il piccolo Kai era cresciuto laggiù […] selvaggio come un animale selvatico fra polli e cani [war der kleine Kai wild wie ein Tier unter den Hühnern und Hunden herangewachsen]» (Budd, p. 517; tr. it. p. 485). Di Malpelo si diceva che fosse «un brutto ceffo, torvo ringhioso e selvatico» (RM3, p. 50). I compagni di Malpe-lo sono il cane e l’asino, quelli di Kai i cani, i polli e i porcellini d’India. «Hanno Buddenbrook l’aveva visto […] saltare in mezzo ai cavoli come un coniglio e ruzzure coi cuccioli e spaventare le galline con le capriole [Hanno Buddenbrook [hatte, N.d.A.] ihn gesehen, wie er gleich einem Kaninchen im Kohle umhersprang, sich mit jungen Hunden balgte und mit seinen Purzelbäumen die Hühner erschreckte]» (ibidem; tr. it. p. 485).
Sono echeggiate nitidamente, in queste espressioni, movenze di Jeli il pastore e della Storia dell’asino di San Giuseppe. Si legge p. e. nella Storia dell’asino di san Giuseppe: «[l’asinello da cucciolo giocava nella stalla, N. d. A.] a fare a testate e a capriole col montone, e […] a stuzzicare il maiale nel suo cantuccio»; e nella prima novella:
nome [Dort nähmlich, weit draußen, unfern des ersten Dorfes, war irgendwo ein kleines Ge-höft, ein winziges, fast wertloses Anwesen, das überhaupt keinen Namen hatte]» (ibidem; tr. it. 484). Ancora: «Vi si scorgevano un letamaio, un branco di polli, un canile e una povera ca-supola dal tetto rosso e spiovente [man gewann, blickte man hin, den Eindruck eines Misthau-fens, einer Anzahl Hühner, einer Hunde–hütte und eines armseligen, katenartigen Gebäudes, mit tief hinunterreichendem, rotem Dache]» (ibidem; tr. it. p. 484). Ivi il conte vive e lavora da contadino, «dedicandosi all’allevamento di polli e cani e alla coltivazione di legumi [be-schäftigt mit Hühner–, Hunde– und Gemüsezucht]» (ibidem; tr. it. p. 485).
CAPITOLO III – Il Verga verista nel giovane Thomas Mann 121
Jeli si ficcava negli spineti come un segugio per andare a scovare delle ni-diate di merli che guardavano sbalorditi coi loro occhietti di pepe; i due fanciulli portavano spesso nel petto della camicia dei piccoli conigli allora stanati, quasi nudi, ma dalle lunghe orecchie diggià inquiete. Scorazzavano pei campi al seguito del branco dei cavalli, entrando nelle stoppie dietro i mietitori, passo passo coll’armento29. Hanno «lo aveva poi ritrovato nell’aula scolastica e da principio
doveva aver provato soggezione per l’aspetto selvaggio [vor dem verwidelten Äußeren] del contino» (Budd, p. 517; tr. it. p. 485; i cor-sivi sono miei). Malpelo dona subito a Ranocchio ciò che ha di più prezioso, cioè il suo scarso cibo; successivamente gli darà perfino i pantaloni di fustagno quasi nuovi che ha ereditato dal padre amatis-simo. Kai ne segue l’esempio, regalando subito a Hanno le proprie cose più care: «ma Kai gli aveva regalato tutto ciò che aveva, le pal-line di vetro, le trottole di legno e persino una pistola di latta, storta, che era quanto di meglio possedeva [aber er hatte ihn mit Allem be-schenkt, was sein gewesen war, mit Glaskugeln, Holzkreiseln und sogar mit einem kleinen, verbogenen Blechpistole, obgleich sie das Beste war, was er besass…]» (ivi, p. 518; tr. it. p. 486). Sia Malpelo che Kai, in una circostanza, mordono i loro nemici. Le unghie del Rosso si sono strappate a furia di scavare per cercare di disseppellire suo padre dopo la frana in miniera; quando gli altri minatori cercano di portarlo via, «non potendo più graffiare, mordeva come un cane arrabbiato, e dovettero afferrarlo pei capelli, per tirarlo via a viva forza» (RM3, pp. 215–216; il corsivo è mio). Kai si tuffa un giorno di nascosto in una piscina per difendere l’amico Hanno dall’aggressione di due robusti coetanei; nuota non visto sott’acqua «arrivando a mordere il giovane Hagenström ficcandogli i denti nel-la carne come un botolo infuriato [und den jungen Hagenström ge-bissen mit allen Zähnen ins Bein gebissen hatte, wie ein kleiner wütender Hund ]» (Budd, p. 625; tr. it. p. 587: corsivi miei; lette-ralmente è da tradurre: «e aveva morso il giovane H. lo aveva morso conficcandogli tutti i denti nella gamba come un cagnaccio in-
29 G. VERGA, Jeli il pastore, cit., p. 136 (cfr. cap. II, nota 10) e Id., Storia dell’asino di S.
Giuseppe, in G. V., Tutte le novelle, cit. (cfr. cap. I, nota 1), p. 274: il testo della seconda no-vella è conforme a quello allestito da Verga nel 1882 per le Novelle Rusticane.
PARTE PRIMA – Giovanni Verga e la letteratura europea 122
furiato»). Qui, come ognun vede, Thomas Mann riutilizza esattamen-te l’identica similitudine che era stata adoperata da Verga.
Thomas Mann è attratto dalla scena primordiale: dai morsi di Mal-pelo, dai capelli usati come presa per trascinarlo via. Lo scrittore tede-scoi la rielabora, mescolandola probabilmente ad altri suggerimenti di origine diversa, nel primo capitolo della parte seconda del romanzo. Il console Jean rilegge il quaderno di famiglia. Gli capita sotto gli occhi tra l’altro il resoconto di un accidente occorso a lui. «A Bergen Dio l’aveva salvato dalla morte per annegamento». Caduto in acqua tra le chiatte, affiora due volte senza che nessuno riesca ad afferrarlo; alla terza volta affiorano solo i capelli, e nondimeno «uno […] poté pren-dermi per i capelli e io mi aggrappai al suo braccio. Ma poiché non ri-usciva neanche lui a reggersi si mise a gridare e a strepitare, così forte che gli altri udirono e […] lo trattennero. Anch’io non lasciai la stret-ta, quantunque lui mi mordesse il braccio, e così fu che egli poté sal-varmi» (Budd, p. 53–54; tr. it. p. 48–49). Vi è, rispetto a Rosso Malpe-lo, inversione delle due azioni e anche del secondo agente: nel roman-zo prima Jean viene afferrato per i capelli, poi il soccorritore gli mor-de il braccio (mentre Malpelo morde lui i pretesi soccorritori) per libe-rarsi della sua stretta. In entrambi i casi la situazione si innesta su un incidente mortale o potenzialmente mortale.
Le intense e insistite fantasie di morte di Hanno traggono almeno parzialmente origine da quelle di Malpelo. È dato ravvisare in en-trambi i testi una sorta di progressiva presa di coscienza del loro de-stino da parte dei due fanciulli. Entrambi muoiono dopo aver piena-mente compreso che il loro destino è di morire prima di diventare adulti. Entrambi ritengono che la morte sia per loro la migliore solu-zione possibile. Alle fantasie di morte si unisce la morbosa attrazione di entrambi i ragazzini verso la decomposizione (il tema, è chiaro, fa parte dell’esprit du temps). Malpelo comincia a coltivare questa at-trazione dopo il ritrovamento della salma di suo padre, Hanno dopo la morte di sua nonna Elisabeth, alla salma della quale egli è costret-to a rendere un estremo omaggio (Budd, p. 587–589; tr. it. pp. 550–552). In seguito a queste esperienze entrambi i ragazzini, in diverse occasioni, si trovano a fronte della sensazione o della realtà del di-sfacimento dei corpi. In Hanno prevale la sensazione olfattiva, in Malpelo quella visiva. L’ultimo incontro di Malpelo con Ranocchio
CAPITOLO III – Il Verga verista nel giovane Thomas Mann 123
coincide con la visita di Malpelo a Ranocchio, il quale è ridotto a let-to in fin di vita a casa sua e ormai non è più in grado di riconoscere nessuno, neppure sua madre e neppure Malpelo30. L’ultimo incontro di Kai con Hanno coincide con la visita di Kai ad Hanno, ridotto dal tifo a letto in fin di vita a casa sua. Udendo la voce di Kai, Hanno sembra sorridere, benché ormai non sia più in grado di riconoscere nessuno.
È tempo di concludere. Quando, all’inizio del capitolo quinto della parte settima, Thomas Buddenbrook comincia ad accarezzare il progetto di fare costruire per sé e per la propria famiglia una casa sontuosa, pensa subito di farla edificare su un vasto appezzamento di terreno sito nella Fischergrube. La seconda casa–simbolo del prestigio e poi del declino dei Buddenbrook viene sempre chiamata la casa della Fischergrube e tale espressione ricorre parecchie volte fino alla conclusione del romanzo. Il pescatore, in tedesco, è Fi-scher, der Fischer; Grube, die Grube, è invece una fossa profonda, ma anche la cava, la miniera. Il mago, der Zauberer, pone un niti-dissimo segnale toponomastico a indicare e nominare esattamente il confine e al contempo il congiungimento del tratto di romanzo che
30 «Finalmente un lunedì Ranocchio non venne più alla cava, e il padrone se ne lavò le
mani, perchè allo stato in cui era ridotto oramai era più di impiccio che d’altro. Malpelo si in-formò dove stesse di casa, e il sabato andò a trovarlo. Il povero Ranocchio era più di là che di qua, e sua madre piangeva e si disperava come se il suo figliuolo fosse di quelli che guada-gnano dieci lire la settimana. […] Ma il povero Ranocchio non gli dava retta e sembrava che badasse a contare quanti travicelli c’erano sul tetto» (RM3, pp. 71–72). Mann trae da Verga l’idea dell’estremo incontro dei due amici, ma la rielabora con gusto sensualistico, ottenendo effetti languidi e morbidi. In Budd si tratta dell’ultimo disperato incontro raccontato dai pa-renti di Hanno, testimoni oculari tra l’amante e l’amato–amata. Perfino al cospetto della morte spettano a Kai i caratteri virili dell’irruenza, della potenza, della foga passionale e ad Hanno quelli tradizionalmente muliebri della dolcezza, della debolezza e della passività: «Poi si rievocò quell’ultimo episodio, la visita del contino malvestito che si era introdotto quasi a forza nella camera dell’ammalato. Hanno, udendo la sua voce, aveva sorriso per quanto non riconoscesse più nessuno, mentre Kai non cessava dal baciargli le mani [Und dann rief man sich jene letzte Episode ins Gedächtnis zurück… den Besuch dieses kleinen, abgerissenen Grafen, der sich beinahe mit Gewalt den Weg zum Krankenzimmer gebahnt hatte… Hanno hatte gelächelt, als er seine Stimme vernahm, obgleich er sonst niemanden mehr erkannte, und Kai hatte ihm unaufhörlich beide Hände geküßt]» (Budd, p. 758; tr. it. p. 709).
PARTE PRIMA – Giovanni Verga e la letteratura europea 124
ha trovato alimento nei Malavoglia con il tratto di romanzo, la sto-ria di Hanno, che ha preso spunto da Rosso Malpelo: i Fischer, i pe-scatori, rinviano a Padron ’Ntoni e alla sua famiglia; die Grube alla cava in cui lavorano Malpelo e Ranocchio. La letteratura italiana che Mann apprezzò massimamente fu soprattutto quella ambientata nella terra dove «fioriscono i limoni».
Capitolo I – Appunti sulle stampe di Rosso Malpelo
127
Capitolo I
Appunti sulle stampe di Rosso Malpelo
1. La stampa abusiva di Rosso Malpelo e i problemi filologici da es-sa sollevati Rosso Malpelo fu pubblicato per la prima volta sul «Fanfulla» di
Roma, il 2, 3, 4 e 5 agosto 1878 (d’ora innanzi RM1). Fu poi ri-stampato con il titolo Scene popolari. Rosso Malpelo, come opu-scolo n. 29 della collana «Biblioteca dell’Artigiano», edita dalla «Lega italiana del Patto di fratellanza» per la diffusione di buone letture fra gli operai (come recita la didascalia sottostante), Roma, Tipografia del Senato di Forzani e C., febbraio 1880 (d’ora innanzi RM2). Fu successivamente inserito nel volume di G. Verga, Vita dei campi, Milano, Treves 1880 (d’ora innanzi RM3), che costitui-sce la fondamentale prima raccolta di novelle (per lo più d’argomento rusticano) composte dallo scrittore siciliano con spiri-to di adesione alla poetica naturalista. Nella predetta editio princeps di Vita dei campi Verga apportò a Rosso Malpelo alcune significa-tive modificazioni rispetto al testo apparso sul «Fanfulla» due anni prima. La novella fu inoltre riprodotta, senza modificazioni, nella seconda edizione di Vita dei campi, Milano, Treves 1881, e nella terza edizione, Milano, Treves 1892. Nella quarta edizione, di lus-so, illustrata da Arnaldo Ferraguti, Milano, Treves 1897, l’ultima riveduta e corretta da Verga (d’ora innanzi RM4), si registrano mo-dificazioni alquanto rilevanti rispetto alla editio princeps del 1880: rilevanti anche nel caso di Rosso Malpelo1.
1 RM3 è qui sempre citato secondo l’edizione critica di G. V., Vita dei campi, a cura di C.
Riccardi, cit. (cfr. nota 1 al capitolo III della Parte prima). RM1, RM2 e RM4 sono riferiti sia secondo la corrispondente edizione ottocentesca indicata sopra nel testo, sia secondo
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle 128
Il presente scritto costituisce l’adempimento di un piccolo impe-gno di ricerca che intendevo prendere e che credevo di avere ef-fettivamente preso nella conclusione della Nota al testo di Rosso Malpelo, premessa al mio volume Dai suoni al simbolo, di relati-vamente recente pubblicazione. A parer mio così volevo scrivere nella Nota e ribadisco adesso non si può escludere categorica-mente che le varianti di RM2, sebbene, quasi certamente, non siano d’autore, non abbiano costituito per Verga oggetto di riflessione, lievemente influenzandolo nella revisione da lui compiuta per RM3 e soprattutto per RM42. Chiunque sia stato il correttore che ha rive-
l’edizione critica or ora menzionata a cura di Carla Riccardi: la prima indicazione del numero delle pagine si riferisce alle stampe ottocentesche e verrà posta dopo le sigle RM1, RM2 e RM4; la seconda indicazione, preceduta dalla sigla R., si riferisce all’edizione critica e verrà posta dopo le citazioni. Solo ed esclusivamente nel caso della stampa sul quotidiano «Fanful-la», ove ogni puntata è pubblicata a pag. 3, dopo la sigla RM1, in luogo dell’indicazione della pagina, figurerà quella del giorno di pubblicazione, abbreviata e preceduta dal numero del fa-scicolo. È indicato nel presente studio con la sigla RMA l’autografo definitivo di Rosso Mal-pelo, quello consegnato per la stampa in rivista, come è ricostruito nell’edizione critica delle novelle di Vita dei campi a cura di C. Riccardi; la sigla ms si riferisce invece al manoscritto autografo di Rosso Malpelo conservato presso il Fondo Manoscritti della Biblioteca Universi-taria di Catania (BUC, Ms. 239–264). Si avverte qui una volta per tutte sia che in RM4 i no-mignoli dei personaggi corrispondenti a loro qualità o fisiche o morali sono costantemente corretti in carattere curvo (Malpelo, Ranocchio, il grigio, lo Sciancato, il Bestia) e che questa correzione, pertanto, non sarà più espressamente registrata, sia che tutti i corsivi all’interno delle citazioni, salvo diversa, esplicita indicazione, sono di Verga.
2 Nello studio Ancora sulle stampe di Rosso Malpelo, pubblicato sulla «Rivista di lettera-tura italiana» nel 2004, si leggeva alla nota 2 una breve postilla. La riferisco tra virgolette bas-se quasi tale quale era: «Apprendo solo adesso, a fine gennaio 2003, che nella mia Nota al te-sto di Rosso Malpelo, alle pp. 27–28 del volume su Giovanni Verga intitolato Dai suoni al simbolo. Memoria poetica [etc], Pisa–Roma, IEPI, Collana Biblioteca della «Rivista di lette-ratura italiana», pp. 485 (in distribuzione dal gennaio 2003) non vi è traccia della promessa di redigere la piccola ricerca che ho concluso e che presento in questa sede. Trattasi di mia col-pevole e inescusabile svista, della quale è opportuno spiegare gli antecedenti. Nella redazione definitiva del volume Dai suoni al simbolo, consegnata con dischetti e supporto cartaceo alla IEPI, e precisamente nel terzo capoverso della Nota al testo di Rosso Malpelo, menzionavo lo studio di ROSSANA MELIS, Sulle prime edizioni di «Rosso Malpelo» e di «Cavalleria rustica-na». Con una lettera di Giovanni Verga al quotidiano «Fanfulla», su «Giornale storico della letteratura italiana», Torino, CLXVI (1989), n. 535, pp. 433–486. Questo studio reca solide prove a favore del fatto, sconosciuto a tutti gli studiosi dello scrittore verista, che la seconda edizione in opuscolo di Rosso Malpelo (RM2, pressoché identica alla prima, cioè a RM1) era avvenuta all’insaputa di Verga, e che questi, quando fu informato della cosa, protestò vivace-mente contro l’abuso di cui era stato vittima. Un attento raffronto tra le quattro prime stampe di Rosso Malpelo mi aveva tuttavia portato alla conclusione che Verga aveva probabilmente tenuto conto di RM2: in misura lievissima per la terza edizione di Rosso Malpelo e in misura
Capitolo I – Appunti sulle stampe di Rosso Malpelo 129
duto il testo di Rosso Malpelo (nella fattispecie, RM1) per allestire RM2 correttore che verrà d’ora innanzi indicato con la sigla Verga2 , la collazione delle diverse stampe da RM1 a RM4 sug-gerisce con estrema cautela, s’intende che Verga tenne di conto le modificazioni presenti in RM2: sia per introdurre identiche o analoghe modificazioni, sia per riflettere circa una più efficace nuova correzione da apportare a RM3 e soprattutto a RM4. Quelle di RM2, pur non essendo, quasi certamente, varianti d’autore, con-tribuiscono forse in lieve misura a stimolare la produzione di va-rianti d’autore esercitando una mediazione interessante, e stilisti-camente non del tutto irrilevante, tra RM1 e RM3–RM4: in maniera estremamente parca nel percorso RM1 RM3 e in maniera alquan-to più fitta nel percorso RM3 RM4. Ho scritto dianzi «quasi cer-tamente» perché la storia delle stampe dei testi narrativi verghiani, appartengano o non appartengano al periodo del verismo, è costel-lata di avventure drammatiche e di colpi di scena. Ogni studioso prudente ha imparato ormai che quando si ragiona delle edizioni di romanzi e di novelle composti da Verga occorre non dare nul-la come definitivamente certo e assodato3.
non lievissima per la quarta. Tale circostanza, entrambe le due ultime edizioni essendo state sicuramente sorvegliate e corrette dall’autore, aveva fornito decisiva motivazione alla mia scelta di riscontrare, oltre a RMA, a RM1, a RM3 e, più parcamente, a RM4, anche RM2. Per la verità, l’interesse di RM2 in relazione ai propositi e agli esiti delle mie prime ricerche sulla narrativa verghiana era praticamente nullo: appunto perché esso è quasi identico a RM1 e, dal punto di vista evolutivo, legato assai più a RM4 che non a RM3. In considerazione di ciò mi ripromettevo, a conclusione del terzo capoverso della Nota dianzi menzionata, di occuparmi successivamente, in altra sede, delle relazioni RM2 RM3 e soprattutto RM2 RM4. Du-rante la correzione delle bozze del volume Dai suoni al simbolo mi è giunto tra le mani l’assai importante fascicolo monografico di «Italianistica», Pisa–Roma, XXX, 2001, a cura di B. Porcelli, nel quale, alle pp. 515–638, si leggono sei studi di Aa.Vv. sul tema Da «Rosso Mal-
pelo» a «Ciàula scopre la luna». Le avventure editoriali di Rosso Malpelo vi sono a più ripre-se ricordate in dettaglio, e duri sono i giudizi pronunziati nei confronti dell’Edizione naziona-le di Vita dei campi (in cui RM2 figura come testimone nella prima fascia, genetica, dell’appa-rato) da specialisti molto autorevoli. Ho allora cassato, sulle bozze del mio volume, il terzo capoverso della Nota al testo di Rosso Malpelo, per rifarlo in modo assai più sintetico. Dopo avere eseguito il piccolo rifacimento mi sono sempre dimenticata, in ogni fase della correzio-ne, di trascriverlo sulle bozze rivedute. Null’altro posso fare che appellarmi al Vangelo: “Chi è senza peccato scagli la prima pietra”.
3 Cfr., per alcune di queste tormentate vicende, le Note ai testi di Storia di una capinera, di
Nedda e di Rosso Malpelo, alle pp. 25–28 del mio ricordato volume Dai suoni al simbolo. La ricostruzione delle vicende di Rosso Malpelo effettuata da Rossana Melis, per esempio, non ci
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle
130
Le modificazioni che apparentano RM2 a RM4 sono in assai larga misura varianti d’interpunzione. Esse mirano quasi costantemente a rendere più chiari e comprensibili alla media dei lettori vale a dire alla media delle persone capaci di leggere senza difficoltà i perio-di, cioè le frasi composte da più proposizioni, della novella; periodi che sia in RM1 sia in RM3 sono talvolta densi, extra–grammaticali e oscuri tanto che il loro significato letterale è stato frainteso perfino da specialisti eminenti e da sommi critici4. Lo scrittore siciliano sembra considerare, e usare, Verga2 alla stregua di un “idealtipo” at-to a rappresentare il lettore sufficientemente colto, e forse, anzi, un pochino più esperto della media5. Gli interventi compiuti da questo lettore “idealtipico” in RM2 sono spie preziose e rivelatrici, per l’autore, dei luoghi in cui le sue scelte stilistiche hanno suscitato qualche disagio nel predetto lettore, sono state da questo giudicate inopportune per ragioni di varia indole, ma in genere sempre suffi-cientemente chiare6. Quella che si è or ora esposta è una congettura,
consente d’essere assolutamente certi che Verga2 non ebbe tra le mani l’autografo consegnato al «Fanfulla» per la stampa di RM1. Ricordo che l’esistenza della rara edizione Treves 1897 di Vita dei campi è stata scoperta e resa nota agli studiosi nel 1957 da Giovanni Cecchetti, il quale ha dato inizio anche allo studio, a tutt’oggi assai fiorente, delle varianti d’autore a partire dalla stampa su rivista dei racconti di Vita dei campi (tutti pubblicati tra 1878 e 1880) fino alla edizione Treves 1897: G. CECCHETTI, Il testo di «Vita dei campi» e le corre-
zioni verghiane, (1957), in Id., Il Verga maggiore. Sette studi, Firenze, La Nuova Italia Edi-trice 19702, pp. 45–76.
4 Al riguardo cfr. in particolare, nel mio libro Dai suoni al simbolo, cit., il secondo capito-lo della Parte terza, intitolato Presenza o assenza di Leopardi in Rosso Malpelo. Letture criti-
che e problemi di parafrasi (1919–1999), pp. 235–255. 5 Secondo A. STUSSI (Lettura linguistica, nel volume monografico di «Italianistica» citato
alla nota 2, pp. 579–607) Verga2 altri non può essere che il compositore della tipografia del Senato, cioè un «modesto copista “attivo”» che, «essendo del mestiere ben sapeva di avere davanti agli occhi un testo dove potevano essersi insinuati errori tipografici» (entrambe le ci-tazioni si leggono ivi, a p. 585). Molto giustamente Stussi rileva che l’indizio “filologico” di gran lunga più autorevole a sostegno del fatto che Verga non avesse né autorizzato (come lo scrittore siciliano vivamente assicurò all’editore Treves) né tantomeno corretto RM2 risiede nel fatto che sul frontespizio dell’opuscolo si riporta, come nome dell’autore, Giulio Verga invece di Giovanni Verga: «svista che si spiega perché nel “Fanfulla” il titolo è Rosso Malpe-
lo. Racconto di G. Verga, con G. puntata che l’ignaro compositore, in balia di sé stesso, sciol-se con Giulio» (ivi, p. 584).
6 Giovanni Verga ricevette in prestito tra la fine di marzo e l’aprile del 1880 l’opuscolo usci-to, come ventinovesimo, nella collana «Biblioteca dell’artigiano», ed ebbe la possibilità di guar-darlo con attenzione: cfr. MELIS, Sulle prime edizioni di «Rosso Malpelo»…, cit., pp. 440–441.
Capitolo I – Appunti sulle stampe di Rosso Malpelo 131
certo, ma non ha minore riscontro nei “fatti”, nei dati oggettivi di cui siamo in possesso, rispetto all’altra congettura secondo cui lo scritto-re siciliano non dette peso alcuno alla parsimoniosa revisione che un correttore ignoto (il quale lavorava però per una collana notissima, diretta da Achille Grandi) aveva operato sul testo di RM1 per ap-prontare quello di RM2. È fuor di dubbio, infatti, che Giovanni Ver-ga ricevette in prestito tra la fine di marzo e l’aprile del 1880 l’opuscolo uscito, come ventinovesimo, nella collana «Biblioteca dell’artigiano», ed ebbe la possibilità di guardarlo con attenzione. Anche ammettendo (ma trattasi di “ammesso e non concesso”) che egli non prese appunti dall’esemplare di RM2 che gli era stato presta-to; che di esso egli nulla trascrisse e nulla annotò sulla prima stampa da lui sorvegliata; che egli non ebbe più tra le mani, negli anni suc-cessivi al 1880, alcun esemplare dell’opuscolo stampato presso la ti-pografia di Forzani e C.; anche ammettendo tutto questo, non è pos-sibile negare recisamente che tracce della lettura dell’opuscolo non si siano in qualche modo impresse nella mente dello scrittore, e non abbiano lentamente e gradualmente donato un piccolo contribuito al mutamento linguistico, stilistico e del gusto in senso lato, che quali-fica il passaggio da RM1–RM3 a RM4.
Il fatto che la revisione semplificatrice e banalizzante di Rosso
Malpelo, RM4, sia consegnata a un’edizione di lusso, della quale fu-rono stampati un limitato numero di esemplari, nulla toglie alla validi-tà della tesi secondo cui Verga, in RM4, mirava a rendere comprensi-bile il suo testo al pubblico dei semidotti, virtualmente allargando quanto più possibile la fascia d’utenza. Codesta tesi trova anzi soste-gno e motivazione nel fatto che RM4 era un’edizione di lusso, insom-ma un volume che sarebbe andato tra le mani di signore appartenenti all’alta società o alla “buona borghesia” dei professionisti. A queste donne era in genere riservato e consentito, al massimo, un percorso scolastico che le mettesse in grado vuoi di sostenere conversazioni meramente salottiere su argomenti invece intellettualmente impegnati-vi per chi di essi si occupasse non in modo conversevole sibbene con intenti scientifici, critici, e con raffinata perizia tecnica; vuoi di legge-re senza l’aiuto d’altrui componimenti in versi o in prosa non troppo difficili e anzi relativamente semplici, nel lessico come nella gramma-tica e nella sintassi.
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle
132
Vengo ora al rapporto RM2 RM37. Diversi sono stati e sono gli studiosi proclivi a ritenere che RM2 non abbia esercitato mediazione alcuna tra RM1 e RM3–RM4. È stato affermato sia a proposito del-le differenze nell’interpunzione che distinguono RM2 da RM1, sia a proposito di un intervento più “intelligente” (perché implica la com-prensione del contesto) compiuto in RM2 dall’ignoto correttore, inter-vento poi identicamente effettuato dall’autore in RM3 che codeste sono «variazioni poligenetiche, e perciò tali che Verga potrà in séguito arrivare a introdurne di identiche per suo conto»8. Trattasi senza dub-bio di valutazioni rigorose e da condividere metodologicamente. L’intervento “intelligente” di Verga2 consiste nel trasformare «e di di-sperata» di RM1 («e nessuno avrebbe potuto dire se quel sempre cur-vare il capo e le spalle fosse effetto di bieco orgoglio, e di disperata rassegnazione,»: n. 209, sa 3 ago; R., p. 60, rr. 181–182) nell’altro «o di disperata» di RM2 (p. 16), RM3 e RM4 (p. 239; R., r. 182). Una rondine, è vero, non fa primavera; però lasciando per adesso da parte le varianti d’interpunzione , di “rondini” ve ne sono più d’una, che conviene osservare alquanto da vicino con prudenza.
L’influenza di RM2 su RM3 è minima, s’è scritto dianzi, ma baste-vole a suggerire una modificazione dal valore morfologico–lessicale e
7 Per il rapporto RM1 RM2 rinvio a STUSSI, Lettura linguistica, cit., in particolare pp.
584–586. Stussi nota che Verga2 «corregge ovviamente refusi evidentissimi [di RM1], come bigogna per bisogna», mentre lascia correre passivamente ereditando sviste tipografiche di RM1 , «l’erroneo Corvana per Carvana, designazione d’una zona di Catania, refuso che il catanese Verga avrebbe potuto correggere, se avesse rivisto il testo, non certo il compositore della tipografia del Senato»; talora, inoltre, Verga2 interviene per modificare, banalizzandoli, costrutti difficiliores che certamente erano stati ad arte elaborati dall’autore (cfr. ivi: la prima citazione si legge a p. 585 e la seconda alle pp. 585–586); Verga in RM3 corresse «Corvana» trasformandolo in «Carvana» e mantenne l’opportuna correzione in RM4. È tuttavia da notare che non solo «il compositore della tipografia del Senato», ma chiunque non si fosse espressa-mente procurato una conoscenza minuziosa ed esatta dei toponimi corrispondenti alle zone di Catania compresi, poniamo, De Sanctis e Croce non avrebbe potuto rilevare l’errore presumibile nella lezione «Corvana». È da dire inoltre che sull’autografo consegnato da Verga per la stampa di RM1 il toponimo è scritto in maniera dalla difficile decifrazione. Non è affat-to impossibile che, in accordo con il compositore di RM1, sia ivi da leggere piuttosto «Corva-na» che non «Carvana» (cfr. ms, p. 2, interlinea tra il rigo 18 e il rigo 19), nonostante il diver-so, autorevole parere di Carla Riccardi (RMA, p. 50, r. 23). Soggiungo che diversi altri refusi di RM1 sono corretti in RM2 (e le correzioni vengono riprodotte, o grazie alla mediazione di RM2 o per autonoma iniziativa dell’autore, in RM3 e in RM4) ma di essi non verrà fatta men-zione nel presente studio. Bastino le appropriate osservazioni di Stussi.
8 STUSSI, Lettura linguistica, cit., p. 585.
Capitolo I – Appunti sulle stampe di Rosso Malpelo
133
grafico. Sull’autografo (ms, f. 13, rr. 6 e 7) si legge «La povera vedo-va di Mastro Misciu era desolata di aver per figlio quel tristo arne-se,»9; in RM1 (n. 210, do 4 ago) è scritto «La vedova di Mastro Misciu era disperata di aver per figlio quel malearnese,» (R., p. 61, rr. 198–199); RM2 (p. 17) reca una variazione interessante: «La vedova di Mastro Misciu era disperata di aver per figlio quel malarnese,» (tutti i corsivi sono miei). RM3 e RM4 concordano con RM2. Qui l’ignoto correttore è intervenuto anzitutto al fine di correggere quello che gli appariva come un vero e proprio refuso, e poi, forse, anche per uni-formare le occorrenze della stessa parola all’esito che giudicava mor-fologicamente più corretto: più toscano e più italiano. «Malpelo seppe in quell’occasione che la prigione era un luogo dove si mettevano i la-dri, e i malarnesi come lui,»: (RM1, n. 211, lu 5 ago; RM2, p. 31; RM4, pp. 258–259; RM3, R., p. 73, rr. 407–408). Non è impossibile che il «malearnese» di RM1 sia effettivamente un refuso; appare tutta-via più probabile che Verga, il quale si era affaticato, con piena co-scienza riflessa, fin dalla redazione manoscritta, nella ricerca della qualifica peggiorativa più adatta all’“arnese” abbia in RM1 esitato e oscillato tra le due forme distinte «malearnese» e «malarnese», pro-prio come, sempre in RM1, oscilla tra “piagnucolare” e “piagnuccola-re”. Nel caso del «malarnese», a differenza come meglio si vedrà
dell’altro caso, egli apprezza la decisione dell’ignoto correttore e la fa sua fin da RM3.
Un altro caso non probante ma sicuramente assai interessante, ai fi-ni del giudizio circa il duplice rapporto RM1 RM2 RM3 e soprat-tutto RM1 RM2 RM4, è costituito dalla forma grafica del nomigno-lo «sciancato» («sciancato»)–«Sciancato» («Sciancato») nelle tre stampe sorvegliate dall’autore e in quella “curata” da Verga2. L’autore, in RM1 e in RM3, oscilla vistosamente tra l’uso della maiu-scola e quello, assolutamente prevalente, della minuscola. In RM1 (n. 208, ve 2 ago) e in RM3 si legge: «Zio Mommu lo sciancato,» (R., p. 53, r. 41); RM1 (n. 208, ve 2 ago) e RM3: «e lo sciancato disse» (R., p. 54, r. 74); RM1 (n. 208, ve 2 ago) e RM3: « To’! disse lo scian-cato» (R., p. 55, r. 84); RM1 (n. 209, sa 3 ago) e RM3: «E un’altra vol-
9 Carla Riccardi non segnala l’aggettivo «povera», che nell’autografo qualifica la «vedo-
va» e che viene definitivamente soppresso a partire da RM1. Cfr. RMA, p. 61, r. 198.
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle
134
ta, dietro allo sciancato:» (R., p. 57, r. 124); RM1 (n. 209, sa 3 ago) e RM3: «come fa lo Sciancato,» (R., p. 59, r. 158); RM1 (n. 209, sa 3 ago) e RM3: « ripeteva lo sciancato » (R., p. 59, r. 158); RM1 (n. 211, lu 5 ago) e RM3: «rispose lo sciancato.» (R., p. 73, r. 417). Come ognun vede, si registra una sola occorrenza della forma con la maiu-scola.
Anche lo sconosciuto revisore oscilla tra la forma con la maiuscola e quella con la minuscola. Egli, per esempio, in RM2, p. 6 accoglie la forma di RM1: «Zio Mommu lo sciancato». Senonché, trattandosi nel-la fattispecie di un’apposizione del soggetto, l’uso della maiuscola non è richiesto in modo cogente. Si considerino dunque tutte le altre occor-renze del nomignolo. RM2, p. 8: «e lo Sciancato disse»10; RM2, p. 9: « Tò! disse lo sciancato»; RM2, p. 11: «dietro allo sciancato:»; RM2, p. 14: «come fa lo Sciancato»; RM2, p. 21: « ripeteva lo Sciancato »11; RM2, p. 31: «rispose lo Sciancato». Verga2, in so-stanza, interviene sulla seconda occorrenza del nomignolo donandole lettera iniziale maiuscola perché ritiene che la iniziale minuscola di RM1 sia un refuso. Trovandosi poi nuovamente a faccia di due lettere iniziali minuscole (terza e quarta occorrenza) non osa modificarle, perché gli par che la minuscola, ortodossa o eterodossa che sia a nor-ma della “buona” lingua scritta, rifletta la volontà dell’autore. Imbat-tendosi però successivamente in una lettera iniziale maiuscola (quinta occorrenza) che per quanto gli constava era assai più corretta dell’altra, e anzi forse l’unica corretta nella grammatica che si impar-tiva e si impartisce nelle scuole la rispetta, riproducendola nella se-de or ora detta. Non solo: dopo aver conseguito la certezza che l’autore non è intenzionalmente avverso alla iniziale maiuscola il “cu-ratore” di RM2 corregge, uniformando alla iniziale maiuscola le due ultime occorrenze del nomignolo. A questo punto egli avrebbe dovuto ritornare sui propri passi per sostituire la lettera iniziale minuscola con maiuscola a p. 9 e a p. 11, ma ciò non fa: per distrazione, per incuria o per chissà quale altro motivo. In ogni caso le minuscole di p. 9 e di p. 11 vanno equiparate a refusi che non sono stati notati, mentre l’orientamento dello sconosciuto revisore è ben chiaro, anzi chiarissi-
10 Questa variazione non è registrata da Riccardi. 11 Neppure questa variazione è registrata nell’edizione critica di Vita dei campi.
Capitolo I – Appunti sulle stampe di Rosso Malpelo
135
mo: quando non è apposizione, il nomignolo richiede lettera iniziale maiuscola.
Si giunge così a RM4, ove l’oscillazione dell’autore par che tocchi il culmine: p. 224: «zio Mommu lo sciancato»; p. 228: «e lo sciancato disse»; p. 231: « To’! disse infine uno»; p. 234: «dietro allo Sciancato»; p. 237: «come fa lo Sciancato»; pp. 243–244: «ripeteva lo sciancato»; p. 259: «rispose lo Sciancato». Come si può notare a una lettura più attenta, in un primo momento l’autore aveva deciso di uni-formare secondo la minuscola, attenendosi alla forma assolutamente prevalente in RM1 e in RM3. Qualcosa, poi, lo spinge a ritornare sulla propria decisione e a riflettere con una certa attenzione sulla forma grafica preferibile. Che egli rifletta con una certa attenzione si evince dal fatto che, nel terzo dei segmenti sopra riferiti, egli evita di affron-tare il problema, sostituendo al nomignolo il pronome indefinito «u-no». L’ignoto revisore aveva preso partito fin dalla seconda occorren-za, ancorché si fosse poi provvisoriamente “riallineato” a RM1 in terza e in quarta sede; l’autore comincia a sentirsi in crisi forse a partire dal-la seconda occorrenza, ma tale crisi diviene manifesta in terza sede. Subito dopo anch’egli, come parecchi anni prima Verga2, opta per la forma con la lettera iniziale maiuscola. La parola «sciancato», che si legge a p. 244 di RM4, infatti, è un evidente refuso: essa non solo reca una lettera iniziale minuscola, ma, a differenza dell’uso sempre adotta-to in RM4, è in carattere corsivo tondo invece che in corsivo curvo12. S’è scritto dianzi che Verga riflette con una certa attenzione sul pro-blema minuscola/maiuscola; ch’egli non vi rifletta con cura e atten-zione ben vigili si evince dal fatto che neppure correggendo le bozze della edizione di lusso egli si ricorda (né si preoccupa) di tornare in-dietro per correggere in seconda sede uniformando secondo la maiu-scola.
Eccezion fatta per gli episodi che sono stati riferiti e commentati, e per pochi altri meno importanti che saranno esaminati in séguito, Ver-
12 Questa variazione non è segnalata nel vol. XIV della Edizione Nazionale delle opere di
Giovanni Verga; curiosamente, poi, Gino Tellini, nella bella edizione delle novelle di Vita dei campi da lui curata, in cui è adottato come testo–base quello della edizione Treves 1897, cor-regge il refuso di cui s’è toccato senza darne notizia e trascrive senz’altro la parola «scianca-to» (con iniziale minuscola) in carattere corsivo curvo («sciancato»): G. V., Le novelle, a cura di G. Tellini, Roma, Salerno Editrice 1980, 2 tomi; cfr. p. 222 del tomo I.
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle
136
ga, nell’allestire il testo di RM3, si attiene con fedeltà all’assetto lin-guistico (lessicale, grammaticale, sintattico) e stilistico di RM1. Sono bensì implicate in variante cospicue porzioni di testo di RM3, ma trat-tasi di trasformazioni del “contenuto” in senso molto stretto. Codeste varianti interessano, in altri termini, nuclei tematici che vengono pro-fondamente rielaborati al fine di rendere intensamente tragici e pateti-ci, in RM3, alcuni episodi che in RM1 e in RM2 erano meramente or-rendi e macabri e perciò stesso privi o quasi di pathos. Su ciò chi scri-ve ha avuto modo e agio di soffermarsi distesamente e minuziosamen-te in altra sede13.
Correggendo, quasi venti anni dopo la prima stampa, il testo di Rosso Malpelo per l’edizione di lusso del 1897, Verga compie una re-visione stilistica, linguistica e anche contenutistico–espressiva alquan-to approfondita rispetto alle scelte effettuate per RM1 e per RM3. Egli persegue con quasi dogmatica ortodossia l’obiettivo della piena vero-simiglianza di tutte le vicende narrate, e a tal fine sopprime quanto di eccessivamente crudele e grottesco connotava, a parer suo, i compor-tamenti dei personaggi in RM3. Lo scrittore si preoccupa inoltre di rendere più comprensibile il testo in ogni dettaglio. A tal fine egli sa-crifica in certa misura l’andamento paratattico che qualificava RM1 e RM3: un andamento parco di virgole e di altre pause; in cui ogni pe-riodo constava in genere di diverse proposizioni; ricco sia di congiun-zioni coordinanti portatrici, ciascuna, di valori sintattici molteplici, e perciò stesso popolarescamente non ben definiti, sia di legami irrazio-nali (il «che» posto a mimare il «ca» siciliano); non privo di scorret-tezze sintattico–grammaticali ricercate ad arte (gli anacoluti), quasi con sensibilità da espressionista, talvolta al fine di fondere le emozioni e i pensieri di Malpelo con quelli del narratore antifrastico, a Malpelo ostile. A codesto andamento paratattico viene sostituita una sintassi dal tratto assai più ipotattico e scevro di ambiguità (confusione, com-mistione), sia pure veristicamente popolaresca. Mentre ogni subordi-nata acquista il suo chiaro valore sintattico, viene messo in risalto al-tresì, mediante un impiego dei segni d’interpunzione assai più fitto che in precedenza, il valore grammaticale di ciascun elemento del di-
13 Cfr. in particolare il capitolo I della Parte prima, il capitolo I della Parte terza e la Ap-
pendice prima alla Parte quinta della mia già ricordata monografia Dai suoni al simbolo.
Capitolo I – Appunti sulle stampe di Rosso Malpelo 137
scorso. Simultaneamente, la punteggiatura crea segmentazione ritmica e instaura pause, brevi o meno brevi, le quali danno respiro al discorso e consentono al lettore di riprendere fiato e di comprendere esattamen-te ciò che sta leggendo. Trattasi di scelte linguistico–stilistiche che contrassegnano, come è stato giustamente notato, la crisi irreversibile del verismo, e che si collocano per molti versi agli antipodi non solo di Vita dei campi del 1880 ma anche e soprattutto dei Malavoglia14. S’intende, naturalmente, che attuando lo scrittore siciliano una revi-sione così impegnativa e minuziosa, questa si estende a numerosissimi luoghi che la penna di Verga2 non aveva sfiorato, e tale considerazio-ne è affiatata con le valutazioni di Stussi, ancorché chi scrive, forse, non condivida interamente le conclusioni tratte dall’autorevole lingui-sta. La revisione inizia dai primi righi della novella. In RM1 (n. 208, ve 2 ago), RM2 (p. 3) e RM3, alla fine del primo capoverso, si legge: «e persino sua madre col sentirgli dir sempre a quel modo avea [ave-va: RM3] quasi dimenticato» (R., p. 49, rr. 4–5). In RM4 (p. 221): «e persino sua madre, col sentirgli dir sempre a quel modo, aveva quasi dimenticato». Si considerino anche un paio d’esempi tolti dalla zona finale della novella: RM1 (n. 210, do 4 ago), RM2 (p. 24) e RM3: «es-so se ne ride dei colpi e delle guidalesche con quella bocca spolpata e tutta» (R., p. 67, rr. 302–303); RM4 (p. 249): «guidalesche,» (R., r. 303). RM1 (n. 211, lu 5 ago), RM2 (p. 24) e RM3: «La sciara si sten-deva malinconica e deserta fin dove giungeva la vista,» (R., p. 67, r. 305); RM4 (p. 249): «deserta,».
Le variazioni banalizzanti da Verga2 apportate al testo uscito pres-so la Tipografia del Senato, e volte a rendere più correttamente gram-maticale o semplicemente più chiaro il discorso, offrono allo scrittore siciliano un battistrada ch’egli tiene di conto nella revisione che sfocia in RM4. L’ignoto revisore, giova ribadirlo, è assunto come “idealti-po”, o come prototipo, del lettore medio. Le sue correzioni costitui-scono per l’autore spontanea o riflessa che sia la coscienza da cui questi è guidato una spia efficace del disagio che il lettore comune poteva avere provato leggendo RM1 e soprattutto RM3. Non si dimen-tichi, del resto, che i Malavoglia, giudicati senza esitazione (seppure
14 Questi acuti e pertinenti giudizi sono formulati da Riccardi nell’Introduzione (“Vita dei
campi”. Storia della raccolta), all’edizione critica di Vita dei campi, pp. LI sgg.
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle
138
non sempre apertamente e pubblicamente) un capolavoro da tutti i let-tori davvero esperti, da D. H. Lawrence a Thomas Mann, erano stati accolti al loro primo apparire in modo assai tiepido sia dalla critica ita-liana che dal pubblico al quale Verga presumeva di poterli destinare o di averli destinati15.
Le correzioni relative all’interpunzione introdotte in RM2 sono per lo più riconducibili a tre grandi categorie generali: A) eliminazione delle virgole poste in RM1 dall’autore innanzi la congiunzione “e”. B) aggiunta di punteggiatura segmentante. C) eliminazione o sostituzione di segni d’interpunzione di RM1 con altri e diversi segni: questi inter-venti mirano a presentare in maniera anche visivamente continua, coe-sa e compatta elementi grammaticali di una proposizione (o membri di un periodo) tra i quali l’autore aveva inserito una pausa; elementi o membri che, secondo il gusto e il giudizio dell’ignoto revisore, si inte-grano e si completano vicendevolmente dando luogo o a una unità (u-na cellula espressiva) logico–semantico–grammaticale oppure a un’organica unità semantico–sintattica.
2. Dalla stampa in rivista all’opuscolo, alla princeps di Vita dei campi e alla edizione di lusso: primo quadro Si può adesso esaminare in modo circostanziato il duplice percorso
correttorio RM1 RM2, e RM2 RM3 RM4, ove importanza assolu-tamente prevalente riveste, come s’è già scritto, il rapporto RM2 RM4. Ogni tappa del duplice percorso sarà contrassegnata da un numero, per ragioni di chiarezza espositiva. La singola tappa e il numero che la precede, cioè il capoverso, talvolta concerne un solo in-tervento di Verga2, mentre altre volte abbraccia più interventi, che è parso opportuno, per meglio commentarli, mettere a raffronto. In que-sto caso le modificazioni che interessano porzioni di testo diverse, seppure o contigue o molto vicine e che pertanto non sono recate all’interno della medesima coppia di virgolette basse di apertura e di
15 Con lettera datata 11 aprile 1881 Verga manifestava a Capuana, con sconforto, la pro-
pria netta percezione dell’insuccesso dei Malavoglia: «I Malavoglia hanno fatto fiasco, fiasco pieno e completo»: cfr. CartVC, p. 61.
Capitolo I – Appunti sulle stampe di Rosso Malpelo 139
chiusura , vengono precedute a loro volta da numero (in ogni tappa al primo intervento corrisponde il numero 1)) e da lettera dell’alfabeto in carattere minuscolo (le lettere avranno carattere progressivo: se all’interno di un capoverso, o tappa, la lettera è d), nel paragrafo suc-cessivo sarà e))
1) RM1 (n. 208, ve 2 ago) e RM3: «e ciascuno gli diceva la sua motteggiandolo, e gli tiravan dei sassi,» (R., p. 50, rr. 16–19); RM2 (p. 4): «sua,» (R., r. 18). L’intervento dell’ignoto correttore ricade nella tipologia B), ed è accolto in RM4 (p. 222): «e ciascuno gli diceva la sua, motteggiandolo,» (R., rr. 17–19).
2) RM1 (n. 208, ve 2 ago), RM3 e RM4 (p. 224): «si contentava di buscarsi il pane colle sue braccia, invece di menarle addosso ai com-pagni, e attaccar brighe. [RM1: brighe; R., p. 52, r. 36]» (R., pp. 51–52, rr. 35–36); RM2 (p. 5): «ai compagni e attaccar» (l’intervento non è segnalato in R., rr. 35–36). La correzione appartiene alla tipologia A). La sua educazione grammaticale conduce Verga2 a giudicare im-propria la virgola che precede la congiunzione «e», ed egli pertanto la sopprime. Tale soppressione, in sé arbitraria e illecita, è richiesta an-che, secondo la mentalità grammaticale dell’ignoto correttore, dal fat-to che la congiunzione «e», nel contesto specifico, unisce alla prima coordinata avversativa una seconda coordinata, dall’identico valore, essa pure dipendente da «invece di». L’intervento essendo questa volta suggerito da un gusto opposto rispetto a quello che anima l’autore nella revisione culminata in RM4 non viene accolto da Verga nelle stampe successive a RM2.
3) RM1 (n. 208, ve 2 ago), RM3 e RM4 (p. 224): «Va là, che tu non ci morrai nel tuo letto, come tuo padre.» (R., p. 51, rr. 38–39); RM2 (p. 5): «Va là; che» (R., r. 38). La variazione non si lascia comprendere facilmente. Se la sostituzione del punto e virgola alla virgola non è, come in effetti quasi certamente non è, un refuso, è forse spiegabile mercé la forte propensione dell’ignoto correttore a usare la punteggia-ture per costituire gerarchie logiche, grammaticali, sintattiche e se-mantiche definite e precise: i membri di un periodo che non siano tra loro congiunti da legame semantico stretto e necessario devono pre-sentarsi in maniera grammaticalmente e visivamente più segmentata (tipologia B) che non membri dello stesso periodo i quali si integrino e si completino a vicenda nel produrre il significato preminente della
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle
140
frase: questi possono essere demarcati soltanto da una pausa di breve respiro, cioè da una virgola, mentre quelli dovranno essere disgiunti da una pausa più netta. Legittimazione al proprio intervento Verga2 trovava nel fitto ricorso dell’autore, fin dai primi righi della novella, al punto e virgola come segno d’interpunzione che separa due o più pro-posizioni relativamente indipendenti l’una dall’altra. La proposizione (o alcune delle proposizioni disgiunte da punto e virgola facenti parte di una serie relativamente numerosa compresa tra punti fermi) colloca-ta dopo il punto e virgola può essere una falsa coordinata, cioè una principale “travestita” da coordinata.
4) 1a) RM1 (n. 208, ve 2 ago) e RM3: «[Misciu] rispondeva soltan-to cogli ah! ah! dei suoi bei colpi di zappa» (R., p. 52, rr. 49–50); RM2 (p. 6): «ah! ah!» (R., r. 50).
2a) RM1 (n. 208, ve 2 ago) e RM3: «il grosso pilastro rosso […] si piegava in arco come se avesse il mal di pancia, e dicesse: ohi! ohi! anch’esso.» (R., p. 53, rr. 55–57); RM2 (p. 7): «ohi! ohi!» (l’intervento non è segnalato in R., r. 57). Verga2 pone qui rimedio alla curiosa e contraddittoria oscillazione dell’autore sia essa frutto di deliberata volontà di lui o invece di una sua distrazione nella scelta di un se-gno grafico atto a evidenziare esclamazioni emesse da “cose”, cioè e-sclamazioni immaginate e riferite dal narratore in modo antropomorfi-co. Nell’edizione Treves 1880 l’autore non presta ascolto alla legitti-ma pretesa insita in RM2 di rappresentare graficamente in modo uni-forme l’esclamazione dei colpi di zappa e quella del pilastro. Nella re-visione attuata molti anni dopo per RM4 egli nota l’incongruenza ti-pografica esistente in RM1 e in RM3, ma non ha più tra le mani RM2 né ricorda (o ricorda solo vagamente) se una soluzione, e quale even-tualmente, fosse ivi stata data al “dilemma tipografico”. Così egli giunge a un accomodamento frettoloso e insoddisfacente della que-stioncella: «rispondeva soltanto cogli “ah! ah!„» dei suoi bei» (RM4, p. 227; R., 52, r. 50) e «si piegava in arco, come se […] dicesse ohi!» (RM4, p. 227 e R., p. 53, r. 57).
5) RM1 (n. 208, ve 2 ago) e RM3: «non avevano badato [«non ba-darono»: RM3, r. 82] a una voce di fanciullo,» (R., p. 55); RM2: «ba-dato ad una». L’ignoto correttore non nutre simpatia per lo iato. Il segmento riferito appartiene a un luogo che subisce un vero e proprio rifacimento in RM4, in nome dell’ossequio alla piena verosimiglianza
Capitolo I – Appunti sulle stampe di Rosso Malpelo
141
naturalista. Che RM2 secondo un ufficio che esso spesso adempie per la revisione di RM4 abbia in qualche modo contribuito a ri-chiamare l’attenzione di Verga sul luogo in questione, trova conferma nel fatto che il rifacimento sebbene il segmento sopra riferito venga anch’esso modificato profondamente , nella rappresentazione dell’incontro di «e» e di «a» con parola che inizia per vocale si adegua al gusto del lettore “idealtipico”: «Nessuno badava al ragazzo che si graffiava la faccia ed urlava,» (RM4, p. 231; R., p. 55, rr. 80–87; i cor-sivi sono miei).
6) RM1 (n. 208, ve 2 ago) e RM3: «mordeva come un cane arrab-biato e dovettero afferrarlo pei capelli,» (R., p. 55, rr. 93–94); RM2 (p. 9) e RM4 (p. 231): «arrabbiato,» (ivi, r. 93). L’intervento dell’ignoto correttore, accolto da Verga per RM4, appartiene alla tipologia B); grazie all’inserzione della virgola una breve pausa, un momento di re-spiro, separa la proposizione principale dalla coordinata che segue.
7) La variazione successiva è di carattere morfologico–ortografico. In RM1 (n. 209, sa 3 ago), Verga oscilla tra la forma «piagnuccolan-do» (R., p. 55, rr. 95–96), meno corretta (se non propriamente scorret-ta) di quella con la –c– scempia, e quest’ultima («piagnucolando»: sa 3 ago; R., p. 59, r. 163). In RM3 egli risolve senz’altro il dilemma sce-gliendo (e uniformando nel testo secondo) la forma con –cc– dura. Ciò lo scrittore fa ad arte e a ragion veduta, essendo egli massimamente impegnato nella ricerca di quell’assetto fonetico–sonoro duro, aspro, gracchiante che è tra i principali contrassegni, se addirittura non è il principale dei livelli che concorrono all’espressività (alla “significa-zione”) di Rosso Malpelo nel periodo propriamente verista dell’autore. L’ignoto correttore, al quale sfuggono le ragioni e l’efficacia di una ta-le scelta, scambia la –cc– per un refuso da correggere e normalizzare in «piagnucolando» (RM2, p. 9; R., rr. 95–96); in RM4 (p. 232) l’autore, animato dall’intenzione di rendere il discorso linguisticamen-te più corretto e ortodosso di quanto non fosse nelle prime stampe, si adegua alla forma con la –c– scempia, ancorché ciò provochi una mu-tilazione non grave, s’intende , del livello forse più importante nella strutturazione di Rosso Malpelo.
8) RM1 (n. 209, sa 3 ago) e RM3: «e se Ranocchio non si difende-va, lo picchiava più forte, con maggiore accanimento, e gli diceva: To’! Bestia! Bestia sei!» (R., p. 57, rr. 135–136); RM2 (p. 12): «To’,»
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle
142
(R., p. 57, r. 136); RM4 (p. 235): «accanimento, dicendogli: To’,» (R., p. 57, r. 136). La sostituzione del punto esclamativo con la virgola è quasi certamente dettata dalla consueta adesione di Verga2 a un si-stema normativo e prescrittivo grammaticale angusto, forse un po’ meschino, certo assai rassicurante per il lettore non esperto di cose d’arte; lettore che, in grazia di un insieme di regole sufficientemente codificate e apprese come se esse costituissero la grammatica senz’altro, da applicare a ogni corretta scrittura e a ogni bello scrivere
, si sente in possesso di criteri atti a orientarsi nella selva degli ele-menti che compongono la lingua di un testo scritto. Il popolaresco co-strutto verbale imperativo «To’» non può costituire un’esclamazione a sé stante, separata dal nome ch’essa chiama, tanto più che ragiona Verga2 , l’eliminazione del punto esclamativo e la ricomposizione di «To’» e di «Bestia» in un segmento unitario, dotato al proprio in-terno soltanto di una brevissima pausa, instaura o ripristina una sim-metria quasi perfetta con il segmento immediatamente successivo: «Bestia sei!». A conferma di queste valutazioni si può osservare che il «Tò! [sic!]» viene salvaguardato in RM2 in un luogo ove costituisce sicuramente un’esclamazione a sé stante, sia perché non si congiunge né grammaticalmente né a senso con alcun nome da chiamare, sia per-ché è separato anche graficamente, mediante inserzione di una porzio-ne di discorso indiretto, dal discorso diretto restante, del quale costi-tuisce una tessera: « To’! — disse lo sciancato è Malpelo!» (RM1, n. 208, ve 2 ago, e RM3: cfr. R., p. 55, r. 84); RM2 «Tò» e RM4 (p. 231): « To’! — disse infine uno è Malpelo! »16.
Difficile capire se il chiasmo «— To’, Bestia! Bestia sei!» parve in fondo non disdicevole soluzione stilistica all’autore medesimo; questi, tuttavia, non poteva non capire che in tal modo si introduceva quasi uno snaturamento del primitivo discorso diretto d’indole popolaresca, volutamente (nell’intenzione originaria dello scrittore) e giustamente alquanto disordinato e scompaginato, alieno da sottomissione a criteri produttivi di equilibrio e di ordinato bilanciamento. Certo sembra in-vece che Verga, ancora una volta, avvertì la correzione introdotta in RM2 come spia evidente del disagio di un lettore “mediamente attrez-
16 Riccardi non segnala la correzione («Tò») apportata in RM2 all’espressione «To’» di
RM1.
Capitolo I – Appunti sulle stampe di Rosso Malpelo 143
zato” e la accolse per RM4 al fine di porre rimedio a quel disagio, semplificando e banalizzando, a detrimento degli intensi effetti artisti-ci perseguiti e conseguiti in RM1 e soprattutto in RM317.
9) RM1 (n. 209, sa 3 ago), RM3 (R., p. 58, rr. 140–141) e RM4 (p. 235): « Così, come ti cuocerà il dolore delle busse, imparerai a dar-ne anche tu! »; RM2 (p. 10), invece: «tu.» (R., r. 141). Eliminando il punto esclamativo e sostituendolo con un punto fermo (intervento che appartiene, parzialmente, alla tipologia B) lo sconosciuto revisore at-tenua fortemente, o toglie, l’enfasi e la concitazione che contrassegna-no spesso, e anche nel caso specifico, le parole e gli atti di Malpelo e, più in generale, l’atmosfera della novella e l’ethos dei personaggi. In certo qual modo tale svista trova delle ragioni: l’insegnamento rude-mente impartito da Malpelo a Ranocchio sembra avere carattere sen-tenzioso, e alle sentenze non si pone come sigillo un punto esclamati-vo. Dopo questa esclamazione sentenziosa Malpelo impartisce altri in-segnamenti a Ranocchio, riferiti per tre volte mediante discorso diretto chiuso da punto fermo. Senonché la correzione che l’autore, con sicu-ro senso della convenienza, questa volta non accoglie per RM4 era piuttosto un ordine, un comando, che non un’argomentazione senten-ziosa. Attraverso questo comando si apre un nuovo capoverso, il quale inizia dopo un capoverso che si chiude mediante parecchie esclama-zioni riconducibili a una medesima inserzione del discorso diretto. En-fasi, concitazione, brevi proposizioni e singole parole gridate connota-no efficacemente un ambiente che, come altra volta si è dimostrato, è “dantescamente infernale”. Le ragioni dell’arte sfuggono talora a letto-ri che ritengono d’essere provetti e fini intenditori, figuriamoci se non sfuggono al lettore “idealtipico”.
10) RM1 (n. 209, sa 3 ago), RM3 e RM4 (p. 236): «Alle volte la be-stia si piegava in due per le battiture, ma stremo di forze [RM4: “for-ze,”, R., r. 145] non poteva fare un passo, e cadeva sui ginocchi, e ce n’era uno il quale era caduto tante volte, che» (R., p. 58, rr. 144–147); RM2 (p. 13): «strema» (R., r. 145). Questo intervento è già stato da al-tri esaustivamente commentato18. Non occorrono pertanto che pochis-sime riflessioni brevi. L’autore non accoglie l’inopportuna correzione
17 Cfr. la nota 14. 18 Cfr. A. STUSSI, Lettura linguistica, cit., p. 585.
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle 144
di Verga2 perché essa attenua fortemente il tratto popolaresco del re-soconto del narratore senza renderlo più chiaro e anzi rendendolo de-cisamente più contorto. Tuttavia, l’attenzione dall’autore prestata, per via dell’imbarazzo manifestato dal lettore idealtipico, alla porzione di testo sopra riferita, si tradusse nell’aggiunta di una virgola superflua: superflua perché apposta (non a caso subito dopo un complemento di specificazione o di quantità direttamente dipendente da «stremo») all’interno di una proposizione breve e dal carattere compatto e unita-rio, la quale, come ognun vede, fa parte di un periodo segmentato e ricco di pause fin dalle prime stampe. Intento dell’autore, naturalmen-te, è di offrire, con quella virgola, un contributo alla chiarezza del con-testo, insomma di “venire incontro” alle esigenze del lettore medio un po’ in difficoltà.
11) RM1 (n. 209, sa 3 ago), RM2 (p. 14) e RM4 (p. 237): «piagnu-colava» (R., p. 59, r. 163); RM3: «piagnuccolava» (ibidem). S’è già osservato che l’ignoto correttore risolve l’oscillazione d’indole morfo-logico–ortografica presente in RM1 eliminando la forma con –c– dura doppia, linguisticamente scorretta e uniformando con –c– dura scem-pia. Verga in RM3 stabilisce a sua volta l’uniformità avvalendosi sol-tanto, per le ragioni già illustrate al punto 7), della forma con –cc– du-ra. In RM4, invece, l’autore si adegua all’esigenza di correttezza grafi-co–morfologica del lettore medio “idealtipico”.
12) RM1 (n. 209, sa 3 ago) e RM3: «perciò ei si pigliava sempre i castighi anche quando il colpevole non era stato lui; già se non era sta-to lui sarebbe stato capace di esserlo,» (R., pp. 59–60, rr. 176–178); RM2 (p. 15): «castighi,» (R., p. 60, r. 177) e RM4 (p. 238): «castighi, […] lui. Già» (R., r. 177). Secondo una sua attitudine sintattico–grammaticale in cui è già accaduto di imbattersi in queste pagine, Verga2 instaura mediante virgola una breve pausa, una lieve demarca-zione, tra la principale e la subordinata (è un tipico esempio della tipo-logia B). L’autore non solo accoglie questa correzione per RM4, ma rafforza la segmentazione del contesto separando mediante punto fer-mo due periodi separati in RM1 e in RM3 dal punto e virgola, ora av-vertito come segno d’interpunzione non “ortodosso” per il caso speci-fico. La modificazione, come sempre, mira ad accrescere la semplicità e la chiarezza del discorso, ma ciò facendo attenua fortemente il fasci-no della sintassi paratattica di RM3: una sintassi capace di affastellare
Capitolo I – Appunti sulle stampe di Rosso Malpelo 145
l’una dopo l’altra numerose coordinate o false coordinate, efficace-mente producendo l’impressione della mimesi del parlato e di un parlato popolaresco e preparando la coralità dell’erlebten Rede ma-gnifica dei Malavoglia.
13) Opposto appare il caso successivo, tanto da far dubitare che possa trattarsi di un refuso caduto in RM2. RM1 (n. 209, sa 3 ago) e RM3: «Adunque, la domenica, in cui tutti gli altri ragazzi del vici-nato si mettevano la camicia pulita per andare a messa o per ruzzare nel cortile, ei sembrava non avesse altro spasso che di andar ran-daggio [RM3: “randagio”, R., r. 194] per le vie degli orti, a dar la caccia [“caccia a sassate”: RM3, r. 195] alle povere lucertole, le quali non gli avevano fatto nulla, oppure a sforacchiare le siepi dei fichi d’India [“fichidindia”: RM3, r. 196].» (R., pp. 60–61, rr. 192–196); RM2 (p. 16): «nulla;» (R., r. 196); RM4 (p. 239): «Per questo, la domenica, […] randagio […], a dar la caccia alle lucertole e alle altre povere bestie che […] fichidindia.». Se non si tratta di refuso, bensì di correzione riconducibile alla tipologia C) (nel suo confine estremo, coincidente con il momento antitetico della categoria B)), trattasi di una svista non lieve. L’ignoto correttore introduce una sorta di scissione all’interno di un periodo lungo e compatto ma chiarissimo, arbitrariamente separando mediante punto e virgola due subordinate finali che dipendono dallo stesso verbo reggente. L’autore non accoglie questa modificazione per RM4, tuttavia è tratto, forse a causa di essa, come di consueto, a riesaminare accu-ratamente la porzione di testo su cui Verga2 è intervenuto. In linea con la tendenza all’attenuazione dei “toni” e dei “colori” troppo forti o troppo ripetitivi compiuta per RM4 l’autore mitiga lievemen-te l’aggressività insita nel comportamento di Malpelo togliendo l’espressione «a sassate» e aggiungendo l’altra «e alle altre povere bestie».
3. Ancora sulle tipologie di intervento dell’ignoto correttore. Se-condo quadro 14) L’intervento successivo di Verga2 pur essendo una corre-
zione inerente la punteggiatura non è riconducibile a nessuna
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle
146
delle tre principali tipologie determinate all’inizio circa le modifi-cazioni dei segni d’interpunzione. Eppure proprio questo episodio fornisce una testimonianza preziosa circa il fatto che Verga2 non è persona incolta e ch’egli talvolta (non sempre) legge con attenzione il tratto all’interno del quale si trova il punto che suscita in lui qualche perplessità, sebbene non giunga quasi mai a tener conto del testo (della sua strutturazione espressiva) nella sua totalità. Egli, qui e altrove, decide in favore della correzione non solo sulla scorta di extra–artistiche motivazioni linguistico–grammaticali o dell’esigenza di uniformare là dove lo scrittore è oscillante, ma an-che sulla scorta di ragioni stilistiche intratestuali, insomma di ra-gioni che gli sembrano scaturire dal vivo della compagine espressi-va e che, pur essendo ingenue e rudimentali, non sono spregevoli. Verga2, nella fattispecie, toglie una virgola (tipologia C)), colle-gando strettamente due complementi di luogo, come se il secondo fosse, eminentemente, una espansione e chiarificazione del primo. L’autore, giustamente, non accoglie né per RM3 né per RM4 questa piccola variazione d’indole stilistica. Il contesto allargato in cui es-sa cade, infatti, è composto da un lungo periodo a prevalente anda-mento paratattico, nel quale numerose proposizioni si susseguono in modo lentamente e armoniosamente ritmato; spesso la zona di confine tra l’una e l’altra proposizione è costituita da complementi demarcati e scanditi da brevi pause melodiose, cioè dalle virgole, e complementi e pause diventano particolarmente fitti nella chiusa del periodo. La correzione di Verga2 va in direzione e verso oppo-sti rispetto alla ricerca di musicale lentezza perseguita dall’autore e scalfisce, si direbbe, lo studiato parallelismo tra i tre principali tronchi del periodo. Vale la pena di riferire il tratto in questione:
Certamente egli avrebbe preferito di fare il manovale, come Ranocchio, e lavorare cantando sui ponti, in alto, in mezzo all’azzurro del cielo, col sole sulla schiena [RM4, p. 241: «schiena,», R., r. 216] o il carrettiere come quei [RM3: «carrettiere, come compare Gaspare» e RM4, p. 241: «carret-tiere, come compare Gaspare,», R., r. 16] che veniva a prendersi la rena della cava, dondolandosi sonnacchioso sulle stanghe, colla pipa in bocca, e andava tutto il giorno per le belle strade di campagna [RM4, p. 241: «cam-pagna;» e R., r. 218] o meglio ancora [RM4, p. 241: «ancora,», R., r. 219] il contadino [RM3, r. 219: «ancora avrebbe voluto fare il contadino»;
Capitolo I – Appunti sulle stampe di Rosso Malpelo 147
RM4, p. 241: «contadino,», R., r. 219] che passa la vita fra i campi, in mez-zo al verde, sotto i folti carrubbi, e il mare turchino là in fondo, e il canto degli uccelli sulla testa. (RM1, n. 210, do 4 ago; R., p. 62, rr. 214–221)19. In RM2 (p. 18) si legge «sui ponti in alto,» (R., r. 215). L’ignoto re-
visore eliminò la virgola perché gli parve: che il complemento «in al-to» fosse perfettamente simile e parallelo al complemento «in fondo»; che ciascuno dei due complementi svolgesse identica funzione rispetto al segmento che immediatamente lo precede («sui ponti» e «il mare turchino là»). In RM4 Verga accresce notevolmente il numero delle pause, rallentando ulteriormente il già lento fluire del discorso quale si presentava in RM1 e in RM3. Il punto e virgola collocato al posto della virgola a separare il terzo tronco del periodo tronco che acquista così maggiore autonomia sintattica dai primi due si spiega sicura-mente mercé la volontà dell’autore di semplificare il testo e conferirgli maggior chiarezza. Da non sottacere è il fatto che gli interventi com-piuti per RM4 istituiscono parallelismi perfetti tra i tre nuclei («mano-vale,», «carrettiere,», «contadino,»; «come Ranocchio,», «come com-pare Gaspare,» ancorché tra essi non sia da noverare quello malde-stramente ma non stupidamente istituito da Verga2.
15) RM1 (n. 210, do 4 ago), RM3 e RM4 (p. 242): «ei fu colto da tal tremito che dovettero tirarlo all’aria aperta colle funi,» (R., p. 63, rr. 238–239); RM2 (p. 19): «tremito,» (R., r. 238). Anticipando la tendenza che contrassegnerà la revisione attuata da Verga per l’edi-zione Treves 1897 di Vita dei campi, il “curatore” di RM2 ha per abi-tudine di segmentare il periodo separando mediante virgole le propo-sizioni che lo compongono (tipologia B)). L’autore, tuttavia, non ac-coglie questa correzione per RM4 sia perché non ravvisa, nella pro-pria scelta, infrazione di regole linguistico–sintattiche prescrittive, sia perché, nel contesto ritoccato da Verga2 v’è drammaticità e re-pentinità di sentimenti, di azione e di reazione: drammaticità e repen-tinità che la pausa, cioè la virgola, attenuerebbe arbitrariamente.
19 Erroneamente trattasi di refuso banale la didascalia che precede l’inizio della ter-
za puntata di Rosso Malpelo sul fascicolo di domenica 4 agosto del «Fanfulla» recita: «(Con-tin. vedi N. 208)», identicamente alla didascalia che precede l’inizio della puntata pubblicata il giorno precedente, laddove, sulla didascalia della puntata di domenica dovrebbe invece leg-gersi: «(Contin. vedi N. 209)».
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle 148
16) RM1 (n. 210, do 4 ago), RM3 e RM4 (p. 243): «e qualche ope-raio, nuovo del mestiere, [RM4: «al mestiere,» R., p. 63, rr 242–243] osservava curiosamente come fosse capricciosa la rena, che» (R., p. 63, r. 243); RM2 (p. 20): «operaio nuovo del mestiere osservava» (R., p. 63, rr. 242–243). L’intervento rifiutato dall’autore per RM4 trova motivazione, ancora una volta, nella radicata propensione dell’ignoto correttore a usare la punteggiatura per creare gerarchie lo-gico–semantico–grammaticali precise: due membri di una proposizio-ne che si integrino e si completino tra loro l’uno dei quali sia cioè espansione chiarificatrice dell’altro devono presentarsi visivamente più uniti e compatti che non membri della stessa proposizione i quali non siano congiunti da legame semantico altrettanto stretto e necessa-rio. Cfr. le situazioni esaminate ai punti 3) e 14).
17) RM1 (n. 210, do 4 ago) e RM3: «Lo zio Mommu osservò che avea [RM3: “aveva”, R., r. 252] dovuto stentar molto a morire, per-chè […] il pilastro […] l’aveva seppellito» (R., p. 64, r. 252–253); RM2 (p. 20): «stentare» (R., r. 252); RM4 (p. 243): «penar molto a finire, […] sepolto» (R., rr. 252–53). A Verga2 la caduta della –e fi-nale del verbo all’infinito sembrava probabilmente un refuso, e la correzione era volta a uniformare, donando allo “stravagante” «sten-tar» la stessa forma degli altri verbi all’infinito del capoverso inte-ressato, tutti provvisti di –e finale. Sfuggono a Verga2 le ragioni pro-fonde dell’autore, il quale aveva ad arte soppresso la –e finale del verbo nell’ambito della ricerca, perseguita già a partire dalla versio-ne manoscritta della novella, di un assetto fonetico–sonoro morbido e dolce per il periodo in cui ricorre, in discorso indiretto, l’osserva-zione sopra riferita del minatore; osservazione che chiarisce in realtà quanto atroce fu l’agonia e la morte di mastro Misciu. Da codesta scissione (e da non poche altre, su cui mi sono diffusamente soffer-mata in altra sede) tra livello fonetico–sonoro (inerente i puri signifi-canti) e livello del significato letterale si sprigionano effetti somma-mente ambigui e inquietanti. Attraverso tali scissioni e i loro effetti viene dato in questa fattispecie sinistro risalto, anzitutto, al larvato sadismo dei «compagni» di Misciu. Inoltre, più in generale, il “di-sordine” e il capovolgimento dei valori fono–stilistici normali, i qua-li avrebbero dovuto essere, a rigore, aspri e cupi, enfatizza per antite-si il “disordine” e il capovolgimento, nella cava, dei valori e della
Capitolo I – Appunti sulle stampe di Rosso Malpelo 149
prassi che dovrebbero costituire la normale, desiderabile serenità del-la vita.
La più interessante e probante, tra le varianti d’autore che palesano codeste intenzioni di Verga e codesto suo impegno espressivo, consi-ste nella sostituzione della locuzione «Lo sciancato», presente nella versione definitiva dell’autografo consegnato per la stampa di RM1 (ms, f. 16, r. 21; RMA, p. 64, r. 252), con l’altra, dalla diversissima so-stanza fonica: «Lo zio Mommu». Verga effettuò con ogni probabilità tale sostituzione sulle bozze di RM1. Peraltro, come sempre accade durante la revisione che sfocia in RM4, l’intervento dell’ignoto corret-tore attirò forse l’attenzione dell’autore, il quale decise di rendere quanto più insistita ed evidente fosse possibile la ricerca di eufonia ambigua e conturbante che al lettore “idealtipico” era completamente sfuggita. Si ha così, in RM4, la sostituzione di «penar» a «stentar», di «finire» a «morire» e di «sepolto» a «seppellito».
18) RM1 (n. 210, do 4 ago), RM3 e RM4 (p. 244): «“[…] ei sca-vava di qua, mentre suo figlio scavava di là.”» (R., p. 64, rr. 256–257); RM2 (p. 21): «qua mentre» (R., r. 257). Non è agevole comprendere la ragione di questo intervento. Qui il revisore sopprime una virgola, cioè una lieve pausa preposta a separare una proposizione principale dalla sua (unica) subordinata, che è una temporale. Nel periodo in discorso indiretto immediatamente seguente quello in discorso diretto che si sta per ora considerando, Verga2 mantiene senza difficoltà (cfr. capoverso 19) la virgola che separa, in RM1, la principale dalla sua unica subor-dinata (RM1 e RM2: «Però non dissero nulla al ragazzo, per la ragione che lo sapevano maligno e vendicativo.»). È dunque da escludere che l’ignoto correttore stia cercando, quasi contro il proprio gusto persona-le, di uniformare la punteggiatura ai criteri ch’egli ha giudicato preva-lenti in RM1. Sembra di contro assai più probabile che la modificazio-ne sia stata dettata dalla mentalità e dal gusto corrispettivi alla tipolo-gia C) (cfr. p. e. il punto 16). L’intervento che non viene accolto dall’autore per RM4 trova cioè motivazione nella radicata propen-sione dell’ignoto correttore a usare la punteggiatura per creare precise gerarchie logico–semantico–grammaticali: due proposizioni che si in-tegrino tra loro e si completino intimamente costituendo una sorta di organica unità semantica devono presentarsi visivamente più u-nite e compatte che non membri o proposizioni appartenenti alla stessa
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle 150
frase, tra i quali non esista legame semantico altrettanto stretto e ne-cessario.
19) 1b) RM1 (n. 210, do 4 ago), RM2 (p. 21) e RM4 (p. 244): «Però non dissero nulla al ragazzo, per la ragione che lo sapevano maligno e vendicativo.» (R., p. 64, rr. 257–258); RM3: «ragazzo per la» (R., rr. 257–258).
2b) RM1 (n. 210, do 4 ago) e «Il carrettiere sbarazzò il sotterraneo dal cadavere […], chè stavolta oltre al lezzo del carcame, c’era che il carcame era di carne battezzata, [RM3: “battezzata;”, R., r. 261]» (R., p. 64, rr. 260–261); RM2 (p. 21) «chè stavolta, oltre al» (R., r. 260); RM4 (p. 244): «chè stavolta, oltre […] carcame, trattavasi di un com-pagno, e di carne battezzata.» (R., rr. 260–261).
3b) RM1 (n. 210, do 4 ago), RM3 e RM4 (p. 244): «e la vedova [“La vedova”: RM4, r. 261] rimpiccolì i calzoni e la camicia, e li adat-tò a Malpelo, il quale» (R., p. 64, rr. 261–262); RM2 (p. 21): «camicia e» (R., r. 262).
4b) RM1 (n. 209, sa 4 ago) e RM3: «stava a contemplarsele coi gomiti sui ginocchi, e il mento nelle palme per delle ore intere,» (R., p. 65, rr. 271–272); RM2 (p. 22): «ginocchi e» (R., r. 272); RM4 (p. 247): «a guardarle, […] palme, […]» (R., rr. 271–272).
Sull’asse, se è lecito chiamarlo così, RM2 RM4, a differenza che sull’asse RM1 RM3, il discorso limitatamente ai punti 1b) e 2b)
viene rallentato e intervallato da brevi pause frequenti. La soppres-sione, in RM3, al punto 1b), della virgola esistente in RM1 (e ripristi-nata in RM4), se non è un refuso, si deve probabilmente al fatto che essendo il periodo formato da due sole concise proposizioni l’autore giudicò stilisticamente inopportuno disgiungerle visivamente e rallentare il ritmo della frase, ben demarcata da punto fermo a en-trambi i suoi confini, iniziale e finale. Al punto 2b) l’autore, sebbene non accolga per RM3 la virgola inserita dal revisore in RM2 (tipologia B)) virgola che sarà accolta invece per RM4 , presta in qualche modo attenzione al disagio manifestato dal lettore “idealtipico”. Il pe-riodo, dal prevalente andamento paratattico, e composto da undici proposizioni, tra principali, subordinate e coordinate, fa lievi pause in RM1 grazie a sei virgole. Una di queste (dopo «battezzata») viene soppressa in RM3 e sostituita da punto e virgola. Il periodo non viene in tal modo propriamente scisso, ma subisce certo una segmentazione
Capitolo I – Appunti sulle stampe di Rosso Malpelo
151
che lo divide visivamente nei suoi due tronchi principali, rendendone più agevole la comprensione per i lettori non bene attrezzati. La scis-sione viene poi effettuata mediante inserzione del punto fermo in luogo del punto e virgola in RM4, nell’ambito di quella revisione che si vuole quanto più possibile chiarificatrice. Così, i due tronchi di-ventano due periodi l’uno dall’altro indipendenti.
Gli interventi 3b) e 4b) costituiscono casi esemplari della tipologia A) e hanno in certo qual modo direzione e verso opposti rispetto a quelli effettuati dall’ignoto correttore ai precedenti punti 1b) e 2b), e dall’autore, per RM4, anche ai punti 2b) e 3b). Le regole grammaticali da lui assorbite e fatte alquanto dogmaticamente proprie impediscono a Verga2 di accettare che una virgola preceda la congiunzione “e”. Così egli elimina le due virgole, con la convinzione, forse, di correg-gere due refusi veri e propri.
20) RM1 (n. 210, do 4 ago) e RM3: «rimugginando» (R., p. 65, r. 272); RM2 (p. 22) e RM4 (p. 247): «rimuginando». Si sarebbe tentati di pensare che, imbattendosi in parole dalla veste ortografica dubbia, e di primo acchito scorretta, Verga2 consulti il vocabolario e poi inter-venga imponendo la sola o la prevalente veste tosco/italiana della pa-rola. L’autore aveva scientemente, in RM1, e poi in RM3, sacrificato l’ortodossia grafica, raddoppiando in –gg– per evitare che il contesto venisse troppo addolcito, nel suo livello fonetico–sonoro, da una paro-la morbida come «rimuginando». Compiendo la revisione per RM4, Verga si sottomette agli scrupoli, anzi alla condanna, decretata dal let-tore “idealtipico” e ripristina la prevalente forma tosco/italiana ante-cedentemente rifiutata.
21) RM1 (n. 210, do 4 ago), RM3 e RM4 (p. 247): «e quando gli aveano chiesto di venderli [RM3 e RM4: “se voleva venderli”, R., r. 275], e di pagarglieli [RM3 e RM4: “che glieli avrebbero pagati”, R., rr. 276–277] come nuovi, ei avea risposto no. Che suo padre [RM3: “nuovi, egli aveva risposto di no; suo padre”, R., rr. 277–278; RM4: “egli aveva risposto di no. Suo padre”, R., rr. 277–278] li ha fatti [RM3: “ha resi”, R., r. 278; RM4: “li aveva resi”, rr. 277–278] così li-sci e lucenti nel manico colle sue mani, ed ei non avrebbe potuto far-sene degli altri più lisci e lucenti di quelli,» (R., pp. 65–66, rr. 276–279). RM2 (p. 22): «avean chiesto di venderli e di […]. Chè suo padre li avea fatti […] mani, ch’ei» (ivi, rr. 276–278). Questa porzione di te-
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle
152
sto, in cui sono implicate tante varianti d’autore e diverse correzioni apportate dall’ignoto revisore è stata già attentamente e persuasiva-mente passata al vaglio da altri per quanto riguarda le varianti d’autore20. Mi restringerò quindi all’esame dei rapporti tra RM2 e le stampe di Rosso Malpelo autorizzate e corrette da Verga. RM2 diverge da RM1 in ciò: 1) soppressione della vocale finale di «aveano»; 2) e-liminazione della virgola dopo «venderli». 3) abolizione del «Che» con valore di congiunzione e sua sostituzione con un «chè» avente va-lore di “perché”; 4) abolizione coerentemente con l’intervento di cui al punto precedente — del passato prossimo «li ha fatti» e sua sostituzione con il trapassato prossimo; 5) sostituzione del coordinante «ed ei» con un subordinante «ch’ei» dal valore consecutivo.
Difficile comprendere le ragioni del primo intervento. Non pare tut-tavia illecito supporre che l’ignoto correttore, presa familiarità con il testo, avvertisse confusamente l’importanza del livello, o dei livelli, fonetico–sonori di esso e anche dei bruschi trapassi da zone a forte du-rezza e stridore fonici a zone intrise di musicalità dolorosa. Se così fosse, egli potrebbe avere eliminato la vocale finale di «avean» in sintonia con analoghe soppressioni effettuate dall’autore in zone di-verse del testo perché l’eccesso di vocali non gli pareva adeguato a un tratto “contenutisticamente” pateticissimo e fonicamente dolce e melodioso quale è quello sopra riferito. Il trapasso da un tono all’altro, sicuramente ricercato dall’autore, assume però così un carattere ecces-sivamente repentino e lezioso che l’autore avrebbe voluto evitare; la frase precedente quelle sopra riferite, infatti, è qualificata da una rela-tivamente alta densità di suoni duri e sgraziati: «strane», «siccome», «piccone», «zappa», «quantunque», «troppo». Verga non accoglie la correzione dell’ignoto revisore né per RM3 né per RM4. Non gli sfugge però che il lettore medio “idealtipico” manifesta disagio al cospetto di gruppi fonetico–sonori eccessivamente ricchi di vocali. Così, sia in RM3 che in RM4 «l’ei avea» di RM1 e di RM2 diventa «egli aveva».
20 Cfr. STUSSI, Lettura linguistica, cit., pp. 585–587. Per una forma di cortesia nei con-
fronti di Carla Riccardi, Stussi non segnala che nella fascia di apparato genetica dell’edizione critica di Vita dei campi RM1 e RM2 sono erroneamente agguagliati così: «no. Che» (R., r. 277). Chi scrive è cosciente dell’immane lavoro cui si è sobbarcata la curatrice della detta e-dizione e dell’attenzione scrupolosissima con cui lo ha svolto e condotto a termine.
Capitolo I – Appunti sulle stampe di Rosso Malpelo 153
L’eliminazione, in RM2, della virgola dopo «venderli» si spiega, ovviamente, con la riottosità di Verga2 ad ammettere che la congiun-zione “e” possa esser preceduta da virgola. Neppure questa modifica-zione viene accolta, né per RM3 né per RM4, e tuttavia essa sembra favorire un ripensamento dell’autore; ripensamento che, sia in RM3 sia in RM4, si traduce in una riscrittura amplificante, il che è in con-trasto con l’abituale tendenza verghiana a correggere scarnificando. La virgola viene mantenuta, però la congiunzione «e» viene abolita in fa-vore di un «che» coordinante. L’autore non accoglie, invece, la corre-zione ed ei ch’ei, poiché la formula originaria, sempre mantenuta, ha ormai in RM4 un valore coordinante ben chiaro, perfettamente ade-guato al contesto allargato, e intriso di una efficace patina popolaresca che verrebbe a mancare trasformando la coordinata in una sintattica-mente più elegante consecutiva.
In RM1 il «Che» introduce una porzione di discorso diretto mime-tizzata, o di discorso semi–diretto, come se il narratore avesse delle difficoltà a coordinare il proprio discorso indiretto con il residuo di di-scorso pensato o pronunziato da Malpelo: quasi, cioè, al discorso indi-retto del narratore si venisse ad appoggiare un residuo del discorso di-retto di Malpelo non ancora del tutto trasferito dal narratore in discor-so indiretto puro. In RM2, il residuo di discorso diretto viene senz’altro trasformato in discorso puramente indiretto, la prima propo-sizione del quale è una subordinata causale dipendente da «avea rispo-sto». Le correzioni che trasformano il residuo di discorso diretto pre-sente in RM1 nel discorso puramente indiretto di RM2 sono ovviamen-te banalizzazioni, «lectiones faciliores», com’è stato giustamente af-fermato da Stussi.
L’ultima variazione («ch’ei» in luogo di «ed ei») lascia fortunata-mente indifferente Verga. Tutt’altro atteggiamento egli manifesta in-vece nel percepire la forte difficoltà, anzi l’incapacità, del lettore “ide-altipico” vuoi di comprendere il brusco trapasso dal discorso indiretto al residuo di discorso diretto (il trapasso marcato dal punto fermo do-po il quale comincia, mediante «Che» iniziale, un nuovo periodo); vuoi di accettare come stilisticamente valide per un testo artistico delle deviazioni tanto forti dalle norme grammaticali. In RM3 Verga cerca di attenuare soprattutto il “disagio grammaticale” dei suoi lettori, so-stituendo il punto fermo con un punto e virgola e abolendo il «Che».
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle
154
Con ciò non si giunge all’ortodossia grammaticale, ma si perviene a una formulazione più agile e snella, ove la sola “sgrammaticatura” forte risiede nel passato prossimo, che contrassegna lo scarto dal pre-cedente discorso puramente indiretto, in cui è usato esclusivamente il trapassato prossimo. Nell’edizione del 1897 Verga cede alle richieste basilari del suo lettore “idealtipico”, naturalmente al fine di ridurre al minimo le difficoltà di comprensione del testo. L’autore ripristina il punto fermo in luogo del punto e virgola, pone il soggetto «Suo pa-dre» all’inizio del secondo periodo, e adotta per questa frase un ine-quivocabile discorso puramente indiretto (tutto del narratore) median-te sostituzione del trapassato al passato prossimo.
Concludendo, è doveroso osservare cautamente che l’autore, in RM3 e in RM4, assume talvolta iniziative correttorie decisamente in controtendenza rispetto a quelle sopra enucleate e commentate. Egli, forse, percepisce vagamente che le modificazioni apportate dall’ignoto revisore si armonizzano bene con l’organamento sintattico complessi-vo della novella e con la mimesi della lingua parlata in essa operante. Vi sono infatti zone di RM3 e di RM4, più o meno lontane dal luogo riferito all’inizio del presente paragrafo, ove par che tale percezione produca effetti addirittura copiosi. Si ponga di nuovo mente, anzitutto, all’esempio 2b) del paragrafo 19, limitatamente a RM1 e a RM3: «Il carrettiere sbarazzò il sotterraneo dal cadavere […], chè stavolta oltre al lezzo del carcame, c’era che il carcame era di carne battezzata, [RM3: “battezzata;”]». Si considerino poi altri esempi caratteristici: a) RM1 (n. 208, ve 2 ago) e RM3: «Era sempre cencioso e lordo […], chè la sua sorella era [RM3: “s’era fatta”] sposa,» (R., p. 50, r. 22); b) RM1 (n. 209, sa 3 ago) e RM3: «la sorella afferrava il manico della scopa […], che [RM3: «chè»] avrebbe fatto scappare il suo damo» (R., p. 60, rr. 188–189)21; c) RM1 e RM3: «dichiarò che […] si contentava di sta-re in galera tutta la vita, e che [RM3: «vita, chè la»] la prigione, in confronto, era un paradiso» (n. 4, lu, 5 ago). In RM1 Verga2 trovava
21 Il microfilm del fascicolo del «Fanfulla» da me esaminato presso la Biblioteca Nazio-
nale Centrale di Roma non è in buone condizioni perché ingiallite e macchiate dal tempo sono le pagine del quotidiano (né sono o erano in buone condizioni, purtroppo, gli apparecchi che consentono di leggere i microfilms), tuttavia mi par proprio che sia da leggere (d’intesa con Luperini) «che avrebbe fatto scappare». Secondo Riccardi, invece, sia in RM1 che in RM3 sa-rebbe da leggere «chè».
Capitolo I – Appunti sulle stampe di Rosso Malpelo
155
sia il «chè» polivalente con prevalente valore di “perché” da lui ri-preso e collocato all’inizio del periodo ove si trova un residuo di di-scorso diretto di Malpelo («Chè suo padre li avea fatti») sia il «che» polivalente con prevalente valore di congiunzione dichiarativa ma non privo di sfumature d’altro genere (causali, in particolare). Questo secondo «che» fornisce lo spunto per l’altra sensibile variazio-ne inserita in RM2: «li avea fatti così lisci […] mani, ch’ei non avreb-be potuto». L’aspetto più interessante di tutta la questione consiste nel fatto che l’autore è colpito dalla capacità, mostrata dal «chè» poliva-lente (e, in minor misura, anche da quella del «che», esso pure, par-zialmente, versione italianizzata del «ca»), di farsi comprendere e ap-prezzare da un gusto ricettivo e da un tipo di sensibilità culturale i quali poco o nulla hanno in comune sia con il pubblico italiano più colto sia con l’idioma siciliano municipale. Il «chè», pur riproducendo il “ca” siciliano, e pur essendo impiegato in costrutti sintattici non ve-ramente italiani, possiede vitalità intensa ed estesa tanto che perfino il medio–basso lettore idealtipico riesce ad appropriarsene per usarlo al-lo scopo di mimare pedissequamente le movenze del parlato. Così, fin da RM3, due occorrenze di «che», quelle di cui s’è or ora toccato al punto b) e al punto c) vengono trasformate in «chè». Esse non solo vengono mantenute in RM4, ma almeno un’altra, inesistente in RM1 e in RM3, viene aggiunta nell’edizione di lusso: RM1 (n. 11, lu 5 ago) e RM3: «D’ora in poi, se lo battevano, a loro non importava più nulla, e a lui nemmeno, e quando sarebbe divenuto come il grigio [RM3: “gri-gio”, R., r. 402]» (R., pp. 72–73, rr. 401–402); RM4 (p. 258): «a loro non importava più nulla, e a lui nemmeno, chè quando sarebbe dive-nuto» (R., rr. 401–402).
4. Interventi del correttore ignoto e reazioni dell’autore. Terzo quadro 22) 1c) RM1 (n. 210, do 4 ago) e RM3: «bisogna avvezzarsi a vedere
in faccia ogni cosa bella o brutta;» (R., p. 66, rr. 286–287); RM2 (p. 23) e RM4 (p. 248): «a vedere in faccia ogni cosa, bella» (R., rr. 286–287).
2 c) RM1 (n. 210, do 4 ago) e RM3: «Adesso non soffriva più, l’asino grigio, e se ne stava tranquillo» (R., p. 66, rr. 293–294); RM2
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle 156
(p. 23): «più l’asino» (R., r. 293); RM4 (p. 248): «Adesso non soffre più. L’asino grigio se ne stava tranquillo,» (R., rr. 293–294).
In 1c) l’aggiunta di una virgola (tipologia B)) stacca leggermente la coppia di aggettivi «bella o brutta» dal nome cui si riferivano, donando ineccepibile risalto stilistico–linguistico all’unità organica della coppia, coincidente con una forte antitesi: un risalto tuttavia superfluo, data la banalità degli aggettivi, il quale rallenta un poco l’andamento voluta-mente rapido del periodo implicato nella predetta correzione e di quello successivo. L’autore raccoglie il suggerimento per RM4, nella cui strut-turazione ha gran parte il rallentamento ritmico–stilistico di tutto il di-scorso costitutivo della novella. Al punto 2c), invece, si manifesta la consueta propensione dell’ignoto revisore a usare la punteggiatura per creare precise gerarchie logico–semantico–grammaticali (tipologia C)): due membri di una proposizione che si integrino e si completino inti-mamente tra loro devono presentarsi visivamente più uniti e tra loro coesi che non membri della stessa proposizione i quali non siano con-giunti da legame altrettanto stretto e necessario. Nella fattispecie, l’anastrofe (collocazione del soggetto alla fine della proposizione principale, e conferimento a esso di risalto mercé la sua inserzione tra due virgole) viene mantenuta, ma il soggetto viene organicamente riunito alla proposizione cui appartiene mediante la soppressione della virgola che in RM1 lo precede. In RM4 Verga, come spesso gli accade, esagera nel correggere banalizzando, al fine di rendere più perspicuo il contesto. La constatazione che l’asino ha finito di soffrire viene trasposta nel di-scorso diretto con cui Malpelo ammaestra Ranocchio, mentre in RM1 e in RM3, assai più efficacemente e delicatamente, faceva parte del discorso indiretto in cui vengono riferiti i più intimi pensieri di Malpelo, o da Malpelo stesso o dal narratore, qui in simbiosi con Malpelo. L’anastrofe viene abolita; viene ripristinato l’ordine logico–grammaticale proprio della lingua, scevra di letterarietà, usata nella comunicazione e informa-zione ordinaria; alla fine della proposizione principale, che inizia con il soggetto «L’asino» e che apre il periodo, viene collocata una virgola, nel quadro, abituale, della maggiore segmentazione corrispettiva, in RM4 al ricercato rallentamento ritmico del discorso (si noti anche l’inserzione di un’altra virgola dopo «tranquillo»).
23) Superfluo sarebbe indugiare sulla modificazione successiva ap-portata da Verga2; basti prenderne nota. RM1 (n. 210, do 4 ago), RM3
Capitolo I – Appunti sulle stampe di Rosso Malpelo 157
e RM4 (p. 248): «e se ne stava tranquillo colle quattro zampe distese,» (R., p. 66, rr. 293–294); RM2 (p. 23): «con le» (R., r. 294). Difficile capire perché all’ignoto correttore la preposizione articolata con ag-glutinazione desse fastidio. Certo è che l’intervento tende ad affievoli-re le forse casuali allitterazioni (co–, –qua) e soprattutto a eliminare i sicuramente studiati omoteleuti (–llo, –lle) che traducevano, specie gli ultimi, in sostanza fonetico–sonora l’approdo dell’asino nel nulla (cor-sivo mio), ove si trova la pace.
24) 1d) RM1 (n. 211, lu 5 ago) e RM3: «ripeteva che al di sotto era tutta scavata dalle gallerie, per ogni dove, verso il monte e verso la valle;» (R., p. 68, rr. 309–310); RM2 (p. 24): «gallerie per» (R., r. 309); RM4 (p. 249): «ripeteva che la terra lì sotto era tutta vuota dalle gallerie, per» (R., r. 309).
2d) RM1 (n. 211, lu 5 ago) e RM3: «la campagna circostante era nera anch’essa, come la sciara; e [RM3: “sciara, ma”, R., rr. 318–319] Malpelo» (R., p. 68, rr. 318–319); RM2 (p. 25): «essa come» (R., r. 318); RM4 (p. 250): «nera anch’essa, come la lava, ma Malpelo» (R., rr. 318–319).
Le due modificazioni presenti in RM2 sono riconducibili alla tipo-logia C) e sono molto simili a quella rappresentata al punto 14). Se-condo l’ignoto correttore il complemento di luogo «per ogni dove», al punto 1d), è un’espansione semantico–grammaticale chiarificatrice del precedente segmento «era tutta scavata dalle gallerie», e il comple-mento di paragone «come la sciara» è intimamente collegato al predi-cato nominale «nera». Viene pertanto eliminata in RM2, al punto 1d), la virgola che staccava lievemente «per ogni dove» dal segmento pre-cedente. L’autore non accoglie questa modificazione per RM4, tuttavia è tratto a riesaminare la porzione di testo su cui il revisore è intervenu-to. Verga modifica così abbastanza profondamente il segmento che precedeva il complemento di luogo e che era in effetti linguisticamen-te scorretto (le gallerie vengono scavate, non compiono esse l’azione di scavare) sebbene fosse pittoresco e adeguato al livello di un uso par-lato vicino al tono popolare. La soluzione di RM4, meno poetica, è però linguisticamente ineccepibile. Quanto al punto 2d), la situazione appare analoga. L’autore non accoglie la soppressione della virgola per RM4, però è tratto a riesaminare la porzione di testo in oggetto e a darle veste linguistica più “italiana” («lava» in sostituzione di «sciara»).
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle
158
25) RM1 (n. 211, lu 5 ago), RM3 e RM4 (p. 250): «le stelle splen-devano lucenti anche sulla sciara [“sciara”: RM4, r. 318], e la campa-gna circostante era nera» (R., p. 68, rr. 317–318); RM2 (p. 25): «sciara e» (R., p. 68, r. 318)22. La correzione di Verga2, che cade all’interno di un rigo intermedio tra le due porzioni di testo or ora esaminate, appar-tiene alla tipologia A), consiste cioè nell’eliminazione della virgola dopo la quale si trovi la congiunzione “e”.
26) RM1 (n. 211, lu 5 ago), RM3 e RM4 (p. 250): «col viso verso il cielo» (R., p. 68, r. 320); RM2 (p. 25): «verso al cielo» (R., r. 320). Dubbi linguistici, ortografici e grammaticali tormentarono, come sap-piamo, l’autore, durante la revisione del testo per RM4. Questa volta egli nonostante lo animassero scrupoli linguistico–grammaticali non dissimili da quelli di Verga2 non accolse tuttavia in RM4 la va-riazione riferita sopra. Egli era ben certo di essere nel fatto suo: cer-tezza acquisita, molto probabilmente, con l’aiuto di vocabolari e di grammatiche.
27) RM1 (n. 211, lu 5 ago): «Anche la civetta sente i morti che son qua giù,» (R., p. 68, rr. 325–326); RM2 (p. 25): «son quaggiù,» (R., r. 326). L’autore, nel caso in questione, condivise l’insoddisfazione di Verga2, ma trovò una soluzione del dilemma assai più poetica sia ri-spetto alla versione di RM1 che all’“aggiustamento” di RM2. Egli in-trodusse in RM3 e in RM4 (p. 251) una bella variante lessicale: «son qua sotterra [RM4: “sotterra,”]» (R., r. 326).
28) RM1 (n. 211, lu 5 ago) e RM3: «ma il Rosso lo sgridava perchè chi è costretto a star solo non deve aver paura di nulla,» (R., pp. 68–69, rr. 327–328); RM2 (p. 25): «sgridava, […] solo,» (R., p. 69, rr.
22 Il luogo preceduto dalla sigla 2d), riferito al paragrafo n. 24 e quello riferito in questo
paragrafo n. 25 appartengono al tratto più difficile e controverso della novella. Il significato dell’intero passo è ancora frainteso da studiosi benemeriti e qualificatissimi di Verga come R. LUPERINI, alle pp. 548–549 della sua Lettura storico-sociologica, nel volume monografico di «Italianistica» citato alla nota 2 e M. PICONE, nella sua Lettura simbolica pubblicata sul me-desimo volume di «Italianistica», p. 561. Ho già chiarito diffusamente il senso di questo luogo finora sempre frainteso nel secondo capitolo della Parte terza del mio già citato (cfr. la nota 4) volume Dai suoni al simbolo, di cui cfr. soprattutto le pp. 251 sgg.; poiché però Luperini in tempi di poco successivi alla pubblicazione del suo articolo su «Italianistica», ha ritenuto di dovere oppugnare in modo reciso la mia interpretazione, ritornerò su di essa, e sul passo contro-verso, fornendo prove ulteriori, decisive, dirimenti, della impossibilità che il passo controverso venga interpretato diversamente da come io lo interpreto. Cfr. la mia postilla, collocata dopo il capitolo 2 di questa Parte seconda, e intitolata: Notti estive e firmamento in Rosso Malpelo.
Capitolo I – Appunti sulle stampe di Rosso Malpelo 159
327–328); RM4 (p. 251): «sgridava,» (R., pp. 68–69, rr. 327–328). Le due modificazioni dell’interpunzione di RM1 apportate in RM2 appar-tengono alla tipologia B). Correttamente, in RM4 Verga accoglie solo la prima delle due virgole segmentanti, perché la seconda, curiosa-mente apposta dallo sconosciuto revisore in macroscopica contraddi-zione con i suoi radicati principi corrispondenti alla tipologia D), scinde due proposizioni subordinate che hanno sì diverso valore sin-tattico (la causale «non deve aver» e la sua soggettiva–relativa «chi è costretto a star solo») e tuttavia costituiscono una unità ben definita e compatta, quasi una monade logico–semantica.
29) 1e) RM1 (n. 211, lu 5 ago), RM3 e RM4 (p. 251): «avvezzo a lavorar sui» (R., p. 69, r. 331); RM2 (p. 26): «lavorare sui».
2e) RM1 (n. 211, lu 5 ago), RM3 e RM4 (p. 251): «ti tocca a viver sotterra,» (R., p. 69, r. 332); RM2 (p. 26): «ti tocca vivere sotterra,». La sostituzione di «tocca a» con «tocca» è una correzione scolastica-mente grammaticale, che annulla un costrutto al contempo ricercato e vicino all’uso parlato: situazione carissima a Verga, il quale non tiene di nessun conto, infatti, la variazione. L’aggiunta della vocale finale al verbo, poi, è tendenza non infrequente ma neppure abituale di Verga2. Nella frase riferita estesamente sopra al paragrafo 28), precedente e contigua a quella interessata dalle correzioni 1e) e 2e), per esempio, l’ignoto revisore non completa mediante l’aggiunta della vocale finale le due forme «star solo» e «aver paura». Egli si astiene da tale inter-vento anche nel caso della forma «aver paura» (RM1, n. 211, lu 5 ago; RM2, p. 26; RM4, p. 251; RM3 e R., p. 69, r. 333), appartenente alla proposizione principale del periodo che subisce le inspiegabili corre-zioni, e se ne astiene altresì, pochi righi sotto, nelle parole da Malpelo rivolte a Ranocchio: «tu dovresti portar la gonnella» (RM1, n. 211, lu 5 ago; RM2, p. 26; RM4, p. 252; RM3 e R., p. 69, r. 342). La situazio-ne di cui ai punti 1e) e 2e) è dunque per un verso inspiegabile, quasi un ghiribizzo, un capriccio del revisore. Per altro verso, la sua deci-sione di ritoccare tradisce in questo caso non solo scarsa sensibilità poetico–letteraria e imperizia stilistica, ma anche e soprattutto incuria e distrazione nella lettura del testo da comporre. Perfino un tipografo giovane, inesperto e relativamente ignorante, avrebbe facilmente nota-to che sia il capoverso su cui cadono i ritocchi sia i capoversi a esso immediatamente precedenti e immediatamente successivi sono fitta-
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle 160
mente contesti di forme verbali prive di vocale finale. È fin troppo e-vidente che queste forme rispecchiano la ben meditata intenzione gra-fica dell’autore, anche quando non se ne comprenda la ragione forma-le–espressiva. Verga mirava a creare, subito all’inizio del più impor-tante tra i dialoghi di Malpelo con Ranocchio, un’atmosfera fonetico–sonora frammista di suoni duri e aspri («strideva», «civette», «pipi-strelli», «sgridava», «costretto», «tetti», «gatti», «tocca», «grattava») e di suoni dolci («son», «solo», «nulla», «nemmeno», «aveva», «lavo-rar», «diceva», «viver», «aver», «ali» che sfocia, verso la fine di que-sto affettuoso colloquio notturno tra i due, nonostante il cupo pessimi-smo del Rosso, in una sensibile diminuzione dei suoni sgraziati e, prima ancora, nelle parole di Ranocchio, in un deciso prevalere delle parole dolci e melodiose («spiegargli», «stelle», «lassù», «alto», «pa-radiso», «buoni», «domandava», «mamma», «allora», «sorridendo»).
È sicuramente molto probabile che il testo di RM1 e le bozze di RM2 siano stati riveduti e corretti da una sola persona, ma non è im-possibile che i revisori siano stati più di uno e che avessero diversa preparazione culturale.
30) RM1 (n. 211, lu 5 ago): «a lavorar sui tetti, come i gatti gli diceva, e allora era» (R., p. 69, r. 331); RM2 (p. 26) e RM3: «tetti […] diceva»; RM4 (p. 251): «gatti, gli diceva,». Verga2 elimina la prima virgola in ossequio alla tipologia D) della sua grammatichetta: cfr. il caso, assai simile perché riguarda un complemento di paragone, esaminato al punto 2d) del paragrafo 24); ed elimina la seconda virgo-la in ossequio alla tipologia A), cioè per l’incompatibilità della virgola con la successiva preposizione “e”. Impossibile stabilire con sicurezza se l’autore arrivi per suo conto (ma non sembra questa l’ipotesi più probabile) a compiere le due identiche modificazioni per RM3, o se, invece, raccolga i suggerimenti di RM2. L’esigenza di creare, per RM4, un rallentamento ritmato soprattutto da numerose pause lievi (e più raramente dalla scissione di periodi molto lunghi, mediante inser-zione di punto e virgola o di punto fermo in luogo di preesistenti vir-gole) induce curiosamente l’autore caso infrequente a collocare tra virgole il verbo dicendi e il suo complemento di termine, ancorché essi reggano un discorso diretto e siano pertanto già collocati tra line-ette, le quali certo non sono ufficialmente pause, ma sempre inducono il lettore a una breve sosta, a un momento di respiro.
Capitolo I – Appunti sulle stampe di Rosso Malpelo 161
31) RM1 (n. 211, lu 5 ago), RM3 e RM4 (p. 252): «“Tua madre ti dice così perchè, invece dei calzoni, tu dovresti portar» (R., p. 68, rr. 341–342); RM2 (p. 26): «così,» (ivi, r. 341). La leggera segmentazio-ne introdotta dal revisore e non accolta dall’autore in nessuna stampa da lui sorvegliata si spiega ovviamente con l’intenzione di costruire, mediante l’interpunzione, le corrette scansioni sintattiche (tipologia B): un intento chiarificatore, certo banalizzante ma non spregevole, che crea una lieve demarcazione tra la proposizione prin-cipale e la subordinata causale, annullando l’effetto visivo tale per cui, di primo acchito, al lettore di RM1, RM3 e RM4 il «perchè» sembra piuttosto un elemento della principale, che non l’elemento iniziale e “forte” della subordinata causale.
5. La stampa abusiva e gli interventi dell’autore. Ultimo quadro 32) 1f) RM1 (n. 211, lu 5 ago) e RM3 «a a dimostrarglielo, si dava
dei gran pugni […] con un sasso; anzi un operaio, […], gli sferrò un […] calcio sulle spalle, un calcio che risuonò» (R., p. 70, rr. 358–359); RM2 (p. 28): «sasso:» (R., r. 359); RM4 (p. 255): «spalle:» (R., r. 259).
2f) RM1 (n. 211, lu 5 ago), RM3 e RM4 (p. 255): «eppure Malpelo non si mosse, e […] dopo che l’operaio se ne fu andato, aggiunse: — Lo vedi?» (R., p. 70, rr. 361–362); RM2 (p. 28): «mosse; […] vedi!» (R., pp. 70–71, rr. 361–362).
La sostituzione dei due punti al punto e virgola in RM2 (cfr. 1f)) era correzione inutile, così come la sostituzione del punto esclamativo al punto interrogativo (cfr. 2f)). I due interventi furono compiuti, pro-babilmente, allo scopo di uniformare il segno d’interpunzione finale di tutte le esclamazioni angosciate di Malpelo dopo la prima manifesta-zione della malattia di Ranocchio. A un primo esame superficiale di RM4 pare che l’autore forse raccolga, parzialmente, un solo suggeri-mento proveniente da RM2. Egli, infatti, inserisce sì in RM4, al punto 1f), una pausa più forte della semplice virgola, e atta a slegare i due periodi tra i quali è frapposta; ma sceglie i due punti, invece del punto e virgola di RM2 (collocato all’inizio della frase che segue quella ri-portata al punto 1f): cfr. 2f)), e, rispetto a questo ne arretra la sede. Gli altri interventi dell’ignoto revisore al punto 2f) restano apparentemen-
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle 162
te inefficaci. A ben guardare, però, nel loro insieme, le correzioni di Verga2 mirano anche a una maggiore segmentazione del discorso, alla suddivisione di periodi a parer suo troppo lunghi in periodi più brevi: ne fa fede la sostituzione del punto e virgola alla virgola al punto 2f) (la parola «sasso» chiude un periodo in RM1 e RM3 composto di nove proposizioni). Il periodo che in RM1 e in RM3 va da «anzi» ad «ag-giunse» oscilla tra un numero di sei e un numero di sette proposizioni. Il vero è dunque che in RM4 l’autore fa propria, in misura maggiore di quanto non sembri a una prima osservazione, l’esigenza che il lettore “idealtipico” rappresentato da RM2 gli segnala: quella di rendere me-no affollati i periodi. L’autore, pur applicandosi anch’egli a segmenta-re maggiormente il contesto, compie sulla punteggiatura interventi di-versi da quelli effettuati dall’ignoto revisore. Verga sostituisce alla virgola i due punti, che dividono in due frasi uno dei periodi predetti; rallenta inoltre il discorso nell’intero capoverso mediante l’inserzione di parecchie virgole; esagerando, a parer mio: il discorso, assume sì a tratti il ritmo cadenzato tanto attentamente perseguito per RM4, ma talvolta prende un andamento quasi singhiozzante23.
33) 1g) RM1 (n. 211, lu 5 ago) e RM3: «Malpelo se ne stava zitto ed immobile chino su di lui, colle mani sui ginocchi,» (R., p. 71, rr. 370–371); RM2 (p. 28) e RM4 (p. 256): «immobile,» (R., r. 370).
2g) RM1 (n. 211, lu 5 ago), RM3 e RM4 (p. 256: «Finalmente un lunedì Ranocchio non venne più alla cava,» (R., p. 71, r. 378); RM2 (p. 29): «Finalmente, un lunedì,». Si comprende agevolmente che
23 Mi restringo ad annotare le varianti d’interpunzione limitatamente al confronto RM1
RM4 e a una porzione ampia del capoverso (non riportato, dunque, nella sua totale estensio-ne); trascrivo anche varianti di diversa indole solo ove esse consentano di meglio cogliere la qualità delle varianti d’interpunzione. RM1 (n. 11, lu 5 ago) e RM4 (p. 255): «per lavorare in una miniera [RM4: “miniera,”, R., r. 351] senza lasciarvi la pelle [RM4: “pelle,”, ibidem] bi-sognava nascervi. Malpelo allora si sentiva orgoglioso di esserci nato [RM4: “nato,” ivi, r. 352] e di mantenersi così sano e vigoroso in quell’aria malsana, e con tutti quegli stenti. Ei si caricava Ranocchio sulle spalle, e gli faceva animo alla sua maniera, sgridandolo e picchian-dolo. Ma una volta [RM4: “volta,” ivi, r. 355] nel picchiarlo sul dorso [RM4: “dorso,”, ibidem] Ranocchio fu colto da uno sbocco di sangue, e Malpelo [RM4: “sangue; allora Malpelo”, ivi, r. 356] spaventato si affannò a cercargli nel naso e dentro la bocca cosa gli avesse fatto, e giu-rava che non avea potuto fargli poi gran male, così lievemente come l’avea battuto, e a dimo-strarglielo, si dava dei gran pugni sul petto e sulla schiena [RM4: “schiena,”, ivi, r. 359] con un sasso; anzi un operaio, che avea visto la scena, gli sferrò un bel calcio sulle spalle, [RM4: “spalle:”, ivi, r. 360] un calcio che risuonò come su di un tamburo:» (R., p. 70, rr. 357–360).
Capitolo I – Appunti sulle stampe di Rosso Malpelo
163
l’autore, in RM4, presti ascolto, come suole, all’esigenza di maggiore correttezza grammaticale insita nell’intervento di Verga2 al punto 1g). Non sorprende neppure che, di contro, egli non accolga le modifica-zioni all’interpunzione di cui al punto 2g). Vi è naturalmente un legge-rissimo margine di arbitrio nelle decisioni, non sempre uniformi, dell’autore. In questo caso, però, l’intervento di Verga2 non aggiunge perspicuità; crea una certa divaricazione tra elementi della proposizio-ne che sono invece fortemente uniti sul piano logico–semantico–grammaticale, tanto che l’autore ha scientemente “racchiuso” soggetto e verbo tra complemento di tempo e complemento di luogo; attenua la patina popolaresca e vicina al parlato del discorso, attenuazione e ba-nalizzazione in cui, senza dubbio, anche l’autore incorrerà in parecchi luoghi di RM4. Si può aggiungere che l’autore aveva inserito una vir-gola nella proposizione precedente quella di cui al punto 2g) onde conferire risalto alla felicemente sgrammaticata replicazione del com-plemento indiretto, che ricorreva sia mediante il pronome personale sia mediante il nome, come spesso accade nel parlato quando il com-plemento indiretto è circondato da una certa enfasi (RM1, n. 211, lu 5 ago, RM2, p. 29 e RM3: «E il padrone diceva che Malpelo era capace di schiacciargli il capo a quel ragazzo, e bisognava sorvegliarlo.»: R., p. 71, rr. 376–377; RM4, p. 256: «il capo, a quel ragazzo,»: R., r. 377). Peraltro, il risalto che gli è donato conferisce al complemento indiretto una letterarietà più ricercata, che contrasta con l’antecedente cura po-sta a riprodurre un parlato che appaia autentico e ingenuo. Checché sia di ciò, se in 2g) l’autore avesse accolto la correzione dell’ignoto revi-sore, la zona contestuale sulla quale ci si sta per ora soffermando a-vrebbe assunto l’andamento singhiozzante che spiace aver dovuto ri-levare al precedente paragrafo 32)24.
34) RM1 (n. 211, lu 5 ago): «e quando sarebbe divenuto come il grigio, e come Ranocchio,» (R., p. 73, r. 402); RM2 (p. 30): «grigio e» (ivi, r. 402); RM3 e RM4 (p. 258): «grigio o». La consueta soppressio-ne della virgola che precede la congiunzione «e», compiuta dall’ignoto revisore, questa volta non lascia indifferente Verga né per RM3 né per RM4. Oltre che eliminare la virgola egli sostituisce alla congiunzione un «o» nel senso di “oppure”. Non si tratta di sostituzio-
24 Cfr. la nota precedente.
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle
164
ne felice: l’asino grigio è un completamento e quasi un raddoppiamen-to di mastro Misciu e di Ranocchio, e dunque non è in alternativa con essi, tanto più che sia i due personaggi umani che l’animale sono ri-dotti a «carcame» nel momento in cui alla mente di Malpelo si affac-cia il pensiero sopra riferito parzialmente.
35) RM1 (n. 211, lu 5 ago) e RM3: «era scappato dalla prigione, e se lo pigliavano ce lo tornavano a chiudere per degli anni e degli an-ni.» (R., p. 73, rr. 406–407); RM2 (p. 31): «chiudere per degli anni.» (R., r. 407); RM4 (p. 258): «per degli anni ed anni.». Lo sconosciuto revisore sente come scorretta o stonata la formula «per degli anni e degli anni», in qualche modo effettivamente lontana dallo stile che si conviene a una narrazione e a una tranche de vie naturalista, e adegua-ta invece allo stile delle leggende e delle fiabe popolari. Nelle novelle di Vita dei campi, e in Rosso Malpelo in particolare, però, come è no-tissimo, l’autore ancorché quasi sempre tragici siano i fatti narrati
crea un’atmosfera mitica, leggendaria, fiabesca, la quale convive pacificamente con la dimensione in senso stretto naturalista, vale a di-re con il riferimento a dati storicamente esatti e a esperienze o condi-zioni di vita effettive: in Rosso Malpelo la piaga costituita dallo sfrut-tamento del lavoro dei bambini e la vita nelle miniere di Sicilia quale è presentata nell’inchiesta Franchetti–Sonnino25. L’ignoto correttore incorre dunque in una svista grave. Tuttavia, il disagio manifestato dal suo “idealtipico” lettore induce l’autore a un “pastiche”, a un esito in-termedio, se è lecito dir così, tra la formula fiabesca e popolaresca di RM1 e di RM3 e la ricerca di una maggiore letterarietà e proprietà del-la lingua. Si tratta in verità di soluzione meno efficace sia rispetto alla movenza stilistica di RM1 e di RM3, sia rispetto a quella, affine, di cui si discorrerà al successivo punto 42.
36) RM1 (n. 211, lu 5 ago): «Invece le ossa le lasciò nella cava Malpelo, come suo padre,» (R., p. 73, r. 419); RM2 (p. 31), RM3 e RM4 (p. 259): «cava,». L’autore accetta fin dalla seconda stampa da lui sorvegliata la correzione apportata in RM2 perché, probabilmente,
25 Dall’inchiesta di L. FRANCHETTI e S. SONNINO su La Sicilia nel 1876, Firenze, Le Mon-
nier 1877, 2 voll., Verga trasse importanti informazioni (specie dal secondo volume dell’inchiesta, quello di Sonnino, intitolato I contadini in Sicilia, in fondo al quale, alle pp. 472–489, si legge il «Capitolo supplementare» circa Il lavoro dei fanciulli nelle zolfare sici-liane).
Capitolo I – Appunti sulle stampe di Rosso Malpelo 165
apprezza la simmetria che meglio si stabilisce tra il segmento prece-dente e quello seguente il soggetto segmenti a questo entrambi in-timamente legati dal punto di vista logico–grammaticale , collocan-do il soggetto tra le due virgole. La simmetria, seppur priva dell’effetto di bilanciamento che si instaura a partire da RM2, era stata ad arte cercata dall’autore stesso, il quale, fin da RM1, aveva posto il soggetto in sede finale, come ultimo tra gli elementi–base della propo-sizione.
39) RM1 (n. 211, lu, 5 ago): «non aveva nemmeno chi si prendesse tutto l’oro del mondo per la sua pelle se la sua pelle fosse valuta» (R., p. 74, rr. 426–427); RM2 (p. 32): «pelle, se» (R., r. 427); RM3 e RM4 (p. 261): «pelle, se pure la sua pelle valeva» (R., r. 427). L’inserzione della virgola in RM2 crea sia una opportuna piccola sospensione, un momento di respiro per il lettore, sia una demarcazione visiva tra la proposizione principale e la subordinata concessiva; questa demarca-zione, senza troppo rallentare il flusso del discorso, consente al lettore di afferrarne tempestivamente gli elementi logico–grammaticali e sin-tattici. Il ritocco subito da RM2 convince Verga e viene da questo ac-colto sia in RM3 che in RM4.
40) RM1 (n. 211, lu 5 ago) e RM3: «ed ei non aveva altro che» (R., p. 74, r. 429); RM2 (p. 32): «avea»; manca in RM4. La correzione vor-rebbe uniformare la forma dell’imperfetto indicativo all’esito grafico–morfologico prevalente in RM1: inutilmente e cervelloticamente, giac-ché pochissimi righi sotto la medesima forma ricompare sia in RM1 che in RM3 senza subire in questo caso ritocco alcuno in RM2. RM1 (n. 211, lu 5 ago), RM2 (p. 32) e RM3: «e s’ei non si aveva riguardo alcuno,» (R., r. 431; manca in RM4).
41) 1h) RM1 (n. 211, lu 5 ago): «gli commettevano sempre i lavori più rischiosi, e le imprese più pericolose,» (R., p. 74, rr. 430–431); RM2 (p. 32): «rischiosi e» (R., r. 431); RM3: «più pericolosi, e […] più arrischiate» (R., r. 431; manca in RM4).
2h) RM1 (n. 211, lu 5 ago) e RM3: «Prese […] il sacco col pane, e il fiasco del vino, e se ne andò; [RM3: “andò:”, R., r. 437]» (R., p. 74, rr. 436–437); RM2 (p. 32): «pane e il fiasco del vino e se ne» (R., r. 437); RM4 (p. 261): «col pane, il fiasco del vino, e se ne andò:» (R., r. 437). Trattasi in entrambi i casi, per quanto concerne il duplice per-corso correttorio al centro del quale sta RM2, della consueta soppres-
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle 166
sione della virgola innanzi la congiunzione «e» (riconducibile alla ti-pologia A)), attuata frequentemente da Verga2. Al punto 2h) vengono soppresse ben due virgole, che precedevano altrettante congiunzioni «e». In questo caso pertanto, diversamente che al punto 1h), l’autore tiene di conto per RM4 queste due manifestazioni del disagio e della diversa, alquanto scolastica, mentalità grammaticale espresse dal letto-re “idealtipico”. L’autore, al fine di mantenere gli obiettivi che si pre-figge nella revisione stilistica di RM4, cioè, nella fattispecie, per non affrettare l’andamento e il ritmo cadenzato del discorso, non sopprime alcuna virgola, sibbene la prima congiunzione «e»26.
42) 1i) RM1 (n. 211, lu 5 ago), RM3 e RM4 (p. 261): «si risovvenne del minatore, il quale si era smarrito, da anni ed anni, e cammina e cammina ancora al buio [RM4: “buio,”, R., p. 74, r. 434]» (R., p. 74, rr. 433–434); RM2 (p. 32): «smarrito da» (R., rr. 433–434).
2i) RM1 (n. 211, lu 5 ago), RM3 e RM4 (p. 261): «chè hanno paura di vederselo comparire dinanzi, coi capelli rossi e gli occhiacci grigi.» (R., p. 74, rr. 439–440); RM2 (p. 32): «dinanzi coi» (R., r. 440). Trat-tasi di due interventi tra loro affini ed entrambi riconducibili alla tipo-logia C), la più frequentata da Verga2. Interessante è soprattutto il ca-so 2i). A Verga2 il complemento di tempo indeterminato appare come un elemento integrante, come un completamento organico della breve proposizione relativa che lo precede: esso costituisce con quella una unità logico–grammaticale e semantica coesa e compatta. Probabil-mente il revisore giudicava la virgola di RM1 o come un refuso o co-me il frutto di una distrazione dell’autore. Egli riteneva forse che, sopprimendo la virgola, venisse conferito spicco sia al parallelismo tra la prima proposizione relativa e la seconda, raddoppiata («e cammina e cammina ancora al buio»), sia alla simmetria tra il complemento di
26 Sono al di fuori del giro di interessi del presente lavoro le porzioni di testo implicate in
varianti semantico–lessicali nel percorso RM1 RM3. Non parrà forse inopportuno, invece, che si esponga qualche delucidazione circa la variante d’interpunzione che, al punto 2h), chiude le espressioni riferite tra virgolette basse. Il punto e virgola di RM1 viene eliminato e sostituito con i due punti sia in RM3 che in RM4. Ciò segnala al lettore che gli si chiede di concentrare la propria attenzione sulla breve proposizione che segue i due punti e che costitui-sce la prima chiusa della novella; proposizione che non è, dunque, una coordinata dotata di rango uguale a quello di tutte le numerosissime coordinate che formano il racconto, soprattut-to in RM3, e che invece riveste speciale interesse e richiede speciale considerazione; RM3 e RM4: «e se ne andò: né più si seppe nulla di lui» (R., p. 74, r. 437).
Capitolo I – Appunti sulle stampe di Rosso Malpelo
167
tempo, anch’esso raddoppiato, il quale chiude la prima proposizione relativa, e il raddoppiamento del verbo con cui inizia la seconda rela-tiva. Intento precipuo dell’autore era, per contro, quello di donare sia alla prima chiusa della novella con cui termina il resoconto della piccola tragedia individuale di Malpelo , sia alla seconda chiusa in cui la vita e soprattutto la morte di Malpelo diventano per sempre materia di racconti superstiziosi e gravidi di paura , il respiro pro-prio delle fiabe e delle leggende popolari. A tal fine l’autore crea un lieve stacco tra la classica formula fiabesca «da anni ed anni» (cfr. il paragrafo 35) e la proposizione di cui essa logicamente costituisce l’elemento conclusivo. Ponendo il complemento di tempo tra due vir-gole l’autore consegue un duplice effetto: quello di donare la massima evidenza visiva all’elemento in questione; quello di evitare ch’esso sembri del tutto disgiunto dalla seconda proposizione relativa. In tal modo per un verso si suggerisce implicitamente che il minatore smar-rito cammina da anni e anni e ancora cammina; per altro verso si in-duce il lettore a percepire la stretta affinità e l’intima coesione stilisti-ca che unisce le due formule attinte dalle fiabe: «da anni ed anni, e cammina e cammina». Gli effetti stilistici in questione sono rafforzati, in RM4, mediante la pausa inserita dopo «buio». L’autore rinunzia a ottenere un ancor più accentuato parallelismo tra la prima relativa e la seconda, raddoppiata; esito che si sarebbe ottenuto racchiudendo tra due virgole il complemento «al buio». Evitando questo artificio egli evita altresì di creare quel ritmo non più cadenzato sibbene “singhioz-zante” che talora, sfortunatamente, viene suscitato in RM4 dall’inserzione di un numero eccessivo di pause, sia pur lievi, che non esistevano in RM1 e in RM3.
6. Conclusioni Rossana Melis nell’articolo in cui presenta le prove a sostegno del-
la tesi che RM2 già circondato da una certa diffidenza degli specia-listi non fu autorizzato né, tantomeno, riveduto e corretto da Verga, scrive che «tutta la vicenda qui ricostruita permette quindi di conside-rare abusiva l’edizione del ”Patto di fratellanza” di Rosso Malpelo, chiarendo alcuni aspetti contraddittori che essa presentava, e la espun-
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle 168
ge definitivamente dall’apparato critico». A questo giudizio non deve però esser sotteso il proposito (il quale non è espresso, si badi, da Me-lis) che di RM2 si scriva solo nelle pagine introduttive dell’edizione critica, e che ivi la stampa in questione venga considerata come un e-pisodio caratteristico della storia del malcostume editoriale e come un momento significativo della fortuna di Rosso Malpelo. È doveroso la-sciare alla competenza degli specialisti della filologia italiana la di-scussione circa il modo tecnicamente più opportuno di “reinserire” RM2 dopo che gli sarà stato tolto il ruolo di testimone , in un’apposita appendice, o altrove, all’interno dell’edizione critica pro-priamente detta. Il critico letterario e lo storico della cultura prudenti, nello studio del processo genetico di RM3 e di RM4 non prescinderan-no mai del tutto da RM2, pur badando a servirsene con tutte le oppor-tune cautele, in maniera guardinga.
169
Capitolo II
Lo stridore e l’armonia. Jeli il pastore tra Rosso Malpelo e I Malavoglia
1. I suoni come livello fondamentale dello stile nel Verga verista1 La presente indagine è nata per deduzione, sulla scorta dei risultati
raggiunti da chi scrive in altri studi su Verga2. È stato ormai accertato che Verga prestò massima attenzione, nel periodo verista–rusticano, alla corrispondenza tra il livello fonetico–sonoro del testo e la qualità dei “contenuti” (anche delle diverse “porzioni di contenuto”)3. Agli albori della scelta naturalista, primo frutto della quale è la novella RM (1878), lo scrittore si rivolse all’Inferno di Dante, continuando con perseveranza e gusto stilistico ormai esperto una ricerca sugli aggrega-ti fonetico–sonori striduli, aspri, gracchianti, che egli aveva iniziato,
1 Abbreviazioni e sigle: RM(1–3–4): Rosso Malpelo (1878–1880–1897), in G. V., Vita dei
campi, a cura di C. Riccardi, vol. XIV della Ediz. naz. delle Opere di G. V., cit.; Je: Jeli il pa-store, (1880), ivi (per il vol. Vita dei campi cfr. nota 1 al capitolo precedente); Mal: G. V., I Malavoglia, cit.; MdE: G. V., Il marito di Elena, cit. (per Mal e MdE cfr. nota 1 al cap. I della Parte prima). L’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso di D. ALIGHIERI (secondo l’edizione criti-ca di G. Petrocchi) saranno citati mediante le abbreviazioni Inf, Purg e Par. Avverto che elen-cando le aggregazioni fonetico–sonore che imprimono il tratto fonico ai singoli significanti o a porzioni del discorso, le ho sempre poste tra due trattini, anche quando si tratti di particelle monosillabiche, al fine di renderle nitidamente percepibili, insomma leggibili senza equivoci.
2 Cfr. in particolare il mio volume Dai suoni al simbolo, cit. (per cui cfr. nota 2 al capitolo primo di questa parte seconda).
3 Uso la formula “livello fonetico–sonoro” invece della formula “livello fonico” perché nel livello fonico talvolta vengono inclusi aspetti metrici e prosodici estranei alle questioni che si toglieranno a esame. Neppure l’espressione “livello acustico–sillabico” è adeguata al presente studio perché gli aggregati fonetico–sonori appartengono sì al sistema dei puri signi-ficanti ma non sono necessariamente incatenati alle sillabe. Eventualmente si dovrebbe usare la formula (ma a che pro, dato che è magniloquente?) livello delle aggregazioni fonetico–consonantico–vocaliche.
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle
170
lasciandosi guidare dalle tendenze del romanticismo macabro, a parti-re da Storia di una capinera (1870–73).
Nel De vulgari eloquentia Dante discorrendo dello stile nobilis-simo condanna l’asprezza delle rime («rithimorum asperitas»:), a meno che non sia frammista alla morbidezza («nisi forte sit lenitate permixta»): perché egli asserisce la tragedia riceve il proprio splendore precisamente dalla mescolanza di rime dolci e di rime aspre («lenium asperorumque rithimorum mixtura ipsa tragedia nitescit)4. Nelle rime cosiddette “petrose” il sommo poeta si attiene fedelmente a questo precetto. Anche in Inf suoni morbidi si combinano o si alterna-no con suoni duri, aspri e striduli; senonché Inf essendo scritto in stile “comico” e non “tragico” , i suoni aspri e striduli vi assumono rilievo crescente via via che ci si cala verso le profondità estreme dell’abisso, sul limitare delle quali infatti il poeta esplicitamente invo-ca e trova le «rime aspre e chiocce». Durante questo “crescendo”, il lettore prova l’impressione, non tanto sensoriale, quanto invece acu-stico–mentale, che nella zono più bassa dell’inferno la dissonanza prevalga nettamente sui suoni lievi e diafani. E questo è certamente uno dei livelli stilistico–formali (attinente i puri significanti) adeguati a donare configurazione espressiva al male assoluto, alla disperazione cieca.
Lungo la direttrice RM(1–3) Mastro–don Gesualdo si sostanzia una Weltanschauung intratestuale improntata a pessimismo cupo e privo di ogni contraltare, una visione del mondo come bellum omnium contra omnes secondo cui la sofferenza, la sopraffazione e il male, quelli individuali e quelli sociali, sono insiti nell’ordine naturale delle cose, e la natura stessa per lo più è inerte fonte di dolore per l’uomo. Dal bellum omnium contra omnes in cui consiste la sostanza antropo-logica e sociale della vita non sorgono, o meglio, non prendono mai a lungo il sopravvento, individui o gruppi più capaci e più forti degli al-tri, e più degli altri adatti all’ambiente: i mala in mundo sono escato-logicamente effetto del malum mundi. Nel mondo dei Vinti tutti sono dei vinti (qualche eccezione nei Mal): anche i duchi e le duchesse dai
4 D. ALIGHIERI, De vulgari eloquentia, a cura di A. Marigo, Firenze, Le Monnier 1968:
le tre espressioni riferite nel testo tra virgolette basse sono tratte dal libro II, cap. 13, par. 12, p. 274.
CAPITOLO II – Lo stridore e l’armonia 171
palazzi sfarzosi. Il male assoluto, la disperazione cieca, contrassegna-no e tutta intridono RM(1–3). La dissonanza è un modo poetico–formale atto a esprimere un disvalore totale. In RM(1–3) la famosa du-rezza e asprezza linguistica di Verga consegue il primo esito maturo; essa troverà anni dopo il proprio approdo più complesso e illustre nel Mastro–don Gesualdo.
Dal nulla non nasce nulla: quella durezza e quell’asprezza sono, come si è ricordato, il frutto di un lungo e strenuo esercizio compiuto su Inf. Questa cantica costituì per lo scrittore siciliano una ricchissima miniera di parole, di agglomerati consonantico–vocalici (non necessa-riamente coincidenti con quelli sillabici) e di effetti sonori durissimi, striduli, rauchi, gracchianti. Lo studio e lo sperimentalismo verghiano sono attivi e creativi, mirano a utilizzare il repertorio di parole e di suoni fornito dal Dante “infernale” rifacendolo in maniera corrispon-dente alle proprie esigenze. Sovente, com’è naturale, Verga si avvale di parole dantesche che ogni lettore competente riconosce come pa-role ricorrenti in Inf e connotate in senso strettamente “infernale” (strida, brighe, picchia, grattava, greppi, pipistrello) 5. Da Inf proven-gono l’uso vistoso e la sapiente ripetizione delle varie forme del verbo «crepare» («crepato», «crepi», «creperai») e in genere le coppie grac-chianti gr– e soprattutto cr– (cfr. Inf, XXX, vv. 102 e 121: «col pugno li percosse l’epa croia» e «“E te sia rea la sete onde ti crepa”»). La verghiana rielaborazione fonetico–sonora dei materiali lessicali tratti da Inf talora avviene mediante la figura etimologica, cioè mediante la ripresa della radice di una parola e l’attribuzione di un valore gramma-ticale diverso alla nuova parola coniata mantenendo la predetta radice: il dantesco verbo «ringhia» diventa in RM3 l’aggettivo «ringhioso»; ma in modo analogo sorgono i verghiani ca/sti/ghi, cin/ghia, rim/pic-co/lì, ros/icchia/rsi, ruv/idi, sfor/acchia/re, sgom/berare, sonn/ac-chio/so, spro/fondava, stra/volto. Verga si serve spesso dell’annomi-nazione: si ha identità o quasi identità dei significanti accompagnata da estraneità reciproca dei significati (p.e. «si rannicchiava» e «nic-chio» termine che fa il proprio esordio nel Mastro, ove ricorre spesso rispetto al dantesco «si nicchia»). Dante fornisce sicuramen-
5 Cfr. il mio volume sopra citato Dai suoni al simbolo, specie alle pp. 46–48, alle pp. 213
sgg. e alle pp. 230–232.
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle 172
te a Verga in modo diretto o indiretto tante parole a sonorità greve e dissonante: «crollava», «crudele», «ingrassava», «grossa», «grigio», «graffiare», «magro», «grida», «grattava» e pure «mastro», «pipistrel-li», «strinsero», «strano», «stremo», «strada», «disgrazia», «sgridava», «brighe», «unghie», «cinghia», «castighi» e soprattutto «strida». In generale, RM(1–3) è debitore a Inf delle parole in cui l’elemento foni-co–acustico dominante risiede negli aggregati duri e gutturali (e nelle loro numerose variazioni morfologiche) –acchi–, –epp–, –ghi–, –ghe–, –icchia–, –occa–, –ucco–, –sbra–, –schia–, –schiu–, –sga–, –sghe–, –sgo–, –ucco–, e in quelli striduli (con le loro numerose variazioni morfologiche) –cre–, –cro–, –cru–, –gra–, –gre–, –sbr–, –scr–, –sgra–, –spro–, –stra–, –stre–, –stri–, e via dicendo. Qualche volta l’esame delle varianti d’autore lungo il percorso correttorio dalla prima reda-zione manoscritta della novella alla stampa nella edizione princeps di Vita dei campi mostra che le parole infernali dure e stridule vengono primamente riprese da testi di area romantica (specie di Foscolo e in più lieve misura di Monti), che hanno carattere lugubre o propriamen-te sepolcrale; ma Verga in corso d’opera si riavvicina sempre alla fon-te originaria, cioè a Inf.
Non di rado Verga attua la scomposizione, lo “smontaggio” delle parole dantesche per poi assemblare nuovamente, in modo differente, gli aggregati fonetico–sonori; egli perviene così a usare vocaboli per-fettamente italiani i quali non ricorrono però nella Commedia e non hanno alcuna parentela semantica con le parole di Dante. Nondimeno, queste nuove espressioni di origine dantesca recano in sé, nitidamente percepibile, il marchio di provenienza; all’interno di esse, cioè, ricom-paiono in qualche modo gli originari agglomerati danteschi (pi/la/stro; sgan/ghe/rate; atr/oci; z/appa; sbat/acchia/to; car/ca/me; stri/scia; mi-ne/stra; ra/schia/va; lu/gu/bri; cr/occhi/o; im/bra/tta/to; p/icco/ne; di/sgra/zia; sbra/ca/to; str/appa/re; z/occo/li; gui/dale/sche; sp/acche/rò). Così, per esempio, nall’aggettivo sgan/gher/at –a–e–i–o, carissimo a Verga e inesistente nella Commedia, sono presenti porzioni di parole ben dantesche come sgan/ni e gher/mito.
La morfologia degli aggregati acustico–sillabici mediante i quali Verga imprime al suo primo racconto verista un assetto fonetico–so-noro duro, aspro, stridulo, gracchiante è stata definita e descritta se-condo sei tipi fondamentali in altra sede, cui si rinvia per ogni ulterio-
CAPITOLO II – Lo stridore e l’armonia 173
re delucidazione inerente la questione in oggetto6. Non ho usato allora e non userò neppure in questa sede l’alfabeto dell’Associazione Fone-tica Internazionale (A.F.I.) per rendere graficamente foni (qui per lo più denominati semplicemente suoni) e fonemi; i segni alfabetici con-venzionali della lingua italiana (lettere) sono infatti bastevoli a ottene-re la corrispondenza tra grafia e pronuncia propria della nostra lingua poetico–letteraria (e sicuramente di quella verghiana). Il presente lavoro è estraneo agli interessi della fonologia e della linguistica scientifiche, prende in esame suoni e lettere. Forse vengono sfiorati qua e là temi
6 Cfr. ivi, pp. 123–124 e anche 133 e 321. Giova riferire sinteticamente la classificazione–base, come la si può desumere da tutte le pagine succitate: 1) adozione di aggregati vocalico–consonantici non coincidenti con quelli sillabici cui la marca vocalica fondamentale venga impressa dalla u, specie dalla u in posizione iniziale e finale o percossa da accento. 2) Rile-vante presenza del suffisso peggiorativo –acci, –accio. Il tratto fonico determinante risiede in questo caso nella palatalizzazione, e può apparire scorretto, dunque, inserire il detto suffisso, cioè un valore semantico–lessicale, tra espedienti e valori puramente fonetico–sonori. Il suf-fisso –acci, –accio, tuttavia, esercita spesso, sebbene non sempre, una formidabile suggestione psicologica, la quale conduce il lettore a percepire come sgraziata e dissonante la parola che reca quel suffisso. Per esprimersi in maniera più appropriata, si può dire che esso contribuisce alla creazione di uno “sfondo preparatorio”, di una diffusa atmosfera complessiva cupa e im-pregnata di emozioni negative: sfondo dal quale la sonorità greve e stridente trae vivida inten-sità. 3) Ricerca insistita di consonanti dure o relativamente dure seguite da –r– e da vocale: –bra–, –bre–, –bri–, –bro–, –bru–, –cra–, –cre–, –cro–, –cru–, –dri–, –dro–, –gra–, –gre–, –gri–, –gro–, –pre–, –pri–, –pro–, –pru–, –tra–, –tre–, –tri–, –tro–. L’effetto più o meno grac-chiante di questo genere di aggregazioni fonetiche, situate sia all’inizio, sia al centro, sia alla fine della parola, raggiunge l’apice nei casi in cui: 31)la lettera che precede la –r– è –c– oppu-re –g– (crepare, graffiare ecc.); 32) il gruppo formato da consonante seguita da –r– e da vocale è preceduto da s–: –sbra–, –sgra–, –spro– e soprattutto –stra–, –stre–, –stri–. Si ottengono in quest’ultimo caso gli esiti forse più sgraziati e dissonanti, trattandosi dell’agglomerato per an-tonomasia e per onomatopea più stridulo. 4) Uso frequente delle consonanti dure –c– e –g– scempie, anche e soprattutto nei fonemi –ch– e –gh–, sia all’inizio, sia alla fine, sia nel corpo centrale della parola; queste unità fonetico–sonore sono particolarmente efficaci se, come spesso accade, –c–, –g–, –ch–e –gh– sono precedute da altra consonante o se, meno spesso, precedono la –i– seguita da altra vocale: –ca–, –co, –ga–, –ghe–, –ghi–, –go–, –nchi–, –nghe–, –nghia, –rca–, –rchi–, –sca–, –sche–, –schia–, –schie–, –schiu–, –sco–, –sga–, –sghe–, –sgo–. 5) Esteso ricorso al raddoppiamento di consonanti che non siano né dolci né morbide; esse sono per lo più precedute e seguite da vocale e solo raramente, invece, seguite da –r– e voca-le: –a(o, u)bb–, –a(o, u)pp–, –a(o, u)tt–, –a(o, u)zz, –attr–, –ebbr– (e anche, con minore inten-sità –epp–, –ett–, –ezz–). 6) Uso insistito e scaltro della –cc– dura (della –c– raddoppiata), ovviamente preceduta da vocale e non raramente seguita da –i– e da altra vocale. È irrilevante che questo agglomerato talora coincida con suffissi (rosicchiarsi, sonnacchioso), o che sia in-vece libero, come spesso accade, da connotazioni morfo–lessicali specifiche e si trovi pure in posizione iniziale di parola. È questa l’aggregazione di consonanti e di vocali che più di ogni altra imprime al discorso effetti fonetico–sonori gutturali e duri, anzi durissimi: –a(e, i, o, u)cca–, –a(e, i, o, u)cchi–, –a(e, i, o, u)cco–, e anche a(e, i, o, u)chhia, –a(e,i,o,u)cchio.
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle
174
che possono avere un modesto interesse per il linguista: se così fosse, al linguista sarà assai facile tradurre nel suo lessico scientifico le os-servazioni a parer suo pertinenti per la sua disciplina. Superfluo, anzi scioccamente lezioso, sarebbe rendere qui graficamente sc–iame con –iame o distinguere sia graficamente sia fonicamente tra –n– velare e
–n– dentale. Nondimeno, coloro i quali, anche tra i non addetti ai la-vori, per apprezzabili motivi fossero interessati a queste distinzioni potranno agevolmente ricavarle con l’ausilio di manuali idonei7.
Le novelle veriste di Verga successive a RM(1–3) sono spesso qua-si tanto quanto il Mastro dure e corrosive dal punto di vista tematico, laddove assai più intenerita, rispetto alle novelle e al Mastro, è l’atmosfera dei Mal. Viene dunque da chiedersi come mai, eccezion fatta, solo parzialmente, per La Lupa, le altre novelle veriste, sia quel-le incluse in Vita dei campi sia quelle raccolte nelle Rusticane, specie quelle che più rispecchiano una visione del mondo improntata a pes-simismo cupo, non siano contrassegnate da asprezza e stridore fonici speciali. Non credo si possa rispondere che la materia loro, spesso in-trisa di violenza e di gretti istinti patologici, non sia altrettanto cana-gliesca, acida, corrosiva quanto quella di RM(1–3) e quella del Ma-stro. Ritengo più verosimile che grazie a RM(1–3) Verga senta di ave-re appreso l’arte di creare agglomerati fonetico–sonori gracchianti, du-ri, sommamente disarmonici: quest’arte è confluita nel suo bagaglio di esperienze ed egli se ne avvale alquanto più parcamente nelle novelle successive per poi tornare ad avvalersene, in maniera decisamente più accentuata che in queste, nel Mastro. RM(1–3) conduce verso il Ma-stro, mi è avvenuto di scrivere. Tra i due testi si colloca tutta la restan-te produzione verista di ambiente siciliano pubblicata da Verga: in particolare, mentre redige RM(1–3), Verga ha già concepito i Mal. La principale ragione per cui egli rinunzia a un uso massiccio della disso-nanza nel percorso tra RM(1–3) e il Mastro è che la materia dei Mal
7 Rinvio al manuale di L. SERIANNI, con la collaborazione di A. CASTELVECCHI, Gramma-
tica italiana. Italiano comune e lingua letteraria, Torino, UTET Libreria 1989 e a quello di M. DARDANO e P. TRIFONE, Grammatica italiana con nozioni di linguistica, Bologna, Zani-chelli 19953. Cfr. anche M. MIONI, Fonetica e fonologia, in Aa.Vv., Introduzione all’italiano contemporaneo. Le strutture, a cura di A. A. Sobrero, Roma–Bari, Laterza 19983, pp. 101–139 e A. DE DOMINICIS, Fonologia comparata delle principali lingue europee moderne, Bo-logna, CLUEB 1997.
CAPITOLO II – Lo stridore e l’armonia 175
non è affatto unilateralmente negativa; e lo scrittore sente di dovervi pertanto ritrarre in maniera perfettamente bilanciata ed equilibrata, senza prevalenza del tratto fonetico–sonoro duro e stridulo, tutta la speciale sonorità del suo dialetto: impasto linguistico splendido di suoni duri e di suoni dolci, di suoni stridenti e di suoni armoniosi.
2. La lingua dei Malavoglia e la mimesi del dialetto siciliano–ca-tanese Giova fornire sensibilmente un saggio di quel “dialetto siciliano i-
deale”, insomma di quella ricchezza sonora e di quello straordinario amalgama di armonia, durezza, asprezza, musicalità e stridore che Verga intendeva riprodurre nell’assetto fonetico–sonoro della sua ope-ra forse maggiore. Le nove strofette sotto riferite sono tolte dalla Rac-colta di proverbj siciliani ridotti in canzoni dall’abate catanese Santo Rapisarda, che Verga ebbe certamente tra le mani al più tardi entro il 23 agosto 1880, opera di grande interesse come documento del patri-monio folklorico, della cultura popolare e del dialetto siciliano di Ca-tania, sia pure modellato con intenti artistici8. Gli aggregati fonetico–sonori duri, aspri, gracchianti, striduli che entrano a comporre le paro-le delle canzoni raccolte da Santo Rapisarda sono molto simili a quelli che contrassegnano RM e presentano affinità notevolissime con quelli “infernali” maggiormente usati da Verga nella succitata novella.
Considerando la Raccolta nel suo insieme, però, come s’è già anti-cipato, la lingua riprodotta da Rapisarda non è dura e gracchiante; è anzi, come lo è la lingua dei Mal, un impasto meraviglioso di stridore e armonia:
8 Raccolta di proverbj siciliani ridotti in canzoni dall’abate SANTO RAPISARDA di Catania,
Catania, Niccolò Giannotta editore 18812: le canzoni tratte dal detto volume saranno riferite nel testo con l’indicazione del numero del libro e di quello della pagina. I titoli delle canzoni sono in corsivo nel volume di Rapisarda. Con lettera da Catania del 20 aprile 1879 Verga a-veva scritto a Capuana ch’egli andava cercando la raccolta dei proverbi del Rapisarda, intro-vabile sebbene stampata a Catania (cfr. CartVC, p. 83). Nella successiva lettera da Mendrisio del 23 agosto 1880 allo stesso corrispondente Verga scrive di avere ricevuto i proverbi (cioè la raccolta di Rapisarda) e ringrazia Capuana (ibidem).
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle
176
La cursa di l’asinu facisti /Si cerchi qualchi ’mpiegu, ed è in cuntrasti, / Fatti lu loccu e teniti a li visti / Pirchì si ti ci affuddi, forsi tasti / Qualche lignata di li genti tristi, / Cerca tuccari cun arti li tasti, / Comu fannu li boni strumintisti, / Pri un ti sentiri diri un ci arrivasti, / E la cursa di l’asinu faci-sti. (libru primu, p. 13) Lu puviru malatu si nni mori / Invano cerca la fortuna ria / Cunsulari stu miu mischinu cori, / Ammatula mi mustra curtisìa, / E mi lusinga ccu duci palori, / È veru ca mi dici gioja mia, / Quantu prima su to li mei tesori. / Ma mentri ca lu medicu studìa / Lu puviru malatu si nni mori. (ivi, p. 60) Pisti l’acqua ’ntra lu murtaru / Sempri dici nna cusa, ed iu ti juru / Ca l’arma m’hai cardatu, amicu caru, / Sempri sentiri un cantu è troppu duru, / Mi fai passari li jorna in succaru: / Si ’na vera liscia, ti l’assicuru, / Si ’na cimicia sicca di cuddaru / Quasi m’hai misu cu li spaddi a muru / Pistannu l’acqua dintra lu murtaru. (ivi, p. 64) Munti ccu munti non si jonci mai / Orvu si dici a cui d’un occhiu è offisu, / Non mi la dari, rispunni, a to soru, / Si dici a un zoppu, camina chiù tisu / Si sdegna, e dici, tu lu sai cu foru; / Lu jocu ccu lu veru ha tantu pisu, / Ch’un omu saggiu, e di multu decuru / Non dici, ’ntra la casa di lu ’mpisu / Non ci appenniri mancu l’ugghialoru. (libru secunnu, p. 73) Feti comu un cani mortu / Si tu non voi lu nomu di cafoni / Cridimi pridd’amuri ca ti portu, / Non disprizzari l’onesti pirsuni, / Ch’a li toi vog-ghi un si ni jaru a tortu: / Pirchí autrimenti ccu giusta raggiuni / Tutti le genti ti dirannu stortu: / Gatta ch’un po’ arrivari a lu primuni / Dici ca feti comu un cani mortu. (ivi, p. 112) Cui è prena ha figghiari, e cui ha dari ha pagari / Ci volino fatti, amicu, e non palori; / Lu cridituri tu lu poi ’mbrugghiari / Pri pocu tempu, s’è bonu di cori, / Ma poi sarai costrittu di sbrumari: / Li pruverbii pri mia sunnu te-sori, / Mentri si dici: cui è prena ha figghiari, / Cui nasci tra lu munnu, certu mori, / E chiddu ch’avi a dari avi a pagari. (libru terzu, p. 188) Quannu l’ossu c’è, la carni veni / Quann’era affrittu ’ntra ddi lochi strani, / Pruvai l’amaru, li cchiù crudi peni, / Abbannunatu, e sulu comu un cani / Non potti mai vidiri umbra di beni; / Ma dicia li mei spranzi un su lontani, / E stu pinseri in vita mi manteni / Su magru è veru, ma l’ossa su sani, / E quannu l’ossu c’è, la carni veni. (libru quartu, p. 211) Avìa novantanovi mali, vinni vaddaredda e fici centu / Iu vi lu juru pri lu megghiu Santu, / Chi tra l’angustii mei non appi abbentu, / Tr’amarizzi tra
CAPITOLO II – Lo stridore e l’armonia
177
palpiti e tra scantu, / Non appi paci chi fussi un mumentu: / Ma un jornu mentri la passava in chianti, / Iu cascu ’nterra, cripari mi sentu; / Novanta-novi mali «iu cridu intanto / E vinni vaddaredda e fici centu. (sic, senza virgolette di chiusura, N.d.A.; ibidem) Mortu lu cani finisci l’arraggiu / Rutti li roti finisci lu roggia; / Fatta la paci finisci l’ostaggiu; / Cadutu un muru finisci l’appoggiu; / Mortu un Ministru finisci l’omaggiu; / Falluta ’na lucanna un c’è cchiù ortaggiu; / Finitu un signuriu finìu lu sfoggiu; / Mortu lu cani finisci l’arraggiu. (ivi, p. 237) Nei Mal confluisce dunque lo sperimentalismo fonetico–sonoro
infernale avviato fin da Storia di una capinera e giunto a perfe-zione o quasi in RM3, ma esso è bilanciato da altre fondamentali esperienze, forse compiute dopo RM(1–3) per sfociare infine nel romanzo. In filigrana traspare nitidamente che all’altezza dei Mal vi è stata l’acquisizione, nel bagaglio di Verga, della capacità di elaborare e modellare agglomerati fonetico–sonori aggraziati, dol-ci, melodiosi. Quando prende a scrivere Mal, lo scrittore ha effet-tuato anche una ricerca molto accurata sui suoni diafani e lievi e sul modo o di renderli preponderanti in certe porzioni di testo op-pure di mischiarli a quelli prevalentemente aspri e gracchianti all’interno di una medesima porzione di testo. La raccolta di Rapi-sarda è stata un punto di riferimento utilissimo anche per questa seconda ricerca, nel senso che essa ha fornito a Verga il modello melodioso e stridulo, dissonante e musicalmente soave da tener presente e da imitare attraverso parole perfettamente toscane e ita-liane. In maniera analoga, la raccolta di Rapisarda si era prestata alla ricerca di espressione mimetica, per RM, attraverso parole to-sco–italiane, dei suoni precipuamente aspri del dialetto catanese e siciliano9.
Si può enucleare così la principale domanda alla quale il presente studio tenterà di dare risposta: in quale testo da lui composto antece-dentemente ai Mal Verga si esercitò in una ricerca e riproduzione si-stematica, mediante parole tosco–italiane, dei suoni dolci, musical-
9 Per una esemplificazione di testi a carattere prevalentemente aspro e gracchiante tra
quelli inseriti da Rapisarda nella sua raccolta cfr. il mio volume Dai suoni al simbolo, cit., pp. 130–131.
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle 178
mente diafani, soavi, frammisti a quelli di segno opposto? E ammesso che una siffatta ricerca e i suoi esiti vi siano stati, e che sia dato reperi-re il testo in cui essi si sono principalmente sostanziati, presso quale autore o quali autori della letteratura e poesia italiana Verga rinvenne un repertorio di suoni armoniosi dalla ricchezza paragonabile a quella del repertorio di suoni aspri fornitogli da Inf?
Lo si ribadisca e lo si specifichi in maniera più esauriente: l’assetto fonetico–sonoro “misto”, per ora invero solo postulato, dei Mal risiede nella insistita e magistralmente conseguita mescolanza, inerente il li-vello dei puri significanti, di dolcezza e durezza, armonia e stridore, asprezza e sonorità diafana; codesto assetto trova a parer mio fortissi-me ragioni nel contenuto dell’opera; costituisce cioè un momento e-spressivo sommamente adeguato ai nuclei tematici propulsivi da cui si genera il testo a alla complessiva “significazione” di questo. I Mal si sottraggono in notevole misura, infatti, alla visione puramente “infer-nale” del mondo. Nel romanzo si fronteggiano e si bilanciano senza che la visione pessimista del mondo giunga a sopraffare le note positi-ve , da un lato la tenacemente operosa, semplice, costruttiva attività umana e l’inclinazione umana ad affetti radicati, teneri, duraturi, e dall’altro lato la cupidigia, l’istinto di sopraffazione e la tendenza u-mana al facile godimento edonistico. Le dolorose sciagure, materiali e morali, che si abbattono sulla famiglia e in particolare quelle pro-vocate dal tralignamento di ’Ntoni sono cautamente mitigate dal ri-scatto materiale e morale cui è affidata la chiusa del romanzo (Alessi, il più giovane dei nipoti di padron ’Ntoni, riesce a ricomprare la casa del nespolo e a restituire rispettabilità alla sua famiglia). I Mal sono, per così dire, un’opera dall’andamento e dalle conclusioni stricto sen-su dialettici.
Sono pressoché estranei agli interessi del presente studio gli aspetti grammaticali, sintattici e lessicali inerenti la lingua del Verga verista e le varie forme della geniale e peculiare erlebte Rede dei Mal, nei quali tutti gli abitanti di Aci Trezza sono personaggi e narratori. Quanto al lessico, mi restringo a ricordare che sia in Vita dei campi sia nelle Ru-sticane Verga si avvale sempre (con l’eccezione di “sciara”) di parole rigorosamente toscane e dunque impeccabilmente italiane. A proposi-to delle questioni di organizzazione e struttura della narrazione, è suf-ficiente rammentare che in Mal esiste un narratore pseudo–popolare, il
CAPITOLO II – Lo stridore e l’armonia
179
quale talora assume da solo la responsabilità della narrazione, ed esi-ste anche il fitto parlottio di un coro paesano che non coincide con la suddetta voce narrante.
Do come accertato e universalmente noto che la formidabile inno-vazione sintattica dei Mal talché la lingua del romanzo pare altra cosa rispetto a quella delle novelle risiede eminentemente in due fattori: 1) nell’uso massiccio dell’erlebte Rede; 2) nell’avere imitato per la lingua della narrativa la sintassi propria della lingua italiana par-lata, ancorché l’autore si avvalga in modo insistito di alcuni tratti sin-tattici che qualificano il siciliano municipale10. Quanto al lessico dei Mal, è mutuato esso pure dal toscano, esigua essendo la frequenza di vocaboli siciliani non comprensibili al lettore italiano provvisto di una certa istruzione. Verga doveva riuscire a rendere più marcata e più densa la patina sicilianeggiante del suo romanzo coniando una lingua (una sorta di idioletto) che mimasse non solo il siciliano municipale ma soprattutto quello parlato a Catania (scarsissime le inserzioni dia-lettali in senso stretto). Questa problema egli si era già posto parzial-mente, risolvendolo in maniera efficace, nelle novelle antecedenti i Mal e soprattutto in RM(1–3). Ai fini della soluzione del problema, la strutturazione del livello fonetico–sonoro riveste anche nel romanzo un’importanza nulla di meno che essenziale.
3. Sulla lingua dei Malavoglia come impasto splendido di armonia e di stridore La gente, i ceti sociali, rappresentati in Vita dei campi, nelle Rusti-
cane e nel romanzo sono per lo più i medesimi, senza apprezzabili dif-ferenze, e sono gli umili e gli umilissimi, le plebi siciliane della cam-pagna e del mare; salvo che nei Mal i pescatori sono i principali pro-tagonisti, i contadini, i braccianti, i muratori e i carrettieri (con i picco-li proprietari terrieri) li affiancano, mentre sono assenti i pastori11. Nondimeno il registro stilistico che qualifica Mal è, in taluni non po-
10 Si pensi all’insistito uso verghiano del chè posto a mimare il “ca” polivalente siciliano, mediante il quale si stringono legami sintattici irrazionali.
11 Vi sono poche eccezioni: la più rilevante è costituita dalla novella Di là del mare, ac-colta tra le Rusticane, i protagonisti della quale appartengono al “mondo di lusso”.
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle
180
chi luoghi, a causa dell’assai maggiore densità, rispetto alle novelle, di parole ed espressioni basse e plebee, decisamente più popolaresco (a tratti sguaiato) rispetto a quello delle novelle: «e la domenica [Lola] si metteva sul ballatoio colle mani sul ventre»12; «comare Piedipapera e la cugina Anna le vennero incontro, colle mani sul ventre» (Mal, p. 47); «il vignaiuolo, il quale era ricco come un maiale, dicevano, e a-veva una figliuola in casa»; «ci beve nel brago, e c’ingrassa come un maiale!»13; «lui è ricco come un maiale» (Mal, p. 17), «tu lo ingrassi meglio di un maiale» (ivi, p. 280); «tutti quelli che sapevano la storia di Don Alfonso gli ridevano sul naso» (Je, p. 41); «la tromba dei sol-dati che suonava come un gallo che sappia le ore, e metteva in rivolu-zione tutto»14; «rideva a crepapancia con degli Ah! Ah! Ah! Che sem-brava una gallina» (ivi, p. 22); «e quando Gramigna udì la fucilata si mise a sghignazzare, e disse fra sé: Questa era per me »15; «sghi-gnazzò»16; «santo diavolone! voleva trargli fuori le budella dalla pan-cia, voleva trargli, a quel di Licodia!»17; «mormorava […] colle mani sulla pancia» (Mal, p. 88), «se no vi restano sulla pancia, come le cas-seruole vecchie» (ibidem), «sangue della madonna» (ivi, p. 279); «dargliela sul muso la sua sciabola» (ibidem), «e strillava e si strappa-va i capelli che lo volevano ridurre in camicia» (ivi, p. 94); «stava ad ascoltare colle spalle al muro e le mani in tasca, sputacchiando di qua e di là»18; «sputacchiare» (Mal, p. 281); «una di quelle giornate in cui i contadini si strappano i capelli dinanzi ai campi “bruciati”»; «E alla sorella che strillava e si strappava i capelli, Santo per rabbonirla tor-nava a dire:»19. Giova ribadirlo: si rileva nei Mal maggiore densità e
12 G. VERGA, Cavalleria rusticana, in Id., Tutte le novelle, cit., vol. I, p. 180. 13 La prima citazione riferita nel testo si legge ivi, p. 181 e la seconda nella novella Pento-
laccia, in G. V., Tutte le novelle, cit., vol. I, p. 211. 14 G. V., Cos'è il re, (nelle Novelle Rusticane), ivi, p. 227. 15 G. V., L’amante di Gramigna, ivi, p. 196. 16 Si segnalano nei Mal undici ricorrenze del verbo “sghignazzare” («sghignazzava»,
«sghignazzando», «sghignazzavano» ecc.), a fronte di una sola ricorrenza in Vita dei campi e nelle Rusticane.
17 G. V., Cavalleria Rusticana, cit., p. 179. 18 G. V., Pane nero, (nelle Novelle rusticane), in Id., Tutte le novelle, cit., p. 290. 19 La prima citazione si legge in G. V., Guerra di santi, cit., p. 205 e la seconda in Pane
nero, cit., p. 293.
CAPITOLO II – Lo stridore e l’armonia
181
frequenza delle espressioni anzidette, le quali come si è notato ri-corrono tal quali, ma assai meno fittamente, anche nelle novelle. La lingua dei Mal è cioè assai più vicina al registro plebeo rispetto a quel-la delle novelle. In queste le espressioni popolarescamente colorite e di registro basso costituiscono delle macchie nel contesto di una lin-gua media la quale, come non rifugge da alcuni tratti quasi scurrili, così si incorpora volentieri espressioni raffinate provenienti dalla lin-gua poetica aulica20.
Stridore, durezza, dissonanza possono essere (e nella lingua in senso stretto poetica sono sempre) elegantemente ricercati all’interno di una porzione di testo aulico. Si pensi alle descrizioni di duelli e battaglie, alla ricerca poetica di resa epica della sonorità propria del fragore delle armi ecc. Si pensi alla sensualità acre delle Petrose dantesche, resa con stile eloquente e aspro. In ogni tempo accade che parole aspre e dure dal punto di vista fonetico–sonoro siano del tutto estranee allo stile plebeo, “comico”. Invece le parole volgari e plebee sono quasi sempre avvertite dall’uditore–lettore sufficientemente e-sercitato e sensibile come sgraziate e pesanti dal punto di vista fone-tico–sonoro, ancorché questo uditore–lettore sia naturalmente in gra-do di coglierne e apprezzarne l’efficacia espressiva, di comprendere che stonata sarebbe in un determinato contesto (o testo) una parola meno sguaiata, che proprio la sguaiataggine è quel che ci vuole. La patina socio–semantica della parola influenza la ricezione acustica della mente. In altri termini: si avvertono come sguaiati e perciò stesso fonicamente sgraziati taluni vocaboli sol perché appartengono tradizionalmente al vocabolario plebeo: ci soccorre l’esempio di «muso» o «musi» in conflitto con «muse». Quando aggregati foneti-co–sonori identici a quelli delle parole plebee formano una parola tradizionalmente sentita come colta e raffinata non si avverte quasi mai effetto fonico gracchiante e sguaiato, ma al massimo una certa durezza o un leggero stridore. Si ponga mente p. e. a parole come “grumo” e “grugno”, ove il comune agglomerato gru– viene percepi-to in modo diverso dal lettore sensibile, avvezzo sia allo stile “comi-co” sia alla letterarietà raffinata. La seconda parola è avvertita come
20 Per alcuni approfondimenti cfr. il mio studio Dai suoni al simbolo, cit., in particolare
alle pp. 198–205.
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle
182
fonicamente più pesante e forse più sgraziata della prima, che pure le è fonicamente similissima. Mal a prescindere dalla forte difficoltà di comprensione, da
parte del lettore “medio”, della lingua ivi coniata dallo scrittore sono forse l’opera di Verga dal tratto linguistico in senso lato più sicilianeggiante; lo sono anche grazie alla magistralmente conse-guita mescolanza di dolcezza e durezza, di armonia e stridore, di asprezza e sonorità diafana. Dante, come s’è constatato, non si rife-risce a una ricerca linguistica del genere di quella che trova esito splendido nei Mal, sebbene Verga abbia tenuto in gran conto la le-zione teorica dantesca. Pertanto, cioè per non suscitare indebiti e-quivoci, rinuncio a definire “misto” l’assetto fonetico–sonoro del romanzo, ancorché l’espressione sia per se stessa calzante: per se stessa, vale a dire prescindendo dalle fortissime connotazioni dan-tesche legate alla «lenium asperorumque rithimorum mixtura». A mio avviso l’assetto fonetico–sonoro inerente il livello dei puri si-gnificanti (e i loro componenti nei Mal) è un sistema estremamente dinamico, mobilissimo e cangiante. Attraverso svolte talora, anzi spesso, marcate ma graduali e in altre occasioni invece brusche e rapidissime è espressa, sempre in relazione organica con i trapassi inerenti il sistema dei significati o dei contenuti, una straordinaria varietà di gradazioni fonetico–sonore schiettamente siciliane e an-che (specie nel registro dolce) schiettamente italiane. Ho seleziona-to sotto una serie di passi, tutti tematicamente rilevanti (o almeno tematicamente molto intensi per l’intensità della Erlebnis inerente i casi concreti e le reazioni dei personaggi) e corrispondenti a un campione di situazioni sufficientemente rappresentativo. Mi sono provata a dare una mappa dettagliata della conformazione fonetico–sonora di ciascuno dei tratti prescelti nella trascrizione dei tratti stessi. È un lavoro che può interessare pressoché soltanto i lettori particolarmente attenti al livello fonico–acustico della forma e-spressiva e i poeti professionali, mentre a chiunque altro parrà sommamente noioso. Senza loro danno, coloro che non apparten-gono alle dette due categorie possono limitarsi alla lettura del commento puramente narrativo ai Mal e a Je.
CAPITOLO II – Lo stridore e l’armonia 183
4. Alcuni criteri di registrazione degli effetti fonetico–sonori I luoghi (la topografia interna alla storia) nei quali o all’interno dei
quali si intrecciano conversazioni o sorgono i pensieri dei personaggi sono numerosissimi, e in un certo senso, avendo ciascun luogo il pro-prio genere di frequentatori abituali e ideali, in ciascun luogo ricorro-no anche, quanto alle conversazioni e ai pensieri dei personaggi, sfu-mature timbrico–linguistico–tonali peculiari, che sarebbe interessante analizzare partitamente (ma chi scrive purtroppo non ha ora la possibi-lità di svolgere un’analisi siffatta). Mi limito a elencare i luoghi più importanti: il sagrato della chiesa, l’interno della stessa, la piazza, il lavatoio, la riva del mare ove stanno all’asciutto barche e pescherecci (di cui la sciara è prolungamento ai limiti del paese e verso monte), l’interno della Provvidenza (ai remi di essa), l’interno di casa Malavo-glia, il ballatoio della stessa, la strada in fondo alla quale sta la casa del nespolo e sulla quale si affacciano anche le case della cugina An-na, di Nunziata, dei Piedipapera e di compare Alfio; l’uscio e l’interno della bottega dello speziale, la bottega del barbiere Pizzuto, la sgan-gherata taverna e il piccolo spazio a essa antistante ove lo zio Santoro chiede l’elemosina.
Il presente lavoro non ha carattere tecnicistico; esso presume un lettore che abbia interiorizzato le consuetudini e l’orizzonte normati-vo (non prescrittivo) della lingua italiana letteraria e della poesia ita-liana e abbia sviluppato la sensibilità a essi connessa: un lettore intri-so di gusto della lingua italiana. Ciò posto, enuncio preliminarmente alcuni criteri (discutibili) ai quali mi sono attenuta. 1) Tutti i mono-sillabi danno “oggettivamente” (non si può non usarli) un contributo rilevante all’assetto fonetico–sonoro. Sono stati contrassegnati con sottolineatura, in questo passo e in tutti gli altri che verranno recati successivamente, i monosillabi di cui l’autore si avvale in modo spe-ciale per il loro carattere lieve e diafano, incluse alcune preposizioni composte (–al–, –ce–, –ci–, –da–, –di–, –don–, –e–, –ei– [egli, N.d.A.], –gli–, –i–, –il–, –in–, –la–, –le–, –li–, –lì–, –ne–, –non–, –pel–, –se–, –si–, –un– e altri affini). 2) Alcuni gruppi fonetico–sonori, per lo più coppie, quali –me– o –sa– sono stati tenuti di con-to, sono cioè stati cioè inseriti in corsivo (o con sottolineatura) nella mappa come componenti a carattere fonicamente lieve quando sono
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle
184
collocati accanto ad altri suoni morbidi (ma–ni); quando sono invece collocati accanto ad aggregati asprigni non si è tenuto conto che dell’insieme, cioè di un piccolo significante (madre, non madre) o di una porzione di significante o di un gruppo di significanti contigui in cui suoni e aggregati asprigni e suoni e aggregati morbidi si amal-gamano in un certo senso neutralizzandosi a vicenda; altre volte, specie quando sono in marcata allitterazione o corrispondenza omo-fonica con aggregati vicinissimi, i gruppi morbidi sono stati segnalati come dolci ma si è contestualmente segnalato l’aggregato contiguo a carattere, almeno relativamente, duro (come Me–na); altre volte il fonema e lettera virtualmente duro viene riassorbito e “neutralizzato” dal piccolo contesto melodioso di cui fa parte, per esempio nel caso in cui ricorra in un significante ricco di vocali eufoniche contigue (quei). 3) Vi sono parole in grado di esercitare un intensissimo effet-to di suggestione psicologica per la connotazione o estremamente negativa o estremamente positiva che ne contrassegna intimamente il significato. Il lettore percepisce, per così dire, il suono del significa-to, non quello del significante. In questi casi non si è tenuto conto del carattere fonico relativamente duro (nel caso di connotazione po-sitiva: cuore, non cuore) né del carattere relativamente dolce (nel ca-so di connotazione marcatamente negativa: mala, malo, cioè Mala-voglia). 4) Intensissimo effetto psicologico esercitano sul lettore i diminutivi affettuosi; essi hanno in genere qualità fonetico–sonora morbida e tenera, ma, a prescindere da ciò, li si è sempre considerati come componenti che addolciscono (il lettore, ancora una volta, per-cepisce il suono del significato prima e piuttosto che quello del signi-ficante): –etta/–ette/–etti/–etto (fiaschetto), –ina/–ine/–ini/–ino (or-ciolino), –uccia (straduccia) ecc. Non sono stati equiparati a questi i diminutivi strettamente siciliani, come –uzza (Maruzza), perché il lettore italiano medio non ha familiarità con essi e ancorché ne in-tuisca spesso la funzione , non si lascia suggestionare dalla qualità semantica attribuendole mentalmente omogenea corrispondenza fo-nico–acustica.
CAPITOLO II – Lo stridore e l’armonia
185
5. Conversazioni nei luoghi frequentati da uomini Il primo passo da leggere concerne la descrizione di un normale
momento all’interno della taverna. A parte l’ostessa, Santuzza, gli av-ventori sono tutti uomini; e naturalmente, oltre a qualche brava perso-na che vi beve il bicchierino con gli amici nei giorni di festa, passa il tempo nella taverna la feccia del paesino. Il passo è a sonorità preva-lentemente dura e aspra. I gruppi di lettere in grassetto corrispondono alla morfologia dei sette tipi fondamentali di agglomerati fonetico–sonori mediante i quali Verga, sulla scia del Dante infernale, riproduce in italiano e anzi in toscano il tratto duro, cupo, stridulo del siciliano; i gruppi di lettere in corsivo marcano gli aggregati fonetico–sonori dol-ci e delicati, necessari, secondo la lezione stessa di Dante, a evitare l’impasse dei “suoni”; i numeri tra parentesi tonde corrispondono alla numerazione con cui in altra sede sono stati forniti elenco e descrizio-ne degli aggregati aspri e duri21.
Ne–lla bettola (6) di suor Marian–ge–la la Santuzza (1, 5) c’era folla: quell’ubbr–iacone (1, 5, 4) di Rocco (6) Spatu (1), il quale (4) vocia–va e sputava (1) per dieci; compare (4) Tino Piedipapera, mastro (3) Turi (1) Zu–ppiddu (1, 5), compare (4) Man–gia–carr–ubbe (4, 1, 5), don Michele (4) il bri–gadiere (3, 4) de–lle guardie (4) dogana–li (4), coi calzoni (4) dentro (3) gli stiva–li, e la pistola appesa (5) sul ventre (3), quasi do–vesse an–dare a caccia (4) di contr–abbandieri (4, 3) con quel tempaccio (2), e compare (4) Mariano Cinghialenta (4). Que–ll’ele–fa–nte di mastro (3) Turi (1) Zu–ppiddu (1, 5, 1) an–da–va distribuendo (3) per ischerzo (4) agli ami–ci dei pugni (1) che avrebbero acco–ppato (5, 6) un bue (1), come (4) se ci avesse ancora (4) in ma–no la ma–la–be–stia di ca–la–fato (4), e allora compare (4) Cinghialenta (4) si metteva a gridare (3) e bestemmiare, per far ve–dere che era uomo (1) di fegato (4) e carrettiere (4) (Mal, pp. 39–40). Le singole consonanti o i gruppi (coppie per lo più) di lettere in
corsivo corrispondenti ai suoni morbidi, sono stati reperiti in maniera per ora solo intuitiva; essi, sebbene siano quantitativamente numerosi, nel passo in oggetto, valgono ad alleggerire la pesantezza della sonori-tà stridula e dura (–ghi–, –stro–, –upp–, –stri–, –acco–, –oppa–, –uzz–,
21 Cfr. nota 6.
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle 186
–ubbr–, –gri– e così via), non a bilanciarla facendole da equilibrato contrappeso, come in altre zone del testo. A creare la pesantezza foni-ca contribuisce in notevole misura l’uso fitto della vocale –u–, sia a i-nizio che nel corpo, che alla fine di parola (questa qualità della –u– è quasi neutralizzata nell’articolo indeterminativo). Non è questione di “numero”, naturalmente, come se la quantità degli aggregati dolci fos-se inferiore a quella degli altri (il che davvero non è); è questione di intensità: gli agglomerati fonetico–sonori sono in questo tratto partico-larmente duri e striduli. Nel luogo succitato l’assetto aspro e grac-chiante costituisce il primo coerente sviluppo, nei Mal, di un espedien-te primamente e felicemente collaudato in RM: quello di attribuire massicciamente ai personaggi non tanto diminutivi ipocoristici, come in genere nelle altre novelle (Turi, Neli, Nino, Nanni, Masi ecc.) bensì soprannomi e nomignoli dalle componenti fonetico–sonore più che sgraziate e più che dure e stridule (necessariamente frammiste, come insegna Dante, ad aggregati morbidi, che non fanno spicco per se stes-si). In RM, a differenza che nel romanzo, nomi e nomignoli sono diret-tamente prelevati dalle Malebolge dantesche e soprattutto dalla zona dei barattieri e dei ladri, e contribuiscono in modo rilevante ad adden-sare un’atmosfera infernale22. Non è casuale che nel romanzo codesti nomi e soprannomi plebei coniati mediante agglomerati fonetico–sonori di matrice “infernale” ma indipendenti dall’Inferno quanto al significante nella sua totalità , vengano affastellati massicciamente soprattutto nelle scene ambientate all’interno della bettola. Trattasi di nomignoli e soprannomi popolareschi volgari sia nel significato sia nella sonorità dura e sguaiata; essi non sono dissimili da quelli che co-
22 Provengono da Inf, tra l’altro, tutti i soprannomi dei protagonisti di RM: «Malpelo»,
«mastro Misciu Bestia», «lo Sciancato», «Ranocchio». Questi nomignoli non si limitano a of-frire un contributo rilevante al prolungamento simbolico del significato letterale guidato, nel predetto racconto, eminentemente dalla relazione intertestuale con Inf. Essi adempiono altre due funzioni: concorrono, per un verso, ad abbassare alquanto, in virtù del loro carattere po-polaresco se non proprio plebeo, il registro stilistico, tendenzialmente medio; e per un altro verso concorrono a marcare, in non lieve misura, nel modo ricordato sopra nel testo, il livello fonetico–sonoro; le trentadue ricorrenze del soprannome “Ranocchio”, per esempio, offrono un contributo rilevante alla durezza di Rosso Malpelo. Identica funzione svolge, nella novella La Lupa, il nomignolo della figlia della protagonista: «Maricchia» (G. VERGA, La Lupa, in Id., Tutte le novelle, cit., vol. I). È da notare che i due personaggi in oggetto, Ranocchio e Ma-ricchia, antiteticamente alla greve durezza e pesantezza dei suoni che si sprigionano dal loro nome, sono creature innocenti, vittime, specie la seconda, dell’altrui cinico egoismo.
CAPITOLO II – Lo stridore e l’armonia
187
stituiscono nomi, nomignoli e soprannomi dei personaggi di RM. Nel-
la bolgia infernale dei barattieri, come si ricorderà, Malacoda assegna
come scorta a Dante e a Virgilio una pattuglia di Malebranche, dei
quali distintamente scandisce i nomi: Graffiacane, Libicocco, Barba-
riccia, Ciriatto sannuto, Draghignazzo ecc. Dante espressamente pensa
alla taverna: «Ahi fiera compagnia! ma ne la chiesa / coi santi e in ta-
verna coi ghiottoni.»: Inferno, XXII, 14–15. I soprannomi plebei dei
personaggi dei Mal sono similissimi a quelli dei demóni quanto alla
pesantezza e sguaiataggine fonica inerente il sistema dei puri signifi-
canti.
Un altro luogo in cui avvengono conversazioni tra soli uomini sono
i gradini della chiesa (qui sotto tra Piedipapera, padron ’Ntoni, padron
Fortunato Cipolla, e il fratello di Menico della Locca):
Lo zio Croci–fisso strilla–va come se gli str–appassero le penne mastre,
ma non bisogna badarci, perchè de–lle penne ne ha molte, il vecchio. Eh!
s’è lavorato! potete dirlo anche voi, padron ’Ntoni! ma per padron ’Ntoni
ei si sarebbe buttato da–ll’alto del fariglione, com’è vero Iddio! e a lui lo zio
Croci–fisso gli da–va retta, perchè egli era il mestolo de–lla pentola, una
pentola grossa, in cui bolli–va–no più di due–cen–to onze all’anno! Campa-
na di legno non sapeva soffiarsi il naso senza di lui. Il fi–glio de–lla Locca
uden–do parlare de–lle ricch–ezze de–llo zio Croci–fisso, il quale a lui gli
era zio davvero, perchè era fratello de–lla Locca, si sen–tiva gonfiare in petto
una gran tenerezza pel parentado. Noi siamo parenti, ripeteva. Quando
va-do a giornata da lui mi dà mezza paga, e sen–za vi–no, perchè siamo pa-
renti. Piedipapera sghignazzava. — Lo fa per tuo bene, per non farti ubbria-
care, e per la–sciarti più ricco quando creperà. (Mal, p. 18)23
23
Pare opportuno riferire due porzioni di conversazioni e di erlebte Rede che avvengono
nei due ambienti più importanti oltre a quelli in cui si tengono i colloqui in discorso diretto
oppure nell’indiretto libero sopra riferiti, e cioè dentro la chiesa e nella bottega dello speziale:
«La Santuzza scuoteva il capo, e diceva che mentre si è in chiesa non bisogna sparlare del
prossimo. “Chi fa l'oste deve far buon viso a tutti”, rispose la Zuppidda, e poi all’orecchio
della Vespa: La Santuzza non vorrebbe si dicesse che vende l'acqua per vino; ma farebbe
meglio a non tenere in peccato mortale massaro Filippo l'ortolano, che ha moglie e figliuoli.
Per me, rispose la Vespa, gliel'ho detto a don Giammaria, che non voglio più starci fra le Figlie
di Maria se ci lasciano la Santuzza per superiora. Allora vuol dire che l'avete trovato il mari-
to? rispose la Zuppidda. Io non l'ho trovato il marito, saltò su la Vespa con tanto di pungi-
glione. Io non sono come quelle che si tirano dietro gli uomini anche in chiesa, colle scarpe
verniciate, e quelli altri colla pancia grossa. Quello della pancia grossa era Brasi, il figlio di
padron Cipolla, il quale era il cucco delle mamme e delle ragazze, perchè possedeva vigne ed
oliveti. Va a vedere se la paranza è bene ammarrata; gli disse suo padre, facendosi la croce.
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle 188
Il tratto è a sonorità cangiante, ma danno principalmente il timbro gli aggregati gracchianti e aspri; gli aggregati morbidi e leggeri pre-valgono nella zona ove parla in discorso diretto il nipote dello strozzi-no, e hanno funzione ironica, servono ad accompagnare e ad accentua-re la stupidità del ragazzo, il quale si intenerisce al pensiero della pa-
Ciascuno non poteva a meno di pensare che quell'acqua e quel vento erano tutt’oro per i Ci-polla; così vanno le cose di questo mondo, che i Cipolla, adesso che avevano la paranza bene ammarrata, si fregavano le mani vedendo la burrasca; mentre i Malavoglia diventavano bian-chi e si strappavano i capelli, per quel carico di lupini che avevano preso a credenza dallo zio Crocifisso Campana di legno. Volete che ve la dica? saltò su la Vespa; la vera disgrazia è toccata allo zio Crocifisso che ha dato i lupini a credenza. “Chi fa credenza senza pegno, per-de l’amico, la roba e l'ingegno”» (Mal, pp. 42–43). «Lo zio Crocifisso se ne stava ginocchioni a piè dell’altare dell'Addolorata, con tanto di rosario in mano, e intuonava le strofette con una voce di naso che avrebbe toccato il cuore a satanasso in persona. Fra un’avemaria e l’altra si parlava del negozio dei lupini, e della Provvidenza che era in mare, e della Longa che rimane-va con cinque figliuoli. Al giorno d’oggi, disse padron Cipolla, stringendosi nelle spalle, nessuno è contento del suo stato e vuol pigliare il cielo a pugni. Il fatto è, conchiuse com-pare Zuppiddu, che sarà una brutta giornata pei Malavoglia. Per me, aggiunse Piedipapera, non vorrei trovarmi nella camicia di compare Bastianazzo» (ivi, p. 44). Ancora: «e don Fran-co voleva insegnare una maniera nuova di salare le acciughe, che l’aveva letta nei libri. Come gli ridevano in faccia, si metteva a gridare: Bestie che siete! e volete il progresso! e volete la repubblica! La gente gli voltava le spalle, e lo piantava lì a strepitare come un pazzo. Da che il mondo è mondo le acciughe si son fatte col sale e coi mattoni pesti. Il solito discor-so! Così faceva mio nonno! seguitava a gridare loro dietro lo speziale. Siete asini che vi manca soltanto la coda! Con gente come questa cosa volete fare? e si contentano di mastro Croce Giufà, perchè il sindaco è stato sempre lui; e sarebbero capaci di dirvi che non vogliono la repubblica perchè non l’hanno mai vista! Questi discorsi poi li ripeteva a don Silvestro, a proposito di certo ragionamento che avevano fatto a quattr’occhi, sebbene don Silvestro non avesse aperto bocca, è vero, ma era stato zitto ad ascoltare» (ivi, pp. 209–210). «Si sapeva poi che [don Silvestro, N.d.A] era in rotta colla Betta di mastro Croce, perchè il sindaco voleva farlo lei, e suo padre s’era lasciato mettere la gonnella al collo, talchè oggi diceva bianco e domani nero, come voleva la Betta. Egli non sapeva dir altro che: Il Sindaco son io, caspi-tina! come glielo aveva insegnato a dire a sua figlia, la quale appuntava i pugni sui fianchi parlando con don Silvestro, e gli rinfacciava: Vi pare che vi lasceranno menar sempre pel naso quel buon uomo di mio padre, per fare gli affari vostri e mangiare a doppio palmento? che perfino donna Rosolina va predicando che vi rosicate tutto il paese! Ma me non mi man-gerete, no! chè non ci ho la smania di maritarmi, e bado agli interessi di mio padre. Don Fran-co predicava che senza uomini nuovi non si faceva nulla, ed era inutile andare a cercare i pez-zi grossi, come padron Cipolla, il quale vi diceva che per grazia di Dio ci aveva il fatto suo, e non aveva bisogno di fare il servitore del pubblico per niente; oppure come massaro Filippo il quale non pensava ad altro che alle sue chiuse e alle sue vigne, e solo ci aveva prestato orec-chio quando s'era parlato di levare il dazio sul mosto. Gente vecchia! conchiudeva don Franco colla barba in aria. Gente buona pel tempo della camarilla. Al giorno d'oggi ci vo-gliono uomini nuovi. Adesso manderemo dal fornaciaio per farli fare apposta, rispon-deva don Giammaria. Se le cose andassero come dovrebbero andare si nuoterebbe nell'oro!
diceva don Silvestro: non diceva altro» (ivi, pp. 210–211).
CAPITOLO II – Lo stridore e l’armonia
189
rentela con un uomo tenuto in gran considerazione perché ricco, senza comprendere la crudeltà rapace di suo zio. Ancorché sia stata riferita una conversazione tra Compare Tino, l’usuraio e il fratello scemo di Menico, la persona che sta al centro del gruppo (e che prende la parola a tratti seppure non qui) è padron ’Ntoni, il personaggio che incarna il tipo virtuoso, il galantuomo plebeo dalle parole sempre misurate e mai volgari, il quale in questo momento, malgrado qualche nube già gli si addensi nel cuore, spera ancora vivamente in un esito felice dell’impresa che suo figlio sta conducendo sul mare. Lo strozzino e il sensale invece, i due personaggi forse più avidi, odiosi e disumani del romanzo sono sempre o immersi in– o circondati da– aggregati duri e stridenti.
6. Armonia e stridore, con speciale riferimento alle donne Le conversazioni tra sole donne avvengono qualche volta al lava-
toio e soprattutto nella strada in fondo alla quale sta la casa del nespo-lo e sulla quale si affacciano le case della cugina Anna, della Nunzia-ta, di Alfio Mosca. Il fitto parlottio tra le comari verte su argomenti futili, sulle piccole cose ordinarie e fastidiose della vita quotidiana. Sarebbe però errore grave credere che Verga si compiaccia di ripro-durre la quotidianità insulsa e banale come se essa abbia per se stessa interesse narrativo o abbia per se stessa il diritto di essere narrata. Ve-diamo:
Comare Grazia Piedipapera, se–nt–endo che ne–lla strada c’era conversa-zione, si affacciò anch’essa sull’uscio, col grembiule gonfio de–lle fa–ve che stava sgu–sci–ando, e se la pigliava coi topi che le ave–va–no bucherellato il sacco come un colabrodo, e pareva che l’a–vessero fatto apposta, come se ci avessero il giudizio dei cristiani; così il discorso si fe–ce ge–ne–rale, perchè alla Maruzza glie–ne ave–va–no fatto tanto del da–nno, quelle bestie scomu-nicate! La cugi–na An–na ne ave–va la casa piena, da che gli era morto il ga-tto, una bestia che va–le–va tant’oro, ed era morto di una pedata di compare Tino. I ga–tti grigi sono i mi–gliori, per acchi–appare i topi, e andrebbe-ro a scovarli in una cr–una di ago. (Mal, p. 24) Anche questo tratto è cangiante; vi prevale tuttavia una sonorità
più morbida che in quelli precedenti, malgrado la non lieve compo-
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle 190
nente asprigna, che riflette lo stato d’animo prevalente della Piedipa-pera, il quale si estende immediatamente alle comari, tutte, come la Piedipapera, adirate per i danni provocati alle loro masserizie dai to-pi, che maledicono. Nondimeno, sia le inserzioni del narratore che mette in scena le donne e descrive particolari della scena, sia il chiacchierio delle donne tra loro, proprio perché si tratta delle donne più garbate del romanzo (fatta salva l’assenza di Mena e di Nunziata, che stanno per arrivare) ha conformazione timbricamente se non ag-graziata, quasi aggraziata. Siamo lontani dal tratto fonetico–sonoro prevalente nei discorsi tra soli uomini dianzi riferiti. A testimonianza del fatto che questi effetti sono intenzionalmente ricercati dall’autore si nota l’uso, dapprima, dell’espressione «Comare Grazia Piedipape-ra» invece di «Comare Grazia»: ciò imprime immediatamente al tes-suto cangiante del discorso la risonanza asprigna di cui si è detto. Ri-corre alcuni righi più sotto, per indicare il marito dell’ottima Grazia, la formula compare Tino, quasi morbida fonicamente; l’uomo, un furfante, è per lo più menzionato dalla voce narrante (che sicuramen-te esprime mentalità maschile) e dal coro paesano come Piedipapera e basta (sguaiato il soprannome, come il suo animo, goffa l’andatura, come il suo corpo). È la cugina Anna a usare nell’indiretto libero la formula «compare Tino», anche al fine di marcare il carattere fami-liare della conversazione tra amiche che sogliono radunarsi abitual-mente.
Subito dopo la conclusione dell’ultima conversazione riferita si mostra Mena, la quale probabilmente spera di vedere, come il con-testo lascia intuire, compare Alfio, l’uomo da lei amato in segreto, che si trova in casa propria. La trascrizione della realtà prosaica immediata, delle chiacchiere innocue e prive di importanza delle donnette, è un modo mutuato dalla tecnica teatrale della commedia per preparare la rivelazione delle due grandi storie di vero amore del romanzo e l’ingresso sulla scena delle due coppie di amanti. Dapprima arrivano la Nunziata e Alessi (il quale è già palesemente innamorato della fanciulla ed è il suo principale sostegno affettivo e materiale). Le vicine accolgono festosamente e quasi con gioia sia Mena dalla quale sempre si sprigionano grazia e soavità che Nunziata, la personalità della quale è contrassegnata da allegria e bontà. La conversazione prosegue, malgrado le donne, e soprattutto
CAPITOLO II – Lo stridore e l’armonia
191
Nunziata, siano affaccendate. Ora, però, la compresenza dei quattro personaggi giovani più virtuosi e amabili del romanzo uno, Al-fio, silenzioso e non visibile crea un’atmosfera gentile, su cui aleggia l’amorevolezza: tale atmosfera trova puntuale riscontro nell’assetto fonetico–sonoro di questa seconda fase della conversa-zione, assetto nel quale diventano gradualmente più fitti gli aggre-gati dolci, e altri espedienti inerenti la costruzione sia del signifi-cante che del significato. Viene specificamente costruito un clima affettuoso in tutti i livelli della compagine espressiva. Si leggano almeno alcuni luoghi del passo:
Le vi–ci–ne ave–va–no fatto come le lu–mache quando piove, e lungo la straduccia non si udi–va che un continuo chi–acchierio da un uscio all’–altro. Persi-no la fi–nestra di compare Al–fio Mosca, quello del carro de–ll’asi–no, era aperta, e ne usci–va un gran fumo di gi-nestre. La Me-na ave–va la–sciato il telaio e s’era affacciata al ballatoio anch’essa. Oh! Sant’Agata! esclamarono le vi–ci–ne; e tutte le fa–ce–va–no festa. […] In questo mo–me–nto si udì un fruscìo di frasche per la via, e arrivarono Alessi e la Nunziata, che non si ve–de–va–no sotto i fa–sci di gi–nestre, tanto erano pic–ci–ni. Oh! la Nunziata! esclamarono le vi–ci–ne. Che non ave–vi paura a quest’ora ne–lla sciara? C’ero anch’io, rispose A-lessi. Ho fatto tardi con comare Anna al la–vatoio, e poi non ci ave–vo legna per il focolare. La ragazzina accese il lu–me, e si mi–se lesta lesta ad apparecchiare ogni cosa per la ce–na, mentre i suoi fratelli–ni le an–da–va–no dietro per la stanzuccia, che pareva una chioccia coi suoi pu-l-ci-ni. Alessi s’era scaricato del suo fa–scio, e sta-va a guardare da-ll’uscio, serio serio, e colle ma–ni ne–lle tasche. O Nunziata! le gridò Me–na dal ballatoio; quando avrai messo la pentola a bollire, vieni un po’ qua. Nunziata la–sciò Alessi a custodire il focolare, e corse ad appoll–aiarsi sul ballatoio, accanto alla sant’Agata, per godersi il suo riposo an-che lei, colle ma–ni in ma–no. (ivi, pp. 28–29)
La selezione degli aggregati a sonorità lieve e tenera è stata fat-
ta alla buona, con empirismo e “navigando a vista”; va da sé che sebbene le letture critiche fondate sull’applicazione di metodologie rigide non di rado soffochino e stritolino la sintassi lirica e le paro-le poetiche, non sempre si può evitare di ricorrere a qualche classi-ficazione e nomenclatura tecnicistica, perfino a quelle legate agli “specialismi” di moda; fortunatamente se ne può fare a meno in questa sede. Sopra sono state talora demarcate coppie di lettere
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle
192
coincidenti con la scansione sillabica. Checché sia di ciò, il tratto presenta forma dei suoni nitidamente dolce, a suo modo popolare-scamente melodiosa. Questo si conviene alla raffigurazione di sen-timenti d’amore timidi e casti seppure assai coinvolgenti. Ma con-viene continuare a sondare l’impasto fonetico–sonoro del romanzo.
7. Sensazione e realtà del naufragio nel livello fonetico–sonoro I tre luoghi riferiti sotto sono un trittico. Essi fanno parte delle ul-
time pagine del capitolo III. I primi due tra essi sono contigui e sono congiunti alla terza porzione di testo con la quale il capitolo si chiude , da un passo che presenta interesse espressivo non minore ma in un certo senso subordinato. Siamo in presenza di un sapientis-simo crescendo, il cuore del quale naturalmente sta al centro (nel se-condo passo). Ivi prevalgono le “dolenti note”, sommesse, quasi foni-camente tremule: all’urlo del mare, che tutti percepiamo (trattasi di classica onomatopea), fanno riscontro il pianto della bambina e le chiacchiere apparentemente innocue e tranquille delle comari, rese con particolare intenerimento del registro fonetico–sonoro. Nel primo pas-so si stringe il nodo, nel secondo avviene la catastrofe, ivi annunciata in maniera indiretta, nel terzo vi è lo scioglimento, perché la catastrofe vi si palesa esplicitamente e in tutta la sua tremenda portata:
Il fi–glio de–lla Locca, che era lì fuori colle ma–ni in tasca perchè non ci ave–va un sol–do, disse anche lui: Lo zio Croci–fisso è an–dato a cercare pa-dron ’Ntoni con Piedipapera, per fargli con–fessare da–va–nti a testimo–ni che i lupini glie–li ave–va dati a credenza. Vuol dire che anche lui li ve–de in pe-ricolo colla Provvidenza . Colla Provvidenza c’è an–dato anche mio fra-tello Me–nico, in–sie–me a compare Bastianazzo. Bravo! questo di–ce–va–mo, che se non torna tuo fratello Me–nico tu resti il barone de–lla casa. C’è an–dato perchè lo zio Croci–fisso vole–va pagargli la mezza giornata anche a lui, quando lo man–da–va co–lla paranza, e i Malavoglia in–ve–ce glie–la pa-gavano in–tiera; rispose il fi–glio de–lla Locca senza capir nu–lla; e come gli altri sghignazzavano rimase a bocca aperta. (Mal, p. 46)
Sull’imbrunire comare Maruzza coi suoi fi–gli–uol–etti era an–data ad aspet-tare sulla sciara, d’on–de si scopriva un bel pezzo di mare, e uden–do–lo ur-lare a quel modo trasa–li–va e si gr–attava il capo senza dir nul–la. La
CAPITOLO II – Lo stridore e l’armonia 193
picc–ina pian–ge–va, e quei poveretti, di–menticati sulla sciara, a quell’ora, pareva–no le ani–me del purgatorio. Il pian–gere de–lla bambina le fa–ce–va ma–le al–lo stomaco, al–la povera don–na, le sembrava quasi un malau–gurio; non sapeva che in–ventare per tranquillarla, e le cantava le canzon–ette colla voce tremola che sapeva di lagrime anche essa. Le comari, mentre torna–va–no da–ll’osteria, coll’orciol–ino de–ll’olio, o col fiaschetto del vi–no, si ferma–va–no a barattare qualche parola con la Longa senza aver l’aria di nu–lla. (ibidem; nel testo della edizione critica la parola «sciara» è in ca-rattere corsivo) Di–nanzi al balla–toio de–lla sua casa c’era un gr–uppo di vi–ci–ne che l’aspettava–no, e cicala–va–no a voce bassa fra di loro. Come la vi–dero da lontano, comare Piedipapera e la cugi–na An–na le ve–nnero incon-tro, colle ma–ni sul ventre, senza dir nu–lla. Allora ella si cacciò le un-ghie nei capelli con uno strido disperato e corse a rintanarsi in casa. Che disgrazia! di–ce–va–no sulla via. E la barca era carica! Più di qua-rant’onze di lupini! (ivi, p. 47) I due distinti gruppi di personaggi raffigurati nei due primi passi
conversano apertamente, oppure pensano solo mentalmente, senza verbalizzarlo, al pericolo che corrono il carico di lupini, la Provviden-za e l’equipaggio dell’imbarcazione. Gli oggetti di queste, diciamo, preoccupazioni, sono disposti secondo la successione corrispettiva alla gerarchia di valore che rivestono per i personaggi che conversano; l’ordine gerarchico va invertito o considerato simmetricamente nel caso del secondo gruppo di personaggi, quelli che confortano la Longa.
I personaggi del primo gruppo sono tutti uomini, che stanno sulla porta o che entrano nell’osteria (lo zio Santoro, Rocco Spatu, il figlio minore della Locca, Piedipapera). Cinicamente beffardi nei confronti del fratello scemo di Menico, imbarcato sulla Provvidenza con Bastia-nazzo, essi riferiscono circa il comportamento che in quel preciso i-stante sta tenendo lo strozzino. Questi, alieno di ogni forma di umana pietà, a fronte della sciagura imminente si è recato insieme al sensale da Padron ’Ntoni, la principale (insieme a Maruzza) vittima della scia-gura stessa, a tutti noto come galantuomo onestissimo e provvisto di forte senso dell’onore, per ottenere garanzie. L’assetto acustico–voca-lico–consonantico ha sonorità bilanciata. I numerosi gruppi dolci e me-lodiosi esprimono la pietà e l’intenerimento della voce narrante (e si conformano alla ovvia rezione impietosita dei lettori). La dolcezza fo-
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle 194
nica della tessitura fonetico–sonora cangiante, però, esprime fortissi-ma la propensione dell’autore a marcare fin d’ora quale tra tutti i per-sonaggi del romanzo sarà il più duramente e irreparabilmente marcato dalla tragedia: la Locca, subnormale quanto si vuole, ma attaccatissima ai due figli e soprattutto a Menico (–fi–, –gli–, –de–, –ll–, –ll–, –ci–, –va–, –an–, –fa–, –gli–, –da–, –van–, –glie–, –li–, –li–, –ve–, –de–, –in–, –an–, –da–, –di–, –ce–, –de–, –ll–, –in–, –ve–, –ce–, –glie–, –fi–, –gli–: ho prelevato e riferito qui solo gruppi inseriti all’interno di signi-ficanti complessivamente melodiosi o significanti monosillabici dol-ci). Non a caso, adottando un espediente appreso nel corso della ricer-ca sui suoni lievi e armoniosi condotta antecedentemente, l’autore fa ricorrere due volte nel tratto in questione la parola «figlio».
Tela assai cangiante si è detto: allo stesso passo imprimono il pro-prio timbro anche gli agglomerati gracchiante e duri (–cr–, –dr–, –pr–, –pr–, –br–, –cr–, –tr–; –occa–, –ezz–, –occa–, –sghi–, –azz–). Ciò non è casuale: l’autore mette qui in scena uccelli del malaugurio i quali os-servano con cinismo, da lontano, la sciagura imminente; e narrano che corvi e altri divoratori di animali feriti e di carogne si apprestano a fa-re scempio delle vittime della disgrazia (delle vittime che rimarranno vive, non di quelle che moriranno).
Nel secondo passo campeggia inizialmente Maruzza con i suoi fi-gli. Tra questi per la verità solo la piccola Lia è in qualche modo attri-ce sia pure con un ruolo modesto. Maruzza intuisce che la sciagura è inevitabile ma si impone sommessamente di sperare nell’impossibile miracolo. La sua forte angoscia latente si manifesta nelle sensazioni che in lei suscita la normale reazione di pianto della piccola Lia, spa-ventata dall’ansia che avverte nella mamma e in un certo senso co-stretta da questa a una semi–immobilità faticosa e snervante per un bambino. A Maruzza il pianto della bimba pare esso foriero di sventu-ra. Con l’aria di chi passa per caso accanto al gruppetto dei Malavo-glia, le donne rivolgono a Maruzza brevi buone parole, per esserle in qualche modo di conforto. La catastrofe non è ancora avvenuta, la Longa si sforza di credere che non avverrà. L’atmosfera complessiva è assai patetica, ma anche affettuosa e pregna di umana solidarietà, sep-pure già carica di dolore. L’autore, per addensare quanto più possibile codeste qualità espressive commette una curiosa, lieve forzatura, quel-la di scrivere dei figli di Maruzza come se fossero tutti bambini («fi-
CAPITOLO II – Lo stridore e l’armonia
195
glioletti»), laddove neppure Alessi, il minore e penultimo, è più tale propriamente, in un mondo come quello di Aci Trezza, dove i ragazzi-ni imparano molto in fretta a lavorare accanto agli adulti. L’impasto fo-netico–sonoro, ricco e vario, è qualificato da sicura prevalenza di suoni morbidi e teneri (–ll–, –fi–, –gli–, –uol–, –an–, –da–, –ll–, –de–, –si–, –di–, –li–, –e–, –il–, –an–, –cci–, –ge–, –va–, –di–, –men–, –ll–, –il–, –an–, –ge–, –ll–, –le–, –fa–, –ce–, –va–, –al–, –in–, –ll–, –ci–, –de–, –ll–, –vi–) con alcune non poche macchie a carattere dissonante (–br–, –uzz–, –pr–, –ur–, –gr–, –br–, –u–, –gu–, –tr–, –tr–, –gr–, –tr–). L’atmosfera gentile e solidale è ottenuta prevalentemente mediante un uso fitto di diminutivi affettuosi che spesso qualificano gli oggetti: –etti (figlioletti), –ina (piccina), –ette (canzonette), –ino (orciolino), –etto (fiaschetto). La voce narrante scrive, o dice, fiaschetto e orcioli-no come se oggetti e parole avessero la possibilità di accarezzare e confortare la madre e i suoi figli (soprattutto lei).
Se lo scarto tra il timbro del primo e quello del secondo passo è for-te ma non è né brusco né repentino, rapido e brusco è quello tra il se-condo e il terzo, appunto perché nel secondo l’atmosfera era divenuta tanto intenerita. In questo terzo passo campeggia ancora Maruzza, e intorno a lei o vicino a lei, le donne. Consapevole ormai dell’avvenuta sciagura, la moglie di Bastianazzo lascia che la sua angoscia, almeno per un istante, erompa infine tremenda, senza più essere trattenuta a forza nel subcosnscio. Le donne non osano neppure confortare la ve-dova, che ora vuol solo sottrarre alla vista altrui il proprio strazio. Il passo ha assetto fonetico–sonoro composito e a chiazze, con marcata presenza di suoni striduli e gutturalmente duri (–gr–, –upp–, –u–, –ghie–, –stri–, –sgra–).
8. Le donne, la disgrazia, la follia e il tessuto fonetico–sonoro can-giante A prevalenza stridula e aspra è la sonorità dei passi in cui compare
il personaggio più tragico del romanzo: la mamma idiota resa folle dalla morte del figlio Menico. Ciò si nota in particolare nel secondo passo, in cui sono messi a frutto gli aggregati infernali che avevano dato il tratto a RM: –occa–, –pr–, –cr–, –tr–, –app–, –cr–, –stri–, –u–,
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle
196
–gu–, –ecca–, –accio– (sull’effetto psicologico del suffisso peggiora-tivo mi sono già soffermata sopra). La sonorità anzidetta, costruita mediante felicissimi accostamenti degli agglomerati nei significanti (e costante attenta commistione di suoni striduli e gracchianti e suoni li-quidi e morbidi, sempre prevalenti, questi, sul piano quantitativo) è la sola possibile in un contesto in cui sia divenuto folle e stia delirando un personaggio dalla infima estrazione sociale. Verga l’aveva già par-zialmente sperimentata, in maniera costà non convincente, in un ro-manzo d’ambiente borghese, Storia di una capinera, e segnatamente nelle pagine conclusive: suor Maria, innamorata del fidanzato della sorella, a partire dal momento in cui la sua monacazione forzata divie-ne fatto compiuto e irrevocabile, comincia a dare segni sempre più pe-santi di squilibrio fino a precipitare nella follia per poi morirne. Ancor più che a suor Maria, la Locca è vicina alla Ecuba divenuta folle e rabbiosa che Dante presenta nel canto XXX di Inf; questa Ecuba è un personaggio a Verga carissimo e da lui variamente imitato nell’opera propria (per raffigurare il dolore disperato di Malpelo e poi quello di padron ’Ntoni dopo la definitiva rovina morale, oltre che materiale, della sua famiglia)24:
Maruzza si tappava le orecchie colle ma–ni per non sentire la Locca che si era appollaiata sul ballatoio, dietro l’uscio, e strilla–va da–lla mattina, con quella voce fessa di pazza, e pretendeva che le restituissero loro il suo fi–gli–uo–lo, e non vole–va sentir ragione. (Mal, p. 61) e la Locca che gironzava se–mpre da quelle parti, perchè le ave–va–no de–tto che il suo Me–ni–co era an–dato ne–lla barca dei Malavoglia, e crede–va che do–ve–sse trovarlo ancora là, appena ve–de–va suo fratello Croci–fisso, le–va–va le strida al pari di un ucce–llaccio del malau–gurio, e gli smuove–va la bi–le anche lei. Questa qui mi fa far peccato! borbottava Campana di legno. (ivi, p. 67) Quando il medesimo personaggio, la Locca, è invece oggetto di
considerazioni in apparenza oggettive, dalle quali si sprigiona una so-ave nota patetica, l’assetto fonetico–sonoro, misto come sempre, rice-ve il tratto specialmente dagli aggregati melodiosi, e il sistema dei si-
24 Cfr. il mio volume Dai suoni al simbolo, pp. 45–46 e 220–225.
CAPITOLO II – Lo stridore e l’armonia
197
gnificanti viene molto sapientemente organizzato all’interno di propo-sizioni coordinate brevi e pausate, dall’andamento musicalmente sem-plice, le quali ricordano il mormorio e la cadenza lieve delle onde che giungono a riva nella calma del mare:
A certe cose ci pen–sa–no se–mpre soltanto i vecchi, quasi fosse stato ieri tanto che la Locca era se–mpre lì da–va–nti alla casa dei Malavoglia, seduta contro il muro, ad aspettar Me–nico, e voltava il capo di qua e di là per la straduccia, ad ogni passo che senti–va. (ivi, p. 74; ad a[spettar] è stato tratta-to come aggregato omogeneo, poiché tale risulta alla lettura sia mentale che orale) Checché sia di ciò, il passo or ora riferito reca tre soli agglomerati
di quelli marcatamente duri o striduli: –ecchi, –occa, str–: e la qualità dissonante di quest’ultimo è attenuata in maniera rilevante dalla forte suggestione psicologica che esercita il diminutivo affettuoso –uccia. Le –c– palatali, le –n–, le –m– le –l–, le –v– e le –s– seguite da vocale capace di valorizzarne il suono aggraziato prevalgono nettamente. Pe-raltro anche il primo dei tre passi relativi alla Locca che si sono riferi-ti, chi ben guardi, impressiona perché la follia della sventurata, e l’effetto emotivamente sgradevole esercitato su Maruzza dalle urla de-liranti di quella, vi sono descritti a tinte forti nel livello del significato letterale. Il livello fonetico–sonoro è contrassegnato senza dubbio da un più fitto ricorrere di aggregati marcatamente duri e striduli (–app–, –ecchi–, –occa, –app, str–) rispetto al terzo; però vi sono frammisti con forte effetto di bilanciamento, molti aggregato morbidi e lievi: ba-sti osservare che vi ricorre sei volte la –l– raddoppiata e una volta il dolcissimo –gli–. Dei tre luoghi, come si è già scritto, quello dall’as-setto più duro e gracchiante è il secondo; lo è anche perché vi compare da ultimo la figura dell’usuraio, metaforicamente del corvo, se è con-cesso continuare a usare questa espressione (non a caso l’aggregato cr– ricorre due volte in pochissimi righi).
9. Le tonalità lievi come maschera Rapidi cambiamenti nel registro fonetico–sonoro si verificano an-
che nelle conversazioni tra i personaggi maschili: sia perché interven-
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle
198
gono ragioni affettive autentiche che spingono il personaggio, even-tualmente, a usare toni più teneri e miti, abbandonando quelli aspri; sia per ragioni di mera opportunità e convenienza materiale dei prota-gonisti, come nei due passi contigui che si riferiscono separatamente sotto, in cui la fa da attore protagonista l’usuraio:
I Morti non sono ancora venuti, rispondeva Piedipapera gesticola–ndo;
abbiate pazienza. Volete su–cchiargli il sangue a padron ’Ntoni? Già non a-vete perso nu–lla, perché i lupini eran tutti fradi–ci, lo sapete! Ei non sapeva nu–lla; sapeva soltanto che il sangue suo era ne–lle mani di Dio. E i raga–zzi dei Malavoglia non osava–no giocare sul ballatoio quando egli passava da–vanti alla porta di Piedipapera. E se incontrava Al–fio Mosca, col carro de–ll’a–si–no, che gli fa–ce–va di berretto anche lui, colla fa–ccia tosta, si senti-va bollire il sangue, per la ge–lo–sia de–lla chi–usa. Mi ucce–lla la nipote per portarmi via la chi–usa! borbottava con Piedipapera. Un fa–nnu–llone! che non sa far altro che an–dare attorno col carro de–ll’a–si–no, e non pos-sie–de altro. Un morto di fa–me! Un birbante che le dà ad intendere d’essere innamorato del suo gru–gno di porco, a quella bru–tta strega di mia nipote, per amor de–lla roba. (Mal, pp. 67–68) Le porzioni di testo che precedono la chiusa hanno timbro misto e
per certo non particolarmente duro: il sensale cerca di ammorbidire lo strozzino, e sia pure senza successo. Quanto ai personaggi che si na-scondono alla vista dell’usuraio, o che, ignari della collera di questo, lo salutano anzi educatamente, sono le figure più gentili del romanzo: i ragazzetti di casa Malavoglia, Alfio Mosca. Dunque, ancorché lo zio Crocifisso sia il personaggio dominante, il registro fonetico–sonoro si impregna di note miti e dolciastre. Nella esplosione di rabbia che con-clude il passo, invece, lo strozzino lascia trapelare senza reticenze la sua indole e si lascia immergere in una sonorità intensamente stridula e gracchiante, acuita dal registro stilistico–lessicale acremente plebeo.
Nel passo sottostante, al fine di conseguire uno dei suoi cupidi fini, quello di evitare che la chiusa della nipote possa essergli sottratta da un eventuale matrimonio di questa con compare Alfio (trattasi di strategia attuata dalla nipote, all’insaputa di Alfio, al fine di ingelosire lo zio), l’usuraio si fa mellifluo e piagnucoloso, impetrando l’aiuto di un al-tro dei personaggi meramente “economici” (meramente attaccati al denaro). L’assetto fonetico–sonoro è leggero e quasi melodioso, in virtù, ancora una volta, della sapiente scansione delle proposizioni,
CAPITOLO II – Lo stridore e l’armonia
199
organizzate secondo un ritmo pausato che ricorda quello di semplici versi sciolti popolareschi o delle fiabe popolari: un ritmo vagamente cantilenante, analogo a quello dell’ultimo dei passi succitati relativi al-la sorella demente dello strozzino. È da tenere ben fermo, dunque, che brevi tratti ad assetto fonetico–sonoro melodioso e gentile possono es-ser tali perché fungono da supporto a un “contenuto” (senso letterale) menzognero. La compagine espressiva allora, per conseguire al con-tempo l’effetto rappresentativo ingannevole e la demistificazione di esso (la rivelazione dell’inganno) deve essere in grado di mettersi una maschera, che abbastanza facilmente venga percepita come tale: per questa ragione il capoverso immediatamente precedente la com-pagine in oggetto si chiudeva con una invettiva contro Alfio e la Ve-spa, volgare e violenta nel contenuto (senso letterale), e nelle com-ponenti acustico–vocalico–consonantiche, aggressiva, gracchiante, stridula. Si legga il passo in cui l’assetto fonetico–sonoro funge da maschera:
E quan–do non ave–va altro da fare an–da–va a piantarsi da–va–nti all’osteria de–lla Santuzza, accanto allo zio Sa–ntoro, che se–mbrava un al-tro poverello come lui, e non ci an–da–va per spendere un sol–do di vi–no, ma si metteva a guaio–lare come lo zio Sa–ntoro, tale quale come se chiedes-se la limosi–na anch’esso; e gli di–ce–va: Sentite, compare Santoro, se ve–dete da queste parti mia nipote la Vespa, quan–do Al–fio Mosca vie–ne a portare il carico del vi–no a vostra fi–glia la Santuzza, state a ve–dere cosa fa–nno fra di loro; e lo zio Santoro, col rosario in ma–no e gli occhi spen-ti, gli di–ce–va di sì, che non dubitasse, che era lì per questo, e non passava una mosca che ei non lo sapesse; (ivi, Cap. 5, capovv. 32 in poi)
10. Suoni melodiosi e sentimenti teneri, patetici, dolenti Si può chiudere questa ampia rassegna con la citazione di due
luoghi dal fondamentale interesse tematico in cui il contenuto pateti-co, tenero e doloroso suscita organicamente livelli fonetico–sonori morbidi e carezzevoli o melodiosamente dolenti. Trattasi degli ultimi due tentativi, da parte dei familiari, di evitare il tralignamento di ’Ntoni. Il primo tentativo è indiretto: è compiuto da Mena senza l’intenzione esplicita e neppure la speranza concreta di ottenere un
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle
200
cambiamento delle abitudini di vita dissipate ormai contratte dal fra-tello. Quel che Mena esplicitamente si propone di ottenere è solo che il nonno non debba assistere a tarda sera, prima del riposo notturno, allo spettacolo della dissipazione di ’Ntoni. Per un istante il rispetto che la giovane, malgrado tutto, continua a mostrare verso di lui e l’affetto protettivo che ella dimostra verso il nonno toccano profon-damente il cuore del fratello. Mena, costretta a vedere la depravazio-ne di ’Ntoni appunto per evitare che la veda padron ’Ntoni, non può trattenere il pianto, ma sta bene attenta a piangere in modo sommes-so e silenzioso, sia per non irritare il fratello sia, soprattutto, perché il nonno non possa udirla:
Come Me–na lo ve–de–va arrivare colla fa–ccia palli–da e gli occhi lu–stri, gli di–ce–va: Entra da questa parte, che ci è il no–nno! E lo fa–ce–va entrare da–lla porticina de–lla cuci–na; poi si metteva a pian–gere cheta che-ta accanto al focolare; tanto che ’Ntoni disse alla fi–ne: Non voglio an–darci più all’osteria, ne–anche se m’a–mmazzano! E tornò a lavorare di buo–navoglia come prima; anzi, si alzava prima de–gli altri, e an–da–va ad a-spettare il nonno alla marina, che ci vole–va–no due ore a far giorno, i Tre Re erano ancora alti sul campani–le del vi–llaggio, e i grilli si udi–va–no tril-lare ne–lle chiuse come se fossero lì accanto. Il nonno non ci capiva più ne–lla cami–cia da–lla contentezza; an–da–va chi–acchierando con lui on–de provargli come gli volesse bene, e fra di sé di–ce–va: Son l’a–ni–me sa–nte di sua madre e di suo padre che hanno fatto il miracolo. Il miracolo durò tutta la settima–na, e la do–me–ni–ca ’Ntoni non vo–lle ne–mmeno an–dare in piazza, per non ve–dere l’osteria da lontano e gli ami–ci che lo chiama–va–no. (Mal, pp. 259–260)
Il secondo passo ci racconta dell’estremo, preoccupatissimo e molto af-
fettuoso tentativo attuato da padron ’Ntoni al fine di recuperare il nipote: ormai senza successo, una volta per tutte. Gli aggregati fonetico–sonori vi si organizzano in un sistema di puri significanti dal tratto morbido, specie nella prima parte; sia qui sia negli ultimi tra i due luoghi riferiti sopra in cui cam-peggia l’usuraio un ruolo fonicamente rilevante è svolto dalla monosillabica negazione “non”: un effetto eufonico ottenuto in modo quasi paradossale, perché semanticamente vi è espressa la mancanza della buona coscienza e l’impossibilità di ottenere i risultati desiderati:
Una volta successe una br–utta sce–na. Il nonno, non sapendo più che fare per toccargli il cuore, l’a–ve–va tirato ne–ll’–an–golo de–lla cameruccia, ad
CAPITOLO II – Lo stridore e l’armonia
201
usci chiusi, perché non udissero i vi–ci–ni, e gli di–ce–va pian–ge–ndo come un ragazzo, il povero vecchio: Oh ’Ntoni! non ti rammenti che qui c’è mor-ta tua madre? Perchè vuoi darle questo do–lore a tua madre, di ve–derti fare la riescita di Rocco Spatu? Non lo ve–di come stenta e si affatica la povera cugi–na Anna per quell’ubbriacone di suo fi–glio? e come pian–ge alle volte, allorchè non ha pane da dare agli altri suoi fi–gli–uo–li e non le basta il cuo-re di ridere? «Chi va col lupo allupa» e «chi pratica con zoppi all’anno zoppi–ca». Non ti rammenti quella notte del colèra che eravamo qui tutti da–va–nti a quel lettuccio, ed e–lla ti raccoma–nda–va Me–na e i raga–zzi? — ’Ntoni pian–ge–va come un vitello slattato, e di–ce–va che vole–va morire anche lui; ma poi ada–gio ada–gio torna–va all’osteria, e la notte, in–ve–ce di ve–nire a casa, an–da–va per la via, fermandosi dietro gli usci, colle spalle appoggiate al muro, stanco morto, in–sie–me a Rocco Spatu e a Cinghiale–nta; e si metteva a cantare con loro, per scacciare la ma–linconia. (ivi, pp. 260–261) Circa gli agglomerati a sonorità dura, aspra, gracchiante si rinvia a
quanto s’è scritto in altra sede. Circa gli agglomerati a sonorità dolce, lieve, pateticamente dolente si possono fare alcune ulteriori osserva-zioni superficiali, che scaturiscono dal confronto tra le non poche can-zoni prescelte dal libro di Rapisarda e i passi succitati tratti dai Mal. Verga usa in modo assiduo, con l’intento di ammorbidire fonicamente un contesto, le coppie di avverbi o di aggettivi identici che qualificano la parlata siciliana ordinaria, sia quella dialettale sia quella municipale e, in modo marcato, il cantilenare siciliano (nel dialetto modellato con intenti artistici di Rapisarda: «nicchi nicchi», «sanu sanu»)25: «lesta le-sta», «cheta cheta», «adagio adagio» (nel terzo passo dai Mal la prima e nell’ultimo passo la seconda e la terza).
11. La novella verista antecedente I Malavoglia in cui è stata pri-mamente cercata e conseguita la dolcezza fonica
Si è ricordato e ripetuto sopra fino alla noia che le componenti a-
spre, stridule, sguaiate, gracchianti della lingua splendida dei Mal traggono origine dalla ricerca sull’Inferno dantesco di cui un esito magistrale è RM. Si è al contempo postulato che neppure gli aggregati
25 La due coppie sono tolte rispettivamente dalla prima e dalla seconda tra le canzoni della Raccolta di Rapisarda dianzi riferite nel testo.
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle 202
fonetico–sonori diafani, dolci, teneri dei Mal possano essere mera-mente frutto né della efficacia esercitata dalla Raccolta di Rapisarda, né dell’estro, né di semplici letture, sia pure finalizzate allo scopo di ottenere quel frutto. Era pur sempre possibile, certo, che la lettura, e la costante rilettura, dei maggiori (direi quasi dei più scolasticamente no-ti) autori della nostra tradizione, in particolare di Dante, di Foscolo, di Leopardi e di Manzoni, fossero stati bastevoli a soccorrere Verga nel reperimento degli agglomerati fonetico–sonori e in genere degli espe-dienti linguistici atti a dare alla lingua fonicamente cangiante dei Mal le componenti morbide e affettuose. Ho menzionato Dante (invero so-prattutto quello infernale), Foscolo, Leopardi e Manzoni perché i son-daggi sulla banca dati LIZ 4 attestano che questi autori hanno massi-mamente fornito, insieme al Monti della Traduzione dell’Iliade cellule propulsive che generano, nell’opera verista di Verga, parti importanti dell’ossatura tematica e del tessuto figurativo. Nondimeno, data l’im-portanza che Verga attribuì ai Mal fin dal primo concepimento di essi, mi pareva assai più probabile, già negli anni in cui effettuavo i primi sondaggi sul Verga “aspro” e “stridulo”, che l’autore, prima di redige-re il romanzo verista, si fosse esercitato nella ricerca di suoni a effetto dolce, diafano, soave, tanto quanto si era esercitato in quella dei suoni cupi, grevi e “gracchianti”.
Cercare e trovare il testo in cui quell’esercizio e quella ricerca po-tessero essersi sostanziati non è davvero stato difficile. È stato suffi-ciente leggere in modo attento quel che Verga aveva scritto tra RM e i Mal. Le novelle successive a RM1–RM3, ancorché il loro contenuto sia tragico (Cavalleria rusticana) o patologico e tragico insieme (La Lupa, L’amante di Gramigna, per certi versi Pentolaccia) non sono mai, neppure a tratti, con la solo parziale eccezione della Lupa, aspre e dure tanto quanto RM; sono però spesso tematicamente scheletriche, straordinariamente asciutte, brevi, secche quasi. Esclusi Fantastiche-ria e Guerra di santi, il testo che possiede esattamente tutti i caratteri dei quali ero alla ricerca è Jeli il pastore: la storia stessa è quasi un bi-lanciamento di quella raccontata in RM: quasi tutta vissuta in una vo-ragine sotterranea questa, e invece all’aperto, nel contesto di una natu-ra sconfinata quella. Je è diviso in tre nuclei tematici che si innestano cronologicamente l’uno nell’altro, corrispondono cioè a periodi suc-cessivi e contigui della vita di Jeli. Il terzo periodo segna un cambia-
CAPITOLO II – Lo stridore e l’armonia
203
mento radicale rispetto al primo, il secondo funge da raccordo tra essi due, così diversi tra loro. Il primo coincide con la fanciullezza e l’adoloscenza del guardiano di cavalli Jeli, che conduce una vita da nomade, quasi sempre lontana da paesi e paesetti, vicina solo alle masserie (principalmente a quella affidata a massaro Agrippino, dalle parti di Tebidi). L’isolamento del pastorello ha come cornice il respiro di ambienti naturali vastissimi e quasi incontaminati, animati da tan-tissime vite, animali e vegetali. Il secondo tratto coincide con il viag-gio compiuto di notte da Jeli con il garzone Alfio per condurre i caval-li alla fiera di San Giovanni, ove saranno venduti. Nel corso del viag-gio il cavallino detto lo stellato precipita in un burrone e Jeli viene li-cenziato. Alla fiera di San Giovanni e qui si inizia il terzo tratto narrativo il giovane ritrova massaro Agrippino e la sua famiglia, i quali ora abitano a Marineo, e d’indi innanzi Jeli comincia una nuova esistenza. Massaro Agrippino gli trova lavoro come pecoraio alla Sa-lonia, dove è fattore massaro Neri, il padre del fidanzato di sua figlia Mara. Jeli conduce ora una vita sedentaria, diligentemente si occupa delle pecore, impara a fare ricotta e formaggi e, dopo che il fidanza-mento tra Mara e il figlio di massaro Neri viene rotto, sposa Mara, della quale è innamorato fin da bambino. Tutti sanno che Mara se la intende con Don Alfonso detto “il signorino”, il quale era stato da ra-gazzino grande amico di Jeli. Jeli è a conoscenza di queste voci, ma la sua mente primitiva, per alcuni versi infantile (per altri versi assai giu-diziosa) non può associare l’idea al fatto. Nella sua mente la persona di Don Alfonso coincide con l’immagine del ragazzino di tredici anni con cui egli giocava l’estate a Tebidi. Un giorno il pecoraio rivede do-po tanti anni alla Salonia Don Alfonso, che è ormai un uomo fatto, dalla barba ricciuta, amico del padrone della fattoria. Questi ha voluto offrire agli amici una grande festa. Si balla sull’aia. Eccezionalmente è venuta anche Mara. Ora Jeli riesce a vedere la corrispondenza tra l’idea della tresca, di cui tanto aveva sentito parlare dagli altri senza riuscire a immaginarsela, e il fatto concreto. Quando Don Alfonso in-vita Mara a ballare e la tocca, Jeli lo sgozza.
La vicenda passionale in se stessa è molto banale. Si tratta di una delle numerose variazioni sul tema del bovarismo tanto di moda e tan-to caro a Verga. A suo modo anche Cavalleria rusticana è una varia-zione su questo tema, salvo che nella figura di Lola vi è pure qualcosa
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle
204
delle maliarde di Turgenev, specie di Irina; in entrambi i casi, siamo in presenza della speciale versione del bovarismo inaugurata da Verga, che prevede la vendetta inesorabile del marito. Jeli assomiglia molto a Charles Bovary nel temperamento: entrambi sono buoni, fiduciosi, la-vorano duramente, sono disposti a ogni sacrificio e fanno di tutto per non vedere quel che accade sotto i loro occhi. Entrambi sono in ciò as-sai diversi da Cesare Dorello, il quale vede bene quale vita conduca la moglie amatissima e fino all’ultimo si illude che Elena, più volte adul-tera, si penta, o almeno comprenda che nessuno la ama tanto quanto la ama lui, e dia nuovamente a lui il proprio cuore26. Mara, a differenza di Emma (e anche di Elena), ancor prima di cercarsi un fidanzato, si era già votata all’edonismo dei sensi non sappiamo se confuso con l’amore e al desiderio di un legame con un uomo dal rango sociale molto più alto del suo. Mara cerca uno sposo — dapprima il figlio di massaro Neri, poi Jeli — per non restare zitella, e per di più disonorata dalla condizione di amante del “signorino”. Tra i due corni dell’alter-nativa (nella novella inespressi), la condizione di donna adultera e quella di serva–amante, pare a Mara (e ai suoi genitori) preferibile la prima, la seconda essendo particolarmente disonorevole per la figlia di un massaro. Mara è socialmente superiore alla bracciante Nedda o alla indigente trovatella Diodata. Mara, prima del matrimonio, è una gio-vane donna da tempo profondamente cinica e corrotta, ancorché abbia temperamento allegro e socievole. Il percorso evolutivo della persona-lità di lei è descritto dall’autore con cenni sobri e molto convincenti. La bimbetta di cui il ragazzino Jeli si innamora è inizialmente un po’ selvatica, guardinga, silenziosa; ma è anche molto sicura di se stessa, priva di diffidenza vera, ed è un’ottima compagna di giochi. Quando massaro Agrippino viene licenziato e deve sloggiare dalla casa di Te-bidi per trasferirsi a Marineo, Mara è un’adolescente belloccia, felice di andare a vivere in un paese più grande, e anche, lei crede, in una ca-
26 Non mancano movenze esteriormente simili in ordine alla timidezza dei due uomini in-namorati e oggetto di tante chiacchiere, i quali camminano tra la gente insieme alla consorte: «Mara era bella e fresca come una rosa […]; sicché Jeli quando andava per le strade al fianco di lei, camminava impalato, tutto vestito di panno e di velluto nuovo, e non osava soffiarsi il naso, col fazzoletto di seta rosso, per non farsi scorgere, e i vicini e tutti quelli che sapevano la storia di Don Alfonso gli ridevano sul naso» (Je, p. 41). «La gente, quando vedeva passare il marito un po’ triste, ma calmo, come un uomo in lutto, accanto alla bruna e fiera beltà, gli get-tava dietro il suo scherno» (MdE, pp. 113–114).
CAPITOLO II – Lo stridore e l’armonia
205
sa più grande. È felice, soprattutto, perché godrà molto di più della compagnia dei suoi coetanei e perché a Marineo vi saranno occasioni di feste e di ballo sull’aia. Mara ha già un temperamento superficiale, aspira principalmente a divertirsi e questo desiderio occupa la sua mente e il suo cuore.
Quanto a Jeli, egli è un giovane molto sensibile che non matura mai. Pur avendo molto sofferto per la perdita dei carissimi genitori, la vita inconsueta e solitaria che ha condotto come guardiano di cavalli ha per certi versi bloccato la sua formazione; gli è stato impedito di cimentarsi con le delusioni e le frustrazioni affettive che la vita riserva a tutti nei rapporti reciproci, a partire da quelli con i genitori; pertanto non ha mai appreso a fronteggiare codeste frustrazioni. Il suo rapporto simbiotico con i cavalli basta a giustificare il suo dolore per la morte del puledro lo stellato; però la sua reazione silenziosa e dura nei con-fronti del fattore, che spara al puledro il colpo di grazia, la sola cosa che si potesse fare, è indice di immaturità. La bontà di Jeli è nativa, non si è temprata nella lotta contro le tentazioni, non è mai diventata coscienza morale riflessa e sia pure “primitiva”, come lo è invece la coscienza morale di Padron ’Ntoni, di Maruzza, di Mena, di Alessi. Mi par certo che la violenza omicida del pecoraio non è determinata da lucida e rabbiosa necessità di lavare il proprio onore offeso, come nel caso di compare Alfio di Cavalleria rusticana. Non so se si possa parlare, a proposito di Jeli, di “raptus”, di incontrollabile scatto ferino dettato da gelosia. V’è anche questo, ma Jeli desidera anzitutto e princi-palmente eliminare, annientatare subito colui il quale gli ha inganne-volmente preso e gli sta portando via sotto i suoi stessi occhi ciò che è suo e che egli massimamente desidera, da sempre. Egli agisce sot-to la spinta di emozioni violentissime sì, ma simili a istinti infantili, semplici. Quasi non si avverte in lui rancore nei confronti dell’adultera, quel rancore che, frammisto alla gelosia, armerà da ultimo la mano di Cesare Dorello contro Elena. Quando Don Alfonso invita Maria a balla-re, Jeli con voce sorda chiede alla moglie di non accettare l’invito. Se Mara avesse accolto la richiesta del marito, forse questi avrebbe avuto la sicurezza che Mara era più “sua” che non del “Signorino” e ciò sa-rebbe stato per Jeli sufficiente, così da non dovere eliminare il rivale.
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle
206
12. Il tessuto fonetico–sonoro di Jeli il pastore
Passo a dar conto, tracciando la quasi collaudata mappa, dell’asset-
to fonetico–sonoro di Je. Ho scelto, ovviamente con una certa lar-
ghezza, sei passi corrispettivi sia a tutte le età del guardiano di cavalli
e pecoraio sia alle situazioni o speciali o particolarmente drammatiche
della sua vita:
Però do–ve il man–gi–me era abbondante, e i cava–lli in–du–gia–va–no vo–
len–tieri, il raga–zzo si occupava con qualche altra cosa: fa–ce–va de–lle
gabbie di canna per i grilli, de–lle pipe intagliate, e dei panierini di gi–unco;
con qu–attro ramosc–elli, sapeva rizzare un po’ di tettoia […]. Don Al–fon–
so che era tenuto nel cotone dai suoi ge–nitori, in–vi–dia–va al suo amico Je–
li la tasca di tela do–ve ci ave–va tutta la sua roba, il pane, le cipolle, il
fiasch–etto del v–ino, il fazzoletto pel freddo, il batuffol–etto dei ce–n–ci col
refe e gli aghi grossi, la scatol–etta di latta coll’esca e la pietra focaja; gli
in–vi–dia–va pure la superba cava–lla va–jata, quella bestia dal ciuff–etto di
peli irti sulla fronte, che ave–va gli occhi cattivi, e gonfi–ava le froge al pari
di un mastino ringhioso qu–an–do qualcuno vo–le–va montarla. Da Je–li in–
ve–ce si la–sci–ava montare e gr–attare le orecchie, di cui era ge–lo–sa, e
l’a–nd–ava fiutando per ascoltare quello che ei vo–le–va dirle. La–scia
stare la vaja–ta, gli raccoma–nd–ava Je–li, non è ca–ttiva, ma non ti cono–
sce. (Je, pp. 16–17)
Col marzo tornarono le allo–do–le nel pia–no, i passeri sul tetto, le fo–glie e i
ni–di ne–lle sie–pi, Mara riprese ad an–dare a spasso in compagnia di Je–li
ne–ll’erba so–ffi–ce, fra le macchie in fiore, sotto gli al–beri ancora nu–di
che comin–cia––va–no a punt–eggiarsi di verde. Je–li si ficcava ne–gli spi-
ne–ti come un segugio per an–dare a scovare de–lle ni–dia–te di mer–li che
guarda–va–no sbalordi–ti coi loro occhietti di pepe; i due fan–ciu––lli porta-
va–no spesso nel petto de–lla cami–cia dei piccoli coni–gli allo–ra stana–ti,
quasi nu–di, ma da–lle lunghe orecchie di–ggià inquie–te. Scorazzava–no
pei campi al seguito del branco dei cava–lli, entran–do ne–lle stoppie dietro
i mie–ti––to–ri, passo passo coll’ar–mento, ferman–do–si ogni volta che una
giu–menta si ferma–va a stra–ppare una boccata d’erba. La sera, gi–unti al
pon–ti–cello, se ne an–da–va–no l’u–no di qua e l’altra di là, senza dir–si
ad–dio. (ivi, pp. 21–22)
Je–li assisteva il ge–nitore come me–glio sap–eva. Ogni mattina, prima d’an–
dar–se–ne coi puledri, gli la–scia–va il deco–tto preparato ne–lla ciotola, il
fa–scio dei sarmenti sotto la ma–no, le uo–va ne–lla ce–nere calda, e torna–
va presto al–la sera colle altre le–gne per la notte e il fiasche–tto del vi–no e
CAPITOLO II – Lo stridore e l’armonia 207
qualche pezzetto di carne di montone che era corso a comperare si–no a Li-
codia. Il povero raga–zzo fa–ce–va ogni cosa con garbo, come una brava
massaia, e suo padre, accompagnan–do–lo cogli occhi stanchi ne–lle sue fa–
cce–nd–uo–le qua e là pel casolare, di tanto in tanto sorride–va pen–san–do
che il raga–zzo avrebbe saputo aiutarsi, quan–do fosse rimasto so–lo. (ivi,
p. 23)
Quello lì è il fi–gli–uo–lo di massaro Ne–ri, il fattore de–lla Sa–lo–nia,
e spende più di die–ci li–re di razzi! di–ce–va la gnà Lia acce–nn–an–do a
un gio–vinotto che an–da–va in giro per la piazza te–nen–do due razzi alla
volta ne–lle ma–ni, al pari di due cande–le, sicchè tutte le do–nne se lo
mangia–va–no cogli occhi, e gli grida–va–no Vi–va San Gio–va–nni.
Suo padre è ricco e possie–de più di venti capi di bestia–me, aggi–un–ge–
va massaro Agr–ippino. Mara sa–pe–va anche che ave–va portato lo sten–
dardo gran–de, ne–lla processio–ne e lo regge–va diritto come un fu–so,
tanto era forte e bel gio–va–ne. Il fi–glio di massaro Ne–ri pareva che li
sentisse, e acce–ndesse i su–oi razzi per la Mara, fa–cen–do la ruota di–
nanzi a lei; e dopo che i fuochi furono cessati si accompagnò con loro, e li
condusse al ba–llo, e al cosmorama, do–ve si ve–de–va il mon–do vecchio e
il mon–do nuo–vo, pagando lui per tutti, anche per Je–li il quale an–da–va
dietro la comi–ti–va come un cane senza padrone, a ve–der ba–llare il fi–
glio di massaro Ne–ri colla Mara, la quale girava in tondo e si acco–ccola–
va come una colom–be–lla sulle tegole, e te–ne–va tesa con bel garbo una
co–cca del grem–bia–le, e il fi–glio di massaro Ne–ri saltava come un pu-
ledro, tanto che la gnà Lia pi–an–ge–va come una bim–ba da–lla conso–
lazione, e massaro Agr–ippino fa–ce–va ce–nno di sì col capo, che la cosa
an–da–va be–ne. (ivi, p. 34)
Sua mo–glie lo la–scia a infradi–ciare dietro l’uscio, di–ce–va–no i vi–
ci–ni, quando in casa c’è il tordo! Ma Je–li non sa–pe–va nu–lla, ch’era
becco, né gli altri si curava–no di dir–glie–lo, perchè a lui non glie–ne im-
portava nien–te, e s’era accollata la do–nna col da–nno, dopo che il fi–glio
di massaro Ne–ri l’a–ve–va piantata per aver saputo la storia di don Al–
fon–so. Je–li in–ve–ce ci vi–ve–va beato e cont–ento nel vituperio, e c’in-
grassava come un majale, «chè le corna so–no magre, ma mantengono la
casa grassa!». Una volta in–fi–ne il raga–zzo de–lla mandra glie–lo disse
in fa–ccia, mentre si abbaruffava–no per le pezze di formaggio che si tro-
va–va–no tosate. Ora che don Al–fon–so vi ha preso la mo–glie, vi pare
di essere suo cognato, e ave–te messo superbia che vi par di essere un re di
corona con quelle corna che ave–te in testa. Il fattore e il camp–ajo si a-
spettava–no di ve–der scorrere il sangue a quelle parole; ma in–ve–ce Je–li
ri–ma–se istupidi–to come se non le avesse udi–te, o come se non fosse
stato fatto suo, con una fa–ccia da bue che le corna gli stava–no be–ne. (i-
vi, pp. 43–44)
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle
208
Ma la prima vo–lta che per sua disgrazia rivi–de don Al–fon–so, dopo tanti an–ni, Je–li si se–ntì dentro come se lo cuocessero. Don Al–fon–so s’era fatto gran–de, da non sembrare più qu–ello; ed ora ave–va una be–lla barba ric-ciuta al pari dei capelli, e una giacchetta di velluto, e una cate–ne–lla d’oro sul panciotto. Però riconobbe Je–li, e gli batté anche sulle spalle sa–lu–tan–do–lo. Era ve–nuto col padrone de–lla fattoria in–sie–me a una brigata d’a–mi–ci, a fare una scampagnata nel tempo che si tosa–va–no le pecore; ed era ve–nuta pure Mara all’–improvvi–so col pretesto che era in–cinta e ave–va vo–glia di rico–tta fresca. Era una be–lla giornata calda, nei campi bi–on–di, colle siepi in fiore, e i lunghi fi–lari verdi de–lle vigne, le pecore saltellava–no e be–la–va–no dal pia–cere, al sentirsi spogliate da tutta quella la–na, e ne–lla cuci–na le do–nne fa–ce–va–no un gran fuoco per cuocere la gran ro-ba che il padrone a–ve–va portato per il de–si–nare. I signori intanto che a-spettava–no si erano messi all’–ombra, sotto i carrubi, e fa–ce–va–no suo–nare i tamburelli e le cornamuse, e ba–lla–va–no colle do–nne de–lla fattoria che pareva–no tutt’una cosa. Je–li mentre an–da–va tosa–ndo le pecore, si sen–ti––va qualcosa dentro di sé, senza sapere perchè, come uno spino, co-me un chiodo, come una forbi–ce che gli la–vorasse interna–me–nte mi–nuta mi–nuta, come un ve–le–no. (ivi, p. 46)27 In ogni luogo ci troviamo in presenza di un tessuto fonico dolce, a
tratti dolcissimo e diafano, appena chiazzato qua e là di macchie a-sprigne atte a evitare l’eccesso di morbidezza. L’autore aveva lasciato intendere che in Je era da lui perseguita in modo programmatico la dolcezza fonica: sugli abbozzi il primo diminutivo ipocoristico è Jele, tanto che si potrebbe pensare al nome Daniele, che però è pochissimo rappresentato a Catania e nella provincia di Catania. Jeli, invece, rin-via a Raffaele, che a Catania veniva pronunziato e forse è ancora pronunziato “Raffieli”. Jele rivelava fin troppo apertamente che il tratto del protagonista è delizioso, amabilissimo: ancorché, ad arte, non sia raffigurato nella novella l’aspetto fisico di lui (il corpo è agile e prestante, in ogni caso), sempre egli si comporta in maniera con tutti gentilissima, servizievole, sommamente paziente. In un’altra novella inclusa nella stessa raccolta, una donna “allupata” grida il suo deside-rio a un giovane bello, simpatico e amabile: «ma proprio quello che si dice innamorarsi, sentirsene ardere le carni sotto al fustagno del cor-petto […]. Una sera ella glielo disse, mentre […] i cani uggiolavano
27 Ho già parzialmente analizzato la parte più melodiosa di questo passo (da «era una bella
giornata» a «cosa») alle pp. 129–130 del mio studio Dai suoni al simbolo, cit.
CAPITOLO II – Lo stridore e l’armonia 209
per la vasta campagna nera: Te voglio! Te che sei bello come il so-le, e dolce come il miele. Voglio te!»28. Così il diminutivo ipocoristico Jele–Jeli dice che il significante–nome proprio e il personaggio si cor-rispondono e sono dolci come il miele. Il personaggio resta fino alla fine dolce come il miele, fino a quando sente la spina, il chiodo, il ve-leno che gli lavorano dentro: il miele si trasforma in fiele, il giovane si avventa su don Alfonso e lo sgozza. Nella novella non ricorrono mai né l’una né l’altra parola, né miele né fiele, egualmente lievi e dolci fonicamente: ma il gioco dei significati contrari corrispondenti ai due significanti, che contengono entrambi il diminutivo Jele, è abbastanza chiaro; il fatto che il gioco non sia apertamente accennato gli conferi-sce ambiguità29.
13. Per il conseguimento della dolcezza fonica Si è così messo a fuoco l’espediente che principalmente conferisce
alla novella la sua peculiare qualità fonetico–sonora: il significante Je-li ricorre infatti nel racconto, invero il più lungo della collezione Vita dei campi (oltre il doppio di RM), centosedici volte. Il diminutivo svolge funzione simmetrica, fonicamente speculare, in rapporto a
28 G. VERGA, La Lupa, cit., p. 187 (il corsivo è mio). 29 Anche il nome Mara è onomasticamente pregnante e ambiguo: il significante bisillabo è
per se stesso abbastanza morbido fonicamente, ma il significato reca duplicità. Da un lato nel-la zona di Catania Mara può essere avvertito come contrazione di Maria, dunque del nome della vergine madre del Redentore, e qui trattandosi del nome di una adultera scellerata, la quale da ultimo reca in grembo un bimbo dalla paternità molto incerta si avverte il consue-to sarcasmo di Verga nei confronti delle credenze religiose cristiane. Dall’altro lato non solo Mara è anagramma dell’amare e dell’amaro ma, soprattutto, rinvia etimologicamente in modo diretto all’amarezza. Il nome Mara, di origine ebraica, continua l’aggettivo marah, amaro, e trova riscontro nella Bibbia come nome occasionale. Così si autodefinisce infatti Noemi (che significa ‘mia gioia, mia delizia’) dopo la morte del marito e dei tre figli, ritenendo il suo no-me precedente non più adatto alla sua attuale infelice condizione (Ruth, 1, v. 20: «non chia-matemi Noemi, chiamatemi amarezza, perché l’Onnipotente mi ha inflitto grande amarezza»). All’origine dell’espressione di Ruth si trova il verbo marar, ‘essere amaro’, mentre Mara, nel-la Bibbia, denominava un pozzo del deserto di Shur, presso il Sinai, non lontano dal Mar Ros-so, citato in Esodo, 16, v. 23: «Giunsero a Mara e non poterono bere l’acqua di Mara, perché amara: perciò fu chiamata Mara. Per dissetare il suo popolo Mosé gettò un bastone nell’acqua e questa diventò dolce» (ho tolto queste informazioni da A. ROSSEBASTIANO–E. PAPA, I nomi di persona in Italia: dizionario storico ed etimologico, con presentazione di G. Gasca Quei-razza, Torino, UTET 2005).
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle
210
quella che il diminutivo Maricchia (sette occorrenze, in un testo di cinque pagine) e il soprannome Ranocchio (trentadue occorrenze in quindici pagine), durissimi fonicamente, svolgono rispettivamente nel-la Lupa e in RM. Fonicamente aggraziati sono molti dei nomi propri di persona del racconto, più di quanto non sogliano esserlo in media nei testi veristi siciliani di Verga: Don Alfonso, Lia (la madre di Mara), Menu (il padre di Jeli), Alfio, Neri, Cola. Due soli antroponimi aspri-gni ricorrono nel testo, uno fittamente e l’altro in modo occasionale: Agrippino, ove i due primi agglomerati, aspri e duri, sono un poco ammorbiditi dal diminutivo che chiude il nome, e Isidoro Macca, ove il nome di battesimo mitiga in notevole misura la durezza del cogno-me. Un solo antroponimo dagli agglomerati fonetico–sonori nettamen-te grevi e taglienti si incontra: Scordu il Bucchierese. Anche i toponi-mi (tra gli altri: Licodia, Don Ferrante, Passanitello, Granvilla), sono fonicamente assai meno duri, se non si vuol dire che nel complesso sono morbidi, rispetto alla normale, consueta, qualità fonica dei topo-nimi che si incontrano in Vita dei campi30.
Passo a enunciare gli altri criteri adottati da Verga per la costitu-zione del tessuto fonetico–sonoro eufonico di Je: 1) adozione massic-cia di aggregati vocalico–consonantici non importa se coincidenti con quelli sillabici cui la marca vocalica fondamentale viene im-pressa dal fonema (o vocalico o semiconsonantico) i, corrispettivo ai grafemi –i–, –j– e –y–: Jeli, figli–a, –e–o (figlia ricorre sei volte in Je e quattro nella Lupa, figlio ricorre quindici volte in Je e dieci nell’in-sieme delle altre novelle di Vita dei campi; una volta ciascuno ricorro-no in Je figliuolo, figliato, figliavano), innanzi, grilli, panierini, invi-diava, nidi, mietitori, dieci, vicini, infine. L’uso della –i– può servire ad attenuare fortemente la qualità altrimenti aspra di una parola: ricor-re una volta p. e. gridìo in luogo di grida. L’accento che percuote la –i– ne marca la pienezza fonica mentre la componente rauca è riassor-bita all’interno di una piccola totalità aggraziata. 2) Rilevante presenza
30 Questo è l’elenco spero completo dei toponimi che ricorrono in Je: Tebidi, Licodia,
Poggio alla Croce, Resecone, Caltagirone, Vizzini, Ragoleti, Don Ferrante, Commenda, Valle del Jacitano, Passanitello, Marineo, poggio del Bandito, piano del Lettighiere, poggio di Mac-ca, salita dei Galli, Monte del Calvario, Monte del Mulino a Vento, Piano del Corvo, Monte Arturo, Monti della Canziria, Granvilla, Santa Domenica, Sant’Antonio (quartiere di Vizzini), Salonia.
CAPITOLO II – Lo stridore e l’armonia
211
di suffissi coincidenti con i diminutivi affettuosi –ello, –etto, –ino, –uole (faccenduole); talora il suffisso è raddoppiato, sempre con carat-tere affettuoso: stradicciola. Il tratto fonico all’interno di questi suffis-si è normalmente assai dolce; nondimeno può apparire scorretto inse-rire un valore d’indole eminentemente semantica tra espedienti e valo-ri puramente fonetico–sonori. I suffissi con diminutivo, tuttavia, eser-citano spesso, sebbene non sempre, una intensa suggestione psicologi-ca (la mente ha occhi, orecchie e anche olfatto e tatto!), la quale con-duce il lettore a percepire come aggraziata e fonicamente gentile la pa-rola che reca quel suffisso per il sol fatto che in essa è espresso un movimento tenero o intenerito: ancora una volta, il suono del signifi-cato piuttosto che il suono del significante. Esprimendosi in maniera più appropriata si può dire che i diminutivi affettuosi contribuiscono in modo rilevante alla creazione di uno “sfondo preparatorio”, di una diffusa atmosfera complessiva intenerita e quasi soave, impregnata di emozioni umanamente positive: sfondo dal quale la sonorità dolce e melodiosa trae limpidezza e intensità. 3) Ricerca insistita di lettere che danno luogo a fonemi dolci o morbidi perché seguiti dalle vocali –i– ed –e–: –ce–, –ci–, –ge–, –gi–,–gli –, –glia–,–glie–, –gli(o)–, –sce–, –sci– (noci, ponticello, giorni, froge, ciglione, moglie, ramoscelli, fu-scellino). 4) Uso frequente delle consonanti scempie morbide e dolci –d–, –f–, –l–, –m–, –n–, –v– e in certa misura anche –b– e –s– prece-dute e seguite da vocale (specie a, e, i) oppure precedute da –l–, –m–, –n–: sapientissimo e calibrato con cura ben vigile è il ricorso agli in-contri consonantici –ld–, –lf–, –nd–, –nf–, –ns–. Sono limpidi, e molto rappresentati, ancorché un poco meno lievi, pure gli incontri conso-nantici –lp–, –lt–, –lz–, – mb –, –mp–, –nt–, –nz– (alberi, calda, andare, bimba, campi, contento, senza). 5) Esteso ricorso al raddoppiamento delle consonanti più melodiose e dolci: soprattutto –ll–, e –nn–, in assai minor misura anche –mm–: canna, allodole, mamma, fanciulli, allora, cenno, saltellavano, gemme, tamburelli, donne. 6) Ricorso al raddop-piamento di altre consonanti eufoniche (–dd–, –ff–, –vv–), specie se precedute e seguite da aggregati complessivamente morbidi: acciuffan-do, affannano, affaticava, diffidenza, addio, addirittura, addomesticarsi, avvampassero, avvenimenti, avvezza, avviati. 7) Fitta inserzione di in-contri vocalici (o di semiconsonante con vocale), si tratti o non si tratti di dittonghi, si tratti o non si tratti di monosillabi, che o creano di per sé
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle 212
sonorità lieve e diafana (ei, ai, dai, dei, bei) oppure imprimono una sor-ta di rallentamento nel significante o nella serie di significanti, rallen-tamento che ha più o meno vaga qualità melodiosa: guardiano, focaja, vajata, villeggiatura, Marineo, faccenduole, ballatojo, stradicciuola, campajo e così via. Gli incontri vocalici possono aver luogo tra parole diverse, creando agglomerati particolarmente melodiosi: le foglie e i.
Balzano agli occhi due importanti espedienti morfologico–lessicali atti a costituire significanti secondo i criteri sopra enunciati: 1) abbon-danza dei verbi; quando le forme verbali sono conformate all’imper-fetto narrativo spesseggiano le terminazioni lievi –ava, –avano, –eva, –evano, quando sono conformate al gerundio spesseggia il fondamen-tale incontro consonantico –nd– 2) uso di perifrasi che consentono di ripetere molte volte una parola dai suoni dolci o molto dolci. Il caso più evidente è quello di un personaggio cui è affidato un ruolo non ir-rilevante ma che nel racconto non ha nome proprio: si tratta del primo fidanzato di Mara, costantemente denominato sia dalla voce narrante che dagli altri personaggi “il figlio di massaro Neri”. La perifrasi con-sente di replicare un gran numero di volte l’espressione “il figlio”. L’effetto di rallentamento del discorso con esito melodioso è conse-guito spesso mediante la duplicazione di avverbi o di aggettivi quasi sempre eufonici o abbastanza eufonici: adagio adagio, mogio mogio, passo passo, lento lento, serio serio, ben bene, a poco a poco, quatto quatto, lesta lesta, lontan lontano, allora allora, duro duro e così via. Siffatta replicazione, come si è già notato, è vivissima nella parlata si-ciliana, in tutti gli strati linguistici, dal più municipalmente colto al dialetto popolaresco.
Non è inutile notare che le chiazze aspre e dure le quali consentono di evitare l’eccesso di eufonia, e dunque il rischio di una conforma-zione fonica languida, sono quelle da tempo collaudate, specie in RM: –acchi–, –acco–, –app–, –azz–, –ghi–, –ghe–, –gra–, –gre–, –opp–, –sbr–, –sgr–, –str–, e così via: accoccolato, greppo, cazza, crocchio, strepito, sonnecchiava, disgrazia, stradone, sbrancati, schioppo, unghie ecc. Il rischio di eccedere nell’eufonia viene mitigato anche mediante espedienti che contemperano suggestioni puramente psicologiche e forme in senso stretto foniche: per esempio mediante l’uso di suffissi accrescitivi. Particolarmente importante il suffisso accrescitivo –one (vallone, ciglione): la sua qualità fonetico–sonora non è certo aspri-
CAPITOLO II – Lo stridore e l’armonia
213
gna. Tuttavia in un testo tanto ricco di –e–, di –i– e anche di –a–, la o viene percepita come non–dolce. Dal punto di vista meramente psico-logico–mentale, l’accrescitivo, pur non recando alcuna nota peggiora-tiva, è percepito come parziale attenuazione della soavità fonica del significante o del tratto in cui è inserito.
14. I testi che hanno fornito ausilio all’eufonia e le contraddizioni di Jeli il pastore Dall’indagine condotta sulla banca dati LIZ 4 risulta che i testi dai
quali Verga ha attinto massimamente la serie di risorse stilistiche so-pra elencate sono in particolare i capolavori della narrativa ottocente-sca: in posizione dominante, oltre ai Promessi Sposi, le Confessioni di un Italiano e il Novelliere campagnolo di Ippolito Nievo; di contro, stanno in posizione più defilata le Ultime lettere di Jacopo Ortis. Mo-desto è il contributo fornito dai testi poetici di Foscolo, Leopardi e Manzoni, certo inferiore a quello dell’Inferno e del Purgatorio di Dante (“vallone”, p. e., è parola schiettamente dantesca; l’Inferno ha procurato anche suoni e aggregati dolci, poiché questi vi stanno fram-misti agli agglomerati aspri, duri, striduli). I promessi Sposi, le Con-fessioni di un Italiano e il Novelliere campagnolo sono anche la fonte principale del vocabolario di Je, insomma del lessico tra fiabesco e ru-sticano della novella. L’opera di Leopardi, invece, offre un ausilio (anche teorico) importante ma indiretto; aiuta principalmente a trac-ciare uno sfondo eidetico, uno scenario, che si armonizza bene con la ricerca della musicale dolcezza fonica. In Je viene ritratta con mano abbastanza felice una natura vasta, sconfinata, incontaminata, arcadi-ca, tendenzialmente inverosimile, della quale non sono delineati con precisione i contorni. Viene inoltre evocato il susseguirsi costante e immutabile delle stagioni; e si cerca di far sentire pure gli odori e i rumori della natura, o il suo silenzio, sotto forma di echi generici e in-definiti, suscitati da parole a dire il vero per se stesse eufoniche, che recano le sfumature della vaghezza, della lontananza, della indistin-zione: «Lo si vedeva sempre di qua e di là, pei monti e nella pianura» (p. 13); «i bei giorni d’aprile, quando il vento accavallava ad onde l’erba verde, e le cavalle nitrivano nei pascoli» (ibidem); «i bei merig-
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle
214
gi d’estate, in cui la campagna, bianchiccia, taceva, sotto il cielo fosco e i grilli scoppiettavano fra le zolle, come se le stoppie si incendiasse-ro!» (ivi, pp. 13–14); «il bel cielo d’inverno attraverso i rami nudi del mandorlo, che rabbrividivano al rovajo, e il viottolo che suonava gela-to sotto lo zoccolo dei cavalli, e le allodole che trillavano in alto, al caldo, nell’azzurro!» (ivi, p 14); «le belle sere di estate che salivano adagio adagio come la nebbia;» (ibidem); «il buon odore del fieno in cui si affondavano i gomiti, e il ronzio malinconico degli insetti della sera, e quelle due note dello zufolo di Jeli iuh! iuh! iuh! che face-vano pensare alle cose lontane» (ibidem).
Si è sentito dire spesso a proposito di Romeo and Juliet, nei di-scorsi alla buona, che la tragedia era nata come commedia (si pensi alla adolescenziale volubilità di Romeo) e poi per qualche misterio-sa ragione si è tramutata in tragedia, senza che le due diverse ispi-razioni si siano bene amalgamate. Qualcosa del genere vale anche per Je. Il livello fonetico–sonoro del testo, “idillico”, si adegua or-ganicamente soltanto al primo tratto (cioè al primo nucleo temati-co) della novella. Nel secondo tratto, di raccordo tra le “due esi-stenze successive” di Jeli, accade una disgrazia che sconvolge la vi-ta del giovane. Nel terzo tratto egli deve dapprima fare i conti con un sentimento aspro per lui nuovo e quasi indefinibile, la gelosia nei confronti del figlio di massaro Neri; poi con una situazione per lui inimmaginabile ma di cui sa che tutti parlano: la sua Mara sa-rebbe l’amante di Don Alfonso, colui che è stato il suo migliore amico d’infanzia. La mente di Jeli e il suo cuore non possono accet-tare questo: il tradimento dell’amicizia, di un vincolo ben più sacro del matrimonio in una società arcaica, compiuto per lo più da una persona la cui immagine conserva un’età anagrafica di molti e molti anni più giovane rispetto a quelli che hanno i coniugi Jeli e Mara. Da ultimo l’agnizione e la vendetta, impulsiva, feroce, spietata. Ep-pure non il primo tratto soltanto ma l’intero racconto è il frutto di gran lunga più dolce e armonioso dello sperimentalismo fonico–linguistico verghiano. Je è dunque un testo “stonato” per eccesso di eufonia.
CAPITOLO II – Lo stridore e l’armonia 215
15. Un capolavoro nato dalla discordia: soavità dei suoni e asprezza dei contenuti Sia chiaro: Verga non aveva mai pensato di scrivere una storia che
somigliasse a una piccola commedia e neppure una vicenda a lieto fi-ne. Aveva originariamente pensato, invece, di scrivere una Knabenno-velle d’indole rusticana, la storia delle prime emozioni d’amore di un fanciullo dei più semplici che è giunto alla pubertà. Lo documentano i tre abbozzi che precedono la stesura del testo destinato a diventare l’autografo definitivo, quello che verrà inviato in tipografia31. La storia doveva essere delicata e ingenua, con un finale patetico: il giovinetto veniva costretto dai casi della vita a separarsi dalla ragazzina che era oggetto dei suoi pensieri più teneri. Nel primo abbozzo (J1) il padre della ragazza viene licenziato in modo improvviso e la famigliola di lei deve sloggiare. Jele va ad assistere alla partenza, senza dire una pa-rola, e la ragazza, taciturna ella pure, non manifesta alcuna emozione palese, dunque nessun desiderio di partire. Qualche tempo dopo Jele apprende che la ragazza si è fatta sposa e, senza stare a rifletterci su, si reca subito a Marineo, per capire se la notizia sia esatta e soprattutto per capire se la ragazza desideri sposare il giovane che le si è promes-so. Sebbene ciò non sia esplicitamente scritto, Jele dunque supponeva o sperava che la fanciulla ricambiasse i suoi sentimenti. Durante il breve colloquio ella gli conferma invece che sta per sposarsi e l’atteggiamento di lei, invero timido e casto (arrossisce quando le giunge all’orecchio la voce del fidanzato) lascia intendere a Jele che la fanciulla è innamorata di colui al quale è destinata. Jele torna alla sua vita solitaria; e in solitudine, con l’aiuto dei suoi animali e del suo zu-folo, inconsapevolmente cerca di “elaborare” la sua prima, grande de-lusione. Il secondo abbozzo (J2) si chiude con la partenza della fami-glia di lei per Marineo. Jele manifesta alla ragazza il proprio dolore per il fatto che ella e i suoi se ne vanno. Ella, però, è contenta di andar via, pensa che godrà della compagnia dei coetanei, che vedrà molta gente, e non bada al dolore di lui. Egli quasi cerca di ottenere una buo-
31 Cfr. il paragrafo Jeli il pastore, dedicato alla descrizione degli autografi della novella, nella Introduzione premessa da Carla Riccardi a G. V., Vita dei campi, cit., pp. LXX–LXXIV. Cfr. soprattutto la trascrizione degli abbozzi, procurata dalla stessa Riccardi e stampata in Ap-pendice al succitato volume con le sigle J1, pp. 131–136, J2, pp. 127–144 e J3, pp. 146–156.
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle
216
na parola da lei, ma forse intuisce che la fanciulla non contraccambia i suoi sentimenti ed è emotivamente assai lontana da lui. Il terzo abboz-zo si chiude come il secondo, salvo che contiene uno sguardo più am-pio sulla natura che circonda il ragazzo.
Tra gli abbozzi, il più compiuto tematicamente è il primo, il più breve, quello in cui tutto accade in modo veloce. Forse a Verga parve che questo ritmo serrato, unitamente alla indubbia esiguità, e sia pure delicata, della vicenda principale, non fossero adeguati a un idillio te-nero e pateticamente “unilaterale”. È poi probabile che l’autore sentis-se il bisogno di ampliare il racconto al fine di rendersi saldamente e-sperto del registro fonetico–sonoro dolce e melodioso. Nell’am-pliamento (J2 e J3) la vita di Jele in mezzo alla natura incontaminata è descritta con assai maggiore ricchezza di dettagli, il giovane perde del tutto la modesta intraprendenza amorosa che dimostra nel primo ab-bozzo, e la personalità della ragazza viene modificata radicalmente. Il secondo e il terzo abbozzo hanno carattere assai più descrittivo che non narrativo, contrariamente alla radicata e peculiare vocazione del Verga verista. Il registro armonioso viene conquistatato saldamente (la corrispondenza tra il secondo e il terzo abbozzo e il primo tratto di Je è molto marcata), ma la storia, per usare un termine caro a Verga, è assai “dilavata”, ancorché sia perfettamente verosimile.
Si badi: non è questione di “contenuto” astrattamente inteso. Da uno spunto tematicamente esilissimoThomas Mann è stato in grado di trarre un racconto lungo d’indole tenera e patetica dalla efficacia psico-logica straordinaria e dalla luminosa bellezza espressiva32. Ma alla sog-gettiva personalità artistica di Verga non si addiceva la composizione prevalentemente e quasi totalmente giocata sulle note tenere e patetiche. Tentò, e si rese conto dell’insuccesso. Egli decise così di scrivere una continuazione del suo racconto nella quale il livello eidetico e la tonalità emotiva fossero radicalmente diverse rispetto a quelle degli abbozzi. All’idillio patetico e delicato, che originariamente abbracciava tutta la novella, e che in Je resta come primo troncone di essa, aggiunse gli altri due tratti corrispondenti a nuclei tematici nuovi e diversi: attraverso e
32 Unordnung und frühes Leid (malamente tradotto, credo per ragioni commerciali, Disor-dine e passione precoce anziché, come sarebbe corretto, Disordine e dolore precoce): la pri-ma “cotta” e delusione d’amore di una bimbetta, delusione mitigata sul finale da un garbato colpo di scena).
CAPITOLO II – Lo stridore e l’armonia
217
dopo riscritture e correzioni essi alla fine coincisero con il viaggio di Jeli verso Vizzini in occasione della festa di San Giovanni e con la sua nuova vita: un lavoro diverso e sedentario e la condizione coniugale. Idillio, dramma, tragedia si sommano senza fondersi: il fatto che coin-cidano con tre storie relativamente autonome l’una dall’altra conferi-sce al lungo racconto il suo fascino misterioso, arcano, inconsueto. Pe-raltro non è difficile comprendere perché Verga avesse avuto tanto a cuore il cimento con il registro tutto malinconico e patetico: con esso non si era mai cimentato prima (neppure con Nedda, ove non a caso il finale è tragico) ma ora stava per intraprendere la stesura definitiva dei Mal, nei quali la più costruttiva, semplice e tenace operosità umana e l’inclinazione umana ad affetti radicati, teneri e duraturi si scontra con la cupidigia, con l’istinto di sopraffazione e con la tendenza umana al facile godimento edonistico. Come si è constatato, effetti sommamente patetici si sprigionano dai colloqui e dal rapporto tra Maruzza e il figlio maggiore, dai colloqui e dal rapporto tra padron ’Ntoni e ’Ntoni, dalla rinunzia di Mena e Alfio, e da tante altre vicende e nuclei tematici.
Per altro verso è da notare che grazie all’aggiunta dei due tratti nar-rativi, e soprattutto dell’ultimo che snaturano la originaria fisiono-mia del racconto, incentrata sulla prima delusione d’amore di un ado-lescente dal carattere delizioso, non privo di spirito d’iniziativa ma del tutto inesperto Je viene a stringere effettivamente una relazione in-teressante con RM(1–3–4). Questa relazione era quasi inesistente limi-tatamente agli abbozzi, o meglio era solo parzialmente esistente nella contrapposizione fonica dei sistemi inerenti i puri significanti. I due testi, nella princeps di Vita dei campi, divengono tra loro perfettamen-te antitetici sia quanto all’assetto fonetico–sonoro (aspro e duro in RM3 e anche in RM4, melodioso e dolce in Je) sia quanto al livello ei-detico: in RM3, questo coincide eminentemente con una voragine labi-rintea sotterranea, cupa e buia, e invece in Je con gli immensi spazi sotto il sole o sotto le stelle, i quali sono sede di una natura viva, in-contaminata, sottomessa solo al ritmo delle stagioni.
Alla doppia contrapposizione si aggiunge però una affinità tematica profonda: entrambe le storie raccontano di giovanissimi i quali si per-dono perché non hanno avuto il sostegno e la guida ferma e amorevole dei genitori. La maturazione affettiva e morale di Jeli, che pure è sag-gio, oltre che spontaneamente dolce e buono, resta incompiuta per
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle
218
questa ragione. All’età in cui Jeli prende moglie, del resto, spesso non si è ancora raggiunta un’esperienza della vita che consenta di ricono-scere con sicurezza insidie e pericoli. La guida o il consiglio di perso-ne benevole ed esperte sarebbe ancora molto utile, se non indispensa-bile. Nel testo la cosa è marcata in modo efficacissimo dal fatto che un coetaneo di Jeli, di lui più fortunato, non ha nome ed è identificato sempre mediante la formula «il figlio di massaro Neri». La figura del padre campeggia, mentre il figlio è raffigurato allusivamente come un’appendice del padre, quasi un bene appartenente a colui, al quale il giovane è certamente sottomesso, al quale il giovane deve e porta il massimo rispetto33. Massaro Neri viene a sapere della tresca tra Mara e Don Alfonso e salva suo figlio, mentre Jeli, il quale non ha nessuno che si prenda cura di lui, si perde; massaro Agrippino, ovviamente, an-tepone l’interesse di sua figlia e quello suo proprio all’interesse di Jeli. Così, attraverso una medesima, piccola e innocente perifrasi, Verga persegue e consegue due obiettivi, l’uno di carattere squisitamente eu-fonico–stilistico (la ripetizione della parola «figlio» dolcissima e stra-ordinariamente ricca di connotazioni affettuose), e l’altro d’indole te-matico–morale.
Preme notare, traendo infine le conclusioni, che nei primi tre ab-bozzi non v’è alcuna traccia del “signorino”. Il padroncino Alfonso compare a partire dalla versione allungata dei due nuovi nuclei temati-ci, quella destinata a essere di poco rielaborata per l’autografo defini-tivo. Nei primi tre abbozzi, il compagno di giochi di Jele, fanciullo e-gli pure e appartenente (come poi Don Alfonso) all’ambiente dei lati-fondisti, è un io narrante che nelle prime pagine svolge a pieno titolo anche il ruolo di personaggio, per l’esattezza fino a quando entra in scena la bambina. In sostanza, l’idea di far di Jeli una persona imma-tura tanto da non accettare, contro ogni evidenza, il fatto che Mara “ami” un altro; la tresca di Mara con Don Alfonso; il finale sanguinoso e tragico: tutti questi temi si sono affacciati alla mente di Verga in modo indipendente dalla prima concezione della novella; e restano sempre e-stranei all’ispirazione originaria. Essi vengono sottomessi a questa so-
33 Sono debitrice di questa osservazione agli studenti (in particolare a Daniele E. Giam-matteo) del corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne della Univ. d. St. di Mi-lano che hanno preso parte, nell’a.a. 2007–2008, primo semestre, al mio seminario su Dante, Verga e Collodi.
CAPITOLO II – Lo stridore e l’armonia 219
lo per la loro piena appartenenza, o sudditanza, rispetto alla prestabili-ta forma eufonica. Ma la cattiveria e durezza dei nuovi nuclei tematici avrebbe richiesto, se non un assetto fonicamente improntato a stridore e pesantezza, almeno un assetto cangiante tra sonorità cupa e greve e sonorità dolce e limpida. In Je l’autore rinunzia a questi effetti, ma grazie agli antitetici e complementari esercizi compiuti in RM e in Je l’assetto fonico cangiante contrassegnerà la lingua splendida dei Mal.
221
Postilla I
Notti estive e firmamento in Rosso Malpelo
1. Luperini, le stelle e la luna. Una replica1 Il critico Romano Luperini si è soffermato diffusamente, in un
suo libro recente, sulla mia lettura di un passo della novella Rosso Malpelo2. Egli molto gentilmente conviene che la mia spiegazione del passo, come appunto sostenevo, è diversa da tutte quelle che ne erano state date antecedentemente, e anche dalla sua; e conviene al-tresì sul fatto che l’interpretazione da darsi a quel passo è assai im-portante ai fini della comprensione in particolare della psicologia di Malpelo e in generale della visione del mondo (Weltanschauung) sottesa alla novella3. Il libro di Luperini è impostato in chiave so-ciologica, mentre al centro dei miei interessi sta la letterarietà di Verga; forse anche per questa ragione non sono riuscita a farmi comprendere dallo studioso. Mi provo a fare meglio, e a dare qual-che chiarimento atto a evitare che mi si attribuiscano pensieri che non sono i miei. Anzitutto sono da adunare alcuni tratti del raccon-to, celeberrimo, che contribuiscono alla comprensione del passo su cui vi è discussione. Li reco secondo l’ordine con cui si succedono nel racconto:
1 Per le abbreviazioni e sigle cfr., in questa Parte seconda, la prima pagina del cap. I e la
nota 1. 2 R. LUPERINI, Verga moderno, Bari, Laterza, 2005. Nella parte prima Verga moderno (la
quale dà il titolo a tutta la raccolta), da p. 5 a p. 102, Luperini rielabora saggi suoi recenti su G. V già pubblicati altrove e ne aggiunge tre prima inediti. Nella parte seconda, Simbolo e co-struzione allegorica in Verga, ristampa tre studi già inclusi nel volumetto omonimo uscito nel 1989 presso l’editore il Mulino di Bologna.
3 Mi corre l’obbligo di precisare che la formula recata nel testo tra virgolette alte è mia, Luperini non la usa e usa invece la parola “ideologia”, estranea al mio lessico scientifico.
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle
222
[Dopo la morte del padre, alla quale Malpelo ha assistito, N.d.A.:] Però in-fine tornò alla cava dopo qualche giorno, quando sua madre piagnuccolan-do ve lo condusse per mano, giacchè, alle volte il pane che si mangia non si può andare a cercarlo di qua e di là. (RM3, p. 55) Il sabato sera, appena arrivava a casa con quel suo visaccio imbrattato di lentiggini e di rena rossa, e quei cenci che gli piangevano addosso da ogni parte, la sorella afferrava il manico della scopa se si metteva sull’uscio in quell’arnese, chè avrebbe fatto scappare il suo damo se avesse visto che razza di cognato gli toccava sorbirsi; la madre era sempre da questa o da quella vicina, e quindi egli andava a rannicchiarsi sul suo saccone come un cane malato. Adunque, la domenica, in cui tutti gli altri ragazzi del vi-cinato si mettevano la camicia pulita per andare a messa o per ruzzare nel cortile, ei sembrava non avesse altro spasso che di andar randagio per le vie degli orti, a dar la caccia a sassate alle povere lucertole, le quali non gli avevano fatto nulla, oppure a sforacchiare le siepi dei fichidindia. Per altro le beffe e le sassate degli altri fanciulli non gli piacevano. (Ivi, pp. 60–61) E Malpelo, […] se veniva fuori dalla cava il sabato sera, era perchè aveva an-che le mani per aiutarsi colla fune, e doveva andare a portare a sua madre la paga della settimana. (Ivi, pp. 61–62) Certamente egli avrebbe preferito di fare il manovale, come Ranocchio, e lavorare cantando sui ponti, in alto, in mezzo all’azzurro del cielo, col sole sulla schiena o il carrettiere, come Compare Gaspare che veniva a pren-dersi la rena della cava, dondolandosi sonnacchioso sulle stanghe, colla pi-pa in bocca, e andava tutto il giorno per le belle strade di campagna o meglio ancora avrebbe voluto fare il contadino che passa la vita fra i campi, in mezzo al verde, fra i folti carrubi, e il mare turchino là in fondo, e il can-to degli uccelli sulla testa. Ma quello era stato il mestiere di suo padre, e in quel mestiere era nato lui. E pensando a tutto ciò, indicava a Ranocchio il pilastro che era caduto addosso al genitore, e dava ancora della rena fina e bruciata che il carrettiere veniva a caricare colla pipa in bocca, e dondolan-dosi sulle stanghe, e gli diceva che quando avrebbero finito di sterrare si sa-rebbe trovato il cadavere di suo padre, il quale doveva avere dei calzoni di fustagno quasi nuovi. Ranocchio aveva paura, ma egli no. Ei narrava che era stato sempre là, da bambino, e aveva sempre visto quel buco nero, che si sprofondava sotterra, dove il padre soleva condurlo per mano. Allora stendeva le braccia a destra e a sinistra, e descriveva come l’intricato labi-rinto delle gallerie si stendesse sotto i loro piedi dappertutto, di qua e di là, sin dove potevano vedere la sciara nera e desolata, sporca di ginestre riarse, e come degli uomini ce n’erano rimasti tanti, o schiacciati o smarriti nel buio, e che camminano da anni e camminano ancora, senza poter scorgere
POSTILLA I – Notti estive e firmamento in Rosso Malpelo
223
lo spiraglio del pozzo pel quale sono entrati, e senza poter udire le strida di-sperate dei figli, i quali li cercano inutilmente. (RM3, pp. 62–63) E ogni volta Malpelo ripeteva che al di sotto [la sciara, N.d.A] era tutta scava-ta dalle gallerie, per ogni dove, verso il monte e verso la valle; tanto che una volta un minatore c’era entrato coi capelli neri, e n’era uscito coi capelli bianchi, e un altro cui si era spenta la torcia aveva invano gridato aiuto ma nessuno poteva udirlo. Egli solo ode le sue stesse grida! Diceva, e a quell’idea, sebbene avesse il cuore più duro della sciara, trasaliva.
Il padrone mi manda spesso lontano, dove gli altri hanno paura d’andare. Ma io sono Malpelo, e se io non torno più, nessuno mi cercherà. Pure, durante le belle notti d’estate, le stelle splendevano lucenti anche sulla sciara, e la campagna circostante era nera anch’essa, come la scia-ra, ma Malpelo stanco della lunga giornata di lavoro, si sdraiava sul sacco, col viso verso il cielo, a godersi quella quiete e quella luminaria dell’alto; perciò odiava le notti di luna, in cui il mare formicola di scin-tille, e la campagna si disegna qua e là vagamente allora la sciara sembra più brulla e desolata. Per noi che siamo fatti per vivere sotter-ra, pensava Malpelo, ci dovrebbe essere buio sempre e dappertutto. La civetta strideva sulla sciara, e ramingava di qua e di là; ei pensava: Anche la civetta sente i morti che son qua sotterra e si dispera perchè non può andare a trovarli. Ranocchio aveva paura delle civette e dei pipistrel-li; ma il Rosso lo sgridava perchè chi è costretto a star solo non deve aver paura di nulla, e nemmeno l’asino grigio aveva paura dei cani che se lo spolpavano, ora che le sue carni non sentivano più il dolore di essere mangiate.
Tu eri avvezzo a lavorar sui tetti come i gatti gli diceva e allora era tutt’altra cosa. Ma adesso che ti tocca a viver sotterra come i topi, non biso-gna più aver paura dei topi, nè dei pipistrelli, che son topi vecchi con le ali, e i topi ci stanno volentieri in compagnia dei morti. Ranocchio invece provava una tale compiacenza a spiegargli quel che ci stes-sero a far le stelle lassù in alto; e gli raccontava che lassù c’era il paradiso, dove vanno a stare i morti che sono stati buoni e non hanno dato dispiaceri ai loro genitori. «Chi te l’ha detto?» domandava Malpelo, e Ranocchio rispon-deva che glielo aveva detto la mamma. Allora Malpelo si grattava il capo, e sorridendo gli faceva un certo verso da monellaccio malizioso che la sa lunga. «Tua madre ti dice così perchè, invece dei calzoni, tu dovresti portar la gonnella». E dopo averci pensato su un po’: «Mio padre era buono e non faceva male a nessuno, tanto che gli dicevano Bestia. Invece è là sotto, ed hanno persino trovato i ferri e le scarpe e questi calzoni qui che ho indosso io» (ivi, pp. 68–69, corsivo mio, N.d.A.)
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle
224
Il passo controverso è quello recato sopra in corsivo. Nel volumetto pubblicato nel 1976 Luperini asseriva che per Malpelo la cava «è il suo ambiente, ed è l’ambiente della morte»; dunque Malpelo «odia le notti di luna: il suo cielo deve essere nero come la volta della miniera, la sua campagna è la sciara “nera e rugosa” (non un’alternativa alla cava, ma la sua continuazione)»4. Si tratta — me ne accorgo adesso — di una parafrasi molto simile a quella che era stata proposta da Luigi Russo5. Nella Lettura storico–sociologica pubblicata su «Italianistica» nel 2001 Luperini confermava in tutto e per tutto l’interpretazione cir-ca il rapporto tra il Rosso e la luna piena fornita venticinque anni pri-ma, aggiungendo brevi considerazioni che la amplificano un pochino senza modificarla: «la vita autentica non è quella della normalità sola-re e diurna ma quella tenebrosa e notturna dei sotterranei. Per questo Rosso Malpelo odia le notti di luna, che fingono uno splendore e un’“aura” che sono in insanabile contraddizione con l’essenza spie-tata della vita rivelata invece dall’orrore della cava»6. A prova di sif-fatta sua asserzione Luperini reca parte della porzione di testo sopra ri-ferita in corsivo, da «perciò» (dopo il punto e virgola) a «desolata».
Nel capitolo “Rosso Malpelo” trent’anni dopo (2005), che è un ri-facimento della Lettura storico–sociologica Luperini scrive che il pas-so di RM3 da me dianzi riferito in corsivo è chiarissimo e non si presta punto all’interpretazione che ne ho dato io. Delinea quindi la parafrasi corretta, poi porge al lettore la parafrasi del passo che avrei dato io, er-rata, dopo avere informato che essa tiene conto di un’influenza della Ginestra leopardiana su Verga. Le osservazioni mie riferite da Lupe-rini non sono la parafrasi da me donata del passo di RM3, sibbene il commento al raffronto tra quel passo e un gruppo di versi della Gine-stra di Leopardi, la fonte più vicina e più certa del luogo verghiano.
Produco sotto l’autentica parafrasi del passo di RM3 che avevo do-nato nel volume uscito nel 2002 e che a Luperini è sfuggita:
4 R. LUPERINI, Verga e le strutture narrative del realismo, Saggio su «Rosso Malpelo»,
Padova, Liviana Editrice 1976, p. 63 (corsivo mio). 5 «anche Malpelo odiava le notti di luna, la “placida notte” e “il verecondo raggio della
cadente luna” perché per lui che è fatto per vivere sotterra, “ci dovrebbe essere buio sempre e dappertutto”» (L. RUSSO, Giovanni Verga, Bari, Laterza 19413, p. 98).
6 R. LUPERINI, Lettura storico-sociologica, cit. (cfr. nota 22 al capitolo primo della parte seconda, Appunti sulle stampe di Rosso Malpelo), p. 549 (corsivo mio).
POSTILLA I – Notti estive e firmamento in Rosso Malpelo
225
Mi pare che il senso vero del passo con particolare riferimento a RM3 sia trasmesso dalla seguente parafrasi interpretativa, implicita nelle o-
biezioni qui mosse alle spiegazioni prese in esame: Malpelo ama le notti e-stive piene di luna perché la volta celeste gli appare allora risplendente di stelle, mentre il circostante paesaggio della sciara, della campagna e anche del mare è avvolto da una totale oscurità, che lo occulta e impedisce all’occhio di percepirlo. In quei momenti il fanciullo, disteso a terra sopra il suo sacco, con il viso e gli occhi rivolti al cielo, si abbandona in pace al si-lenzio e alla contemplazione della volta stellata. Egli detesta invece le notti di luna, perché la luce lunare offusca la luminosità delle stelle, attenuando il fascino suggestivo del cielo stellato, e soprattutto regala spicco e nitidez-za di contorni agli elementi del paesaggio sublunare, i quali ricordano al Rosso il suo duro e disperato destino: il mare, in cui si riverbera con infini-te scintille la luce della luna (lo scintillio del mare contribuisce a togliere risalto al cielo stellato e a darne invece ai contorni della campagna e della sciara), la campagna (qui considerata soprattutto come l’elemento che con-fina con la sciara, immediatamente suscitando il ricordo o la percezione di questa) e soprattutto la sciara, la quale, alla luce della luna, appare più ari-da, spoglia e desolata che mai. Riaffiorano di conseguenza in Malpelo i consueti pensieri cupi e sepolcrali7. Soggiungevo subito dopo (e Luperini non si è soffermato né nel
suo testo né in nota su queste espressioni, assai più importanti come complementi e supporti della mia interpretazione rispetto a quelle da lui riportate):
La descrizione del cielo e del paesaggio è squisitamente verista: chiunque abbia trascorso un periodo estivo in Sicilia e vi abbia ammirato il cielo e il paesaggio da una località di campagna priva di illuminazione, sa che nelle notti senza luna è impossibile distinguere, neppure vagamente, i contorni del paesaggio, mentre in cielo le stelle brulicano in modo spettacolare, co-me a sciami radianti. Per contro, nelle notti di luna la luminosità delle stelle si attenua, e la luce lunare rischiara abbastanza distintamente il paesaggio8. La parafrasi da me procurata (in ogni caso il lettore è indotto a crede-
re che quella recata da Luperini costituisca la parafrasi da me proposta) sarebbe invece secondo lo studioso questa che trascrivo qui sotto:
Come l’io lirico leopardiano, seduto di notte sulla cava pietrificata [io ave-vo scritto “sulla lava pietrificata”, N.d.A.], contempla “dall’alto fiammeg-
7 Dai suoni al simbolo, cit., pp. 251–252. 8 Ivi, p. 252.
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle
226
giar le stelle”, così Malpelo, sdraiato di notte sulla sciara, contempla le stel-le che “splendevano lucenti” come “luminaria dell’alto (i corsivi sono miei) [io avevo posto le virgolette di chiusura dopo alto, N.d.A.]. […] per Malpe-lo lo spettacolo delle stelle, la “luminaria dell’alto” nelle notti in cui non c’è luna, è la sola esperienza del pieno abbandono a una impressione del tutto positiva, è un oblio del proprio esserci (della coscienza riflessa di sé) che è però anche piacere, inconsapevole apprezzamento della capacità di provare sensazioni. Esplicita antitesi delle stelle è per lui la sciara, coinci-dente con il momento negativo, con la stretta mortale: antitesi sensibile e anche antitesi psicologica, esistenziale, morale, estetica9. Questa, come ognun vede, non è la parafrasi da me donata del pas-
so di RM3, sibbene il commento al raffronto tra quel passo e un grup-po di versi della Ginestra di Leopardi, la fonte più certa (e riscontrata da Verga) ancorché non vicinissima del luogo di cui si sta discorren-do. Luperini commenta poi così quella ch’egli ha supposto essere la mia parafrasi:
Nel testo non c’è traccia di un’esperienza effettiva di abbandono allo splendore del cielo stellato né di autocompiacimento nel personaggio per la propria capacità di provare sensazioni, né di oblio del proprio esserci, né di antitesi morale, esistenziale ed estetica tra le stelle e la sciara. Vi si dice solo che, stanco della lunga giornata, Malpelo si godeva la quiete di quella luminaria dell’alto. Nessuna disinteressata contemplazione «dell’io lirico». Il verbo («godersi») rimanda a una precisa sensazione fisica e psichica, do-vuta al rilassamento del riposo, al silenzio della notte e alla vista delle stelle (nell’autografo manca addirittura il verbo, e si legge soltanto: «Allora egli soleva sdraiarsi sul sacco, rifinito dalla stanchezza, a guardare in alto; e o-diava perciò le sere di luna in cui il mare brulica di scintille, e la campagna biancheggia qua e là diversamente, e la sciara sembra più brulla e desola-ta»)10. Quel che leggendo Luperini non sono riuscita a comprendere è se a
parer suo l’influenza della Ginestra sia da ridimensionare sensibil-mente oppure se quell’influenza abbia agito efficacemente su Verga ma non sia esatto il mio commento–raffronto dei due testi («Le impli-cazioni esistenziali ed estetiche sono un’aggiunta della Riccobono. Un’influenza di Leopardi è probabile, ma è avvertibile più in alcune
9 R. LUPERINI, Verga moderno, pp. 81–82. 10 Ivi, p. 82, i corsivi sono miei.
POSTILLA I – Notti estive e firmamento in Rosso Malpelo 227
suggestioni paesaggistiche e filosofiche che nella situazione di fat-to»)11. In ogni caso è mio dovere: 1) confermare che Verga si ricordò intensamente della Ginestra12; 2) che nulla trovo oggi da modificare nel raffronto Verga–Leopardi (RM3–Ginestra) da me sviluppato nel 2002 (Malpelo «gode» alla vista del cielo stellato nelle notti senza lu-na mentre prova un’emozione tutta negativa nelle notti di luna; l’io li-rico della Ginestra, invece, rimane dal punto di vista emotivo del tutto indifferente a ciò che vede, e non riflette né sulla luce né sul buio). Sa-rebbe stata colpa mia grave commentare in parallelo i due luoghi d’autore senza dare al lettore la possibilità di comprendere quanto di-versa sia la Weltanschauung delle due menti che si trovano al cospetto della natura notturna. Toccavo dell’argomento per prima, e le conside-razioni brevemente sviluppate hanno richiesto un lessico adeguato a entrambi gli autori, cioè tale da non impoverire un poeta dalla Weltan-schauung sommamente complessa quale è Leopardi. La Weltan-schauung iscritta nella novella di Verga nello studio del 2002 l’ho ribadito fino alla nausea è sì complessa essa pure; però è espressa con un lessico “medio” e la si comprende a fondo solo a partire dalla relazione intrinseca stretta da RM(1–3–4) con l’Inferno di Dante e con il carme dei Sepolcri. Di tutto ciò avevo trattato distesamente nei capi-toli che precedono quello su cui Luperini si è soffermato. Nelle succi-tate righe finali di Luperini si rinviene un procedimento filologico che proprio non mi sento di condividere: nel raffronto delle varianti si
11 Ibidem. 12 A ricordarsi della Ginestra e probabilmente a riscontrarla Verga fu indotto da analogia
delle due situazioni: l’io lirico leopardiano contempla di notte, seduto sulla sciara alle pendici del Vesuvio, il firmamento stellato che si rispecchia nel mare; a Malpelo, sdraiato sulla sciara alle pendici dell’Etna, Verga fa contemplare la volta celeste stellata, ma veristicamente trova la maniera di evitare che egli percepisca il mare: veristicamente, perché per esperienza lo scrittore sapeva che dalle pendici dell’Etna, più lontane dal mare rispetto a quelle del Vesu-vio, era possibile non scorgere il mare nelle notti di luna nera. Verga ha tenuto presente la quarta strofa, vv. 58–66, della Ginestra: «Sovente in queste rive, / Che, desolate, a bruno / Veste il flutto indurato, e par che ondeggi, / Seggo la notte; e su la mesta landa / In purissimo azzurro / Veggo dall’alto fiammeggiar le stelle, / Cui di lontan fa specchio / Il mare, e tutto di scintille in giro / Per lo vòto seren brillare il mondo» (G. LEOPARDI, Canti, in Id., Tutte le ope-re, con introduzione e a cura di W. Binni, Firenze, Sansoni, 1969, vol. 1. La Ginestra si legge alle pp. 42–45). Per il raffronto Leopardi–Verga rinvio al capitolo secondo (Presenza o assen-za di Leopardi in Rosso Malpelo) del mio qui senza dubbio troppo citato volume Dai suoni al simbolo, pp. 252–255 («troppo» non per mia volontà ma per necessità dettata dal dovere di ri-stabilire il vero).
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle
228
procede infatti come se la redazione iniziale del testo (RMA), aperta e provvisoria, rispecchiasse in modo più perspicuo ciò che l’autore e-sprime in una redazione posteriore (in RM3); ma questa è diversa ap-punto perché l’espressione originaria è stata dall’autore ritenuta poi insoddisfacente ed egli l’ha corretta.
Si consideri ora la parafrasi del medesimo passo di Rosso Malpelo fornita da Luperini nel volume del 2005:
Il senso del passo della novella a me pare questo: la luce della luna permet-te di scorgere sia il mare che formicola di scintille, sia la campagna e la sciara, che così sembra anche più brutta e desolata. Meglio le notti senza luna dove Rosso può vedere soltanto lo scintillio lontano delle stelle sulla sua testa. Mentre quella luminaria dell’alto offre un momento di quiete a chi come lui è stanco del lavoro della giornata, la distesa di tenebre che lo circonda, ora compatta perché non contrastata dalla luce lunare è partico-larmente adatta a lui che preferisce l’oscurità alla luce: «Per noi che siamo fatti per vivere sotterra, pensava Malpelo, ci dovrebbe essere buio sempre e dappertutto»13. Mentre nel 1976 Luperini aveva sostenuto che il cielo di Malpelo
deve essere nero ora egli conviene che Malpelo apprezza la vista del cielo stellato nelle notti senza luna. La parafrasi da me offerta ha dun-que influenzato lo studioso, spingendolo a modificare i suoi convin-cimenti in ordine al rapporto cielo–stelle, che nel passo è nulla di me-no che fondamentale. Come mai egli non si è reso conto di cio? E co-me mai errori di distrazione non lievi («cava» per «lava», cioè sotter-raneo per superficie terrestre!) si sono insinuati, per rimanervi, all’interno delle parti di discorso mie quali egli le riferisce nel suo li-bro? E come mai Luperini mi attribuisce pensieri che non ho mai pen-sato? Per esempio, la «disinteressata contemplazione “dell’io lirico”» di Malpelo che Luperini contesta recisamente e mi rinfaccia è una in-venzione dello stesso Luperini: io ho parlato dello spettacolo di una natura notturna splendida descritta dall’io lirico leopardiano con asso-luta indifferenza a essa, e ho contrapposto a tale indifferenza le due diverse posizioni emotive di Malpelo (abbandono nelle notti senza lu-na e turbamento in quelle di luna)14. Luperini rovescia il senso del mio
13 R. LUPERINI, Verga moderno, cit., pp. 80–81. 14 Dai suoni al simbolo, cit., p. 254.
POSTILLA I – Notti estive e firmamento in Rosso Malpelo 229
discorso e attribuisce a Malpelo l’io lirico di Leopardi e quasi la posi-zione di questo. Ancora: nel raffronto Verga–Leopardi io non ho mai usato l’espressione «autocompiacimento» del personaggio, perché questa espressione (il compiacersi di se stessi) non significa punto o-blio della coscienza riflessa (e men che meno oblio di quella sponta-nea, è ovvio) di sé e neppure apprezzamento inconsapevole della pro-pria capacità di provare sensazioni. Ancora: Luperini scrive che «semmai Malpelo riflette sul buio, non sulla luce»; il suo lettore può allora essere tratto a credere ch’io abbia scritto o suggerito, forse sur-rettiziamente e perfino in maniera non intenzionale, che l’io lirico leo-pardiano rifletta sulla luce15. Nel mio studio invece si legge che esso è del tutto indifferente allo spettacolo della natura che lo circonda, ed è indotto dalle stelle soltanto «a una razionale e sentenziosa meditazione sulla infima condizione e importanza del pianeta Terra e di quel suo abitatore chiamato uomo»16. Ho insistito in modo martellante sulla «sostanziale differenza ed estraneità dei due testi quanto alle situazio-ni esistenziali in cui si trovano i protagonisti»17. È Luperini colui che attribuisce, indirettamente e forse in maniera non intenzionale, inesi-stenti riflessioni sulla luce all’io lirico leopardiano. Tutte codeste non sono sviste da poco.
Si riprenda in considerazione l’ultima (in ordine di tempo) parafrasi proposta da Luperini. Egli traduce «splendevano lucenti» con «scintil-lio lontano». Nel testo non c’è alcun elemento che autorizzi l’inserzione dell’avverbio “lontano”. Al massimo, si potrebbe accetta-re la traduzione «lo scintillio delle stelle sulla sua testa», che non sto-na con l’altra espressione «Luminaria dell’alto»; in tal modo verrebbe banalizzato, ridotto a lessico giornalistico, il significato delle parole poetiche di Verga, inteso a fornire risalto alla luce fiammeggiante del-le stelle («splendevano lucenti», cioè sfolgoravano) nelle notti di luna nera, luce che ha positivo effetto calamitante su Malpelo. «Dell’alto» significa al disopra, in antitesi con la sciara e la campagna all’altitudine delle quali si trova Malpelo rischiarate un pochino dall’aborrita luce della luna. Questa luce viene “moltiplicata” dal mare
15 R. LUPERINI, Verga moderno, cit., p. 82. 16 Dai suoni al simbolo, cit., p. 254. 17 Ibidem.
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle 230
(che rispetto al ragazzino è assai più in basso), il quale grazie alla luna formicola di scintille. Lo «scintillio lontano» delle stelle non è quello percepito da Malpelo, sibbene quello che percepiamo oggi noi nelle notti serene dalle nostre città, strade, autostrade e dai nostri paesi o paesetti dotati di illuminazione stradale notturna, mai o quasi mai privi di inquinamento luminoso e di “smog”, e anche dalle case con giardini illuminati di notte da lampioni. Nondimeno è da prendere atto con compiacimento e approvazione del fondamentale ripensamento del critico di cui s’è toccato all’inizio del precedente capoverso.
Non corrisponde all’intenzione espressiva di Verga, invece, il col-legamento diretto che Luperini istituisce tra il primo periodo del pas-so, da «pure, durante» fino al punto e virgola («luminaria dell’alto») con i pensieri di Malpelo riferiti in discorso diretto dal narratore e pensati dal Rosso quando le notti di luna permettono al ragazzino di vedere (anzi obbligano il ragazzino a vedere) i contorni del paesaggio. Per sostenere questo collegamento Luperini è costretto anzitutto a in-vertire l’ordine (e quindi i legami logici e semantici) tra le due parti iniziali del passo, e poi a alterare il senso certo di alcune parole o e-spressioni: egli traduce come se Verga avesse scritto: 1) Malpelo o-diava le notti di luna, in cui il mare formicola di scintille, e la campa-gna si disegna qua e là vagamente; 2) allora la sciara sembra più brulla e desolata 3) durante le nere notti d’estate, le stelle [scintilla-vano lontane] anche sulla sciara, e la campagna circostante era per-ciò nera anch’essa, come la sciara, ma Malpelo stanco della lunga giornata di lavoro, si sdraiava sul sacco, col viso verso il cielo, a [ri-posarsi in] quella quiete e quella [non intensa] luminaria dell’alto Per noi che siamo fatti per vivere sotterra, pensava Malpelo, ci do-vrebbe essere buio sempre e dappertutto. Ho usato il corsivo per ren-dere ben visibili le parole in tondo. Tra parentesi quadre in tondo normale ho immesso parole, appartenenti quasi tutte al vocabolario del Verga rusticano, indispensabili a giustificare la parafrasi di Luperini; ho spostato al medesimo fine la posizione del «perciò» e dell’ag-gettivo «nera»; ho anche soppresso le parole che ostacolano la tradu-zione proposta dal critico, come l’aggettivo «belle» (connotazione e-stetica) e il verbo «godersi» (ricevere soddisfazione e diletto; per lo più, secondo l’etimo e i dizionari, gioire: connotazione emotiva di una Erlebnis, di un vissuto).
POSTILLA I – Notti estive e firmamento in Rosso Malpelo 231
Nel passo è invece scritto diversamente dalla versione proposta da Luperini che: 1) Malpelo, nelle notti senza luna, quando tutto il paesaggio intorno a lui si agguaglia in un buio indifferenziato ed è im-possibile distinguere la sciara, si riposa dopo essersi sdraiato sul suo saccone e intanto gode, prova autentico piacere, per la quiete in cui si sente immerso e per la vista delle stelle luminosissime alte in cielo, quasi festose 2) Malpelo detesta le notti di luna perché la luce lunare rende il mare scintillante dei propri riflessi, e fa intravedere la campa-gna e soprattutto la sciara, la quale alla luce della luna piena è demar-cata abbastanza distintamente dalla campagna e sembra, nella conti-guità con la campagna, più orrida che mai 3) la percezione di questo orrore ridesta in Malpelo i consueti pensieri masochisti, cupi e sepol-crali.
Confermo che ai sensi della grammatica e della costruzione lin-guistica generale non si danno altre possibilità: è l’orrore (spontaneo, se così piace) alla vista della sciara ciò che riconduce Malpelo a in-vocare o a desiderare in modo esplicito le tenebre perenni e la per-manente esistenza sotterranea e in modo implicito la morte. Rinvio alla parafrasi leggermente amplificante da me procurata nel mio stu-dio del 2002 e recata qui sopra. Confermo le deduzioni ovvie che l’interprete trae su suggerimento dell’autore, quali quella per cui lo scintillio del mare contribuisce nelle notti di luna ad accrescere e a diffondere il chiarore. Due sole modificazioni, lievi, apporterei oggi a quella mia parafrasi: il termine di Verga «quiete» era stato da me tradotto con “silenzio”. In realtà le notti estive (di queste si sta par-lando) sulle alture disabitate e nelle campagne di Sicilia non sono af-fatto silenziose; molti animali vi si muovono e la brezza notturna crea essa pure in vario modo interruzioni del silenzio. Nel termine «quiete» è sì implicata anche un’esperienza di silenzio almeno rela-tivo, in confronto alle urla e ai colpi di piccone della giornata; ma la «quiete» è soprattutto calma, pace, riposo dell’animo possibile in una situazione di rilassamento del corpo: è appunto l’opposto dell’inquietudine, dell’agitazione. Verga nell’autografo aveva insisti-to solo sul riposo del corpo («Allora egli soleva sdrajarsi sul sacco, rifinito di stanchezza, a guardare in alto»).
Nel percorso correttorio dall’autografo a RM3 Verga sente il biso-gno di attenuare alquanto la mera fisicità o corporeità del riposo di
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle
232
Malpelo e di accennare l’abbandono di Malpelo a una quiete che av-volge tutta la sua persona (fisica, mentale, spirituale) durante le notti senza luna; il godimento della «luminaria dell’alto» ed è questa la seconda lieve modificazione da apportare sicuramente reca implici-tamente il senso, come meglio si vedrà, che Malpelo ha l’impressione di assistere a un evento festoso. Poi Verga contrappone quella quiete, l’abbandono al cielo stellato, quasi addobbato a festa, e la correlativa sensazione del piacere, all’inquietudine spirituale e al sentimento dell’orrore che afferrano il ragazzino nelle notti di luna (inquietudine e sentimento dell’orrore che sono già presenti nell’autografo ma non in contrapposizione chiara all’altra esperienza).
Luperini mi rimprovera di avere scritto che Verga adopera una grammatica difficile e un poco contorta18: io, a dire proprio il vero tro-vavo e trovo del tutto perspicuo il significato del passo e ne trovavo e trovo magnifica ed efficacissima la forma espressiva (anche quella grammaticale); mi pareva però assai strano che molti critici eminenti avessero frainteso il testo e quasi cercavo spiegazioni di ciò. Mi è parso che due studiosi i quali hanno impresso un’orma negli studi su Verga fornissero giudizi contemperando i quali era possibile render conto sia del generale fraintendimento del passo sia della sua effettiva semplicità: per un verso Vittorio Spinazzola, là dove scrive che a rappresentare «il faticato, riluttante e tuttavia inevitabile abbandono del sogno», l’impossibilità di abbandonarsi all’estasi, Verga si avvale di un «sapien-te uso dei contorcimenti anacolutici e delle sfasature logiche» (Spinaz-zola tiene presente il testo secondo RM4 e si riferisce dunque ai legami «ma […]; perciò […] perchè»)19; e per un altro verso, opposto, mi sono lasciata influenzare da Alfredo Stussi, il quale, alcuni anni or sono, nella breve discussione che seguì la sua relazione a un Convegno in Gargnano organizzato dal Dipartimento in cui presto servizio, sostenne che di anacoluto, nelle connessioni sintattico–grammaticali presenti nel
18 Riferisco le mie parole di allora: «Questa interpretazione si rafforza guardando al testo
di RM4, ove, come si è già scritto, Verga ha instaurato all’interno del primo passo connessio-ni subordinanti, creando un fortissimo legame di causa–effetto: “perciò odiava le notti di lu-na,” (effetto), “perchè allora la sciara sembra più brulla e desolata.” (causa). È un legame sin-tatticamente non lineare, che di primo acchito può sembrare perfino scorretto» (Dai suoni al simbolo, cit., p. 252).
19 V. SPINAZZOLA, Verismo e positivismo, Milano, Garzanti 1977, p. 63.
POSTILLA I – Notti estive e firmamento in Rosso Malpelo
233
passo di cui si sta discutendo, proprio non era da parlare; e affermò che a parer suo il «ma», il quale introduce il secondo periodo di esso, dopo «sciara,» aveva mero valore coordinante, forse un poco enfatico. Ciò posto, non ho difficoltà alcuna ad ammettere che il «ma» potrebbe avere un valore concessivo o lievemente avversativo: Malpelo, sfinito dalla fatica, nelle notti estive senza luna, malgrado una oscurità totale avvol-ga il paesaggio di superficie, si sdraia sul suo sacco col viso rivolto ver-so l’alto e gode allo spettacolo festoso del cielo sfolgorante di stelle. In-fatti, quando il buio avvolge il paesaggio circostante rendendolo indi-stinto, Malpelo non percepisce i contorni dei luoghi che gli ricordano il suo duro destino, e segnatamente della sciara angosciante e desolata; la sua mente e la sua emotività si distraggono allora da essi e in particolare da quella e si concentrano spontaneamente sul cielo lucente di stelle, fonte di piacere.
Luperini ricorda che «l’autore» (la parola è di Luperini; io avrei scritto “il narratore”) nei capoversi precedenti il passo che si sta com-mentando aveva messo insistentemente in risalto la negatività della sciara. Lo studioso soggiunge che «proprio tale negatività la rende [la sciara, N.d.A.] preferibile alla luminosità dei raggi lunari»; e che «no-nostante dunque tale negatività, le notti d’estate (s’intende, come si capisce dopo, quelle senza luna) sono belle, vi splendono le stelle e la campagna è nera come la sciara». Ancorché «la campagna sia allora tutta nera e somigli alla sciara assumendone la negatività, tuttavia (“Ma”) Rosso, stanco della dura giornata di lavoro, si gode la lumina-ria dell’alto». Argomenta Luperini: «evidentemente il narratore che espone la vicenda e la cui ottica non coincide con quella del protago-nista contrappone l’oscurità (e la conseguente negatività, dal suo pun-to di vista) della campagna alla soddisfazione di Rosso che si riposa guardando il cielo, e per questo inserisce una avversativa, “Ma”». In effetti, a parere del critico, «la prospettiva del personaggio è diversa da quella comune degli uomini e dello stesso narratore: proprio per-ché (“Perciò”) Rosso preferisce intorno a sé le tenebre (quelle della sciara e quelle della notte) e sopra di sé soltanto lo scintillio delle stel-le, odia la notte lunare che invece fa formicolare di scintille il mare e rivela tutta la desolazione della sciara». E ancora: «Il nero della cam-pagna e della sciara è indubbiamente negativo per tutti, dunque anche per il narratore. Ma per Rosso diventa paradossalmente positivo: in
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle
234
quanto rivela la vera essenza negativa della vita, è preferibile all’incanto lunare. Per chi vive sotterra, infatti, “dovrebbe essere buio sempre e dappertutto”». Luperini ha fede in un dogma e quasi gli at-tribuisce il carattere di verità assoluta: «la logica coerente di questo personaggio solitario e scostante è ovviamente contrapposta alla logi-ca comune (espressa anche dalla voce narrante) che odia invece la negatività della notte e della sciara e ama le notti lunari»20.
Mi permetto di tirare le somme: secondo Luperini la sciara è asso-lutamente negativa. Tale negatività la renderebbe preferibile alla lu-minosità delle notti di luna (e questo pare sia l’intenzione dell’autore e il punto di vista di Malpelo). Perciò Malpelo preferisce le notti tene-brose, senza luna, in cui la campagna è nera e assume tutta la negativi-tà della sciara. Il narratore e tutti gli uomini comuni (inclusi tutti i let-tori) invece preferiscono le notti di luna, perché la luce lunare è per tutti (eccezion fatta per Malpelo) necessariamente incantevole. Le not-ti di luna nera in cui in cielo si vedono esclusivamente le stelle vanno bene soltanto per Malpelo (il quale guarda il cielo stellato), e sono in-vece avversate dal narratore e dal comune degli uomini. Nelle notti di incantevole luna piena, da Malpelo odiate e sentite come tutt’altro che incantevoli, si rivela completa la desolazione orrida della sciara. Nelle notti di luna nera, sciara e campagna si fondono in un paesaggio tene-broso e basta. La tenebra nerissima che rende indistinguibili sciara e campagna è negativa per tutti, narratore e uomini comuni, ma per Malpelo è positiva, perché rivela la vera essenza negativa della vita (per chi è dannato a un’esistenza sotterranea dovrebbero esserci sem-pre tenebre nere e basta). Da questa ricostruzione si evincerebbe che quella di Malpelo è una «logica coerente», e che «elementari ma strin-genti e lucidissime» sono le sue argomentazioni (cioè quelle di Lupe-rini).
Una cosa son certa di averla capita: Luperini ama le notti di luna piena che rischiarano il paesaggio e non ama invece quelle di luna ne-ra in cui il buio avvolge terra e mare mentre in cielo risplendono me-ravigliose le stelle. Dunque a Luperini poco importa delle stelle, e il suo gusto estetico, secondo che egli ci informa, è condiviso dallo stu-
20 R. LUPERINI, Verga moderno; la prima citazione si legge alle pp. 80–81, nota 17; quelle
successive ivi, nota 17, p. 81; i corsivi sono miei.
POSTILLA I – Notti estive e firmamento in Rosso Malpelo 235
dioso americano Nelson Moe21. Ne ho piacere per Luperini. Torno al testo di Verga. Se le cose stanno così come scrive Luperini, perché Malpelo non apprezza la possibilità, donatagli dalle notti di luna, di scorgere distintamente l’orrore della sciara, la quale è sempre «nera e rugosa», che sia giorno o che sia notte con chiarore lunare? Vedere sotto la luna l’orrido colore nero della sciara dovrebbe essere confer-ma almeno parziale di questa negatività che per lui è positività. Preve-do l’obiezione: ma nelle notti di luna le tenebre non avvolgono tutto, tutto agguagliando sotto il cielo in tenebre nere; è questo tutto negati-vo nero (negativo per il narratore e il comune degli uomini) ciò che è paradossalmente positivo per Malpelo. Ah sì? E allora perché nelle notti di luna nera, dimentico che suo compito è di immergersi nelle te-nebre, per esempio mettendosi a riposare di fianco o a pancia in giù o almeno chiudendo gli occhi; perché il Rosso se ne sta a guardare le «stelle che splendevano lucenti anche sulla sciara», godendosi, insie-me alla quiete, «quella luminaria dell’alto»? Questa non è una que-stione personale; il vero è che soltanto la parafrasi da me proposta consente di capire cosa sia veramente espresso in un luogo fondamen-tale di uno tra i più pregevoli racconti che siano mai stati scritti. Quan-to all’incanto delle notti stellate e a quello, tutto diverso, delle notti di luna: Giovanni Verga preferiva di gran lunga l’incanto delle notti stel-late. Che il narratore da Verga manovrato tanto sapientemente, come appunto scrive il critico, preferisca l’incanto della luna alle notti pu-ramente stellate è una mera invenzione di Luperini 22. Il narratore, che è in questo caso semplice e innocuo portatore diretto del gusto dell’autore, mostra invece una implicita ma evidente preferenza per le stelle, per l’incanto delle stelle e del firmamento stellato rispetto al fa-scino che su altri esercitano la luna e il paesaggio sotto la luce lunare. È doveroso ricordare che intensissimo valore estetico e morale attribuì alle stelle, nella Divina Commedia, Dante, il padre della nostra lingua e della nostra poesia, dal cui magistero Verga trasse il massimo profit-to stilistico, e non stilistico soltanto, specie per RM. Anche in luoghi di RM nei quali la luna non avrebbe stonato affatto (peraltro può darsi che vi sia anche un po’ di luna in cielo: non se ne parla) la corposità
21 Ibidem. 22 Cfr. R. LUPERINI, Verga moderno, pp. 74–75.
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle 236
della notte, e di una notte che si vuole bella, è indicata dalle stelle. L’incidente in cui muore il padre di Malpelo accade a tarda sera, e il narratore vuole mettere in risalto l’antitesi tra la bellezza (raggiante di stelle) della notte fuori della cava e l’evento luttuoso che sta per acca-dere in miniera (e in concomitanza con il quale si spegnerà d’improv-viso la lanterna):
Adunque il sabato sera mastro Misciu raschiava ancora il suo pilastro che l’avemaria era suonata da un pezzo, […]; e intanto borbottava: Questo è per il pane! Questo pel vino! Questo per la gonnella di Nunziata! e così andava facendo il conto del come avrebbe speso i denari del suo appalto il cottimante! Fuori della cava il cielo formicolava di stelle, e laggiù la lan-terna fumava e girava al pari di un arcolaio; (RM3, pp. 52–53; corsivo mio, N.d.A.) In Appendice alla presente Postilla reco i risultati della piccola e
semplicissima ricerca compiuta sulla LIZ 4, riproducendo i risultati di essa esattamente come li porge la banca dati. Ho selezionato tutte le opere rigorosamente veriste e siciliane di Giovanni Verga (Vita dei campi, Novelle rusticane, I Malavoglia, Mastro–don Geusaldo e le Novelle sparse. Ho compiuto la ricerca inserendo i lemmi “lun*” (luna e lune) e “stell*” (stella, stelle, stellat –a –e –i). I risultati non lasciano adito a dubbi: la luna riveste assai scarso valore nelle notti di Verga, mentre le stelle hanno un valore molto intenso, infinitamente più in-tenso di quello del simpatico pianeta su cui gli Americani hanno con-fitto la loro bandiera (sì, ammetto che ormai condivido in pieno le pre-ferenze di Verga, non a causa degli Americani, ma perché Verga mi ha insegnato a percepire il fascino straordinario delle belle notti estive senza luna). Addirittura, in un caso, il grande scrittore bamboleggia volutamente e ironicamente con la luna del Pastore errante, mettendo nella mente della scervellata Isabella Motta Trao banalissime e insipi-de reminiscenze leopardiane, che si mischiano alle fantasticherie della fanciulla sull’amore proibito tra lei e La Gurna. Nelle medesime opere sopra selezionate ho cercato la parola «luminaria», al fine di controlla-re che uso precisamente ne faccia Verga e in quali contesti la inseri-sca. Ne è risultato che gli addobbi di luci detti «luminaria» sono sem-pre concomitanti a eventi festosi; in un sol caso trattasi, quasi in modo figurato, di un gran numero di ceri accesi all’interno della chiesa per il
POSTILLA I – Notti estive e firmamento in Rosso Malpelo 237
funerale di Bastianazzo. La piccolissima Lia non ancora abituata ad assistere a funerali scambia le copiose candele accese per «luminaria», cioè per illuminazione corrispondente a un evento festoso. Anche di questa seconda piccolissima ricerca inserisco in Appendice i risultati.
Se invece che di Malpelo si stesse parlando di un bambino o di un ragazzino come tanti verrebbe fatto di pensare che egli giochi con le stelle, si metta a sognare o a fantasticare. Le espressioni che usavo per commentare il raffronto Verga–Leopardi, o meglio RM3–La ginestra: «esperienza del pieno abbandono a una impressione del tutto positi-va», «oblio del proprio esserci (della coscienza riflessa di sé) che è pe-rò anche piacere», «inconsapevole apprezzamento della capacità di provare sensazioni» sono giudizi esatti circa la qualità dell’esperienza del Rosso sotto le stelle, ma sono formulati con un lessico relativa-mente difficile, adeguato alla Weltanschauung dell’io lirico leopardia-no e al suo concettualismo. Prescindo dal raffronto Verga–Leopardi e traduco quei giudizi in parole più semplici, teoreticamente meno rigo-rose, un po’ più adeguate a Malpelo, cioè a un ragazzino, e al narrato-re pseudo–popolare: forse Malpelo non riesce a giocare con le stelle, a fantasticare, a sognare, come farebbero gli altri bambini; tuttavia gra-zie alle stelle dimentica per un istante o per qualche minuto la sua vita quotidiana e il suo destino; in quel brevissimo lasso di tempo incanta-to cessa l’angoscioso rimuginare che sempre accompagna il Rosso quando lavora, quando mangia, quando è a casa, quando va in giro da solo alla domenica e così via. Questo angoscioso rimuginare, a suo modo raziocinante, e la logica perversa e disperata che gli è sottesa, sono il contenuto principale della coscienza vigile di Malpelo; la vista del cielo sfolgorante di stelle rapisce Malpelo, così da produrre l’oblio di quel contenuto della coscienza; Malpelo si abbandona a un’espe-rienza di godimento puro; ciò significa che gli è possibile sentire in sé, spontanea, la capacità di godere (se non la sentisse non proverebbe godimento). Le notti estive in cui vi è luce lunare impediscono l’oblio e l’abbandono, anche per pochi istanti, della realtà: Malpelo è afferra-to da fantasie angoscianti, nere, macabre, e rimugina pensieri tetri in quel suo modo più che raziocinante.
Luperini presenta nei suoi interventi recenti su Malpelo un ragazzi-no tutto d’un pezzo, privo di sfumature e di percorso evolutivo (non così nel volumetto del 1976). Dal racconto di Verga, però, si evince
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle 238
che subito dopo la morte del padre Malpelo tenta di non tornare a la-vorare in miniera. Sua madre non si lascia però intenerire; lo ricondu-ce d’autorità alla cava affinché il figlioletto le porti il salario. Malpelo, quando stringe amicizia con Ranocchio, ha già compreso o sta com-prendendo e accettando il fatto per cui da un lato vi sono i “buoni”, i quali sono Bestie (gente che non ha capito come si deve vivere e che pertanto sarà vittima della miniera) quali suo padre e poi Ranocchio; e dall’altra parte ci sono coloro che sanno vivere: a) come il «padrone», che fa il proprio interesse e sfrutta l’ingenuità dei buoni o Bestie fino a provocarne la morte; b) come i “compagni”, soprattutto, che sanno vi-vere e non si lasciano gabbare dal padrone; che lo aiutano a fare corre-re ai buoni o Bestie i rischi mortali ch’essi non corrono; che provano compiacimento crudele a fronte delle disgrazie che accadono ai buoni o Bestie; «che se sei più debole ti pestano la faccia, e se sei più forte, o siete in molti, come fa lo Sciancato, allora si lascia vincere» (RM3, p. 53); c) come quei famigliari (in questa novella le due donne) per i quali i figli sono solo inutili bocche da sfamare nella primissima in-fanzia e poi molto presto carne da lavoro (la formula braccia da lavoro sarebbe troppo umana); e quando già i figli contribuiscono attivamen-te e con sacrificio al sostentamento della famiglia son da continuare a educare a nerbate affinché non si ribellino mai.
Il Rosso per qualche tempo avverte ch’egli avrebbe preferito lavo-rare all’aria aperta, fra i campi, in mezzo al verde, all’ombra dei folti carrubi, sotto il cielo azzurro, con il mare turchino sullo sfondo, in un paesaggio allagato dal sole. Ci pensa ancora, molto di rado, quando dopo il ritorno alla cava gli capita di fantasticare, di sognare; ma or-mai si rassegna fatalisticamente (e in modo acutamente patologico e masochistico) al suo destino. I pensieri cupi costituiscono per lui l’adattamento alla realtà: e subito rivive la morte del padre e ci rimu-gina su, con l’aiuto delle leggende orribili che circondano le sciagure mortali accadute nella miniera. A partire dalla morte del padre la co-munità paesana (specie i compagni di lavoro, i minatori) emargina sempre di più e con crescente sadismo Malpelo, rimasto privo di ogni protezione; la madre e la sorella lo abbandonano; da ultimo muore Ranocchio, il suo ormai unico grande affetto. Via via che questo de-stino di sfruttamento, di angoscia, di maltrattamenti, e di assoluta soli-tudine si compie, Malpelo, creatura ruvidissima ma, sotto la crosta,
POSTILLA I – Notti estive e firmamento in Rosso Malpelo 239
profondamente affettuosa, bisognosa di affetto e capace di straordina-ria oblatività (come dimostra durante il periodo della malattia di Ra-nocchio) si sottomette alla propria sorte, da lui ritenuta ineluttabile; accetta con sempre maggiore rassegnazione tanto che questa rasse-gnazione par coincidere con i suoi desidèri autentici la condizione di abitante della buia voragine labirintea; allora il punto di vista e i giudizi del Rosso e quelli della comunità che lo usa come capro espia-torio vengono sempre più spesso a coincidere; egli quasi invoca come se si fosse escluso per sua scelta dal mondo del sole, del cielo, del mare e della terra fertile , il buio assoluto e gli abitanti della not-te; così come invoca e attende la nullificazione completa; infine si consegna alla morte, liberatrice tanto temuta, fonte di angoscia sempre crescente dal giorno della morte del padre23.
Chi non si è sentito amato da bambino desidera la morte e ne è spa-ventosamente ossessionato. La sua capacità di adattamento alla realtà è solo apparente, è una finzione nella quale colui vuole credere per non smarrirsi completamente nella depressione cieca e nella follia. Ranocchio, fisicamente fragile, dal carattere mite e pauroso ma equili-brato e capace di adattamento autentico alla realtà (vive con una mam-ma che lo ama) è turbato e stupito dalla mancanza di ribellione aperta di Malpelo a fronte delle tante accuse ingiuste che a questo vengono mosse e dei maltrattamenti che subisce (cfr. RM3, p. 60).
L’autore intenzionalmente lascia delineare al narratore anche un paesaggio notturno assai suggestivo “oggettivamente”, vale a dire per-cepito come tale dal gusto ricettivo di chi si è formato in età romantica e dagli epigoni del gusto romantico–leopardiano, ai quali Malpelo è del tutto estraneo. Dei due spaccati di natura avvertita come splendida a parte subjecti, cioè dall’eroe, quello diurno solo fantasticato e quello goduto nelle notti senza luna, ho scritto nel 2002 che «entrambi […]
23 «Poco dopo, alla cava dissero che Ranocchio era morto, ed ei pensò che la civetta ades-
so strideva anche per lui nella notte, e tornò a visitare le ossa spolpate del grigio, nel burrone dove solevano andare insieme con Ranocchio. Ora del grigio non rimanevano più che le ossa sgangherate, ed anche di Ranocchio sarebbe stato così, e sua madre si sarebbe asciugati gli occhi, poichè anche la madre di Malpelo s’era asciugati i suoi dopo che mastro Misciu era morto, e adesso si era maritata un’altra volta, ed era andata a stare a Cifali; anche la sorella si era maritata e avevano chiusa la casa. D’ora in poi, se lo battevano, a loro non importava più nulla, e a lui nemmeno, e quando sarebbe divenuto come il grigio o come Ranocchio, non a-vrebbe sentito più nulla» (RM3, pp. 72–73).
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle
240
preludono a durissimi ritorni a una realtà sottomessa al senso del ma-cabro e dell’orrore, all’angoscia, al dominio assoluto della più tetra “sotterraneità sepolcrale”»24. La sciara è sicuramente antitesi psicolo-gica, esistenziale, morale, estetica ai due spaccati di natura splendida. Solo il fatto dell’antitesi morale potrebbe creare qualche perplessità in un lettore ingenuo. Il resto, dopo tutte le delucidazioni già date, è ov-vio. Ho parlato di antitesi morale delle stelle alla sciara perché Ranoc-chio ha evidentemente notato che la contemplazione delle stelle nelle notti senza luna procura a Malpelo un piacere intenso e quiete25. Così Ranocchio tenta di rendere esplicite anche le spontanee componenti ludico–morali di quella contemplazione e racconta all’amico fantasti-cherie dolci, a lui care, legate all’amore. Tra i due avviene il colloquio circa l’esistenza del paradiso, di cui le stelle sarebbero la sede. Il Ros-so, in modo pacato, oppone all’amico la sua dura “filosofia della real-tà”, una filosofia (morale), e una verità adeguate alla vittoria (cosmi-ca) delle tenebre e alla sparizione della luce.
Sono del tutto d’accordo con Luperini sul fatto della «“terribilità” di Verga, sullo scatto maligno e anticonformistico della sua cattiveria rappresentativa, così antitetica a ogni idillismo e così inconciliabile con ogni riformismo» (p. 83)26. Nel mio libro del 2002 ho dimostrato che la cava intrattiene un rapporto strettissimo con l’Inferno di Dante; salvo che nel mondo di Verga, sulla linea RM(1–3) Mastro–don Ge-sualdo (facevo e faccio molto parzialmente eccezione solo per i Mal) non esistono né Purgatorio né Paradiso, non esiste illusione alcuna di alcun genere:
I temi biblici ed evangelici della caduta, della redenzione, della resurrezio-ne e della vita eterna sono beninteso nell’ultratesto simbolico della novella di Verga rovesciati prima o piuttosto che secolarizzati: vittime e carnefici,
24 Dai suoni al simbolo, cit., p. 251. 25 Su tutto ciò cfr. le mie più sviluppate considerazioni nel volume Dai suoni al simbolo,
cit., specie alle pp. 239–240 e 243–245. Scrivevo tra l’altro, in cortese polemica con Giorgio Bàrberi Squarotti: «è vero che per Malpelo le stelle nulla hanno a che fare con un Dio tra-scendente, però il fatto emotivo della pacificazione interiore, e sia pure generata da limitati momenti di godimento estetico, non può non recare con sé pure un riflesso di indole morale (la liberazione dalle passioni e dall’angoscia del male, almeno durante quegli istanti)» (ivi, p. 245).
26 R. LUPERINI, Verga moderno, cit., p. 83.
POSTILLA I – Notti estive e firmamento in Rosso Malpelo
241
innocenti e colpevoli, tutti possono essere condannati da una sorte cieca e particolarmente avversa alla dannazione infernale dell’esistenza tra le tene-bre in miniera27. Questa vita è la sola vita ed è un inferno, per tutti. Nella cava i rap-
porti e i caratteri si polarizzano, perdono le sfumature e le mezze tinte che è dato trovare nel mondo di superficie: vi sono le Bestie e vi sono quelli che “sanno vivere”. Ma il sapere stare al mondo, l’ottenere gra-zie alla cattiveria, al ghigno del demonio, alla sopraffazione, di poter soddisfare i propri istinti e bisogni primordiali (non soltanto quelli pu-ramente materiali, spesso quelli viziosi) non vale a ottenere né serenità né godimento, neppure quello meramente edonistico. I malvagi (in chiave escatologica, secondo che piace a Verga), cioè gli abitanti della cava che “sanno vivere”, sono equiparabili ai diavoli dell’inferno dan-tesco: questi sono più potenti dei dannati contro i quali incrudeliscono, da aguzzini e da guardiani, ma sono dei dannati, completamente dan-nati, essi pure.
La vita nella cava è un rispecchiamento concentrato della vita tutta; in questo senso la vita nella cava dice la verità sulla vita nel mondo di superficie, più ricca di sfumature, sottigliezze, ipocrisie. Prive di ogni luce (se si vuole con Verga continuare a usare la metafora della luce), prive di ogni gioia e di serenità, malgrado la soddisfazione effimera di appetiti viziosi, sono la vita dello zio Crocifisso, di Mazzarò, del Re-verendo, del campiere Surfareddu, del proprietario della fornace di gesso (per il quale si veda la postilla che segue), della baronessa Ru-biera e di tanti altri tipi che sanno vivere; ma vinti sono tutti, si sa (qualche distinguo è da farsi per i Mal). E dei vinti, dalla vita senza gioia, sono anche Speranza e Bianca, mastro–don Gesualdo e i suoi sprezzanti e stolti cognati Trao, Diodata e Isabella, i due figli “bastar-di” di Gesualdo e il padre di questo, mastro Nunzio. All’interno delle opere appartenenti al ciclo dei Vinti non sono mai rappresentate per-sone delle quali si possa dire che si sentono e che sono o soddisfatte o fortunate, perché hanno raccolto e godono dei frutti della loro tenacia e del loro impegno. Fanno eccezione, insieme a pochi altri personaggi minori, Alessi e Nunziata dei Mal, che non hanno mai avuto la fortuna
27 Dai suoni al simbolo, cit., p. 41.
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle
242
dalla loro parte eppure sono sempre stati sereni e allegri. I due, grazie alla loro capacità di accettare le difficoltà della vita e di reagire sem-pre a esse in modo costruttivo, godono da ultimo di una vita coniugale e familiare serena, sulla quale stende ancora la propria ombra il dolore per ciò che è accaduto, e che è irredimibile.
Esistono nell’opera verista di Verga persone che hanno raccolto e godono soddisfatte, appagate, dei frutti della loro capacità di sopraffa-zione? L’autore non ci permette di apprendere che cosa la sorte riser-verà nel futuro (quello che le novelle non raccontano) alla sorella e al-la madre di Malpelo o al Reverendo e al barone della novella Don Licciu Papa. Nel corso della storia o alla fine di essa costoro incassa-no il premio che si sono guadagnati per il loro cinismo. Il Mastro–don Gesualdo ci porta però a credere che i frutti in questione non avranno lunga durata.
Mi piace ricordare che verso la fine del paragrafo dedicato alla con-futazione del «mio» firmamento notturno e del paesaggio rischiarato dalla luna Luperini scrive: «se non si coglie il tragico rovesciamento della prospettiva comune operato da Rosso, e per di più gli si attribui-scono predisposizioni a incanti e a smemoramenti estetici, temo pro-prio che di questa novella si capisca assai poco». La «cattiveria rap-presentativa» di Verga è «antitetica» a ogni idillismo28. Di «abbandoni idillici», «subito soffocati» da parte di Malpelo ha scritto Luigi Russo, non io, e Luperini (ancorché la sua parafrasi del luogo relativo alle notti o stellate o di luna fosse affiatata con quella frettolosamente do-nata da Russo) gli contestava ciò con durezza fin dal suo saggio del 197629. Russo è stato echeggiato da numerosissimi studiosi: di «va-gheggiamento di partecipazione idillica all’armonia universale» da parte del Rosso ha scritto Vittorio Spinazzola30. Di sempre inconfessa-ta ma vigorosa e insopprimibile «aspirazione idillica a un mondo su cui non pesino più le dure leggi della realtà» ha scritto Gaetano Rago-
28 R. LUPERINI, Verga moderno, cit., p. 83. 29 L. RUSSO, op. cit., p. 99. R. LUPERINI, Verga e le strutture narrative del realismo, cit.,
p. 78, nota 64. Russo molto presente negli anni ’70 alla coscienza riflessa di Luperini occupa ora un posto di rilievo, com’è naturale, nell’immaginario di questo .
30 Op. cit., p. 63: Spinazzola si riferisce al paesaggio diurno meramente fantasticato dal Rosso. Lo stesso critico scrive anche di impulso all’estasi e di impossibilità di abbandonarvisi da parte di Malpelo, che generano «un impulso opposto» (ibidem).
POSTILLA I – Notti estive e firmamento in Rosso Malpelo
243
nese31. Di «lirismo» da Verga ottenuto senza trasfigurazione poetica nella rappresentazione del paesaggio notturno e di «incanto lirico» da lui suscitato e goduto dal lettore ha scritto Giacomo Debenedetti (il quale però non scrive di predisposizione di Malpelo all’incanto)32.
Ad aver capito assai poco di questa novella, anzi a non averne ca-pirne nulla, è Giovanni Verga, che ha osato scrivere pezzi di narrativa inconciliabili con la logica luperiniana e ha fatto in modo da sottrarsi al letto di Procuste su cui il suo critico vorrebbe “aggiustarlo”.
2. Appendice (con i riscontri dalla LIZ 4)
VERGA, G., Vita dei campi [2]
1) quella luminaria dell’alto; perciò odiava le notti di *luna*, in cui il mare formicola di scintille, e – Rosso Malpelo.32
2) la batteva. Finalmente una notte in cui brillava la *luna* nei fi-chidindia, Gramigna le disse Vengono! e – L’amante di Gra-migna.31
VERGA, G., I Malavoglia [8]
1) Era una bella sera di primavera, col chiaro di *luna* per le strade e nel cortile, la gente davanti – Cap. 8.97
2) Nunziata a piangere sotto il nespolo, al chiaro di *luna*. – Cap. 8.110
3) nel cortile dei Malavoglia, con un bel chiaro di *luna*; e sul tardi poi, quando tutti erano stanchi – Cap. 9.65
4) naso in aria, diceva pure: «Quando la *luna* è rossa fa vento, quando è chiara vuol dir – Cap. 10.17
5) affari tuoi; uno di quei grulli che abbaiano alla *luna*! un chiac-chierone! Ma infine cosa ho detto – Cap. 10.202
31 G. RAGONESE, Interpretazione del Verga, Palermo, Manfredi 1965, p. 57. 32 G. DEBENEDETTI, Verga e il naturalismo, Milano, Garzanti 1976, p. 415, da cui sono
tratte le due espressioni recate nel testo tra virgolette basse.
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle
244
6) da un uscio all’altro, e c’era la *luna*, e i vicini discorrevano lì davanti, e si – Cap. 15.50
7) stavano a chiacchierare da un uscio all’altro, colla *luna*, e si u-diva tutto il giorno il colpettare del – Cap. 15.59
8) e la Lia, tutti lì, al chiaro di *luna*, che si sentiva chiacchierare per tutto il paese, – Cap. 15.98
VERGA, G., Novelle rusticane [5]
1) stesso luogo, di notte, che c’era la *luna* di Pasqua, e ci si vedeva chiaro come di – Il mistero.26
2) due, tre, finché il diavolo lo tentò colla *luna* che trapelava sino al letto dalle fessure delle imposte, – Il mistero.29
3) ombra, solo in mezzo alla piazza tutta bianca di *luna*, e in un si-lenzio che si udiva suonare ogni – Il mistero.29
4) e vi muore il sole di brace, e la *luna* smorta, e la Puddara, che sembra – Malaria.1
5) con un rosicchiare secco di ossa, nel chiaro di *luna* che lavava ogni cosa, e mostrava spalancati i portoni – Libertà.9
VERGA, G., Mastro–don Gesualdo [17]
1) cogli occhietti che sorridevano in mezzo al viso placido di *luna* piena. Zitto! zitto. Vado a – Parte 1, cap.3.15
2) il marchese. Il barone Zacco che abbaia alla *luna*. Poi, men-tre scendeva insieme a Bianca, – Parte 1, cap.3.260
3) muro, le mani penzoloni fra le gambe. La *luna* doveva essere già alta, dietro il monte, verso – Parte 1, cap.4.85
4) su di un sasso, col viso bianco di *luna*, il mento sui ginocchi, in un gomitolo. – Parte 1, cap.4.93
5) e si spandevano lontane, nell’aria sonora. La *luna*, ora discesa sino all’aia, stampava delle ombre – Parte 1, cap.4.93
6) fresco, dopo cena, con quel bel chiaro di *luna*, si lasciava anda-re alla tenerezza dei ricordi. – Parte 1, cap.4.105
7) Don Gesualdo spiccherebbe di lassù il sole e la *luna* per farvi piacere!… Non ci vede più dagli occhi – Parte 1, cap.6.46
POSTILLA I – Notti estive e firmamento in Rosso Malpelo
245
8) Sentiva quasi piovere dalla *luna* sul suo viso, sulle sue mani una gran dolcezza – Parte 3, cap.2.8
9) desolazione delle forre dove non poteva giungere il raggio del-la *luna*, la festa delle rocce che s’orlavano d’argento – Parte 3, cap.2.8
10) lei. Laggiù, dietro quel monticello, la stessa *luna* doveva scin-tillare sui vetri della sua finestra, la stessa – Parte 3, cap.2.8
11) stormivano e le portavano tante voci da lontano. *Luna* bian-ca, luna bella!… Che fai, luna? – Parte 3, cap.2.8
12) portavano tante voci da lontano. – Luna bianca, *luna* bella!… Che fai, luna? dove vai? – Parte 3, cap.2.8
13) Luna bianca, luna bella!… Che fai, *luna*? dove vai? che pensi anche tu? – Parte 3, cap.2.8
14) mani esili e delicate, candide anch’esse come la *luna*, con una gran tenerezza, con un vago senso – Parte 3, cap.2.8
15) vuole per lei. Voialtri Trao siete tanti pulcini colla *luna*. Un braccio di mare quella zia Cirmena. – Parte 3, cap.2.10
16) Di dove volete che venga dunque, dalla *luna*? Caro mio, queste son parole al vento. – Parte 3, cap.4.21
17) pare che il signor duca sia ridotto a cercare la *luna* nel pozzo, mi pare! La povera morta – Parte 4, cap.3.3
VERGA, G., Novelle sparse [5]
1) stampava come uno sterminato nuvolone nero sul pallido cielo di *luna* nuova, e le fiamme che si accendevano di tratto – Un’altra inondazione.3
2) viali remoti dei Campi Elisi, quando la *luna* si posava dolce-mente sul lago e le accarezzava le mani – Il come, il quando ed il perché.80
3) cespugli immobili e neri come spettri nel raggio misterioso della *luna*. Penso alle lunghe notti d’inverno, spazzate – Passato!.4
4) errante, coi rumori del vicinato, colla carezza della *luna* che entrava dall’alta inferriata a posarsi sul lettuccio verginale – O-locausto.4
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle
246
5) Sempre! A quella prima notte… di *luna*!… Tutta roba passata! sentenziò la – Una capanna e il tuo cuore.42
VERGA, G., I Malavoglia [1]
1) uno stormo di passere attorno alla fontana, e la *stella* della sera era già bella e lucente, che pareva – Cap. 1.29
VERGA, G., Mastro–don Gesualdo [3]
1) un lume di carbonai, e più a sinistra la *stella* del mattino, sopra un nuvolone basso che tagliava l’ – Parte 1, cap.1.3
2) Vedi, ciascuno viene al mondo colla sua *stella*… Tu stessa hai forse avuto il padre o la – Parte 1, cap.4.127
3) se Dio m’aiuta, saranno nati sotto la buona *stella*!… Vossi-gnoria siete il padrone… Egli – Parte 1, cap.4.129
VERGA, G., Mastro–don Gesualdo [1]
1) alla Fontana di don Cosimo, con una bella sera *stellata*, il cielo tutto che sembrava formicolare attorno a Budarturo – Par-te 3, cap.3.39
VERGA, G., Novelle sparse [1]
1) seguiva nei rumori che giungevano dalla via, nelle notti *stellate*, nel cielo che stendevasi al di là delle inferriate – Olo-causto.10
VERGA, G., Vita dei campi [6]
1) in alto, cogli occhi umidi, quasi tutte le *stelle* che andavano ac-cendendosi in cielo vi piovessero in cuore, – Jeli il pastore.1
POSTILLA I – Notti estive e firmamento in Rosso Malpelo
247
2) e lucenti dietro i monti della Canziria, come le *stelle* che pio-vono in agosto. È come la – Jeli il pastore.68
3) era rossa ed allegra cogli occhi neri che sembravano due *stelle*, e rideva che le si vedevano i denti bianchi – Jeli il pastore.192
4) cottimante! Fuori della cava il cielo formicolava di *stelle*, e laggiù la lanterna fumava e girava al pari – Rosso Malpelo.8
5) Pure, durante le belle notti d’estate, le *stelle* splendevano lucen-ti anche sulla sciara, e la campagna circostante – Rosso Malpe-
lo.32 6) compiacenza a spiegargli quel che ci stessero a far le *stelle* las-
sù in alto; e gli raccontava che lassù c’ – Rosso Malpelo.35
VERGA, G., I Malavoglia [10]
1) proverbio “Mare crespo, vento fresco”. Stasera le *stelle* sono lucenti, e a mezzanotte cambierà il vento; – Cap. 2.17
2) senza andare a cercarle lontano. Guardate quante *stelle* che ammiccano lassù! rispose Mena dopo un pezzetto. – Cap. 2.126
3) Sentite, le disse Alfio dopo che ebbe guardate le *stelle* anche lui; voi che siete Sant’Agata, se – Cap. 2.127
4) Buona sera! rispose Mena. Le *stelle* ammiccavano più forte, quasi s’accendessero, e i – Cap. 2.129
5) prima di chiudere l’uscio, a guardare le *stelle* che luccicavano più del dovere, e poi borbottò: – Cap. 2.130
6) arrivò col berretto sull’orecchio, e la camicia colle *stelle*, che la mamma non sapeva saziarsi di toccargliela, – Cap. 5.59
7) domenica, per menare a spasso la sua camicia colle *stelle*; quel dopopranzo si divertirono a prendersi a pugni con – Cap. 6.9
8) e Mena gli toccava il berretto e la camicia colle *stelle*, per vede-re com’eran fatti, il nonno gli – Cap. 6.12
9) luccicava dall’altra parte, e il cielo formicolava di *stelle*, che parevano le monachine quando corrono sul fondo nero – Cap. 6.16
10) davanti al mare nero, dove si specchiavano le *stelle*, e che rus-sava lento sul greto, e si – Cap. 6.17
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle
248
VERGA, G., Novelle rusticane [3]
1) si facevano schermo stringendosi fra di loro. Ma quelle *stelle*
che luccicavano come spade li passavano da parte a parte – Storia
dell’asino di S. Giuseppe.64
2) casolare più sgangherato della fornace del gesso, dove le *stelle*
penetravano dal tetto come spade, quasi fosse all’aperto – Storia
dell’asino di S. Giuseppe.65
3) grandi occhi pensosi nelle ombre vaganti del mare. Le *stelle*
scintillavano sul loro capo, e attorno a loro non – Di là dal ma-
re.1
VERGA, G., Mastro–don Gesualdo [8]
1) cantonata del Collegio, dal cielo profondo, ricamato di *stelle*
una più lucente, lassù, che sembrava guardasse – Parte 1,
cap.3.209
2) affinato dal chiarore molle: gli occhi come due *stelle*; le belle
trecce allentate sul collo; la bocca – Parte 1, cap.4.97
3) lodò gli occhi, degli occhi blù che erano due *stelle*. “Degli oc-
chi che vedevano il peccato”, disse – Parte 3, cap.1.32
4) finestra, fantasticando, guardando il cielo che formicolava di
*stelle*. La sua anima errava vagamente dietro i rumori della –
Parte 3, cap.2.8
5) fantasie che avevano intermittenze luminose come la luce di
certe *stelle*: le sue amiche, Marina di Leyra, un – Parte 3,
cap.2.8
6) nessuno s’arrischiasse ad aprire la finestra per guardar le
*stelle*. – Speranza ogni tanto s’accostava al malato in – Parte
3, cap.3.16
7) per l’estate? T’insegno io a contar le *stelle*! Non m’hai visto
ancora uscir dai gangheri! – Parte 3, cap.4.8
8) gratis. Lumi, cantate, applausi che salivano alle *stelle*. La si-
gnora Aglae era venuta apposta da Modica, – Parte 4, cap.4.1
POSTILLA I – Notti estive e firmamento in Rosso Malpelo
249
VERGA, G., Novelle sparse [5]
1) Avemaria, voi vi chinate sul parapetto a mirare le *stelle* che ad
una ad una principiano a riflettersi sulla tranquilla – I dintorni di
Milano.10
2) a contemplare l’acqua, i monti e le *stelle*. Lo specchio del lago
riverberava tutte le sfumature dei – Il come, il quando ed il per-
ché.80
3) suo sguardo nel buio interminato, al di là delle *stelle*, e fantasti-
care su quel che doveva rischiarare qualche lumicino – Il come, il
quando ed il perché.80
4) l’ultimo di agosto: una notte buia e senza *stelle*. Bellina andava
avanti, col naso al vento, – La chiave d’oro.9
5) bassure della zolfara, mi parve di essere davvero nelle *stelle*,
all’ombra della tettoia sgangherata che faceva da angiporto – Una
capanna e il tuo cuore.1
VERGA, G., Vita dei campi [3]
1) che in ogni fattoria si fa festa e *luminaria*, e per tutta la campa-
gna si vedono qua e – Jeli il pastore.69
2) di vino e vollero condurlo con loro a veder la *luminaria*, insie-
me alle comari ed ai vicini. Arrivando – Jeli il pastore.98
3) verso il cielo, a godersi quella quiete e quella *luminaria*
dell’alto; perciò odiava le notti di luna, – Rosso Malpelo.32
VERGA, G., Novelle rusticane [3]
1) soltanto a pensarci, e non si godette più la *luminaria*, né la ban-
da che suonava in piazza, né – Cos’è il re.3
2) e tutti quei razzi, quella folla, quella *luminaria* e quello scam-
panìo se li sentiva sullo stomaco, e – Cos’è il re.4
3) che un pezzo di città sfilasse lì davanti, colla *luminaria* delle
strade, e le botteghe sfavillanti. Poi il – Malaria.15
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle
250
VERGA, G., I Malavoglia [2]
1) fiori di carta; e la bambina, vedendo la *luminaria*, e udendo suonar l’organo, si mise a – Cap. 4.5
2) la cornamusa che andava a suonare davanti alle cappellette colla *luminaria*, accanto agli usci. Solo in casa dei Malavoglia – Cap. 6.76
VERGA, G., Mastro–don Gesualdo [3]
1) loro nell’orecchio Santo Motta. Sarà una bella *luminaria* con tutta questa roba vecchia! Per di – Parte 1, cap.1.33
2) fingendo di osservare attentamente l’uomo che andava spegnendo la *luminaria, nella piazza deserta, e il giovane del paratore – Par-te 1, cap.3.209
3) lo scampanìo, la banda che suonava, la *luminaria* più tardi. Le sole finestre che rimanessero chiuse erano – Parte 4, cap.3.5
251
Postilla II
Lettura cristologica della Storia dell’Asino di S. Giuseppe Analizzando qualche anno fa Rosso Malpelo avevo osservato che
nell’ultratesto simbolico della novella verghiana è iscritto un rove-sciamento, intenzionale e ricercato, dell’escatologia biblica e soprat-tutto evangelica1. I temi biblici ed evangelici della caduta, della reden-zione, della resurrezione e della vita eterna vi sono rovesciati, prima e piuttosto che secolarizzati. Malpelo è la vittima principale, sicuramen-te innocente. Dopo la “Passione”, cioè dopo un lungo cammino in di-scesa lungo un Calvario capovolto che si inerpica verso il centro della terra Calvario del quale la sciara rappresenta le pendici egli viene immolato dall’altrui malvagità (in particolare da quella dei “compagni” minatori). Anche mastro Misciu appartiene al sistema delle vittime, ma vi appartiene soprattutto l’asino grigio, dal cui carattere di vittima, dalla cui Passione e dal cui sacrificio si sprigiona un pathos quasi altrettanto intenso rispetto a quello di cui è circonfuso il lento martirio di Malpelo (il Rosso, si badi, è tra i carnefici dell’asino). La Passione e la morte degli agnelli sacrificali non recano nessuna salvezza e nessuna resurre-zione, cioè nessuna redenzione, neppure tutta intramondana.
La Passione e la morte dell’asino grigio, vittima completamente in-nocente, insegnano che la sola redenzione dal male in cui i mortali,
1 La Storia dell’asino di S. Giuseppe, cit., sarà d’ora innanzi indicata con l’abbreviazione
StA (cfr. nota 29 al capitolo III della parte prima: Il Verga verista nel giovane Thomas Mann). La novella era stata primamente pubblicata da Verga sul «Fanfulla della domenica» di Roma, n. 16, il 17 aprile 1881. Per i dati sulla novella Rosso Malpelo e le abbreviazioni con cui la si cita cfr. la nota 1 alla postilla precedente, Il cielo, le stelle e la luna in Rosso Malpelo. Per la Bibbia mi sono attenuta alla Biblia sacra Vulgata iuxta vulgatam versionem (d’ora innanzi Vulgata), adiuvantibus B. Fischer, I. Gribomont, H. F. D. Sparks, W. Thiele, recensuit et brevi apparatu critico instruxit Robertus Weber, editionem quartam emendatam, Deutsche Bibelge-sellschaft, Stuttgart 1994.
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle
252
buoni o malvagi che siano, possono sperare, risiede nel disfacimento completo dell’esserci, nell’annientamento o “dis–creazione” di ogni scintilla di vita e di coscienza.
Il rovesciamento della cristologia pervade l’opera specie verista e rusticana di Verga, in modo più o meno diretto e visibile. È stato intel-ligentemente dimostrato che esso, per esempio, intride Cavalleria ru-sticana a partire dal sistema onomastico, e soprattutto antroponoma-stico, della novella, «finalizzato alla parodia della Pasqua, alla riscrit-tura profana e trasgressiva del mistero cristiano»: «Celatamente rical-cata sulla vicenda evangelica, la tragica storia dell’amante accoltellato è, secondo noi, una Passione imperfetta, in cui la resurrezione è sosti-tuita da una morte che non lascia spazio alla speranza»2. La Passione e morte dell’asino grigio trovano un prolungamento sferzante e sarcasti-co nei confronti della escatologia cristiana ed evangelica in una novel-la che fa parte delle Rusticane, la Storia dell’asino di San Giuseppe. Vi sono raccontate e descritte le stazioni della durissima via crucis percorsa dalla povera bestia a partire dal momento in cui è un puledri-no non ancora svezzato fino alla morte per sfinimento quando è un a-nimale ancora giovane. L’autore si compiace di stabilire un collega-mento diretto tra questo racconto e Rosso Malpelo. Ivi i resti dell’a-sino grigio che si decompongono nella sciara sono denominati «car-came»; toccando di uno dei tanti maltrattamenti subiti da Malpelo all’interno della cava, Verga scrive che «un operaio, lì presente, gli sferrò un gran calcio sulle spalle, un calcio che risuonò come su di un tamburo» (RM3, p. 70, il corsivo è mio). Trattasi di uno dei numerosi luoghi di RM3 in cui sono ricontestualizzate espressioni tolte dall’Inferno di Dante, nella fattispecie dalla rissa tra maestro Adamo e Sinone: «E l’un di lor, che si recò a noia / forse d’esser nomato sì o-scuro, / col pugno li percosse l’epa croia. / Quella sonò come fosse un tamburo;» (XXX, vv. 100–103). La relazione “forte” stretta da Rosso Malpelo con l’Inferno, e il rovesciamento del valore profetico e salvi-fico del viaggio e pellegrinaggio di Dante nell’aldilà costituiscono un elemento–chiave del rovesciamento della escatologia evangelica e cri-stiana nella succitata novella. In essa, però, non si ravvisa ancora sar-
2 P. GIBELLINI, I nomi di cavalleria rusticana, «Il Nome nel testo. Rivista internazionale
di onomastica letteraria», IV–2002, n. 1, p. 84, da cui sono tolte entrambe le citazioni.
POSTILLA II – Lettura cristologica della Storia dell’asino di S. Giuseppe 253
casmo esplicito nei confronti dei grandi sistemi di valori religiosi o a-tei (il carme Dei Sepolcri) che vi sono presi di mira. Nella chiusa di StA un carrettiere propone all’ultima sventurata proprietaria dell’asino di san Giuseppe di comprare la legna che l’asino trasportava prima di stramazzare definitivamente a terra: « Compro soltanto la legna, perché l’asino ecco cosa vale! E diede una pedata sul carcame, che suonò come un tamburo sfondato» (StA, p. 281). In tal modo Verga at-tua anche un congiungimento di StA al pervertimento del viaggio sal-vifico e del profetismo dantesco espressi nel livello simbolico di Ros-so Malpelo.
Puledrino vispo che cerca le poppe della madre, l’asino viene ven-duto dai primi padroni, nella stalla dei quali è nato, durante una fiera a Buccheri. L’asino non ha un nome e mai lo avrà: l’essere privi di no-me, nella mentalità arcaica magica e anche in quella vetero–testamentaria, implica assenza dell’identità, assenza di radici, di fami-glia e di appartenenza tribale, di casa, e anche di un padrone preciso. A partire dal momento in cui viene venduto il puledro infatti perde per sempre tutte queste cose3. La prima compravendita, la più laboriosa e impegnativa sia per chi vende che per chi compra, apre una serie di al-tre compravendite (altre quattro per l’esattezza) fino all’ultima, in cui l’asino morto, definitivamente ridotto a cosa inerte non può neppure esser più oggetto di mercato o di scambio. Il carrettiere acquista solo la legna, perché dell’asino non ha valore alcuno neppure la pelle: scuoiarlo sarebbe anti–economico4. Sia in ogni venditore che in ogni
3 «lasciare per sempre la stalla dov’era stato al caldo, accanto alla madre, a fregarsi il mu-
so sulla sponda della mangiatoia, o a fare a testate o a capriole col montone, e andare a stuzzi-care il maiale nel suo cantuccio. E la padrona, che contava di nuovo i denari nel fazzoletto da-vanti al banco dello speziale, non pensava nemmen lei che aveva visto nascere il puledro, tut-to bianco e nero colla pelle lucida come seta […]. La sola che si rammentasse del puledro era la ciuca, che allungava il collo ragliando verso l’uscio della stalla; ma quando non ebbe più le poppe gonfie di latte si scordò del puledro anch’essa» (StA, p. 274).
4 Nella novella Jeli il pastore il puledro chiamato lo stellato, il quale si è rotto le gambe, viene ucciso dal fattore in modo che si possa almeno prendere la sua pelle. Ancor più interes-sante la chiusa della novella Gli orfani (1881) che fa parte delle Rusticane. Compare Meno si lascia persuadere facilmente, mentre è accanto alla salma della moglie, a contrarre un nuovo matrimonio con la cugina Alfia. Allora si rivolge alla vicina di casa Angela, che ha appena perso di malattia il suo asino, e le dice con tono consapevole del fatto che la sventura di lei è peggiore di quella occorsa a lui: « Ora che ci aspettate a fare scuoiare l’asino? Almeno pi-gliate i denari della pelle» (G. VERGA, Gli orfani, in Tutte le novelle, cit., p. 261).
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle
254
acquirente che poi diviene venditore è adombrata la maschera di Giu-da: nessuno di essi, fuor che l’ultima proprietaria, la vedova, ha il mi-nimo riguardo per l’asino. Ognuno degli acquirenti fa lavorare l’animale fino allo sfinimento, affinché in un tempo breve sia recupe-rata con interessi e vantaggio la somma spesa per acquistarlo5.
Non viene detto quale santo patrono si stia festeggiando a Buccheri nel giorno in cui l’asino è venduto per la prima volta. Il lettore ap-prende soltanto che quella è una «santa giornata» (StA, p. 270). Al momento di ringraziare i numi perché è riuscito a concludere il nego-zio, il primo padrone dell’asino ringrazia san Gaetano. Il lettore è tut-tavia indotto a ritenere che il santo festeggiato nel giorno della fiera sia san Giuseppe. Non si spiegherebbe, diversamente, come mai il pu-ledro che non ha un nome e che mai lo avrà, venga indicato dal primo compratore, compare Neli, con l’espressione e denominazione “asino di san Giuseppe”. Da quel momento in poi la individualità della bestia sarà consegnata sempre all’espressione, che non è un nome, “asino di san Giuseppe”. “Di san Giuseppe” è una sorta di patronimico; in Ca-valleria rusticana, per esempio, vi sono Lola di massaro Angelo e Santa di massaro Cola. L’asino è dunque “figlio” di san Giuseppe e per questa ragione non è figlio di nessuno. In quanto figlio di san Giu-seppe adombra il Cristo, il quale non era realmente figlio del falegna-me di Nazareth. La moglie del primo padrone dell’asino, durante la fiera, si reca dal marito, preoccupata perché nessuno compra il pule-drino. Ella confida nell’aiuto della madre del Cristo: « Che non lo manda oggi la Madonna uno che compri il puledro?» (ibidem). Il sar-casmo nei confronti delle verità di fede è aperto e pesante. La madre del Cristo si spera faccia arrivare chi — dotato della maschera di Giu-da — comprerà il figlio di san Giuseppe, del suo sposo. E questo fi-glio è un asino, nato in una stalla, come il bambino Gesù. Tutte le compravendite hanno movenze simili a quella del Cristo, venduto per trenta monete d’argento (era questo l’indennizzo stabilito dalla legge
5 «Alla trebbiatura il puledro […], trotterellava sui covoni da mattina a sera, tanto che si
riduceva stanco e senza voglia di abboccare nel mucchio della paglia» (StA, p. 274), e «gli ca-lò il sangue alle gambe, e dovettero portarlo dal maniscalco» (ivi, p. 275); «ma al padrone non gliene importava nulla, perché la raccolta era stata buona, e il puledro si era buscato le sue trentadue lire e cinquanta. Il padrone diceva: “Ora il lavoro l’ha fatto, e se lo vendo anche per venti lire, ci ho sempre il mio guadagno”» (ibidem).
POSTILLA II – Lettura cristologica della Storia dell’asino di S. Giuseppe
255
mosaica per uno schiavo ucciso), così come è raccontata in Matteo (26, vv. 14–15), il solo Vangelo che entri nel dettaglio. Nel Vangelo, però, è Giuda a prendere l’iniziativa di recarsi dai sommi sacerdoti e di chiedere loro quanto siano disposti a dargli in cambio della conse-gna di Gesù. Gli “acquirenti” fissano il prezzo6. La situazione evange-lica verrà tenuta di conto da Verga nell’ultimo tratto della novella.
La Passione dell’asino comincia nel giorno della festa del santo pa-trono, quando il padrone, prima della conclusione del negozio «lo fa-ceva tacere a bastonate, perché non l’avevano voluto» (StA, p. 271). Quando lavora per compare Neli, le fatiche ininterrotte cui è costretto sono tali che «gli calò il sangue alle gambe, e dovettero portarlo dal maniscalco» (ivi, p. 275). Questi, al fine di rimettere il ciuco in condi-zioni di camminare gli brucia più volte «le gambe coi ferri roventi», mentre «il puledro si contorceva», «stralunava gli occhi dallo spasi-mo», «e la pelle fumava e friggeva come il pesce nella padella» (ibi-dem): si pensa, qui come nel caso delle bastonate assestate dal primo padrone, alle frustate che percossero il Cristo per ordine di Pilato. Massaro Cirino aggioga l’asino insieme a una vecchia cavalla, assai più alta del somaro, talché questo il giogo essendo troppo alto ri-spetto a lui deve sobbarcarsi a una fatica immane; ma massaro Ci-rino desidera appunto risparmiare la cavalla. Si pensa al Cristo che comincia a portare la Croce su per il Calvario. Il carrettiere compare Luciano, al quale è morta la mula e che non ha soldi da poterne com-perare un’altra, costringe l’asino a tirare un carro dalle stanghe troppo alte per lui. La bestia, già stremata per la vita condotta presso il prece-dente padrone, comincia a cadere per la strada7. V’è il ricordo delle cadute del Cristo, già sfinito dai maltrattamenti e dalle torture patite antecedentemente, mentre è costretto a portare la croce verso la som-mità del monte Calvario. È questa una credenza che non ha riscontro nei racconti evangelici ma è sempre stata vivissima nell’immaginario
6 «tunc abiit unus de duodecim qui dicitur Iudas Scarioth ad principes sacerdotum [,] et ait illis[:] quid vultis mihi dare et ego vobis eum tradam[?] at illi constituerunt ei triginta argente-os» [la punteggiatura tra parentesi quadre è mia, N.d.A.].
7 «sicché non avrebbe durato nemmeno sei mesi, arrancando per le salite, che ci volevano le legnate di compare Luciano per mettergli un po’ di fiato in corpo; e quando andava per la discesa era peggio, perché tutto il carico gli cascava addosso, e lo spingeva in modo che do-veva far forza con la schiena in arco, e con quelle povere gambe rose dal fuoco, che la gente vedendolo si metteva a ridere» (StA, pp. 276–277).
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle
256
dei cattolici d’Occidente. Sotto il penultimo padrone l’asino quasi mo-ribondo e completamente sfigurato trasporta sacchi di gesso sulla groppa8. Invece «la notte il branco restava allo scoperto, accanto alla fornace, e le bestie si facevano schermo stringendosi fra di loro. Ma quelle stelle che luccicavano come spade li passavano da parte a parte, malgrado il loro cuoio duro, e tutti quei guidaleschi rabbrividivano e tremavano al freddo come avessero la parola» (ivi, p. 279). Il Cristo è sulla croce, nudo, esposto al ludibrio e al freddo, insieme agli altri sventurati condannati al medesimo supplizio9. È da por mente in parti-colare a Giovanni (19, vv. 33–34), in cui si narra che uno dei soldati trafisse con un colpo di lancia il fianco del Cristo prima che questo fosse deposto dalla croce.
Nell’universo contadino della novella di Verga non esiste religione cristiana. Vi regna un politeismo assolutamente pagano e superstizio-so. I santi sono altrettanti numi potenti, divinità che propiziono la fe-condità della terra, il favore delle condizioni climatiche contingenti, e dunque l’abbondanza dei raccolti, e i preti sono i rappresentanti con-creti, sul territorio, del potere dei numi. Divinità di second’ordine, ma all’occorrenza capaci esse pure di interventi miracolosi, sono gli ange-li e le anime dei beati10. E tuttavia questi sono capricciosi, non sempre vengono incontro alle esigenze dei devoti: «massaro Cirino se ne tor-nò con la falce in spalla dal seminato, che non ci fu bisogno di mieter-lo quell’anno, malgrado ci avessero messo le immagini dei santi infi-late alle cannucce, e avessero speso due tarì per farlo benedire dal pre-te» (STA, p. 277). Suprema tra gli dei è tuttavia la Madonna, la quale mantiene eminentemente il classico ruolo di Madre della terra e dei raccolti: «i contadini spagliavano, gridando: Viva Maria» (ivi, p. 275).
8 «era tutto coperto di cicatrici […], colle gambe solcate dal fuoco, e le spalle logore dal
pettorale, e il garrese roso dal basto dell’aratro, e i ginocchi rotti dalle cadute, e poi quel pe-lame bianco e nero […]» (ivi, p. 278; «Alle volte la gente che saliva a piedi lemme lemme dietro il carro, vedendo la povera bestia che puntava le zampe senza forza e inarcava la schie-na, col fiato spesso e l’occhio scoraggiato, suggeriva: Metteteci un sasso sotto le ruote, e lasciategli ripigliar lena a quella povera bestia» (ibidem).
9 «andava col muso a terra e le orecchie a paracqua […], torcendo il groppone alle legnate del ragazzo che guidava il branco» (ivi, p. 279).
10 «e quando cascava ci volevano tutti gli angeli del paradiso a farlo rialzare» (ivi, p. 277); « anime sante ! borbottava la donna portatemelo voialtre quel carico di legna!» (ivi, p. 280).
POSTILLA II – Lettura cristologica della Storia dell’asino di S. Giuseppe
257
D’altronde, se sia la Madonna che i santi devono ormai dare una mano anche nei commerci, nelle compravendite, nei negozi che fruttano de-naro contante, ciò avviene perché mantengono il loro antico ruolo an-che in un’economia ove pur sopravvivendo il baratto non si può pre-scindere dalla intermediazione del denaro. Il denaro, però, non è mai oggetto di cupidigia fine a se stessa (questa, eventualmente, è preroga-tiva della borghesia di paese); esso è necessario per procurarsi beni di prima necessità che un tempo venivano acquisiti (quando venivano acquisiti) mediante il baratto o attraverso un rituale e una organizza-zione sociale che prevedeva l’esistenza “strutturata” di maghi o di monaci conoscitori delle erbe e di analoghe figure di “uomini della medicina” o guaritori.
Il bene primario che si tenta di procacciarsi attraverso il denaro so-no le medicine e le cure mediche. Nei Vangeli, come è noto, Gesù viene chiamato dai discepoli e in genere da coloro che lo avvicinano “Maestro” in relazione al contenuto del suo insegnamento profetico e messianico, così complesso; viene invece chiamato dalle medesime persone “Signore” in relazione alla potenza salvifica che si sprigiona da lui, potenza che si esplica prevalentemente nella guarigione di ma-lati e infermi di ogni sorta: una liberazione dal male fisico e morale che riporta alla salute e alla vita normale anche i più impuri (i lebbro-si, l’emorroissa) e perfino gli indemoniati. Così, i primi proprietari del puledro hanno urgentemente bisogno di denaro non solo per far la spesa ché non vi è nulla da mangiare per quella sera ma anche per comprare il solfato al loro figliolo malato di malaria, Turiddu. Co-loro che comprano l’asino di san Giuseppe, e che lo rivendono dopo averlo sovraccaricato di lavoro e quasi massacrato agiscono sì in base alla logica tutta economica di cui sempre si parla a proposito degli “umili” di Verga, ma agiscono così anche perché sono spinti da una necessità incalzante, che talvolta investe la loro stessa possibilità di sopravvivere11. Pare che ad alcuni l’asino di san Giuseppe porti il soc-corso materiale di cui hanno bisogno. Beneficiano grazie all’asino di una relativa liberazione dal male (possibilità di curare la malattia; sol-
11 « Ma compare Luciano rispondeva: Se lo lascio fare quindici tarì al giorno non li
guadagno. Col suo cuoio devo rifare il mio. Quando non ne potrà più del tutto lo venderò a quello del gesso» (ivi, p. 278).
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle
258
lievo dalla condizione di semi–indigenza o di totale indigenza) sia i primi proprietari, come si è detto, sia il secondo, compare Neli, sia il quarto, compare Luciano, sia la quinta acquirente e ultima proprieta-ria, la vedova. Altri invece, come il terzo proprietario (e secondo ac-quirente) massaro Cirino perdono il raccolto, a causa delle sfavorevoli condizioni climatiche dell’anno12. Massaro Cirino non impreca contro la malasorte, ma contro l’asino “figlio” di san Giuseppe, reo di ave-re attirato l’avversa fortuna. L’imprecazione superstiziosa è rivolta contro il nume tutelare che avrebbe dovuto vegliare sul buon esito della fatica del somaro; ed è anche bestemmia, espressa in modo da evidenziare il rapporto di discendenza diretta dell’asino dal padre putativo del Cristo: «maledetto sia lui e il santo che l’ha fatto!» (StA, p. 277).
Ma la liberazione dal male recata dall’asino ha quasi sempre carat-tere effimero. Coloro che credevano di aver tratto dalla compravendita il maggior beneficio (i proprietari nella cui stella il puledro era nato; compare Neli, la vedova) ritornano in capo a poco tempo e indi-pendentemente dall’asino, che talvolta è già stato rivenduto nella miseria originaria, o nella malattia, o cadono in una sventura ancor più tetra13. Non solo non vi è liberazione dal male; non vi è neppure sol-lievo temporaneo da esso.
12 «La donna guardava l’annata che si preparava, nel campicello sassoso e desolato, dove
la terra era bianca e screpolata, da tanto che non ci pioveva, e l’acqua veniva tutta in nebbia, di quella che si mangia la semente; e quando fu l’ora di zappare il seminato pareva la barba del diavolo, tanto era rado e giallo, come se l’avessero bruciato coi fiammiferi. “malgrado quel maggese che ci avevo preparato!” piagnucolava massaro Cirino strappandosi di dosso il giubbone. “Che quell’asino ci ha rimesso la pelle come un mulo! […]”» (ivi, pp. 276–277).
13 «La moglie di compare Neli, quando vedeva passare l’asino col padrone nuovo, diceva: “Quello era la nostra sorte, quel pelame bianco e nero porta allegria nell’aia, e adesso le anna-te vanno di male in peggio, talché abbiamo venduto anche il mulo”» (ivi, p. 276); «ma l’asino di san Giuseppe non l’avrebbe riconosciuto più nemmeno la padrona che l’aveva visto nasce-re, tanto era mutato […]. Pure anche la padrona stessa era mutata a quell’ora, colla malannata che c’era stata, e la fame che aveva avuta, e le febbri che avevano preso tutti alla pianura, lei, suo marito e il suo Turiddu, senza denari per comprare il solfato, ché degli asini di san Giu-seppe non se ne hanno da vendere tutti i giorni, nemmeno per trentacinque lire» (ivi, p. 279); la vedova e suo figlio “campano” vendendo al mercato fasci di legna che rubacchiano come possono dalle grandi proprietà. Dopo avere acquistato l’asino intensificano l’attività: «final-mente il campiere del barone colse il ragazzo sul fatto a rubar frasche e lo conciò per le feste dalle legnate. Il medico per curare il ragazzo si mangiò i soldi del fazzoletto, la provvista della legna e tutto quello che c’era da vendere, e non era molto» (ivi, p. 280).
POSTILLA II – Lettura cristologica della Storia dell’asino di S. Giuseppe 259
La figura della Sacra Famiglia è adombrata più volte nel racconto. È adombrata per la prima volta al momento della fiera di Buccheri, nella triade grottesca e appena camuffata asino di san Giuseppe–Madonna; ma è adombrata anche nella famiglia del primo e in quella del secondo padrone dell’asino, composte, entrambe, da un padre, una madre e un unico (a quanto pare) giovanissimo figlio maschio: il fi-gliolo ammalato di malaria dei primi proprietari del puledro si chiama Turiddu, che è il vezzeggiativo di Turi, diminutivo di Salvatore: l’at-tributo qualificante il Messia, attributo che è in Sicilia un diffusissimo nome di persona. Il «figlio di compare Neli» viene in qualche modo agguagliato all’asino per il fatto che non viene mai menzionato dalla voce narrante con il nome proprio ma sempre mediante perifrasi e in particolare mediante quella sopra recata tra virgolette basse. Neli è il diminutivo ipocoristico di Emanuele, nome che deriva dall’ebraico e che, secondo la spiegazione più divulgata, significa “Dio è con noi”. La formula «figlio di compare Neli» indica dunque che il giovinetto è figlio di Dio. Egli è la sola persona che voglia sinceramente bene al-l’asino e lo tratti con tenerezza. Per questa ragione il padre lo redar-guisce urlandogli: « Bestia! Perché piangi?». L’appellativo di «Be-stia» contrassegna sempre in Rosso Malpelo le persone buone, miti e affettuose. «Bestia» viene chiamato dai “compagni” il padre di Malpe-lo, mastro Misciu; con lo stesso appellativo Malpelo chiama e redar-guisce Ranocchio, il quale non si difende dalle percosse dell’amico. Nel mondo rusticano di Verga gli asini sono quasi per antonomasia le “bestie”: «lo chiamavano mastro Misciu bestia, ed era l’asino da basto di tutta la cava» (RM3, p. 51). Così, attraverso l’appellativo insultante, lo stesso compare Neli istituisce una relazione di analogia tra il pro-prio figliolo e l’asino da questo amato, nel quale è adombrata, con sar-casmo grottesco eppure non privo di pietà, la Passione del Cristo.
Il tratto in cui l’equiparazione dell’asino al Cristo e la parodia sar-castica della Sacra Famiglia raggiungono l’apice è l’ultimo, quello che si inizia quando il narratore introduce e presenta la vedova, l’ultima acquirente dell’asino. In questo tratto del testo, inoltre, viene quasi ab-bandonato il sistema di credenze pagane, magiche, superstiziose, e fa invece da sfondo la religione cristiana, che talvolta è evocata sul pro-scenio con pennellate popolaresche. Il penultimo proprietario dell’a-sino, «quello del gesso», abituato ad acquistare asini macilenti e mori-
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle 260
bondi che «campavano di quelle boccate di erbacce che potevano strappare lungo il cammino» (StA, p. 278), decide di sbarazzarsi del-l’asino di san Giuseppe, il quale è sopravvissuto al durissimo inverno ma non è più in grado di compiere lavoro alcuno. Il proprietario della fornace di gesso non è ricco, probabilmente, ma tutto lascia supporre che sia il più benestante, oltre che il più avaro e astuto, tra i padroni del ciuco. Pur di guadagnare ancora qualcosa egli persuade la donna indigente ad acquistare il somaro moribondo; egli le dice che grazie a esso ella e il suo figliolo, un ragazzino che non è più nella prima in-fanzia, potranno portare in paese, per venderli, fasci di legna più gros-si. La poveretta casca nella trappola e dà a «quello del gesso», in cam-bio dell’asino, le poche lire che costituiscono i suoi risparmi. In questo modo l’uomo recupera praticamente tutto il denaro che aveva speso per acquistare la bestia alcuni mesi prima. S’è già accennato il fatto che questa compravendita è costruita in modo da echeggiare quella del Cristo come la racconta Matteo. In modo opposto rispetto a tutte le al-tre compravendite narrate nella novella (inclusa la proposta di acqui-stare la sola legna, formulata nella chiusa dal carrettiere) colui che vende prende l’iniziativa di recarsi da un compratore che egli stesso sceglie con sagacia. Il venditore ha tutti i caratteri della persona mal-vagia. Non solo l’asino, ma anche e soprattutto la vedova è sua vitti-ma. Egli la inganna tre volte: una volta perché le lascia credere che l’asino di san Giuseppe sia ancora in grado di lavorare; una seconda volta perché le fa pagare una cifra spropositata rispetto al valore attua-le dell’asino, pari a zero, e una terza volta perché con parole atte a il-luderla la sprona scientemente a mettere in pericolo grave se stessa e il figliolo. Era notissimo, infatti, che la legna venduta dai due al villag-gio veniva da loro rubacchiata e che ciò era assai rischioso, perché i campieri erano gente spietata e violenta.
La vedova, tutti lo sanno, in realtà non è mai stata una donna sposa-ta. Il figlio non si sa di chi sia; potrebbe essere figlio di un uomo cui ella si è data volontariamente e che l’ha abbandonata dopo averla resa gravida; ma potrebbe anche essere il frutto di uno stupro da lei subito. Una donna era disonorata anche se era stata stuprata: a maggior ragio-ne se aveva tenuto con sé la propria creatura invece di ucciderla o di abbandonarla nella ruota. Madre e figlio dunque non possono vivere nel villaggio e non hanno una casa vera, o almeno un ricovero degno
POSTILLA II – Lettura cristologica della Storia dell’asino di S. Giuseppe
261
di questo nome. I due abitano in un casolare diroccato, il tetto del qua-le è caduto da tempo.
Per i due ingenui sventurati l’asino costituisce il bene più prezioso che abbiano mai posseduto. Per tale ragione la donna gli usa ogni ri-guardo e lo fa dormire nella stamberga senza tetto accanto a se stessa e al figlio. Così, di notte, grazie al calore del corpo e del fiato dell’asino, ella e il figlio godono di un poco di tepore in più. Questa è la raffigu-razione, volta al grottesco, della Sacra Famiglia al momento della na-tività: un presepe. È una raffigurazione derisoria nei confronti delle credenze religiose e invece intenerita nei confronti della sofferenza umana, irredimibile. Ci si trova a faccia di un figlio di cui nessun uo-mo è padre; di una madre dal cuore pieno di amore per la sua creatura e dall’indole sostanzialmente gentile; dell’asino di san Giuseppe e di una stamberga riscaldata dall’asino. Manca al quadro solo il bue. Non sta nascendo nessun messia, invece, e l’acquisto dell’asino è causa in-diretta di malattia, forse di morte, certo dei più terribili dolori morali, oltre che della ricaduta della famigliola irregolare in una condizione di tetra e assoluta indigenza. Il campiere del barone riduce in fin di vita il ragazzo da lui sorpreso a rubare frasche nelle proprietà del suo padro-ne. Per pagare il medico non solo la madre perde tutto il suo gramo ri-sparmio ma è costretta a vendere tutto il pochissimo che possiede. Malgrado le cure il ragazzo peggiora:
sicché la madre una notte che il suo ragazzo farneticava dalla febbre, col viso acceso contro il muro, e non c’era un boccone di pane in casa, uscì fuori smaniando e parlando da sola quasi avesse la febbre anche lei, e andò a scavezzare un mandorlo lì vicino, che non pareva vero come ci fosse arri-vata, e all’alba lo caricò sull’asino per andare a venderlo. Ma l’asino, dal peso, nella salita s’inginocchiò tale e quale come l’asino di san Giuseppe davanti al Bambino Gesù, e non volle più alzarsi. (StA, p. 280)
La nascita del Messia viene apertamente seppure quasi affettuosa-
mente schernita. La sola redenzione, la sola liberazione dall’afflizione e dal male, come aveva intuito Malpelo, risiede nella morte, il che non toglie punto alla morte il suo carattere di massimo motivo di dolore e di paura per gli esseri umani (nella novella, ancora una volta in linea con la tradizione cristiano–cattolica, vi è sullo sfondo soprattutto la fi-gura dell’Addolorata, della Madre che assiste alla sofferenza del figlio
PARTE SECONDA – Alla ricerca dello stile per le novelle
262
e quasi certamente lo vede morire). La via crucis è agita e patita da un asino perché l’autore intenzionalmente vuole deridere il cristianesimo; la parodia è rinsaldata dal fatto che l’asino senza nome ha pelo chiaz-zato come quello delle gazze. Ma il fine derisorio non è la sola ragio-ne, credo. L’asino e il cane sono nel mondo contadino i più fedeli compagni dell’uomo, fanno parte della famiglia e nei paesi e villaggi abitano spesso all’interno della casa, in un locale loro riservato. Il solo altro animale al quale si sarebbe potuto affidare il ruolo del Cristo è il cane. Mentre l’asino, però, qualifica il mondo contadino e da quel mondo tendenzialmente non esce, così non è del cane. La novella è una favola dal finale triste, poiché protagonista ne è un animale che pare avere e mantenere, dall’inizio alla fine, la personalità di un bam-bino vivace, mite, obbediente, angelico.
L’aspetto più inverosimile del racconto consiste nella assoluta mancanza di un poco di affetto nei confronti dell’animale da parte di tutti i suoi padroni fuorché dell’ultima. L’animale, invece, è affettuo-so, come dimostra la sua capacità di apprezzare e ricambiare l’attacca-mento del figlio di compare Neli. Un altro aspetto non del tutto vero-simile è che l’asino non mostri mai testardaggine, che sia sempre sot-tomesso, che nessun istinto ribelle si manifesti mai in esso. Verga ha voluto che la parodia delle credenze religiose, e dunque la Passione e morte di Cristo, prendesse corpo in una creatura dolce, buona, mite, indifesa: una creatura innocente, scevra di qualsivoglia colpa, priva anche del peccato originale.
265
Capitolo I
La poesia ermetica di Quasimodo: letture essoteriche
1. L’influenza dei classici e della poesia italiana medievale1 In un articolo pubblicato in anni recenti su «Italianistica» ho confu-
tato alcune diffuse credenze corrispondenti in certa misura al ritratto
1 Bibliografia essenziale: S. QUASIMODO, Ed è subito sera: poesie, con un saggio di S.
Solmi, Milano, Mondadori 19515; G. CONTINI, Salvatore Quasimodo, in Id., Letteratura dell’Italia unita 1861~1968, Firenze, Sansoni 1968, p. 908. Il parere di Contini trova parziale sviluppo e anche parziale limitazione nel noto articolo di O. MACRÌ, La poetica della parola e Salvatore Quasimodo (che, su richiesta del poeta esaminato, fu premesso, come saggio intro-duttivo, alla raccolta antologica di S. Q, intitolata Poesie, Milano, Primi Piani 1938), ora in Id., La poesia di Quasimodo: studi e carteggio con il poeta, Palermo, Sellerio 1986, pp. 279–313 (questo volume costituisce forse il più importante contributo alla esegesi di Quasimodo); Aa. Vv:, Salvatore Quasimodo. Atti del convegno nazionale di studi Siracusa–Modica, 26–27–28 ottobre 1973, a cura di M. Sipala ed E. Scuderi, Catania, Tringale Editore 1975; G. ZAGARRIO, Salvatore Quasimodo, Firenze, La Nuova Italia 19795; G. FINZI, Invito alla lettura di Salvatore Quasimodo, Milano, Mursia 19833; E. SALIBRA, Salvatore Quasimodo, Roma, Edizioni dell’Ateneo 1985; AA.VV., La poesia nel mito e oltre, (Atti del convegno nazionale di studi su Salvatore Quasimodo: Messina, 10–12 aprile 1985), a cura di G. Finzi, Roma–Bari, Laterza 1986; AaVv, Quasimodo e il post-ermetismo: atti del 2. Incontro di studio: Modica, 14–16 maggio 1988, Modica, Centro nazionale di studi su Salvatore Quasimodo (stampato dalla litografia La Grafica) 1989; N. LORENZINI, La poesia di Quasimodo tra mito e storia, Modena, Mucchi editore 1993 (Collana Ghirlandina di classici italiani del Novecento); G. SAVOCA, Concordanza delle poesie di Salvatore Quasimodo: testo, concordanza, liste di fre-quenza, indici, con lettera–presentazione di O. Macrì, Firenze, L. S. Olschki 1994; P. BIANCO, Tra ermetismo e realismo. La poesia siciliana da Quasimodo a Cattafi ed Aliberti, Foggia, Bastogi Editrice Italiana 1999; AA.VV., Salvatore Quasimodo nel vento del Mediterraneo, At-ti del convegno internazionale, Princeton 6–7 aprile 2001, a cura di P. Frassica, Novara, Inter-linea Edizioni 2002; N. TEDESCO, L' isola impareggiabile: significati e forme del mito di Qua-simodo, Palermo, Flaccovio 20022; AA.VV., Quasimodo e gli altri, Atti del convegno interna-zionale, Lovanio, 27–28 aprile 2001, a cura di F. Musarra, B. van den Bossche e S. Vanvol-sem, Firenze (F. Cesati)–Leuven (Leuven university press) 2003; AA.VV., Nell’antico lin-guaggio altri segni, «Rivista di letteratura italiana», XXI (2003), 1–2 (Atti del convegno in-ternazionale su Salvatore Quasimodo, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 18–20 febbraio 2002); E. CANDELA, Il sentimento della terra perduta. Salvatore Quasimodo, Napoli,
PARTE TERZA – L’Apocalisse, l’amore, la natura
266
di se medesimo che Quasimodo ci ha tramandato2: quella per cui il poeta, nella sua prima epoca, mentre cerca, come mite e misurato can-tore, di collocarsi sul solco della pagana antichità greca e latina, si la-scerebbe guidare e influenzare soprattutto da Petrarca e si terrebbe lontano dalla Commedia3; l’altra per cui egli stabilirebbe invece un rapporto profondo e intenso con Dante, specie con le dissonanze “in-fernali”, dopo la fine del secondo conflitto mondiale, nella sua cosid-detta poesia civile, dialogica ed epico–lirica, dall’andamento spesso narrativo. Al poeta parve che la sua prima stagione definita spesso dagli studiosi, con quel tanto di arbitrio che nella valutazione critica è difficile evitare, monologica, intimistica, puramente lirica , fosse contrassegnata dalla soavità e dall’armonia dei suoni, un’armonia cui gli eventi bellici e post–bellici lo avrebbero poi costretto a rinunziare (sappiamo che così non è: la maggior parte dei critici ha dimostrato che eufonia e sonorità limpida e melodiosa contrassegnano anche la
L’Orientale stampa 2004; M. G. RICCOBONO, La centralità di Dante in Quasimodo. Una in-terpretazione finora mai adombrata della quasimodiana prima epoca, «Italianistica», XXXIV–2005, n. 1, pp. 11–32.
2 Salvo esplicita diversa indicazione tutti i rimandi contenuti nella presente ricerca alle poesie e ai saggi di estetica e di critica letteraria di Salvatore Quasimodo, e anche le citazioni da essi tratte, si leggono nel volume S. QUASIMODO, Poesie. Discorsi sulla poesia, a cura e con introduzione di G. Finzi e con prefazione di C. Bo, Milano, Mondadori 1989 (ottava ed. nella collana dei Meridiani), d’ora innanzi indicato con la sigla PDp. Si è naturalmente con-sultato con profitto l’apparato critico–genetico delle varianti da Finzi in PDp registrate in nota alle singole poesie cui si riferiscono. Le poesie della prima stagione sono quelle da Quasimo-do riunite nel volume Ed è subito sera, edito primamente a Milano, presso Mondadori, nel 1942. Vi sono incluse le seguenti collezioni: Acque e terre (1920–29), pubbl. nel 1930, d’ora innanzi AT; Òboe sommerso (1930–32), pubbl. nel 1932, d’ora innanzi ÒS; Erato e Apòllion (1932–36), pubbl. nel 1936 (di cui sono qui tolti a esame solo i testi mai stampati nelle due raccolte precedenti), d’ora innanzi EA e Nuove poesie (1936–42), d’ora innanzi NP, pubbl. per la prima volta in Ed è subito sera, d’ora innanzi ESS. L’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso di D. ALIGHIERI (secondo l’edizione critica di G. Petrocchi) saranno citati mediante le abbrevia-zioni Inf, Par e Purg. Il Canzoniere di F. PETRARCA è citato secondo la edizione a cura di M. Santagata, Milano, Mondadori 1996 (d’ora innanzi RVF). Rimandi e citazioni saranno diret-tamente accompagnati, nel testo di questo studio, dalle abbreviazioni e sigle e dai numeri cor-rispondenti alle pagine, ai canti, ai versi; nel caso di RVF verrà indicato invece il numero del componimento. Tutti i riferimenti alla Bibbia si leggono nella Vulgata (cfr. nota 1 alla Postilla II della Parte seconda); qualche volta la Vulgata presenta lezioni diverse rispetto alla succes-siva, assai diffusa e sempre riedita Biblia sacra vulgatae editionis, Sixti V Pontificis Maximi iussu recognita et Clementis VIII auctoritate edita. Di ciò si darà conto solo ove sia stretta-mente indispensabile.
3 M. G. R., La centralità di Dante in Quasimodo, cit.
CAPITOLO I – La poesia ermetica di Quasimodo: letture essoteriche 267
maggior parte delle poesie della seconda epoca). Egli additò come an-tecedenti degli effetti fono–linguistici, prosodici e stilistici da lui per-seguiti e in genere conseguiti nelle raccolte confluite in ESS, oltre al magistero di Petrarca, la duecentesca e trecentesca lirica umbra, sici-liana, siculo–toscana, bolognese e toscana d’amore (soprattutto quella d’indole cortese, ma non quella stilnovista specialmente), la lirica pe-trarchista e Leopardi4. Agli studiosi che hanno sottoposto a giudizio e sviluppato queste indicazioni è parso che la qualità della cetra quasi-modiana fosse grecizzante ab origine cioè prima della traduzione dei melici greci procurata da Quasimodo. Tale qualità avrebbe tratto pre-cipuamente origine dal rapporto stretto dal poeta con la succitata lirica italiana dei primi secoli5.
Quasimodo ha affermato di avere studiato il greco e il latino, nelle ore libere e di notte, durante il periodo romano, tra il 1923 e il 1926. Fu, quello, il suo periodo più dispersivo. Che intraprendesse fin da quegli anni, come poteva, lo studio predetto, è possibile. Ma che riu-scisse a procurarsi prima del 1935–1936 una solida conoscenza di co-deste due lingue è assai improbabile6. Sicuro pare invece che per en-
4 Cfr. S. QUASIMODO, Una poetica, (1950), PDp, pp. 277–279.
5 Cfr la prima pagina della Introduzione (le cui pagine non sono numerate), firmata dal so-lo L. Anceschi, al volume Lirici minori del XIII e XIV secolo, Milano, Edizioni della Conchi-glia (Edizione di cinquecento esemplari numerati) 1941 (scelta ordinata da L. Anceschi e S. Quasimodo ed illustrata da A. Martini).
6 Scrive Gilberto Finzi: «avvenimenti, aneddoti, tappe della vita di Quasimodo assumeva-no già, lui vivo, un carattere mitizzante. Arduo dunque distinguere, nel suo raccontare, realtà da mito, favola o addirittura sogno di cose sperate. Anche per questo, oltre che per una tipica civetteria di scrittore affermava, per esempio, di essere nato a Siracusa, tentando di conferma-re così, abbastanza ingenuamente, il suo mito di “siculo greco”» (nella Cronologia premessa a PDp, p. IXC). La “favola” della nascita a Siracusa è stata accolta come dato biografico certo perfino da Contini, nella pregevolissima scheda citata alla nota 1. G. SAVOCA, nelle Conclu-sioni al secondo incontro di studio su Quasimodo in Modica, maggio 1988 (in Aa.Vv., Qua-simodo e il post–ermetismo, cit.) ricorda che, quando nacque Quasimodo, Modica era in pro-vincia di Siracusa e non di Ragusa. A buon diritto pertanto a parere dello studioso il poeta po-teva dirsi e sentirsi siracusano e siculo–greco. Mi pare che la considerazione di Savoca attenui ma non vanifichi la mitizzazione (legittima, si badi) della propria biografia da parte di Quasi-modo, che non volle dire di esser nato a Modica. Simpatici e un poco goffi tentativi di mimesi della ritmica latina sono ben visibili fin dai testi più antichi di AT. Come non sentire, per e-sempio, che la cadenza del verso «Tindari, mite ti so» arieggia la prima parte di uno dei più celebri esametri latini, uno di quelli su cui chiunque si forma le prime basi della prosodia anti-ca: «Tytire tu patulae […] /»? mi pare che non se ne sia avveduto neppure Macrì, nelle sue in-telligenti definizioni metrico–prosodiche, verso per verso, di Vento a Tindari: «modellino del ritmo gestito, sì che la riduzione metrico–sintagmatica compenetra i due ritmi paradigmatici,
PARTE TERZA – L’Apocalisse, l’amore, la natura
268
trare in rapporto diretto con la poesia latina e con quella greca si sia avvalso di numerose traduzioni: da quelle più scolastiche e destinate all’uso degli studenti inesperti a quelle pregevoli procurate da studiosi insigni7. Del resto l’esito originale e poeticamente magistrale conse-guito dal poeta nella sua versione dei lirici greci poggia di certo su una conoscenza molto vasta e solida delle traduzioni che precedettero la sua. Occorre respingere l’idea che il poeta avesse diretta e vera confi-denza con le lingue latina e greca entro l’inizio degli anni ’30.
2. Atteggiamenti giocosi nei confronti di Petrarca e di Leopardi La quasimodiana poetica della parola è dotata però fin dagli esordi
di un assai elevato grado di autonomia. Giova esemplificare: il magi-stero di Petrarca si avverte nelle scelte linguistiche dell’autore, specie
pari e dispari, trocaico–dattilico e giambico, separati dalle origini, giovando, naturalmente, l’esperienza barbara (Carducci) o neoclassica (Pascoli, D’Annunzio) […]. Primo verso: datti-lico–coriambico; secondo: paradigmaticamente giambico–endecasillabo, sintagmaticamente cretico–trocaico e dattilico–cretico; terzo: paradigmaticamente novenario dattilico, sintag-maticamente deuteropeone e deuteroepitrito» (O. MACRÌ, La poesia di Quasimodo, cit., p. 102).
7 Questa valutazione, ovvia, è stata espressa, a dire il vero sempre un poco in sordina, da parecchi studiosi. Interessanti gli esiti di ricerche condotte anni addietro da una laureanda del-la Università di Catania: «Nella tesi sui lirici greci che ho appena ricordato, ad esempio, una mia bravissima allieva ha scoperto delle cose di cui non si sono accorti i molti studiosi di Quasimodo traduttore, i quali tendono a ripetere giudizi che altri hanno dato. Sviluppando l’ipotesi che qui a Modica avevo avanzato per il Catullo quasimodiano, e cioè quella della mediazione di traduzioni precedenti, questa giovane studiosa ha scoperto che Quasimodo tra-duceva i greci, rapportandosi ovviamente all’originale, com’era sempre giusto, ma avendo an-che sott’occhio delle traduzioni latine. I più anziani forse ricorderanno che una volta si faceva il salutare esercizio di tradurre dal greco in latino, e che ci sono delle antologie della lirica greca con versioni latine. Quasimodo, con un pizzico giustificabile di astuzia, non cita mai le antologie del Lavagnini, del Cammelli, del Landi, in cui c’erano delle versioni in latino dei li-rici greci che chiaramente egli teneva presenti per le sue versioni» G. SAVOCA, Conclusioni, cit. (cfr. nota precedente). Non direi sia da vedere un pizzico di astuzia, e sia pure giustificabi-le, nel fatto che Quasimodo non dichiarò apertis verbis di avere meritoriamente e intelligen-temente studiato e poi sempre tenuto sott’occhio traduzioni latine dei lirici (come si potrebbe compiere in modo diverso un percorso di formazione e di crescita culturale?). Il poeta, ogni poeta autentico, non è un critico e storico di se stesso; dunque non è tenuto a esibire bibliogra-fia alcuna. Spetta al critico di capire quali furono le letture compiute dal poeta, sempre vaste o vastissime nel caso dei poeti autentici, e da loro dichiarate solo parzialmente o frammentaria-mente.
CAPITOLO I – La poesia ermetica di Quasimodo: letture essoteriche 269
nella soavità melodiosa di molte parole. Ma queste medesime parole recano un senso letterale e una raggiera di connotazioni molto diffe-renti rispetto a quelle recate dagli identici vocaboli petrarcheschi. Conviene anzitutto enucleare, in modo breve, gli aspetti caratteristici dell’atteggiamento di Quasimodo nei confronti di Petrarca e di Leo-pardi.
L’aggettivo «aspr–» par che venga dal poeta adoperato con conno-tazioni riconducibili al grande lirico del Trecento:
Non una dolcezza mi matura, / e fu di pena deriva / ad ogni giorno / il tempo che rinnova / a fiato d’aspre resine. (L’Eucalyptus, in ÒS, p. 40, vv. 1–5) Autunno mansueto, […] / […] / […]. // Aspra pena del nascere / mi trova a te congiunto; / e in te mi schianto e risano: // povera cosa caduta / che la terra raccoglie. (Autunno, ivi, p. 53: la prima espressione è tolta dal v. 1, mentre le altre riproducono i vv. 4–8) Ma se maggior paura / non m’affrenasse, via corta et spedita / trarrebbe a fin questa aspra pena et dura; (RVF, n. 71, vv. 42–44; tutti i corsivi nei tre luoghi citati sono miei) Nella parola–chiave dolcezza sono concentrati il calore famigliare e
amicale, il senso di intimità e in genere tutti gli affetti che contrasse-gnarono l’infanzia e l’adolescenza in Sicilia. L’isola è richiamata pri-mamente dall’espressione «aspre resine». Peraltro questo rinnovarsi in poesia della dolcezza perduta non produce effetti balsamici. Il tempo dedicato alla ricerca dell’espressione e la balenante trasfigurazione poetica di frammenti del passato sono anzi fonte quotidiana di sensa-zioni dolorose, le quali non hanno un fine, sono prive di meta. In Au-tunno l’«aspra pena» è connessa all’atto del venire al mondo, alla sta-gione autunnale; probabilmente a una precisa stagione autunnale è at-tribuita anche la guarigione, la rigenerazione («risano») dopo uno «schianto». Pare di trovarsi a fronte di un ribaltamento delle connota-zioni che son proprie, abitualmente, dell’autunno. Le parole poetiche conducono il lettore in prossimità dell’alveo semantico del parto: «schianto» si avvicina alla sensazione del precipitare improvviso e del cadere brutale e inaspettato al di fuori del grembo materno; «risano» si avvicina alla sensazione dell’essere ancora vivi, malgrado lo schianto, e del percepire lo sviluppo di una nuova vitalità, positiva.
PARTE TERZA – L’Apocalisse, l’amore, la natura
270
Oltre al senso letterale le parole poetiche adombrano forse oscura-mente come spesso e in vario modo accade nei testi della prima stagione) l’esperienza di una “rinascita del canto”, cioè dell’energia creativa, dopo un periodo di apatia e aridità. Anche nei momenti di fe-lice conseguimento degli effetti sperati la ricerca espressiva è sempre avvertita come dolore, pena, fatica. Il distico finale si riferisce di nuo-vo, potentemente, all’alveo semantico del parto: la creatura indifesa espulsa con violenza dal grembo materno è accolta da un nuovo grembo materno (la terra). Per altro verso il distico contiene significati letterali inerenti aspetti e momenti ovvi dell’autunno: in autunno la terra raccoglie, secondo che natura vuole, le foglie che cadono. L’allusione velata alla morte è però assorbita e amalgamata nell’alveo semantico di cui s’è scritto sopra (la terra raccoglie, come una levatri-ce o una culla); inoltre, secondo natura ancorché questo possibile accenno sia quello meno importante , il ritmo delle stagioni prevede la rinascita: fronde nuove ricopriranno in primavera le piante e gli al-beri. Nel complesso, in entrambi i testi di Quasimodo da cui si sono tolti a esame gruppi di versi, la ricontestualizzazione di movenze pe-trarchesche persegue e raggiunge esiti semantico–espressivi lontanis-simi, quasi antitetici, rispetto a quelli perseguiti da Petrarca.
La parola «selva», poi, abitualmente ricca, nella poesia italiana, di connotazioni dantesche che materialmente la associano al buio, al la-birinto, all’ostilità della natura, al fatto di smarrirsi senza più saper ri-trovare la propria strada, e, spiritualmente, al traviamento morale, al peccato, alla perdizione, la «selva» è ricontestualizzata sulla scorta di un gusto estetizzante squisito, che mette in valore le qualità eufoniche e melodiose della parola in oggetto, anche mediante sapienti giochi al-litterativi:
Dormono selve / di verde serene, di vento, / pianure dove lo zolfo / era l’estate dei miti / immobile. (Dormono selve, in ÒS, p. 55, vv. 4–8) Avremo voci di morti anche noi, / se pure fummo vivi talvolta / o il cuore delle selve e la montagna, / che ci sospinse ai fiumi, / non ci volle altro che sogni. (Dove morti stanno ad occhi aperti, ivi, p. 61, vv. 7–11)
Non dirmi parole: in me tace / amore di suoni, e l’ora è mia / come nel tempo dei colloqui / con l’aria e con le selve. (Verde deriva, ivi, p. 71, vv. 3–6)
CAPITOLO I – La poesia ermetica di Quasimodo: letture essoteriche
271
Inutile giorno, / mi togli da spazi sospesi, / (deserti spenti, abbandoni) / da quiete selve / avvinte da canapi d’oro (D’alberi sofferte forme, ivi, p. 74, vv. 8–12) Così solo, numeri di perduto bene / mi narravo, e giorni, / e, splendenti in remote aure, / acque di selve ed erbe (In luce di cieli, ivi, p. 91, vv. 11–14; tutti i corsivi, nelle quattro citazioni, sono miei) Sembra vengano arieggiate le selve di RVF ma così non è, e ciò già
ho potuto dimostrare nell’articolo su «Italianistica» ricordato all’inizio di questo capitolo. La questione verrà nondimeno riesaminata e appro-fondita nel capitolo successivo.
Si leggano altri versi nei quali par che siano echeggiate movenze petrarchesche:
In fresco oblio disceso / nel buio d’erbe giace: / l’amata è un’ombra e ori-glia / nella sua costola. / Mansueti animali, / le pupille d’aria, / bevono in sogno. (L’Ànapo, in EA, p. 82, vv. 19–25) E ora / che avete nascosto i cannoni fra le magnolie, / lasciateci un giorno senz’armi sopra l’erba / al rumore dell’acqua in movimento, / delle foglie di canna fresche tra i capelli / mentre abbracciamo la donna che ci ama.
(Anno Domini MCMXLVII, appartenente alla raccolta La vita non è sogno, (1946–1948), p. 156, vv. 8-13; tutti i corsivi, nei luoghi citati, sono miei) La lontananza di Quasimodo dal compiaciuto e malinconico ripie-
gamento di Petrarca sul proprio amore impossibile e sulla virtuosa o indifferente resistenza di Laura, è totale e assoluta. Le parole di Pe-trarca ricreate e inserite nel proprio discorso poetico dal poeta sicilia-no esprimono o la dolce stanchezza e il sonno che vincono l’uomo do-po il pieno appagamento erotico goduto nella carnalità dell’amplesso, o il desiderio degli amanti e il loro disporsi al reciproco abbandono. Per Quasimodo amare fisicamente chi ci ama è segno di naturalità spontanea e pura, anzi di innocenza, estranea o antitetica, sia nell’uo-mo che nella donna, al “male” e alla peccaminosità8. In Anno Domini MCMXLVII, l’unione con l’amata, sentita come esperienza gentile e
8 «Era beata stanotte la tua voce / a me discesa per nuova innocenza / nel tempo che pati-sco un nascimento / d’accorate letizie. / Tremavi bianca, / le braccia sollevate; e io giacevo in te / con la mia vita / […] / dimentico del canto /» (A me discesa per nuova innocenza, ÒS, vv. 1–8 e 10).
PARTE TERZA – L’Apocalisse, l’amore, la natura
272
moralmente costruttiva (quasi al modo del goethiano “viva chi vita crea”) è contrapposta apertamente al lavoro di quegli infernali stru-menti di morte e di sterminio che sovente sono metaforicamente assi-milati agli organi genitali maschili. Non certo a caso il poeta immagi-na che i cannoni siano stati temporaneamente nascosti tra le magnolie: la magnolia è tra i fiori che meglio si prestano, come la rosa (sempre impiegata diversamente da Quasimodo) a simboleggiare gli organi ge-nitali femminili.
Talvolta vagheggiare l’armonioso corpo femminile nudo produce voluttuoso piacere, e malinconia, invece, il possesso e il soddisfaci-mento fisico9. Altre volte il desiderio e l’eccitazione sono effetto e causa al contempo, nell’uomo mentre la sua donna gli dorme a fianco, serena e appagata , di tristezza e di senso della decadenza del vivere. Per valutare la qualità del rapporto che collega le parole poetiche e la sensualità espresse da Petrarca con quelle espresse da Quasimodo giova leggere per intero il testo Senza memoria di morte (ÒS, p. 51), all’interno delle cui due terzine finali è implicato l’amore di Petrarca per Laura secondo i modi espressivi della canzone Chiare, fresche et dolci acque:
Primavera solleva alberi e fiumi; / la voce fonda non odo, / in te perduto, amata. // Senza memoria di morte, nella carne congiunti, / il rombo d’ultimo giorno / ci desta adolescenti. // Nessuno ci ascolta; / il lieve respi-ro del sangue! // Fatta ramo / fiorisce sul tuo fianco / la mia mano. / Da piante pietre acque / nascono gli animali / al soffio dell’aria. È qui intenzionalmente rovesciato il tipo di piacere che Petrarca
rievoca nel rivolgersi al secondo testimone presente quando egli con-templò sulle rive del Sorga le belle forme di Laura, cioè l’albero (per sineddoche «ramo»): «gentil ramo ove piacque / (con sospir’ mi ri-membra) / a lei di fare al bel fiancho colonna;» (RVF, n. 126, vv. 4-6).
9 «Ti so. In te tutta smarrita / alza bellezza i seni, / s’incava ai lombi e in soave moto /
s’allarga per il pube timoroso, / e ridiscende in armonia di forme / ai piedi belli con dieci con-chiglie. // Ma se ti prendo, ecco: / parola tu pure mi sei e tristezza.» (si tratta della seconda strofa e del distico finale di Parola, in ÒS, p. 45, vv. 8–15). La tristezza subentra per il fatto che dopo l’amore, nell’ora notturna, anche la donna e i riti appena avvenuti si offrono come materia alla sillabazione, con il conseguente carico di tormento. Cfr. il secondo paragrafo e le note 19 e 20.
CAPITOLO I – La poesia ermetica di Quasimodo: letture essoteriche
273
Il godimento procuratosi da Petrarca consistette in una non “platoni-ca” e anzi voyeuristica e onanistica eccitazione dei sensi. Quasimodo è del tutto alieno dall’accarezzare siffatte emozioni, morbide e lieve-mente masochistiche: non senza irriverenza nei confronti di Petrarca, egli canta le esuberanti e voluttuose carezze che la sua mano (fitomor-ficamente divenuta «ramo»10) imprime sul «fianco» dall’amata, dal re-ciproco ardore traendo, lo si ribadisca, gioiosi primaverili piaceri che sono orgasmo e sono creazione di nuova vita. Il “cantore siculo–greco”, attratto dalla sana dolcezza dell’innamoramento e dell’amore fisico, giudica Laura frigida e incapace di amore più che virtuosa. Scrive per esempio, del resto in sintonia con alcuni dei contrastanti stati d’animo di Petrarca, di «gelidi lauri», e poco importa che «geli-di» rechi forse anche la connotazione di “incorruttibili dal tem-po”(Ariete, AT, p. 15, v. 11)11. In Senza memoria di morte, inoltre, la ricercata antitesi al mondo emozionale di Petrarca è preceduta dalla contrapposizione a temi leopardiani, forse meno vistosa del contrasto successivo, ma animata da intenzione non dissimile.
Il felice oblio di sé nel coito e nell’orgasmo viene posto dal poeta siciliano a faccia della lamentosa inettitudine leopardiana all’appaga-mento erotico e al leopardiano vittimistico vagheggiamento della vec-chiaia, temuta età estrema della vita, gelida e tetra, colma solo di rim-pianto, sempre presente e attuale all’io lirico, e anche al parallelo ac-carezzamento leopardiano della morte odiata–amata. L’atmosfera leo-pardiana è ricreata in positivo nel primo verso, mediante la raffigura-zione della natura nel suo aspetto sia maestoso che dolce: l’endeca-sillabo quasimodiano «Primavera solleva alberi e fiumi» echeggia li-beramente i versi 5 e 6 del Passero solitario: «Primavera dintorno / brilla nell’aria, e per li campi esulta» e i versi 6 e 7 della Quiete dopo la tempesta: «Sgombrasi la campagna / E chiaro nella valle il fiume appare.»12. Il primo testo leopardiano si chiude con la prefigurazione, sentenziosa e affranta solo apparentemente, del pentimento da cui il
10 Per la fitomorfòsi cfr. il commento alla poesia D’alberi sofferte forme, al paragrafo suc-
cessivo e la nota 28. 11 Circa le rime di Petrarca che possono aver suggerito l’espressione «gelidi lauri» cfr. in
particolare RVF, 23, vv. 32–40, 66, vv. 19–24, 135, vv. 65–73. 12 Ho tratto le citazioni da G. LEOPARDI, Canti, con introduzione e note di F. Brioschi, Mi-
lano, Rizzoli (BUR) 1974, p. 90 e p. 139.
PARTE TERZA – L’Apocalisse, l’amore, la natura
274
poeta sarà assalito se mai varcherà la soglia della vecchiaia: quello di aver ceduto sempre in gioventù alla inclinazione cupa, alla solitudine e alla misantropia. Chiude il secondo testo la persuasione, non meno sentenziosa, che il solo piacere concesso ai mortali consista nella so-spensione di affanni e dolori. Quasimodo, con impertinenza giocosa ed efficace nei confronti del grande pessimista dell’Ottocento, gode in appagamento totale il congiungimento con l’amata, propiziato dalla primavera. Tanto intensamente e completamente vi si coinvolge, che può farsi insieme a lei dimentico d’ogni cosa e soprattutto della morte (dunque ερωζ–αθανατοζ). Il risveglio dall’estasi è sì dai due amanti vissuto come «rombo d’ultimo giorno», ma l’approssimarsi della mor-te li sorprende giovanissimi («ci desta adolescenti.»), eternando quasi la loro rigogliosa felicità.
3. Atteggiamenti innocenti e giocosi nei confronti della Bibbia Il «rombo d’ultimo giorno» conduce in modo evidente e diretto al
giorno del giudizio, prefigurato nell’Apocalisse. Il poeta si accosta in maniera alquanto irriverente anche al testo sacro. Anzitutto è da notare che la poesia presenta numerose movenze edeniche, marcate in parti-colare dalla strofa finale, che echeggia Genesi, 2, v. 19, cioè il punto in cui il Signore plasma dal suolo ogni sorta di animali e gli uccelli del cielo e li conduce all’uomo affinché questi dia loro un nome. Nitida è anche la risonanza da ivi, v. 24, in cui è scritto che l’uomo abbandone-rà suo padre e sua madre e si unirà alla donna e i due saranno una sola carne. Quasimodo raffigura il congiungimento carnale dell’uomo e della donna, creati per essere perennemente giovanissimi; la maggior felicità del paradiso terrestre pare risiedere nell’appassionata dolcezza dell’amore. Il primo giorno della coppia umana (e di conseguenza il principio dei tempi) viene dal poeta riallacciato senz’altro all’ultimo giorno, come se l’amore naturale e spontaneo avesse salvaguardato la coppia dal peccato, e quindi dal castigo. L’io lirico e l’amata non odo-no gli angeli, i santi e Dio stesso gridare a gran voce che l’ora del giu-dizio e dello sterminio dei malvagi è giunta (cfr. Apocalisse, cap. 4, v. 1, cap. 7, v. 2, cap. 10, vv. 2–3, cap. 11, v. 15, cap. 12, v. 10, e soprat-tutto cap. 14, vv. 2, 7, 8, 9, 13, 15, 18, cap. 16, vv. 1 e 17, cap. 18, vv,
CAPITOLO I – La poesia ermetica di Quasimodo: letture essoteriche 275
2 e 4, cap. 19, v. 1). I due giovani, dimentichi della morte forse immi-nente e rapiti nell’amore, vengono “risvegliati”, riportati a percepire ciò che accade fuori dalla diade che essi costituiscono, dalla voce si-mile a rombo di tuoni possenti (e a fragore di grandi acque): così gri-da, in Apocalisse, 19, v. 6, la folla immensa della chiesa dei vivi, il rombo della cui voce si mescola alle grida della folla dei santi che già si trovano al cospetto di Dio. Poco più che fanciulli, ingenui e immuni dal peccato originale, i due non si lasciano impressionare dalla “situa-zione apocalittica”, quasi la morte non abbia potere su di loro. Certo è che essi non desiderano unirsi al coro dei santi destinati ad abitare la Gerusalemme celeste. Essi non vengono notati e badano a non farsi notare. Si immergono nuovamente nel piacere della loro dolce e sana corporeità e il gioco amoroso ricomincia. Il solo paradiso realmente e intensamente vagheggiato dall’io lirico è quello che fu abitato dai primi uomini, prima che questi ne venissero scacciati: il giardino di Eden.
4. La notte, il sogno, il rinnovamento della dolcezza perduta Come accade, leggendo e discutendo poi i testi di Quasimodo con
gli studenti universitari, e mettendo a frutto le osservazioni dei colle-ghi (in particolare di Claudio Milanini), alcune idee da me sostenute nel detto saggio sulla Centralità di Dante in Quasimodo mi si sono ri-velate bisognose di revisione o di migliore delucidazione. In questo capitolo mi propongo sia di esporre i nuovi convincimenti che ho frat-tanto maturato sia, soprattutto, di affiancare e anzi premettere alla let-tura “esoterica” dei testi quasimodiani della prima età cioè all’in-terpretazione desumibile solo dall’accostamento del Purgatorio a quei testi la lettura “essoterica”, consistente in una parafrasi che cerca di restituire quanto più possibile il senso primario e letterale del testo, indipendentemente dalle allusioni e risonanze che creano significati ulteriori.
Il fatto che il legame stretto dalla poesia quasimodiana della prima epoca con Purg sia stato primamente notato solo in anni recentissimi costituisce senza dubbio un momento rilevante della sfortuna incontra-ta da Quasimodo, non importa se a torto o a ragione, in Italia (l’autore
PARTE TERZA – L’Apocalisse, l’amore, la natura
276
è molto noto in ambiente germanico e anglosassone). La mancata comprensione del detto rapporto non è da addebitare a una sorta di oc-cultamento o “depistaggio”, studiato e recato a buon fine dal cantore siciliano medesimo. Egli, infatti, nel Discorso sulla poesia del 1953, se indicava in Chiare, fresche et dolci acque il componimento poetico a lui forse più caro nel corso del suo primo periodo, segnalava aper-tamente altresì che le due serie di vocaboli, e di suoni, due–trecenteschi da lui prediletti erano stati «dolce color d’orïental zaffiro» (Purg, I, 13) e «fresca aura dei lauri»13. È innegabile, in verità, e lo si è già accennato a sufficienza, che l’artista, scrivendo la “critica di se stesso”, abbia confuso un poco le acque. Ogni artista, però, nel rico-struirsi pseudo–criticamente tende a utilizzare assai più la memoria poetica e l’energia la quale, plasmando, trasfigura che non il pensiero rigoroso, la scrupolosa ricerca ed esegesi delle fonti, la perizia e l’acribia della filologia testuale, la documentata ricostruzione e siste-mazione storica; stranissimo, quasi aberrante, sarebbe il contrario. Ciò naturalmente vale solo per “l’auto–critica”: nulla vieta che un artista possa giudicare con discernimento propriamente scientifico l’opera di altri artisti.
È lecito dire che se qua e là il poeta si avvale con civetteria com-piaciuta e perfino giocosa del rapporto con Purg, prevalente è l’ispirazione seria e raccolta. Una non casuale e manierata identifica-zione con Dante, fondata sulla comune condizione di esuli dei due po-eti, prende corpo già, com’è ben noto, in Vento a Tìndari. Nella quarta strofa Quasimodo si rivolge così all’amata località di mare: «Aspro è l’esilio, / e la ricerca che chiudevo in te / d’armonia oggi si muta / in ansia precoce di morire; / e ogni amore è schermo alla tristezza, / taci-to passo nel buio / dove mi hai posto / amaro pane a rompere». Nella banale ed enfatica parificazione della propria vita attuale al doloroso esilio di Dante è implicato ovviamente soprattutto il colloquio tra Dante e Cacciaguida14; dall’incontro tra Dante e Forese Donati provie-
13 Cfr. Discorso sulla poesia, PDp, p. 290. 14 Vento a Tìndari fa parte di AT (pp. 10–11); sono citati nel testo i vv. 23–30. Il poeta,
com’è chiaro, si sente in esilio perché nella sua isola non c’è lavoro. Egli è costretto pertanto a nutrirsi presentemente di un pane che non gli piace, cioè a “guadagnarsi il pane” lontano dalla Sicilia. Le parole di Cacciaguida sono divenute popolari: «Tu lascerai ogni cosa diletta / più ca-ramente; e questo è quello strale / che l’arco dello essilio pria saetta. / Tu proverai sì come sa
CAPITOLO I – La poesia ermetica di Quasimodo: letture essoteriche
277
ne invece palesemente il verbo «sfoglia» («Però mi dì, per Dio, che sì vi sfoglia»: Purg, XXIII, v. 58).
In questa sede viene indagato il mondo morale di Quasimodo quale è raffigurato nella sua poesia. Pertanto ci si trova a faccia di un io liri-co e di una personalità poetica che talora non consegue gli effetti sperati e forgia versi banali , e non di una personalità autobiografica e di un io empirico che trascriva in modo quasi immediato i dati della propria esperienza. Ciò posto, è da mettere in evidenza che in Vento a Tindari assume primamente corpo la poetica dello sdoppiamento, che qualificherà in assai larga misura i testi raccolti nel 1942 in ESS. Nella seconda, nella terza e nella quarta strofa del componimento l’io che cammina con la brigata di amici, ed è al contempo io lirico, abbando-na il mondo reale e si immerge nelle proprie fantasticherie. Queste si impossessano completamente della mente e dei sensi del poeta. Egli viene ridestato da uno dei suoi amici nel secondo verso dell’ultima strofa. Lo sdoppiamento (ma in questo caso speciale sarebbe lecito anche parlare di un semplice cadere assorto in pensieri e immagini ca-re o dolorose che estraniano solo momentaneamente l’io dalla realtà circostante) è tanto intenso che a lettori autorevoli (Salvatore Pugliat-ti) il “tu” delle strofe or ora menzionate è parso non essere più Tindari o la Sicilia bensì una donna, forse del passato, forse del passato e del presente insieme, repentinamente evocata ed estranea alla gita e Tin-dari e alla brigata di amici. Conviene enunciare chiaramente la forma
alquanto diversa e più evoluta rispetto a quella rappresentata per la
di sale / lo pane altrui, e com’è duro calle / lo scendere e ’l salir per l’altrui scale» (Par, XVII, 55–60). In Vento a Tìndari, però, diversamente che in Purg, si avverte anche non lontana l’eco della maledizione scagliata da Dio contro Adamo al momento della cacciata dal paradiso terrestre (Genesi, 2, vv. 17–19). Nelle note ai testi Finzi segnala che Quasimodo, nella prima stampa della collezione aveva inserito, tra il v. 18 e il v. 19 attuali «un altro verso: “…nutro / fra gente petrosa ai sogni”», mentre al v. 23 si leggeva «fitto» anziché «aspro» e al v. 25 «si scarna» anziché «si muta». La ricerca di un legame con Dante si snoda dunque lungo un per-corso sperimentale che originariamente, in Vento a Tìndari, prendeva in considerazione opere del poeta supremo diverse e animate da intenti tra loro anche lontanissimi e disparati; «petro-sa» rimanda naturalmente al gruppo di rime composte da Dante per la donna detta Petra; «si scarna» a Inf, XXX, v. 69 («[...] ’l male ond'io nel volto mi discarno.») e a Purg, XXIII, v. 51
«né a difetto di carne ch'io abbia;». Il poeta sostituì con «muta» il lezioso ma efficace «scar-na» perché la vicinanza di «scarna» a «schermo», che ricorre poco sotto, creava una oggettiva cacofonia. Il verbo di ascendenza dantesca fu poi inserito nel primo verso di Parola, in ÒS, p. 54: «Tu ridi che per sillabe mi scarno» (tutti i corsivi, nel testo e in nota sono miei).
PARTE TERZA – L’Apocalisse, l’amore, la natura 278
prima volta in Vento a Tindari assunta dallo sdoppiamento soprat-tutto nelle prime raccolte poetiche e più in generale in quelle di Ed è subito sera. Ivi ci si imbatte sovente nella notte, tempo altro e per certi versi antitetico rispetto a quello della giornata; esso è prosaico e gret-to, e per questa ragione, tra l’altro, Louis Aragon, non senza frainten-dere alquanto la poesia del collega italiano, ha potuto scrivere, com’è notissimo, che nella Sicilia trasfigurata liricamente da Quasimodo re-gna una luce nera15.
Durante la sera e la notte e fino all’alba e al mattino, la realtà della vita concreta, diurna, quotidiana, molto sgradevole, viene cancellata o relegata in un tempo–spazio lontano. Il poeta può cercare le “sillabe” mediante le quali dar forma16: 1) o a un evento onirico, cioè a una sor-ta di delirio, di allucinazione, che assomiglia a un sogno in senso stret-to ed è costituito da diverse tessere o frammenti che balenano rapidi, spesso impregnati di un passato rivissuto adesso con diversa, attuale tonalità emotiva; 2) oppure a una fantasticheria, favorita dal silenzio e dalla possibilità di raccoglimento e di oblio. Chiamerò “poesie della notte” o “notturne” i componimenti in cui la poetica anzidetta, che è anche poetica dello sdoppiamento, si fa palese. In diverse poesie solo una parola, ma ben marcata, o una espressione breve rendono esplicito il fatto che il testo appartiene ai “componimenti notturni”17. La doppia
15 Cfr. i Tre giudizi che chiudono le pagine introduttive a S. QUASIMODO, Tutte le poesie, Milano, Mondadori 1971 (terza ediz. negli Oscar).
16 Le espressioni “sillabe” o “sillabazioni”, in luogo di parole poetiche, erano espressioni care ai poeti ermetici e soprattutto a Quasimodo, perché toglievano l’equivoco per cui dalla poesia ci si potessero e dovessero aspettare enunciati informativi, valori semantici legati emi-nentemente al senso letterale di una parola e delle parole in genere. I livelli espressivi della sillabazione sono molteplici e forse quello del senso letterale non è il più importante ai fini della “significazione”.
17 «stasera», in Albero (At, p. 14); «dormono» in Ariete (ivi, p. 15); «sonno», in Acqua-morta, (ivi, p. 30); «notte», in Terra (ivi, p. 17); «si china il giorno» in Si china il giorno (ivi, p. 18); «centro di buio» in Spazio (ivi, p. 19); «destano», nei Morti (ivi, p. 23); «notte» e «so-gno» in Mai ti vinse notte così chiara (ivi, p. 24); «desti [da destare, N.d.A.]» e «notte» in Fresca marina (ivi, p. 26); «stanotte», in Specchio (ivi, p. 27); «buie», in Nessuno (ivi, p. 28); «svegliano», «sera», «tarde», «notte», «buio», in Vicolo (ivi, p. 29); «notte», «stelle», «notte», «alba», «lucciola» nei Ritorni (ivi, pp. 31–32); «notturni», «buio», «notte» in Rifugio d’uccelli notturni (ivi, p. 33); «ora di sospirati abbandoni», «sera», «tramonta» in Òboe sommerso (ÒS, p. 39); «assonnata» nell’Eucalyptus (ivi, p. 40); «sonno», «mi desto», «buio» in Alla mia terra (ivi, p. 41); «dormo», «mi desta», «notte», in Riposo dell’erba (ivi, p. 43); «sognati» in Nell’antica luce delle maree (ivi, p. 44); «piogge notturne», «notte», «astri» in Di fresca don-na riversa in mezzo ai fiori (ivi, p. 46); «sera», in Curva minore (ivi, p. 48); «sopito spazio» e
CAPITOLO I – La poesia ermetica di Quasimodo: letture essoteriche 279
poetica dello sdoppiamento e della sillabazione di sogni notturni si e-saurisce con NP (1936–1942). Ora il poeta ha una sorta di seconda pa-tria (Milano, la Lombardia), ancorché la sua “siepe” sia e sempre sarà la Sicilia. Egli non è più costretto «amaro pane a rompere» da ragioni sentite come estranee al suo cuore. Non a caso scrive, in una delle prime poesie di NP: «Finita è la notte e la luna / si scioglie lenta nel sereno, / tramonta nei canali»; è, questo, un congedo esplicito dal tempo in cui le sillabe poetiche venivano impetrate e ottenute quando «Fuori era notte / e gli astri seguivano precisi / ignoti cammini in cur-ve d’oro» (Di fresca donna riversa in mezzo ai fiori, ÒS, p. 46) e dai contenuti tutti legati solo alla Erlebnis dell’io che si sostanziano nella poesia di quel tempo.
Ciò posto, su quel tempo occorre ora soffermarsi un poco. La ricer-ca serale e notturna delle sillabazioni, delle parole, della forma espres-siva, è ardua, dolorosa18. L’ora della poesia non ottiene sempre l’esito cui pure il poeta consacra ogni sua energia19. Egli allora, forte implici-tamente del fatto che “non di solo pane vive l’uomo”, si rivolge umil-mente a Dio padre, con preghiera in cui imita il Padre nostro, suppli-
«dormono» in Un sepolto canta in me (ivi, p. 48); «lume di lucerna» e «sonno tardo» in Com-pagno (ivi, p. 49); «prima sera», «buio» in Preghiera alla pioggia (ivi, p. 52); «sera», in Foce del fiume Roia (ivi, p. 54); «dormono» in Dormono selve (ivi, p. 55); «buio», in Metamorfosi nell’urna del santo (ivi, p. 58); «stanotte», in A me discesa per nuova innocenza (ivi, p. 59); «sera», in Isola (ivi, p. 60); «notti», in Dove morti stanno ad occhi aperti (ivi, p. 61); «astri», «insonni», «notte» in Dammi il mio giorno (ivi, p. 62); «risvegli», in Convalescenza (ivi, p. 63); «dorme», «lo desta», «alba» in L’angelo (ivi, p. 64); «notte aereo mare» in Vita nascosta (ivi, p. 65); «buio», «astri», «notte», «dormono», «sonno» in Mobile d’astri e di quiete (ivi, p. 66); «alba», «buio» e «sonno» in L’acqua infradicia ghiri (ivi, p. 68); «notte», «dorme» in Seme (ivi, p. 69); «mi desta», «buio», «stelle», «aurore» in Primo giorno (ivi, p. 70); «sera», «sopori», «dormivano», «sonno», «stelle» in Verde deriva (ivi, p. 71); «notte» e «sonno» in Fresche di fiumi in sonno (ivi, p. 72); «notte», «stelle», «lune», «alba», «mi svegli» in D’alberi sofferte forme (ivi, p. 74). È inutile o quasi citare da EA, dedicata alle divinità della notte; produco qualche esempio da NP, ove peraltro la poetica enunciata in Angeli è in via di superamento: «sera», «sonno», «destatevi», «luna» in Ride la gazza, nera sugli aranci (ivi, p, 101); «Espero» e «luna» in Strada di Agrigentum (ivi, p. 102); «sera» (e forse anche «scure case»), in La dolce collina (ivi, p. 103).
18 «Tu ridi che per sillabe mi scarno / e curvo cieli e colli, azzurra siepe / a me d’intorno, e stormir d’olmi / e voci d’acque trepide; che giovinezza inganno / con nuvole e colori / che la luce sprofonda.» (è la prima strofa di Parola, in ÒS, p. 45).
19 «Avara pena, tarda il tuo dono / in questa mia ora / di sospirati abbandono» (è la terzina iniziale di Òboe sommerso, in ÒS, p. 39).
PARTE TERZA – L’Apocalisse, l’amore, la natura
280
candoLo di dargli la parola, il suo pane quotidiano20. Onnipresente o quasi sullo sfondo dei testi di EES è il tempo diurno, durante il quale il poeta è costretto «amaro pane a rompere», insomma a procurarsi me-diante lavori ingrati i mezzi per vivere. Questo tempo della realtà em-pirica e prosaica viene richiamato in modo aperto e diffuso, come si è ricordato, solo in Vento a Tindari, ove non funge da sfondo e basta, e neppure funge da contraltare al tempo, che in questo testo è diurno e in quelli successivi diverrà notturno, della creazione e del sogno.
Generalmente il «tu» cui il poeta si rivolge, nelle poesie di ESS, o è Dio («Padre», «Signore»); o è la (sua) donna; o è la notte, o è, con movenze assai varie, talora arcane o ardite, la Sicilia, oppure è l’infan-zia o la giovinezza. Spesseggiano già, nei testi riuniti in AT, i morti (anche generici spiriti di trapassati, quasi fantasmi) e i bambini, men-tre gli angeli compaiono, in questa prima raccolta, una volta nella poe-sia dal titolo omonimo, poi, in maniera inquietante, nel componimento intitolato Spazio, e una terza volta in Antico inverno. I tre ultimi ele-menti, legati alle forme della religione di Quasimodo, potrebbero ap-parire in contrasto con gli altri elementi–chiave della raccolta, quelli che le danno il titolo e quelli che, pur non essendo nel titolo, dovreb-bero tuttavia esservi e vi stanno in effetti impliciti: l’acqua (specie dei fiumi e dei mari), la terra, la luce, il buio, l’aria, il cielo. Non ci si tro-va però al cospetto dell’emergere di archetipi, o non soltanto di un sif-fatto emergere. Ci si trova piuttosto a fronte di un io lirico che con-templa e idoleggia gli esiti della creazione quale uscì dalle mani del Creatore: una contemplazione che avviene con occhi non offuscati o non troppo offuscati dalla civiltà e che non è immune dalla no-stalgia per una sorta di innocenza perduta.
Sia in AT che in ÒS, la Sicilia è l’isola, quasi per antonomasia, ed è avvertita come un continente a sé, piccolo che sia; è avvertita soprat-tutto come un mondo sciolto da ogni rapporto con altre terre e altre genti, o meglio, come una terra che è in rapporto solo con le acque (fiumi e soprattutto mare) e con il cielo. Da ciò deriva il titolo della
20 «In povertà di carne, come sono / eccomi, Padre; polvere di strada / che il vento leva
appena in suo perdono. // Ma se scarnire non sapevo un tempo / la voce primitiva ancora roz-za, avidamente allargo la mia mano: / dammi dolore cibo cotidiano» (Avidamente allargo la mia mano, in AT, p. 30); «Il tuo dono tremendo / di parole, Signore, / sconto assiduamente» (Al tuo lume naufrago, EA, p. 85; la terzina sta nel componimento come quarta strofa).
CAPITOLO I – La poesia ermetica di Quasimodo: letture essoteriche 281
prima raccolta, Acque e terre. Il poeta entra in rapporto con le terre (li-torali e zone dell’interno, pianeggianti o montuose che siano) e con le acque di Sicilia in concomitanza con l’intervento, quasi sempre, dell’aria o vento e degli alberi. Dopo il 1931 Quasimodo scriverà spesso di «isole» al plurale; ciò accade prima che egli trascorra un breve periodo di lavoro in Sardegna. Si può ipotizzare cautamente che il poeta mediante il plurale «isole» trasfiguri anzitutto l’intera Sicilia, pure gli arcipelaghi che fanno parte di essa, come già aveva fatto in Vento a Tindari, e solo in un secondo momento (a partire da EA) allu-da forse anche alla Sardegna. Ancora fino alle poesie incluse in EA la Sicilia è la «patria perduta» (Sovente una riviera, EA, p. 87), è la «mia terra» (Isola, ÒS, p. 60), è «grembo celeste» (Nascita del canto, ivi, p. 42), è «Città d’isola / sommersa nel mio cuore» (Nell’antica luce delle maree, ivi, p. 44), è «Una città a mezz’aria sospesa» (in questo caso per sineddoche, forse, perché la città a mezz’aria sospesa potrebbe es-sere Modica: Di fresca donna riversa in mezzo ai fiori, ivi, p. 46).
L’infanzia, intimamente fusa alla Sicilia, è «beata nascita» (Com-pagno, ivi, p. 49); è, soprattutto, «infanzia imposseduta» (Convale-scenza, ivi, p. 63). I luoghi, gli affetti, le esperienze, la natura che con-trassegnarono l’infanzia e la prima giovinezza sono, nel loro insieme, la «dolcezza». Di questa fanno parte anche sentimenti dolorosi avver-titi presentemente come ricchi di intimità, familiari, intensi, gentili. La Sicilia sarà poi per sempre la «siepe», cioè l’àmbito che delimita lo spazio vitale del poeta e la sua prospettiva, e soprattutto l’esistenza concreta dell’amore che dona e chiama amore: «la terra impareggiabi-le» (nella poesia omonima inclusa nella raccolta omonima 1955–1958, p. 198).
5. Letture essoteriche da AT Parecchi testi di ESS, pur essendo relativamente ermetici hanno sia
un significato letterale, essoterico, che si lascia cogliere senza difficol-tà, sia un significato allusivo molto più recondito dell’altro ma non meno autentico. Conviene produrre dapprima il significato letterale di tutti i testi da esaminare; solo dopo avere affrontato questo primo li-vello esegetico si prenderà in considerazione, nel capitolo che segue,
PARTE TERZA – L’Apocalisse, l’amore, la natura
282
la parafrasi che restituisce, degli stessi testi, il significato esoterico. Si consideri dunque il secondo testo tra quelli inclusi in AT, Angeli, che contiene quasi una lucida enunciazione programmatica dei principali temi della collezione:
Perduta ogni dolcezza in te di vita, / il sogno esalti; ignota riva incontro / ti venga avanti giorno / a cui tranquille acque muovono appena / folte d’angeli di verdi alberi in cerchio. // Infinito ti sia; che superi ogni ora / nel tempo che parve eterna, / riso di giovinezza, dolore, / dove occulto cercasti / il nascere del giorno e della notte. Il significato letterale del testo è abbastanza chiaro. Il poeta ha per-
duto gli affetti, l’intimità, il calore, il conforto legati all’infanzia e all’adolescenza sull’isola. La vita quotidiana del presente è arida e pe-nosa, con prevalenza (soprattutto in AT e in ÒS), della sensazione di deserto affettivo, di mancanza di sentimenti teneri e gentili. Il poeta si rivolge a se stesso, e a tal fine usa il pronome “tu”. Egli esorta il “tu”, cioè se stesso, ad abbandonare lo stato di veglia (il terreno della real-tà), e a visitare un sogno, uno stato onirico. Il sogno coincide con una rappresentazione eminentemente eidetica i contorni e colori della qua-le sono prescritti dall’io lirico a se medesimo. Il sogno avviene, come ogni sogno che sia poi ricordato, nelle ore notturne che immediata-mente precedono il mattino. Prima che sia giorno, forse durante i pri-mi chiarori dell’alba, il poeta (“tu”) dovrà vedere, e vedrà, sponde lambite da un’acqua marina calma, e incoronate da una schiera di al-beri verdi (disposti cioè in modo circolare o semi–circolare), simile a una schiera di angeli. Forse il cerchio di verdi alberi sembra una schie-ra d’angeli, o forse gli angeli sono verdi, e per questo somigliano a un gruppo di alberi; o forse angeli e verdi alberi coesistono, disposti in cerchio. Nella seconda strofa l’io lirico si propone e si impone, con accenti tra demiurgici e religiosi, di superare i limiti spazio–temporali che contrassegnano l’esperienza umana. Egli potrà e dovrà lasciarsi al-le spalle la falsa o solo apparente eternità di quelle ore della vita reale che pareva non dovessero avere fine, come se non avvenissero all’interno del tempo caduco21; saranno inoltre da lui trasfigurati e su-
21 Intensamente e illimitatamente durevoli sembrano in particolare le esperienze
dell’infanzia, specie quelle dei giochi ripetitivi; il bambino, quanto più è piccolo, tanto più
CAPITOLO I – La poesia ermetica di Quasimodo: letture essoteriche
283
perati, nell’assenza di spazio–tempo, le gioie allegre e i dolori della prima giovinezza: dunque tutti i momenti e le esperienze di quell’in-fanzia contrassegnata dal fatto che il poeta, come ogni fanciullo, inda-gava sul mistero dell’alternarsi di luce diurna e notte (si chiedeva cioè dove andasse la notte quando sorgeva il giorno e dove fosse il giorno quando era notte). L’atmosfera del breve componimento è assorta e re-ligiosa: negli ultimi versi commentati sono probabilmente arieggiati i versetti di Genesi, 1 (capitolo riconducibile alla dotta fonte sacerdota-le) nei quali si narra che Dio creò la luce; che, dopo averla creata, la giudicò cosa buona e separò la luce dalle tenebre; che Dio chiamò la luce giorno e le tenebre notte22. Nell’infanzia e nella prima giovinezza dell’io lirico avvenne anche l’acquisizione della fede religiosa e il sor-gere delle domande a essa connesse. Nella traduzione proposta, sicu-ramente la più attendibile, la forma verbale «superi» (da chi scrive sdoppiata al fine di rendere distesa e perspicua la parafrasi del pe-riodo concentrato del poeta nei due costrutti verbali dal significato analogo «potrà e dovrà lasciarsi alle spalle» e «saranno trasfigurati e superati») ha tre complementi oggetti: «ora» (e la proposizione rela-tiva che segue e specifica questo nome), «riso» (di giovinezza) e «dolore».
Significa tutto questo che l’io lirico si propone di donare una sorta di eternità al vagheggiamento oggi balenante della gioia e dei dolori dell’infanzia, tempo di stupori e di percezione dello stupore? Il testo in se stesso non consente di dare per certa questa possibilità. Nelle poesie successive, però, essa verrà in certa misura oggettivata. Eternatrice sa-rà la parola poetica, naturalmente, che per questo può apparire o essere senz’altro «gelida», vale a dire capace di dare forma incorruttibile. Gli alberi e soprattutto gli angeli sono compagnie normali e congeniali ai fanciulli. Quasi tutti i bimbi, in Occidente, fino a pochi decenni or so-
fortemente prova la sensazione che il tempo sia quasi fermo e crede che egli mai diverrà adulto.
22 L’interpretazione è avallata dai numerosi echi di Genesi, 1 reperibili in ESS; si legge p. e. in Preghiera alla pioggia, vv. 11–13, coincidenti con la terza strofa: «Pietà del tempo cele-ste, della sua luce / d’acque sospese». Da Genesi 1, vv. 7–8 apprendiamo che dopo avere se-parato, nel primo giorno, la luce dalle tenebre, Dio, nel secondo giorno fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento da quelle che son sopra il firmamento. Le cate-ratte della volta celeste (firmamento) si apriranno e ne eromperanno le acque del diluvio (Ge-nesi, 8, vv. 10–12).
PARTE TERZA – L’Apocalisse, l’amore, la natura 284
no, percepivano il proprio angelo custode, e godevano della sua com-
pagnia.
Piace riferire e illustrare brevemente anche un testo estraneo, alme-
no apparentemente, alla fitta serie delle poesie notturne, e dunque alla
poetica sogno–rinnovamento fantastico della «dolcezza» legata al
tempo trascorso sull’isola. Il componimento, Specchio (AT, p. 27), pa-
re lontano da intenzioni ermetiche: Ed ecco sul tronco / si rompono gemme: un verde più nuovo dell’erba / che
il cuore riposa: / il tronco pareva già morto, piegato sul botro. // E tutto mi
sa di miracolo; e sono quell’acqua di nube / che oggi rispecchia nei fossi /
più azzurro il suo pezzo di cielo, / quel verde che spacca la scorza / che pu-
re stanotte non c’era.
Si tratta naturalmente della descrizione della primavera, quale av-
viene nel rinascere di una vita vegetale. Si dischiudono («rompono»)
le gemme, sorgono foglioline color verde tenero, che rispetto al verde
dell’erba sembrano e sono più giovani e fresche; questo colore delica-
to è riposante per l’anima e per i sensi. Il tronco, reclinato verso il
fossato pareva morto in inverno e ora rivive. Questo rinnovarsi pri-
maverile della vita pare al poeta splendidamente prodigioso, come
suole sempre accadere agli animi innamorati della natura. Gli pare di
essere, per panica trasformazione in un elemento naturale e per sim-
biosi con tutti gli elementi della natura, acqua piovana. L’acqua di
una pioggia recente, che è ora l’essere del poeta, riempie pozze e fos-
sati; essa è limpida e in essa si riflettono lo scorcio di cielo sovrastan-
te e le novelle fronde verdi dell’albero, le quali nella notte non erano
ancora sorte.
Si è scritto dianzi che la poesia non appartiene apparentemente al-
la serie di quelle notturne. Il riferimento finale alla notte appena tra-
scorsa porta però a non escludere che il rinnovarsi della vita vegetale
cui l’io assiste e il panismo che si appropria di lui siano fenomeni le-
gati all’alba, al sorgere del sole (ma queste indicazioni temporali non
sono accennate neppure per allusioni). Certo è che durante la notte
l’io aveva percepito la natura e l’albero, ed esso non era ancora stata
rinnovato dall’evento prodigioso. La descrizione non è realistica,
non è verosimile, se non per il fatto che vi sono tutte le parole atte a
dare l’idea del rifiorire di un albero. Le gemme, in natura, non si di-
CAPITOLO I – La poesia ermetica di Quasimodo: letture essoteriche
285
schiudono sul tronco, come accade nell’albero fantasticato, bensì sui
rami. Le fronde, nella realtà, non spaccano la scorza né dei rami né
del tronco. A ben guardare la poesia è un inno alla nascita universa-
le. Le gemme si rompono come grembi di donne che partoriscono fi-
gli. Il tronco, non i rami, è luogo di questo parto, proprio come il
grembo della donna (e, certo, di tutti gli animali mammiferi) è nel
tronco o busto di lei, tutto costituito al fine primario della maternità e
della nascita, non è nelle braccia, nelle mani, nelle gambe, nei piedi
(rami e “radici” del corpo umano). Il corpo femminile è spaccato dal
parto, come la scorza di questo albero lo è dal verde. Si può notare
che pure i gusci delle uova deposte e covate dagli uccelli vengono
spaccati dagli esserini implumi alla loro nascita. In giorni successivi
il poeta canterà anche la nascita di uccelli: «Ad altra foce / più dolen-
te sostanza / soffiò di vita l’urlo dei gabbiani» (è la seconda strofa,
vv. 3–6, di Sardegna, EA).
In generale è lecito dire che in Quasimodo il panismo si congiunge
con naturalezza a una sensualità spontanea, edonisticamente ma non
“egolatricamente” (espressione di conio crociano) propensa a collabo-
rare alla creazione stessa nella gioia del congiungimento carnale con
la donna e negli atti del concepire e del generare, atti che accompa-
gnano tutto il ritmo perpetuo della fecondazione, della nascita e della
rigenerazione cui in natura sono sottoposte le creature viventi. Quasi-
modo ammira questo ritmo; assai più simpatetica è la sua attenzione
alle piante e all’ambito vegetale che non al mondo animale, sebbene vi
siano esempi significativi, in ESS, di fecondità e di nascite attinenti
questo secondo ambito.
6. Letture essoteriche da ÒS
Piace parafrasare e commentare l’Eucalyptus (ÒS, p. 40):
Non una dolcezza mi matura, / e fu di pene deriva / ad ogni giorno / il tem-
po che rinnova / a fiato d’aspre resine. // In me un albero oscilla / da asson-
nata riva, / alata aria / amare fronde esala. // M’accori, dolente rinverdire, /
odore dell’infanzia / che grama gioia accolse, / inferma già per un segreto
amore / di narrarsi all’acque. // Isola mattutina: / riaffiora a mezza luce / la
volpe d’oro / uccisa a una sorgiva.
PARTE TERZA – L’Apocalisse, l’amore, la natura 286
È un “sogno”, invero come in Angeli, molto lucidamente e partita-mene raccontato. Nella parola–chiave «dolcezza» sono concentrati come s’è già notato il calore affettivo, il senso di intimità, le gioie e i dolori che contrassegnarono la prima giovinezza in Sicilia. Dopo la fi-ne di essa gli anni trascorrono e vanno alla maturità della vita
senza che nessuno di quei dolci sentimenti accompagni più il poeta. L’isola è richiamata primamente dall’espressione «aspre resine». L’aggettivo aspre si riferisce in modo immediato al sapore della resi-na, famigliare a ogni bimbo di Sicilia, e poi all’amarezza profonda di cui la presente lontananza dalla patria è causa. Il tempo che rinnova a fiato d’aspre resine è l’ora della sera o della notte in cui l’io lirico si dedica alla ricerca dell’espressione poetica, mediante la quale fa riaf-fiorare e trasfigura («rinnova») infanzia e adolescenza. «Rinnova a fiato d’aspre resine» (l’òboe è uno strumento a fiato) significa che il fare poetico restituisce una sorta di giovinezza a quel tempo lontano. Peraltro questo rinnovarsi in poesia della dolcezza perduta non produ-ce effetti balsamici. Il tempo dedicato alla ricerca dell’espressione e alla trasfigurazione poetica di frammenti del passato sono anzi fonte quotidiana di sensazioni dolorose, le quali non hanno un fine, sembra-no prive di indirizzo, di rotta e di meta («deriva di pene»).
Nella seconda strofa cominciano il sonno e il sogno (anche per questo vi si trova l’aggettivo «assonnata»; alla riva è attribuita la con-dizione dell’io poetante: l’essere in dormiveglia all’alba o in ogni caso nei primi istanti del mattino). Si affaccia alla mente un albero che pare oscillare e il poeta sente di essere quell’albero. Esso si trova sulla sponda di acque non precisate. Il mare? Un fiume? Poi, nella irrealtà onirica, vengono percepiti aria in movimento, quasi fosse mossa dal battito di ali, e fogliame, probabilmente la chioma dell’albero. Questa desta un senso di pena, non è sentita come elemento naturale benigno. Il sogno comincia a somigliare a un delirio, e paiono lecite due possi-bilità di traduzione: nella prima soggetto della forma verbale «esala» è l’albero, il quale, mentre oscilla, emana sia aria in movimento lieve sia le proprie fronde (con inversione dell’ordine logico: si legge dapprima il terzo elemento, «alata aria», poi il secondo, «amare fronde» e da ul-timo il primo «esala»). La seconda possibilità è che i rapporti consueti di causa ed effetto siano stati invertiti: l’aria mossa, e non l’albero, sa-rebbe il soggetto di «esala» e emette essa le fronde, quasi queste fos-
CAPITOLO I – La poesia ermetica di Quasimodo: letture essoteriche
287
sero pareggiate a fiato di vento. La prima traduzione è più rispettosa diciamo della “verosimiglianza minima”, e a renderla assai più proba-bile vale anche la presenza di un chiasmo che nella seconda ipotesi andrebbe perduto: soggetto («albero»), verbo («oscilla»), complemen-to («da assonnata riva») complementi («alata aria», «amare fron-de»), verbo («esala») e soggetto sottinteso; da notare anche il fatto che tutti e tre i complementi cominciano con la a– dell’aggettivo che li qualifica. La seconda ipotesi pare a me di gran lunga più poetica e ric-ca di prolungamenti simbolici del significato. Una forte dose di ambi-guità, tale da porre il dubbio che si è esposto, è però voluta: il poeta si è adoperato al fine di suscitare almeno in certa misura gli echi corri-spondenti al secondo significato; ciò ha fatto mediante la scelta della forma verbale «esala», legata da molto intensa consonanza e assonan-za con «alata aria».
Checché sia di ciò, forse nell’aria che par mossa dal battito d’ali si trovano angeli (ma agli angeli si può pensare, ammesso e non conces-so che tale ipotesi sia lecita, solo in virtù dell’aggettivo «alata»). Simi-lissima l’immagine del fiato di vento che grazie alle ali appena si muove nel componimento Òboe sommerso: «Ali oscillano in fioco cielo, / labili)», il quale funge da testo proemiale alla raccolta omoni-ma (ÒS, p. 39).
L’io percepisce questo paesaggio e questa esperienza interiore co-me un rinascere di sensazioni provate in un tempo lontano; i sensi gli trasmettono gli odori che gli erano stati familiari nell’infanzia. Il poeta avverte come assai dolorose queste percezioni («m’accori», «dolen-te»). L’infanzia è sì intimità e calore, ma la felicità fu sempre poca, fu sempre offuscata dal dolore (l’infanzia fu «inferma»). In particolare viene “rinverdita” e balena nel sogno un’esperienza priva o quasi di gioia, quella di un amore molto giovanile che creò tormento al poeta (l’infanzia fu «inferma già per un segreto amore») e che non fu mai confessato a nessuno se non alle acque (forse le stesse acque che ba-gnano la riva sulla quale oscilla l’albero). Ammesso che il «segreto amore» sia da intendere come passioncella per una ragazzina ma nessun altro elemento che la parola «amore» autorizza questa ipotesi
, ella nulla seppe dell’amore di cui fu oggetto. Sta per affacciarsi l’alba, nel sogno e nella realtà. Nell’ultima parte del sogno il poeta contempla per un istante l’isola, sulla quale cadono le prime luci del
PARTE TERZA – L’Apocalisse, l’amore, la natura
288
mattino. Egli vede una sorgente dalla quale affiora, anzi riaffiora una volpe che è stata uccisa: la volpe sembra essere color oro, forse per ef-fetto della luce soffusa e delicata ma crescente. Anche questo potrebbe essere un frammento in cui ritrova vita una esperienza infantile.
Vengo al componimento dal titolo Di fresca donna riversa in mez-zo ai fiori (ÒS, p. 46):
S’indovinava la stagione occulta / dall’ansia delle piogge notturne, / dal va-riar nei cieli delle nuvole, / ondose lievi culle; / ed ero morto. // Una città a mezz’aria sospesa / m’era ultimo esilio, / e mi chiamavano intorno / le soa-vi donne d’un tempo, / e la madre, fatta nuova dagli anni, / la dolce mano scegliendo dalle rose / con le più bianche mi cingeva il capo. // Fuori era notte / e gli astri seguivano precisi / ignoti cammini in curve d’oro / e le co-se fatte fuggitive / mi traevano in angoli segreti / per dirmi di giardini spa-lancati / e del senso di vita; ma a me doleva ultimo sorriso // di fresca don-na riversa in mezzo ai fiori. Anche questa poesia è una poesia notturna e vi si racconta un “so-
gno”. La parafrasi più aderente potrebbe essere questa: si era entrati in una fase di cambiamento di stagione. Le modificazioni climatiche, cioè il fatto che di notte piovesse e che il tempo fosse variabile, an-nunciavano l’approssimarsi della nuova stagione, la quale non era an-cora iniziata effettivamente. Il cielo era spesso nuvolo, e le nuvole camminavano velocemente; parevano culle che vengano fatte dondo-lare, simili a navicelle che ondeggino sul mare23. Il poeta («io») dor-miva, e non apparteneva più al mondo dei vivi. // In sogno egli si tro-vava in una città posta in alto, forse sul fianco di un monte; [letteral-mente, però, la città non poggia su terra ma è sospesa tra cielo e terra, in aria, N.d.A.]. La città sospesa costituiva l’estrema dimora (dopo la morte, appunto) del poeta, l’ultima in cui egli si sentisse come confi-nato, al di fuori della sua patria autentica.
[La «città a mezz’aria sospesa» potrebbe coincidere con la «Città d’isola / sommersa nel mio cuore» (Nell’antica luce delle maree, ÒS p. 44); essa potrebbe anche essere Modica, ma a rigore essa può
23 In dialetto siciliano culla si dice “naca” e cullare “annacare”; naca deriva da una contra-
zione della forma tardo–latina navicula: navicella o anche semplicemente nave. La nave don-dola sulle onde, e per questo le sono state assimilate le culle, le quali fino a qualche decennio or sono erano fabbricate in modo che dondolassero.
CAPITOLO I – La poesia ermetica di Quasimodo: letture essoteriche 289
rappresentare tutte le città della Sicilia, situate tutte tra mare e cie-
lo, perché l’isola stessa lo è; contro questa interpretazione cozza
però il fatto che il poeta si sente in esilio nella città sospesa, essa
non ha nessuna delle connotazioni della “patria” o in ogni caso del-
la terra d’origine, della terra sentita come la propria terra: N.d.A].
Intorno al poeta stavano le figure femminili più care della sua in-
fanzia e giovinezza, e tra esse sua madre, che era assai diversa ri-
spetto all’immagine di lei che il figlio aveva custodito. Il carico de-
gli anni l’aveva rigenerata. Non è impossibile (ma nulla ci autorizza
ad abbracciare senz’altro questa ipotesi) che la madre apparisse ora
al poeta come ringiovanita; sognare i propri genitori ringiovaniti,
dopo la loro morte, è una esperienza abbastanza comune. La madre,
con amorevolezza soave, sceglieva da un fascio di rose (non preci-
sato ulteriormente: un cespuglio, dei cespugli?) i fiori più candidi, e
con essi incoronava il capo del figlio. Le mani stesse della madre
erano bianche e delicate come le rose («la dolce mano scegliendo
dalle rose», non “scegliendo delle rose” oppure “scegliendo rose”).
Mentre ciò accadeva egli percepiva che stava dormendo e sognan-
do, e che era notte. Stelle e pianeti parevano ruotare su orbite circo-
lari luminose e prefissate. Al poeta sembrava, quasi egli fosse in
dormiveglia, che le cose caduche proprie della vita concreta e reale
si appartassero con lui in luoghi riposti e a lui ignoti, per indicargli
la strada che conduce all’albero della vita24. Come si ricorderà, do-
po aver cacciato gli uomini dal giardino di Eden, Dio pose a oriente
del giardino i cherubini e la fiamma della spada folgorante affinché
fosse custodita (e resa inaccessibile all’uomo) la via all’albero della
vita. Nel sogno che era sul finire il paradiso terrestre non era più
custodito dai cherubini e dalla spada fiammeggiante. Era nuova-
mente aperto a tutti, accogliente. Ma il poeta non riusciva a gioire e
a lasciarsi attrarre, anzi una sofferenza acuta lo pungeva, perché
l’immagine della madre che prima aveva percepito nel sogno veni-
va a confondersi con l’immagine di una donna, composta prima
della sua sepoltura (forse conservata dalla memoria del poeta). Dal-
la fusione delle due immagini risultava la visione di una donna ric-
ca di vitalità gentile, la quale era caduta bruscamente e giaceva
24
Cfr. Genesi, 3, vv. 22–24.
PARTE TERZA – L’Apocalisse, l’amore, la natura 290
senza vita, almeno all’apparenza, sopra i fiori (forse il fascio di ro-se dell’immagine onirica). Il poeta nel sogno pare resistere alla se-duzione del ritorno al giardino edenico, alla seduzione della beati-tudine. Nessuna redenzione riconcilia appieno l’uomo e Dio: la du-rezza del castigo inflitto da Dio agli uomini, quello della morte di coloro che si amano, della fine necessaria di ogni cosa gentile, im-pedisce di dimenticare i dolori del mondo.
Giovano a concludere il commento sia di questa poesia sia del suo ruolo centrale in ESS due osservazioni: la prima è che gli astri sono uno degli “indicatori” più frequenti del carattere notturno delle poe-sie e dunque della poetica legata alla notte e al sogno, cioè della pre-scrizione «Infinito ti sia» (atemporale cosmicità degli astri). La se-conda osservazione è che fin dall’aggettivo–chiave del titolo, «fre-sche», titolo il quale si distende poi nell’ultimo verso, viene implica-ta in modo evidente nel componimento quasimodiano la più celebre canzone di Petrarca, Chiare, fresche e dolci acque. Quasimodo riva-leggia con Petrarca nella creazione di un’atmosfera satura di amore. In linea di massima il tentativo quasimodiano è coronato da succes-so, ancorché la soavità che impregna l’incontro della madre con il fi-glio appaia, forse, eccessiva. Petrarca fa dire a uno dei fiori bianchi che cadono su Laura o accanto a lei: «qual, con un vago errore / gi-rando, parea dir: qui regna amore» (RVF, n. 126, vv. 51–52). Quasi-modo in Di fresca donna riversa in mezzo ai fiori si propone espres-samente e con discreto successo, in competizione con il sommo poe-ta del Trecento, di rendere palpabile, densissima, la temperie amoro-sa senza ricorrere a testimoni esterni al rapporto tra coloro che si amano. La donna più amata, il principale centro affettivo dell’io liri-co quasimodiano, è la madre, in voluta contrapposizione all’amante eroticamente vagheggiata e sempre “imposseduta” di Petrarca.
In Chiare, fresche e dolci acque il poeta fantastica di morire, di essere seppellito sulle rive del Sorga, frequentate da Laura, e di otte-nere per sé morto i sospiri, il pianto e le preghiere dell’amata. Nel te-sto quasimodiano i rapporti sono invertiti: riversa per terra, tra fiori simili a quelli della canzone di Petrarca, è una donna amata (forse la madre, fresca perché gli anni l’avevano resa nuova nel “sogno”), mentre profondamente addolorato alla vista di lei e quasi sequestrato da questo dolore è il poeta.
CAPITOLO I – La poesia ermetica di Quasimodo: letture essoteriche
291
Ci si può ormai sbilanciare alquanto intorno alla natura dei più pro-fondi rapporti tematici intercorrenti tra il Petrarca di RVF e il Quasi-modo di ESS. Nel suo canzoniere Petrarca plasma di continuo e varia con infiniti dettagli e sfumature quello che non poco superficialmente e schematicamente si potrebbe definire un nucleo tematico “invarian-te” di base: l’amore intriso di desiderio per la donna da lui sempre “imposseduta”. Il giovane Quasimodo si prefigge in Angeli un nucleo tematico invariante di base che verrà rimodulato costantemente e in varia guisa in ESS, specie in AT e in ÒS: il recupero infantile e adole-scenziale del tempo della dolcezza (non un recupero memoriale, ma un rinnovamento fantastico); esso coincide con l’insieme degli affetti incarnati dalla sua isola e trova risalto sullo sfondo della– e in con-trapposiziane all’aridità prosaica del presente. Tale recupero, che con-duce al di là o al di sopra del tempo caduco, avviene di sera, di notte, all’alba, mediante immagini balenanti in sogno o mediante lucide, sentenziose e deliranti fantasticherie. È da soggiungere che il testo di Petrarca, assai lungo invero, in cui Quasimodo poté trovare lo spunto principale, e quasi l’insieme degli elementi (anche la fitomorfòsi25) atti a costituire il contenuto invariante di base modellato primamente in Angeli è Nel dolce tempo della prima etade (RVF, n. 23)26. Qualche in-fluenza sul concepimento di un nucleo tematico–poetico invariante poté averla anche Leopardi, il quale nei canti giovanili modella in va-ria guisa il tema della fine delle illusioni e della impossibilità della gioia.
Ai fini del presente studio speciale interesse riveste l’analisi della poesia Dormono selve (ÒS, p. 55):
25 Per la fitomorfòsi, preparata, nei versi di Petrarca citati alla nota successiva, dalla paro-
la–chiave «scorza» (carissima a entrambi i poeti), cfr. il successivo commento alla poesia D’alberi sofferte forme e la nota 28.
26 Il componimento di Petrarca è dei più lunghi di RVF. Se ne rileggano i primi versi (1–20): «Nel dolce tempo de la prima etade, / che nascer vide et anchor quasi in herba / la fera voglia che per mio mal crebbe, / perché cantando il duol si disacerba, / canterò com’io vissi in libertade, / mentre Amor nel mio albergo a sdegno s’ebbe. / Poi seguirò sì come a lui ne ’ncrebbe / troppo altamente, e che di ciò m’avenne, / di ch’io son facto a molta gente exem-pio: / benché ’l mio duro scempio / sia scripto altrove, sì che mille penne / ne son già stanche, et quasi in ogni valle / rimbombi il suon de’ miei gravi sospiri, / ch’aquistan fede a la penosa vita. / E se qui la memoria non m’aita / come suol fare, iscùsilla i martiri, / et un penser che solo angoscia dàlle, / tal ch’ad ogni altro fa voltar le spalle, / e mi face obliar me stesso a for-za: / ché tèn di me quel d’entro, et io la scorza.»
PARTE TERZA – L’Apocalisse, l’amore, la natura 292
Matrice secca d’amore e di nati, / ti gemo accanto / da lunghi anni, disabita-to. // Dormono selve / di verde serene, di vento, / pianure dove lo zolfo / era l’estate dei miti / immobile. // Non eri entrata a vivermi, presagio di dure-vole pena. / La terra moriva sulle acque / antiche mani nei fiumi / coglieva-no papiri. // Non so odiarti: così lieve / il mio cuore d’uragano. Questa poesia, pur appartenendo a pieno titolo a quelle “notturne”,
sembra l’esito molto concentrato ed ermetico di una lucida riflessione cui è data forma di delirio per immagini balenanti. Nondimeno viene anche data forma a un “sogno”, a uno stato onirico. Nella prima strofa l’io lirico si rivolge a un grembo materno divenuto arido, infecondo e incapace di dare amore. L’io da molti anni prova questa sensazione di abbandono, di mancanza dell’amore cui aspira («disabitato»), se ne duole e se ne lamenta; e tuttavia nel corso di questi anni ha continuato a stare accanto a questo grembo materno inaridito, da cui pare non sappia allontanarsi. Il primo significato della parola «matrice» che si legge sui dizionari della lingua italiana è “utero”. Il primo significato della parola latina matrix, sulla edizione 1969 del Georges–Calonghi che ho tra le mani ma anche sul Thesaurus Linguae latinae in CD rom e sui dizionari on line Forcellini e Blaise consultati mediante la banca dati Brepolis Database of Latin Dictionaries (DLD) è invece “femmina da razza”, “riproduttrice”. La «matrice» potrebbe essere metaforicamente l’isola natale, cantata in un momento in cui la co-scienza avverte come sterile la perenne nostalgia e la vicinanza fittizia dell’isola procurata dalla notte e dal sogno. Potrebbe però essere an-che il «grembo celeste» del sesto verso (il primo della terza strofa) di Nascita del canto (ÒS, p. 42): «grembo celeste» che denota al con-tempo il sorgere dell’energia poetica e il contenuto che viene da essa formato, cioè l’«adolescenza»; allora «matrice» indicherebbe la genesi dell’esperienza spirituale. Stando a questa seconda ipotesi la prima strofa di Dormono selve lamenterebbe un perdurante tempo di stan-chezza e aridità creativa, di assenza del dono amoroso e doloroso del poetare.
Nella seconda strofa l’io lirico durante il sonno vede gli amati giardini folti d’alberi e lievemente accarezzati dal vento e le zone pianeggianti e riarse della sua isola natale (ai quali è come di consue-to attribuita la qualità di essere addormentati e trasognati). A questa rinviano di necessità lo zolfo (la Sicilia è terra di zolfare) e la immo-
CAPITOLO I – La poesia ermetica di Quasimodo: letture essoteriche
293
bile estate dei miti; lo zolfo, elemento dalla tonalità giallo–citrina, fornisce la qualità del colore tipico dell’estate siciliana nelle piane dell’interno. Esso, sostanza altamente combustibile e in senso stretto incendiaria, procura all’estate pure una connotazione di calore osses-sionante; anche allora le estati siciliane erano non di rado funestate da incendi distruttivi. Nei miti sono implicate in particolare la grecità e la classicità antica. L’estate è la più lunga delle stagioni in Sicilia, quella che meglio può rispecchiare la forma incorruttibile dei miti («immobile»).
Nella terza strofa, in cui tutti i verbi sono al passato, l’io lirico ri-corda il tempo in cui non era afflitto dalla presente sensazione di aridi-tà e di mancanza di amore (sia tale sensazione legata al ricordo della Sicilia sia legata invece all’assenza della parola poetica). Rivede quin-di le sponde di Siracusa (che non è nominata) lambite dal mare; e ri-vede i fiumi (il Platani e il Ciane, qui non nominati), che sfociano in mare in prossimità della città; e vede o ripensa alle piante di papiri che in un’epoca remota crescevano spontanei sulle sponde di quei fiumi e venivano raccolti e lavorati. Il poeta vede, forse in sogno, le mani di quegli antichi lavoratori. In verità i papiri sono stati prelevati dai fiumi di quel litorale e sottoposti a lavorazione senza soluzione di continuità a partire da quei tempi remoti fino ai nostri giorni27. Il tempo dei miti si prolunga perpetuandosi dall’antichità favolosa verso il presente.
Nel distico finale l’io lirico constata di non provare nessun rancore nei confronti della matrice, dunque del grembo arido, in tutte le acce-zioni sopra lumeggiate. Il cuore del poeta è scosso dalle passioni, il che è umanissimo fatto di natura, e nondimeno la delicatezza del senti-re qualifica intimamente il suo cuore.
Non si può non ricordare che nell’uso linguistico meridionale, e in-tensamente in quello siciliano, “matrice” è la chiesa madre, la catte-drale. Si potrebbe dunque supporre che la prima strofa lamenti sia l’inaridimento del senso religioso, vale a dire della fede, della speran-za, della carità e delle opere che in virtù di esse si attuano. Diversi te-sti di ESS mettono a tema la non innocente fragilità del poeta al co-
27 Oggi la siepe di papiro cresce ancora spontanea solo nel Ciane, ma è a rischio di estin-
zione perché l’abbassamento del livello del fiume ha determinato un pericoloso aumento della salinità dell’acqua.
PARTE TERZA – L’Apocalisse, l’amore, la natura
294
spetto di Dio (cfr. p. e. Si china il giorno)28. La «cattedrale», inoltre, è un elemento ricorrente, quasi una parola–chiave dei testi di EES. Dif-ficile è però conciliare la «matrice» intesa come cattedrale e per esten-sione come senso religioso con l’ultima strofa, in cui il poeta lascia in-tendere che, sebbene la «matrice» inaridita sia per lui ragione di dolo-re, egli non sa odiarla. Sarebbe, codesto, un atteggiamento antitetico a quello della contrizione e della preghiera, che qualifica costantemente il rapporto con Dio sillabato in ESS.
Presenta interesse abbastanza rilevante anche la poesia Verde deri-va (ÒS, p. 71):
Sera: luce addolorata, / pigre campane affondano. / Non dirmi parole: in me tace / amore di suoni, e l’ora è mia / come nel tempo dei colloqui /con l’aria e con le selve. // Sopori scendevano dai cieli / dentro acque lunari / case dormivano sonno di montagne, / o angeli fermava la neve sugli ontani, / e stelle ai vetri / velati come carte d’aquiloni. // Verde deriva d’isole, approdi di velieri, la ciurma che seguiva mari e nuvole / in cantilena di remi e di cordami / mi lasciava la preda: / nuda e bianca, che a toccarla / si udivano in segreto / le voci dei fiumi e delle rocce. // Poi le terre posavano / su fon-dali d’acquario, / e ansia di noia e vita d’altri moti / cadeva in assorti fir-mamenti. // Averti è sgomento / che sazia d’ogni pianto, / dolcezza che l’isole richiami. Si entra nella fase della “dolcezza ritrovata”. Il tempo della prosai-
ca aridità della vita quotidiana fuori dall’isola è finito; la «dolcezza» appartiene nuovamente al presente, non già perché il poeta sia ritorna-to nell’isola bensì perché, con suo stupore o sbigottimento, un amore intenso e corrisposto scalda il suo cuore e i suoi sensi, dandogli intimi-tà, calore e speranza, come è scritto nei versi finali. La poesia potrebbe appartenere alla serie di quelle “notturne”: in tal caso al presente ver-rebbe espresso il contenuto della coscienza vigile e al passato (all’imperfetto) quello del “sogno”: il primo contenuto è riconducibile alla prima e all’ultima strofa, mentre il secondo occupa tutte le altre. Il “tu” al quale il poeta si rivolge a partire dal secondo verso è certamen-
28 «Mi trovi deserto, Signore, / nel tuo giorno, serrato ad ogni luce. // Di te privo spauro, /
perduta strada d’amore, / e non m’è grazia / nemmeno trepido cantarmi / che fa secche mie voglie. // T’ho amato e battuto; / si china il giorno / e colgo ombre dai cieli: che tristezza il mio cuore / di carne!» (AT, p. 18).
CAPITOLO I – La poesia ermetica di Quasimodo: letture essoteriche 295
te una donna. Pare o è da escludere, in virtù dell’ultima strofa, la pos-sibilità che il “tu” sia la sera: tutto lascia pensare alla dolcezza della compagnia femminile e del possesso di una amante–amata, il “tu” ap-punto. Il poeta desidera il silenzio, un silenzio amoroso, e cerca sillabe per la sua compagna, con la sicurezza inespressa che ella saprà ap-prezzarle.
Vengo a una proposta di parafrasi. È sera; la luce del giorno è sta-ta scacciata, v’è una luminosità assai fievole; il poeta sente gli ultimi rintocchi delle campane, in distanza. Chiede al “tu” di non parlargli; assapora il silenzio e sente di essere nella medesima disposizione in cui si trovava quando la sua fantasia si intratteneva con l’aria e con i boschi di Dormono selve; potrebbe trattarsi di disposizione creativa, o di disposizione attinente la sfera emotiva, o di disposizione al su-peramento dell’ora meramente terrena per «l’infinito» del «sogno», secondo che il poeta si era un tempo proposto in Angeli. Forse il «sogno» si impadronisce di lui e a lui sembra di aver vissuto nel pas-sato ciò che sogna presentemente; ma sembra piuttosto che egli ri-cordi presentemente un «sogno» che altra volta lo aveva visitato. A lui pareva scendesse dal cielo un torpore, insieme ad acque prove-nienti dalla luna (piogge, forse avvertite come all’interno di uno stato onirico); oppure nello stato tra veglia e sonno il poeta vedeva acque marine che scendevano dai cieli e vedeva anche montagne abitate: vedeva insomma le forme caratteristiche della sua isola durante la stagione invernale. Si è già ricordato che per gli antichi semiti (cfr. Genesi 1, vv. 6–7) il firmamento, volta apparente del cielo, era una cupola solida che racchiudeva le acque superiori: dalle sue aperture scorrerà il diluvio. Le case sui monti erano silenziose e prive di luce: i loro abitanti dormivano. La neve fissava (formava) figure angeliche sulle folte chiome degli alberi e sagome di stelle sui vetri delle fine-stre, velati (dalla neve) e simili a carta leggera, che dava l’impres-sione di aerea levità.
Nella terza strofa il poeta vede delle isole (le sue? cioè la Sicilia e gli arcipelaghi che la fiancheggiano?), trasportate dalla corrente del mare, verde; vede bastimenti a vela attraccare sulle rive delle isole; vede una moltitudine di persone che costituisce l’equipaggio dei bastimenti. L’accostamento della parola ciurma alle parole ve-liero, remi e preda allude di necessità a due possibili campi seman-
PARTE TERZA – L’Apocalisse, l’amore, la natura
296
tici: quello dei galeoni e dei vascelli condotti dalle braccia o di schiavi o di galeotti in stato di prigionia, e quello delle navi dei pi-rati e del canagliume che vi si era arruolato come equipaggio: gente abituata a solcare i mari aperti, quasi guidata dalle nuvole, e a re-mare al ritmo delle cantilene, tra i rumori delle funi (il testo auto-rizza però anche l’interpretazione per cui durante la navigazione si ode un monotono mormorio costituito dal rumore dei remi che bat-tono l’acqua e da quello delle funi variamente impiegate). Nel “so-gno” la gente dei bastimenti consegnava al poeta una donna: la qua-lità femminile è tutta legata al femminile «preda» e ai suoi aggetti-vi, «nuda» e «bianca», e tuttavia è molto marcata. Ella era stata fat-ta prigioniera e veniva trattata come un oggetto passivo; la donna era al contempo angelica e sensuale, tanto che, toccandola, il poeta percepiva dentro di sé i rumori di una natura semplice e incontami-nata: nella fattispecie il mormorio dell’acqua che scorre sulle rocce e quello, fantasioso, delle rocce attraversate e scavate dall’acqua. Si tratta dell’immagine balenante dei fiumi e delle rocce di Siracusa, tanto amati.
Le terre che andavano alla deriva poi si fermavano, trovando dimo-ra e ancoraggio sopra fondali marini che nel «sogno» parevano quelli di un acquario (forse le isole sembravano essersi immerse dolcemente nelle acque, fino a poggiare sui fondali marini); quindi il «sogno» si allargava a una visione quasi cosmica, al contempo quieta e inquieta: esso abbracciava ora una molteplicità di firmamenti, trasognati e come concentrati in se stessi; questi venivano percossi da un fremito che conteneva opposizione e desiderio: una ribellione alla noia, alla stati-cità di una situazione immobile, e un desiderio di nuova vita e di nuo-ve attive esperienze. Il fremito e il desiderio forse appartenevano, o erano appartenuti, alla coscienza spontanea (certo non a quella vigile!) del poeta.
Nell’ultima strofa il poeta si trova nello stato di coscienza riflessa, vigile; egli si rivolge alla donna, al presente, e le dice che averla con sé, cioè averla come compagna e come amante gli dona felicità sbigot-tita, quasi incredula: una felicità che lo ripaga di ogni presente ama-rezza della vita concreta e che è equiparabile alla dolcezza del tempo infantile, dunque una felicità ricca di calore affettivo, di intimità, di conforto. Non è dato però capire con certezza se la donna del presente,
CAPITOLO I – La poesia ermetica di Quasimodo: letture essoteriche
297
il “tu”, sia o non sia la stessa che i predoni consegnarono nel “sogno” al poeta.
Si giunge all’ultima poesia di ÒS (p. 74) tolta ad analisi in questo capitolo, D’alberi sofferte forme:
Ora matura primizia del sole / la luce che destò d’intorno / d’alberi sofferte forme / e sospirar d’acque / che la notte confuse alle parole, e sollevate l’ombre / si piegano alle siepi. // Inutile giorno, / mi togli da spazi sospesi, / (deserti spenti, abbandoni) / da quiete selve avvinte da canapi d’oro / cui non muta senso / lo stormire dei venti / che d’impeto crolla, / né volgere di stelle. // Il cuore mi scopri sotterraneo, / che ha rose e lune a dondolo / e ali di bestia di rapina / e cattedrali da cui tenta / altezze di pianeti l’alba. / I-gnoto mi svegli / a vita terrena.
Il testo appartiene in modo evidentissimo alla serie di quelli
“notturni”: vi si depreca infatti il risveglio e si rimpiange la visione, il «sogno» ai quali l’io viene sottratto. Una parafrasi plausibile po-trebbe essere quella che segue. Ora diviene intensa («matura», sicu-ramente forma verbale) la luce del mattino irradiata dal sorgere del sole, luce che aveva destato (cioè reso nitidi, dopo che la notte li aveva resi oscuri e indistinti) i contorni pieni di sofferenza degli al-beri e aveva ridestato altresì il mormorio sospiroso delle acque; mormorio che la notte aveva assimilato alle parole, agguagliando l’uno e le altre in un solo rumore (nel sonno e nell’oblio notturno all’io i rumori giungono in modo indistinto); e sotto le siepi si sten-dono lunghe ombre. Il poeta si rivolge al giorno, e gli dice ch’esso gli è molesto, ch’egli lo sente inutile. Il giorno (e il risveglio) sepa-ra l’io dal «sogno» e dalla fantasticheria. Esso lo conduce via da luoghi sospesi tra terra e cielo (da zone simili a deserti bui, come certe parti della Sicilia al crepuscolo e durante la notte, da momenti di abbandono forse trasognato del mondo reale); lo conduce via da giardini sereni folti d’alberi e legati da funi color oro: giardini ai quali non viene impresso movimento in alcuna direzione né dal vento, il quale fruscia e soffia leggero e che repentinamente cessa (forse perché l’io si risveglia), né dal ruotare degli astri nelle loro orbite. L’inutile giorno riporta alla luce e mette a nudo («mi scopri sotterraneo») il cuore del poeta, impasto di tendenze buone e gentili e di inclinazioni viziose.
PARTE TERZA – L’Apocalisse, l’amore, la natura
298
È quasi superfluo ricordare che «cuore» è termine–chiave dell’Anti-co Testamento: il cuore dell’uomo è modellato a somiglianza di quello di Dio, diversamente l’alleanza non sarebbe possibile. Nel «cuore» vi sono la grazia e il profumo dei fiori più belli e la luce delicata e la forma della falce di luna, simile a culla di bimbo che dondola; ma le rose hanno spine e la falce di luna ricorda anche lame taglienti. Nel «cuore» del poeta risiedono altresì la rapacità degli uccelli da preda e la ecclesia quae est in nobis, il senso morale e religioso. Quest’ultimo elemento è percepito esso pure in modo materiale, infantile, come spazio grande e solenne; gli edifici del culto frequentati dal poeta nell’infanzia, ampi, austeri e un po’ freddi affiorano in diverse poesie. L’alba, il tempo che precede il mattino e il risveglio, suole sollevare in sogno i desidèri e le tendenze (il «cuore») dell’io verso spazi sospesi al di là del tempo caduco (il cielo e gli astri, in un senso speciale che si vedrà in séguito). È grammaticalmente possibile che l’alba «tenta altezze» a partire dalle cattedrali; vi sarebbero allora balenanti perce-zioni infantili, il senso dell’altezza delle cupole, dei tetti delle navate centrali e dei campanili delle chiese, che paiono raggiungere il cielo, qui rappresentato dai pianeti. Procediamo nel commento: l’inutile giorno, ridestando il poeta, lo riporta alla vita sulla terra e nel tempo. L’aggettivo ignoto potrebbe riferirsi sia all’«inutile giorno» sia al pro-nome con valore di complemento oggetto «mi». A parere di chi scrive più probabile è la seconda ipotesi: allora «ignoto» marca l’idea del passaggio dallo stato di oblio, di non–conoscenza della realtà con-dizione dall’aggettivo precipuamente indicata allo stato di veglia e di coscienza vigile.
La sofferenza di cui al terzo verso è attribuita agli alberi, anzi alle loro forme: siamo nell’àmbito di quella che è stato molto felicemente e intelligentemente definita la «fitomorfòsi» di Quasimodo29. Negli al-
29 «Propongo il neologismo “fitomorfico” (o “fitomorfo”) nel senso di “a forma di pianta”
come equivalente di attributi normalmente usati come zoomorfo o teriomorfo, “a forma di a-nimale”. Esiste d’altra parte il sostantivo fitomorfòsi (fondato sul greco phuton, “pianta”), an-corché con significato tecnicamente delimitato: “Modificazione delle forme esterne e delle strutture di un organo vegetale provocata dall’azione di un altro vegetale» […]. Il mio, dun-que, più che un neologismo è una risemantizzazione: intendendo per fitomorfòsi il processo generale di assimilazione o trasformazione di un corpo umano in pianta» (P. VALESIO, Qua-simodo, la fitomorfòsi e l’(in)(di)visibile, in Aa.Vv., Salvatore Quasimodo nel vento del Medi-terraneo, cit. (cfr. nota 1), p. 138, nota 7).
CAPITOLO I – La poesia ermetica di Quasimodo: letture essoteriche
299
beri e lo mostrano le loro parvenze , accade per assimilazione del corpo umano in pianta ciò che avviene nella persona del poeta: vi è sofferenza a causa della difficile ricerca della sillabazione (notturna), sofferenza a causa dell’imminente risveglio.
7. Dopo il ritorno della dolcezza: l’innocenza e il paradiso perduto Si arriva così a uno dei testi più citati, più commentati e più sem-
plici di ESS, Del peccatore di miti (EA, 97); si constaterà nel prossimo capitolo che nondimeno il significato principale del componimento è stato tardivamente capito nell’intera gamma dei suoi valori:
Del peccatore di miti, / ricorda l’innocenza, / o Eterno; e i rapimenti, / e le stimmate funeste. // Ha il tuo segno di bene e di male, / e immagini ove si duole / la patria della terra.
È questa la poesia con cui si chiude la raccolta EA. Il fatto che il
poeta non si rivolga più al Signore bensì all’Eterno è indizio di una ri-cerca espressiva rivolta a dare maggiore spazio a parole e movenze prive di forte connotazione storica e apparentemente atte a rappresen-tare l’atemporalità immutabile (o presunta tale) del mito. L’Eterno, senza dubbio è Dio ed è il Dio dei cristiani, perché gli dei pagani sono immortali ma non eterni (tutti sono nati). Nelle poesie che hanno il ca-rattere di preghiere e invocazioni il poeta si era rivolto sempre a Dio chiamandolo Signore; in un caso, aveva mimato la più diffusa pre-ghiera cristiana, aveva sottinteso che si rivolgeva al Padre. Com’è no-to gli apostoli e in genere i seguaci del Cristo nei Vangeli si rivolgono a Lui o chiamandolo Maestro, con riferimento al suo insegnamento profetico–messianico, alla verità da Lui proclamata e illustrata; oppure chiamandolo Signore, con riferimento alla potenza salvifica che da Lui si sprigionava. Mediante tale potenza Egli da un lato liberava gli infermi dall’afflizione delle malattie e dall’altro lato guariva dal male morale, dal peccato. Quasimodo usa l’espressione «Eterno» in luogo di Padre o di Signore perché essa non è compromessa con la nomina-zione cristiana di Dio e ha addirittura un vago sapore di “mito” (la pa-role eterno evoca l’idea di ciò che è incorruttibile dal tempo, che è co-
PARTE TERZA – L’Apocalisse, l’amore, la natura
300
stituito in una forma immobile). In tal modo, il poeta mette in risalto sia il peccato di cui si accusa (la potente attrazione nei confronti dei miti greco–pagani) sia la propria purezza. Egli chiede a Dio di ricono-scere la sua innocenza. Come alcuni grandi santi, egli porta in sé le cristianissime «stimmate». Le «stimmate funeste» si riducono qui alla vocazione poetica, intesa come un dono che si riceve direttamente da Dio e che il poeta ha accolto: non a caso le «stimmate» che si vedono, che non si possono nascondere, sono quelle delle mani, cioè delle membra del corpo usate per scrivere. Questo dono è infausto e luttuo-so, perché la ricerca dell’espressione è causa di infinita sofferenza. Nelle parole del poeta sono balenate sempre l’invocazione al Dio dei cristiani e l’immagine di un mondo altro da quello contrassegnato dal-la caducità e dalla morte («rapimento»: quasi una visione estatica in cui il poeta è trasportato nel «tempo celeste»).
Il quinto verso pare a me il più difficile da decifrare, perché Dio non ha creato il male ed è assolutamente immune dal male. L’interpretazione più verosimile è che il poeta riconosca di essere un impasto di bene e di male come lo sono tutti gli uomini dopo il pecca-to originale (con la sola ovvia eccezione della Vergine madre); e rico-nosca di avere pertanto immesso nella sua poesia l’impronta sia delle inclinazioni agli occhi di Dio virtuose sia di quelle viziose. Negli ul-timi due versi il poeta dice a Dio che le sue parole poetiche hanno rie-vocato con nostalgia e con dolore profondi «la patria della terra», e a-scrive ciò a proprio merito. Pare assai improbabile che il poeta si rife-risca alla propria patria, cioè alla Sicilia, e anche al mondo antico, pa-gano o giudaico che sia, perché esso è implicato nella parola «terra», che è il nostro mondo. Quasimodo si riferisce invece al testo delle Ge-nesi, e dunque alla creazione del cosmo: la dimora dei primi esseri umani fu il paradiso terrestre, che è appunto, con ogni evidenza, la «patria della terra»: della terra in cui l’uomo vive da quando è stato cacciato dal giardino di Eden.
301
Capitolo II
Il giovane Quasimodo, la Bibbia, il Purgatorio: letture esoteriche
1. La chiave che conduce al Purgatorio di Dante: Dormono selve Si è discorso un poco, nel capitolo precedente, della convinzione
circa la qualità ab origine grecizzante della cetra quasimodiana. Code-sta convinzione è stata fatta propria anche dal maggiore, dopo Croce, critico letterario italiano del Novecento, sia pure con accenti indipen-denti da quelli degli studiosi detti “contemporaneisti”. Si rileggano le celebri espressioni con le quali Gianfranco Contini mette in luce la so-stanza a parer suo più profonda e più tenace dell’intera produzione poetica di Quasimodo, sincronicamente e diacronicamente delibata, quella che Leo Spitzer avrebbe chiamato l’etymon:
Quando dai detrattori della poesia moderna fu inventata l’etichetta di erme-tismo, il giovane Quasimodo poté passarne per l’esponente forse più em-blematico. Un sogno di sensazioni e sentimenti dichiaratamente legati ai miti mediterranei ambiva a trasformarsi in una materia verbale incorruttibi-le, lapidea, lucidissima. E legittimamente si sarebbe potuto parlare di ideale traduzione dal greco prima e senza che le effettive versioni [1939-40, N.d.A.] fornissero la letteralità della chiave: nel senso che una sfera di og-getti puri tende a sillabarsi con novità, più esattamente che metrica, proso-dica, cioè di raggruppamenti accentuativi (nell’aspetto prosodico dell’espe-rienza è palese il riconosciuto insegnamento di Ungaretti)1.
1 G. CONTINI, Salvatore Quasimodo, cit. alla nota 1 del capitolo precedente, p. 908. Il parere di
Contini trova parziale sviluppo e anche parziale limitazione nel noto articolo di O. MACRÌ, La poe-tica della parola e Salvatore Quasimodo (che, su richiesta del poeta esaminato, fu premesso, come saggio introduttivo, alla raccolta antologica di S. QUASIMODO, intitolata Poesie, Milano, Primi Pia-ni, 1938), ora in O. MACRÌ., La poesia di Quasimodo: studi e carteggio con il poeta, cit. (alla nota 1 del capitolo precedente), pp. 279–313. I riferimenti alla Bibbia si leggono tutti nella Vulgata (cfr. la nota 1 alla Postilla II della Parte seconda e la nota 2 al capitolo I della Parte terza).
PARTE TERZA – L’Apocalisse, l’amore, la natura
302
E ancora: Il desiderio di “eterno” si palesa in un’infallibile spia grammaticale: sostan-tivi non “attualizzati” o comunque determinati da articoli, così nella tradu-zione («giovinezza dilegua», «a me non ape, non miele») come nell’originale proprio («soave amico mi desta»). Imprevedibile, e assai fe-condo, l’incontro di questa, come fu definita, “poetica della parola” con le occasioni intensamente storiche, non di rado propriamente politiche, del dopoguerra2. Per diverso tempo anche chi che redige il presente saggio ha as-
sunto senza sufficiente sorveglianza la “vulgata quasimodiana” e, in ossequio passivo all’autorità di Contini, la tesi secondo cui i testi della prima età sarebbero sogni mediterranei dall’inclinazione gre-cizzante. Pertanto mi era sembrato che fosse da escludere l’ipotesi di una intenzionale rielaborazione quasimodiana, non immune e-ventualmente da qualche civetteria, della «selva» amena e meravi-gliosa nella quale Dante pellegrino ritrova l’antico paradiso terre-stre («né quantunque perdeo l’antica matre»: Purg, XXXI, v. 52)3. Successivamente, a partire dallo studio sulla Centralità di Dante in Quasimodo, ho potuto riconoscere l’autentica e del tutto prevalente vocazione della poesia quasimodiana durante la prima stagione4. Nella strutturazione espressiva di essa la seconda cantica della Commedia esercita un’influenza fondamentale, forse addirittura maggiore rispetto a quella esercitata dalla poesia di Pascoli, di D’Annunzio, di Ungaretti. La selva o le selve di Quasimodo sono filiazioni dirette del giardino edenico che sta sulla vetta della mon-tagna del purgatorio. Per altro verso i sempre molto ammirati e do-viziosamente echeggiati Petrarca e Leopardi (ammirati malgrado
2 G. CONTINI, op. cit., p. 908. All’«infallibile spia» grammaticale viene donato massimo
risalto si può soggiungere da due banali eppure efficacissimi moduli lirico–grammati-cali e lirico–sintattici: 1) dalla fitta selva di nomi (soggetti, complementi, apposizioni) che non amano la compagnia degli aggettivi e che sono distribuiti all’interno dei versi e delle strofe mediante legami paratattici ai quali manca talvolta il verbo; 2) dal fatto, più rilevante ai fini del risalto da conferire all’«infallibile spia», che la serie degli elementi grammaticali si dispo-ne spesso nella successione complemento verbo soggetto.
3 Cfr. il mio saggio Memoria poetica e memoria delle poetiche in Quasimodo, in Aa.Vv., Nell’antico linguaggio altri segni, cit. Gli esempi riprodotti nel testo e le valutazioni che li ac-compagnavano si leggono alle pp. 395–396 e alla nota 40.
4 Nel saggio su «Italianistica» già più volte ricordato nel capitolo precedente.
CAPITOLO II – Il giovane Quasimodo, la Bibbia, il Purgatorio 303
l’atteggiamento ambivalente da Quasimodo assunto verso Petrarca nella seconda età) sono talvolta oggetto, come s’è constatato, di sorriso malizioso e schernevole.
È parso assennato fin dal capitolo precedente prendere rispettosa-mente le distanze da Contini, con speciale riguardo alle raccolte ante-cedenti lo spartiacque costituito dalle traduzioni, cioè AT, ÒS e EA. Salvo errore, l’assetto della poesia quasimodiana nella prima età, e pertanto «la materia verbale incorruttibile, lapidea, lucidissima» (la musicale ferma armonia), le quali anticiperebbero il diretto abbraccio del poeta siciliano con i lirici greci procedono dalla confluenza e riu-nificazione di tre correnti e tradizioni diverse: la poesia due–trecentesca soprattutto cortese; la classicità e “grecità” di cui la poesia di Petrarca aveva saputo appropriarsi indirettamente, cioè attraverso la mediazione dei sommi poeti della latinità; la terza influenza, non me-no importante rispetto alla lezione di Petrarca, proviene dalla lirica greca e latina voltata in lingua italiana dai traduttori che precedono il poeta siciliano. A ciò si può aggiungere, specie a partire da EA, la cre-scente consuetudine con la lingua originale di questi testi, e soprattutto con quella latina5. La poesia quasimodiana, così intrisa di echi biblici, lascia supporre che la Bibbia voltata in lingua latina da San Girolamo (la Vulgata) e le versioni rivedute di essa siano state uno degli stru-menti mediante cui il poeta cominciò l’apprendimento della lingua la-tina, assiduamente esercitandosi. La traduzione dal greco all’italiano del Vangelo secondo Giovanni (1945) fu quasi certamente compiuta da Quasimodo sulla scorta (e con la mediazione) di una solida cono-scenza della Bibbia latina.
In ÒS i temi della raccolta precedente si ripresentano in guisa tale da sembrare più estetizzanti, più grecizzanti, anche più maturi stilisti-camente: prende a ricorrere quasi subito fittamente l’«isola» (a partire dal secondo testo, L’eucalyptus), che sappiamo esser congiunta spes-sissimo al ricordo e al rimpianto dell’«infanzia imposseduta»6; sia l’isola che l’infanzia sono immagine di un favoloso paradiso perduto; entrano poi in scena gli «angeli» (per l’esattezza a partire dalla terza poesia, Alla mia terra), «i morti», «i bambini», il «Signore», mentre in
5 Cfr. nota 2 al capitolo precedente. 6 La formula ricorre nell’ultimo verso della poesia intitolata Convalescenza (p. 63).
PARTE TERZA – L’Apocalisse, l’amore, la natura
304
modo generico eppure riconoscibile fanno la loro comparsa tipici sti-lemi danteschi, come l’abbinamento del «vapore» ai «pianeti» (da Dante, diversamente che da Quasimodo, sempre denominati, nell’ac-costamento al «vapore», con il loro nome proprio): «Si cresceva in vi-sta d’alti cieli / correndo terre e vapori di pianeti» (Compagno, ÒS, p. 49, vv. 14–15, terza strofa). Tutti questi germi di nuclei espressivi so-no da ricondurre in vario modo al Purgatorio. Si torni a leggere per intero, il componimento Dormono selve (per il commento essoterico al quale cfr. il capitolo precedente):
Matrice secca d’amore e di nati, / ti gemo accanto / da lunghi anni, disabita-to. // Dormono selve / di verde serene, di vento, / pianure dove lo zolfo / era l’estate dei miti / immobile. // Non eri entrata a vivermi, presagio di dure-vole pena. / La terra moriva sulle acque / antiche mani nei fiumi / coglieva-no papiri. // Non so odiarti: così lieve / il mio cuore d’uragano. Stazio, accompagnandosi a Dante e a Virgilio verso la cornice
dei lussuriosi, tiene a Dante una complessa lezione scolastica circa l’origine organica dell’uomo, l’organizzazione di tutte le funzioni sensitive nel feto (di cui sono apici l’anima vegetativa e poi quella sensibile) e l’intervento finale di Dio, che infonde nell’esserino l’intelletto possibile o anima intellettiva. In modo simile, sebbene più stringato, questo tema è svolto da Dante nel Convivio. Dice Stazio sul concepimento, prendendo come soggetto attivo l’elemento maschile (lo sperma formato da sangue purissimo e per-fetto): «Ancor digesto, scende ov’è più bello / tacer che dire; e quindi poscia geme / sovr’altrui sangue in natural vasello» (Purg, XXV, 43–45). Il «natural vasello», insomma l’organo genitale femminile, la vagina, in cui il seme maschile feconda l’elemento femminile («altrui sangue», il sangue mestruale), viene definito nel Convivio «matrice»: «E però dico che quando l’umano seme cade nel suo recettaculo, cioè nella matrice, esso porta seco la vertù dell’anima generativa e la vertù del cielo e la vertù delli elementi legati, cioè la complessione;»7. Diverse altre immagini, e le parole chiamate a raffigurarle e a denotarle, sono riconducibili a Purg. Si
7 D. ALIGHIERI, Convivio, a cura di F. BRAMBILLA AGENO, Firenze, Casa Editrice Le Let-
tere 1995, Trattato IV, cap. 21, par. 3 (rr. 21–23), pp. 390–391 (corsivo mio).
CAPITOLO II – Il giovane Quasimodo, la Bibbia, il Purgatorio 305
tenga presente che la forma verbale «gemo» del secondo verso di Dormono selve non ha il significato attribuitole da Dante in Purg bensì quello ormai più abituale nella nostra lingua: dolersi lamento-samente. Direi che l’accostare due parole–chiave tolte rispettiva-mente da un luogo del Convivio e da uno della Commedia riconte-stualizzandole in modo che il significato di una delle due (di quella corrispettiva al testo più letto e conosciuto) non sia lo stesso che nell’opera di Dante è una pura civetteria: con essa, nondimeno, si intendeva indicare ai lettori “attrezzati” il percorso analogico da seguire.
I primi due versi della seconda strofa di Dormono selve sono modulati in maniera da echeggiare tutti i boschi e i giardini più dol-ci, gradevoli, ameni della poesia italiana, a partire dai canti in cui Dante rappresenta liberamente la sommità del Purgatorio. I versi anzidetti si legano in modo speciale appunto al dantesco giardino dell’Eden, alla «selva antica» della quale Dante percepisce anzitut-to il «soave vento», perennemente uguale quanto a intensità e dire-zione: «Un’aura dolce, sanza mutamento» (Purg, XXVIII; cfr vv. 7, 9 e 23). Dante evita con cura, lungo l’intero canto XXVIII, di ado-perare la parola “verd–” (nome o aggettivo, e i suoi derivati) in qualsivoglia funzione grammaticale: impresa ardua, giacché dal pri-mo all’ultimo verso del canto viene evocato il respiro calmo e so-lenne di una natura incontaminata, piena d’alberi dal ricco foglia-me, di fiori multicolori, di erba vivida. A tale impresa il poeta si sobbarca anzitutto per riprodurre, forse musicalmente, la sostanza soprannaturale del paesaggio piuttosto che i dettagli plastici e le no-te di colore, ma non per questo soltanto. L’apoteosi di Beatrice vie-ne preparata fin dall’ingresso di Dante nel giardino, accuratamente, attraverso le fittissime allitterazioni con –v– scempia e –vv– doppia e le appena meno numerose allitterazioni mediante –f– che costel-lano quasi ossessivamente il canto XXVIII e quello successivo (ove la parola «verde» avrà, con misura, diritto di cittadinanza, come in una sorta di climax che culmina appunto nell’apoteosi or ora men-zionata): le prime allitterazioni rinviano al verde intenso del manto di Beatrice, colore della speranza, e in certa misura anche alla co-rona di foglie d’ulivo che cinge la fronte di lei, sopra il candido ve-lo; le altre al rosso fiammeggiante (colore della carità e dell’amore)
PARTE TERZA – L’Apocalisse, l’amore, la natura
306
dell’abito ch’ella indossa8. Lo zolfo quasimodiano, intimamente le-gato, anche mediante la –f–, alle fiamme, rimanda dunque pure alla veste di Beatrice.
Il gioco allitterativo in –v–, insistentemente echeggiato da Quasi-modo, instaura con il canto XXVIII di Purg una relazione non occa-sionale e adeguata all’intero testo “ermetico”. Carattere peculiare del-l’«aura dolce, sanza mutamento», è quello di lasciarsi impregnare del-la virtù generativa delle piante, per poi diffonderla, circolando. Dal suolo fecondato grazie a siffatta, spontanea, propagazione della virtù generativa, sorgono sempre nuove piante; ed è in grazia di questa pro-pagazione che talora, anche sulla terra abitata dagli uomini, nascono e crescono piante che non erano state seminate9.
Si è già notato in sede di interpretazione essoterica che le bassure e vallate immobili dell’estate dei miti ricordano la Sicilia. Tali pianure as-solate e riarse, in cui nulla si muove nelle ore di caldo canicolare, sono sì associate alla vagheggiata grecità dell’isola, da Quasimodo sentita come remotissima, atemporale e sempre presente, e nondimeno il poeta le associa anche allo zolfo, elemento pericolosamente capace di suscita-re le fiamme. Lo zolfo rimanda anche alle miniere sotterranee, alle vere e proprie voragini infernali in cui la vita umana cessa d’esser tale: la mente del lettore torna a raffigurarsi le realtà geologico–economico–sociali magistralmente raccontate da Verga (Rosso Malpelo e la cava di rena rossa) e da Pirandello (la zolfara di Ciàula scopre la luna). Il puzzo di zolfo, nelle leggende superstiziose e nelle fiabe, è associato alla presenza o al passaggio del demonio: per estensione, faustiana-mente, alle credenze religiose e all’aldilà. L’origine di queste credenze sta nell’Apocalisse: in Apocalisse (19, v. 20) la bestia, cioè Roma per-secutrice, e il suo falso profeta vengono gettati vivi nello stagno di fuoco ardente di zolfo; nello stesso stagno di fuoco e zolfo viene suc-
8 L’abito e il mantello compaiono primamente in Purg, XXX, 31–33: «sovra candido vel
cinta d'uliva / donna m'apparve, sotto verde manto / vestita di color di fiamma viva.» (i corsivi sono miei).
9 «in questa altezza ch'è tutta disciolta / ne l'aere vivo, tal moto percuote, / e fa sonar la selva perch'è folta; / e la percossa pianta tanto puote, / che de la sua virtute l'aura impregna / e quella poi, girando, intorno scuote; / e l'altra terra, secondo ch'è degna / per sé e per suo ciel, concepe e figlia / di diverse virtù diverse legna. / Non parrebbe di là poi maraviglia, / udito questo, quando alcuna pianta / sanza seme palese vi s'appiglia.» (ivi, XXVIII, vv. 106–117).
CAPITOLO II – Il giovane Quasimodo, la Bibbia, il Purgatorio 307
cessivamente gettato anche il diavolo (ivi, 20, v. 10)10. Così, svolgen-do le relazioni analogiche, siamo giunti al testo biblico.
L’associazione fra i papiri, le antiche mani e i fiumi riconduce al Platani e al Ciane i lettori che siano stati curiosi di documentarsi su Si-racusa, ma riconduce al Nilo favoloso e biblico il lettore comune. L’immagine delle mani che nei fiumi coglievano papiri evoca, credo, anche antichissime e favolose vicende bibliche. Durante la schiavitù degli Ebrei in Egitto, come ognun sa, il faraone aveva dato ordine che tutti i bimbi maschi appena nati degli Ebrei fossero affogati nel Nilo. Era formata di papiri e spalmata di pece e di bitume la cesta contenen-te il piccolo Mosé, posata dalla madre di questo, per salvargli la vita, sulla riva del Nilo, nella giuncaia frequentata dalla figlia del faraone e dalle sue ancelle (Esodo, 1 e 2, vv. 1–10). Bitume, pece e zolfo sono sostanze infiammabili; ma quelle di cui era spalmata la cesta conte-nente Mosé non potevano essere arse, grazie alle acque del Nilo, lad-dove lo zolfo delle assolate piane siciliane nell’ora canicolare vivida-mente evoca l’immagine del fuoco, che distrugge la vita animale e ve-getale e che, se reiteratamente divampa nello stesso luogo, ne rende sterile la terra.
Sia nella sua più profonda radice che lungo tutta la sua estensione, il componimento Dormono selve lamenta la sterilità della donna, la tristezza e anche la stanchezza del compagno per gli amplessi da lungo tempo infecondi, il desiderio di un figlio, marcato efficacemente e de-licatamente dall’allusione ai papiri tagliati per costruire una culla gal-leggiante al neonato. Il desiderio di paternità nel poeta è divenuto in-tenso tanto che la compagna gli è ormai «durevole pena», sebbene non possa odiarla. Lo zolfo, esplicitamente legato all’idea del calore inten-so (la siciliana estate dei miti), e implicitamente alle fiamme, alla ste-rilità e all’aldilà attesta, in modo serio, privo di note giocose, e anzi con una certa sofferenza, che l’amore tra Dante e Beatrice supera sì la morte e la vince, ma non crea nuova vita, non genera figli, è sterile es-so pure, nella prima come nella seconda vita.
10 Cfr. anche Apocalisse, 9, vv. 17–18 e 14, vv. 9–10. In ivi, 21, v. 8, Dio ordina allo
pseudo–Giovanni di scrivere che nello stagno ardente di fuoco e di zolfo troveranno la secon-da morte i vari ordini di peccatori.
PARTE TERZA – L’Apocalisse, l’amore, la natura 308
Si può esser tratti a domandarsi perché il cantore siciliano abbia preferito l’espressione del Convivio, «matrice», a quella, dall’identico significato, di Purg: «natural vasello»11. Varie e dotate di pari dignità le risposte: «vasello» è anche, in Purg, la barca sulla quale l’angelo nocchiero fa salire le anime convenute presso la foce del Tevere per traghettarle alla sponda dell’isola altissima (cfr. ivi, II, v. 41), talché l’adozione della parola anzidetta, in luogo di quella prescelta, avrebbe provocato, in un testo “ermetico”, un indebito e fastidioso ingorgo di significati; d’altronde, l’adozione della intera formula «natural vasel-lo» avrebbe reso troppo scoperto ed evidente, banalizzandolo, il ricer-cato legame con la lezione tenuta da Stazio; il nome, maschile, della formula, avrebbe ostacolato la comprensione, necessaria, della fem-minilità dell’elemento che, grazie al Convivio, può esser denominato «matrice»; la «matrice» è etimologicamente imparentata con i vocabo-li e le idee “madre” e “maternità”, cioè, direttamente, con il ruolo della donna nella procreazione e nella cura della prole.
Come si ricorderà, la lezione di Stazio trae origine da una impor-tante domanda di Dante: quella se l’anima mantenga dopo la morte, nell’aldilà, qualche forma corporea, legata insomma alla , giac-ché le stesse Scritture neotestamentarie parlano del fuoco (Dante, Vir-gilio e Stazio stanno appunto per raggiungere il muro di fuoco della cornice dei lussuriosi), lasciando così supporre che l’anima possa sof-frire pene corporee. La prima parte della risposta di Stazio (la sola che qui interessi) è incentrata, secondo che s’è già ridotto alla mente, sul concepimento e sulla formazione del corpo umano. La virtù attiva del
11 La parola dantesca «matrice» è posta direttamente in rapporto con una donna sterile an-
che nel romanzo di G. D’Annunzio Il trionfo della morte (TrM: cfr. nota 13 al capitolo I), da Quasimodo molto ammirato e variamente echeggiato nella propria poesia. Vi è antitesi ricer-cata, in entrambi i casi, rispetto all’inserzione dantesca della parola in un contesto relativo al concepimento. Ippolita, la donna amata da Giorgio Aurispa, diviene sterile dopo aver contrat-to dal marito, fin dai primi giorni del matrimonio, una brutta malattia venerea. Scrive D’Annunzio: «Ippolita era andata a nozze nella primavera avanti quella dell’amore. Dopo al-cune settimane le era cominciata la malattia della matrice, lenta e crudele, che […] l’aveva te-nuta molti giorni sospesa tra la vita e la morte» (TrM, p. 174). Quasimodo tiene certamente presente il luogo del romanzo di D’Annunzio (anche per Verde deriva, come si vedrà), ma e-gli nondimeno si collega direttamente a Dante: lo prova il fatto che in Dormono selve e in al-tre poesie a questa successive e contigue ricorre il verbo “gemere”, il quale non è ricontestua-lizzato da D’Annunzio in nessuno dei luoghi in cui sono implicati la «matrice» e il «grembo» sterili.
CAPITOLO II – Il giovane Quasimodo, la Bibbia, il Purgatorio 309
seme maschile, subito dopo il concepimento, diviene primamente a-nima solo vegetativa dell’embrione, quale è quella delle piante «con la sola differenza che l’anima della pianta è già in sé perfetta (già a ri-va), mentre questa del feto è destinata a modificarsi, per giungere alla sua perfezione (cioè è passibile di ulteriore sviluppo)»12: la fitomorfòsi di Quasimodo, il suo essere e sentirsi anche albero, così come l’albero che ha vita all’interno di lui, traggono dal ragionamento di Stazio im-pulso fondamentale seppure non esclusivo.
2. Altre letture esoteriche: le isole al plurale (la Sicilia e il purga-torio) L’interpretazione esoterica di Dormono selve trova conforto nella
poesia che si legge immediatamente dopo, Alla notte: «Dalla tua ma-trice / io salgo immemore / e piango. // Camminano angeli, muti / con me; non hanno respiro le cose; / in pietra mutata ogni voce, silenzio di cieli sepolti. // Il primo tuo uomo non sa, ma dolora.». Come ognun vede, tra l’altro, anche l’interpretazione essoterica che si era proposta per Dormono selve è da ritoccare lievemente: in Dormono selve il “tu” cui il poeta si rivolge è la «matrice»; si era ipotizzato che essa coinci-desse senz’altro con la Sicilia, intesa come grembo materno, madre, origine. In Alla notte il “tu” e la «matrice» non coincidono. In sede di interpretazione essoterica di Dormono selve interpretazione che trae ora vivida luce nuova dal ritrovamento del legame esoterico ESS–Purg occorrerà escludere che la matrice sia senz’altro l’isola e ammettere invece che l’isola–madre abbia un grembo materno, un ute-ro, che è parte di essa, al quale soltanto il poeta si rivolge, ancorché si possa tentare di invocare la sineddoche: la «matrice», parte del “tu”, starebbe in Dormono selve in luogo del “tu” del canto successivo, rap-presenterebbe insomma quel medesimo “tu”. Si dica il vero: il ricorso alla sineddoche è assai infelice; troverebbe qualche ragione se Alla notte precedesse Dormono selve. Il vero è che di entrambi i testi (e di
12 La citazione è tolta dalla nota ai vv. 52–54 di Purg, XXV redatta da A. Chiavacci Leo-
nardi per il commento al Purgatorio da lei procurato (Milano, Mondadori 2004, Collana I Meridiani, p. 741; il corsivo è di A. Chiavacci Leonardi).
PARTE TERZA – L’Apocalisse, l’amore, la natura
310
numerosi altri tra quelli raccolti in ESS) il significato letterale risulta piano e ben comprensibile solo alla luce della lettura esoterica.
A proposito di essa in questa sede interessano precipuamente i pri-mi quattro versi di Alla notte. Il poeta si stacca fisicamente dalla don-na alla quale si è appena congiunto; egli prova un senso di indifferen-za («immemore») nei confronti della donna, che è quasi certamente la medesima di Dormono selve. Egli piange: in altro contesto potrebbe trattarsi di commozione in accezione positiva, ma nulla autorizza que-sta interpretazione, talché alle «lacrime» son da associare le connota-zioni più ovvie, che implicano tristezza e abbattimento. Gli angeli, i quali camminano con il poeta silenziosi e partecipi, non appartengono a un momento onirico; costituiscono una compagnia collaudata, la quale si presenta anche alla coscienza vigile e riflessa. Gli angeli sono una eco gentile, lontana e studiata sia del mondo dell’infanzia sia di quello descritto da Dante in Purg, al quale, e segnatamente alla lezio-ne di Stazio, attraverso la mediazione del Convivio, è da riallacciare la «matrice» di questa poesia.
Diverse sono, in EES, le poesie nelle quali dal rapporto intertestua-le con Purg prende avvio il processo generatore del tessuto figurativo. Prima di passare a esaminarle occorre domandarsi se in AT non si tro-vino per avventura una o più poesie in cui la relazione predetta, invece che prefigurata e basta, non sia già attuale, già coerentemente rispec-chiata dalle parole poetiche. Si è notato in sede di lettura essoterica che in Angeli è formulata una vera e propria dichiarazione di poetica. Non è sfuggito a diversi lettori che il testo ha movenze che riconduco-no al litorale del purgatorio dantesco13. Si riesamini dunque il testo in questione.
Nel primo verso il poeta (l’io lirico) constata che non trova più ispi-razione che lo muova a ricreare in poesie la vita umana concreta e si prescrive l’«infinito» e il «sogno. Le prime espressioni che definisco-no il sogno ricordano l’arrivo di Dante e Virgilio, un paio d’ore innan-zi il sorgere del sole, sulla sponda del monte circolare del Purgatorio («in cerchio», scrive Quasimodo), lambita da acque tranquille (il
13 Cfr. p. e. L. FAVA GUZZETTA, Semantica del tempo e dell’oltre nella raccolta Ed è subi-
to sera fra Acque e terre e Òboe sommerso, in Aa.Vv., Salvatore Quasimodo nel vento del Mediterraneo, cit., p. 49; la studiosa parla di «sapore dantesco».
CAPITOLO II – Il giovane Quasimodo, la Bibbia, il Purgatorio 311
«tremolar de la marina.»: Purg, I, v. 117), che l’alba permette poi a Dante di scorgere nitidamente. L’ultimo verso della prima strofa con-duce la mente alla selva edenica, della quale i «verdi alberi» costitui-scono l’elemento essenziale, e a un punto dell’incontro tra Dante e Beatrice (i «cento» angeli che levatisi dal carro sul quale appare Bea-trice gettano fiori sopra e intorno a esso e a lei: ivi, XXX, vv. 16–30). Nella seconda strofa l’io lirico viene esortato a superare l’eternità pu-ramente fittizia delle esperienze che stanno nel tempo. Il superamento concerne anche le esperienze remote e più care, le quali, quando furo-no vissute, sembrarono perenni e misteriose: tutte le anime espianti di Purg ricordano le esperienze caduche (e nel caso delle anime spesso peccaminose) compiute nella prima vita, con dolore e pentimento ma anche con intense sfumature di dolcezza, come chi sa che tutte le espe-rienze verranno trasfigurate nella vita eterna (prive, certo, della sfuma-tura di dolore che nel purgatorio accompagna quelle peccaminose fino a quando le anime non bevono dell’acqua del Leté). Non a caso l’aggettivo «occulta» ricorre al v. 38 del canto XXX (trattasi della sola ricorrenza in Purg) e nel penultimo verso della seconda strofa del te-sto di Quasimodo.
Ancor più interessante è il fatto che la strofa iniziale di Angeli, nel-la prima versione a stampa, era chiusa da un sesto verso, espunto da tutte le edizioni seguenti: «che mai nutrì lo stesso paradiso»14. L’abbinamento degli angeli al paradiso, scontato in sede essoterica, al-ludeva in sede esoterica al paradiso terrestre, luogo disabitato anche di angeli dopo la cacciata degli uomini dal giardino di Eden. Dio, per cu-stodire la via all’albero della vita il quale si trovava all’interno del giardino e il frutto del quale dona l’immortalità , e per rendere quel-la via inaccessibile agli uomini, pose a guardia del giardino, per l’esattezza a oriente di Eden, i cherubini e la fiamma della spada fol-gorante: Genesi, 3, vv. 23–24). Angeli è il manifesto di due poetiche destinate a coesistere: quella dello sdoppiamento, del sogno, della sil-labazione notturna e del rinnovamento della dolcezza al di là da confi-ni temporali; quella della relazione che Quasimodo si prefigge di
14 Cfr. l’apparato delle varianti ricostruito da G. Finzi, a cura di, nelle Note ai testi, PDp,
p. 848 (la prima edizione di Acque e terre fu pubblicata per le edizioni di Solaria, Firenze 1930).
PARTE TERZA – L’Apocalisse, l’amore, la natura 312
stringere con Purg. L’infanzia, si sa, è spesso vissuta come l’età dell’oro della vita; all’infanzia è intimamente connessa una viva com-ponente edenica. La prima e più ovvia interpretazione del mito narrato in Genesi, 2 e 3, è che gli esseri umani devono necessariamente passa-re, per diventare adulti, attraverso una sorta di condizione pre–morale, legata alla costitutiva ingenuità e innocenza del bambino. Questi è mosso spesso da impulsi distruttivi e perfino sadici, ma non è moral-mente responsabile. Maturando, l’uomo perviene all’acquisizione sof-ferta e faticosa della coscienza morale, alla capacità di assumere in modo consapevole le responsabilità. Gli esseri umani adulti, però, non sono mai immuni da inclinazioni al “male”, da “tentazioni”, contro le quali, chi è stato in grado di temprarsi alla lotta, sempre combatte.
Per altro verso, ogni intenso panismo è intriso quasi di necessità, nell’ambiente antropologico e culturale che proviene dalle credenze giudaico–cristiane, di nostalgia del giardino di Eden. Cosciente di tut-to questo Quasimodo, elaborando i temi da sillabare in AT, lesse e ri-lesse con molta attenzione i due testi ai quali è principalmente conse-gnata la descrizione del paradiso terrestre: la Genesi, (ove il giardino di Eden è delineato in modo scheletrico e assai sommario solo in Ge-nesi, 2, che appartiene alla popolareggiante fonte jahvista) e il Purga-torio di Dante, ove il paradiso terrestre giudaico–cristiano, anche per l’ampiezza e ricchezza della descrizione fornita dal sommo poeta, as-surge forse al rango di principale locus amœnus della letteratura uni-versale. Molto significativo è però il fatto che nei testi di AT non sono mai “accordati” né la parola «selva» né i suoi derivati. Sempre si par-la, seguendo la Genesi, di «giardini». Quasimodo, per trovare immagini edeniche, si accostò dapprima e assai intensamente al testo biblico e so-lo in un secondo momento (e con speciale vitalità in ÒS) a Purg.
Se è vero che il cosiddetto ermetismo è in ogni sua fibra costituito, fin dalle radici, di relazioni analogiche, è necessariamente vero altresì che la sua essenza risiede nei rapporti intertestuali; l’altro possibile e-sito impoetico e anche impossibile perché richiederebbe un artefice “poietico” privo di ogni cultura artistico–letteraria , sarebbe che l’ermetismo fosse costituito da relazioni analogiche tutte desunte dai dati dell’immediata esperienza vissuta. In verità, la cifra ermetica, per non essere dissolta dalla penetrazione e decodificazione critica dei rapporti intertestuali, dovrebbe fondarsi non già su relazioni analogi-
CAPITOLO II – Il giovane Quasimodo, la Bibbia, il Purgatorio 313
che bensì sul caos (il quale implica, tra l’altro, babelicamente, la plu-ralità di lingue e di soggetti, ognuno estraneo agli altri e incapaci di comprendersi, che concorrano a scrivere un testo). Quasimodo ha compreso benissimo questo fin da AT. Angeli sicuramente non è stato composto né come primo né come secondo dei testi confluiti in AT: il suo carattere di doppio manifesto rende certi che il poeta, se anche lo concepì abbastanza presto, lo plasmò nella forma con cui lo leggiamo solo dopo che la poetica dello sdoppiamento, del tempo metafisico–onirico, della sillabazione notturna e del rinnovamento della dolcezza perduta si era delineata in modo abbastanza compiuto nella sua mente e nella sua fantasia15.
Si consideri nuovamente Specchio: appare ora evidente che in que-sto testo Quasimodo si serve delle parole con cui Dante descrive la di-struzione dell’albero della scienza del bene e del male per descriverne invece la faticosa rinascita. Ma egli approdò a siffatta scelta dopo un lungo percorso. Nella prima stampa di AT (nel 1930 per le Edizioni di Solaria, giova ricordarlo) la poesia non aveva ancora stretto relazione alcuna con Purg. Al v. 2 si leggeva «bocci» in luogo di gemme, e al v. 5 si leggeva «ceppo» in luogo di «tronco» (parola che in Purg ricorre solo come aggettivo dalla forma verbale “troncare”; ma che in Inf de-signa ripetute volte il tronco del pruno in cui è chiusa l’anima di Pier della Vigna: cfr. XIII, vv. 33, 55, 91, 109); inoltre nella prima edizio-ne di ESS «botro», al v. 6, «viene variato in declivio per ritornare poi nelle edizioni successive»16. Anche «declivio» è parola dantesca (e nella ricontestualizzazione ha sapore tanto lezioso quanto «botro»), salvo che trattasi di aggettivo usato in Par (XX, 61) e non in Purg: «[…] indi distrutto. / E quel che vedi ne l’arco declivo, / Guiglielmo fu, cui quella terra plora / che piagne […]».
In Specchio la scorza è spaccata dalle gemme, in Purg i nemici dell’albero rompono scorza, fiori e foglie nuove17. In altri termini: il
15 G. Finzi, a cura di, ricorda nella sua Premessa (PDp, p. LXVIII) che «le raccolte anto-logiche curate da Quasimodo stesso fino a Ed è subito sera ebbero organizzazione diversa: il poeta variava ogni volta oltre al testo anche la collocazione delle singole poesie, i loro acco-stamenti e la suddivisione in parti o sezioni».
16 G. Finzi, a cura di, Note ai testi di PDp, p. 851. 17 Si mettano a confronto i versi in cui Dante, nello stesso canto XXXII di Purg descrive
dapprima l’albero morto, poi la sua rinascita, infine la sua seconda morte limitatamente all’assalto dell’aquila: «Io senti’ mormorare a tutti “Adamo”; / poi cerchiaro una pianta di-
PARTE TERZA – L’Apocalisse, l’amore, la natura
314
poeta siciliano evita di avvalersi delle espressioni con cui Dante aveva descritto egli pure la rinascita della vita sul tronco che pareva morto quando insieme a «quella milizia del celeste regno», a Stazio, a Bea-trice e alle sette ancelle di lei egli lo raggiunge (cfr. Purg, XXXII; il verso cit. è il v. 22). Quasimodo, intenzionalmente, descrive la rinasci-ta della vita vegetale con le parole di cui Dante si era servito per de-scrivere la successiva seconda morte dell’albero per l’assalto delle tre fiere18. Come mai? Senza escludere una componente di civetteria, cre-do che la ragione di ciò sia profonda e anche molto sentita da Quasi-modo. Mettendo efficacemente le parole al servizio dell’evocazione di forme figurative egli vuol rappresentare che la vita e la morte si impli-cano vicendevolmente; vuole riallacciarsi al monito della Genesi che la nascita, per chi è stato esiliato nel mondo della caducità, della acci-dentalità e della morte, è dolore che spacca il corpo; vuole nondimeno celebrare la vittoria della vita sulla morte, una vittoria anche religiosa, perché la rigenerazione in Quasimodo ha quasi sempre pure la conno-tazione di sofferta e non del tutto “ortodossamente” accettata reden-zione.
Come si è constatato, la ricerca condotta un po’ a tentoni in AT tro-va in ÒS e segnatamente nel testo Dormono selve il proprio apice e-spressivo (non certo il solo approdo). Giova dunque tornare a scrutare spogliata / di foglie e d’altra fronda in ciascun ramo. / La coma sua, che tanto si dilata / più quanto più è sù, fora da l'Indi / ne’ boschi lor per altezza ammirata» (vv. 37–42); « E vòlto al temo ch'elli avea tirato, / trasselo al piè de la vedova frasca, / e quel di lei a lei lasciò legato. / Come le nostre piante, quando casca / giù la gran luce mischiata con quella / che raggia dietro a la celeste lasca, / turgide fansi, e poi si rinovella / di suo color ciascuna, pria che ’l sole / giunga li suoi corsier sotto altra stella; / men che di rose e più che di viole / colore aprendo, s'innovò la pianta, / che prima avea le ramora sì sole.» (ivi, vv. 49–60); «Non scese mai con sì veloce moto / foco di spessa nube, quando piove / da quel confine che più va remoto, / com'io vidi calar l'uccel di Giove / per l'alber giù, rompendo de la scorza, / non che d’i fiori e de le foglie nove; / e ferì ’l carro di tutta sua forza; / ond’el piegò come nave in fortuna, / vinta da l’onda, or da poggia, or da orza.» (ivi, vv. 109–117).
18 Il tema della rinascita primaverile dell’albero era stato già “accordato”, prima di Spec-chio, in Albero con movenze provenienti dall’episodio di Purg che si sta considerando e in parte anche da RVF: «Non solo d’ombra vivo, / ché terra e sole e dolce dono d’acqua / t’ha fatto nuova ogni fronda, / mentr’io mi piego e secco / e sul mio viso tocco la tua scorza» (AT, p. 14, vv. 8–12; è la seconda strofa). In Alla mia terra (ÒS, p. 41) un derivato di «scorza» ver-rà modulato con intenzione semantica opposta a quella primaverile: «Il mio male ha nuovo verde, / ma le mie mani son d’aria / ai tuoi rami / a donne che la tristezza / chiuse in abbando-no / e mai le tocca il tempo, / che me discorza e imbigia.» (vv. 12–18, corrispondenti alla quarta strofa; il “tu” è l’isola).
CAPITOLO II – Il giovane Quasimodo, la Bibbia, il Purgatorio 315
i testi di ÒS. Conviene commentare in chiave esoterica L’eucalyptus. La forma verbale «matura» è filiazione di un aggettivo usato da Dante nella cornice dei lussuriosi, visitata da Quasimodo non in questa occa-sione soltanto: «non son rimase acerbe né mature / le membra mie di là, ma son qui meco» (Purg, XXVI, vv. 55–56: corsivo mio). Non una dolcezza mi «matura» significa precisamente: trascorrono gli anni e io vado verso la maturità della vita senza mai provare il conforto di un caldo senso di intimità. Anche gli elementi di cui è composta l’ultima strofa dell’Eucalyptus rinviano tutti ai primi e agli ultimi canti di Purg: l’«isola mattutina» è ovviamente la Sicilia ma è anche la mon-tagna altissima che sorge dalle acque dell’emisfero disabitato e sopra la quale, al pellegrino che vi giunge all’alba, appare il meraviglioso (meraviglioso anche per Quasimodo) «dolce color d’orïental zaffiro»; la «volpe» non può non ricondurre la mente alla dantesca volpe alle-gorica che si avventa contro il «triunfal veiculo» (Purg, XXXII, v. 119). La volpe di Quasimodo è stata uccisa, quella di Dante viene messa in fuga da Beatrice. La prima volpe è d’oro, e questa pare una connotazione positiva, specie se raffrontata alle connotazioni della volpe dantesca («che d’ogni pasto buon parea digiuna»: ivi, v. 120), allegoria certa delle eresie e dell’eresia in genere. L’oro, tuttavia, è il metallo prezioso e risplendente con cui sono fabbricati spesso o quasi sempre i simulacri delle divinità mesopotamiche e mediterranee non giudaiche né cristiane e soprattutto gli “idoli” (celeberrimo il vitello d’oro: Esodo, 32, vv. 1–14), quelli che la Bibbia sempre addita come i nemici demoniaci dell’unico vero Dio; l’oro, inoltre, è il metallo che indica e simboleggia lo splendore, il lusso, la corruzione morale de-moniaca delle potenti città pagane19. Chi ben guardi, il colore dell’oro ha spesso accezione negativa e quasi satanica in Quasimodo20.
La «sorgiva» fa pensare alla sorgente del Letè e dell’Eunoè, dap-prima accennata nelle parole di Matelda («L’acqua che vedi, non sur-ge di vena» «ma esce di fontana salda e certa, / che tanto dal voler di
19 Cfr. p. e. Ezechiele, 28, v. 4 ed Apocalisse, 18, vv. 8–22. 20 Anche nel tardo Quasimodo: «Giorno dopo giorno: parole maledette e il sangue / e
l’oro. Vi riconosco, miei simili, o mostri / della terra. Al vostro morso è caduta la pietà. […]. Alzeremo tombe in riva al mare, sui campi dilaniati, / ma non uno dei sarcofaghi che segnano gli eroi»; Di Giorno dopo giorno (quinto componimento incluso nella raccolta omonima del 1947, PDp, p. 131) ho riferito i vv. 1–7 dell’unica strofa; il corsivo è mio.
PARTE TERZA – L’Apocalisse, l’amore, la natura
316
Dio riprende, / quant’ella versa di due parti aperta.»: ivi, XXVIII, vv. 121 e 123–126; corsivi miei), e poi mostrata dalle sette donne a Dante, il quale la pareggia alla fantasticata sorgente del Tigri e dell’Eufrate: «Dinanzi ad esse Eufratès e Tigri / veder mi parve uscir d’una fontana, / e, quasi amici, dipartirsi pigri.» (ivi, XXXIII, vv. 112–14).
Alla luce di quanto s’è scritto anche la seconda e la terza strofa dell’Eucalyptus rivelano intimi legami con il giardino posto sulla sommità del purgatorio: «dolente rinverdire» è espressione che si ade-gua bene all’esperienza vissuta da Dante nella perennemente giovane, viva e verdeggiante selva edenica, ove erbe, fiori, piante, alberi e per-sonaggi (questi ultimi di passaggio, se è lecita la precisazione un poco irriverente) sempre si trovano nei pressi delle acque dei fiumi. Dante era stato innamorato di Beatrice fin dall’infanzia; dalla donna velata che sta sopra il carro si sprigiona infatti, rinnovata e fortificata, «l’alta virtù che già m’avea trafitto / prima ch’io fuor di puerizia fosse» (Purg, XXX, 41–42). Beatrice rimprovera e mortifica Dante con a-sprezza, prima di togliersi il velo, rinfacciandogli la sua condotta. An-che Dante è costretto a “rinverdire” con grande dolore, il proprio pas-sato “infermo”, peccaminoso, di cui è necessario ch’egli si penta, fino a scoppiare in un pianto dirotto21. L’albero quasimodiano che come so-litario oscilla riconduce il lettore anche all’albero della scienza del be-ne e del male. Quando nel paradiso terrestre la processione giunge da-vanti a esso, i suoi rami e il tronco sono completamente nudi; però, dopo che il Grifone ha legato intorno al tronco dell’albero il carro trionfale, l’altissima pianta vive, come già si è ricordato, una sorta di rigenerazione, nuovamente rivestendosi di gemme, fiori e fogliame22. Si riduca alla mente che nell’Apocalisse (22, v. 2) è scritto che le fo-glie dell’albero della vita servono a guarire le nazioni.
Subito dopo il prodigioso evento Dante si addormenta profonda-mente: ciò spiega perché «assonnata» sia la terra prospiciente le acque ove l’albero quasimodiano affonda le proprie radici. Dopo che Matel-da lo risveglia, Dante rivede Beatrice, non più velata, «sotto la fronda / nova sedere in su la sua radice:» (Purg, XXXII, vv. 86–87). Subito dopo si avventano uno dopo l’altro in diverso modo contro il carro gli
21 Cfr. Purg, XXX, vv. 91–99 e XXXI, vv. 16–21 e 34–36. 22 Cfr. nota 17.
CAPITOLO II – Il giovane Quasimodo, la Bibbia, il Purgatorio 317
animali allegorici, cioè l’aquila, la volpe e il drago. La volpe è tra essi quello che attrae maggiormente la fantasia quasimodiana; come s’è già messo in chiaro, essa diviene l’elemento che principalmente gene-ra il tessuto figurativo della quarta strofa. Alla volpe sono subordinati gli altri elementi, l’isola, la luce e la sorgiva.
Una volta che la chave dell’Eucalyptus sia stata rivelata e che il te-sto abbia completamente perduto la prima, superficiale e semantica-mente letterale, parvenza ermetica, si può forse concludere ch’esso perda completamente la cifra ermetica a anche, soprattutto, il fascino arcano? A parere di chi scrive la relazione intertestuale con Purg co-stituisce non solo la superficie o l’apparenza del componimento ma il fattore che ne struttura precisamente l’intenzione ermetica. L’aspetto arcano viene dissolto dal ritrovamento della chiave, ma questo non implica un giudizio limitativo. Il componimento era prima del ritrova-mento della chiave, e rimane dopo, a ritrovamento avvenuto, un con-centrato esercizio estetizzante, costruito in notevole misura a partire da uno spunto alquanto banale e immediatamente evidente: la malin-conia del ricordare l’infanzia, l’isola natale da cui ci si sente seque-strati, e forse il primo amore fanciullesco, potente e segreto. L’eucalyptus è una di quelle prove non suscitate dal démone ma dal bisogno di affaticarsi, per dirla con Croce, “a freddo”, su uno spunto e su temi che attirano l’io lirico, in vista del conseguimento di effetti poetici dalla tesa, serrata, originale espressività: effetti raggiunti feli-cemente in Dormono selve (e poco importa che il ritrovamento della chiave abbia tolto anche a questo componimento l’etichetta o sigla ermetica).
Una pura variazione o quasi dell’Eucalyptus è Nascita del canto (ÒS, p. 42):
Sorgiva: luce riemersa: / foglie bruciano rosee. // Giaccio su fiumi colmi / dove son isole / specchi d’ombre e d’astri. // E mi travolge il tuo grembo celeste / che mai di gioia nutre / la mia vita diversa. / Io muoio per riaverti, anche delusa, adolescenza delle membra inferme..
Il poeta descrive lo stesso paesaggio dell’Eucalyptus, colto forse
con una luce appena diversa e più intensa: sembra ch’esso venga raf-figurato in un momento di poco successivo cronologicamente, forse di
PARTE TERZA – L’Apocalisse, l’amore, la natura
318
un quarto d’ora, forse di mezz’ora. A proposito del secondo verso,
«foglie bruciano rosee», si tengano presenti i versi danteschi citati
dianzi: «men che di rose e più che di viole / colore aprendo, s’innovò
la pianta, / che prima avea le ramora sì sole». Il testo è riconducibile a
un di presso vuoi ai medesimi elementi del paradiso terrestre (con
l’eccezione della volpe) vuoi a una situazione emotiva dell’io lirico af-
fine a quella dell’Eucalyptus; è una situazione appena meno rattristata,
perché è ravvivata dalla morte metafisico–onirica che contrassegna i
testi di ESS, cioè dallo sdoppiamento e dall’abbandono del tempo em-
pirico attuale. Codesta morte rigenererà il tempo umano (l’infanzia–
adolescenza impossedute) dall’io presentemente perduto. Si può ora
comprendere con certezza come mai il poeta, a partire dalla seconda
raccolta, adoperi spesso il plurale «isole» (che si incontra anche in Na-scita del canto, ÒS, p. 42, in Seme, ivi, p. 69, in Verde deriva, ivi, p.
71 e via dicendo). Ci si era interrogati cautamente circa le ragioni di
ciò anche nel capitolo precedente, a dire il vero senza trovare una
spiegazione persuasiva. Grazie alla interpretazione esoterica si com-
prende con sicurezza che le isole sono due: la Sicilia e il dantesco
monte del purgatorio.
3. I miti biblici e l’isola estatica alle origini di ESS
Si possono trarre le prime conclusioni: ÒS, la seconda delle quattro
raccolte di ESS, quella centrale quanto a intensità della cifra ermetica
e a quantità dei testi presentati, si rivela decisamente meno legata ai
miti mediterranei di quanto si sia finora creduto, mentre un legame se-
greto ma non troppo la avvince all’emisfero meraviglioso delle acque
oceaniche sul quale si erge solitario il monte gigantesco23. Non solo:
pare che limitatamente ai miti mesopotamici e mediterranei gli echi
sia vetero– che neo–testamentari, ben diversamente da quel che ha
creduto perfino un sommo studioso come Contini, prevalgano su quel-
23
Si toccherà brevemente, in questa sede, della quarta e ultima collezione inclusa in EES,
NP; si avrà modo di mostrare tuttavia che i testi ivi raccolti, scritti fra il 1936 e il 1942, paral-
leli o successivi alla traduzione dei Lirici greci (pubbl. nel 1940), risentono essi pure del le-
game con Purg.
CAPITOLO II – Il giovane Quasimodo, la Bibbia, il Purgatorio 319
li greci e pagani. A queste conclusioni si possono dare supporti ulte-
riori, atti a toglier loro il carattere di provvisorietà. I vari approcci a
Purg primamente oggettivati in AT sono ancora labili, “laterali”, in-
certi. Essi costituiscono un itinerario di ricerca e testimoniano della
calamitante attrazione esercitata dalla meravigliosa montagna di Dan-
te. L’isola abitata dai morti e dagli angeli, confitta nell’emisfero delle
acque, coloratissima, estatica, luminosa, avvolta di notte da tenebre
fittissime, raccolta e concentrata religiosamente, ricca di affetti uma-
namente buoni, devota e grata a Dio; l’isola che è il luogo sia della ri-
generazione all’interno di una temporalità esterna e parallela rispetto a
quella della terrena finitezza e accidentalità sia dell’ingresso nella vita
eterna; che per altro verso contiene, sulla propria vetta, il paradiso ter-
restre lussureggiante di vita in cui i primi uomini abitarono prima
d’esser precipitati nella caducità e nella morte: quest’isola meraviglio-
sa, rasserenante e inquietante, prende a unirsi nella fantasia di Quasi-
modo al vagheggiamento della sensuosa isola natale, della quale il suo
mondo morale è indelebilmente intriso e che porge materia alla sua
energia plasmatrice.
Forse sono presenti anche piccole movenze riconducibili piuttosto a
Par che a Purg; si riconoscerebbero nell’insistenza dell’io lirico sulle
orbite circolari degli astri: «e gli astri seguivano precisi / ignoti cam-
mini in curve d’oro» in Di fresca donna riversa in mezzo ai fiori, tante
volte citato, «né volgere di stelle» e le «altezze di pianeti» in D’alberi sofferte forme (ÒS, p. 74) oppure «mobile d’astri e di quiete», nel
componimento omonimo (ÒS, p. 66). A codesta ipotesi, però, non si
deve dare soverchia importanza. Si tenga presente piuttosto che le e-
spressioni relative al firmamento e agli astri reperibili nella poesia di
Quasimodo sempre o quasi sempre arieggiano gli elementi della crea-
zione del mondo di Genesi, 1 (specie vv. 6–8 e 14–19).
Tutte le considerazioni fino a ora formulate inducono a leggere an-
che Un sepolto in me canta (ÒS, p. 48), che è quasi una variazione di
Òboe Sommerso:
M’esilio; si colma / ombra di mirti / e il sopito spazio m’adagia. // Né amo-
re accosta / silvani accordi felici / nell’ora sola con me: / paradiso e palude
/ dormono in cuore ai morti. // E un sepolto in me canta / che la pietraia
forza / come radice, e tenta segni / dell’opposto cammino.
PARTE TERZA – L’Apocalisse, l’amore, la natura 320
Il poeta vive l’esperienza dello sdoppiamento («m’esilio»): come sempre in tale circostanza gli sembra di morire alla vita reale (il mirto è pianta di onoranza funebre e si trova in particolare sulle tombe degli eroi e dei poeti) e di assopirsi, in questo caso delicatamente. Pare al poeta che nessun sentimento d’amore giunga a portargli liete sillaba-zioni inerenti alberi e boschi: diversamente, forse, da quel che si at-tendeva quando si era “esiliato” nell’ora serale della poesia. Il paradi-so e la palude non vivono nelle sue parole poetiche, restano inerti nel mondo dei morti. Il paradiso e la palude potrebbero sembrare mondi contrapposti in sede di lettura essoterica (l’allitterazione li congiunge strettamente, è chiaro, ma ciò può ben marcare pure un’antitesi): quasi un mondo della piena felicità e un mondo infermo e infernale. La let-tura esoterica non può considerarli invece che alla stregua di significa-ti (e luoghi) che fanno parte del medesimo ambiente: il giardino ede-nico e il «molle limo», a margine tra le acque che lambiscono le spon-de del monte colossale e la spiaggia (Purg, I, v. 102). Il poeta sente che l’io lirico dentro di lui si fa strada. L’io lirico è paragonabile a una radice sotterranea robusta che tenacemente, in luogo di espandersi ed estendersi sottoterra, si faccia strada verso la superficie terrestre («ten-ta segni dell’opposto cammino»), verso l’aria e la luce, arrivando a scardinare una pietraia: simbolo evidente, questa, dell’aridità, cioè del-la difficoltà di raggiungere l’ispirazione. In linea di massima, a partire da Dormono selve, il gruppo di vocaboli «selv–a–e», «verde», «aria» (o «vento»), «acque», «erbe» mentre evoca la Sicilia della «dolcez-za» echeggia intenzionalmente la selva edenica dantesca. Un sepol-to in me canta quasi certamente è stata composta dopo Dormono sel-ve, ancorché nella raccolta sia collocata innanzi il testo–chiave.
Tornando a osservare adesso in maniera più attenta Òboe Sommer-so, la relazione tra questo testo e Purg si mostra abbastanza distinta-mente. La prima strofa della poesia lamenta con accenti assai sofferti l’impotenza a ottenere le parole poetiche. La seconda strofa allude for-se alla rigogliosa vita vegetale perenne della dantesca selva edenica: «Un òboe gelido risillaba / gioia di foglie perenni, / non mie, e sme-mora;». Per Dante la selva è luogo «d’ineffabili delizie» (Purg, XXIX, 29), per l’Apocalisse, come si è già ricordato, le foglie dell’albero del-la vita servono a guarire le nazioni: da ciò l’io lirico quasimodiano si sente escluso. Perché mai questa questa estraneità? Non pare che essa
CAPITOLO II – Il giovane Quasimodo, la Bibbia, il Purgatorio 321
sia dovuta a motivi religiosi; si possono ipotizzare altri due ordini di motivi: 1) il poeta si sente escluso dai «silvani accordi felici» di Un sepolto canta in me, che talvolta ha conseguito, seppure sempre a fati-ca, nell’ora tarda del giorno destinata alle sillabazioni; si badi: egli è escluso dalla gioia di modulare con parole sue il paradiso terrestre, non dalla possibilità di ascoltare antiche e incorruttibili modulazioni altrui (quelle della Genesi? Quelle dell’Apocalisse? Quelle di Purg?). Sebbene egli riesca poi a vivere l’esperienza dello sdoppiamento sera-le («in me si fa sera,», «il cuore trasmigra») e a plasmare parole poeti-che, egli si sente arido; e arida, quasi un cumulo di rovine, gli appare la sua vita reale presente. b) Il poeta accarezza intensamente il ritmo perpetuo della fecondazione e generazione, quale è attuato nella selva edenica dall’aura lieve impregnata di virtù generativa e dalla terra che da questa è fecondata; di tale ritmo il poeta non può essere partecipe, come in qualche modo è scritto negli ultimi due versi della terza strofa («[…] il cuore trasmigra / ed io son gerbido»24), e tuttavia egli sente acuta la nostalgia di esso: «Ali oscillano in fioco cielo,» (quasi una pa-rafrasi dell’«aura dolce, sanza mutamento» di Purg, XXVIII, v. 7, sebbene in Òboe Sommerso le ali che muovono l’aria possano essere ali di angeli). L’aridità che ostacola la sofferta creazione poetica è al-lora anche segno di un sentimento di sterilità fisica, di mancanza, nel proprio corpo, di forza vitale, di capacità di dare la vita.
4. Unione del principio e della fine dei tempi: Di fresca donna
Si rileggano anche le prime tre strofe del componimento Di fresca donna riversa in mezzo ai fiori. S’era supposto nel capitolo precedente che durante la notte la coscienza e il cuore lasciassero il mondo terre-no (le perturbazioni atmosferiche valgono a qualificarlo) ed emigras-sero sull’isola, ove si troverebbe la città sospesa. Si era però notato che la «città a mezz’aria sospesa» non aveva nessuna delle connota-zioni della patria, giacché il poeta la sentiva come «ultimo esilio». Ora è possibile escludere che quella città abbia relazione diretta con la Si-
24 «Gerbido» (terreno piemontese simile a una brughiera) proviene quasi certamente da un
tema mediterraneo gherba allineato ai tipi di arido e simili.
PARTE TERZA – L’Apocalisse, l’amore, la natura
322
cilia. Essa coincide con la città santa, Gerusalemme: in Apocalisse, 21, v. 2 e v. 10, l’angelo conduce lo pseudo–Giovanni (com’è ormai risa-puto, il libro sacro non è di penna dell’apostolo, ancorché sia forse possibile considerarlo di “scuola” giovannea) su un monte grande e al-to, e gli mostra la città santa. Questa scendeva dal cielo, da Dio, e ri-splendeva della gloria di Dio. La madre del poeta, dunque, e le donne soavi, sono risorte nella gloria di Dio; ma il poeta, nonostante l’amore che lo avvince alla madre, non sente punto come patria e dimora desi-derata la Gerusalemme celeste.
Sono evidenti le analogie tra la seconda strofa del testo e l’incontro di Dante con Beatrice. Questo incontro, che abbraccia i canti dal XXIX al XXXIII di Purg, si svolge all’interno del giardino (bosco, per Dante) di Eden25. Il trionfo di Beatrice è contrassegnato, com’è no-tissimo, da una processione di figure e di oggetti simbolico–allegorici tolti da Dante soprattutto all’Apocalisse: i candelabri, i vegliardi dalle stole candide, i quattro animali dotati di sei ali ciascuno, il vecchio addormentato in cui è allegorizzata la stessa Apocalisse, cioè la visio-ne estatica ivi narrata, le miriadi di angeli che nell’Apocalisse (5, vv. 11–12) stanno intorno al trono di Dio, agli esseri viventi e ai vegliardi; in Purg, XXX, gli angeli si levano verso e sopra Beatrice che sta sul carro trionfale trainato dal grifone, cioè dal Cristo. Il sommo poeta ha riunito nello stesso spazio, quello delle origini dell’uomo, l’alfa e l’omega della storia della salvezza. Egli, sul livello del senso letterale, pareggia Beatrice alla sposa del Cantico dei Cantici (4, v. 8): cfr. Purg, XXX, v. 11. Ma come non pensare anche alla sposa dell’Apo-calisse (la città santa, la Gerusalemme messianica), pronta come una sposa adorna per il suo sposo, l’Agnello (ivi, 21, vv. 2 e 9)?
Anche Beatrice è da Dante, in Purg, XXX, v. 79, espressamente equiparata a una «madre» seppure al primo momento non soave e anzi superba. Anche Beatrice, dopo che si è tolta il velo, si rivela a Dante immensamente più bella, grazie alla rigenerazione nella seconda vita, di quanto egli mai l’avesse vista nella prima vita. Ella appare prima-mente all’interno di una nuvola di fiori bianchi e il suo capo, sopra il
25 E all’interno della selva edenica, nel canto XXXII, Dante ri–drammatizza liberamente
anche gli eventi funesti raccontati dal capitolo dodicesimo al capitolo diciottesimo dell’Apocalisse.
CAPITOLO II – Il giovane Quasimodo, la Bibbia, il Purgatorio 323
candido velo, è cinto di una corona di foglie d’ulivo; Quasimodo ribal-ta, concentrandole, queste ultime immagini: l’amatissima madre cinge il capo del figlio di una corona formata da rose bianche. Si ricordi che il capo dei ventiquattro seniori, i quali precedono il carro trionfale e Beatrice, è cinto di gigli bianchi, mentre i sette vecchi che procedono dietro il carro recano in capo corone di rose rosse e di altri fiori ver-migli. Mi pare che Quasimodo desideri che l’accento batta sul colore che rappresenta la fede. Le «soavi donne» quasimodiane rimandano alle ancelle di Beatrice, simbolo delle virtù teologali e cardinali, cioè della virtù cristiana senz’altro. L’io lirico incontra dunque la madre dopo che ella si è purificata da ogni scoria anche minima di peccami-nosità ed è giunta alla compiuta rigenerazione («fatta nuova dagli an-ni» e «fresca»). È l’esito raggiunto da Dante medesimo negli ultimi versi di Purg: «rifatto sí come piante novelle / rinnovellate di novella fronda, / puro e disposto a salire a le stelle.» (XXXIII, vv. 143–145). Il ricordo della madre morta par dunque invitare il figlio alla fede.
Le «cose fatte fuggitive», chi ben guardi, cercano di ricondurre il poeta sulla via per raggiungere l’albero della vita. Come si è già nota-to, Purg, ancor più di Genesi, ha assicurato al poeta che dopo la cac-ciata di Adamo ed Eva dal giardino di Eden, questo era rimasto vuoto di ogni creatura, oltre che inaccessibile agli uomini: «Sí passeggiando l’alta selva vota, / colpa di quella ch’al serpente crese, / temprava i passi un’angelica nota.» (Purg, XXXII, vv. 31–33)26. I «giardini spa-lancati», con ogni evidenza, coincidono con il giardino di Eden. Esso non è più sottratto agli uomini e non è più custodito all’esterno dai
26 L’accanimento ostile di Dante nei confronti di Eva che non pure il racconto della
creazione di Genesi, 1, ma neanche il secondo racconto popolaresco della creazione della coppia umana in Genesi, 2, e poi quello della cacciata (nel medesimo capitolo) autorizza, poi-ché maggior risalto della fanciullaggine di Eva ha di fatto in Genesi, 2, la viltà e debolezza di Adamo non è punto condiviso da Quasimodo. Beatrice, diversamente da Eva, non può es-sere un’amante, lo si ribadisca; ella può fare e fa da figura materna. L’accanimento di Dante, certo, è comprensibile alla luce della misoginia dei Padri e della intera chiesa del medioevo. Piace invece a Quasimodo Eva, donna e casalinga ingenua, innamorata del compagno, lieta e disposta a congiungersi con lui malgrado le numerose gravidanze che “spaccano” il delicato corpo femminile: «In fresco oblio disceso / nel buio d’erbe giace: / l’amata è un’ombra e ori-glia / nella sua costola» (L’Ànapo, EA, p. 82). E vi è piena reciprocità, sillabata in un testo ap-partenente alla medesima collezione: «E vidi l’uomo / chino sul grembo dell’amata / ascoltar-si nascere, / e mutarsi consegnato alla terra, / le mani congiunte, / gli occhi arsi e la mente» (Canto di Apòllion, ivi, p. 80, vv. 4–9, seconda strofa).
PARTE TERZA – L’Apocalisse, l’amore, la natura
324
cherubini e dalle fiamme della spada folgorante: è spalancato; chiun-que lo desideri può entrarvi. A dire il vero, Quasimodo fonde echi del-la Genesi con echi dell’Apocalisse. È in questo libro, infatti, che ri-compare l’albero (forse gli alberi) della vita, e in esso Dio promette che le porte della città santa non si chiuderanno mai. Tutti i giusti, i puri e i santi entreranno e avranno parte all’albero della vita (ivi, 21, v. 25 e 22, v. 14).
Il poeta, però, non si lascia allettare; non può non rimpiangere acu-tamente l’ultimo sorriso della madre doppiamente scomparsa: scom-parsa perché ha lasciato la “prima vita”, scomparsa perché il cuore e la coscienza dell’io lirico lasciano la «città a mezz’aria sospesa» per tor-nare al mondo in cui v’è «ansia delle piogge notturne,» (Di fresca donna, v. 2) e «variar nei cieli delle nuvole,» (ivi, v. 3). In linea di massima è lecito sostenere che vi sia nel testo una certa ribellione a fronte della cacciata dal paradiso terrestre e della severissima punizio-ne da Dio imposta agli uomini. Fuor di metafora, vi è ritrosia a credere che i miti della Genesi possano essere accolti tal quali, come se l’uomo si fosse realmente dato per sua scelta al peccato o alla pecca-minosità mentre gli sarebbe stato possibile vivere nell’innocenza27. Nessuna redenzione vale a risarcire pienamente la ferita che ogni uo-mo subisce a fronte della scomparsa di coloro che ha amato e ama, tanto che l’uomo diventa riluttante, riottoso ad accogliere il dono dell’immortalità e della vita eterna in Dio. In questo senso la «fresca donna», ammesso e non del tutto concesso che si tratti della madre, è simbolo di ogni donna profondamente amata da un uomo28.
27 Per altro verso il poeta non sembra percepire lo strazio e l’ansia di giustizia di coloro
che soffrivano la persecuzione degli imperatori romani (Nerone e Domiziano, per citare quelli coevi alla stesura del gran libro) solo a causa della loro fede: alle vittime di questo sterminio l’Apocalisse vuol ridare speranza e di esse vuole rialzare la forze morale.
28 Vi è anche, specie negli ultimi due versi del componimento, una dura polemica nei con-fronti della patologia dell’amore e dell’eros quale è raffigurata e accarezzata da D’Annunzio in TrM. Piace molto a Giorgio Aurispa, dell’amatissima Ippolita, il singolare pallore, mortale, profondo, cupo, ch’egli non ha mai ritrovato in nessun’altra donna. Egli si trova a pensare che «morta ella raggiungerà la suprema espressione della sua bellezza» (ivi, pp. 168–169); e che, s’ella morisse, «diventerebbe materia di pensiero, una pura idealità. Io l’amerei oltre la vita, senza gelosia, con un dolore pacato ed eguale» (ivi, p. 169). Un giorno di giugno «nei vasi languivano larghi mazzi di rose bianche» (ibidem), e Ippolita, immobile e quasi senza respiro, giaceva assopita sul divano; dopo aver contemplato a lungo la donna Giorgio «per una im-provvisa fantasia, l’aveva coperta di rose, piano piano, cercando di non destarla; le aveva
CAPITOLO II – Il giovane Quasimodo, la Bibbia, il Purgatorio 325
L’interpretazione autorizzata dalla relazione con Purg è sicuramen-te la più aderente alla sostanza espressiva del componimento Di fresca donna riversa in mezzo ai fiori, ma essa non destituisce punto di va-lore l’altra interpretazione che è lecito ricavare dal rapporto del testo di Quasimodo con la canzone Chiare, fresche et dolci acque. Del re-sto la relazione con Purg consente di comprendere come in testi solo apparentemente lontani da esso la intensa sensualità, fisicamente e psichicamente salutare (senza complicazioni morbose di alcun gene-re) dell’io poetante si senta estranea e quasi ostile all’assenza di eros carnale che contrassegna il rapporto tra Dante e Beatrice. Una beati-tudine edenica autentica non può esistere senza desiderio fisico, sia maschile che femminile e senza appagamento di esso; una umana re-alizzazione e felicità nell’amore di coppia non può essere completa senza figli.
5. La lezione di Stazio e la virtù attiva del seme in Quasimodo Il sangue e i suoi derivati rinviano spesso, in grazia del rapporto
intertestuale con la lezione di Stazio e con la diretta dissertazione di Dante nel Convivio, all’atto sessuale: «e io giacevo in te / con la mia vita / in poco sangue raccolta,» (A me discesa per nuova inno-cenza, AT, p. 59, vv. 7–9), ove il «poco sangue» sta a significare il seme maschile; che la poesia canti il culmine del piacere dei due composto su i capelli alcune rose. Ma così infiorata, inghirlandata, ella gli era parsa un corpo esanime, un cadavere. […] Ah il terrore e l’ansia […] e misto al terrore l’entusiasmo per la sovrana bellezza di quel volto straordinariamente rannobilito da quel riflesso di morte!» (ibi-dem). L’apoteosi di Ippolita “come se fosse morta” voluta e compiuta da Giorgio, trae spunto evidente sia dall’apoteosi di Beatrice nella seconda vita cantata da Dante sia da quella di Lau-ra nella prima vita cantata da Petrarca. L’apoteosi di Ippolita è vividamente presente alla men-te del Quasimodo che sillaba Di fresca donna riversa in mezzo ai fiori. Il poeta, però, prova dolore e basta alla vista della amatissima fresca donna esanime. Vuoi che la donna riversa tra i fiori sia una persona amata diversa dalla madre vuoi che sia la madre (la quale aveva incoro-nato di rose bianche il capo del figlio in un atto di amore soave e assoluto, ben diverso dalla macabra voluttà estetizzante dello psicolabile Giorgio) il dolore dell’io lirico è ancora una volta sano, naturale. La morte di coloro che amiamo, anche se indubbiamente continuiamo ad amarli oltre la morte, è perdita irreparabile, specie nel primo tempo del lutto: tanto che il poe-ta non riesce a farsi attrarre dalla possibilità di entrare nel giardino edenico. Quasimodo anco-ra una volta si trova sulla scia della massima goethiana “viva chi vita crea”, e condanna ogni attrazione morbida e patologica nei confronti della morte.
PARTE TERZA – L’Apocalisse, l’amore, la natura
326
amanti è abbastanza chiaro, ma davvero strano sarebbe che in que-sto momento di potenza e vitalità il sangue di lui, anche letteral-mente, fosse da intendere come scarso e debole29. «Né in te riparo, / abbandonata al sonno / da fresca gioia: / vanamente rinsanguo fat-to sesso.» (L’acqua infradicia ghiri, cit., p. 68, vv. 10–13, terza e ultima strofa), ove il poeta pare desiderare un nuovo amplesso con l’amata (pur sapendo che questo probabilmente non ci sarà), e sente avvenire nel suo corpo le conseguenti normali reazioni viri-li. Il senso letterale ancora una volta si comprende bene solo in vir-tù del legame stretto da questi testi con Purg. Il verbo “gemere” ricorre in altri testi vicinissimi o non vicini a Dormono selve, sempre con significato vicino o identico a quello di Dormono sel-ve e mai con significato mutuato da Dante. Tuttavia il poeta si compiace di accostare quel verbo a parole che ricordano o l’atto sessuale o la generazione (anche animale e vegetale): «gemono al seme sparso / larve verdi: il mio volto è loro primavera» (Meta-morfosi nell’urna del santo, ÒS, p. 58, vv. 8–10, seconda strofa; corsivi miei); «Nell’ora mattutina a luna accesa, / appena affiori, geme / l’acqua celeste. // Ad altra foce / più dolente sostanza / soffiò di vita l’urlo dei gabbiani.» (Sardegna, EA, p. 90, vv. 1–6, seconda strofa).
Singole parole o coppie o più termini tra quelli appartenenti al gruppo «matrice», «sangue» (e termini a esso etimologicamente appa-rentati), «gemere», «seme», «selve», «vento», «verd-», vengono spes-so ricontestualizzati in altri testi appartenenti soprattutto ad AT e ÒS
29 «Era beata stanotte la tua voce / a me discesa per nuova innocenza / nel tempo che pati-
sco un nascimento / d’accorate letizie. // Tremavi bianca, / le braccia sollevate; / e io giacevo in te / con la mia vita / in poco sangue raccolta, / dimentico del canto / che già m’ha fatto e-strema, / con la donna che mi tolse in disparte, // la mia tristezza / d’albero malnato»: l’alternanza tra imperfetto e passato remoto rende certo il fatto che l’amante della notte qui cantata è una donna diversa rispetto a quella di Dormono selve e di Alla notte. Il nuovo con-nubio procura al poeta rigenerazione («nascimento») e felicità, attenuata da qualche nota di-scorde (probabilmente il ricordo dell’altra donna, alla quale egli non è più fedele); grazie alla nuova amante il poeta dimentica le sillabazioni in cui era stata data forma alla sua intensissi-ma («estrema») tristezza di creatura assimilabile ad albero infermo; sillabazioni e tristezza proprie di un tempo arido, prosaico e privo di dolcezza nel corso del quale egli era vissuto ap-partato con l’antica amante (o almeno oggi prova la sensazione di essere stato, allora, lontano dal mondo reale con cui forse si sta riconciliando).
CAPITOLO II – Il giovane Quasimodo, la Bibbia, il Purgatorio 327
ma anche a EA30: «E fammi […] / o seme d’orzo […] /» (Curva mino-re, cit., p. 47, vv. 6–7); «che quando Tu voglia / in seme mi getti / già
stanco del peso che dorme» (Seme, ÒS, vv. 13–15: è la terza e ultima
strofa; corsivo mio); «Del mio odore di uomo / grazia all’aria degli
angeli, / all’acqua mio cuore celeste / nel fertile buio di cellula» (Del mio odore di uomo, ivi, p. 93, vv. 5–8; è la seconda e ultima strofa);
«Giace nel vento di profonda luce, / l’amata del tempo delle colombe. /
Di me di acque di foglie, / sola fra i vivi, o diletta, / ragioni; e la nuda
notte / la tua voce consola / di lucenti ardori e letizie. // […] / […] / […]
// Ma dal profondo tuo sangue, / nel giusto tempo umano, / rinasceremo
senza dolore» (Nel giusto tempo umano, ivi, p. 94, vv. 1–7 e 12–14;
trattasi della prima e della terza strofa). Codesti termini, o isolati o in
piccoli gruppi, divengono cellule che nel nuovo testo si sviluppano,
formando sia piccole compagini espressive sia veri e propri tessuti figu-
rativi, sempre direttamente riconducibili alla seconda cantica dantesca,
30
Accanto al gruppo di parole ricordato nel testo, e anzi a esso cronologicamente antece-
dente perché rappresentato fin dall’itinerario sperimentale di AT, se ne può indicare un altro,
più arcano, religioso, estatico e anche o esotericamente o cristianamente connesso alla morte e
alla dimensione abitata dai morti: «angeli», «morti», «bianc–a, –o, –hi» (bianchi sono i mor-
ti), «bambini», «voci», «Signore», «Padre» ecc. Mi limito a registrare, ancora una volta traen-
dole da ÒS, le parti di singoli significanti/significati (p. e. quanto al gioco allitterativo in –v– e
in –f–), le espressioni e i versi più ricchi di legami intertestuali impliciti con Purg.: «E fammi
vento che naviga felice,» (Curva minore, cit., p. 47, v. 6); «silvani accordi felici / nell’ora sola
con me: / paradiso e palude / dormono in cuore ai morti.» (Un sepolto in me canta, ÒS, p. 48,
vv. 5–8); «si cresceva in vista d’alti cieli / correndo terre e vapori di pianeti:» (Compagno, ivi,
p. 49, vv. 14–15); «Nascono gli animali / al soffio dell’aria» (Senza memoria di morte, ivi, p.
51, vv. 14–15); «Pietà del tempo celeste, / della sua luce / d’acque sospese;» (Preghiera alla pioggia, cit., p. 52, vv. 11–13); «I morti maturano, / il mio cuore con essi.» (Metamorfosi nell’urna del santo, cit., p. 58, vv. 1–2); il significato di maturano s’intende riscontrando
Purg, XIX, vv. 89–93 e 139–141: «trassimi sovra quella creatura / […] / dicendo: “Spirto in
cui pianger matura / quel sanza ’l quale a Dio tornar non pòssi, / sosta un poco per me tua
maggior cura.»; «Vattene omai: non vo’ che più t'arresti; / ché la tua stanza mio pianger disa-
gia, / col qual maturo ciò che tu dicesti»; i corsivi sono miei); «Avremo voci di morti anche
noi, / se pure fummo vivi talvolta / o il cuore delle selve e la montagna, / che ci sospinse ai
fiumi, / non ci volle altro che sogni » (Dove morti stanno ad occhi aperti, ÒS, p. 61, vv. 7–
11); «Alberi d’ombre, / isole naufragano in vasti acquari, / inferma notte, / sulla terra che na-
sce: // un suono d’ali / di nuvola che s’apre / sul mio cuore: // nessuna cosa muore / che in me
non viva. // Tu mi vedi: così lieve son fatto, / così dentro alle cose / che cammino coi cieli;»
(Seme, ivi, p. 69, strofe prima e seconda); «grazia amara del viver senza foce. // Vergini strade
oscillano / f resche di f iumi in sonno: // E ancora sono il prodigo che ascolta / dal silenzio il
suo nome / quando chiamano i morti.» (Fresche di fiumi in sonno, ÒS, p. 72, vv. 5–10; in tutti
i luoghi citati i corsivi sono miei).
PARTE TERZA – L’Apocalisse, l’amore, la natura 328
nei quali è implicato fortemente il rimando all’atto sessuale, alla fecon-dità, alla gravidanza e alla nascita. Tali esperienze, come si è detto, so-no qualche volta evocate indirettamente, mediante immagini della natu-ra in senso stretto, e piuttosto vegetali che non umane o animali.
Altre volte, più raramente, il sangue è contrassegno della vita uma-na terrena, nella sua diversità dagli elementi propri del «tempo cele-ste», cioè quello edenico, concepito sia secondo la figurazione della Genesi che secondo quella dantesca (cfr. p. e. le ultime due strofe di Preghiera alla pioggia, ÒS, p. 52). Talvolta, infine, il «sangue» è a-doperato in chiave semanticamente ambigua, tra accezione mistica e accezione sensuale, d’intesa con la lezione di Stazio. Così, p. e. nella strofa finale (la quinta) di Curva minore (ÒS, p. 47), che per la durata delle altre quattro strofe è preghiera e invocazione a Dio (Egli è il “tu” sottinteso della stessa ultima strofa): «Ancora mi lasci: son solo / nell’ombra che in sera si spande, né valico s’apre al dolce / sfociare del sangue.» (vv. 15–18). Non sporadici echi e prolungamenti di que-ste figurazioni e di questi significati si rinvengono anche nelle colle-zioni poetiche della seconda epoca.
Interessante, fin dal titolo, anche la poesia Anellide ermafrodito (ÒS, p. 73), collocata quasi immediatamente dopo Verde deriva: la strofa centrale, «A te mi porgo trebbiato / senza seme; e duole dentro / pietà di magre foglie / che m’aiuta la morte» (vv. 6–9) dice forse di un rapporto sessuale appena consumato e dello sfinimento amoroso, che non impedisce peraltro l’atteggiamento tenero e affettuoso verso la compagna («a te mi porgo»). «Trebbiato» significa che i chicchi di grano, e nella poesia dunque il seme maschile, sono usciti dopo la bat-titura dagli involucri o dalle glume che li contengono. Gli ermetici versi finali: «Dalla fangaia affiora / roseo anellide / ermafrodito» (vv. 10–12) inducono a pensare a un limo fertile, come quello del Nilo, e alla terra dei campi impastata dall’acqua. La lettura esoterica ricondu-ce al verso con cui il personaggio Guido Guinizzelli spiega di appar-tenere alla schiera dei lussuriosi etero– e non già omosessuali: «Nostro peccato fu ermafrodito» (Purg, XXVI, v. 82). Dante echeggia la favo-la ovidiana di Ermafrodito, il quale si congiunse alla naiade Salmace in modo da formare con lei un solo corpo che aveva gli attributi dei due sessi; Quasimodo restituisce invece alla parola ermafrodito il sen-so oggi più consueto: portatore delle ghiandole preposte alla riprodu-
CAPITOLO II – Il giovane Quasimodo, la Bibbia, il Purgatorio 329
zione sia maschili che femminili, depurandolo degli echi grecizzanti (perfezione del genere umano degli ermafroditi e loro superiorità sugli altri) e platonici insiti nella favola ovidiana.
L’anellide, il verme, come abitante della terra materiale, al pari del-le radici degli alberi, che si inoltrano e diramano nella terra cercando l’acqua, è da sempre carissimo al poeta, in esso si concentra il ritmo della vita e della morte31. Nondimeno qui esso suscita l’idea di una sorta di embrione indistinto, del quale è impossibile discernere il ses-so: l’appartenenza delle parole «trebbiato», «seme», «fangaia», al-l’ambito semantico della terra fertile e dell’agricoltura che produce frutti e raccolti rendono certi del fatto che la fangaia è un grembo ma-terno in cui si è annidata e si sviluppa e si muove una cellula feconda-ta. Si tratta nuovamente del desiderio di un figlio: probabilmente la donna con cui il poeta immagina di concepirlo è la medesima di A me discesa per nuova innocenza, di Mobile d’astri e di quiete, di Fatta buio ed altezza, di L’acqua infradicia ghiri e di Verde deriva.
6. Il ritrovamento della “dolcezza” Si consideri di nuovo, brevemente, Verde deriva32. Nella prima
strofa il poeta prega l’amata di tacere, perché in luogo di pronunziare o ascoltare parole, e sia pure parole d’amore, egli nell’ora presente si sente chiamato alla ricerca delle parole poetiche, come nei più creativi tra i momenti in cui, mediante l’intenso colloquio interiore con Purg,
31 «Fitta di bianche e di nere radici / di lievito odora e lombrichi, / tagliata dall’acque la
terra. // Dolore di cose che ignoro / mi nasce: non basta una morte / se ecco più volte mi pesa / con l’erba, sul cuore, una zolla» (Dolore di cose che ignoro, AT, p. 21, testo integrale).
32 «Sera: luce addolorata, / pigre campane affondano. / Non dirmi parole: in me tace / a-more di suoni, e l’ora è mia / come nel tempo dei colloqui / con l’aria e con le selve. // Sopori scendevano dai cieli / dentro acque lunari / case dormivano sonno di montagne, / o angeli fermava la neve sugli ontani, / e stelle ai vetri / velati come carte d’aquiloni. // Verde deriva d’isole, approdi di velieri, la ciurma che seguiva mari e nuvole / in cantilena di remi e di cor-dami / mi lasciava la preda: / nuda e bianca, che a toccarla / si udivano in segreto / le voci dei fiumi e delle rocce. // Poi le terre posavano / su fondali d’acquario, / e ansia di noia e vita d’altri moti / cadeva in assorti firmamenti. // Averti è sgomento / che sazia d’ogni pianto, / dolcezza che l’isole richiami» (i corsivi sono miei; contrassegnano, oltre che le parole–chiave, i giochi allitterativi in –v– mediante i quali Quasimodo si ricollega al momento in cui Dante, nella selva edenica, sta per ritrovare Beatrice).
PARTE TERZA – L’Apocalisse, l’amore, la natura
330
ha potuto raggiungere effetti pregevoli e inconsueti. La donna cui il poeta si rivolge non è la medesima donna di cui il poeta si è stancato in Dormono selve. Questa donna appartiene al tempo della “dolcezza perduta”; la donna–tu di Verde deriva è invece colei che procura la “dolcezza ritrovata”, colei grazie alla quale svanisce il senso di pesan-te e gretta aridità della vita successiva alla giovinezza. Il “tu”, la don-na del presente, è una nuova compagna, insieme alla quale, nell’ultima strofa del testo, la nuova vita si realizza con pienezza di felicità: una felicità («dolcezza») che per lunghi anni il poeta aveva creduto di ave-re perso irrimediabilmente. Nella strofa mediana della poesia, la terza, sembra di avvertire echi provenienti dai romanzi di pirateria di Emilio Salgari e reminiscenze riconducibili ad altra origine, probabilmente “esoterica”.
Che Quasimodo fosse un estimatore dei romanzi di Emilio Salgari; che egli fosse molto attratto dalla straordinaria capacità salgariana di immaginare il «meraviglioso»; che questa egli ammirasse non da ul-timo proprio perché Salgari il quale poco aveva visto perfino del «Mare Nostrum» era stato capace di figurarsi e di raffigurare libe-ramente terre e continenti esotici, oceani lontani, uomini e popoli in-consueti per la cultura europea soprattutto mediterranea: tutto questo si evince limpidamente (e analogicamente) da un breve e commosso “pezzo” giornalistico a firma di Quasimodo, intitolato All’ombra di Salgàri, pubblicato sul settimanale «Tempo» il 13 gennaio 1965, e volto a rievocare la parabola esistenziale e creativa dello sfortunato scrittore di romanzi d’avventure per ragazzi33. Ancorché il poeta non colleghi espressamente la narrativa salgariana alla propria produzione in versi, lettori e critici sono tratti per suo indiretto suggerimento a ri-
33 Scriveva tra l’altro Quasimodo: «Ai giorni di Salgàri, ottanta anni fa, non era difficile
“evadere” dalla prigione del presente. […] Velieri, onde come colline, fughe di belve nella giungla. […] I viaggi lungo il Mediterraneo, non oltre le rive del Mare Nostrum, le prime for-tune editoriali, il matrimonio e i figli. Poi, con la fama, i primi passi a rovescio della felicità. […] Gli editori fanno di Salgari uno schiavo». Infine, «un karakiri italiano». La prima citazio-ne si legge alle pp. 158–159 (il corsivo è mio) e la seconda a p. 159 dell’articolo di Quasimo-do citato nel testo quale è riprodotto da G. FINZI in Appendice al suo intervento L’«indizio creativo» nella critica di Quasimodo, in Aa.Vv., Salvatore Quasimodo. La poesia nel mito e oltre, cit., pp. 133–154. La detta Appendice (pp. 155–170) raccoglie alcune tra le note e gli ar-ticoli pubblicati da Quasimodo nelle rubriche da lui tenute su «Le Ore» e sul «Tempo» e an-che un paio di inediti.
CAPITOLO II – Il giovane Quasimodo, la Bibbia, il Purgatorio 331
condurre il termine «velieri» appunto ai romanzi di Salgari. Mediante la parola «ciurma», alla reminiscenza salgariana si congiunge sponta-neamente, e ancora una volta analogicamente, il ricordo dei romanzi esotici di Joseph Conrad, nella narrativa del quale il mare sempre ri-torna come componente essenziale, simbolo di libertà e di universali-tà34. Dunque i velieri, la ciurma, la pirateria (sottintesa dalle ovvie connotazioni di «ciurma» e di «preda») rinvierebbero forse non tanto al Mediterraneo e alle scorrerie dei corsari saraceni sulle coste dei ter-ritori cristiani né, reciprocamente, alle scorrerie dei cristiani sulle sponde africane, sibbene, piuttosto, agli oceani dopo la scoperta delle Americhe; oceani infestati da pirati a caccia dei tesori contenuti sui galeoni spagnoli e da navi negriere che andavano a procurare, seque-strandoli dalle coste del Centro e del Sud dell’Africa nera, gli schiavi per gli Europei insediatisi nel nuovo continente.
Si avverte però nella strofa in questione anche un senso ulteriore, esoterico, e a parere di che scrive assai più importante rispetto a quello finora reperito. Nell’Apocalisse (18, vv. 9–19) la caduta e l’incendio della idolatra Babilonia–Roma (prostituta–bestia), sede della lussuria e del lusso smodati, è accompagnata dal triplice lamento dei re della ter-ra, dei mercanti e dei naviganti («nautae»). Tutti i comandanti di navi e l’intera ciurma, i naviganti e tutti coloro che commerciando per mare si erano arricchiti grazie alla città infernale, si tengono lontani da Ba-bilonia in fiamme35. Molto importante anche Ezechiele, 26–28, ove la città di Tiro, la quale ha abbandonato l’alleata Gerusalemme, è para-
34 Scrive Quasimodo in un pezzo giornalistico dal titolo Conrad e la giovinezza: «La voce di Joseph Conrad non dimentica mai le leggi della tradizione autentica del prosatore: mistero, realismo, erotismo [probabile refuso per esotismo, N.d.A.] storico, costume, fatti». E ancora: «Ecco un interlocutore che insegna una verità curativa, medicinale, calmante […] domatore degli istinti di quella ciurma, a volte enfatica e violenta con i suoi desideri di rivolta contro le bufere, il capitano e la vita»: le due citazioni sono riportate in fondo allo studio di G. FINZI, L’«indizio creativo» nella critica di Quasimodo, cit., rispettivamente a p. 153 la prima e 153–154 la seconda; il corsivo è mio (entrambe le citazioni si possono leggere nel secondo dei due volumi in cui sono parzialmente pubblicate le prose d’occasione di S. QUASIMODO, «A colpo omicida» e altri scritti, a cura di G. Finzi, Milano, Mondadori 1979).
35 «quoniam una hora destitutæ sunt tantæ divitiæ[,] et omnis gubernator, et omnis qui in locum navigat, et nautae[,] et qui maria operantur[,] longe steterunt […] […] et clamaverunt flentes et lugentes […]» (Apocalisse, 18, vv. 17 e 19; i segni d’interpunzione tra parentesi quadre sono miei). I Biblia sacra vulgatae editionis, Sixti V Pontificis Maximi iussu recogni-ta… seguono i testimoni che leggono «et omnis qui in lacum navigat» («e tutti coloro che na-vigano sul mare») in luogo di «et omnis qui in locum navigat».
PARTE TERZA – L’Apocalisse, l’amore, la natura
332
gonata a un formidabile e magnifico veliero; esso domina i mari ed è re dei commerci ma verrà travolto dal mare e precipitato negli abissi per volere di Dio: davanti a questo evento tutti i naviganti («nautæ»), i piloti e i marinai delle altre terre piangeranno con amaro cordoglio e tutti gli abitanti delle isole (cioè delle rive lontane, nel linguaggio bi-blico) proveranno uno sconvolgente terrore36.
Probabilmente la «preda: nuda e bianca» della terza strofa di Verde deriva, insomma la donna consegnata al poeta in un “sogno” apparte-nente al tempo, non vicino al presente, dei colloqui con l’aria e con le selve, è la medesima che aveva suscitato i sentimenti di infelicità sil-labati in Dormono selve. È la donna che provocò nel poeta la stan-chezza e la noia, oltre che il desiderio di una vita diversa, da lui e-spressi molto ermeticamente nella penultima strofa del testo succitato. A consegnare la donna–preda sono i naviganti impuri che si sono ar-ricchiti mediante i commerci con la città per antonomasia lussuriosa, ricca e cupida di lusso. La donna–preda è vittima dei disvalori incar-nati da Babilonia, in un certo senso ne è schiava, ma ne è anche parte-cipe. Il suo corpo è attraente e pare innocente nella sua bianca nudità; tuttavia ella è lontana dalla fede: forse o probabilmente ella non è stata immune da pratiche lussuriose fini a se stesse e anche da forme di pro-stituzione37. L’interpretazione or ora proposta privilegia l’efficacia e-
36 «et factum est verbum Domini ad me dicens[:] Tu ergo fili hominis adsume super Tyrum lamentum[;] et dices Tyro quæ habitat in introitu maris negotiationi populorum ad insulas mul-tas[:] haec dicit Dominus Deus[:] o Tyre[,] tu dixisti[:] perfecti decoris ego sum et in corde maris sita[.] finitimi tui[,] qui te aedificaverunt[,] impleverunt decorem tuum[;] abietibus de Sanir ex-truxerunt te cum omnis tabulates maris[;] cedrum de Libano tulerunt ut facerent tibi malum[.] quercus de Basan dolaverunt in remos tuos[;] transtra tua fecerunt tibi ex ebore indico[,] et præ-toriola de insulis Italiæ[.] byssus varia de Aegypto texta est tibi in velum ut poneretur in malo[;] hyacinthus et purpura de insulis Elisa facta sunt operimentum tuum[.] habitatores Sidonis et A-radii fuerunt remiges tui[;] sapientes tui, Tyre, facti sunt gubernatores tui.» (Ezechiele 27, vv. 1–8; il corsivo e i segni d’interpunzione tra parentesi quadre sono miei).
37 Questa interpretazione è corroborata dal rapporto tra Dormono selve e il dannunziano TrM. Ippolita, secondo Giorgio, era stata «preda inerte» del marito, il quale si era impadronito di lei e le aveva trasmesso la pericolosa malattia venerea che aveva reso sterile la giovane (ivi, p. 174; sono adoperate poi spesso le parole «ciurma», «ciurmatori», e altre riconducibili all’alveo semantico della pirateria: cfr., p. e., p. 238 e p. 342). La «preda: nuda e bianca», essa pure inerte, proviene da non dissimile esperienza. Di lei si erano impadronite forze potenti e lussuriose come si è ipotizzato nel testo dello studio illustrando il legame tra i versi di Quasimodo e l’Apocalisse ed Ezechiele ; se la «preda: nuda e bianca» coincide, come tutto lascia credere, con la donna di Dormono selve, forse la donna è diventata sterile a causa della consuetudine con queste forze predaci e corrotte.
CAPITOLO II – Il giovane Quasimodo, la Bibbia, il Purgatorio 333
segetica dell’Apocalisse, con riguardo ai naviganti (comandanti delle navi e ciurma), che hanno tratto profitto materiale dal commercio con Babilonia. Nell’Apocalisse le navi sono tante e anche Quasimodo scri-ve “velieri”. L’efficacia dell’Apocalisse, però, è indisgiungibile da E-zechiele, in cui vi è un solo veliero, allegoria della corrotta città di Ti-ro. Uno solo è anche il veliero la cui ciurma consegna la preda all’io lirico in Verde deriva. Nell’un caso (Apocalisse) e nell’altro (Ezechie-le), lo si ribadisca, la donna ridotta forse in schiavitù e poi affidata al poeta proviene da una nave in cui si annidano lussuria, corruzione, cupidigia, vuoi perché la nave tenesse commercio con Babilonia, vuoi perché la nave sia diretta allegoria di una città corrotta.
Se le cose stanno così, allora anche Purg è implicato, forse indiret-tamente: «Veggio il novo Pilato sì crudele, / che ciò nol sazia, ma sen-za decreto / portar nel Tempio le cupide vele.» (ivi, XX, vv. 91–93). «Il novo Pilato» è Filippo il Bello, il quale «abbandonò il papa in ma-no ai suoi nemici mortali, i Colonna, come Pilato consegnò Cristo ai Giudei, e lo mandò così a morte senza sporcarsi le mani». Ai vv. 92 e 93 «è il secondo delitto di cui Dante accusa il re di Francia: la sop-pressione, fatta con la forza e l’arbitrio, dell’ordine dei cavalieri del Tempio, fondato dopo la prima crociata per la difesa del regno di Ge-rusalemme»38. I commentatori otto–novecenteschi di Dante, e tra essi Torraca, scorgono nelle «cupide vele» una immagine piratesca nuova e ardita, come di nave corsara che dia l’assalto per predare39. In so-
38 Le due ultime citazioni sono tolte dalle note 91 e 93 (al canto XX del Purgatorio), re-
datte da A. Chiavacci Leonardi, nella già citata edizione con commento a sua cura della se-conda cantica dantesca (cfr., nel presente capitolo, la nota 12). È appena da ricordare che Fi-lippo il Bello è uno dei personaggi più negativi e più vicini al demonio di Purg. Nell’ultimo canto di Purg, come ognun sa, egli è raffigurato con movenze apocalittiche d’invenzione dan-tesca in guisa di gigante lussurioso e moralmente lurido che si allontana con la prostituta.
39 Cfr. p. e. D. ALIGHIERI, La Divina Commedia, nuovamente commentata da F. Torraca, ot-tava ediz. riv. e corr., Milano, Albrighi, Segati & C. [1933]. Si tenga presente che dalla ricerca condotta sulla LIZ 4 limitatamente al periodo che va dalle Origini a Dante risulta che la sola oc-correnza della parola “navi*ant*” (navigant– o navicant–) è quella di Purg, VIII, v. 2: «Era già l’ora che volge il disio / ai navicanti e ’ntenerisce ’l core». È esatta l’idea abbastanza concorde-mente sostenuta dai commentatori novecenteschi di Dante, i quali scorgono nelle «cupide vele» una immagine piratesca nuova e ardita, come di nave corsara che dia l’assalto per predare. Nessu-no si è avveduto però della contaminazione operata da Dante di Ezechiele con l’Apocalisse. Si ri-legga la porzione del secondo lamento di Ezechiele (27, vv. 3–7) sulla città di Tiro, paragonata a una nave di perfetta bellezza, a un veliero possente (cfr. nota 36). Quanto all’Apocalisse, nella cit-tà santa, la Gerusalemme messianica che non è ancora ed è già la Gerusalemme celeste risplen-
PARTE TERZA – L’Apocalisse, l’amore, la natura 334
stanza Quasimodo si è lasciato volentieri influenzare dai commentato-
dente della gloria di Dio, non v’è più alcun tempio, perché suo tempio sono il Signore Dio onni-potente e l’Agnello (ivi, 21, vv. 10 e 22). Sulla distruzione della città infernale, Babilonia–Roma, gridano, piangono e gemono, come già si è scritto, oltre ai re della terra e ai mercanti della terra, tutti i comandanti di navi e l’intera ciurma, i naviganti e quanti commerciano per mare (ivi, 18, vv. 17–18). Dante accusa cioè Filippo il Bello di aver dato l’assalto, mediante l’inaudita e rapace vio-lenza usata contro i cavalieri del Tempio, alla stessa città santa di Gerusalemme (la Gerusalemme messianica, che non è ancora ma è già la Gerusalemme celeste), che per allegoria è pure la chiesa di Cristo. Che Dante tenesse presente le maledizioni dei profeti e l’Apocalisse è provato in modo, se così piace, indiretto, dal tono tra profetico e apocalittico della invettiva subito scagliata da Ugo Capeto contro la propria stirpe: «O Segnor mio, quando sarò io lieto / a veder la vendetta che, na-scosa, fa dolce l’ira tua nel tuo secreto?» (Purg, XX, vv. 94–96); ed è provato in modo invece di-retto dalle parole che Ugo pronunzia immediatamente dopo: «Ciò ch’io dicea di quell’unica sposa / de lo Spirito Santo e che ti fece / verso me volger per alcuna chiosa» (ivi, vv. 97–99). Si crede spesso che la notissima tradizione secondo cui la sposa dello Spirito Santo è Maria, madre del Cristo, sia da ricondurre direttamente ai Vangeli di Matteo e di Luca, ma i due Vangeli, in verità, si guardano dal rappresentare nozze mistiche: in Matteo, 1, vv. 18–23, un angelo compare in so-gno a Giuseppe e gli rivela che quel che è generato in Maria sua sposa viene dallo Spirito Santo; in Luca, 1, vv. 26–38, l’arcangelo Gabriele annunzia a Maria medesima che lo Spirito Santo scenderà su di lei, talché ella concepirà e darà alla luce un figlio il quale sarà chiamato figlio di Dio. In Purg, XX, vv. 19–24, Ugo medesimo rinvia al lamento in cui egli e le anime sue consorti invocavano gemendo la «Dolce Maria» (v. 19), come le donne fanno sulla terra mentre sono tor-mentate dai dolori del parto. In Apocalisse, 12, si racconta che una donna incinta, la quale grida per le doglie e il travaglio del parto (coerentemente con Genesi, 3, vv. 15–16), viene perseguitata accanitamente da Satana (il drago), che cerca di uccidere il figlio maschio ch’ella partorisce. Le schiere di angeli guidate da Michele hanno la meglio sul drago e Dio mette in salvo il bambino e la donna. Non vi è dubbio sul fatto che il bambino sia il Messia. Oggi sono varie le spiegazioni al-legoriche della donna; inevitabile però è sempre stato il riferimento a Maria, ovvio nell’età di Dante. Nell’Epilogo del gran libro è poi scritto che lo Spirito e la sposa dicono: «Vieni!». Essi si rivolgono probabilmente alle genti che operano secondo virtù, affinché vengano ad attingere gra-tuitamente, come il Cristo vuole, l’acqua della vita. Ciò si desume dal fatto che Gesù, subito dopo quel richiamo a venire, invita tutti coloro che ascoltano a ripetere «Vieni!» e a venire a dissetarsi. Tuttavia il destinatario o i destinatari del richiamo a venire, pronunziato dalla sposa dell’Agnello e a lei (alla Chiesa) ispirato dallo Spirito Santo, non sono apertamente nominati. Da ultimo Gesù di-chiara che egli verrà presto e subito si leva, “anonima”, una nuova ultima supplica (probabilmente da parte dalle comunità cristiane) molto simile a quella della sposa: «Vieni, Signore Gesù». Il pas-so obiettivamente è tra i meno chiari del gran libro tanto visionario e oscuro. I contenuti dell’Epilogo si prestano in modo particolare, anche alla mente di un lettore molto esperto della Bibbia e nutrito dell’insegnamento dei Padri quale era Dante; si prestano all’accavallamento delle idee: dunque alla identificazione tra la donna che partorisce del cap. 12 e la sposa, intesa quest’ultima come sposa dello Spirito Santo. A causa della estrema difficoltà di comprensione, mascherata da un’apparente semplicità, dell’Epilogo dell’Apocalisse, è facile che in esso si scorga una mistica relazione coniugale per cui i due, lo Spirito e la sposa, chiamano il Cristo del quale sono genitori (così, sulla scorta dell’Apocalisse, si può estendere a Maria che concepisce o che sta per concepire nei due passi succitati di Matteo e di Luca, il ruolo di sposa dello Spirito): questa appunto è la situazione rappresentata da Dante in Purg, XX, vv. 19–24 e 97–99. Su tutto ciò sto preparando una nota d’indole precipuamente dantesca.
CAPITOLO II – Il giovane Quasimodo, la Bibbia, il Purgatorio 335
ri di Dante, oltre che dalla potente immagine dantesca nella quale vengono contaminati due Vangeli, Ezechiele e l’Apocalisse: egli ha forgiato l’immagine dei «velieri» e del «veliero» contaminando testi sacri, testi d’autore e commenti, mentre Salgari ha in definitiva un ruolo secondario in questa vicenda, un ruolo forse creato, o almeno suggerito in maniera garbatamente insinuante, ad arte e a posteriori, dallo stesso Quasimodo.
Nell’ultima strofa di Verde deriva la relazione affettuosa con la nuova compagna, il calore che il poeta trova in questo affetto, la sicu-rezza di possedere il cuore dell’amata e forse anche l’appagamento stupito al termine del rito amoroso sono parificati alla duplice dolcez-za dell’isola natale e del purgatorio («dolcezza che l’isole richiami»).
7. Gli amori, il parto, la nascita, le doglie della natura Alcuni testi, collocati in posizione intermedia tra Alla notte e Verde
deriva, cantano delicatamente la nuova infatuazione, sentita come na-scita o rinascita, come amore: perciò stesso la donna è un angelo (ma anche la compagna precedente lo era, nel tempo dell’affetto corrispo-sto) ed è innocente. Su ciò cfr. anche p. e. L’angelo, ÒS, p. 64: ivi l’angelo, la seconda donna, è «gelido» perché è divenuto una incorrut-tibile forma poetica; il poeta prova un leggero sentimento di afflizio-ne, ma afferma di avere dimenticato la prima compagna e, insieme a lei, la tristezza. Si avverte nondimeno il senso di colpa di lui per il fat-to ch’egli si è unito a una nuova amante–amata, senza che dell’altra sia dato supporre la morte: l’altra dunque è viva e probabilmente sof-fre (A me discesa per nuova innocenza, ÒS, p. 59). L’«albero malna-to» di cui all’ultimo verso di A me discesa per nuova innocenza è da riallacciare all’albero di Adamo e simboleggia anzitutto la umana fra-gilità e peccaminosità del poeta. Non solo a un senso di infermità fisi-ca ma soprattutto a una certa infermità morale sono da ricondurre an-che precedenti e successive espressioni fitomorfiche40.
40 «In alto c’è un pino distorto; / […] / col fusto piegato a balestra» (Rifugio d’uccelli not-turni, AT, p. 33, vv. 1 e 3); quasi superfluo ricordare D’alberi sofferte forme; cfr. anche «Gra-to respiro una radice / esprime d’albero corrotto:» (Io mi cresco un male, ÒS, p. 75, vv. 1–2). Che in queste espressioni si avverta l’influenza di D’Annunzio è innegabile.
PARTE TERZA – L’Apocalisse, l’amore, la natura 336
La più densa d’amore, tra queste poesie dedicate all’incanto che si sprigiona dalla nuova relazione sentimentale, è forse Fatta buio ed al-tezza (ÒS, p. 67): «Tu vieni nella mia voce: / e vedo il lume quieto / scendere in ombra a raggi / e farti nuvola d’astri intorno al capo. / E me sospeso a stupirmi degli angeli, / dei morti, dell’aria accesa in ar-co; // Non mia, ma entro lo spazio / riemersa, in me tremi / fatta buio ed altezza». La poesia echeggia in maniera riconoscibile movenze proprie dell’incontro tra Dante e Beatrice nel paradiso terrestre, seb-bene non sia casta neppur essa, come chiaramente dice l’emistichio «in me tremi».
A un «tu» che è la nuova amante–amata il poeta si rivolge in Mobi-le d’astri e di quiete, immaginando che la compagna addormentata sogni dei bambini; egli rivive allora le urla e la concitazione di un par-to, avvenuto in una casa del tempo dell’infanzia, e la gioia che accom-pagnò l’esito felice di esso (gioia della levatrice e dei parenti stretti della puerpera, probabilmente): egli pure apprese allora quale gioia («dolcezze») sia la nascita di un figlio e quale sollievo costituisca per i famigliari la sopravvivenza della puerpera: «Bambini dormono ancora nel tuo sonno; / io pure udivo un urlo talvolta / rompere e farsi carne; / e battere di mani ed una voce / dolcezze spalancarmi ignote» (ÒS, p. 66, vv. 11–15: è la terza e ultima strofa). In tutte le poesie dedicate all’erompere della vita (soprattutto ma non soltanto all’erompere della vita umana) si avverte una lontana risonanza di Genesi, 3, v. 16, ove Dio dice alla donna che Egli moltiplicherà le gravidanze di lei e i do-lori del parto, talché ella partorirà i propri figli tra terribili sofferenze fisiche.
In una poesia di poco successiva sembra che le movenze usate per rappresentare e “rinnovare”, in Mobile d’astri e di quiete, la balenante immagine di un parto, vengano riutilizzate per adombrare un aborto, e il dolore del poeta e della compagna: «Il mare empie la notte, / e l’urlo preme maligno / in poca carne affondato. // Un’eco ci consoli della terra / al tardo strazio, amata;» (Sul colle delle «Terre bianche», EA, p. 84, vv. 7–11). In un testo non di molto posteriore e appartenente alla medesima collezione, il poeta dichiara di non essere più giovane; ora nondimeno, come il D’Annunzio delle Laudi, può «amare tutto della terra», e specialmente la donna che da non molto gli è compagna («e, su ogni parvenza, la donna che mi venne non è gran tempo»: In luce di
CAPITOLO II – Il giovane Quasimodo, la Bibbia, il Purgatorio 337
cieli, EA, p. 91, vv. 5 e 7–8). È definitivamente giunto, insomma, il tempo della “dolcezza ritrovata”. La donna non solo non è quella di Dormono selve, ma neppure è la successiva compagna di Verde deri-va. L’entusiasmo del poeta–amante dice che si tratta di un’altra donna, cui lo stringe la passione erotica più intensa da lui provata fino a quel momento. L’immagine del veliero, poi, torna in L’alto veliero (NP, p. 110, vv. 11–12) in cui l’amata «in sé agitava un mio figlio, / e aveva per esso continuo il mare nell’anima:»41.
Il contatto essenziale con Purg propizia dunque la duratura esal-tazione, nella prima età, oltre che del desiderio privato di un figlio, del rinnovarsi della vita tutta: esaltazione che certo passa in secon-do piano nei testi della seconda età, ma che neppure da essi scom-pare. Il tema della nascita, che suscita le urla di dolore della parto-riente e rompe il corpo della donna, viene da lontano, è stato va-gheggiato primamente nel travaglio della natura (soprattutto degli alberi) che geme essa pure per le doglie del parto: basti ripensare a Specchio. Anche il verbo «rompere» e l’insieme delle parole (nomi o verbi) legate o etimologicamente o semanticamente all’“urlare” sono dunque parole–chiave. Si considerino le prime due strofe di Alla mia terra (ÒS, p. 41) collocata tra l’Eucalyptus e Nascita del canto:
Un sole rompe gonfio nel sonno / e urlano alberi; / avventurosa aurora / in cui disancorata navighi, / e le stagioni marine / dolci fermentano rive nasci-ture. // Io qui infermo mi desto, / d’altra terra amaro / e della pietà mutevo-le del canto / che amore mi germina / d’uomini e di morte. Nella prima strofa di Alla mia terra un elemento maschile («sole»)
«irrompe» turgido («gonfio») nel “sogno” del poeta; l’urlo degli alberi è l’urlo della vita: letteralmente è emesso dagli alberi, ma ricorda quello della partoriente in travaglio e quello della creatura che nasce42.
41 Ancorché le espressioni usate per sillabare quest’isola non corrispondano punto a quelle consuete in Quasimodo a proposito della “sua” isola, l’ambiente isolano dell’Alto veliero è dai più ricondotto alla Sicilia. La tesi si fonda solo sull’appiglio, fragile, che L’alto veliero è il primo di tre testi contigui in cui ricorre l’immagine di questa nave. Si metterà meglio a fuoco il problema nell’ultimo paragrafo.
42 Analogamente leggiamo in altri testi: «M’abbandono, m’abbandono; / ululo di primave-ra, / è una foresta / nata nei miei occhi di terra» (La mia giornata paziente, ÒS, p. 57, seconda e ultima strofa). «Nei moti delle solitudini stellate, al rompere dei grani, alla volontà delle fo-
PARTE TERZA – L’Apocalisse, l’amore, la natura
338
Qui l’incontro del sole con la stagione marina sta per portare alla luce le sponde dell’isola («nasciture»). Nella seconda strofa il poeta si de-sta, carico della propria caducità (non senza allusione alla condizione di peccatore) nel duplice mondo infinito: le due isole. Egli reca seco il senso della durezza del vivere fuori dalle isole e della fatica d’amore capace di dare il frutto pietoso e gentile cioè l’espressione poetica. L’amplesso amoroso, la fertilità, la gravidanza, il nascere o il portare alla vita, l’allevare, oppure la vita assoluta, immune dal tempo, sono spesso accostati o mescolati al travaglio e alla creazione poetica, che reca frutto essa pure, e reca vita, anche quando canti la morte, sola certezza propria di tutti i mortali. Non importa se talora l’azione viene negata o se ai nomi della vita e della generazione vengono accostati con fortissime antitesi i loro opposti: «Io qui infermo mi desto, / d’altra terra amaro / e della pietà mutevole del canto / che amore mi germina / d’uomini e di morte.» (Alla mia terra, ÒS, p. 41, vv. 7–11, seconda strofa); «Non so che luce mi dèsti: / nuziale ellisse di bianco e di celeste / precipita e in me frana. Tu sei, / beata nascita, a toccarmi / e nei silenzi aduni figure dell’infanzia:» (Compagno, ivi, p. 49, vv. 1–5 della prima strofa); «Senza memoria di morte, / nella carne congiun-ti, il rombo d’ultimo giorno / ci desta adolescenti. // Nessuno ci ascol-ta; / Fatta ramo / fiorisce sul tuo fianco / la mia mano. // Da piante pie-tre acque / nascono gli animali / al soffio dell’aria.» (Senza memoria di morte, ivi, p. 51, vv. 4–12).
Il travaglio della natura, e la nascita delle creature non umane si prolungheranno oltre ÒS, accompagnando in modo vistoso in EA l’adombrato (solo liricamente! non certo come trascrizione immediata di fatti biografici) dolore dell’aborto e la successiva gioia del nuovo concepimento e della gravidanza: «nell’ora mattutina a luna accesa, / appena affiori, geme / l’acqua celeste. // Ad altra foce / più dolente so-stanza / soffiò di vita l’urlo dei gabbiani». (Sardegna, ivi, p. 90, vv. 1–6, si tratta delle prime due strofe; corsivi miei).
glie, sarai urlo della mia sostanza» (Delfica, NP, p. 117, vv. 22–25; è la seconda metà della quinta e ultima strofa).
CAPITOLO II – Il giovane Quasimodo, la Bibbia, il Purgatorio 339
8. Il Purgatorio, la Genesi, l’Apocalisse e la poesia matura di Qua-simodo Anche nella raccolta EA gli aspetti levantini, arabi, meridionali e
provinciali della Sicilia sono velati e offuscati, mentre quelli “greci” si fondono in modo trasognato e misterioso con le forme; con i colori; con i suoni e rumori; con i silenzi; con i morti; con gli angeli; con il giardino che è anche foresta; con il cielo che sovrasta; con gli oceani al di sopra dei quali si staglia l’isola sulla cui vetta ebbero dimora i primi uomini, e nella quale ora abitano i morti che sono al contempo all’interno e già al di là del tempo, ma non ancora, propriamente, nell’eterno. Le reminiscenze riconducibili a Purg presenti in EA non sono più, però, nitide come lo erano in ÒS, non sono equiparabili alle cosiddette “riprese” e neppure sono riconducibili a sensualità edenica, naturale e innocente. Sono invece embrioni nuovi, sorti da un relati-vamente inedito e forse più complesso connubio tra vagheggiamento della grecità e vagheggiamento o timore dell’isola dei morti, tra apol-lineità mediterranea e sentimento cristiano della caducità e fugacità di ogni cosa, tra amore pagano della vita e sensibile coscienza cristiana del dolore, della morte, della rinascita (dall’io lirico intesa prevalen-temente come ritorno al giardino di Eden). Dalla fusione dei due ordi-ni tematico–esistenziali promana e si diffonde un sentimento cosmico prima inesistente perché soffocato o impedito dal tema ricorrente, quasi ossessivo e, malgrado ogni sforzo di purificazione, anche al-quanto intimistico, dell’ «infanzia imposseduta»: tema che il poeta non riesce a investire di energia creatrice, di esso superarando e “tra-svalorarando” la banalità. Non sempre la “sprovincializzazione” di quel nucleo, il suo depuramento dalla nativa tendenza all’auto-biografismo immediato, raggiungono in ÒS, come si è constatato, esiti poeticamente felici. Ciò accade malgrado il poeta sempre persegua la trasfigurazione dell’isola natale e la ideale fusione di essa con quella dantesca che giganteggia solitaria sull’emisfero delle acque oceaniche. In EA l’ordine cristiano prevale, ma costituisce anche il limite, il quale in certo modo soffoca o pone dolorose barriere al desiderio di libertà vitale, di abbandono all’edonismo pseudo–grecizzante. Della nativa tendenza alla sensualità, all’atto fecondatore, alla nascita, presente in ÒS, ove è potentemente sentita come edenica, qualcosa emerge ancora
PARTE TERZA – L’Apocalisse, l’amore, la natura
340
in EA (cfr. p. e. Nel giusto tempo umano, p. 94); qui prevale, però, il tema del nascere, depurato da note non caste e congiunto piuttosto al tema della sofferenza, al trauma del venire al mondo. Anche il timore della morte è intriso di cristiana consapevolezza che innocenza e pec-caminosità si sostanziano entrambe, e quasi si fronteggiano, nel canto dell’io poetante43.
Giova analizzare per esteso nel rapporto con Purg la poesia Sul col-le delle «terre bianche» (p. 84) sesta tra quelle incluse in EA, di cui si è già fornita una chiave letterale:
Dal giorno, superstite / con gli alberi mi umilio. / Assai arida cosa; a infer-mo verde amica, / a nubi gelide / rassegnate in piogge. // Il mare empie la notte, / e l’urlo preme maligno / in poca carne affondato. // Un’eco ci con-soli della terra / al tardo strazio, amata; // o la quiete geometrica dell’Orsa. Promana da Sul colle delle «Terre bianche», un senso religioso
profondo. Il poeta si sente fratello e figlio di Adamo, egli è umilmente consapevole del fatto che l’uomo ha meritato di perdere il Paradiso terrestre e di vivere nella caducità (tra «infermo verde» e «nubi gelide / rassegnate in piogge»)44. L’amore dei sensi non consola; forte è la
43 Diversi i luoghi ove questi piccoli nuclei tematici acquistano densità di senso alla luce
del rapporto con Purg: «Di serene foglie / arde l’aria consolata. // Sradicato dai vivi, / cuore provvisorio, / sono limite vano. // Il tuo dono tremendo / di parole, Signore, / sconto assidua-mente. // Destami dai morti: / ognuno ha preso la sua terra e la sua donna». (Al tuo lume nau-frago, EA, p. 85, vv. 3–13, seconda, terza, quarta e quinta strofa); «Un soffio lieto d’alati / a verde lume discorde: / il mare nelle foglie. / Dissono. E tutto che mi nasce a gioia / dilania il tempo; un’eco appena / ne serba in voce d’alberi. / Amore di me perduto, / memoria non u-mana: / sui morti scendono stimmate celesti, / gravi stellati scendono nei fiumi:» (Insonnia. Necropoli di Pantàlica, ivi, p. 86, 1–10; si tratta delle prime due strofe e dei primi quattro ver-si della terza); «e la fraterna aura conforta amore» (ibidem, v. 26); «Così solo, numeri di per-duto bene / mi narravo, e giorni, / e, splendenti in remote aure, acque di selve ed erbe. // Nell’isola morta, lasciato da ogni cuore che udiva la mia voce, posso restare murato» (In luce di cieli, EA, p. 91, vv. 11–18; terza e quarta strofa); «Ad una fronda, docile / la luce oscilla / alle nozze con l’aria; // nel senso di morte, eccomi, spaventato d’amore.» (Nel senso di morte, ivi, p. 96, vv. 4–8, seconda e terza strofa).
44 Per la lezione di Stazio cfr. Purg, XXI, vv. 40–58 (il verso più importante ai fini dell’analisi di Sul colle delle «Terre bianche» è il 51: «nuvole spesse non paion né rade»). As-sai più importanti le parole di Matelda: «Perché ’l turbar che sotto da sé fanno / l’essalazion de l’acqua e de la terra, / che quanto posson dietro al calor vanno, / a l'uomo non facesse alcu-na guerra, / questo monte salìo verso ’l ciel tanto, / e libero n'è d’indi ove si serra.» (ivi, XXVIII, vv. 97–102); «L’acqua che vedi non surge di vena / che ristori vapor che gel converta, / come fiume ch’acquista e perde lena; / ma esce di fontana salda e certa, / che tanto dal voler di
CAPITOLO II – Il giovane Quasimodo, la Bibbia, il Purgatorio 341
coscienza del ripetersi dello strazio, dell’aridità presente di fede, spe-ranza e carità, ma vivo (e consolatore) è, nonostante tutto, l’affetto verso la terra in cui abitano i figli di Adamo. Mi pare che si avvertano nel testo diversi (ma non disparati) echi di Purg: quello, lontano, della prima lezione impartita da Stazio circa la intangibilità del monte del purgatorio propriamente detto da tutte le perturbazioni naturali terre-stri; quello, assai più vicino, delle non dissimili spiegazioni fornite poi da Matelda, circoscritte in particolare alla vetta, cioè alla foresta e al giardino edenici; quello dello strazio subito dal carro della Chiesa a opera delle tre belve (l’aquila, la volpe e il drago): in particolare, della devastazione, compiuta dall’aquila, dei «fiori» e delle «foglie nove» che formavano la rinnovata chioma dell’albero d’Adamo; quello della similitudine in cui la coda del drago è pareggiata al pungiglione della vespa, normalmente affondato in poca carne. «Nubi gelide» sono libe-ra sintesi delle parole di Matelda «che ristori vapor che gel converta». «Strazio» è il coagulo in una sola parola di una o più immagini nel te-sto dantesco mosse e complesse. Analogamente, nell’«infermo verde» sono concentrate sia le offese subite dalle foglie dell’albero di Adamo sia le erbacce che crescono sopra quella che fu «vivace terra»45. I qua-simodiani «maligno», «affondato» (per figura etimologica in rapporto intimo con «fondo», proprio come «gelide» con «gel») e «terra» sono “riprese” vere e proprie, secondo la brutta ma ormai diffusissima paro-la tecnica.
Si ripensi al testo che chiude EA, Del peccatore di miti: «Del pec-catore di miti, / ricorda l’innocenza, / o Eterno; e i rapimenti, / e le stimmate funeste. // ha il tuo segno di bene e di male, / e immagini ove si duole / la patria della terra.» (i corsivi sono miei).
«La patria della terra» coincidente con l’ultimo verso dell’ultimo testo di EA, naturalmente, è il paradiso terrestre non solo nella rappre-sentazione della Genesi ma anche e forse soprattutto in quella del Dio riprende, / quant’ella versa da due parti aperta.» (ibidem, vv. 121–126).
45 «Com’io vidi calar l’uccel di Giove / per l’alber giù, rompendo de la scorza, / non che d’i fiori e de le foglie nove;» (Purg, XXXII, vv. 112–114); «Poi parve a me che la terra s'a-prisse / tr'ambo le ruote, e vidi uscirne un drago / che per lo carro sù la coda fisse; / e come vespa che ritragge l'ago, / a sé traendo la coda maligna, / trasse del fondo, e gissen vago vago. / Quel che rimase, come da gramigna / vivace terra, da la piuma, offerta / forse con intenzion sana e benigna, / si ricoperse, e funne ricoperta / e l'una e l'altra rota e 'l temo, in tanto / che più tiene un sospir la bocca aperta.» (ibidem, vv. 130–141).
PARTE TERZA – L’Apocalisse, l’amore, la natura
342
Purgatorio di Dante. La Genesi costituì il primo gradino. Un Quasi-modo giovanissimo, inesperto, con un bagaglio di letture non ancora ampio, si rivolse primamente alla Genesi e poi all’Apocalisse traendo-ne per la sua poesia immagini o edeniche o inerenti la dimora dell’uomo dopo la morte. Scopo precipuo del poeta era per un verso di trovare immagini paniche e attinenti il mondo abitato dai primi uomini e per l’altro verso di congiungere l’inizio e la fine dei tempi; va da sé che molte parole e movenze sono tratte da libri dell’Antico Testamento diversi dalla Genesi e dall’Apocalisse. Senonché la letteratura cristia-na custodisce da sempre non una raffigurazione splendida soltanto del paradiso terrestre ma due, la seconda delle quali, quella di Dante, è as-sai più sontuosa, ricca e matura della prima. Fin da AT, sebbene preva-lente sia su questa raccolta (e soprattutto sulla prima stampa di essa) l’influenza della Genesi, Quasimodo si avvalse anche di Purg. L’influenza di Purg diventò predominante a partire da ÒS, ove ancora ricorre p.e. la parola «giardini», ma ove compare altresì per la prima volta e con insistenza, in luogo di «giardini», la parola «selva» (e l’aggettivo «silvani»). Il ricorso a Purg è di fondamentale importanza ai fini della strutturazione ermetica della poesia quasimodiana della prima epoca (anche e molto della poesia consegnata a EA), struttura-zione perseguita faticosamente ma non ancora ben conseguita nei testi di AT.
9. Echi biblici e danteschi nella collezione Nuove poesie Si è già ricordato che le espressioni usate in L’alto veliero per sil-
labare l’isola non sono adeguate alla costante, profonda nostalgia di Quasimodo per la sua “patria”; nondimeno alla Sicilia si suole con-dordemente ricondurre l’isola, sentita come ostile, da cui il poeta, nel testo in questione, vorrebbe andarsene. Esso è infatti il primo di tre testi contigui (gli altri due sono Sulle rive del Lambro, NP, pp. 111–113 e Sera nella valle del Màsino, ivi, pp. 114–115) in cui compare la «fredda immagine eterna / navigante!» del veliero o dei velieri 46.
46 L’alto veliero (testo integrale): «Quando vennero uccelli a muovere foglie / dagli alberi
amari lungo la mia casa, (erano ciechi volatili notturni / che foravano i nidi sulle scorze) io
CAPITOLO II – Il giovane Quasimodo, la Bibbia, il Purgatorio 343
In Sulle rive del Lambro e in Sera nella valle del Màsino, però, di-versamente che nell’Alto veliero, il poeta esprime chiaramente la propria intensa nostalgia nei confronti della Sicilia. Credo che l’immagine inconsueta del veliero sia anche in questo trittico una reminiscenza proveniente dall’Apocalisse e da Ezechiele, soprattutto da quest’ultimo libro profetico; tale provenienza è confermata in cer-ta misura dall’aggettivo che ha marcato sapore biblico «navigante»47. L’eternità attribuita alla negativa «fredda immagine» del «veliero» si spiega cioè sia con il fatto ch’esso, fin dal tempo di Ezechiele, sim-boleggia la volontà di potenza politico–economica cupida e malefica, sia con il fatto che parole di Ezechiele (i naviganti, «nautae», non il veliero) sono echeggiate con non dissimile intenzione nel gran libro dello pseudo–Giovanni, sia con il fatto che la potente immagine del veliero piratesco ricorre anche in Purg e Quasimodo l’ha riconosciu-ta: Dante la toglie dai succitati testi sacri, e la pone sulle labbra di Ugo Capeto a condanna di Filippo il Bello.
La città che ha tralignato e che Dio maledice, città (Tiro) concen-trata in Ezechiele nell’immagine del veliero magnifico, è in Quasimo-do probabilmente l’ordinamento politico di un intero paese. Questo paese è la patria del poeta, ma non è più sentito da lui come patria au-tentica. L’immagine dell’isola, da sempre chiamata dal poeta “sua pa-tria” è cioè utilizzata in questo testo anche e soprattutto come sined-doche, come parte del tutto che è la più grande patria, vale a dire
misi la fronte alla luna, / e vidi un alto veliero. // A ciglio dell’isola il mare era sale; / e s’era distesa la terra e antiche / conchiglie lucevano fitte ai macigni / sulla rada di nani limoni. // E dissi all’amata che in sé agitava un mio figlio, / e aveva per esso continuo il mare nell’anima: / “Io sono stanco di tutte quest’ali che battono / a tempo di remo, e delle civette che fanno il lamento dei cani / quando è vento di luna ai canneti. Io voglio partire, voglio lasciare quest’isola.” / Ed essa: “O caro, è tardi: restiamo.” // Allora mi misi a contare / i forti riflessi d’acqua marina / che l’aria mi portava sugli occhi / dal volume dell’alto veliero.». Sulle rive del Lambro: «Illeso sparì da noi quel giorno / nell’acqua coi velieri capovolti. / Ci lasciarono i pini, / parvenza di fumo sulle case, / e la marina in festa / con voce alle bandiere / di piccoli cavalli» (vv. 1–7, prima strofa), «Anche tramonta questa notte / nei pozzi dei declivi; e rulla il secchio / verso il cerchio dell’alba. / Gli alberi tornano di là dai vetri / come navi fiorite. / O cara, / come remota, / morte era da terra» (vv. 51–57, nona e ultima strofa). Sera nella valle del Màsino: «Nello spazio dei colli, / tutto inverno, il silenzio / del lume dei velieri: / fredda immagine eterna / navigante! E qui risorge. // Presto la rana cresce il verde: è foglia; e l’insetto di spine s’avventa sull’erbe dei canali» (vv. 1–8; trattasi della prima strofa e dei tre primi vv. della seconda).
47 Cfr. il commento a Verde deriva (paragrafo 6), all’Alto veliero e le note 35, 36 e 39.
PARTE TERZA – L’Apocalisse, l’amore, la natura
344
l’Italia. La Sicilia sta qui in luogo dell’Italia tralignante a causa dell’ordinamento politico che la contrassegna: il regime fascista, cupo, oppressivo e guerrafondaio. Di ciò v’è una spia appena accennata ma chiara in Sera nella valle del Màsino: «[…] Avverto / la sera alle tem-pie, / e l’allarme / è un canto di cupo dialetto» (vv. 28–30, nella sesta strofa, corsivo mio). I notturni animali alati e ciechi dell’Alto veliero, sono «volatili», non sono uccelli: sono quasi certamente cioè pipistrel-li. Essi sono simbolo del fascismo, che del color nero aveva fatto il proprio colore; sono simbolo degli aspetti più odiosi del regime, tra i quali il sentimento imperialista e bellicista che veniva infuso nei gio-vani e nei giovanissimi e che talvolta creava scissioni penose all’in-terno delle famiglie e delle varie articolazioni comunitarie («forano i nidi»); sono simbolo della incapacità del regime di vedere e prevedere (la “cecità”) l’esito per il paese disastroso che si sarebbe conseguito perseguendo l’ideale dell’imperialismo e della guerra. Ha immense ali di pipistrello Lucifero nella visione di Dante (Inf, XXXIV, vv. 49–50).
«L’insetto di spine» che «s’avventa sull’erbe dei canali» in Sera nella valle del Màsino è quasi certamente la cavalletta, da sempre flagello biblico che divora tutto ciò che sia verde e rigoglioso, e per-ciò simbolo cristiano universale della voracità e del potere invasivo e pervasivo (cfr. in particolare Esodo, 10, vv. 1–18 e Apocalisse, 9, vv. 1–11, in cui re delle cavallette è l’angelo dell’abisso, colui che in greco è detto “distruttore”: Apollyôn). Più ermetica l’immagine della rana che cresce il verde. È da ricondurre anch’essa al gran libro che chiude la Bibbia cristiana. Tre spiriti immondi, simili a rane, escono dalla bocca del drago, della bestia e del falso profeta (caricatura sata-nica della Trinità) in Apocalisse, 16, v. 13. Sono spiriti di demòni che vanno a radunare tutti i re della terra per la guerra del gran gior-no di Dio Onnipotente (ivi, v. 14). Verdi sono i cadaveri in corso di decomposizione (specie per effetto della peste). Il verde è il colore della morte, e come tale ricorre in modo accentuato nelle poesie qua-simodiane della seconda epoca. Anche questa osservazione trae ali-mento dall’Apocalisse prima che dall’osservazione diretta della real-tà48. Dunque il fascismo, potenza idolatra, prepara la guerra e la
48 Il quarto flagello inviato dall’Agnello contro gli idolatri è un cavallo verde o verdastro,
CAPITOLO II – Il giovane Quasimodo, la Bibbia, il Purgatorio 345
morte in antitesi alle leggi del vero Dio. Le «navi fiorite» in Sulle ri-ve del Lambro sono sì un’illusione ottica di cui l’io lirico è consape-vole (sa che sono gli alberi fuori dell’abitazione), ma sono soprattut-to espressione della speranza che la cupa temperie politica presente abbia fine e tornino a diffondersi un’atmosfera politica cordiale, cioè in senso lato (non tecnico) liberale, e la pace.
Il desiderio, espresso in L’alto veliero, di lasciare l’isola e di allon-tanarsi dai ciechi volatili notturni sarebbe allora formulazione dissi-mulata del desiderio di espatriare, per vivere in paesi ove non si sia spiati, sorvegliati, soggetti alla censura e perseguitati per motivi raz-ziali.
Si consideri l’ultimo verso (coincidente con il titolo) della poesia che funge da testo premiale di NP, verso celeberrimo per coloro che frequentano la poesia del Novecento: «ride la gazza, nera sugli a-ranci»49. Si considerino altresì alcuni tra i versi iniziali di Purg; dapprima quelli con cui Dante invoca l’aiuto di Calliope: «e qui Calliopè alquanto surga / seguitando il mio canto con quel suono / di cui le Piche misere sentiro / lo colpo tal, che disperar perdono» (Purg, I, vv. 9–12; corsivo mio); poi quelli, di poco successivi, in cui il sommo poeta esprime con melodiose parole stilnovistiche il suo profondo sollievo per il fatto di rivedere l’azzurro del cielo («Dolce color d’orïental zaffiro,»: ivi, v. 13; è questo il verso che Quasimodo dichiarò di avere massimamente accarezzato durante il suo noviziato di poeta), la luce di Venere («Lo bel pianeta che d’amar conforta / faceva tutto rider l’orïente,»: ivi, vv. 19–20) e quella dei quattro astri che splendono all’emisfero antartico («Go-der pareva ’l ciel di lor fiammelle:» ivi, v. 25). Le Piche, figlie di
cavalcato dalla Morte, dietro a cui veniva l’Inferno (per inghiottire le vittime), che aveva po-tere di sterminare la quarta parte della terra (Apocalisse, 6, vv. 7–8).
49 È opportuno riferire per intero il testo Ride la gazza, nera sugli aranci (NP, p. 101): «Forse è un segno vero della vita: / intorno a me fanciulli con leggeri / moti del capo danzano in un gioco / di cadenze e di voci lungo il prato / della chiesa. Pietà della sera, ombre / riacce-se sopra l’erbe così verde, / bellissime nel fuoco della luna! / Memoria vi concede breve son-no; ora, destatevi. Ecco, scroscia il pozzo / per la prima marea. Questa è l’ora: non più mia, arsi, remoti simulacri. / E tu vento del sud forte di zàgare, / spingi la luna dove nudi dormono / fanciulli, forza il puledro sui campi / umidi d’orme di cavalle, apri / il mare, alza le nuvole dagli alberi: / già l’airone s’avanza verso l’acqua / e fiuta lento il fango tra le spine, / ride la gazza, nera sugli aranci».
PARTE TERZA – L’Apocalisse, l’amore, la natura
346
Pierio re della Tessaglia, canterine esperte e dalla voce meraviglio-sa, avevano osato sfidare al canto le Muse. Vinte da Calliope, furo-no trasformate, per punizione della loro temerarietà, in gazze. Chiudendo il proemio a NP, cioè a un gruppo di poesie composte in parallelo al lavoro di traduzione dei lirici greci, con l’espressione «ride la gazza, nera sugli aranci», Quasimodo esprime in modo più che ermetico, esoterico, alcuni significati semplici: egli è un canto-re di gran lunga inferiore ai cantori supremi, quali Calliope e Dan-te. Egli sente di potersi pareggiare alle Pieridi, dunque alla gazza. Nondimeno egli è una gazza che ride: canta melodiosamente e dif-fonde con il suo canto amore e luce, come suole fare la poesia vera a parere di tanti amanti della poesia. La poesia che fa da proemio a NP è impregnata di gentilezza, è melodiosa, è venata di malinconia e di senso della morte, ma è anche un inno umile e leggiadro alla vita e alla giovinezza. Vi ricorrono varie movenze dal sapore gre-cizzante: «fanciulli con leggeri / moti del capo danzano», «nudi dormono / fanciulli» e così via. Vi campeggia abbastanza centrale e rilevato il «prato della chiesa», insomma il tempio cristiano per an-tonomasia. Come sempre o quasi sempre, alla raffigurazione del mito è congiunta o meglio accostata, senza fusione dei due elemen-ti, la raffigurazione dei simboli più intensi del cristianesimo50. Un poeta della grandezza di Dante può sperare di essere guidato e sor-retto da Calliope, fino a raggiungere esiti espressivi sovrumani. A Quasimodo si conviene invece l’assai più modesta eppura splendida voce delle Pieridi; così la gazza diffonde il suo canto limpido, non sublime eppure capace di irradiare gioia e quasi luce.
50 In AT è proposto fin dal titolo, come ognun sa, l’accostamento di un elemento pagano
(Erato, la musa della poesia lirica soprattutto amorosa) con un elemento attinto ai miti cristia-ni, questa volta visionari e stravaganti: Apòllion, l’angelo dell’abisso, lo sterminatore di cui si parla in Apocalisse, 9, v. 11, il quale è già stato ricordato nel testo di questo paragrafo. Si trat-ta di due figure relativamente poco note e poco menzionate; assumerle a guide e oggetti del proprio canto non è civetteria erudita da parte di Quasimodo; è piuttosto, ancora una volta, se-gno di modestia, di mite coscienza che il suo talento è sì autentico, ma circoscritto.
AREE SCIENTIFICO–DISCIPLINARI
Area 01 – Scienze matematiche e informatiche
Area 02 – Scienze fisiche
Area 03 – Scienze chimiche
Area 04 – Scienze della terra
Area 05 – Scienze biologiche
Area 06 – Scienze mediche
Area 07 – Scienze agrarie e veterinarie
Area 08 – Ingegneria civile e Architettura
Area 09 – Ingegneria industriale e dell’informazione
Area 10 – Scienze dell’antichità, filologico–letterarie e storico–artistiche
Area 11 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
Area 12 – Scienze giuridiche
Area 13 – Scienze economiche e statistiche
Area 14 – Scienze politiche e sociali
Le pubblicazioni di Aracne editrice sono su
www.aracneeditrice.it
Finito di stampare nel mese di settembre del 2011
dalla ERMES. Servizi Editoriali Integrati S.r.l.
00040 Ariccia (RM) – via Quarto Negroni, 15
per la Aracne editrice S.r.l. di Roma