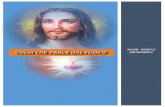E.M. Dal Pozzolo, Ipotesi per un esordio, in Giorgione. Catalogo della mostra (Castelfranco Veneto,...
Transcript of E.M. Dal Pozzolo, Ipotesi per un esordio, in Giorgione. Catalogo della mostra (Castelfranco Veneto,...
39
Se il problema del catalogo e dell’evoluzione arti-stica di Giorgione è complicato, quello relativoai suoi esordi è ancor più ostico1.
Da dove, da cosa e da quando partire, anzitutto?Da Castelfranco e dalla gioiosa et amorosa Marca, cer-cando di rintracciarne le prove d’avvio nel frammenta-rio mosaico degli affreschi sopravvissuti, magari nelBarco di Caterina Cornaro ad Altivole, prestando fedea qualche fonte tarda e di dubbia attendibilità? Oppu-re da Venezia, pescando nel mare magnum della ster-minata produzione che si registra allo scadere del Quat-trocento nelle cerchie dei Bellini, di Carpaccio, di Ba-stiani o dei tanti oscuri miniatori lì attivi di cui così po-co si sa?
E poi cercare cosa? Un paesaggio particolarmentearioso e raffinato, il volto di una Madonna più intensadi altre, un ritratto più psicologico? È forse un ago nelpagliaio; e magari il pagliaio non esiste neanche più. Ri-dolfi (1648) insistette molto sul fatto che egli all’iniziodella sua carriera veneziana si sarebbe specializzato inquel settore della decorazione mobiliare che è in massi-ma parte andata perduta a causa dell’usura quotidianae del cambiamento delle mode2. Scrigni, cassoni, fregi,lettucci, spalliere, restelli e oggetti di tal tipo dopo qual-che generazione venivano per lo più fatti a pezzi e bru-ciati come legna da ardere nei camini. Di fattura vene-ta ne restano ben pochi esemplari, che non bastano adelineare il quadro di una produzione di massa che siintuisce interessantissima, anche perché spesso con-traddistinta dall’adozione di temi classici e umanistici3.
E ancora: cercheremo un Giorgione già Giorgio-ne – magari gracile, ma dalla personalità comunque de-
cisa e riconoscibile – oppure un esordiente alla scopertadi se stesso e del mondo che lo circonda, e quindi (co-me spesso i giovani) con incertezze, obiettivi sfocati evirati, modelli da acquisire mediante imitazioni che po-trebbero essere state – e quasi certamente furono – pe-disseque e banali?
Diciamolo subito. Allo stato attuale delle cono-scenze, queste domande sono destinate a rimanere sen-za risposta; o per lo meno senza una risposta certa, ingrado di rintracciare i segni della sua vicenda persona-le lungo una linea storica ricostruibile e condivisibile.Siamo dunque condannati alle opinioni, che poggianosul labile terreno dell’intuito soggettivo e della perce-zione di un filo rosso che lega ciò che siamo convintiessere, più o meno indiscutibilmente, di Giorgione, al-l’avvio del suo oscuro percorso. Più di uno studioso haesposto le sue congetture al riguardo presentandole co-me dati assodati, ma nella penuria di notizie oggettiveche circonda l’artista non può essere così.
Fino a tempi recentissimi, l’unica fonte veramen-te attendibile in materia giorgionesca ad aver fornitoun minimo spunto sulla questione è Marcantonio Mi-chiel e si lega a un’opera dispersa, vista nel 1525 in ca-sa di Taddeo Contarini, uno dei pochi collezionisti delpittore che sappiamo essere stato anche suo commit-tente. Assieme ai Tre filosofi ora a Vienna e a un pureperduto “Inferno cum Enea et Anchise”, Michiel in-fatti presso di lui segnalò una “tela del paese cum elnascimento de Paris, cum li dui pastori ritti in piede,fu de mano de Zorzo da Castelfranco, et fu delle sueprime opere”4. Si trattava non tanto di una “nascita”bensì di un Ritrovamento di Paride, che alla metà del
Enrico Maria Dal Pozzolo Ipotesi per un esordio
03 Saggio Dal Pozzolo.qxd:CAMMEO GONZAGA 11-11-2009 11:07 Pagina 38
41
D’altra parte poco credito hanno riscosso ulterioriproposte. Come quella di Cook di individuarne l’av-vio in una coppia di tele (ma in origine su tavola) pri-ma presso la collezione Conway e poi in quella Gerlidi Milano: due storie relative all’infanzia di Paride – ilsuo Ritrovamento e la Consegna alla nutrice – assai mal-messe e debolissime dal punto di vista stilistico, concui Zampetti aprì la grande mostra veneziana del 1955e che – dopo essere cadute nel dimenticatoio – sonostate riportate all’attenzione da Hornig nel 1987 (fig.4)12. Opere di un esordiente o piuttosto, come appar-so ai più, di un imitatore alquanto sgangherato? An-cor minor fortuna ebbero Le primizie di Giorgione se-gnalate da Luigi Coletti nel 1953: una Giuditta alloranella collezione Rasini di Milano – poi ricondotta alpennello di Luca Antonio Busati – e una Nascita diAdone di una raccolta veneziana che egli stesso vennea cassare nella sua monografia di due anni dopo13.
Il nucleo giovanile più stabile è di certo quello co-stituito dalla catena che salda le due tavole degli Uffi-zi alla Giuditta dell’Ermitage, e questa a sua volta allapala di Castelfranco (cui talvolta si agglutinava anchela teletta con il santo guerriero da essa desunto alla Na-tional Gallery di Londra: cat. XX). Su tale linea si mos-sero le ricostruzioni di Della Pergola (1955), Zampet-ti (1968) e Anderson (1996), ovviamente con varianti.A partire dall’ingresso di una Madonna col Bambino dicollezione privata a Bergamo (fig. 5), estratta dal cata-logo di Romanino e posta tra le primizie di Zorzi daTestori (1963)14. Tali pezzi furono assorbiti nell’ipote-si di sviluppo della giovinezza di Giorgione proposta
da Alessandro Ballarin in un intervento al convegnodel 1978 a Castelfranco che fece scalpore per l’auda-cia dell’impianto e di svariate attribuzioni15. Ballarincostituiva infatti un corpus giovanile di ben diciotto di-pinti e due disegni, che scalava tra il 1494/1495 del pri-mo numero (il cosiddetto Omaggio al poeta della Na-tional Gallery di Londra; cat. XX) e il 1500, che a suoavviso vedeva la genesi della pala di Castelfranco. Tratali estremi, anno dopo anno, venivano a scalarsi le duetavole degli Uffizi (1496), la Maddalena sopra men-zionata (1496), il Fregio di Castelfranco (1496), la Sa-cra famiglia Benson di Washington (1497), l’Epifaniadi Londra (1497), il Ritratto Giustiniani di Berlino(1497), la Madonna di Oxford (1498), la Sacra con-templazione delle Gallerie dell’Accademia di Venezia(1498-1499), la Giuditta dell’Ermitage (1498-1499), ilGiovane con freccia del Kunsthistorisches Museum diVienna (1498-1499), le due tavolette della raccolta EmoCapodilista di Padova e quella di Washington (1498-1499), la Madonna di Bergamo (1499), la Natività Al-lendale e la simile redazione di Vienna (1499), nonchéil foglio di Windsor legato a questa composizione e unaltro con un Martirio di un santo a Chatsworth (1499).Che tutte queste opere siano della gioventù di Zorzipare a chi scrive improbabile, così come risulta diffi-cile seguire lo studioso nella loro sistematica scansio-ne cronologica ad annum: ma che tale intervento con-tenesse preziosi collegamenti e intuizioni è inconte-stabile16. A partire da quello che oggi appare un pun-to fermo da cui reimpostare il ragionamento sul primoGiorgione: ossia la conferma della datazione sul 1499-
40
XVII secolo si trovava nella collezione dell’arciducaLeopoldo Guglielmo d’Austria e che conosciamo gra-zie a una copia del suo pittore di corte David Teniersil Giovane e a un’incisione a essa collegata (cat. 22)5.Si trattava di una composizione di grande respiro, conpersonaggi attorno al piccolo Paride che ostenta il suosesso (in un richiamo premonitore alla sua passioneper Elena) entro un ampio paesaggio, con altre figurein secondo piano e un gruppo di case sul fondale chericordano quelle reiterate da Giulio Campagnola in va-rie sue incisioni. La precisazione di Michiel che “fudelle sue prime opere” va presa molto sul serio, inquanto è presumibile che le informazioni da lui forni-te a riguardo di Zorzi gli derivassero – oltre che da no-zioni proprie (era anch’egli collezionista e ottimo co-noscitore dell’artista) – proprio dai colloqui con Tad-deo Contarini che, in quanto diretto committente dialcune opere del maestro, sarà stato un testimone benaffidabile.
Ma al di là di ciò – che è molto e poco insieme (einfatti non sono mancati coloro che hanno anche mes-so in forte dubbio che tale Ritrovamento di Paride fos-se davvero degli esordi, tanto esso appare sciolto e com-positivamente evoluto)6 – è chiaro che gli indizi dispo-nibili per un ragionamento sono a dir poco esili e am-bigui. Scorrendo le aperture del suo catalogo nelle tan-te monografie a nostra disposizione ci si trova pertanto
di fronte a numeri e ricostruzioni assai disomogenei, sal-vo riconoscere un minimo comun denominatore (ma ineffetti neanche troppo comune) nella presenza abba-stanza costante delle tavole degli Uffizi con il Mosè allaprova del fuoco e il Giudizio di Salomone (cat. 36-37).
Portiamo alcuni esempi.Per molto tempo, sul tracciato di Ridolfi che indi-
cava in Giovanni Bellini il maestro di Giorgione, si è ri-tenuto di scorgere una testimonianza di tale discepola-to in un Cristo portacroce di evidente matrice bellinia-na già nella collezione Zilieri del Verme a Vicenza e nel1898 passato a Isabella Stewart Gardner a Boston (fig.1). Era un’opinione tradizionale, che risaliva a GiovanniMorelli e che fu accolta, tra gli altri, da Cavalcaselle,Cook, Gronau, Richter e, in tempi più recenti, da Pi-gnatti, l’autore della più autorevole monografia sul mae-stro apparsa in due edizioni nel 1969 e nel 19787. Tut-tavia in seguito, a eccezione di Hornig (1987)8, quasipiù nessuno ha ritenuto di sostenere l’ipotesi e lo stes-so Pignatti – nel volume condotto con Filippo Pedrocconel 1999 – pur senza disconoscere una paternità gior-gionesca, fece slittare il pezzo dopo le quattro tavolet-te dello scrigno smembrato divise tra Padova (cat. XX)e Washington, che riteneva le più antiche della sua pro-duzione e che a loro volta agganciava a una Predica delBattista in collezione Pearl a Washington (già da lui pre-sentato in un saggio sui Giorgione’s Pre-Venetian Be-ginnings) che però nessun altro, e per palesi ragioni for-mali, accreditava come autografa9.
Maggior riscontro recente ha avuto l’ipotesi di Ro-berto Longhi in favore di una Maddalena a mezzo bu-sto la cui pertinenza agli esordi giorgioneschi è stata ri-proposta con forza da Volpe, Ballarin, Rearick e Luc-co (fig. 2)10: un dipinto che richiama anche la Sacra con-templazione delle Gallerie dell’Accademia, da taluni da-ta al giovane Giorgione e da altri viceversa agli esordigiorgioneschi di Sebastiano del Piombo (cat. XX). Po-sto all’asta alla metà degli anni novanta e offerto peruna cifra non alta a vari istituti di credito, non ha ri-scosso un consenso tale da consentire un accasamentopubblico (eppure l’interesse vi fu) e – a quel che mi ri-sulta – è tornata nell’ombra. Federico Zeri per essa pen-sava, sia pur con estrema cautela e senza particolareconvinzione, a Benedetto Diana; Anchise Tempestini eJaynie Anderson al giovane Lorenzo Lotto; chi scriveall’autore di una disastrata pala nella chiesa parrocchialedi Cison di Valmarino, non lontano da Conegliano, rea-lizzata da un pittore di estrazione milanese attivo nelVeneto allo scadere del Quattrocento (fig. 3)11.
1. Giovanni Bellini, Cristo portacroceBoston, Isabella StewartGardner Museum
2. Pittore lombardo attivonel Veneto tra la fine del XVe l’inizio del XVI secolo,MaddalenaCollezione privata
3. Pittore lombardo attivonel Veneto tra la fine del XVe l’inizio del XVI secolo,Madonna col Bambino e santi(particolare)Cison di Valmarino, chiesaparrocchiale
03 Saggio Dal Pozzolo.qxd:CAMMEO GONZAGA 11-11-2009 11:07 Pagina 40
4342
co i risultati di tali ricerche, ma anche – e soprattutto(dal punto di vista degli specialisti) – per verificarne latenuta, l’attendibilità. È quel che avviene anche in que-sta occasione a Castelfranco, dove la scelta delle pre-sunte prove d’esordio di Giorgione – un nucleo fino-ra mai messo assieme in un’esposizione, va sottolinea-to – si lega all’opinione di chi scrive e degli altri cura-tori. Logicamente non la si propone come una veritàincontrovertibile, ma nei termini di un’ipotesi di lavo-ro, di un punto di vista, di una possibilità o di una pro-babilità che dir si voglia, che l’esposizione confermerào contraddirà. Posti uno accanto all’altro, i dipinti in-fatti si attraggono o si respingono: certo, facendo i con-ti con gli occhi diversi di chi li guarda.
L’opera con cui si ritiene di aprire qui il catalogodi Giorgione è uno strano dipinto su tavola di medioformato alla National Gallery di Londra (cat. 35). Perlungo tempo è stato convenzionalmente denominatoEtà dell’oro o Omaggio a un poeta, ma – come per tem-po riconosciuto da Chastel e Gentili17 – si tratta di unasingolare interpretazione del mito di Saturno, il Cro-no greco che aveva evirato il padre Urano e che, pertimore del medesimo destino, si era nutrito dei suoistessi figli: per questo venne detronizzato dal suo ulti-mogenito Zeus/Giove, che ne prese il posto relegan-
do il padre in esilio. Egli qui appare in una sorta di ra-dura, distante dalla città visibile al centro dello sfon-do, circondato da animali e accompagnato da varie fi-gure: una specie di eremita in un antro nella roccia asinistra, un musicista seduto ai gradini del suo tronoche ci fissa e un fanciullo che gli viene introdotto daun servitore con un pugnale infilato nella cintura. L’e-spressione malinconica e lievemente contrariata del diosembrerebbe tradire la sua insoddisfazione per il mon-do privo di violenza di cui è ormai impotente signore,in un’oasi di pace in cui tutti gli esseri convivono inuna concordia irreale e ai limiti dell’assurdo. Ci si do-manda: che senso ha eseguire un quadro simile? Chise lo metteva in casa e perché? Evidentemente qual-che appassionato di tematiche astrologiche, attrattodalla questione ebraica: Saturno era infatti per con-suetudine associato agli ebrei e alcuni atipici elemen-ti di costume (che hanno indotto una specialista a du-bitare di una data tra Quattrocento e Cinquecento),sembrerebbero puntare in quella direzione, a partiredal bizzarro cilindro alle spalle del liutista18.
Il suo artefice si dimostra attratto dal fascino diuna narrazione prevalentemente naturalistica, con ani-mali e specie botaniche descritte con minuzia da mi-niatore, certamente attingendo per alcuni a repertoripreesistenti. Lo dimostra l’affinità del leopardo conquello in un album di Giovannino de’ Grassi alla Bi-blioteca Angelo Mai di Bergamo (figg. 6-7)19, e forseanche il pavone deriva da qualche fonte iconograficanon ancora individuata. Il gruppo di case sul fondale,dai tetti spioventi in paglia di matrice tedesca, tradi-sce la meditazione su stampe di Dürer del 1496, in par-ticolare sul Figliol prodigo (cat. XX), ma in generalel’ambientazione paesistica denuncia non casuali asso-nanze con le impaginazioni düreriane. In ogni modola sua fu un’esecuzione a tratti titubante, come indi-cano i pentimenti evidenziati dalle indagini diagnosti-che (si veda il saggio di Gianluca Poldi in questo ca-talogo), incertezze che non stupirebbero in un pittoreagli esordi.
Che si tratti di Giorgione è suggerito dal nesso chequesta tavola esplicita con le due degli Uffizi, la cui au-tografia, come ricordato, è ammessa dalla maggior par-te degli studiosi (cat. XX). Anch’esse non sono im-muni da disomogeneità e saldature, specie nel rapportotra figure e fondale, ma nell’insieme dimostrano unamaggiore sicurezza e un inoltrato grado evolutivo, conun’attenzione ancor più marcata verso la tematica pae-sistica. Entrambe sono impostate per più di due terzi
1500 della pala di Castelfranco ipotizzata da Ballarinper via stilistica e confermata da Francesca Cortesi Bo-sco sulla base di riscontri di tipo storico (se ne veda ilsaggio a seguire). In considerazione della grande ma-turità esibita, essa costringe a immaginare un percor-so formativo avviato all’inizio degli anni novanta e cheverso la metà del decennio – quando l’artista avrebberaggiunto la maggiore età secondo Vasari (che ne in-dicava la nascita verso il 1477/1478) – avrà registratole sue prime prove personali, slegate cioè dalla con-sueta pratica reiterativa e ancillare cui un apprendistaera destinato a dedicarsi quando si trovava alle dipen-denze di un maestro. Se a tale apporto si aggiungonopoi i dati ragionati da Giacinto Cecchetto in questo ca-talogo in merito alla possibilità di riconoscere il pitto-re in quel “Zorzi di Altadona Barbarela” rintracciatonegli archivi castellani nel 1493, di un ramo probabil-mente veneziano dei Barbarela e non più a Castelfran-co (perché definitivamente a Venezia?) nel 1500, è evi-dente che i margini per prospettare ipotesi storica-mente fondate si precisano, sulla base di indizi docu-mentari fino a ora impensati.
È dunque appunto nell’ultimo lustro del secoloche si dovrà setacciare, andando a ritroso dal 1500 del-la pala, per individuare prove che si possono suppor-
re più incerte, forse addirittura embrionali, in cui siaperò riconoscibile quel quid che – in teoria – dovreb-be sempre contraddistinguere il carattere interpretati-vo di Zorzi.
Prima di entrare nel merito, è doveroso però apri-re una parentesi per i lettori di questo catalogo nonspecialisti: ricordando loro che gli studiosi, nell’impo-stare e tentare di risolvere il problema degli sviluppidi un pittore, devono sempre necessariamente opera-re delle ricostruzioni in qualche misura teoriche e vir-tuali. Le opere sono infatti conservate in musei e col-lezioni diverse, spesso separate da oceani; su alcunenon è possibile effettuare analisi dirette – perché diubicazione ignota o in raccolte inaccessibili – e si è per-tanto costretti a ragionare su riproduzioni fotografi-che, le quali vengono accostate ad altre immagini cuisembrano legarsi, per costituire catene di più o menoevidente solidità che consentano di delineare una pro-gressione sia stilistica sia cronologica. Si tratta dunquedi ricostruzioni almeno in parte ipotetiche, legate a ta-li “evidenze” e alle percezioni individuali che il singo-lo studioso trattiene nella memoria di opere magari vi-ste in situazioni della vita anche tra loro assai distanti.Si capisce dunque perché il momento della mostra ri-sulta fondamentale, non solo per divulgare al pubbli-
4. Cerchia di Giorgione,Ritrovamento di Paride(già?) Milano, collezione Gerli
5. Pittore attivo a Venezia trala fine del XV e l’inizio del XVIsecolo, Madonna col BambinoBergamo, collezione privata
03 Saggio Dal Pozzolo.qxd:CAMMEO GONZAGA 11-11-2009 11:07 Pagina 42
4544
sul fondale: ambientazioni amplissime, di inedita bel-lezza, con dettagli che ribadiscono l’importanza degliesempi di Dürer – forse conosciuti non solo tramite lestampe, ma addirittura negli originali pittorici che ilgiovane norimberghese avrà sfoderato in occasione delsuo soggiorno lagunare del 1494-1495 (basti il raffrontotra le rocce a destra nel Salomone e quelle in un ac-querello all’Ambrosiana del 1495: cat. XX) – e cheinoltre contengono premonizioni di soluzioni future,come quella della coppia di soldati in attesa nel Mosè,che si ritroveranno poi nella pala di Castelfranco.
Le due tavole costituiscono un pendant inscindi-bile. A sinistra si narra della fallace capacità cognitivae precognitiva del faraone d’Egitto, incapace di legge-re il presagio dell’emancipazione del popolo ebraiconel gesto del piccolo Mosè che aveva fatto cadere lasua corona a terra; a destra la superiore prova di di-scernimento da parte di Salomone, il figlio di David ere d’Israele, alle prese con un ostico caso giudiziarioprovocato da due prostitute, una buona e l’altra per-fida, che si contendevano un figlio. Quest’ultimo epi-sodio era spesso portato come esempio di acutezza in-terpretativa da emulare, e l’ipotesi già sostenuta chetale pendant sia stato commissionato da qualche ma-gistrato veneziano potrebbe colpire non lontano dalsegno20.
Un aspetto molto importante finora trascurato èche dietro entrambe le tavole si riconosce una deco-razione fitomorfa con rami intrecciati su un finto mar-mo che tipologicamente richiama alcuni dipinti coeviche prevedevano una doppia visione, in recto e verso(figg. 8-9)21. A quando questa decorazione risalga nonè affatto chiaro, ma – al di là di questo punto, logica-mente cruciale – vari indizi lasciano intendere che finda un’età molto antica le due tavole furono utilizzatecome ante di un mobile: infatti ai margini si ricono-scono incavi con usure dovuti certamente alla siste-mazione di ganci e fermi (fig. 10). Inoltre la fascia oriz-zontale priva di pittura riscontrabile su entrambi i pez-zi corrispondeva ad ampie traverse di supporto poiasportate che erano state fissate dall’origine, come sievince dal fatto che i chiodi vennero battuti dal rectoprima dell’esecuzione della pittura22.
L’abbinamento di questi due episodi con Mosè eSalomone nella pittura veneziana tra Quattrocento eCinquecento non sembra testimoniato da altri casi, senon da uno sul quale non s’è finora richiamata l’at-tenzione e che va invece segnalato anche per la con-creta possibilità che avesse pure composto un mobile,
6. Giovannino de’ Grassi (?)Bergamo, Biblioteca Civica,ms. !. VII. 14, fol. 15v
7. Giorgione, Saturno in esilio(particolare)Londra, The National Gallery(cat. 35)
8. Giorgione, Giudizio diSalomone, retro della tavolaFirenze, Galleria degli Uffizi(cat. 37)
9. Giorgione, Mosè alla provadel fuoco, retro della tavolaFirenze, Galleria degli Uffizi(cat. 37)
10. Giorgione, Giudizio diSalomone, retro della tavola(particolare)Firenze, Galleria degli Uffizi(cat. 37)
03 Saggio Dal Pozzolo.qxd:CAMMEO GONZAGA 11-11-2009 11:07 Pagina 44
4746
soldati, vestiti praticamente nello stesso modo dell’al-tro nella scena precedente. A inquietarsi per la pre-senza del fuoco è solo un piccolo cervo che fugge a si-nistra, un motivo che è una vera e propria cifra stili-stica di Luca Antonio Busati. La stessa impaginazio-ne, nonché la maniera di rendere figure e paesaggio, siritrova in un terzo pezzo, già sul mercato a Monaco diBaviera e attualmente in collezione milanese, dal sog-getto meno facilmente riconoscibile (tavola, 19 ! 41,3cm; fig. 13)26. A sinistra un sovrano seduto con scettroe corona dialoga con un soldato, mentre al centro uninserviente porta un piatto colmo di frutta verso unbraciere spento, dietro il quale compaiono tre madricon in braccio i rispettivi figlioli. Che il re vada iden-tificato nel faraone non pare dubbio, a dispetto della
mise non propriamente orientale, mentre sono leciteperplessità sull’episodio rappresentato, che potrebbeconnettersi sia a quello della prova di Mosè (per quan-to il braciere sia spento e di diverso tipo) o, più pro-babilmente, a un altro passaggio dell’Esodo (1, 8-22)in cui il re d’Egitto ordinò alle levatrici ebree di ucci-dere ogni figlio maschio, risparmiando invece le fem-mine, ordine reiterato anche dopo il rifiuto di costo-ro, con la giustificazione che “le donne ebree non so-no come le egiziane: sono piene di vita. Prima che ar-rivino le levatrici, hanno già partorito”, con la bene-dizione di Dio27.
Il nesso tra questi tre pezzi è evidente. Potrebbeperò esservene un quarto, un Augusto e la Sibilla allaNational Gallery di Londra (fig. 14). Già documenta-
o qualcosa del genere. Si tratta di una serie di tre, oforse quattro, tavolette il cui stile richiama i modi diquel Luca Antonio Busati responsabile della Giudittagià nella collezione Rasini di Milano da Coletti riven-dicata agli esordi di Giorgione e inimmaginabile sen-za una conoscenza diretta del capolavoro dell’Ermita-ge23. Rimettiamoli insieme.
Si può partire dalla tavoletta (16,7 ! 40 cm) raffi-gurante il Giudizio di Salomone nelle raccolte del Cre-dito Valtellinese (fig. 11), che una perizia di RodolfoPallucchini accostava all’autore della predella del po-littico di Cima a San Fior e che come della bottega delmaestro di Conegliano è stata ragionata da PatriziaZambrano, con un’ipotesi in favore del trevigiano Do-menico Capriolo24. Il dipinto rappresenta l’episodio intermini sintetici: al centro un soldato simile a quelli ro-maneggianti dei Lombardo solleva lo spadone sul bim-
bo ritratto in posa equilibristica, mentre a destra Sa-lomone alza gli occhi al cielo chiedendo l’ispirazionedivina e a sinistra le due madri, non distinguibili tra labuona e la cattiva, appaiono in atteggiamento di dia-logo. Il tutto si staglia su un ampio paesaggio a un tem-po lacustre e agreste, con armenti, pastori, cavalieri,una città sullo sfondo e una rocca presumibilmente de-sunta da qualche stampa nordica.
Il dipinto s’appaia a un Mosè alla prova del fuocosu tavola (di 17,7 ! 40,2 cm) che il 26 giugno 2003 ap-parve a un’asta parigina di Christie’s, transitando poiper la Galleria Sarti, sempre a Parigi, che a sua voltala cedette a un privato (fig. 12)25. Anche in questo ca-so del tema si ha un semplice abbozzo narrativo, conil sacerdote che avvicina il piccolo Mosè al braciere dacui attinse i tizzoni ardenti. A differenza dell’esemplaredi Giorgione, qui non compare il faraone, ma solo due
11. Luca Antonio Busati,Giudizio di SalomoneSondrio, Credito Valtellinese
12. Luca Antonio Busati, Mosè alla prova del fuocogià Parigi, mercato antiquario
13. Luca Antonio Busati, Il faraone e le levatrici ebree (?)Milano, collezione privata
14. Luca Antonio Busati,Augusto e la SibillaLondra, The National Gallery
03 Saggio Dal Pozzolo.qxd:CAMMEO GONZAGA 11-11-2009 11:07 Pagina 46
4948
to presso il mercante veneziano Consiglio Ricchetti co-me di Carpaccio, pervenne a Londra con Austen HenryLayard, che lo lasciò al museo con il nome di Girola-mo da Santa Croce. Sulla corretta attribuzione dell’o-pera la critica s’è divisa: Berenson pensò prima a Car-paccio, poi dubitativamente a Giovanni Bellini, a Laz-zaro Bastiani e a Benedetto Diana; Fiocco a Lattanzioda Rimini, Heinemann a Marco Bello, mentre gli esten-sori dei cataloghi della galleria mantenevano una ge-nerica ascrizione a scuola veneziana verso il 150028. Adaccostarlo ai risultati dei Busati fu Pallucchini, che s’in-dirizzava verso Andrea, riferimento meglio orientatosu Luca Antonio da parte di Tempestini29. Le misuresono leggermente inferiori in larghezza rispetto agli al-tri tre (17,5 ! 38,5 cm), ma tutto il resto sembra tor-nare alla perfezione e – se così fosse – si chiarirebbe laprospettiva profetica ed escatologica dell’insieme. Èpossibile che si trattasse di una spalliera, o di qualco-sa del genere, e si deve immaginare una continuità nar-rativa ora interrotta dall’assenza di altri elementi30. Siapure nella dimensione più artigianale, va ammesso chesimili risultati richiamano talune scelte tematiche tipi-che dell’artista di Castelfranco, orientato sulla focaliz-zazione di momenti precristiani spesso di matrice ebrai-ca. E ciò in un contesto sociale, quello del Veneto traQuattro e Cinquecento, che da una parte registrava ildiffondersi a livello popolare di cruenti fenomeni an-tisemiti (accesi in modo particolare dalle infuocate pre-diche di francescani come Bernardino da Feltre)31 edall’altra una diffusa attenzione alla ricchezza cultu-rale della tradizione ebraica, che segnò gli interessi pro-prio di colui che possedeva il suo Autoritratto in vestedi David: quel Domenico Grimani, patriarca di Aqui-leia e potentissimo ambasciatore della Serenissima pres-so il papa, che si era circondato di medici e intellet-tuali ebrei, oltre che dei tanti libri ebraici acquisiti da-gli eredi di Pico della Mirandola32.
Tornando a Giorgione, che egli agli esordi si fos-se dedicato alla decorazione di mobili lo dichiarò, co-me ricordato, Ridolfi, il quale però gli ascrisse esem-plari che sappiamo non essere suoi (come la Nascita ela Morte di Adone di Sebastiano del Piombo al MuseoLia a La Spezia) e perduti, per lo più di tematica ovi-diana33. Ma un’applicazione su tale versante produtti-vo sembra confermata dalle due tavolette dei MuseiCivici di Padova ora in mostra (cat. XX) che, assiemead altre due a Washington su cui si tornerà innanzi, ve-rosimilmente componevano un piccolo scrigno smem-brato. S’è detto, ma senza produrre alcuna documen-
tazione, che esso fosse stato trovato nella raccolta Fa-lier a Caselle di Asolo34. Di certo in antico erano cre-duti del pittore di Castelfranco, come attesta un’iscri-zione “Zorzon” in apparenza settecentesca sul retrodel cosiddetto Idillio campestre di Padova. La criticamoderna si è divisa sull’opportunità di riferire o me-no tali esemplari al maestro, con da una parte coloroche riconoscevano un adeguato livello qualitativo e unaconnessione stilistica con i prodotti giovanili solita-mente accettati, e dall’altra quanti – pur ammettendoun’aura giorgionesca – preferivano un più cauto acco-stamento alla “cerchia” o a qualche “seguace”35. Chiscrive appartiene al primo fronte, perché ravvisa unasostanziale identità esecutiva rispetto alle due tavolefiorentine e soprattutto alla pure abbastanza precoceAdorazione dei Magi della National Gallery di Londra(fig. 15): in quest’ultima certe teste risultano quasi in-terscambiabili con quelle patavine e il fatto che si ri-scontrino connessioni non vaghe pure con certe partifigurali del Fregio di Castelfranco (fig. 16) tenderebbea confermare che ci si trovi innanzi a un nucleo omo-geneo36. Le date vanno circoscritte tra il 1496-1498 del-le stampe di Dürer la cui conoscenza affiora nel Sa-turno e nel Salomone e il 1500 della pala Costanzo, cheapre un nuovo capitolo – ormai maturo e sostanzial-mente emancipato – nella parabola di Zorzi. È inte-ressante osservare che al pari del Saturno e del pendantfiorentino, anche le due tavolette patavine partono dauna riflessione essenzialmente paesistica – un fondaleraffinatissimo, che tradisce una non episodica rifles-sione su esempi perugineschi e miniati – cui solo in unsecondo momento vennero aggiunte le figure37. Se-condo vari specialisti, della stessa mano sarebbe purel’Orfeo e il tempo della Phillips Collection di Wa-shington, che a chi scrive appare in vero un po’ più de-bole, per quanto assai vicino. Di certo ad altro artefi-ce, ovviamente a Zorzi collegato, spetta la Venere e Cu-pido della National Gallery della medesima città (figg.17-18)38.
Non tutti sono d’accordo sull’opportunità di ri-ferire a Giorgione il Fregio di Castelfranco, che per al-cuni sarebbe addirittura successivo al 1510 (cat. XX)39.In verità la maggior parte degli studiosi ammette l’au-tografia per entrambe le porzioni (orientale e occi-dentale), anche se nel saggio presentato in questo ca-talogo Silvio D’Amicone sceglie di scinderle, asse-gnando al maestro la parte est e a un collaboratore eseguace quella ovest. Ora, a prescindere da questo pun-to su cui si tornerà, è innegabile la profonda sugge-
17. Collaboratore di Giorgione,Orfeo e il tempoWashington, D.C., The PhillipsCollection
18. Collaboratore di Giorgione,Venere e CupidoWashington, D.C., NationalGallery of Art
16. Giorgione, Fregio, parete estCastelfranco Veneto, MuseoCasa Giorgione
15. Giorgione, Adorazione deiMagi (particolare)Londra, The National Gallery
03 Saggio Dal Pozzolo.qxd:CAMMEO GONZAGA 11-11-2009 11:07 Pagina 48
51
neggi con alcune precoci stampe del patavino (come ilTobia e l’angelo; cat. XX) e del fatto che pure nelle duetavolette di Washington che componevano lo scrignosmembrato – forse nell’Orfeo col Tempo della PhillipsCollection, quasi certamente nel Venere e Cupido dellaNational Gallery – pare riconoscibile la mano di Giu-lio46. Il problema consiste però nella difficoltà di co-struire un attendibile catalogo pittorico del Campa-gnola senior. Non è certo questa la sede per soffermarsisulla sua sfuggente fisionomia, ma in una prospettivagiorgionesca bisognerà tener conto almeno di alcuniaspetti47. Anzitutto che dalla non indifferente docu-mentazione cartacea disponibile su di lui si desume unaformazione eclettica, atipica e itinerante che lo con-dusse – sulla traccia dei migliori letterati, pittori e mu-sicisti sulla piazza padana – da Padova a Verona, daMantova a Ferrara, per approdare a Venezia. Più o me-no quello, in sostanza, che la produzione d’esordio la-scerebbe intuire per Giorgione. In secondo luogo so-no ben riconoscibili i suoi rapporti con esponenti diquella cultura umanistica rinnovata (da Pietro Bemboad Aldo Manuzio, da Pomponio Gaurico a GiovanniAurelio Augurello, tutti studiosi fortemente interessa-ti alla dimensione artistica) di cui non lui, bensì Zorzirisultò poi la più efficace espressione pittorica. Il terzoe fondamentale riscontro è che dalle fonti più attendi-bili (Michiel) e dall’evidenza visiva va ammessa una suaeffettiva collaborazione col maestro castellano, le cuiidee paiono raccolte fedelmente in talune stampe (si ve-dano in particolare il San Girolamo, il Giovane pastoree la Nuda: catt. XX-XX-XX), in un arco cronologicoche si apre alla fine del Quattrocento per giungere al-meno al 1506 circa del cosiddetto Tramonto di Londra(cat. XX) e poi estendersi verosimilmente anche a Se-bastiano e Tiziano.
Ma, al di là dell’eventualità di una compresenzaesecutiva di Giulio nel Salomone e nello scrigno, ciòche non è discutibile è che in una delle pochissimeiscrizioni antiche, se non coeve, riferibile a Giorgione– quella sul retro della cosiddetta Laura di Vienna –ancora nel 1506 egli è esplicitamente definito cholegadi Vincenzo Catena. Cholega significa socio, collabo-ratore, pari in grado48, e il fatto che a partire da un cer-to momento della sua carriera (più o meno dalla metàdel primo decennio) la produzione di Catena esprimaun’inequivocabile connessione con le composizioni ei modi di Zorzi dà un corpo vivo a tale indicazione. Lacosa pare confermata dalla ben nota presenza, sottol’Autoritratto di Braunschweig, di una Madonna col
Bambino tipica dell’officina di Vincenzo49. Del restopure nel Fregio di Castelfranco e nei due malconci af-freschi nel duomo di Montagnana sono stati indivi-duati scarti esecutivi che suggeriscono la probabilitàche egli non fosse solo sui ponteggi50; anzi, nel casomontagnanese le analisi scientifiche effettuate in oc-casione dell’ultimo restauro hanno riscontrato preci-se differenze tecniche tra i due brani che, unite al ri-scontro di un certo dislivello di fattura tra la smaglianteGiuditta e il meno brillante David, hanno suggerito perquest’ultimo l’intervento di una seconda mano51. E an-cora: se non ci fosse stata un’autentica simbiosi traGiorgione e Sebastiano, non si spiegherebbero le an-nose incertezze sulla paternità di opere come il Giudi-zio di Salomone di Kingston Lacy e la Sacra contem-plazione delle Gallerie dell’Accademia (cat. XX), contre possibilità in apparenza antitetiche: Giorgione, Se-bastiano o entrambi?
Se così fosse – con dunque una saltuaria condivi-sione esecutiva da parte di alcuni collaboratori a luiparticolarmente vicini – da un lato si delineerebbe ilcaso non comune di una piccola compagnia di giova-ni raccolti sotto la sua leadership, che favorì la nascitadi una specie di laboratorio intellettuale aperto e inprogress, dove l’incessante esperimento inventivo e sti-listico stava forse più a cuore dello stesso concetto diautografia individuale (è casuale che di Zorzi e dei suoiprimi compagni non ci siano giunti ante 1510 dipintiesplicitamente firmati?); ma dall’altro lato si potreb-bero meglio intendere, e in fondo giustificare storica-mente, pure le infinite difficoltà relative alle distinzio-ni tra autografi e prodotti di immediata cerchia, traGiorgione e i suoi primi seguaci, che sempre hannoangustiato gli studiosi antichi e moderni. Si tratta diuna via non priva di insidie ma che, come specificatoin altra sede, oggi come oggi sembra quella meglio per-corribile52
Questa mostra è dunque una verifica anche su ta-le versante: non per nulla si è prevista una sezione in-titolata “Sfide”. Sfide di lettura, ipotesi che si aprono,altre che si chiudono, tradizioni da verificare; alcuneconvinzioni cadranno, ma sorgeranno nuovi spunti eprovocazioni. Così, nella parte che si presenta al pub-blico senza il punto interrogativo – quella che agli oc-chi di chi scrive ha le carte in regola per appartenere almaestro di Castelfranco – sono presenti anche pezziche non tutti gli specialisti gli accreditano, anzi. Del re-sto, come ricordato in apertura, le esposizioni servonosoprattutto a questo. Una sola cosa va raccomandata.
stione che affiora nel momento in cui si abbina la pos-sibilità che, come voleva una tradizione di primo Sei-cento, il pittore fosse della famiglia Barbarella con ilriscontro – pure emerso dalle indagini archivistiche diGiacinto Cecchetto40 – che la prima proprietà della ca-sa che ospita il Fregio sembra essere per l’appunto deiBarbarella (poi passò ai Marta e infine ai Pellizzari).Se tutto ciò corrispondesse, forse si tornerebbe all’an-tica e quasi incredibile denominazione di “casa di Gior-gione”. Ma, al di là di una simile congettura, sono al-tresì da rimarcare tre aspetti. Il primo è che se il Fre-gio è di mano del maestro, esso non può che apparte-nere alla sua prima fase, prima del (definitivo?) tra-sferimento a Venezia: i confronti più volte portati consvariati dettagli delle tavole degli Uffizi, nonché quel-li su cui s’è appena richiamata l’attenzione con l’Ado-razione dei Magi di Londra e le tavolette di Padova ap-paiono agli occhi di chi scrive assolutamente eloquen-ti. Il secondo è che il Fregio in qualche misura docu-menta l’estrazione, la matrice castellana di Giorgione:nel senso che spiega come le sue radici di frescante –sottolineate dalle fonti antiche e ragionate da Mariuznel suo ultimo contributo sull’artista41 – affondino inquella “civiltà dell’affresco” che, nonostante le graviperdite subite dal territorio, come documentato dalleponderose ricerche di Fossaluzza, si presenta come unadelle caratteristiche distintive della cultura figurativadella Marca trevigiana. Per quanto magari oggi indi-mostrabile, è lecito supporre che almeno alcune dellesue prime prove si siano svolte proprio in tale campo,dove avrà dunque appreso i rudimenti di quell’arte deldipingere veloce che riconosciamo espressi al massi-mo grado nella Nuda del Fondaco e prima ancora, sesi ammette l’attribuzione, nella retrofacciata del duo-mo di Montagnana42. Poco giocata dai suoi colleghi la-gunari, fu una carta che piacque a certa committenzaveneziana, che ne comprese le enormi potenzialità au-tocelebrative per decorare facciate e cortili. Il terzoaspetto concerne le implicazioni espresse dagli stessicontenuti iconografici e iconologici del Fregio, distraordinaria densità e intricatezza, che ne attestano lefrequentazioni umanistiche, le ansie astrologiche e, infondo (come già osservato da Padoan)43, pure certi li-miti culturali. Su tale questione non è però il caso dientrare, rimandando al ricco saggio di D’Amicone inquesto catalogo.
Come s’è spesso sottolineato, in questa prima fa-se della carriera di Giorgione non mancano disomoge-neità e scarti esecutivi, facilmente comprensibili con gli
esperimenti di un giovane non vincolato ai modelli diun solo maestro e alla ricerca di una sua strada perso-nale. Compaiono infatti simultanei richiami a Bellini, aCarpaccio, a Perugino (a Venezia nel 1494-1495 e for-se nel 1497), a Dürer e ad altri maestri tedeschi deditialla produzione di stampe, alla dimensione dei minia-tori e degli illustratori degli album repertoriali, ma sen-za che l’uno prevalga sull’altro, in un singolare impa-sto linguistico che verrebbe da definire intuitivo, in-termittente e quasi anarchico. Ne consegue che, sullabase di una traccia come quella ora delineata, indicareil nome del suo primo maestro appare un’impresa as-sai ardua, se non impossibile. Nulla vieterebbe di pen-sare che il suo percorso formativo sia stato in qualchemisura itinerante, slegato dal consueto radicamento inuna specifica bottega e perciò senza l’acquisizione or-todossa del linguaggio di un unico caposcuola44.
Ma due ulteriori considerazioni vengono a galla.La prima è che da subito egli intrattenne relazioni ecommittenze segnate da sincretici interessi letterari, an-tiquari, astrologici, ebraizzanti e musicali: appunto ilmondo di quella cultura eterogenea che si materializzaper emblemi nelle sequenze coordinate del Fregio, lacui eccezionalità tipologica è pure da ammettere45. Ditale mondo in fondo si sa ancora troppo poco, ma lasua frequentazione – all’epoca per nulla scontata perun artista emergente – potrebbe in qualche modo averanche favorito il grado di indipendenza immaginativache il giovane maestro dimostra fin da principio. Il cor-pus costituito dalle tavole di Londra, degli Uffizi, di Pa-dova e dal Fregio dichiara espressamente una diversitàdi tematiche e interpretativa rispetto a quelle eviden-ziate da qualsiasi altro pittore veneto contemporaneo,e contiene in sé tutte le premesse dell’allegorismo in-tricato e spiazzante delle più note opere seguenti. Vi èperò un secondo punto particolarmente importante edelicato: la probabilità, se non la certezza, che egli nelsuo percorso si sia trovato più volte nella condizione dicondividere con qualche collega la prassi esecutiva. Lacosa è indicata dalle differenze tra le figure del Mosè edel Salomone, con le prime in sintonia con i modi ele-ganti e fluidi del paesaggio e le seconde invece più mec-caniche e stentate. Come più estesamente ricordato nel-la scheda relativa (cat. XX), l’identità di tale aiuto è dif-ficile da precisarsi: sono stati avanzati i nomi di GiulioCampagnola, di Vincenzo Catena, di Giovanni Agosti-no da Lodi, oppure s’è pensato a qualche misteriosoferrarese. A parere di chi scrive la prima ipotesi sem-brerebbe preferibile, in virtù di certe analogie nei pan-
50
03 Saggio Dal Pozzolo.qxd:CAMMEO GONZAGA 11-11-2009 11:07 Pagina 50
53
1993 (Recensione); Puppi 1994; Stedman Sheard 1994.17 Chastel 1946; Gentili 1980 (ed. 1988, pp. 71-74).18 Dal Pozzolo 2009, pp. 126, 326-327.19 Come evidenziato da Lucco 1995, p. 19. Per questo foglio inoltreScheller 1963, pp. 142-154; Scheller 1995, pp. 276-291 e Degenhart,Schmitt 1990, VI, pp. 539-540; per il fenomeno in generale, inoltre,Elen 1995.20 Lucco 1995, p. 36; Pedrocco, in Pignatti, Pedrocco 1999, p. 114.21 Si vedano i vari casi illustrati da Dülberg 1990: ad esempio i Ri-tratti di Filippo Lippi a Berlino, di Jacometto a New York e di Vander Weiden al Courtauld di Londra (figg. 61, 78, 90).22 Devo questa osservazione alla restauratrice Rita Alzeni nel corsodi un sopralluogo del gennaio 2009.23 Sui Busati si vedano i molti contributi di A. Tempestini, il più am-pio e sintetico dei quali è del 1993.24 Zambrano 1995, p. 11; Zambrano 1996, p. 20 (bottega di Cima).25 Porta un antico numero di inv. 709. Per l’iconografia in area ve-neta di questo tema, si vedano i casi portati da Borenius (1921) – undisegno della collezione Oppe interessante per qualche connessio-ne con le stampe di Giulio Campagnola e una tavoletta di Bonifa-cio Veronese a Dublino – e ancora, della bottega di Bonifacio, l’e-semplare abbinato al Ritrovamento di Mosè all’Ashmolean Museum(Lloyd 1977, pp. 34-35). Cfr. inoltre, A. De Marchi 1991.26 Sul retro compaiono vari cartellini e timbri di collezione, che do-cumentano una vecchia attribuzione a Cima, nonché un’antica iscri-zione “Peruchino” che ne richiama una precedente a Perugino.27 Esodo (1, 19).28 Berenson 1910, p. 102 (Carpaccio); Fiocco 1931, p. 96 (Lattanzioda Rimini?); Berenson 1932, p. 71 (Giovanni Bellini?); Berenson1936, p. 54 (Lazzaro Bastiani?); Fiocco 1941, p. 96 (Lattanzio da Ri-mini?); Davies 1951, pp. 421-422 (Scuola veneziana); Berenson 1958,I, p. 76 (Diana?); Heinemann 1962, I, p. 89, S. 16, II, p. 313 (Mar-co Bello); Baker, Henry 1995, p. 350 (Veneziano, 1500 circa).29 Pallucchini 1951, p. 196 (ma già Davies 1951, p. 421 ne rilevaval’affinità col paesaggio nel Compianto di Andrea alla National Gal-lery di Londra); Tempestini 1993, p. 36 (Luca Antonio Busati?);Tempestini 1998, pp. 89-92 (da avvicinare “al mondo di Busati”).30 Già Davies (1951, p. 421) e Baker, Henry (1995, p. 350) avevanosupposto che la tavoletta londinese fosse stata “a piece of furniture”.31 Per il quadro sociale in cui s’innestava la presenza ebraica ai tem-pi e nei luoghi di Giorgione, basti Segre 2004.32 Su Domenico Grimani resta fondamentale il lavoro monograficodi Paschini 1943; per un aggiornamento, Benzoni, Bortolotti 2002.33 Per la testimonianza di Ridolfi, si veda sopra alla nota 2. Per le ta-vole del Museo Lia, ora Lucco, in Sebastiano del Piombo 2008, p. 92.
34 Coletti 1955, p. 52.35 Si veda in questo catalogo il riepilogo offerto nella scheda cat. XXredatta da Franca Pellegrini.36 Sull’Adorazione dei Magi di Londra, Hornig 1987, pp. 189-191;Pedrocco, in Pignatti, Pedrocco 1999, p. 108; Dal Pozzolo 2009, pp.148-156.37 Si tenga conto anche delle osservazioni al riguardo di GianlucaPoldi nel saggio in questo catalogo.38 Dal Pozzolo 2009, pp. 144-148.39 Sgarbi 1979, pp. 273-284; Anderson 1996, pp. 324-326.40 Cecchetto 1999, p. 132; Colonna, Preti 1999, p. 312, n. 18.41 Mariuz 2004. Cfr. inoltre Gentili 2000, p. 351.42 Dal Pozzolo 1991 e 2009, pp. 180-195.43 Padoan 1979, 1981.44 Sussistono addirittura elementi che fanno sospettare che in qual-che modo il giovane artista ebbe modo di conoscere perfino esem-pi della pittura romana di età imperiale: dalla maniera di definire lefigurine nel fondale e negli elementi decorativi nelle due tavole de-gli Uffizi, all’analogia (riscontrata da Guidoni 1997) tra il profilodella rupe a sinistra nel Saturno con un affresco di età tardorepub-blicana recuperato a Roma in una casa presso l’Esquilino, fino allecitazioni archeologiche nei due affreschi di Montagnana. In tal ca-so, un possibile tramite con la città eterna potrebbe essere stato ilcardinale Domenico Grimani, che possedeva un palazzo nella zonadel Quirinale e il cui legame con Giorgione – attestato dalla pre-senza nella sua collezione di opere del maestro – potrebbe anche ri-salire assai indietro nel tempo. 45 Per una lettura dei contenuti del Fregio, oltre al saggio di SilvioD’Amicone in catalogo, cfr. almeno Mariuz 1996; Cohen 1996; eGentili 2003.46 Dal Pozzolo 2009, pp. 144-148.47 Su Giulio, in attesa della monografia in fase di completamento daparte di Antonio Carradore (alle cui schede nel presente catalogo sirinvia comunque per qualche informazione aggiornata), cfr. Safarik1974; Chiari Moretto Wiel 1988; Christiansen 1994; Dal Pozzolo1996, pp. 159-160, 166-168; Sorce 2003.48 Basti Battaglia 1964, III, 284-285, che ricorda l’occorrenza di Dan-te (Paradiso, II, vv. 118-120: “Pensa oramai qual fu colui che degnoCollega fu a mantener la barca Di Pietro in alto mar per dritto se-gno”).49 Müller Hofstede 1957.50 Per il secondo intervento, cfr. Dal Pozzolo, 2009, pp. 186-195.51 Cfr. Fassina, Fedeli, Stangherlin 2004, pp. 62-63 e Dal Pozzolo2004, Le ragioni, p. 8.52 Dal Pozzolo, 2009, pp. 11-12.
52
Di accostarsi al problema di Giorgione – e in modo par-ticolare a quello dei suoi nebulosi esordi – senza di-menticare mai quanto poco di lui sappiamo, che i suoiriflessi fuoriescono da un buio storico quasi impene-trabile, che tentare di ricostruirne la vicenda biografi-ca e artistica è un’impresa tanto affascinante quantofrustrante, con scommesse da accettare pur sapendoche per lo più produrranno esiti incerti. Dunque ci sisoffermi sulle opere qui radunate senza preconcetti,consapevoli del mistero che esse – in qualsivoglia pro-spettiva privilegiata – documentano. Questo è davve-ro l’unico modo corretto di affrontare uno dei più osti-ci enigmi della storia dell’arte. Che ha però un risvol-to, in una simile ottica, quasi paradossale: ossia che nelcono d’ombra che si formò dietro la sagoma fugace delpittore castellano morto di peste nel 1510, fermenta-rono i semi che permisero ai suoi primi seguaci di av-viare un nuovo capitolo del Cinquecento veneto, conquindi la rivoluzione di Tiziano e poi quelle di Tinto-retto, Veronese, e di lì a Rubens, Velázquez, Manet. Coltempo la possibilità di capire chi fu davvero Giorgio-ne si perse, ma bastò qualche barlume delle sue intui-zioni per illuminare nuove strade.
1 Questo saggio riprende e integra quanto da me ragionato sulla que-stione nella monografia appena pubblicata per Federico Motta edi-tore (2009, pp. 120-147).2 Ridolfi (1648, ed. 1914, I, pp. 97-99) riferiva prima genericamen-te di “quadri di divotione, recinti da letto e gabinetti”, poi al fattoche nella sua bottega di San Silvestro vi dipingesse “rotelle, armarie molte casse in particolare, nelle quali faceva per lo più favole d’O-vidio”, avvertendo infine che “lungo sarebbe il raccontar le favoletutte da Giorgio in più casse dipinte, di Alcide, di Acheloo e dellabella Deianira rapita da Nesso Centauro saetato nella fuga dall’i-stesso Alcide; degli amori di Apollo, e di Giacinto, di Venere e diAdone: e tre di queste favole si trovano appresso de’ Signori Vid-mani; in una è la nascita di Adone, nella seconda vedesi in soavi ab-bracciamenti con Venere, e nella terza vien ucciso dal Cinghiale; etaltre delle descritte furono ridotte parimenti in quadretti e poste invar studii”.3 Oltre al classico Schubring 1923, si vedano, almeno, Thornton1992, e At home in Renaissance Italy 2006.4 Der Anonimo Morelliano 1888, pp. 86-88. 5 Per la stampa si rinvia alla scheda di Francesca Cocchiara in que-sto catalogo; per una riproduzione a colori del dipinto Eller 2007,p. 171, e Dal Pozzolo 2009, p. 35.6 Ad esempio Pignatti 1978, pp. 52-54, 149, e, da ultimo, Eller 2007,pp. 171-173.7 L’attribuzione era stata avanzata nell’Ottocento da Morelli e ac-colta da Berenson, Pignatti (1969, p. 94; 1978, p. 96), Valcanover(1987, pp. 12-13) e altri. Di recente esposto alla mostra bellinianadi Roma, con scheda in catalogo di G.C.F. Villa (in Giovanni Belli-ni 2008, p. 304). Per una recente riabilitazione della tradizionale teo-ria di una derivazione di Giorgione da Giovanni Bellini, Lucco 2008.8 Hornig 1987, pp. 179-181.9 Pignatti 1993, 1994, p. 105; Pignatti, Pedrocco 1999, pp. 42-43,92-104, 130.
10 L’opinione di Longhi, documentata anche da una perizia privatadel 1952, fu raccolta da Zampetti nel catalogo della mostra vene-ziana da questi curata nel 1955, p. 14. In seguito l’autografia fu ri-lanciata da Volpe (1964, p. 4), Ballarin (1979, p. 229, ed. 1993, p.283); Rearick (1979, p. 188, con prudenza), e Lucco (1983, p. 472;1995, pp. 15-17; 2008, pp. 122-124). Venne lasciata sospesa nel lim-bo delle opere “attribuite” da Zampetti (1968, p. 96, n. 42) e Peris-sa Torrini (1993, p. 114), e invece respinta da Pignatti – che pensa-va a un maestro provinciale influenzato da Giorgione, forse Pier Ma-ria Pennacchi (1978, p. 130) – Tempestini (1993) e Anderson (1996,pp. 326-327), orientati sul giovane Lotto. La cautissima opinione infavore di Benedetto Diana venne comunicata oralmente da Zeri al-lo scrivente nel 1996.11 Dal Pozzolo 2009, p. 355 nota 35. La pala nella parrocchiale diCison di Valmarino era riferita ad Antonio Solario da Lucco 1983[voce da verificare], pp. 18-19; inoltre Lucco 1987, p. 161, ma l’at-tribuzione non pare convincente, per quanto di certo si tratti di unpittore di matrice milanese, con precisi richiami all’arte di Braman-tino, che fu attivo nel Veneto tra Quattrocento e Cinquecento. Pur-troppo lo stato conservativo della pala (una tavola trasportata su te-la e della quale si conserva in canonica il supporto originale su cuiè ben leggibile il disegno preparatorio) è disastroso ed è molto dif-ficile precisare un tentativo attributivo. Ai miei occhi l’identità dimano con l’autore della Maddalena si riconosce non solo per l’im-pianto figurale, ma anche per la medesima maniera di costruire ipanneggi e i decori degli scolli, nonché dei nimbi.12 Cook 1904; Zampetti 1955, pp. 2-4; Hornig 1987, pp. 167-168. 13 Coletti 1953, pp. LXXVI-LXXVII; nel 1955 riconfermò a Gior-gione solo la Giuditta, riconducendo a Previtali l’altra (pp. 51-52;per la quale mi sfuggono ulteriori occorrenze bibliografiche). Perl’ascrizione al Busati della Giuditta, cfr. Dal Pozzolo 1992, p. 65;Tempestini 1993, p. 36; Lucco 1995, p. 152. Va ora aggiunto che es-sa è ricomparsa nel settembre 2009 alla mostra antiquaria di Palaz-zo Corsini a Firenze, presentata dalla Galleria Trinity Fine Art diLondra in una forma polilobata differente dal formato rettangolarecon cui l’aveva resa nota Coletti: se si tratta dell’assetto originario,la cosa indurrebbe a pensare che fosse un elemento di mobilio, ve-rosimilmente trasferito da tavola a tela.14 Testori (1963) la poneva verso il 1504, tra la Giuditta dell’Ermi-tage (1503) e la pala di Castelfranco (1505). Per un aggiornamentosulla vicenda critica del dipinto, cfr. Hornig 1987, pp. 168-169 (fa-vorevole); Perissa Torrini 1991, p. 22 (favorevole); Anderson 1996,p. 322 (contraria). Va osservato che la testa di Gesù dipende evi-dentemente da un disegno di Verrocchio a Cambridge che è statoportato a confronto da Brown (1987, p. 51) per la Madonna col Bam-bino tra i santi Giuseppe e Simeone di Andrea Solario a Brera, unprodotto veneziano dell’artista lombardo che – al pari di altri rea-lizzati nella sua fase veneta – potrebbe anche far sospettare della suapaternità di questa, purtroppo pasticciata, bella tavola.15 Ballarin 1979. Sulla linea di Ballarin si sono poi posti in partico-lare Perissa Torrini (1991) e Lucco (1995).16 Ben esplicita la posizione subito assunta, nella sintesi finale delconvegno, da Pallucchini (1979, p. 346): “Nonostante il mio dis-senso con il Ballarin sia ampio, mi corre l’obbligo di affermare cheil suo intervento ha prospettato una serie così ampia di problemiche è necessario fin d’ora prenderne atto, aprendo una discussioneche rischia di far vacillare quei punti d’intesa che la moderna sto-riografia aveva cercato di stabilire”. Non di meno, ancora oggi Luc-co (2008, p. 117) ricorda quella comunicazione come “un imprin-ting, un autentico punto di svolta”. Va altresì riconosciuto tuttaviache il banco di prova della ricostruzione di Ballarin che si ebbe nel-la sala II della mostra parigina del 1993 su “Le Siècle de Titien”– aparte l’avallo dello stesso Lucco (1994, pp. 32-33) – ha per lo piùsuscitato diffuse, e spesso aspre, critiche: cfr. Hope 1993; Humfrey
03 Saggio Dal Pozzolo.qxd:CAMMEO GONZAGA 11-11-2009 11:07 Pagina 52