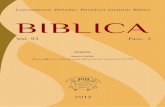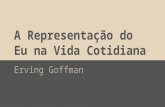EDGAR LEE MASTER, IL TRADITORE DEL VILLAGGIO. Riflessioni su analogie e differenze tra sociologia e...
Transcript of EDGAR LEE MASTER, IL TRADITORE DEL VILLAGGIO. Riflessioni su analogie e differenze tra sociologia e...
EDGAR LEE MASTER,
IL TRADITORE DEL VILLAGGIO
Riflessioni su analogie e differenze tra sociologia e letteratura: Erving Goffman a Spoon River.
RELATORE LAUREANDO
Prof. Fele Giolo Cianci Francesco
1
Indice
INTRODUZIONE ...................................................................pag. 4
CAPITOLO PRIMO
Dall'epigramma greco agli epitaffi di Masters..........................pag. 8
L'antologia di Edgar Lee Masters ......................................... pag. 11
CAPITOLO SECONDO
Spoon River, la sua vita quotidiana come rappresentazione pag. 18
Masters e Goffman ............................................................... pag. 27
Vita di Masters ................................................................... pag. 29
CONCLUSIONI ..................................................................... pag. 34
BIBLIOGRAFIA........................................................................pag. 36
3
INTRODUZIONE
SOCIOLOGIA E LETTERATURA
LETTERATURA E SOCIOLOGIA
Il rapporto tra letteratura e sociologia è da molto tempo oggetto di
discussione e riflessione teorica per chi si occupa di sociologia e di
scienze umane e sociali in genere. Tale campo di studi si è sviluppato,
tra ottocento e novecento, in relazione alla nascita concomitante del
romanzo realista con la sociologia, con quest'ultima che ha dato
diverse interpretazioni della funzione della letteratura. . Tarzia segue
la strada della costruzione teorica sul “come i sociologi utilizzano la
letteratura” delineando un'evoluzione delle concezioni sociologiche e
distinguendo diverse “stagioni” del pensiero sociologico della
letteratura: grandi raggruppamenti di teorie ( e di studiosi) all'interno
dei quali le teorie presenti sono accomunate da un'ottica più o meno
omogenea1. La prospettiva che si sviluppa in Europa attorno a quello
che l'autore chiama il gruppo di Heidelberg all'inizio del novecento,
che vede come esponenti Weber, Simmel, e che deriva da un intento di
ricollocazione teorica rispetto al marxismo ed allo storicismo
positivista. La prospettiva neo-marxista si sviluppa successivamente
da Heidelberg stessa, grazie ai contributi di Lukàcs; all'interno di
questa si possono ricomprendere gli esponenti della scuola di
Francoforte e che, aldilà delle variazioni autoriali (rilevanti in
Benjamin), avrà come fuoco del ragionamento il ruolo della cultura
per il sistema sociale e come appare la società attraverso il
“rispecchiamento” artistico. In questo filone, sono degni di nota e
importanti gli interventi di Benjamin e Watt, figure che si possono
definire interstiziali, a cavallo di diverse prospettive. Il primo,
profondo conoscitore di Freud, introduce, con la sua opera teorica, la
1Fabio Tarzia, I sociologi e lo spazio letterario. Un profilo del novecento. Liguori editore, 2003. Bisogna dire che tale evoluzione non avviene solo su un piano diacronico, ad un determinato periodo storico non corrisponde solo una prospettiva, come si vedrà in seguito. L'evoluzione non è quindi da intendere nel senso cronologico ed hegeliano.
4
possibilità che avvenga una rottura del rigido dualismo struttura-
sovrastruttura proprio della filosofia marxista, tramite il ripensamento
della società che può avvenire proprio grazie all'attività speculativa
che la cultura (quindi la letteratura) opera su di essa. Il secondo, più
weberiano che freudiano, parla sì della possibilità di capire la struttura
sociale grazie alla letteratura, elemento teorico marxista, ma anche di
capire la letteratura partendo da una analisi del sociale.
Fino a questo punto ci si muove quindi sempre su un piano di
distinzione tra la dimensione sociale e quella simbolico-culturale, cui
la letteratura appartiene.
Questi due filoni europei reagiscono, quasi attenuando le loro
differenze, se paragonati al terzo filone presentato da Tarzia. Esso è
costituito dalla sociologia americana, con un percorso teorico che
parte da autori della prima generazione, tra cui spicca George Mead,
ed arriva alla seconda generazione che da vita alla Scuola di Chicago,
con Park, Thomas, Znaniecky, i coniugi Lynd, etc. Già in Mead sono
presenti concetti che aumentano la complessità della concezione
dell'identità individuale e sociale, la teorizzazione del interazionismo
simbolico e quindi la possibilità di un immaginario “lontano dalla
strutturazione binaria marxista”2. Debitrice di questi contributi ma
portatrice di notevoli novità teoriche e metodologiche, la Scuola di
Chicago per la prima volta, intorno agli anni venti, utilizza nello studio
sociologico lo studio sul campo, ricorrendo per la raccolta delle
informazioni della ricerca a materiale documentario diretto (biografia
o auto-biografia) o indiretto (lettere). Znaniecki parla a proposito di
“coefficiente umanistico”3, si tratta di documenti e di elaborati scritti
dai soggetti partecipanti al fenomeno studiato che possono avere anche
contenuto intimo. Questo metodo ha una relazione stretta con l'uso
2 Fabio Tarzia, op. cit., pp. 8-93 Florian Znaniecki, The Social Role of the Man of Knowledge, Harper & Row, 1968. “An observer of cultural life can
understand the data observed only if taken with the ”humanistic coefficient”, only if he does not limit his observation to his own direct experience of the data but reconstructs the experience and the data in the social context of the people involved”
5
della letteratura, espressione massima dell'elaborazione personale, in
sociologia. Questo dato fa capire anche la crescente enfasi nella
letteratura degli studi etnografici sul genere narrativo da adottare per
la stesura del testo della ricerca o sull'approccio narrativo alle
interviste, enfasi che si spiega con la convinzione che sia il
mantenimento delle diverse narrazioni soggettive a costituire la realtà
complessa che si sta studiando. Le diverse pratiche discorsive, le
retoriche e le semantiche soggettive, stabiliscono, all'interno dello
stesso campo sociale, relazioni contrappositive fra di esse che devono
essere ricomposte dallo studioso in un quadro interpretativo unitario e
con una pratica narrativa che sarà egli/ella stesso/a a scegliere4.
Gli studiosi della Scuola di Chicago fanno un ampio ricorso alla
letteratura per la descrizione della realtà urbana, utilizzano non solo i
romanzi urbani contemporanei ma Park utilizzò anche la poesia di
Withman5 (autore peraltro caro a Masters, che di Withman scrisse una
biografia). L'originalità degli studiosi di Chicago sta nella posizione
che i testi letterari assumono nella loro epistemologia: a differenza dei
colleghi europei, essi non credono la letteratura sia un prodotto
simbolico e allegorico che spetta al ricercatore decifrare, al contrario,
credono che “la letteratura è documento, quasi un indagine
sociologica effettuata da un non sociologo tramite l'immaginazione”6.
Altra differenza è che per questi autori la letteratura rappresenta
un'aspirazione al particolare piuttosto che al generale, come invece
sostiene Lukàcs, e che il compito di generalizzare spetta al sociologo.
Tutte queste divergenze possono forse spiegarsi col fatto che diverso è
anche l'”oggetto letteratura” a cui ogni “scuola” si riferisce: il pensare
4 Mariano Longo, Sul racconto in sociologia. Letteratura, senso comune, narrazione sociologica, Nómadas: revista crítica de ciencias sociales y jurídicas, ISSN 1578-6730, Nº. 14, 2006. “Il sociologo, quando svolge consapevolmente il proprio lavoro, giunge a una conoscenza che è valida non perché si assume il compito di rassicurare i soggetti (e nemmeno di scardinarne le certezze), quanto piuttosto perchè utilizza la concettualità della propria disciplina per osservare il mondo da un punto di vista eccentrico. Le fonti narrative [...] vanno anche esse utilizzate non nel rispetto presupposto della rappresentazione che l'attore dà della realtà, ma alla ricerca di interpretazioni sociologicamente coerenti del dato”
5 Fabio Tarzia, op. cit.6 Fabio Tarzia, op. cit., p. 10
6
che la letteratura sia una ed unica annuncia già l'angolatura a-storica
con cui si guarda al fenomeno, trascurando gli aspetti che sono
particolari di ogni contesto. La poesia di Masters o di Withman, o i
romanzi di Fitzgerald o Faulkner, la letteratura americana
contemporanea, non è la stessa che si produce, e su cui il dibattito
intellettuale si sviluppa, in Europa con i romanzi di Kafka, Musil,
Dostoyevsky, e poi Sartre, Camus, effettivamente impregnati di
tematiche intellettuali e filosofiche: insomma, la stessa etichetta di
“letteratura” contiene significati differenti plasmati da campi
intellettuali differenti, di cui anche gli studiosi sono attori.
In questo elaborato si cercherà comunque di evitare, per queste ragioni
, di costruire teorie generali dell'arte e si adotterà una prospettiva
storica allo studio dell'opera scelta. Spero comunque sia utile scegliere
il “particolare” libro di Masters, ”L'Antologia di Spoon River”, caso
forse emblematico della massima convergenza possibile a cui
l'immaginazione sociologica e letteraria possano, parafrasando il titolo
del saggio di Gabriella Turnaturi, arrivare. Per la stessa ragione, aldilà
di questa presentazione della storia delle teorizzazioni sociologiche
della letteratura, non ci si occuperà della costruzione di una teoria
organica, che esula dallo studio “relativizzato”, ossia che concerne
soltanto l'opera in esame ed il suo autore.
7
CAPITOLO PRIMO
DALL'EPIGRAMMA GRECO AGLI EPITAFFI DI MASTERS
L'epigramma nasce nell'Antica Grecia come iscrizione poetica funebre
o dedicatoria: la sua origine viene indicata dal nome stesso il cui etimo
, dal greco ἐπί-γραφὼ, significa letteralmente “scrivere sopra” e
rimanda a quello che è per noi l'epitaffio. Tale forma poetica è
caratterizzata dalla brevità e dalla icasticità della lirica, dal saper
racchiudere in poche parole espressioni definitive che non escludono
sentenza ne consiglio. Queste sono le caratteristiche principali che si
mantengono anche quando, nel periodo ellenistico, l'epigramma viene
adoperato per esprimere argomenti più vari e quindi,
corrispondentemente, mutano e decadono le norme che vincolano il
suo impiego ad un contesto preciso dell'esperienza quotidiana.
A partire dal V sec. a. C., infatti, epigrammi cominciano ad essere
composti da diversi lirici, tragici e anche qualche filosofo: molto
famosi, per la loro forma perfetta, quelli scritti da Platone e Simonide7.
Durante questo periodo gli argomenti trattati diventano molto varii e
quel che riconduce le poesie al genere comune sono la grazia e il
saper chiudere in pochi versi il concetto che si vuole comunicare.
Vengono riportate a tal proposito le parole di Cirillo, poeta, scrittore di
epigrammi, che così scrisse: “Vuoi un epigramma perfetto? Un distico
solo. Se giungi a tre versi, scrivi un poema, non un epigramma”8.
Gli epigrammi composti in età classica giungono ai giorni di Edgar
Lee Masters, ed ai nostri, raccolti in due grandi sillogi, l'Antologia
Planudea e l'Antologia Palatina che classificano le poesie per
argomenti tematici: epigrammi esortativi, dedicatorii,
dimostrativi,erotici, conviviali e sepolcrali.
7 Carlo Del Grande, Storia della Letteratura Greca, Loffredo- Napoli, 19758 Ibidem pag. 274
8
Le storie delle due sillogi sono differenti. La prima, la Antologia
Planudea, è il risultato di uno sviluppo lineare, fatto di ripubblicazioni
e di integrazioni di epigrammi mancanti nei volumi precedenti, una
sorta di “opera collettiva” nata dalla “collaborazione” di diversi
letterati appartenenti a diverse epoche, da Meleagro di Gàdara (III sec.
a. C.) a Costantino Cèfala che ne riordinò il materiale intorno al X
sec. d. C., fino a Massimo Planude che, nel XIV secolo, diede la
definitiva sistematizzazione alla raccolta che ne prese anche il nome.
La Antologia Palatina è il nome che prese un manoscritto, considerato
una revisione dell'Antologia di Cèfala, trovato nella Biblioteca
Palatina di Heidelberg; in questo manoscritto erano presenti poesie
che non si trovavano nell'altra raccolta, dal contenuto erotico e
amoroso, elemento che aveva fatto optare il monaco Planude per un
esclusione di questi testi dalla propria antologia.
La prima stampa completa di questa Antologia, più fedele e più
completa della Planudea, avviene nel 1776 e si può immaginare la
curiosità che suscitò in tutti i giovani interessati di poesia e letteratura
quella raccolta di 3400 poesie che, spaziando dall'erotismo, alla
morte , alla morale, toccavano tutti i problemi della vita e dell'uomo
vissuti in un epoca storica remota. Edgar Lee Masters la lesse nel
1913, dietro consiglio dell'amico, e direttore del giornale Reedy's
Mirrors, William Marion Reedy e, anche se non più giovanissimo, ne
restò molto affascinato e coinvolto. William Marion Reedy sarà, poi,
la persona che inviterà Masters a scrivere e pubblicare periodicamente
sul Reedy's Mirrors gli epitaffi che, raccolti, costituiranno la sua
nuova Antologia: l'Antologia di Spoon River. E' chiara che la volontà
dell'autore, attraverso l'escamotage dell'imitazione del titolo delle
Antologie classiche, è di richiamare provocatoriamente il/la lettore/ice
alla vigilanza circa le analogie e le differenze tra le opere classiche e
la sua. Queste ultime sono sia fonte di ispirazione da onorare quasi
con soggezione, cercando di imitarne la perfezione del linguaggio, la
9
grazia lirica, sia strumenti per la polemica sociale con il mondo e il
“cittadino medio” contemporanei. Questo si può desumere da diversi
elementi. La decisione innovativa di sfidare la rigida divisione
tassonomica della poesia epigrammatica delle Antologie9 creando
degli epigrammi funerari in cui si trattassero tutte le materie della vita
contemporanea: della quotidianità, dell'amore, del denaro, del
conformismo. La stessa scelta dei contenuti ed il modo di trattarli
letterariamente lasciano intravedere l'intento provocatorio dell'autore.
Così, da un lato egli apre alla prosaicità di temi che non compaiono
negli epigrammi greci: l'odio e il rancore nei confronti dei vivi da
parte dell'io parlante defunto, la mancanza di rimpianti al momento
della morte del vizioso e ubriacone del villaggio; dall'altro, riporta
degli eventi concreti e dolorosi della comunità di Spoon River, o di
suoi attori o gruppi, non per mezzo di metafore distaccate, dal tono
filosofico/moralistico e rassicurante, decontestualizzanti e de-
storicizzanti, proprie degli epigrammi classici, ma nel modo in cui il
soggetto farebbe nella pratica, nel linguaggio e nella forma che la
situazione sociale concreta ha plasmati in esso.
In sostanza, Masters costruisce una dialettica tra le immagini dei
mondi umani e sociali che evocano da un lato le antologie greche e
dall'altro l'Antologia di Spoon River, con le prime che proiettano un
mondo senza censure, una umanità libera che non pone limitazioni alle
esperienze esistenziali su cui far poesia, la seconda che ritrae un
umanità schiava del conformismo, in fuga dalla libertà ed
immoralmente moralistica.
9 Si è già detto che l'Antologia di Cèfala distingueva tgli epigrammi in: epigrammi cristiani, epigrammi ciziceni, epigrammi erotici, epigrammi sepolcrali, epigrammi epidittici, epigrammi morali o esortatorii, epigrammi conviviali o satirici, epigrammi in metri vari. [ Carlo Del Grande, 1975, pag.274]. In realtà la classificazione per materia non è stata che adottata dai letterati bizantini (tra cui lo stesso Cèfala) nel X sec. Le raccolte realizzate in epoca greca da Meleagro in poi , ragruppava le poesie in Corone, come se ogni poesia fosse un fiore.[ Antologia Palatina/ Scelta e traduzione di Salvatore Quasimodo, Arnoldo Mondadori Editore, 1992, pag. 8]. In quest'ottica la scelta di Masters è quasi un ritorno, non sappiamo se consapevole o meno, alle origini.
10
L'ANTOLOGIA DI E. L. MASTERS
L'antologia di Spoon River è una raccolta di poesie in forma di epitaffi
pubblicati, dapprima, sul giornale “Reedy's Mirror” di St. Louis tra il
1914 e il 1915 e, nell'aprile del 1915, raccolti in un libro col titolo che
ha reso l'opera famosa. L'opera suscitò grande clamore in America , il
che contribuì al suo grande successo negli anni successivi alla sua
uscita, e fu tradotta in molte lingue, tra cui l'italiano.
Un caso di particolare successo fuori patria riguarda proprio l'Italia,
dove la fama del poeta degli epitaffi si diffuse singolarmente
raggiungendo quasi quella ottenuta negli Stati Uniti. Vale la pena
riportare le vicende della pubblicazione in Italia visto che di quella
vicenda sono protagonisti dei personaggi importanti per la letteratura
italiana del novecento10. Il libro “Spoon River Anthology” viene
regalato nel 1943 da Cesare Pavese, allora docente di Letteratura
Inglese e Americana e pressoché sconosciuto come scrittore, alla
“sua” studentessa Fernanda Pivano che comincia a tradurlo, all'inizio
per diletto; quando Pavese trova i manoscritti in italiano dell'opera di
Masters, spinge subito per pubblicare il libro completo delle poesie: in
un primo momento, il libro subisce la censura del regime fascista,
dopo, grazie all'escamotage di chiamarlo semplicemente “S. River” e
di spacciarlo per una agiografia di un fantomatico Saint River inglese,
viene pubblicato. Il motivo per cui l'opera viene censurata è lo stesso
per cui è così discussa in America e bene lo esprime la stessa Fernanda
Pivano: - “era superproibito quel libro in Italia. Parlava della pace,
contro la guerra, contro il capitalismo, contro in generale tutta la carica
del convenzionalismo. Era tutto quello che il governo non ci
permetteva di pensare [...], e mi hanno messo in prigione e sono molto
contenta di averlo fatto”11. Sarebbe interessante indagare il fatto che la
10 Le vicende qui riportate sono narrate con dovizia di particolari nell'autobiografia, ricostruita dalle pagine di diario, di Fernanda Pivano. - Enrico Rotelli, Mariarosa Bricchi (a cura di), FERNANDA PIVANO, DIARI [1917.1973],
11 Intervista rilasciata da Fernanda Pivano alla trasmissione “La Storia siamo Noi”, RaiTre, 25 febbraio 2008
11
fama de L'Antologia di Spoon River è quasi scomparsa in tutti i paesi
in cui è stata tradotta tranne che in Italia, dove ebbe maggior fortuna
per il “favore” del gruppo di intellettuali anti-fascisti di Torino (i già
citati Pavese e Pivano e inoltre Vittorini, Bobbio, Einaudi, Leone e
Natalia Ginzburg, Calvino, Primo Levi), e quali sono i rapporti di
influenza tra la letteratura americana, civile e realista, del primo '900
(si pensi ad Hemingway ed agli autori già citati) e quella italiana del
secondo dopo-guerra, di cui molti di quegli autori furono
protagonisti.12
Per quanto esuli dal tema trattato, un po' di suggestioni sparse si
possono dare in forma di domande. Chicago e Torino sono le città
industriali che incarnano la velocità della modernizzazione socio-
economica nei rispettivi paesi; puntualizzando le dovute differenze e
analogie (modello industriale con grande concentrazione di capitale
fisico; elevata immigrazione) si può dire che la Torino degli anni
'30/40 italiani, è, funzionalisticamente, la Chicago degli anni a cavallo
tra '800 e '900 negli Usa? Sul versante della “sociologia dell
soggettività artistica”, è possibile che il contesto della borghesia
intellettuale, che accomuna Masters con gli intellettuali italiani citati,
dia la possibilità (compiuta) di una critica che si basa sul vedere le
“virtù pubbliche e i vizi privati” degli strati socialmente e
capitalisticamente dominanti? Che le scelte critiche di alcuni, di
militanza apertamente anticapitalistica nella maggiorparte dei casi,
maturino da questo intreccio di visuale situata, capacità
intellettuale/simbolica elevata, e carica di indignazione giovanile che
si lega a momenti sociali conflittuali13? Sarebbe interessante indagare
1213 Chicago era il centro dell'attività degli IWW, il potente sindacato rivoluzionario americano: inoltre sono di Chicago
i morti del 1886, durante una giornata di sciopero operaio che ha dato al mondo del lavoro la giornata simbolo della loro lotta. Torino è al centro dell'attività antifascista e dell'insurrezione: in Piemonte sono state fondate molte Libere Repubbliche partigiane. Sia nel primo che nel secondo caso l'atmosfera elettrica della lotta si diffonde a tutta la società e in specie agli ambienti intellettuali socialmente più aperti, come dimostra il caso di Italo Calvino partigiano; nel caso di Masters, sia lui che il padre, che hanno condiviso la professione forense, hanno difeso militanti anarchici e rivoluzionari, “quando questo significava coraggio”, per utilizzare le parole di un'intervista rilasciata da De Andrè a Fernanda Pivano.
12
a partire da queste domande ma, appunto, esula dall'economia e dagli
obiettivi del testo.
Tornando all'Antologia di Masters, nelle prossime pagine si cercherà
di cogliere il punto di vista dell'autore sulla società, mettere in luce i
contenuti di critica sociale dell'opera e cioè i motivi per cui l'autore fu
emarginato e stigmatizzato da quelle comunità da egli mise a nudo,
come egli stesso dice nella sua biografia e come risulta dalle lettere
scritte ad amici e parenti14.
Il motivo principale del malcontento è stato la scelta (ingenua?) del
poeta di raccontare storie che riguardavano persone ancora in vita e
avvenimenti allora recenti che presumibilmente gli interessati
cercavano di mantenere segreti.
L'opera è composta da duecentoquarantaquattro epitaffi; i personaggi
citati e trattati sono duecentoquarantotto; alcuni fatti narrati negli
epitaffi si intrecciano tra loro creando diciannove storie all'interno
della raccolta15. Una simile opera, piuttosto che tramite la polifonia di
voci dei tanti io parlanti degli epitaffi, avrebbe potuto essere realizzata
più agevolmente (per l'autore) tramite la forma-romanzo che, con
l'utilizzo della narrazione onnisciente, avrebbe fatto superare la
disgregazione narrativa. Sia che questo dato sia stata dettato da motivi
contingenti e casuali (la pubblicazione periodica sull'inserto di un
giornale è più compatibile con la produzione di poesie), sia che sia
stato invece una scelta consapevole, rende questa opera ancora più
interessante per il fatto che, mentre si è riflettuto molto in sociologia
sul rapporto tra narrazione della realtà nel romanzo e interpretazione
sociologica della realtà, poco si è scandagliato l'orizzonte della poesia
e le peculiarità di conoscenza sociale che è possibile ricavare rispetto
alle altre forme letterarie.
14 E. L. Masters, Across Spoon River, An Autobiography, Prairie State Books, 1990 Herbert K. Russell,Edgar Lee Masters: a biography, Univerity of Illinois Press, 2005
15 E. L. Masters, Across Spoon River, An Autobiography, Prairie State Books, 1990 Fernanda Pivano, Intervista immaginaria ad E.L. Masters, 1971
13
Il lettore che abbia finito di leggere l'Antologia si domanda subito se
Spoon River sia un villaggio esistente della provincia americana, quali
siano i riferimenti reali del libro e quali quelli inventati, come si
colleghino le storie presentate con la vita dell'autore e così via.
Spoon River, come ammetterà l'autore nella sua autobiografia, è un
luogo che non esiste nella realtà, quanto meno con questo nome.
Masters, quando matura la scelta di scriverlo, vive e lavora a Chicago
da diversi anni, e nelle poesie rievoca il periodo vissuto a Petersburg e,
soprattutto, a Lewistown, sul fiume Spoon. Poco tempo prima la
pubblicazione, gli era stata regalata dall'amico William Marion Reedy
l'Antologia Palatina ed un incontro con la madre gli fa tornare in
mente l'infanzia e l'adolescenza passata tra casa dei nonni, a
Petersburg, e Lewistown: questa la situazione in cui decide di
cominciare a scrivere. Quelle che scrive sono esperienze e storie,
alcune inventate, altre realmente accadute e ricordate, unificate
dall'intelligenza dello scrittore-osservatore che ha la capacità di vedere
le comuni regole dell'interazione sociale di contesti in apparenza
completamente diversi, come quelli della città, in cui vive (e osserva la
società) quando sta scrivendo, e quelli del villaggio di provincia in cui,
soprattutto durante l'adolescenza a Lewistown, è avvenuta la genesi
del suo “sguardo sociale”: “mi venne quasi subito l'idea: perché non
fare così il libro che avevo immaginato nel 1906, in cui volevo
rappresentare il macrocosmo descrivendo il microcosmo?”16. L'autore
crea un cosmo sociale fittivo con il fine di far specchiare il cittadino
moderno, metropolitano e colto, che legge il suo libro sull'immagine
del cosmo di uomini che recitano i loro epigrammi e da cui, allo stesso
tempo, sono raccontati. Questo mondo viene delineato con una
sensibilità ed una capacità di interpretare fenomeni complessi che si
16 Fernanda Pivano, Intervista immaginaria ad E.L. Masters, 1971. Utilizzo questa intervista immaginaria, perché costruita dall'autrice grazie alla lettura dell'auto-biografia di Masters ed a interviste agli abitanti di Petersburg e Lewistown realizzate nel 1956, quando l'autore era morto. Per queste ragioni penso sia comunque utilizzabile come fonte. E. L. Masters, Across Spoon River. An Autobiography, Prairie State Books, 1990, p. 339. L'espressione contenuta è la seguente: “...my purpose was to draw the macrocosm by portraying the microcosm.”
14
possono definire sociologiche, seppure inconsapevolmente.
Quello che accomuna tutte le figure rappresentate è la condivisa sorte
della morte , vista come la chiusura del sipario sulla vita; quest'ultima
invece vista (dal retroscena della morte) come continua pressione
esterna sull'individuo e sulla sua libertà. In effetti, la maggior parte dei
personaggi esce sconfitta da questa tendenza al controllo, da questa
forza antagonista della libertà, ma non tutti hanno le stesse rimostranze
e le stesse frustrazioni, oltre al fatto che alcuni outsider si sono posti
totalmente al di fuori del paradigma imposto (è il caso, ad esempio, di
“Jones il violinista”). Questa voglia di controllo e il continuo sentirsi
giudicati rappresentano la dimensione psicologica di fenomeni che
avvengono socialmente. La dimensione sociale, su cui, per quanto
riguarda l'analisi di quest'opera, troppo poco ci si è soffermati, si
sostanzia nel fatto che tutti gli individui denunciano le stesse pressioni,
si sentono braccati dal potere del controllo sociale della comunità di
cui fanno parte. In realtà, nella pratica dei discorsi dei “cittadini” di
Spoon River, è chiaro come la sfera soggetivo-psicologica e quella
oggettiva- sociale non siano distinguibili, essendo entrambe chiamate
in causa e poste in relazione dai soggetti stessi: lo evidenzierò in
seguito analizzando alcuni componimenti particolarmente eloquenti da
questo punto di vista.
In quest'ottica Masters fa un ritratto della pratica dell'azione sociale
molto consonante con la teoria della pratica di Bourdieu e con lo
schema concettuale dello strutturalismo genetico17. Questa prospettiva
della sociologia dell'arte, che vede come esponenti Goldmann e
Bourdieu, assume come fondamento di ogni studio sulle opere
culturali un approccio che sia al contempo storico e sociologico e che
si studi non solo il contesto di ricezione dell'opera ma anche quello di
17 Lucièn Goldmann, Genetic Structuralism in Sociology of Literature in Sociology of Literature & Drama (a cura di Elizabeth e Tom Burns, Penguin Edition, 1973. Pierre Bourdieu, Le regole dell'arte. Genesi e strutture del campo letterario, Il Saggiatore, 2005. A proposito del concetto di pratica, di conoscenza implicita e di teoria della pratica v. anche: Pierre Bourdieu, Per una teoria della pratica. Con tre studi di etnologia cabila, Raffaello Cortina Editore, 2003.
15
produzione18.
Questa prospettiva comporta l'analisi della relazione tra il contesto
sociale19 e il suo autore e guardare all'opera come un prodotto di
questa interazione. Vedere l'opera come prodotto particolare della
traiettoria sociale in cui la conoscenza in essa contenuta rappresenta,
in questo caso particolare, al contempo, la messa in opera della
conoscenza situata associata alla posizione occupata da lui e
l'elaborazione intellettuale sulla logica delle interazioni quotidiane.
Inoltre, l'operazione culturale deliberata di questa antologia è di
mischiare elementi reali e elementi inventati, seppure realistici, per
lasciare una teoria- pamphlet, un'analisi ed un messaggio critico in un
opera che unifica questi elementi. Eppure, oltre al contenuto che si
riferisce all'esperienza particolare della vita dell'autore nella provincia
americana, quest'opera è partecipata altresì dalla vita della metropoli
Chicago, dalle interazioni fuggenti ed epidermiche che nella moderna
metropoli avvengono; quindi, per quanto lo schema con cui Masters
legge la società aveva gettato i suoi semi a Lewistown, è
nell'esperienza a Chicago che esso si struttura: la stessa città che vedrà
nascere, dieci anni più tardi, uno dei gruppi di ricerca e teoria
sociologica più importanti per la storia della sociologi e, trent'anni
dopo, vedrà operare il sociologo Erving Goffman.
Tornando a Lewistown, lo sguardo dell'”attore” Masters, per quanto
critico, si è costruito in reazione alle relazioni, ai valori promossi, alle
visioni della vita di quella piccola società; il suo è uno sguardo situato
ma interno ed è per questo che dopo la pubblicazione e diffusione
dell'Antologia egli ha subìto l'ostracismo dalla “comunità”. Tuttavia, il
18 Goldmann arriva anche a teorizzare l'impossibilità di distinguere i due approcci di studio. Lucièn Goldmann, op. cit. pp. 109-110.
19 Si è detto che le storie riportate sono un amalgama di storie inventate e reali avvenute tra Petersburg e Lewistown. Tuttavia, l'autore dà molta più importanza all'esperienza sociale ed esistenziale vissuta a Lewistown nel determinare le sue disposizioni ed il suo orientamento sociale e politico: è a Lewistown durante l'adolescenza, essa gli sembra un città in miniatura, qui comincia a partecipare della vita “da grande”, a maturare un suo proprio sguardo e ad immergersi nella lettura. E' Lewistown, quindi, il luogo cui ci se riferirà quando si parlerà astrattamente di “contesto sociale”.
16
“trauma” della rottura della pace sociale che la comunità, con
quest'atto, denuncia di aver subito, è dovuto sì al discredito che lo
scrittore ha gettato (senza troppe remore) su quel modello di società
ma anche a fattori esterni e, in un certo senso, superiori. Il fenomeno
della mobilità geografica e sociale che ha reso possibile l'incontro di
Masters con le località sul fiume Spoon, è il sintomo di un
cambiamento che è già avvenuto sia nelle strutture di possibilità
economiche della società sia nella mentalità- e i cambiamenti in essa
riflettono i cambiamenti delle prime-, almeno dello strato sociale cui la
famiglia Masters appartiene. Come vedremo meglio nella parte in cui
ci si soffermerà brevemente sulla vita dell'autore, la scelta di trasferirsi
a Lewistown e , in generale, l'infanzia e adolescenza nomade di
Masters, sono dettati dall'agire da homo oeconomicus del padre
avvocato; le considerazioni alla base degli spostamenti da un villaggio
più piccolo (Petersburg) ad uno più grande (Lewistown), sono
considerazioni che ineriscono le possibilità di inserimento lavorativo
in un mercato più “fertile”, ossia con più domanda e meno offerta del
bene “assistenza forense”, di quello da cui si parte. E' chiaro che la
costruzione di una simile ottica, tipica degli attori in una economia di
tipo capitalistico, rimanda ad un fenomeno molto più globale, lo
strutturarsi appunto del capitalismo, che esula dalla località di
Lewistown o Petersburg; ed è chiaro, anche, come corrispondano a
questo sistema economico una serie di valori culturali e di dinamiche
psicologiche che si estrinsecano, tra le altre cose, nel fatto che la
appartenenza territoriale, a differenza delle società tradizionali e
omogenee al proprio interno, non è più l'unica fonte di identità e
nemmeno la più forte. In questa prospettiva, il libro in questione non
sarebbe stato realizzabile da una persona che, vivendo tutte le sue
relazioni in una città e non avendo speranza di spostarsi, si trova in
una totale dipendenza individuale dalle relazioni materiali e
immateriali che intrattiene con la società cittadina. Io ritengo che il
punto di vista dell'autore, al contempo interno ed esterno, abbia tra le
17
sue cause anche i cambiamenti strutturali della società americana che
agiscono all'interno delle città della provincia. Tali elementi di
cambiamento, che vanno nel senso di una maggiore complessità della
realtà sociale, della comparsa di identità individuali e collettive che
infrangono la monoliticità voluta dalla società puritana, sono già
presenti prima della pubblicazione de L'Antologia: lo “scandalo”
associato alla sua uscita è dovuto al fatto che esplicitamente viene
proiettata nella sfera pubblica l'immagine di una società conflittuale e
disgregata, quanto meschina e ripiegata su sé stessa. Per tutti questi
motivi, l'idea di una reazione compattamente ostracistica della società
cittadina nei confronti di Masters per la critica sociale contenuta ne
L'Antologia si fonderebbe, innanzitutto, sull'incapacità di questa di
leggere il contenuto non locale della denuncia e, in secondo luogo,
dovrebbe implicare una omogeneità sociale che non c'è più: basti
pensare che anche le reazioni in seno alla famiglia del poeta sono state
discordanti, essendo, l'opera, piaciuta molto al padre e poco alla
madre. A proposito del contenuto non locale della denuncia, si è già
detto che la natura “comparativa” delle riflessioni da cui scaturisce
L'Antologia è chiaramente enunciata nella autobiografia di Masters,
l'oggetto dell'argomentazione del presente elaborato è che la posizione
“sociologica” di Masters presenta molto analogie, non esplicitate, con
la teoria teatrale dell'inter-azione sociale di Erving Goffman.
Quest'ultimo è sicuramente più attento alle dimensioni empiriche delle
sue argomentazioni, in numerosi passaggi de La vita quotidiana come
rappresentazione specifica che la sua analisi è adatta a spiegare i
contesti anglo-americani, forse per eccesso di relativizzazione, visto
che in questi contesti ha condotto le sue osservazioni; Masters non si è
mai posto il problema di circostanziare i confini sociali della
leggibilità del suo libro, proprio per la differenza di statuto del campo
letterario da quello scientifico. Tuttavia, se si considera l'affermazione
dell'organizzazione capitalistica della vita sociale l'elemento
consustanziale e determinante le caratteristiche delle teorie sociali dei
18
due autori, si possono dare le società anglo-americane come contesti di
riferimento anche dell'opera di Master, essendo le più progredite, da
questo punto di vista, all'epoca in cui scrivono entrambi20. Nell'ottica
di accostare le figure di Masters e Goffman, può essere utile rilevare la
complementarità delle scelte dei campi simbolici in cui ognuno ha
espresso le proprie posizioni. A proposito dello scrittore Masters, egli
non ha mai nascosto il suo schieramento politico democratico,
-testimoniato anche dalle autobiografie dedicate a Whitman, a
Lincoln,- e umanistico-radicale; sono state invece poco evidenziate le
posizioni sociologiche connesse alla sua posizione politica. Goffman,
d'altro canto, si è sempre e solo “espresso” tramite le sue ricerche e la
capacità, giustamente elogiata, di costruire, partendo da queste,
modelli teorici interpretativi della realtà sociale caratterizzati da una
versatilità che li rende applicabili a qualsiasi contesto; tuttavia, “[...] a
causa di questo commitment scientifico, oltre che per la sua naturale
antipatia per gli slogan e per le facili prese di posizione, ha sempre
evitato di schierarsi politicamente.”21 Nel prossimo paragrafo, si
cercherà di esplicitare i rispettivi contenuti tenuti in ombra dei due
autori.
20 C'è una differenza notevole nella diffusione internazionale dei due libri. Per quanto riguarda il libro di Masters, si è già detto del suo limitato impatto di traduzione e di diffusione , fatta eccezione per l'Italia, in Europa: esso può essere dovuto al fatto che in Europa si combatteva una guerra per cui è presumibile che le energie dei campi intellettuali di questi paesi erano tutte assorbite dal conflitto bellico e da problemi “interni”. Per quanto riguarda il saggio di Goffman, esso fu tradotto in tutte le lingue dei paesi europei e si diffuse molto fin da subito , il che conferma l'omologia dei contesti europei di ricezione e di quello americano di produzione nel momento in cui la guerra è finita ed il modello capitalistico di produzione e consumo unito a valori liberal-democratici si sono affermati anche in Europa.
21 Pier Paolo Gilgioli, Introduzione all'edizione italiana de La vita quotidiana come rappresentazione, Il Mulino, 1969, p. XII.
19
CAPITOLO SECONDO
SPOON RIVER
La sua vita quotidiana come rappresentazione
Il tentativo di far emergere dal (iper)testo in questione un contenuto di
tipo sociologico, implica che ci sia una sorta di sotto-testo: un
contenuto non immediato, da ricostruire, quindi, mediatamente.
Questa metodo sarà utilizzato per mettere in luce le analogie dei sotto-
testi delle poesie di Spoon River con lo schema concettuale di
Goffman sull'interazione quotidiana. Utilizzerò questo metodo anche a
proposito dell'opera di Goffman, La vita quotidiana come
rappresentazione. Se è vero quello che dice Pier Paolo Giglioli a
proposito di Goffman che era dotato de“la grazia e l'ironia dello stile,
la straordinaria acutezza e precisione descrittiva nel cogliere la
complessità del sociale in atti minimi della vita quotidiana fino ad
allora trascurati dalla sociologia, la voluta irriverenza con cui,
sfidando le tradizionali gerarchie intellettuali, sono accostate nella
stessa pagina citazioni colte, riferimenti a manuali di etichetta e curiosi
ritagli di giornali”, è perché il sociologo canadese era ben cosciente
dell'effetto tipicamente letterario, di incuriosimento del lettore tramite
lo shadowing dell'autore, dell'utilizzo di questi artifici; e competente
nel loro utilizzo. Insomma, lo stile, eretico per un sociologo ma non
per uno “scrittore”, di osservazione e tessitura dei testi di Goffman
concede un'analisi del contenuto dei suoi testi.
La prima analogia che può essere rilevata riguarda proprio il self dei
soggetti narranti; questi sono infatti soggetti, si rappresentano come
tali in forza delle frizioni con quello che è diverso da sé: di volta in
volta il marito, la famiglia, la città: le istituzioni, che di volta in volta
si rintracciano come ostacoli alla affermazione del sé. Questa analogia
20
è in forte relazione con le affermazioni di Goffman circa la divinità
dell'individualità come tratto caratterizzante, e socialmente
determinato, la vita moderna22. Eppure, lo stesso Goffman sa quanto
l'idea del self come espressione dell'individuo sia ingannevole23 e lo
schema della contrapposizione dell'antico col moderno inganna
facendo credere ad una discontinuità: la dialettica dell'uomo moderno
liberato contro quello pre-moderno schiavo della società in cui vive.
Questa dialettica è fallace perché omette la dimensione del self come
parte determinata socialmente e funzione della routine che si sta
inscenando. Il libro di Goffman serve, quindi, a mostrare come
centinaia di situazioni diverse siano isomorfe da un punto di vista
sociologico e accomunate culturalmente dalla costruzione sociale della
selficità come categoria teatrale e prodotto della rappresentazione.
Utilizzo la categoria di selficità per distinguerla da individualità, anche
se l'autore statunitense usava ora una ora l'altra senza troppe
differenze. In realtà a me sembra di dovere distinguerle per non
confondere troppo la vita, come insieme di possibilità ed energie
contemplate e non contemplate al momento dell'azione, con
l'immagine necessariamente semplificata e reificata che ne dà la
scienza sociale per servirsene nella propria gnoseologia. Per lo stesso
motivo per cui non sono identica cosa azione e comportamento (che
rappresenta, al più, il lascito esterno visibile dell'azione), e solo di
quest'ultimo un'osservazione esterna può servirsi, l'individualità è a
mio avviso la forza vitale che, cristallizzata e formalizzata, produce
selficità.
Nelle città piccole, come quelle che si nascondono dietro il nome di
Spoon River, le routine da rappresentare sono relativamente poche ma,
22 Erving Goffman, Modelli di interazione, New York, 1967.pp. 99-104 “E' quindi importante notare come il sé sia parte di un oggetto cerimoniale, qualcosa di sacro che deve essere trattato con la dovuta attenzione rituale e che, a sua volta, deve essere presentato agli altri nella sua giusta luce.[...] Ci siamo sbarazzati di molti dei, ma l'individuo rimane ostinatamente una divinità di notevole importanza”
23 Erving Goffman, La vita quotidiana come rappresentazione, p.289. “Una scena ben congegnata e rappresentata induce il pubblico ad attribuire un sé a un personaggio rappresentato, ma ciò che viene attribuito- il sé- è il prodotto di una scena che viene rappresentata e non una sua causa.”
21
non di meno, incentrate sulla presentazione del self come modalità di
regolazione sociale.
Di seguito, riporto degli epigrammi utili a farci capire cosa prevede il
copione per alcuni attori parlanti, quali siano le aspettative e, quindi, i
ruoli, quale la posizione dell'autore sui fatti che racconta. Tutte le
storie raccontate sono piuttosto eccentriche; questo è dovuto al fatto
che sono state raccolte da quel tipo di narrazione e forma di controllo
propria del paese che è il pettegolezzo: fenomeno che si nutre di
situazioni che deviano dalla norma.
Constance Hately
Tu lodi la mia abnegazione, Spoon River,perché ho cresciuto Irene e Mary,orfane della mia sorella più grande!E biasimi Irene e Mary per il loro disprezzo per me!Ma non lodare la mia abnegazionee non biasimare il loro disprezzo:io le ho cresciute, mi sono curata di loro, è vero!-ma ho avvelenato le mie buone azionirinfacciandogli sempre che mi erano di peso!
La signora Pantier
Lo so, che diceva che gli avevo catturato l'anima/ con un laccio che lo
dissanguò a morte./ E tutti gli uomini lo amavano, e tante donne lo
compiangevano./ Ma immaginate di essere una vera signora, e di
gusti delicati,/ e che vi nausei l'odore di whisky e di cipolla,/ e che il
ritmo dell' Ode di Wordsworth vi mormori all'orecchio,/ mentre lui da
mattina a sera va in giro a ripetere banalità del genere: “Oh perché si
inorgoglisce lo spirito mortale?” [...] Per questo lo cacciai di casa/ a
vivere col cane/ nel retro del suo ufficio.
Aner Clute Tante volte mi chiedevano/ mentre mi offrivano vino o birra,/ prima a Peoria e poi a Chicago,/ Denver, Frisco, New York, dappertutto,/ perchè facessi la vita/ e come avevo cominciato./ Beh, dicevo, un abito di seta/ e l'offerta di matrimonio di un ricco-/ (era Lucius Atherton)./ Ma non era vero niente./ Mettiamo che un ragazzo rubi una mela/ dalla cassetta sul banco del droghiere,/ e tutti comincino a dirgli ladro,/ il giornalista, il prete, il giudice, tutti quanti-/ “ladro”, “ladro”, “ladro”, dovunque vada. E non trova lavoro, e non mangia/ se non ruba, allora il ragazzo ruba./ E' come la gente vede il furto della mela/ che fa il ragazzo ladro.
La prima, e fondamentale, cosa da rilevare è la personalità che
emerge, sorta di rivincita del disordine sull'ordine, che emerge in
relazione al ruolo, sorta, invece, di effetto di un meccanismo
eteronomo e autoritario di assegnazione delle identità. La doppiezza di
tutti i personaggi, allo stesso tempo vittime e carnefici del gioco
sociale, a cui non riescono a sottrarsi, che impone la differenziazione
tra ribalta e retroscena e le regole dello spettacolo.
La più elementare assegnazione di ruolo a Spoon River deriva dal
genere cui si appartiene, come si può dedurre da queste poesie, con la
22
netta penalizzazione delle donne: in tutte le poesie, il genere dello
individuo, predetermina i piani dell'azione sociale esperibile, se si è
donna si può essere brava o cattiva moglie (madre, nutrice, zia, ecc.)
ed il “campo del giudizio” non riguarda quasi mai l'azione sociale
pubblica; un caso a parte riguarda le prostitute, in questo caso Aner
Clute, donne in stato di eccezione, come per tutte le società, per cui
l'ascrizione di genere non esiste più.
Nella prima storia, alla donna spetta il dovere di accudire (o meglio,
far apparire questo dovere come assolto) le nipoti a causa della morte
della loro mamma, sua sorella; questo dovere è socialmente prescritto
da norme non scritte, alla donna, dall'intera comunità a cui si rivolge:
quella “Spoon River” troppo severa con le nipoti e indulgente con lei.
Si vede inoltre la doppiezza del personaggio che appare come il
ritratto della perfetta donna davanti al paese giudicante, la persona che
coincide col personaggio sociale che si caratterizza in rapporto alla
“abnegazione” nei confronti della famiglia ma, nel rapporto con le
nipoti, al chiuso delle mura domestiche, è dura ed astiosa. La seconda
poesia, che si pensa sia di ispirazione profondamente autobiografica24,
rivela lo scorcio di un conflitto coniugale dovuto al conflitto sociale
tra gli ambienti di provenienza: la donna sembra estranea al contesto
cittadino e per questo capace (o ignorante delle conseguenze) di una
scelta, quella di cacciare il marito di casa, tanto biasimata da
costringerla a distanza di anni ad una auto sconfessione di quell'azione
(capita la “gravità” della propria colpa). Quel”immaginate di essere
una vera signora[...]” fa capire lo sforzo che necessita la
comprensione, quasi in senso weberiano, dell'azione compiuta e, di
converso, lo spirito reazionario con cui si sanzionano a Spoon River le
“piccole ribellioni” delle minoranze25. L'ultimo dei tre epitaffi riportati
24 Masters. Vita, Poetica, Opere Scelte , Il Sole 24 ore, 2005. La madre di Masters era un'amante della letteratura e donna raffinata come la signora Pantier, il padre un avvocato con scarso capitale culturale, come Benjamin Pantier. Anche il rapporto conflittuale tra i due era un dato di fatto, testimoniato dallo stesso Masters nella sua autobiografia.
25 In questo caso si tratterebbe di una doppia minoranza: sia perché donna, sia perché forestiera. La madre di Masters ha anche questo elemento in comune con la signora Paintier
23
è utile a capire come l'essere una prostituta possa portare ad una
“uscita di ruolo-genere” per cui ci si può trovare gomito a gomito con
gli uomini (maschi) a bere al bancone, come in un gruppo dei pari;
inoltre, è interessante vedere come non si tratti solo della liberazione
dall'obbligo della rappresentazione del ruolo, ma della creazione di un
ruolo nuovo che debba rappresentare la versione ribaltata della donna
puritana virtuosa: in questa poesia, infatti, ella mette in luce quei
valori edonistici (quando parla dell'abito di seta) con cui la società
ufficiale caratterizza l'immagine stereotipica della prostituta, una
figura che “naturalmente” tende all'idea di male, rovesciamento
dell'idea di bene che vuole la donna tutta sacrifici ed attenzioni verso
gli altri (come visto nel primo caso). In questo caso infatti, le stesse
regole di rappresentazione del personaggio che costringono le prime
due donne ad apparire come brava zia o moglie, qui agiscono nella
direzione opposta: la persona- prostituta deve degradarsi per essere
coerente coll'immagine del ruolo che ricopre. E' solo quando è liberata
dal giogo sociale che dice quello che pensa veramente sul “come
aveva cominciato la vita” e, nel farglielo esprimere, Masters rivela la
capacità di mettere in relazione scelte individuali e fenomeni sociali,
contingenza e potere- nel doppio senso di capacità di perpetuazione
della contingenza e soggetto/i sociali in carne ed ossa. E' la stessa
società ufficiale (“il giornalista, il prete, il giudice”), che
etichettando arbitrariamente ed emarginando i soggetti etichettati, crea
le condizioni della “professionalizzazione” del presunto deviante (“E'
come la gente vede il furto della mela che il ragazzo ladro”).
Troviamo, ed è questa la cosa sorprendente, in questo passaggio
un'anticipazione letteraria del cosiddetto Teorema di Thomas,
teorizzato dall'omonimo sociologo dell'università di Chicago, una
ventina di anni dopo, per spiegare i legami tra la devianza e la
condanna sociale.
Un'altra, altrettanto fondamentale, fonte di assegnazione dei ruoli è il
24
lavoro, come testimoniato dal fatto che molti epigrammi hanno come
titolo il nome proprio seguito dal lavoro; in realtà, gli epigrammi con
titoli di questo tipo sono quelli che riguardano i personaggi più in
vista, a significare una corrispondenza istituita tra la gerarchia sociale
e la gerarchia delle professioni: il dottore, il farmacista, il professore,
il reverendo, il direttore del giornale, il diacono. Questi personaggi
sono quelli le cui vicende si intrecciano in diversi epigrammi, entrano
nella vita di molte persone e della comunità: essi sono dotati di potere.
Nondimeno, l'etica del lavoro e la credenza, in una società a religione
protestante, che il successo in esso è espressione del merito della
persona, è presente in quasi tutti gli epitaffi “maschili” (si è detto che
le donne possono ambire unicamente al lavoro di moglie o, al
massimo, insegnante).
Daisy Fraser
Avete mai sentito che il direttore Whedon26/ desse all'erario un po' di soldi intascati/ per appoggiare un candidato?/ O per scrivere elogi della fabbrica di scatolette/ e spingere la gente a fare investimenti?/ O per tacere i misfatti della Banca,/ quando fu marcia e sull'orlo del fallimento?/ Avete mai sentito che il giudice distrettuale/ appoggiasse qualcuno tranne le ferrovie “Q”, o i banchieri?/ O che il reverendo Peet o il reverendo Sibley/ dessero un po' della paga, guadagnata tenendo la bocca chiusa,/o dicendo quello che faceva comodo ai capi,/ per la costruzione dell'acquedotto? [...]
Sexsmith il dentista
Credete che le odi e i sermoni,/ e il suono delle campane,/ e il sangue dei vecchi e e dei giovani,/ martiri della verità che vedevano con occhi illuminati dalla fede in Dio,/ abbiano attuato le grandi riforme del mondo?/ Credete che l'inno della Repubblica/ si sarebbe udito se la merce schiavo/ avesse rafforzato il dominio del dollaro/ nonostante la sgranatrice di Withney,/ e il vapore e i laminatoi e il ferro/ e il telegrafo/ e il libero lavoro bianco?/ Credete che Daisy Fraser/ l'avrebbero buttata fuori/ se la fabbrica di scatolette non avesse avuto bisogno/ della sua casetta e del suo terreno?/ [...] Insomma, un principio morale è come un dente cariato/ che bisogna puntellare coll'oro.
26 Il direttore Whedon, direttore del giornale locale.
25
Griffy il bottaio
Un bottaio deve intendersi di botti./ Ma io conoscevo anche la vita,/ e voi che gironzolate tra queste tombe credete di conoscere la vita./ Credete che il vostro occhio abbracci un vasto orizzonte,/ forse,/ in realtà vedete solo l'interno della botte./ Non riuscite a innalzarvi fino all'orlo/ e vedere il mondo di cose al di là,/ e a un tempo vedere voi stessi-/ tabù e regole e apparenze/ sono le doghe della botte./ Spezzatele e rompete la magia/ di credere che la botte sia la vita,/ e che voi conosciate la vita!
Jones il violinistaLa terra alimenta un fremito continuo/ nel tuo cuore, e quello sei tu./ E se la gente vede che sai suonare,/ be',/ ti tocca suonare,/ per tutta la vita./ Che vedi, una messe di trifoglio?/ O un prato tra te e il fiume?/ C'è vento nel granturco: ti freghi le mani / per i manzi già pronti per il mercato;/ o ti giunge un fruscio di sottane/ come al Little Grove quando ballano le ragazze./ [...] Come a fare a coltivare i miei quaranta acri,/ non parliamo di aumentarli,/ con la ridda di corni, fagotti e ottavini/ che cornacchie e pettirossi mi agitavano in capo,/ e il cigolio di un mulino a vento- vi par poco?/ Mai misi mano all'aratro in vita mia/ senza che ci si mettesse di mezzo qualcuno/ e mi trascinasse via a un ballo o a un picnic./ Finii con i miei quaranta acri;/ finii con il mio violino sgangherato-/ e una risata rauca, e mille ricordi,/ e neppure un rimpianto.
Questi quattro epitaffi riportati, aiutano a sintetizzare bene come
Masters ci presenta il rapporto tra le dinamiche micro-sociali e il
potere a Spoon River. Quest'ultimo è ritratto nei primi due epitaffi: il
direttore di giornale peroratore degli interessi del candidato politico,
del banchiere; i reverendi, al soldo di speculatori edìli, i loro “capi”; il
magnate del paese che sfratta Daisy Fraser per impiantare una fabbrica
di scatolette. Mentre la doppiezza della vita sociale serve alla gente
comune per nascondere “peccati”, socialmente prescritti, di natura
morale, alla elite a compiere azioni che accrescano il loro potere
economico e politico. Quello che Masters ci presenta è un nucleo
integrato di poteri locali: il giornalista, il pastore religioso,
l'industriale. Rileggendo, inoltre, l'epitaffio di Aner Clute troviamo,
con qualche variazione, queste figure presiedere alla costruzione
dell'etichetta di deviante per la prostituta o per il ladro- “[...]e tutti
cominciano a dirgli ladro,/ il giornalista, il prete, il giudice[...]”.
Insomma, l'autore vuole invitare la gente comune ad aprire gli occhi
sulla vera natura delle convenzioni sociali e a vedere queste come il
risultato del processo culturale messo in campo da quel sistema di
potere tramite i propri agenti culturali: il giornale, il reverendo. Questo
punto è allegoricamente ripreso sul epigramma di “Griffy il bottaio”,
nel passaggio, riportato in neretto, in cui invita a rompere i tabù e le
rappresentazioni e a non identificarsi con esse. In pratica, l'autore
26
riconosce la natura finta e socialmente determinata del sistema di
regole drammaturgiche, ma anche morali e culturali, cui le persone, il
voi sottinteso a quel “Non riuscite...”, aderiscono, riconoscendo
legittimità alle istituzioni (chiesa locale, gruppi industriali, etc.)che
creano e promuovono questo sistema; egli intuisce anche che questa
adesione non avviene una volta per tutte ma viene reiterata nella
pratica dell'agire quotidiano, degli stili di vita scelti e che, quindi, il
sovvertimento di questa logica può avvenire altrettanto
quotidianamente: nella metafora, le doghe (le maschere) della botte
(del self) possono essere mandate in frantumi. Questa possibilità di
trasformazione non è, come si potrebbe pensare, soltanto il risultato di
una riflessione filosofica sull'orizzonte del possibile ma del non ancora
avvenuto, essa non appartiene al regno dell'utopia: a Spoon River ci
sono, infatti, esempi concreti di vita che si sottrae alla logica della
rappresentazione. L'epitaffio di Jones il volinista ci dimostra questa
possibilità. Egli, alla febbre dell'accumulo di ricchezza, preferisce gli
inviti degli amici alle feste che, in quanto suonatore, lo vedono
protagonista; questa alternativa tra due scelte di vita differenti è resa
bene nella frase seguente: “C'è vento nel granturco: ti freghi le mani /
per i manzi già pronti per il mercato;/ o ti giunge un fruscio di
sottane/ come al Little Grove quando ballano le ragazze./” Nella
congiunzione, in neretto, “o” risalta la scelta alternativa di chi decide
di vivere il proprio tempo dedicandolo ai valori stigmatizzati
dell'edonismo, tra donne e vino27. Questo personaggio, tra i pochi
anticonformisti del villaggio, finì “con i quaranta acri”, di quaranta
che ne aveva, quindi senza alcun “progresso”, con il violino
sgangherato, “la voce rauca, mille ricordi, e neppure un rimpianto”:
egli è tra i pochi a morire felice, senza rimpianti né frustrazioni.
I sentimenti che i soggetti hanno, da morti, di fronte alla vita possono
27 In quei tre versi c'è forse anche un'allusione alla funzione del lavoro come canale di sublimazione sessuale, resa possibile dalla conoscenza di Freud dell'autore. Questa impressione è data dall'accostamento dell'eccitazione del primo personaggio quando pensa ai proventi futuri alla sensualità della seconda immagine.
27
essere presi come funzioni della posizione occupata da ognuno in vita:
l'outsider (come Jones il violinista, o la stessa Aner Clute, la
prostituta) non ha nessun rimpianto né rabbia; la lunga schiera di gente
comune, nell'opera le persone identificate semplicemente dal nome,
che ha servito quel modello senza ricavarne niente, si rammarica e
talvolta è rabbiosa al momento della morte; i soggetti dotati di potere,
coloro che hanno riprodotto nel loro agire quel sistema di controllo dei
cui frutti si sono nutriti, sentono un grande senso di colpa. Riporto di
seguito gli epigrammi del Direttore Whedon e di “Indignazione”
Jones, per far notare il differente tono che accompagna la riflessione
su due vite differenti. Il primo è il direttore del giornale citato anche
negli epitaffi precedentemente riportati.
Direttore WhedonSaper vedere ogni aspetto del problema, / dar ragione a tutti, essere tutto, non essere nulla a lungo; / pervertire la verità, strumentalizzarla, / sfruttare i grandi sentimenti e le passioni della famiglia umana/ per bassi scopi, per fini astuti / indossare una maschera come gli attori greci- / il tuo quotidiano di otto pagine- / dietro cui ti nascondi, / strillando nel megafono dei caratteri cubitali: / “Sono io il gigante”. / E quindi vivere la vita di un ladruncolo, / avvelenato dalle parole anonime di una amica segreta./ Per danaro insabbiare uno scandalo / o divulgarlo ai quattro venti per vendetta,/ o per vendere il giornale, / distruggendo reputazioni, o corpi, se necessario, / vincere a ogni costo, salvo la vita./ Gloriarsi di un potere demoniaco, minare la civiltà, / come un ragazzo paranoico mette un tronco sulle rotaie / e fa deragliare il rapido./ Essere un direttore come, ero io./ Poi giacere qui accanto al fiume sopra il punto/ dove scorre la fogna del villaggio, / e scaricano barattoli vuoti e immondizie, / e nascondono gli aborti.
“Indignazione” Jones Non ci credereste, vero, / che fossi di buona razza gallese? / Che fossi di sangue più puro della plebaglia bianca di qui? / E di discendenza più diretta di quelli del New England / o della Virginia venuti a Spoon River? / Non ci credereste che avevo studiato / e letto dei libri. /Voi avete visto in me solo un uomo finito, / dai capelli arruffati e la barba / e il vestito a brandelli. / A volte la vita di un uomo si trasforma in un cancro / a furia di venire pestata, pestata sempre di più, / e si gonfia in una massa violacea, / come escrescenza su stelo di granturco. / Ed eccomi falegname affondato nel pantano della vita / in cui camminavo, e lo credevo un prato, /con una sciattona per moglie e la povera Minerva, mia figlia, / che voi avete tormentato e spinto alla morte./ Così strisciai, strisciai da lumaca attraverso i giorni / della vita. / Più non udite i miei passi la mattina, / che risuonano sul marciapiede vuoto, / mentre vado dal droghiere a prendere un po' di farina / e pochi soldi di lardo.
28
MASTERS E GOFFMAN
Quello che abbiamo chiamato lo sguardo sociale di Masters, per
concludere, è uno sguardo composito che realizza la lettura di una
realtà sociale particolare, e delle relazioni che avvengono al suo
interno, con lo spirito di uno studio culturale, come abbiamo visto: una
cultura delle interazioni che travalica i confini della città di provincia
americana e che egli trova a Chicago. L'autore vede questa cultura
delle interazioni fondata sull'utilizzo continuo e capace della messa in
scena da parte degli attori sociali, sull'utilizzo di pratiche teatrali: egli
anticipa lo schema euristico di Goffman. A differenza di quest'ultimo,
però, egli circoscrive la generalità di queste dinamiche relazionali,
prevedendo ed auspicando la possibilità di liberarsene e vedendo,
nell'uso di esse, una pratica strumentale al riconoscimento (od alla non
emarginazione) in società. Altra differenza è che nella pervasività del
controllo resa possibile dalla mancanza di barriere tra le diverse
routine in un contesto semplice come quello di Spoon River, non
esiste differenziazione tra la dimensione micro-sociale e quella macro-
sociale. Se pensiamo infatti quest'ultima rappresentata dall'azione di
quel gruppo (composto dall'industriale, dalla chiesa locale, dal
giornale, dai politici proibizionisti), che si trova effettivamente in una
posizione centrale indicata dal fatto che molti epigrammi citano questo
“gruppo”, esso non agisce in un ambito separato spazialmente e
istituzionalmente dal resto della comunità. Esso non è ancora
istituzionalizzato, non agisce in base a routine standardizzate, a
cerimonie codificate: esso viene raffigurato come in una fase ancora
costituente in cui l'afflato sociale e aggregante è quello
dell'acquisizione di potere nelle varie forme: politiche, economiche,
culturali. Questa particolare situazione descritta da Masters,
verosimilmente reale, poiché fondata sulle conoscenze acquisite di
quel campo dal padre tramite l'esercizio della professione di avvocato,
29
dà la possibilità di pensare che all'epoca della ”osservazione” di
Masters, intorno alla fine dell'ottocento, si stesse realizzando una fase
costituente del processo di istituzionalizzazione che porterà alle
istituzioni, quali luoghi sociali di interazione rituale, di cui parlerà
Goffman. Proprio il fatto di essere in una fase costituente, in cui le
costituende istituzioni sono ancora poco identificabili e separate
socialmente28, rende possibile, poiché lo stesso Masters lo fa, il
tracciare nessi causali tra elementi (che diventeranno) strutturali, e che
investono (e sono investiti) da cambiamenti globali nella sfera
economica e culturale, ed elementi dell'interazione quotidiana. Il
tentativo di tracciare tale nesso manca del tutto in Goffman, come è
stato rilevato29. Tuttavia, se è vero che manca una esplicitazione in
positivo di tale nesso, è anche vero che la maggior parte degli esempi
utilizzati di interazione in contesti naturali ci parla di strati
socialmente centrali: la classe media dei paesi anglo-sassoni, la corte
imperiale cinese, le cerimonie delle istituzioni politiche. Inoltre, vi
sono diversi passaggi in cui si afferma che il livello di sofisticazione
della rappresentazione è direttamente proporzionale allo status sociale,
per ragioni di disponibilità economica- ad esempio la possibilità,
avendo una casa adeguatamente grande, di differenziare gli spazi di
ribalta e retroscena- e capacità culturale- la possibilità di re-inventarsi
e di scegliere diverse routine e identità, per la maggiore quantità di
stimoli che riceve, ad esempio, un professionista di un muratore; il
fatto che questa realtà venga designata con quello che è stato chiamato
il distacco dello scienziato30, che si concretizza nel trattare fenomeni
che riguardano l'alto e il basso della società con lo stesso schema- il
dire che le gerarchie si fondano sulla “scienza della finzione”-, ha una
portata che è indubbiamente, anche se involontariamente, in polemica
con le concezioni dominanti di legittimazione delle diseguaglianze
sociali. Quello che cerco qui di sostenere è che la posizione da cui
28 Sorta di organizzazioni “loosely coupled”, di cui parla Karl Weick. 29 Pier Paolo Giglioli, op. cit., pp. XXIII- XXIV30 Pier Paolo Giglioli, op. cit.
30
Masters e Goffman guardano alla realtà sociale è molto simile e anche
l'oggetto- l'impatto delle istituzioni (come portatrici di idee sociali
totali) sull'interazione- è simile: la embrionalità della analisi di
Masters corrisponde alla embrionalità del fenomeno all'epoca di
Masters, la compiutezza dell'euristica di Goffman al completato
sviluppo di quei fenomeni.
VITA DI MASTERS
Masters nasce a Garnett, nel Kansas, nel 1868 da Emma Dexter e da
Hardin Masters. I suoi primi anni, dopo la guerra civile, li trascorre in
Kansas dove il padre lavora e in seguito a Menard, villaggio dove
vivono i nonni paterni. Il padre del poeta è avvocato, è figlio di un
benestante contadino dell'Illinois nonché uomo politico, esponente
democratico all'Assemblea Legislativa dello Stato: dal ramo paterno
quindi giunge l'interesse e la passione per la politica che animerà
anche il poeta. Il padre, Hardin, studia da giovane alla Michigan
University per diventare avvocato: qui conosce Emma Dexter, la
ragazza che diventerà sua moglie e madre dello scrittore. La madre di
E. L . Masters, figlia di un pastore metodista, era una ragazza
religiosa, amante della letteratura e della musica, e sprezzante del
provincialismo dei paesi dell'Illinois dov'è costretta a vivere a causa
del lavoro del marito. Il rapporto tra i genitori del poeta è molto
conflittuale, a causa dei differenti caratteri dei due- la madre
rimprovera al padre l'indifferenza nei confronti della cultura-, e la
problematicità è acuita dall'insofferenza della madre per l'ambiente
provinciale in cui vivono. L'infanzia e la prima adolescenza sono
comunque caratterizzate dal nomadismo della famiglia: il padre
diventa Procuratore di Stato, eletto come rappresentante democratico,
e la famiglia si trasferisce a Petersburg, capitale della contea.
Dopo pochi anni, nel 1881, si trasferiscono a Lewistown, città in cui il
31
padre aveva molti amici e sperava di trovare maggior fortuna,
speranza poi rivelatasi infondata. La famiglia infatti si trova in cattive
condizioni economiche. E' a Lewistown che Edgar comincia ad
approfondire la conoscenza della letteratura americana ed europea, in
essa si rifugia per trovare quella serenità che in famiglia manca a
causa dei continui screzi tra i genitori. Il giovane Masters, crescendo,
cerca di ritagliarsi i propri spazi di autonomia: comincia a lavorare al
giornale locale, per uno stipendio misero, grazie al quale riesce a
comprare libri e a costruirsi una preparazione letteraria da
autodidatta . Masters comincia a capire sempre di più che la
letteratura è il campo attraverso cui si esprime la sua diversità in
famiglia: al momento della scelta sugli studi universitari, le pressioni
del padre si fanno sempre più insistenti nel prospettare una carriera
forense al figlio e nell'invitare il figlio a lasciare stare l'ambizione
letteraria. E' con questa istanza anti- intellettualistica del padre, che
frustra qualsiasi capacità e attitudine scrittoria del figlio, che Masters
comincia a concepire la realtà sociale costituita come elemento di
oppressione della libertà. Infatti, egli capisce bene come la posizione
del padre sia dettata da considerazioni e idee conformistiche
sull'importanza di una vita ben inserita e decorosa anche
economicamente. Egli si trova combattuto: da un lato non vuole
innescare un conflitto con la famiglia, dall'altro non vuole rinunciare
alla poesie e alla letteratura . In questo conflitto, comincia a
strutturarsi il suo punto di vista con cui concepisce una struttura
duale del “suo” rapporto con la società: le spinte alla conformità e
quindi alla accettazione dei rapporti sociali che gli appaiono intrisi di
falsità; la letteratura, per contrasto, come dimensione “anti-sociale”,
che lo avrebbe portato alla miseria, secondo il padre, quindi regno in
cui si ribaltano i valori dominanti in società. Quindi, questa vita di
relativo isolamento dalla società esterna- in realtà, di cambiamento
dei contesti, egli cambia spesso scuola, non ha amici stabili- dettato
dal nomadismo della crescita, dall'altro la conflittualità in famiglia,
32
contribuiscono a creare uno spazio interiore da cui osserva le
contraddizioni delle persone, le incongruità delle situazioni sociali,
con occhio critico e letterario. Finite le scuole superiori, si allontana da
Lewistown per iscriversi alla Knox Academy di Galesburg, dove
svolge studi umanistici, disapprovati dalla famiglia al punto da non
sostenerlo economicamente. Nonostante avesse cercato di mantenersi,
con un sentimento di rivalsa nei confronti dei genitori, e cominciato a
dare seguito alle sue ambizioni, pubblicando poesie sui giornali locali,
è costretto a ripiegare sugli studi di giurisprudenza. Il senso di
inferiorità nei confronti del padre, di cui non riusciva a eguagliare le
abilità professionali, e continui litigi con la madre gli fanno decidere d
i trasferirsi a Chicago. Chicago è in quel periodo la città simbolo del
capitalismo, di cui segue i ritmi ciclici di espansione e depressione
economica, era passata dall'avere poche centinaia di abitanti a più di
un milione e mezzo, è meta di migrazioni dall'Europa e dal resto
d'America: tutte quelle contraddizioni sociali create dallo sviluppo
forsennato, che Masters vive, di cui si occuperà anni dopo la
sociologia urbana della Scuola di Chicago. Dapprima svolge lavori
svariati, come esattore dei crediti della Edison Company, che gli
forniscono posizioni di osservazione privilegiata sulla città e le sue
diseguaglianze- frequenta osterie, pernsioni, bordelli; in seguito, trova
opportunità di esercitare nuovamente la professione di avvocato
divenendo socio di diversi altri avvocati e vivendo una carriera in
ascesa. Il successo lo apre sia alla vita dell'alta società che alla
conoscenza degli ambienti intellettuali della città e anche in questo
periodo si manifesta tutta la sua doppiezza: conosce e si fidanza con
la figlia di un magnate, Helen Mary Jerkins. Masters dichiara
apertamente nei suoi scritti che in lei vede l'opportunità di sistemarsi
economicamente per poter svolgere la sua attività di scrittore- che
continua a svolgere, con scarso successo, parallelamente a quella di
avvocato- ma non la ama e riconosce che molte differenze lo dividono
da lei. Dietro consiglio del padre, che lo avverte della pubblica
33
riprovazione che seguirebbe la rottura di una promessa di matrimonio
e gli “ricorda” la natura economica di quel matrimonio, si sposa.
Anche in città, negli strati superiori della società, Masters si scontra
con quelle etichette e quel convenzionalismo che lo avevano fatto
partire, anche qui egli non riesce a sciogliere quelle contraddizioni:
come avvocato difende anarchici, sindacalisti e gli oppressi e, grazie ai
lauti proventi della professione, vive una vita agiata al cospetto di
uomini di affari, della borghesia avida e possessiva della città, che
disprezza; sposa, in ottemperanza alle istanze paterne interiorizzate,
una donna che non ama e intrattiene relazioni con donne artiste,
scrittrici e col mondo letterario in genere, le cui frequentazioni sono
tenute quasi segrete. Tuttavia, una nuova speranza lo investe quando
conosce William Marion Reedy, l'editore che pubblicherà in seguito le
poesie di Spoon River, che gli regala l'Antologia Palatina, con la
raccolta di epigrammi greci, che lo illuminerà, e Theodore Dreiser,
scrittore di romanzi in cui si descrive la violenza della vita quotidiana
nella metropoli e di cui Masters apprezza la schiettezza dello stile che
farà sua. In questa situazione interiore, con il pensiero che si fa strada
che l'America moderna avesse tradito lo spirito democratico ed eroico
dei suoi fondatori, l'America di eguaglianza e fratellanza di Whitman,
con gli stimoli delle nuove letture realiste di Dreiser, avviene un
incontro inaspettato con la madre. E' a seguito di questo incontro con
la madre, con cui ricostruirà vicende e ricordi della gente di
Lewistown, che Masters decide di scrivere la Antologia di Spoon
River, un ritratto umano e sociale della America a lui contemporanea.
Dopo quell'incontro, egli arriva alla consapevolezza dell'isomorfismo
delle realtà sociali, della somiglianza delle persone di campagna e di
città. Bisogna tuttavia domandarsi come si siano costituite le capacità
che si sostanziano in quello che egli stesso chiama il suo “occhio
clinico”. L'ontogenesi di Masters avviene in una famiglia appartenente
alla classe media della società americana, essa è, nel contesto delle
città che attraversa, in possesso di capitale culturale maggiore rispetto
34
al resto della popolazione; il progressismo politico del padre, mal si
amalgama con la spinta al successo che vuole istillare nel figlio.
Queste due tendenze della famiglia, e della classe media, da un lato,
ad accettare il modello di organizzazione sociale fondato sul benessere
che garantisce al proprio gruppo, e , dall'altro a criticarlo per le
ingiustizie su cui si fonda, si manifestano nella consapevolezza di
Masters grazie all'autoanalisi cui lo costringe la letteratura. Questi
elementi si arricchiscono della vita a Chicago. Qui, il prorompere dei
fenomeni della complessa realtà sociale metropolitana a cui assiste, e
il contatto con il campo letterario in formazione della città, composto
da scrittori attenti alle tematiche sociali, come Dreiser, fanno nascere
in lui l'esigenza di una espressione dei mali della modernità di cui tutti
partecipano, come in un microcosmo.
CONCLUSIONI
L'Antologia di Spoon River è una metafora della modernità resa
possibile dall'isomorfismo che è alla base di tutti i contesti sociali
organizzati, come direbbe Goffman, di cui l'autore ha preso coscienza.
Il microcosmo è uguale al macrocosmo, per riprendere la metafora di
Masters, perché, a discapito di quel che pensava prima di trasferirsi a
Chicago, la dimensione quantitativa dei fenomeni sociali, il trovarsi in
una metropoli o in villaggio di poche anime, non incide sull'identicità
qualitativa con cui si crea, nell'uno come nell'altro posto, il cosmo di
rapporti istituzionalizzati a cui gli individui e i gruppi, le equipe,
prendono parte. Questa convinzione si è fatta strada nella coscienza di
Masters grazie alla “comparazione” che ha potuto fare dei diversi
contesti ed alla sua particolare identità doppia che gli ha reso
possibile, contemporaneamente, il prendervi parte ed il rimanere
spettatore costante di essi. Tale esperienza può essere paragonata a
35
quella dell'osservatore partecipante che continua a immergersi e a
distaccarsi dal contesto di osservazione e di partecipazione.
Inoltre, le obiezioni che si possono muovere a Masters come uomo e
scrittore per la scelta- che gli è costata la prevedibile emarginazione da
Lewistown e Petersburg- di aver pubblicato storie reali riguardanti
persone che le avrebbero voluto tenere nascoste, sono le stesse che si
potrebbero muovere ad un ricercatore sociale che agisse nello stesso
modo dopo una osservazione sul campo non palesata: nel primo caso
in nome di principi morali, nel secondo in nome dell'etica
metodologica scientifica.
Inoltre, se è vero che rappresentazioni del mondo simili sono il
risultato di posizioni e disposizioni analoghe nel mondo sociale, si
dovrebbe cercare di capire, se la mia argomentazione sulla
somiglianza dei punti di vista dei due autori ha convinto, da quale
punto di vista gli habitus di Masters e Goffman possano essere simili.
Questo orientamento implicherebbe, più complessivamente, lo
studiare le teorie sociologiche anche in relazione alla storia sociale
dell'autore ovvero mettere da parte la convinzione che i sociologi non
siano influenzati dai fenomeni sociali che vivono e attraversano.
D'altro canto, una auto-riflessione critica del sociologo può aiutare a
“prendere atto della propria posizione e del suo evolversi nel tempo
per tentare di controllare gli effetti che potrebbero avere sulle proprie
posizioni scientifiche”31.
31 Pierre Bourdieu, Questa non è un'auto-biografia, Feltrinelli, 2005. Ho modificato alcune parti del testo, essendo il testo originale tutto in prima persona.
36
BIBLIOGRAFIA
Edgar Lee Masters, Antologia di Spoon River, I Giganti di Gulliver, 1995
Master Edgar Lee, Across Spoon River. An autobiography, Prairie State Books, 1990
Pivano Fernanda, Intervista immaginaria a E. L. Master, FERNANDA PIVANO, DIARI [1917.1973], Bompiani, 2008
Goffman Erving, La vita quotidiana come rappresentazione, Il Mulino, 1969
Bourdieu Pierre, Le regole dell'arte. Genesi e struttura del campo letterario, Il Saggiatore, 2005
Bourdieu Pierre, Questa non è un'autobiografia, Feltrinelli, 2005
Coser Lewis, Sociology through literature, Prentice- Hall Sociology series, 1963
Burns Tom, Sociology of Literature and Drama, Penguin Books, 1973
Simmel Georg, Metropoli e vita dello spirito, Armando Editore, 1995
Fabio Tarzia, I sociologi e lo spazio letterario. Un profilo del novecento. Liguori editore, 2003
Antologia Palatina. Scelta e traduzioni di Salvatore Quasimodo. Edizione Mondadori, 1992
37