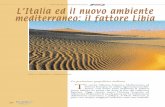Di nuovo sul formalismo russo
Transcript of Di nuovo sul formalismo russo
Direzione
Dante Della Terza, Edoardo Esposito
Comitato scientifico
J. B. Bullen, Jonathan Culler, † Claudio Guillén, Anne-Rachel Hermetet,William Mills Todd III, Jürgen Wertheimer
Responsabili di settore
Giovanna Benvenuti, Anna Maria Carpi, Carlo Di Alesio, Maria Giulia Longhi, Paola Loreto, Antonio Melis, Caroline Patey, Damiano Rebecchini
Redazione
Stefano Ballerio, Francesca Cuojati, Tiziano Moresi, Laura Neri, Stefania Sini
*
Comunicazioni redazionali a Edoardo Esposito,Dipartimento di Filologia Moderna dell’Università degli Studi di Milano,
via Festa del Perdono 7, 20122 Milano
*
La rivista è pubblicata con il contributo del Dipartimento di Filologia Modernadell’Università degli Studi di Milano
Amministrazione e abbonamentiAccademia editoriale®
Casella postale n. 1, succursale n. 8, i 56123 Pisa,tel. +39 050 542332, fax +39 050 574888
Abbonamenti (2007) :Italia : Euro 40,00 (privati) · Euro 60,00 (enti, con edizione Online)
Abroad : Euro 60,00 (Individuals) · Euro 80,00 (Institutions, with Online Edition)Prezzo del fascicolo singolo Euro 100,00
I pagamenti possono essere effettuati tramite versamento su c.c.p. n. 17154550o tramite carta di credito (American Express, Visa, Eurocard, Mastercard)
La Casa editrice garantisce la massima riservatezza dei dati forniti dagli abbonati e la possibilità di richiederne la rettifica o la cancellazione previa comunicazione alla medesima.
Le informazioni custodite dalla Casa editrice verranno utilizzate al solo scopodi inviare agli abbonati nuove proposte (Dlgs. 196/2003).
*
Autorizzazione del Tribunale di Pisa n. 24 del 14 giugno 2007Direttore responsabile : Fabrizio Serra
Sono rigorosamente vietati la riproduzione, la traduzione, l’adattamento, anche parziale o per estratti, per qualsiasi uso e con qualsiasi mezzo effettuati, compresi la copia fotostatica, il micro-
film, la memorizzazione elettronica, ecc., senza la preventiva autorizzazione scritta dellaFabrizio Serra · Editore®, Pisa · Roma, un marchio della Accademia editoriale®, Pisa · Roma.
Ogni abuso sarà perseguito a norma di legge.
*
Proprietà riservata · All rights reserved© Copyright 2007 by Fabrizio Serra · Editore®, Pisa · Roma,
un marchio della Accademia editoriale®, Pisa · Roma
*
www.libraweb.net
*
La Accademia editoriale®, Pisa · Roma, pubblica con il marchioFabrizio Serra · Editore®, Pisa · Roma, sia le proprie riviste precedentemente edite con
il marchio Istituti editoriali e poligrafici internazionali®, Pisa · Roma, che i volumidelle proprie collane precedentemente edite con i marchi Edizioni dell’Ateneo®, Roma,
Giardini editori e stampatori in Pisa®, Gruppo editoriale internazionale®, Pisa · Roma,e Istituti editoriali e poligrafici internazionali®, Pisa · Roma.
i s sn 197 1 -906x
SOMMARIO
Editoriale 9
in limine
Dante Della Terza, Claudio Guillén : un profilo e un ricordo 13Jonathan Culler, Lyric Address 21Edoardo Esposito, Critica e comparatistica 37
ripensare la teoria
Alfonso Berardinelli, Franco Brioschi, un teorico e critico della teoria 45Stefania Sini, Di nuovo sul formalismo russo 49Maria Teresa Giaveri, Fra Italia e Francia : questioni di critica genetica 77Laura Neri, Retorica e teoria della letteratura 89Andrea Mirabile, Dallo strutturalismo al poststrutturalismo : Michel Foucault 113Elio Franzini, Il mestiere del critico e i mondi possibili 129Stefano Ballerio, La comprensione : tra storicismo e neuroscienze 139Romano Luperini, Postmodernità e ruolo dell’intellettuale 153Edoardo Esposito, Una mappa per la letteratura 163
note e discussioni
Caroline Patey, Beckett in movimento. Momenti e motivi di un centenario 169Stefano Versace, Petrarca ist wieder in Sicht. Letture italiane nella biblio- teca di Paul Celan a Marbach 175Marta Szczycin ´ska, La critica dei quotidiani 189
recensioni
« Rhytmica. Revista Española de Métrica Comparada », 2003-2004 (Alfon- so D’Agostino) 197Taste the East. Linguaggi e forme dell’Ostalgie, a cura di Eva Banchelli (An- na Maria Carpi) 200Romano Luperini, L’autocoscienza del moderno (Carlo Di Alesio) 201Francesco Orlando, Obsolete Objects in the Literary Imagination (Lucia Del- la Pietà) 204
DI NUOVO SUL FORMALISMO RUSSO
Stefania Sini
Negare ciò che gli altri fanno ci lega a loro.Viktor Šklovskij
1. Il metodo formale e la fondazione della scienza letteraria
Dopo la fortuna editoriale e critica degli anni Sessanta e Settanta, negli ultimi decenni, in Italia, sul movimento formalista sembra essersi depositato un
persistente silenzio. Se ne dà per assodata l’importanza per la teoria e la critica della letteratura e se ne conoscono i principali contributi teorici e metodologici, quasi sempre assimilati a quelli di provenienza strutturalistico-semiologica, emi-nentemente francesi, che ne hanno decretato il successo. Eppure siffatto filtro culturale – a cominciare dalla celebre antologia di Tzvetan Todorov (apparsa in Francia nel 1965 e in Italia nel 1968) 1 – non ha mancato di condizionare profonda-mente la ricezione del significato e del ruolo storico dei formalisti russi.
In effetti, la koiné teorica che ha preso corpo si è sedimentata nel senso comune degli studiosi di letteratura in una costellazione di loci specifici ascrivibili indifferen-temente al formalismo e allo strutturalismo, laddove i due termini hanno costitui-to quasi sempre una dittologia sinonimica, un’ineccepibile equazione. Trascorsa la stagione trionfale del credo strutturalista, incalzato da altri paradigmi e dal dif-fuso senso di crisi in cui sembra oggi voler versare la riflessione sulla letteratura, è ormai maturo il momento per sottoporre a verifica le genealogie tramandate. 2
Le osservazioni che seguono costituiscono una preliminare messa a punto dei risultati di una ricerca che si è posta come obiettivo una rilettura critica degli
1 I formalisti russi. Teoria della letteratura e metodo critico, a cura di Tzvetan Todorov, Torino, Einaudi, 1968.
2 A questo proposito si domanda Denis Ustinov : « Davvero il principale merito del lavoro dei forma-listi è consistito (e non poteva non consistere) nella costruzione di una poetica descrittiva, e il legittimo “stadio più alto” del formalismo doveva essere (ed è stato) lo strutturalismo, nell’aspetto che ci viene offerto dagli studiosi parigini e/o di Tartu degli anni ’60 ? Se in relazione al primo periodo della storia del metodo formale, terminato nel 1922-1924, una risposta positiva a queste domande sembra più o me-no giusta, tuttavia le successive ricerche dei formalisti negli anni ’20 già la rendono non così evidente » (Formalizm i mladoformalisty [Il formalismo e i giovani formalisti], « Novoe literaturnoe obozrenie », 50, 4’, 2001, p. 298. Ringrazio Damiano Rebecchini per questa segnalazione. Traduzione mia, come sempre d’ora in avanti, se non diversamente segnalato). Da parte sua, Galin Tichanov ritiene che la teoria della letteratura sia oggi addirittura estinta : « retrospettivamente, si possono definire i limiti cronologici della teoria della letteratura nell’intervallo tra la fine degli anni ’10 del Novecento e l’inizio degli anni ’90. La nascita di questa disciplina è stata segnata dall’attività dei formalisti russi, e la sua fine è stata segnata dal passaggio di Iser tra la fine degli anni ’80 e i primi anni ’90 dalla teoria della ricezione e dalla feno-menologia della lettura a ciò che lui ha denominato ‘antropologia letteraria’, e dalla morte di Lotman nel 1993 » (Galin Tichanov, Zametki o dispute formalistov i marksistov 1927 goda [Note sulla disputa del 1927 tra formalisti e marxisti ], ivi, p. 279).
stefania sini50
scritti dei maggiori esponenti del formalismo russo, nel tentativo di chiarificar-ne il contesto di origine, di approfondire la conoscenza delle singole personalità, assai spesso omologate in un’unica fisionomia sovra-individuale, e di colmare quanto possibile le lacune dovute alla selettività del corpus dei testi tradotti in italiano. È parso necessario rivolgere subito l’attenzione alla vicenda storica rap-presentata dall’attività dell’opojaz e del mlk prima di discuterne i molteplici e disparati contributi, dando quindi la precedenza al racconto dei fatti piuttosto che all’esposizione dei concetti. Se tra le varie insidie celate sotto la ben pro-blematica etichetta di « formalismo » una delle più rischiose è quella degli acco-stamenti anacronistici, qualche cenno sommario sull’ambiente culturale della Russia degli anni ’20 può forse aiutare a comprendere meglio la formazione e gli esiti di un apparato di dottrine e di una prassi critica cui ha guardato come al proprio modello di riferimento una cospicua rappresentanza della teoria lette-raria novecentesca. 1
Si può allora dare avvio a queste note prendendo le mosse dalla constatazio-ne diffusamente condivisa secondo la quale proprio con il movimento forma-lista viene storicamente edificata una nuova disciplina del campo umanistico, i cui lineamenti fino ad allora fluttuavano o giacevano irrelati se non inerti negli angoli periferici dei diversi settori storico-filologici. È in Russia, a partire dalla metà degli anni ’10, che « nasce la teoria della letteratura ». 2 Essa si costituisce rivendicando il ruolo di nuova, rivoluzionaria scienza autonoma che circoscri-ve recisamente il proprio oggetto di studio e stabilisce le proprie irrevocabili premesse. Come dichiara Boris Èjchenbaum agli oppositori in un combattivo intervento del 1924 che è anche un primo bilancio retrospettivo dell’attività del-la scuola formale, il programma intrapreso non si esaurisce certo nell’elabora-zione di uno fra i tanti possibili approcci ai testi letterari, per quanto inedito e convincente :
Gli sforzi dei formalisti non sono diretti alla descrizione di singole opere […], ma alla co-struzione della teoria e della storia della letteratura come scienza autonoma. […]
Nell’ambito della scienza letteraria il formalismo è un movimento rivoluzionario, poi-
1 La prima sigla corrisponde, com’è noto, a Obšcestvo izuc ˇenija poètic ˇeskogo jazyka [Società per lo stu-dio del linguaggio poetico] fondato a Pietroburgo nel 1916, a cui aderiscono Viktor Borisovic Šklovskij (1893-1984), Osip Maksimovic ˇ Brik (1888-1945), Boris Michajlovic ˇ Èjchenbaum (1886-1959), Jurij Nikolae-vic Tynjanov (1894-1943), Lev Petrovic ˇ Jakubinskij (1892-1945), Evgenij Dmitrevic ˇ Polivanov (1891-1938) ed altri ; la seconda a Moskovskij lingvisticeskij kružok [Circolo linguistico di Mosca], fondato nel 1915, di cui fanno parte Roman Osipovic ˇ Jakobson (1896-1982), Petr Georgevic ˇ Bogatyrëv (1893-1971), Grigorij Osipovic Vinokur (1896-1947), Boris Isaakovic ˇ Jarcho (1889-1942) ed altri. In considerazione del fatto che gli studiosi pietroburghesi hanno rivendicato ‘in esclusiva’ la qualifica di « metodo formale » (come pubblicamente dichiarato da Èjchenbaum), gran parte del presente lavoro si concentra sull’esperienza dell’opojaz, occupandosi solo nelle ultime pagine del MLK. Sulle affinità, interferenze e collisioni tra le due scuole – alcuni come Brik, Šklovskij, e Boris Viktor’evic ˇ Tomaševskij (1890-1957) vissero sia a Pietroburgo che a Mosca, partecipando alle attività di entrambi i gruppi –, cfr. infra, par. 5.
2 « Nasce la teoria della letteratura. Le domande dei formalisti russi » : così Giovanni Bottiroli intitola il secondo capitolo del suo Che cos’è la teoria della letteratura. Fondamenti e problemi, Torino, Einaudi, 2006.
di nuovo sul formalismo russo 51
ché la libera dalle vecchie consunte tradizioni e la obbliga a rivedere da capo tutti gli sche-mi e le nozioni fondamentali. 1
In prima istanza non si tratta nemmeno, secondo Èjchenbaum, della messa a pun-to di nuovi metodi di analisi delle opere d’arte verbali :
La questione non riguarda i metodi di studio della letteratura, ma i principi di costruzione della scienza letteraria – i suoi contenuti, il fondamentale oggetto di studio, i problemi che la organizzano in quanto scienza particolare. È diventato infine chiaro che la scienza sulla letteratura, poiché non rappresenta solo una parte della storia della cultura, deve essere una scienza autonoma e specifica, che ha il proprio campo di problemi concreti. 2
Molto più del dovizioso equipaggiamento di metodi e strumenti, virtualmente incrementabile e perfettibile, allestito dai formalisti, e su cui si sono scatenate le critiche degli avversari, ciò che conta nell’autoritratto che la nuova scuola presen-ta al mondo è la sua volontà di distinzione epistemologica, insieme alla ribadita affermazione di compattezza e irremovibilità delle posizioni assunte :
Riconoscere che il problema fondamentale della scienza letteraria è la forma specifica del-le opere verbali e che tutti gli elementi da cui è costruita hanno funzioni formali in quanto elementi costruttivi è certamente un principio, e non un metodo. […]
Stimati colleghi, dovete comprendere che non si tratta di metodi, ma di principi. In-ventate quanti metodi volete – il metodo migliore è quello che conduce allo scopo con la maggiore certezza. Abbiamo quanti metodi vogliamo. Ma non può esservi una pacifica coesistenza di dieci principi, e neanche di due. Il principio che stabilisce il contenuto o l’oggetto di una determinata scienza deve essere uno. Il nostro principio è lo studio della letteratura come serie specifica di fenomeni. Va da sé che accanto ad esso non possa star-cene un altro. 3
Il principio in questione viene subito condotto dagli opojazovcy alle sue estreme conseguenze, fino alla « ontologizzazione dell’oggetto delle loro ricerche nell’uni-verso cognitivo », vale a dire alla « irriducibilità del fatto dell’arte al fatto della vita, della serie letteraria alla serie sociale ». 4 Con un preliminare risoluto gesto di epo-ché, essi escludono dal territorio di indagine tutto quanto eccede l’organizzazio-ne interna del manufatto : speculazioni filosofiche, ricerca delle fonti (storiche, biografiche, sociologiche), vale a dire i modi fino ad allora consueti di studiare le
1 Boris Èjchenbaum, Vokrug voprosa o « formalistach » [Intorno alla questione sui formalisti], « Pecat’ i revolucija », 5, 1924, pp. 10-11 (corsivi dell’autore, come d’ora in avanti, salvo diversamente indicato).
2 Ivi, p. 2.3 Ivi, pp. 3-4. Con affermazioni analoghe Èjchenbaum apre il saggio Teorija « formal’nogo metoda » [La
teoria del « metodo formale »] : « Il cosiddetto “metodo formale” non è sorto per effetto della creazione di uno speciale sistema “metodologico”, ma nel corso della lotta per l’autonomia e la concretezza della scienza letteraria. […] Fondamentale per i formalisti non è il problema dei metodi dello studio della letteratura, ma quello della letteratura come oggetto di studio. In sostanza, non parliamo e non discutia-mo di nessuna metodologia » (in Literatura. Teorija, kritika, polemika, Leningrado, 1927, p. 116 ; trad. it. di Carlo Riccio in I formalisti russi, cit., p. 31).
4 Aleksandr Dmitriev, Jan Levc ˇenko, Nauka kak priëm : ešce raz o metodologiceskom nasledii russko-go formalizma [Scienza come procedimento. Ancora sull’eredità metodologica del formalismo russo], « Novoe literaturnoe obozrenie », cit., p. 200.
stefania sini52
opere. Lo sguardo si ferma ostinato sull’officina dell’artista ; la priorità non è lo sprofondamento nell’epistéme, ma l’analisi della téchne : il setaccio di orchestrazioni e intrecci (instrumentovki, sjužety), il riconoscimento delle articolazioni di procedi-menti (priëmy) che innervano i testi in versi e in prosa (« l’infinito labirinto di nessi » di Tolstoj). 1 Nell’individuazione dei tratti distintivi della lingua poetica, della sua « differenza specifica », i formalisti mirano, rigorosi, alla « definizione » dell’oggetto e alla formulazione di « leggi » interne che sanciscano in modo incontrovertibile i tratti di pertinenza della « letterarietà ». 2 Attraverso la « costante attenzione dedi-cata al problema del confine del campo studiato (che cos’è la letteratura, come cambia il contenuto di questo concetto) », attraverso il conio di una nuova termi-nologia adeguata a nuovi mezzi conoscitivi, la scuola formale enuncia dunque « l’assiomatica dei postulati di partenza della scienza della letteratura ». 3
2. Il ‘paradosso anti-accademico’
Di fatto le risolute ambizioni epistemologiche dei giovani membri dell’opojaz sono sostenute da un manifesto atteggiamento settario, sprezzantemente anti-istituzionale, il cui primo immediato bersaglio è il mondo accademico. Gli stu-diosi di letteratura insediati nell’università costituiscono agli occhi dei formalisti un fronte impotente e malfermo, chino sui detriti di una tradizione esangue, e su cui non vale neanche la pena di accanirsi. Questo almeno è quanto risuona dalle dichiarazioni pubbliche, come per esempio dal resoconto di Èjchenbaum :
1 « Labirint sceplenij » è anche il titolo di un saggio di Èjchenbaum dedicato al racconto incompiuto di Tolstoj Fal’šivyj kupon [Il biglietto falso] del 1903-1904, letto dal critico alla luce della celebre definizione tolstojana dell’arte enunciata nella corrispondenza con Strachov del 1876 (« Iskusstvo – beskonec ˇnyj labirint sceplenij »). Il saggio di Èjchenbaum è apparso in due parti su « Žizn’ iskusstva », nn. 314 e 315, il 10 e l’11 dicembre 1919 (« Žizn’ iskusstva. Ežednevnaja gazeta. Izdanie Petrogradskogo teatral’nogo O[tdelenij] N[arodnogo] K[omissarjata] po Prosv[ešceniju] » [La vita dell’arte. Quotidiano. Edizione della Sezione teatrale Pietrogradese del Commissariato Popolare per l’Istruzione]). Sullo stilema tolstojano, molto amato dai formalisti, cfr. Bottiroli, op. cit., p. 53 ; E. S. Timofeeva, Metafora « Labirint sceplenij » i sud’by naucnoj poètiki v Rossii [La metafora del « labirinto di nessi » e i destini della poetica scientifica in Russia], « Èjchenbaumovskie ctenija », Voronež, sentjabr’ 1998, pp. 71-73.
2 Sul « problema delle definizioni » sollevato dalla nozione formalista di letterarietà, cfr. Bottiroli, op. cit., pp. 38-48. Per una critica serrata a questa nozione problematica, in particolare nella versione jakob-soniana di « dominante della funzione poetica », ulteriormente indebolita dalla vulgata strutturalistica, cfr. Costanzo Di Girolamo, Critica della letterarietà, Milano, Il Saggiatore, 1978. Cfr. soprattutto gli im-prescindibili lavori di Franco Brioschi, La mappa dell’impero. Problemi di teoria della letteratura (1983), Mi-lano, Net, 2006, pp. 11-114, 189-231 e Critica della ragion poetica, Torino, Bollati Boringhieri, 2002, pp. 155 ss.
3 Dmitriev-Levc ˇenko, op. cit., p. 198. Secondo i due studiosi, gli opojazovcy (in quanto coesa ed organizzata « comunità ») furono i protagonisti di una « rivoluzione scientifica » in filologia, e non so-lo percorsero la soglia di un nuovo « paradigma », bensì incarnarono e determinarono « un più fonda-mentale processo di formazione di una “matrice paradigmatica” nella conoscenza umanistica » giacché cercarono di costruire « una poetica scientifica che studiasse l’evoluzione specificamente letteraria (le sue leggi interne), al posto della tradizionale filologia accademica in quanto ramo della storia in generale (letteratura come espressione dello Spirito nazionale e/o del genio individuale). In tal modo, non si trattava di una nuova teoria onnicomprensiva, né di un metodo universale, ma di un cambiamento di principio della visione della stessa essenza della scienza della letteratura » (ibidem). Se in questo passo il riferimento all’epistemologia di Kuhn è particolarmente fitto, altrove si utilizzano nozioni di Latour, Bourdieu, ed altri sociologi e filosofi del pensiero scientifico.
di nuovo sul formalismo russo 53
All’epoca dell’apparizione dei formalisti la scienza « accademica », che aveva completamen-te ignorato i problemi teorici e con indolenza s’era servita di « assiomi » estetici, psicologici e storici superati, aveva a tal punto smarrito la percezione dell’oggetto suo proprio d’in-dagine che la sua stessa esistenza era divenuta solo parvenza. Non c’era quasi necessità di lottare contro di essa : a che pro’ sfondar porte, quando risultava che di porte non ce n’erano e in luogo di una fortezza ci trovavamo davanti a uno spazio aperto ? 1
Se in Russia, nel primo decennio del secolo, i metodi di studio della letteratura praticati nelle università sembravano effettivamente fare acqua da tutte le par-ti, 2 d’altro canto l’energica convinzione di Èjchenbaum nasconde un fondo pro-blematico, se non contraddittorio, destinato ad aggravarsi nel corso degli anni. Il disprezzo proclamato nei riguardi delle istituzioni accademiche contrasta in realtà sia con la formazione della maggior parte degli opojazovcy, sia con alcu-ne tappe decisive delle loro carriere, oltre che rappresentare uno dei motivi non trascurabili della « crisi e disfatta » del movimento. 3 Innanzi tutto hanno studiato all’Università di Pietroburgo Boris Tomaševskij, Viktor Šklovskij, Jurij Tynjanov, Boris Ejchenbaum, vale a dire i più noti rappresentanti della scuola formale, 4 che in questa sede hanno potuto conoscersi, dialogare, rinsaldare i loro legami at-traverso la pratica della lettura e dell’analisi dei testi. È nei locali della Facoltà storico-filologica, « continuazione del Nevskij Prospekt », e in particolare nel « 4o auditorio », sede del Dipartimento germanico-romanzo, che il giovane irrequieto Èjchenbaum, approdato dalla provincia nella capitale, dopo avere vagato per stra-de e corridoi, finalmente trova il suo ubi consistam e il respiro europeo che andava da tempo cercando :
Ed ecco che senza uscire di strada improvvisamente capitai in Europa – cioè nel 4o audi-torio. Mi trovai nell’atmosfera del romanticismo tedesco, della lirica provenzale, dell’epos antico-francese, della « Divina Commedia » di Dante. Le mie ricerche erano terminate. […]
E così mi misi in cammino per tutta l’Europa – un rimedio antico ed evidentemente utile. […] I miei compagni di viaggio erano giovani pietroburghesi, alcuni dei quali in seguito si trasferirono del tutto in Europa, altri rimasero a propagandare la letteratura europea sul suolo russo. 5
1 Boris Èjchenbaum, La teoria del « metodo formale », cit., pp. 34-35 (trad. it. di Carlo Riccio).2 « Una meschina fedeltà ai fatti, una diligente ma sterile accumulazione delle più disparate fram-
mentarie conoscenze senza alcun autentico sforzo interpretativo e integrativo – ecco cos’erano in Russia gli studi accademici di letteratura alla vigilia della prima guerra mondiale » (Victor Erlich, Il formalismo russo [1954], trad. it., Milano, Bompiani, 1966, p. 56). Si può ricordare, di contro, l’ottima reputazione goduta in questo periodo dagli studi accademici russi in altre discipline, come per esempio il folclore. Cfr. Rossana Platone, Introduzione a Saggi russi di teoria letteraria, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1995, p. 18.
3 L’espressione, divenuta ormai pressoché formulaica, è anche il titolo di un capitolo del classico studio di Erlich, op. cit., pp. 127-150.
4 Cfr. Catherine Depretto, Peterburgskij Universitet i serebrjannyj vek [L’Università di Pietroburgo e il secolo d’argento], in Sankt Peterburg : okno v Rossiju. 1900-1935 [San Pietroburgo : una finestra sulla Russia], Sankt Peterburg, Feniks, 1997, p. 88.
5 Boris Èjchenbaum, Moj vremennik. Slovesnost’. Nauka. Kritika. Smes’ [Il mio periodico. Letteratura. Scienza. Critica. Miscellanea], Izdatel’stvo pisatelej v Leningrade, 1929, pp. 36-37 ; ora ripubblicato insie-
stefania sini54
È allora opportuno menzionare qui il celebre seminario puškiniano organizzato e diretto a partire dal 1908 fino al 1917 da Semën Afanas’evic ˇ Vengerov (1855-1920) e che vide tra i suoi partecipanti Èjchenbaum, Tynjanov, Tomaševskij. Le testimonianze concordano nel ritenere questo seminario il luogo di gestazione dell’opojaz, resa possibile grazie soprattutto alla straordinaria libertà di parola concessa e sollecitata da Vengerov. 1 Benché Semën Afanas’evic non fosse parti-colarmente propenso alle « anatomizzazioni » dei testi eseguite da alcuni dei suoi studenti più sfrontati, 2 e benché i suoi gusti letterari fossero sostanzialmente tradizionalisti, il Professore che con « frequenti passettini attraversava il corri-doio circondato dalla barba e dagli studenti » e sul quale circolavano allegri ca-lembour, 3 svolse un ruolo ben più che aneddotico nella costituzione del gruppo che avrebbe tra breve intrapreso la battaglia per la palingenesi dello studio della letteratura. 4
Lo stesso, a maggior ragione, si può affermare di Ivan Aleksandrovic ˇ (o Jan Ignacy) Baudouin de Courtenay (1845-1929), docente presso la facoltà storico-fi-lologica di Pietroburgo, eminente linguista di origine polacca, membro dal 1881 della Société de linguistique di Parigi, dove intesse un fecondo scambio scientifico
me a Maršrut v bessmertie [Percorso per l’immortalità], Moskva, Agraf, 2001 (il passo citato è a p. 39). Si può notare come il capitolo di Moj vremennik dedicato all’ingresso del giovane Èjchenbaum nell’Univer-sità di Pietroburgo rechi l’eloquente titolo di Putešestvie po Evrope [Viaggio per l’Europa].
1 « Vengerov’s seminar was marked by lively debate, disagreements, and tolerance of the most varied points of view. Vengerov himself had been dismissed from the university for “political unreliability” in 1899, apparently for criticizing the governement’s educational policy, and he was able to return only af-ter the revolution of 1905. When he created the Pushkin seminar in 1908, he allowed his students every opinion, and the students appreciated this, knowing that Vengerov’s seminar was the one place where they could say whatever they thought. It has been described as “a literary club, a student garret, a hall of parliament, and an auction of philological truths – all at the same time”. [...] Part of the excitement of the seminar stemmed from who was in it – writers, critics, and students all came together to study under Vengerov. [...] It was at one of these sessions that Eikhenbaum first noticed Iurii Tynianov, who would one day become his close friend and colleague in working out a new poetics » (Carol Any, Boris Eikhenbaum. Voices of a Russian Formalist, Stanford California, Stanford University Press, 1994, pp. 15-16). Cfr. Erlich, op. cit., pp. 60-61. Su Vengerov cfr. anche James M. Curtis, Boris Èjchenbaum : ego sem’ja, strana i russkaja literatura [Boris Èjchenbaum : la sua famiglia, il suo paese e la letteratura russa], Sankt Peterburg, Akademiceskij proekt, 2004, pp. 67-72.
2 Cfr. Curtis, op. cit., p. 72 ; Any, op. cit., p. 42.3 Cfr. Èjchenbaum, Moj vremennik, cit., p. 38 (ed. 2001, p.41) : Semën Afanas’evic ˇ Vengerov « melkimi
šažkami chodil po koridoru, okružennyj borodoj i studentami. O nem šutili : “Semën prosemenil v proseminarij” » [Semën passava a passettini nel seminario (nella traduzione va inevitabilmente perduta la paronoma-sia)].
4 Ricorda Lidja Ginzburg : « Tynjanov raccontava ai suoi studenti (non senza un implicito rimprove-ro) che una volta aveva domandato a S. A. Vengerov in quali numeri del ‘Kolokol’ di Gercen fossero stampati certi articoli. “Come – disse Vengerov – io vi lascio all’università e voi non avete ancora letto tutto il ‘Kolokol’ ? Ma come è possibile ?” E Tynjanov raccontava di questo con piacere, ammirando nel vecchio professore il gusto per il materiale » (Lidja Ginzburg, Tynjanov - literaturoved [Tynjanov - studioso della letteratura] [1965, 1974], in Idem, Zapisnye knižki. Vospominanja. Èsse [Libretti di appunti. Ricordi. Saggi], Sankt Peterburg, Iskusstvo-spb, 2001, p. 460). (Lo stesso episodio è ricordato anche in celovek za pis’mennym stolom. Èsse. Iz vospominanij. Cµetyre povestvovanija [Una persona alla scrivania. Sag-gi. Dai ricordi. Quattro narrazioni], Leningrad, Sovetskij Pisatel’, 1989, p. 4).
di nuovo sul formalismo russo 55
con Ferdinand de Saussure, guadagnandone la stima. 1 Insieme all’allievo e sodale Mikolaj Kruszewski, de Courtenay non solo è responsabile della penetrazione delle idee saussuriane in terra slava, ma sembra anche aver sollecitato nell’illustre ginevrino approfondimenti e rifiniture dell’impianto teorico che andrà a confi-gurarsi nel Cours de linguistique générale. 2 Punto di riferimento della « Scuola di Kazan », Baudouin è maestro di studiosi come Viktor Vladimirovic Vinogradov (1894-1969), Lev Vladimirovic ˇ Šc ˇerba (1880-1944), Evgenij Polivanov e Lev Jakubin-skij. 3 Se Vinogradov può considerarsi un ‘fiancheggiatore’, almeno per un certo periodo della sua vita, del metodo formale, « senza mai, per altro, accettare le tesi estreme dei formalisti », 4 così come Šcerba mostra di condividerne alcuni assun-ti, 5 Polivanov e Jakubinskij invece prendono parte diretta e attiva alle iniziative dell’opojaz, fornendo al movimento il sostegno della moderna linguistica, una di-sciplina che si vuole solida e scientifica, capace di porsi alla testa della marcia della ‘specificazione’, e di affrancare così lo studio della letteratura dalle speculazioni filosofiche, dal forzoso determinismo positivistico dei vecchi ‘metodi estrinseci’ e dalle fumisterie della critica impressionistica. 6
1 Cfr. Notizie biografiche e critiche su F. de Saussure, in Ferdinand de Saussure, Corso di linguistica gene-rale, Introduzione, traduzione e commento di Tullio De Mauro, Roma-Bari, Laterza,1987, pp. 306-308.
2 « Non è d’altra parte improbabile che il Versuch einer Theorie phonetischer Alternationen. Ein Kapitel aus der Psychofonetik (Strasburgo 1895) di Baudouin possa aver rafforzato in S.[aussure] la convinzione […] circa la separazione di due discipline, una dei suoni, l’altra delle entità differenziali […] e che una serie di suggerimenti (circa sintagmatica e associatività, sistematicità dei fatti linguistici ecc.) sia venuta a S. dalla lettura degli scritti di Kruszewski […]. Oltre gli eventuali suggerimenti singoli, S. deve aver ricavato dalla conoscenza di B[audoin] e di Kruszewski la coscienza di non essere il solo ad avvertire l’importanza d’una teoria generale della lingua e d’una teoria della linguistica » (ivi, pp. 307-308). Cfr. d’altra parte la critica di Jakobson al concetto saussuriano di « arbitrarietà » cui viene contrapposta la visione alternativa di Kruszewski, in Roman Jakobson, Segno e sistema del linguaggio (1959), in Idem, Lo sviluppo della semiotica, Milano, Bompiani, 1978, pp. 101-102.
3 Cfr. Depretto, op. cit., pp. 87-88.4 Eridano Bazzarelli, Presentazione, in Viktor Vinogradov, Stilistica e poetica (1963), trad. di E.
Bazzarelli e Anna Maria Carpi, Milano, Mursia, 1972, p. vi. Cfr. Vinogradov, Iz istorii izuc ˇenija poètiki [Dalla storia dello studio della poetica], « Izvestija an cccp – serja literatury i jazyka », n. 3, 1975, pp. 259-272. 5 Cfr. Any, op. cit., p. 44.
6 È di Jakubinskij, per esempio, la nota distinzione tra linguaggio pratico « in cui le rappresenta-zioni linguistiche (suoni, morfemi, ecc.) non hanno valore in sé, ma sono soltanto mezzo di comuni-cazione » e linguaggio poetico, « in cui gli scopi pratici passano in secondo piano […] e le combina-zioni linguistiche acquisiscono valore in sé » (O zvukach stichotvornogo jazyka [Sui suoni del linguaggio poetico], in Poetika. Sbornik po teorii poeticeskogo jazyka [Raccolta sulla teoria del linguaggio poetico], vyp. i, Pietrograd, 1916, pp. 37). Tale raffronto « costituì il punto di partenza del lavoro dei formalisti sui problemi fondamentali della poetica » (Èjchenbaum, La teoria del metodo formale, cit., p. 37). Come osserva Peter Steiner, secondo la visione funzionalista di Jakubinskij, « language can be conceptuali-zed as a means-end structure serving particular goals. [...] For Jakubinskij, it was not the subjective intentions of the speaker but the objective correlation of linguistic means and ends that distinguished poetic from practical language. [...] Jakubinskij’s distintion between language as a means of com-munication and language a self-valuable end should remind us of Kruc ˇënych’s distintion between common language and zaum’ » (Peter Steiner, Russian Formalism. A Metapoetics, Ithaca - London, Cornell University Press, 1984, p. 149.Trad. it., Bologna, Il Mulino, 1991). Sia Jakubinskij che Polivanov, inoltre, propongono una serie di importanti riflessioni sull’espressività dei suoni linguistici di cui terranno conto i formalisti non appena si interesseranno agli aspetti fonetici del linguaggio poetico. Cfr. ivi., pp. 156-160.
stefania sini56
Del resto, come si vedrà meglio in seguito, 1 l’insegnamento costituisce per molti opojazovcy l’esito naturale della loro attività intellettuale e il luogo privi-legiato della messa a punto e la trasmissione delle loro proposte teoriche. Dal momento poi che l’istituzione universitaria, pur con tutti i cedimenti e i punti di fragilità del caso, rappresenta comunque per un gruppo di ricerca con ferme pretese epistemologiche un orizzonte di riferimento ineludibile e una garanzia certa di legittimazione, non si può non intravedere nel rapporto ambivalente tra formalismo russo e accademia un paradosso difficilmente sanabile e gravido di conseguenze. 2
3. Il gene dell’avanguardia
Il punto è che l’ambiziosa impresa di fondazione di una scienza letteraria autono-ma trova subito alleati di ben altra schiatta rispetto ai professori dell’Università. Infatti, la prima apparizione pubblica in cui si danno a conoscere i nascituri opoja-zovcy è l’evento organizzato dai futuristi Vecer o novom slove [Serata sulla nuova parola] l’8 febbraio 1914 a Pietroburgo in una sala del Teniševskoe Uc ˇilišce [Istituto Teniševskoe] al n. 35 di via Mochovaja. L’incontro viene presieduto proprio da Baudouin De Courtenay. Coincidenza significativa : in questa stessa sede, tredici anni dopo, il 6 marzo 1927, avrà luogo la celebre disputa tra marxisti (in gran parte docenti) e formalisti che segnerà l’inizio della capitolazione del movimento sotto gli attacchi di avversari sempre più torvamente minacciosi. 3 Boris Tomaševskij, il primo a parlare, tirando le somme della storia del movimento, ricorderà la lonta-na serata futurista :
Tra la gioventù universitaria si formò un gruppo. Questo gruppo intervenne sulla stam-pa, e allora, in questo locale, avvenne una rumorosa disputa. Ricordo che Baudouin de Courtenay fuggì dal posto del presidente e giurava che non avrebbe mai più presieduto dispute letterarie. 4
Con icastica concisione Tomaševskij rievoca sulla scena il Professore che fugge inorridito dalle intemperanze di giovani sedicenti poeti decisi a rovesciare « gli sporchi marchi » « del Buon senso » e del « del Buon gusto ». Il rappresentante del-l’Università, l’autorevole linguista, capitola di fronte agli improperi scagliati con-tro « l’angusto passato », contro « l’Accademia e Puškin più incomprensibili dei geroglifici », in nome della « parola in quanto tale », della lingua « che dev’essere
1 Cfr. infra, par. 4.2 « […] uno dei paradossi che costituì “la molla” dell’attività teorica della scuola formale consisteva
nel fatto che i formalisti conducevano la loro lotta per la scientificità contro l’accademismo. Interveni-vano contro la scienza che già esisteva, ma non tanto come insieme speciale di conoscenze e di tecniche della loro ricezione e verifica, ma innanzi tutto in qualità di istituto sociale, infarcito di cattedre univer-sitarie e accademiche, di giornali ecc. » (Dmitriev-Levc ˇenko, op. cit., pp. 218-219).
3 Cfr. infra, par. 6.4 Denis Ustinov, Materialy disputa « marksizm i formal’nyj metod » 6 marta 1927. I. Doklad B. V.
Tomaševskogo [Materiali della disputa « marxismo e metodo formale » del 6 marzo 1927. Relazione di B. V. Tomaševskij], « Novoe literaturnoe obozrenie », cit., p. 252.
di nuovo sul formalismo russo 57
innanzi tutto lingua, e se deve ricordare qualcosa, piuttosto ricordi la sega e la freccia avvelenata del selvaggio ». 1 Ecco il tratto somatico più appariscente del movimento formalista, il suo legame costitutivo con l’oltranzismo rivoluzionario dei futuristi, i quali, armati di versi inauditi e di una condotta ostentatamente stra-vagante, chiassosa, eversiva, travolgono idoli, autorità intoccabili, tradizioni e isti-tuzioni. 2 E tale legame si manifesta innanzi tutto nell’intransigenza manichea con cui entrambi i gruppi demarcano i confini tra il proprio fronte e quello dei rivali : « Troviamo per esempio un adeguamento concettuale e operativo alla formula « chi non è con noi è contro di noi » negli slogan, nel comportamento culturale e sociale dei futuristi già negli anni ’10 […] e in seguito anche nei formalisti ». 3
L’alleanza perseguita dagli opojazovcy con questi artisti eccentrici e sregolati si fonda, com’è noto, su forti e duraturi vincoli di amicizia, sulla frequentazione assidua nelle abitazioni private oltre che nei luoghi pubblici. 4 Ma è radicata altresì in una florida humus di premesse comuni, a cominciare dal dogma dell’autonomia dell’arte, tradotto nella teoria e nella pratica della parola che ha valore di per sé (samocennoe, samovitoe slovo) e della lingua trasmentale (zaumnyj jazyk). In un con-testo storico incandescente, segnato da un fervore intellettuale e creativo straor-dinario, i formalisti si trovano a operare nella grande fucina di sommovimenti, smottamenti e sperimentazioni in atto in ogni campo della produzione artistica, dove gli incontri e le intersezioni tra le diverse pratiche invadono la scena cultu-
1 Cfr. i manifesti futuristi Pošcecina obšcestvennomu vkusu [Schiaffo al gusto del pubblico] (1912), fir-mato da David Burljuk, Aleksandr Krucenych, Vladimir Majakovsikj e Viktor Chlebnikov e Slovo kak takovoe [La parola in quanto tale] (1913), firmato da Krucenych e Chlebnikov, in Literaturnye manifesty. Ot simvolizma do « Oktjabrja » [Manifesti letterari. Dal Simbolismo a « Ottobre »], sostaviteli N. L. Brodskij i N. P. Sidorov, Moskva, Agraf, 2001 (i ediz. 1924), pp. 129-132 ; 137-140. Cfr. Giorgio Kraiski, Le poetiche russe del Novecento. Dal simbolismo alla poesia proletaria, Bari, Laterza, 1968, pp. 98 ; 101.
2 Cfr. Erlich, op. cit., pp. 42-52.3 Denis Ustinov, Materialy disputa « marksizm i formal’nyj metod » 6 marta 1927 [Materiali della disputa
« marxismo e metodo formale » del 6 marzo 1927], cit., p. 252.4 Il riferimento più immediato è naturalmente l’amicizia tra Majakovskij e i coniugi Brik, su cui
cfr. Lilja Brik, Pristrastnye rasskazy [Racconti appassionati], 2-e izdanie, ispravlennoe i dopolnennoe, sosteviteli Ja.I. Grojsman, I Ju. Gens, N. Novgorod, Dekom, 2003. Così Lilja Brik ricorda la costante vicinanza del poeta ai primi lavori del marito e alle discussioni dei formalisti » : « Io conoscevo a memo-ria tutti i versi di Volodja, e Osip vi si immerse. Da questo momento cominciarono anche i cosiddetti “moscerini” [kozjavki, tradotto in Erlich, op. cit., p. 72, con ‘geroglifici’]. Chiamavo così i segni di cui Osja riempiva i quaderni. […]. Osja lavorava dalla mattina alla sera. […] E come sono fatti (kak sdelany) i versi di Puškin ? Perché sono geniali ? Come decifrare il loro enigma ? E Osip Maksimovic ˇ ‘smontava” (razvincival) senza fine Puškin, Lermontov, Jazykov, riempiva pile di carta di segni, dai quali poi appar-vero le “ripetizioni di suono” (svukovye povtory). Dopo le “ripetizioni di suono” cominciò a lavorare alle “figure ritmico-sintattiche” (ritmiko-sintaksiceskie figury). Ci furono conversazioni con Jakobson, Šklovskij, Jakubinskij, Polivanov. […] I filologi si riunivano da noi. Vagliarono temi, scrissero articoli. Gli articoli venivano letti ad alta voce e discussi. Brik pubblicò la prima “Raccolta sulla teoria del lin-guaggio poetico” [Sbornik po teorii poètic ˇeskogo jazyka]. È interessante che in entrambe le raccolte del-l’Opojaz non vi sia alcuna citazione dai versi di Majakovskij, alcun riferimento a loro, solo una volta è menzionato di sfuggita il nome di Majakovskij. Gli opojazovcy, nonostante l’amore per i suoi versi, non lo avvicinavano ancora. Majakovskij poteva ascoltare per ore le conversazioni degli opojazovcy. Non smetteva di chiedere a Osip Maksimovic ˇ : “E allora ? Hai trovato qualcosa ? Cosa hai trovato ancora ?” Si faceva raccontare di ogni nuovo esempio » (Lilja Brik, op. cit., pp. 47-49).
stefania sini58
rale di testi, esecuzioni, artefatti immancabilmente improntati all’assioma della novità. 1
Di qui il tenore provocatorio e il volume alto di molte affermazioni dell’opojaz, di qui quegli slogan su cui poi si dirigeranno gli strali degli avversari. E i più intel-ligenti di loro non si fermeranno al semplice infastidito rilievo degli eccessi pole-mici, ma vedranno tali eccessi agire in profondità all’interno dell’impianto teorico dei formalisti, sino a determinarne la configurazione dell’oggetto di studio. Per esempio Pavel Medvedev, nella sua serrata analisi del « metodo formale nella scien-za della letteratura » (Formal’nyj metod v literaturovedenii, 1928), valutando i risultati metodologici del primo periodo del movimento, « strettamente intreccia[ti] con il programma artistico e gli interessi progettuali del futurismo », osserva :
Le negazioni polemiche, penetrando nelle definizioni formaliste, hanno condotto a ciò, che la stessa costruzione artistica è diventata secondo la loro teoria una costruzione inte-ramente polemica. Ciascuno dei suoi elementi realizza il proprio compito costruttivo solo negando qualcosa ed essendo diretto polemicamente verso qualcosa. […]
La polemica dei formalisti, condotta all’estremo, dal loro lavoro di ricerca è penetrata nello stesso oggetto di ricerca, conferendo ad esso un tono polemico. La costruzione poe-tica in quanto tale si è trasformata in costruzione polemica. 2
In effetti, alle più interessanti definizioni formalistiche dell’opera letteraria pertie-ne una concezione fortemente drammatica, agonistica, secondo cui le relazioni
1 Non è qui la sede per soffermarsi sui molteplici legami che intercorrono tra il movimento formale e i protagonisti delle diverse arti, come la musica, il teatro, la fotografia, il cinema (per il quale alcuni di loro, come Šklovskij e Tynianov, lavorano). Tanto meno è possibile dare conto sia pur sommariamente dei contatti e delle intersezioni tra le diverse pratiche artistiche di questo periodo. Si può solo ricordare il caso emblematico della feconda collaborazione tra Kazimir Severinovic ˇ Malevic ˇ e Chlebnikov avviata a partire dagli anni ’10. Il pittore illustra infatti le edizioni : V. Chlebnikov, A. Krucenych, E. Guro, Troe [Tre], SPb, 1913 ; A. Krucenych, V. Chlebnikov, Slovo kak takovoe, SPb 1913 (alle illustrazioni collabora O. Rozanova) ; A. Kruc ˇenych, Pobeda nad Solncem [Vittoria sul sole], Prolog V. Chlebnikova, SPb, 1913 ; A. Kruc ˇenych, V. Chlebnikov, Igra v Adu [Gioco nell’inferno], Dop. Izd., SPb, 1914 (anche qui con la Rozanova) ; V. Chlebnikov, Rjav ! Perc ˇatki [Rrr ! Guanti], SPb, 1914. « Nella primavera del 1917 Malevic fu inserito da Chlebnikov nel Governo della Sfera Terrestre (Pravistel’stvo Zemnogo Šara), diventandone uno dei Presidenti. Nei “disegni ombreggiati” (tenevye certeži) di Malevic (così il poeta aveva denomina-to i disegni suprematisti del 1916-1917), con la loro aspirazione ad esprimere la nuova esperienza cosmica dell’umanità, Chlebnikov trovò proporzioni multiple del sacro 365. Chlebnikov li analizzò nelle tesi del-l’articolo “La testa dell’universo, il tempo nello spazio” [Golova vselennoj, vremja v prostranstve] (RGALI. F. 665. Op. 1. Ed. chr..32) » (S. G. Boc ˇarov, V. Radziševskij, V. F. Tejder, V. V. Kožinov, F. D. Ašnin, A. M. Kuznecov, L. S. Melichova, N. I. Nikolaev, A. S. Šatskich, Kommentarii, in M. M. Bachtin : besedy s V. D. Du-vakinym [conversazioni con Duvakin], Moskva, Soglasie, 2002, pp. 343-344). Cfr. Rainer Crone, David Moos, Kazimir Malevich : The Climax of Disclosure, Chicago, Chicago University Press, 1991.
2 Pavel N. Medvedev, Formal’nyj metod v literaturovedenii [Il metodo formale nello studio della letteratura, 1928], in M. M. Bachtin, (pod maschoj) [dietro la maschera], sostavlenie, tekstologic ˇeskaja podgotovka I. V. Peškova ; kommentarii V. L. Machlina, I. V. Peškova, Moskva, Labirint, 2000, pp. 243-245. (Questa è dunque una delle ‘opere controverse’ attribuite a Michail Bachtin, o ascritte al suo magiste-ro). Sulle possibili correlazioni e influenze tra il comportamento sociale e di gruppo dei formalisti e la formulazione delle loro teorie, cfr. Marieta O. C µudakova, Social’naja praktika, filologic ˇeskaja reflekcija i literatura v nauc ˇnoj biografii Èjchenbauma i Tynjanova [Pratica sociale, riflessione filologica e letteratura nella biografia scientifica di Èjchenbaum e Tynjanov], in Tynjanovskij sbornik. Vtorye tynjanovskie ctenija [Raccolta tinjanoviana. Seconde letture tynjanoviane], Riga, Zinatne, 1986, pp. 103-131.
di nuovo sul formalismo russo 59
tra gli elementi costruttivi si configurano come pressione reciproca, lotta per la supremazia, e dove i termini utilizzati rivelano una flagrante emergenza dell’area semantica polemologica. Per esempio dichiara Èjchenbaum in Melodica del verso lirico russo :
L’opera d’arte è sempre il risultato di una lotta complessa di distinti elementi formativi, è sempre una sorta di compromesso. Questi elementi non coesistono semplicemente, e non « corrispondono » semplicemente l’uno all’altro. A seconda del carattere generale dello stile, questo o quell’altro elemento ha significato di dominante organizzativa. 1
Ancora più recisa è la nota affermazione di Tynjanov :
L’unità del’opera non è un intero (celost’) chiuso e simmetrico, ma un’integrità (celostnost’) dinamica in sviluppo ; tra i suoi elementi non vi è il segno statico dell’uguaglianza e del-l’addizione, ma vi è sempre il segno dinamico della correlazione e dell’integrazione. […]
L’arte vive di questa interazione, di questa lotta. Senza la sensazione della sottomisssio-ne, della deformazione di tutti i fattori da parte del fattore che svolge il ruolo costruttivo, non vi è fatto d’arte. 2
Se l’osservazione di Medvedev, estrapolata dal contesto, può apparire riduttiva rispetto alle articolate implicazioni teoriche che informano tale concezione del-l’opera letteraria, resta il fatto che dell’aggressività dei loro slogan, delle dichiara-zioni a voce alta, gli « specificatori » 3 dovranno infine dar ragione non senza una buona dose di storicizzante consapevolezza. Così Èjchenbaum in La teoria del « me-todo formale » :
Parlando del metodo formale e della sua evoluzione, non bisogna dimenticare che molti principî avanzati dai formalisti negli anni di contesa accanita cogli avversari avevano un valore non soltanto di principî scientifici, ma anche di slogan inaspriti fino al paradosso a scopi propagandistici e di lotta. Non tener conto di questo fatto e considerare i lavori dell’« Opojaz » del 1916-21 come lavori di carattere accademico significa ignorare la storia. 4
E a proposito delle rumorose apparizioni pubbliche del movimento, in territori usualmente poco frequentati dai cultori di filologia :
« L’uscita in strada » fu spontanea e assolutamente naturale così come lo fu prima di questa l’uscita in strada dei futuristi. 5
Altrettanto storicizzante, ma proiettata sulla vasta latitudine epocale, è l’afferma-zione di Tomaševskij :
1 Èjchenbaum, Melodika russkogo liriceskogo sticha [1921], in Id., O poèzii [sulla poesia], vstupitel’anaja stat’ja Vl. Orlova, Leningrad, Sovetskij Pisatel’, Leningradskoe otdelenie, 1969, p. 332. A proposito del termine « dominante », cruciale per l’impianto teorico del formalismo, Èjchenbaum rinvia in nota alla traduzione russa di Broder Kristiansen, Philosophie der Kunst [1911].
2 Jurij Tynjanov, Problema stichotvornogo jazyka (1924), in Idem, Literaturnaja èvolucja. Izbrannye tru-dy [L’evoluzione letteraria. Opere scelte], Sostavlenie, vstupitel’anaja stat’ja, kommentarij Vl. Novyko-va, Moskva, Agraf, 2002, pp. 33-34. Trad. it., Il problema del linguaggio poetico, Milano, Il Saggiatore, 1968.
3 « Non ci interessa la parola “forma”, ma soltanto una sua particolare sfumatura. Noi non siamo “formalisti”, ma, se si vuole, specificatori » (Èjchenbaum, Vokrug vosprosa o « formalistach » [Intorno alla questione sui formalisti], cit., p. 3). 4 Idem, La teoria del metodo formale, cit., p. 51.
5 Idem, Vokrug vosprosa o « formalistach », cit., pp. 5-6.
stefania sini60
Sì. L’Opojaz parlava con il tono della pubblicistica gridata. E parlava così proprio perché questo è il tono della modernità. 1
Senz’altro, questo tono caratterizza un’intera epoca percossa dagli eventi dram-matici della guerra e della Rivoluzione. 2 Un’epoca attraversata dal convulso incal-zare di poetiche in conflitto tra loro, di rutilanti scenari orgogliosamente inaugu-rati e custoditi dai vari movimenti artistici in nome dell’inedito e dell’estraniante. In un contesto siffatto, i giovani formalisti non possono che farsi scudo di quell’ « assiologia del nuovo » che li condurrà in difficoltà, se non all’impasse teorica, nel momento in cui dovranno fare i conti con la storia. 3
4. Eterogeneità e lacerazioni
Il difficile accordo tra il lavoro di ricerca e l’elaborazione di un rigoroso paradigma scientifico da parte di studiosi provenienti dall’università o gravitanti intorno ad essa, da un lato, e la roboante militanza di intellettuali schierati nelle file dell’avan-guardia, dall’altro, rivela già con sufficiente evidenza la difformità problematica inscritta nel codice genetico dell’opojaz. Delle istanze eteroclite che concorrono alla sua nascita sono del resto pienamente consapevoli gli stessi formalisti, che ne forniscono non di rado testimonianza retrospettiva. Ecco come per esempio esse trovano espressione nei ricordi sincopati di uno degli opojazovcy più brillanti e impertinenti, Viktor Šklovskij :
1 Boris Tomaševskij, Formalnyj metod : (Vmesto nekrologa) [Il metodo formale (in luogo di necrolo-gio)], in Idem, Sovremennaja literatura. Sbornik statej, Leningrad, 1925, p. 151
2 « Le clamorose esagerazioni di questa prima fase si possono per gran parte attribuire alla combatti-vità naturale in una giovane scuola critica decisa ad ogni costo a differenziarsi dai suoi predecessori ; ma le esagerazioni, in parte volute, del primo Šklovskij e del primo Jakobson si possono anche giustificare mettendole in rapporto con il costume futurista di scandalizzare i filistei. […] Il tono stridente delle pubblicazione dell’Opojaz non fu soltanto un’eco degli schiamazzi futuristi, poiché rispecchiava, non diversamente da questi ultimi, il carattere di una generazione. Tra il 1916 e il 1921, gli anni tumultuosi e ricchi d’avvenimenti della guerra e della rivoluzione, bisognava urlare per farsi intendere sulla piazza del mercato delle idee » (Erlich, op. cit., p. 81).
3 « Il programma delle avanguardie fa propria […] una concezione della modernità come divenire, proiezione verso il futuro, esplorazione del possibile. In questo senso, non è sorprendente che il Nuovo assuma una connotazione assiologica. Peccato che, di per sé, la nozione di novità sia assolutamente adiafora, e che quindi identifichi un principium individuationis a dir poco labile, se non affatto specioso e inconsistente. La verità è che si tratta anche qui di una nozione autofagica. Non tanto perché il nuovo di oggi si candida sin d’ora a essere il vecchio di domani. O perché un programma antiletterario non può sortire altro esito che una pratica iperletteraria : quasi tutte le tecniche dello sperimentalismo trovano qualche riscontro più o meno peregrino nella minuziosa mappa classificatoria dell’antica retorica, a co-minciare dalla mixtura verborum. La differenza, e non è sicuramente una differenza trascurabile, è che la retorica le registrava come licenze a cui far ricorso in circostanze estreme e a dosi omeopatiche, la teo-ria modernista le erige a regola. Ma se in teoria il significato e il valore estetico di un testo coincidono con l’ostensione della sua differenzialità, allora qualsiasi altro testo egualmente trasgressivo, a stretto rigore, ne sarà un sinonimo e avrà uguale merito artistico. Anche qui, insomma, ci si attenderebbe da ultimo una catastrofica reductio ad unum » (Franco Brioschi, Assiologie della modernità, in Idem, Critica della ragion poetica, cit., p. 32).
di nuovo sul formalismo russo 61
In un buio auditorio faceva lezione Baudouin de Courtenay, filologo che ha cambiato mol-to nella sua scienza, ma che non ha potuto scrivere il libro. Il libro l’ha poi scritto Meillet.
Il primo anno di permanenza alla facoltà filologica il filologo doveva dare l’esame di lingua greca, raggiungendo la capacità di tradurre un libro di Senofonte.
Io non l’ho dato.A quel tempo comparvero i futuristi. […]Allora compresi l’arte come sistema indipendente. […] Con un libretto di 32 pagine
in caratteri ciceroniani mi presentai da Baudouin de Courtenay (« La risurrezione della parola »).
È un grande vecchio assurdo.Mi trovai nell’appartamento del professore […].Baudoin è un re di Gerusalemme, come lui scrisse una volta […]. Baudouin, o Baldovi-
no, è sicuramente un discendente del primo re di Gerusalemme.Mi ascoltò e mi presentò a Lev Jakubinskij. […]Di Baudouin c’è poco da dire. Presiedette alla riunione e alla fine parlò di scienza e
democrazia. Ma non punse.Diventai amico di Jakubinskij. 1
Da parte sua, Boris Tomaševskij si interroga con ironica mestizia sugli spuri cro-mosomi della creatura, ch’egli dichiara ormai deceduta, i cui primi vagiti avevano fatto sobbalzare gli illustri professori :
Da dove era venuto il formalismo ? Dagli articoli di Belyj, dal seminario di Vengerov, dalla sala [dell’Istituto] Teniševskij, dove i futuristi rumoreggiavano sotto la presidenza di Bau-douin De Courtenay ? Lo deciderà il biografo del defunto. Ma, indubbiamente, gli strilli del bambino si sentivano da tutte le parti […]. S.A. Vengerov, avendo sentito gli strilli del bambino in seno al suo seminario, dove inaspettatamente per lui risuonarono le relazioni sulla cesura del pentamentro giambico, della costruzione ad anello dell’Autunno di Puškin, guardò desolatamente il neonato, ma poi, a malincuore, lo benedisse. 2
La risposta del « biografo » non può che appellarsi alla eterogeneità difforme. Di fatto, poi, lo stigma originario si accentua e complica con la crescita e lo sviluppo della scuola. A partire dai primi anni Venti, quando inizia il « secondo periodo » del formalismo, via via che le discussioni si infittiscono e gli studiosi maturano le pro-prie convinzioni teoriche pubblicandone i relativi risultati, prolifera la varietà di prospettive e metodi. 3 Come peraltro hanno osservato gli esperti più autorevoli
1 Viktor Šklovskij, Tret’ja fabrika [La terza fabbrica] (1926), in Idem, Ešce nicego ne koncilos’’[Non è ancora finito nulla], predislovie A. Galuškina ; kommentarii A. Galuškina, V. Nechotina, Sankt Peter-burg, Propaganda, 2002, pp. 350-354.
2 B. Tomaševskij, Formal’nyj metod, cit., pp. 146-147. Cfr. Steiner, op. cit., p. 16 (dove tutto il primo capitolo è dedicato alla « mancanza di consenso tra gli studiosi » e alla « resistenza alla sintesi » del for-malismo russo).
3 Dmitriev e Levcenko distinguono « una prima fase di sviluppo del formalismo, prospettivamente riduzionistica e una seconda, che traccia « una poetica storica in generale o un approccio “sistemati-co-funzionale” del formalismo della prima metà degli anni ’20 » (op. cit., p. 218). « Il primo periodo di sviluppo della scuola formale è stato contrassegnato dalla riduzione del possibile campo di oggetti alla categoria dell’“oggetto estetico” in quanto risultato di straniamento, deautomatizzazione dell’im-pressione, di ostacolo della percezione. Dall’inizio degli anni ’20, “il centro di gravità si sposta dalla
stefania sini62
(in particolare Viktor Erlich e Peter Steiner), l’accordo tra i formalisti è tutt’altro che unanime ; la vis agonistica e i toni polemici che contrassegnano il movimento nei confronti degli avversari corrisponde sempre meno a un fronte compatto di opinioni armoniosamente coerenti. E anche di ciò si accorgono presto i contem-poranei :
Nel secondo periodo di sviluppo del formalismo russo, dagli anni 1920-1921, inizia un certo dissidio tra i suoi rappresentanti e l’isolamento di quelle tendenze e quegli elementi che inizialmente, nel primo periodo, erano fusi in esso.
Questo dissidio si rafforza per il fatto che al gruppo iniziale degli opojazovcy si unisce una serie di nuovi fiancheggiatori e compagni di viaggio.
In rapporto alla necessità di passare dalle dichiarazioni generali di carattere semi-let-terario e semi-scientifico al lavoro specialistico di ricerca, iniziano a separarsi gli interessi scientifico-specificatori. Lo studio e il cabaret (kabinet i èstrada) si dividono […]
Ciò che in precedenza veniva proclamato come « risurrezione della parola », ora, nel secondo periodo, si trasforma nell’orientamento della poetica verso la linguistica. 1
In realtà la situazione è ben più complicata rispetto alla diagnosi di Medvedev ; le divaricazioni in seno al gruppo non si riducono alla polarità « cabaret/studio », e tanto meno la vicenda può parafrasarsi come un percorso di ricerca partito dagli schiamazzi futuristi e approdato di necessità alla capitolazione della poetica di fronte alla linguistica.
Nel 1920, presso l’Istituto di storia delle arti (iii - Institut istorii iskusstv, poi giii - Gosudarstvennyj Institut istorii iskusstv) di Pietrogrado viene inaugurato il Diparti-mento di storia delle arti verbali (Otdelenie istorii slovesnych iskusstv) ; il fondatore e rettore dell’Istituto, il conte Valentin Platonovic ˇ Zubov (1884-1969) chiede a Viktor Maksimovic Žirmunskij (1891-1971) di presiedere il Dipartimento e di reclutare gli insegnanti. 2 In breve tempo la nuova istituzione diventa la « piattaforma naturale
rappresentazione primaria degli atti costitutivi e dai procedimenti costruttivi-secondari alla struttura sintagmatica dell’opera d’arte, alle sue concrete regole di composizione, al sistema di procedimenti e funzioni” » (ivi, p. 218 n, con riferimento a Aage Hansen-Löve, Russkij formalizm. Metodologic ˇeskaja rekonstrukcija razvitija na osnove principa ostranenie [Il formalismo russo. Ricostruzione metodologica dello sviluppo sulla base del principio dello straniamento], Mosca, 2001, p. 219). Secondo L. D. Gudkov, i momenti nodali della storia di opojaz sono : « le idee di Šklovskij di “arte come procedimento” e “straniamento”, i lavori tynjanoviani sulla parodia (prima fase), quindi le nozioni di “fatto letterario” e di “evoluzione letteraria” (seconda fase), e infine l’inizio della crisi teorica e della disgregazione con-cettuale con alcune possibilità, appena profilate, di uscita in uno schema più complesso e generale di comprensione del sistema letterario » (Ponjatie i metafory istorii u Tynjanova i opojazovcev [La nozione e le metafore della storia in Tynjanov e negli opojazovcy], « Tynjanovskich sbornik. Tret’i tynjanovskie ctenija », Riga, Zinatne, 1988, p. 98).
1 Medvedev, op. cit., p. 246.2 Il Zubovskij Institut era stato fondato dal nobile filantropo e cultore delle belle arti nel 1912 nella
sua proprietà in Piazza sant’Isacco 5. Il progetto di fondazione si ispirava all’Istituto tedesco di arte di Firenze, che Zubov aveva conosciuto personalmente e ammirato. Verso la fine del decennio il conte, che era riuscito a far sopravvivere la sua creatura alla tempesta bolscevica grazie a un’abile politica diplomatica e culturale, poté constatare soddisfatto : « ora si riuscì a dare all’Istituto quel carattere che mi ero immaginato alla sua fondazione e che nei primi periodi non si era potuto realizzare per forza di cose. Fu stabilito che innanzi tutto fosse un’istituzione scientifica e di ricerca (ho sentito che dopo la mia partenza fu ridenominata Accademia), e non un istituto superiore (‘Vuz’). Il suo scopo principale furo-
di nuovo sul formalismo russo 63
per l’Opojaz : il Dipartimento di arti verbali si sarebbe occupato di poetica storica e teorica, in particolare dello studio della letteratura in quanto arte, senza dupli-care le funzioni della Facoltà di filologia dell’Università ». 1 Zubov « simpatizza » con l’approccio alla letteratura degli opojazovcy, giacché vi intravede « una paren-tela » con il suo modo di studiare le arti figurative. 2 In effetti Valentin Platonovic ˇ annovera tra i suoi maestri Heinrich Wölfflin, del quale nel 1907 aveva frequen-tato le lezioni all’Università di Berlino. Nelle aule dell’Istituto ha dunque luogo l’incontro tra il formalismo russo e quello che da molte parti è stato definito il « formalismo occidentale » (zapadnoevropejskij formalizm). 3 Vengono chiamati a in-segnare Èjchenbaum (che dirigerà la Sezione di poesia e prosa russa), Šklovskij, Tomaševskij, Tynjanov, Šerba, Vinogradov. 4 Il giii promuove altresì la pubblica-zione periodica dei volumi di Poètika, contenenti gli scritti dei formalisti. 5
Nelle aule del Dipartimento di arti verbali sembrano regnare la feconda colla-borazione tra studiosi e artisti e un libero atteggiamento sperimentale :
no i lavori individuali e collettivi dei suoi membri, letti e discussi nelle riunioni delle sezioni e stampate nella casa editrice ‘Accademia’ associatasi all’Istituto » (Gr. Valentin P. Zubov, Stradnye gody v Rossii. Vospominanija o Revolucii (1917-1925) [Anni di raccolto in Russia. Ricordi della Rivoluzione], München, Wilhelm Fink verlag, 1968, pp. 99-100), ora ristampato a cura di T. D. Ismagulova, Moskva, Indrik, 2004. Sull’Istituto cfr. anche Izol’da Sèpman, Rossijskij institut istorii iskusstv, Sank Peterburg, RIII, 2004.
1 Any, op. cit., pp. 43-44. Lo stesso Zubov precisa come vada intesa la denominazione : « Dipartimento di arti verbali, cioè della letteratura, considerata esclusivamente dal punto di vista della forma » (Otdele-nie slovesnych iskusstv, to est’ literatury, rassmatrivaemoj iskljuc ˇitel’no s toc ˇki zrenija formy) (Zubov, op. cit., p. 99). Così ne racconta la nascita : « Già prima della guerra del 1914 in Russia aveva cominciato a delinearsi un approccio alla letteratura diverso rispetto a quello che ci avevano insegnato a scuola. Interessava non il contenuto, ma esclusivamente la forma. Una serie di ricercatori si occupava di questi problemi, e l’idea della creazione di un centro unificatore girava nell’aria, c’era bisogno soltanto di una spinta. Una sera, non ricordo precisamente in quale anno, ero da Tamara Žukovskaja-Miklaševskaja-Krasina nella Via Puškinskaja. E lì c’era Viktor Žirmunskij […]. Conversammo sul metodo formale in letteratura ; io dissi a Žirmunskij : “Dài, organizziamo insieme un dipartimento di arti verbali nel mio istituto”. Detto – fatto : nel giro di poco tempo il dipartimento era in piedi » (ivi, p. 103). 2 Ibidem.
3 Cfr. Medvedev, op. cit., pp. 221-252, in cui si dedica molta attenzione ad affinità e divergenze tra le tendenze teoriche occidentali, soprattutto di area germanica, di impostazione ‘formale’ (Hanslick, Hildebrand, Fiedler, Wörringer, Wölfflin, Walzel) e il movimento russo. Cfr. Èjchenbaum, La teoria del metodo formale, cit., p. 33. Cfr. anche Elio Franzini, Estetica, teoria dell’arte e scienze dell’uomo. Un itine-rario nell’estetica contemporanea, Milano, Signorelli, 1985 ; René Wellek, Austin Warren, Teoria della letteratura [1942], Bologna, Il Mulino, 1989, pp. 176-188 ; Erlich, op. cit., pp. 60-61.
4 Vanno menzionati anche Sergej Baluchatyj, Boris Engel’gardt, Grigoryj Gukovskij, Boris Kazan-skij (cfr. Any, op. cit., p. 44). Cfr. i nomi elencati da Zubov : « Viktor Žirmunskij era il presidente del dipartimento ; tra i membri ricordo Miron Žirmunskij, fratello gemello di Viktor, Èjchenbaum, Viktor Šklovskij, Michail e Grigorij Leonidovic Lozinskij, Modest L. Gofman, il famoso sinologo Alekseev, Nestor Kotljarevskij, Nikolaj Stepanovic ˇ Gumilëv, B.V. Tomaševskij, Jurij Tynjanov ; erano allora stu-denti, in seguito divenuti famosi, Nikolaj Arkadevic Kovarskij e Venjamin Kaverin » (Zubov, op. cit., p.105 ). Soprattutto, dall’Istituto esce la più brillante degli allievi di Tynjanov, vale a dire Lidja Jakovlevna Ginzburg.
5 La prima raccolta dell’opojaz è Sborniki po teorii poètic ˇeskogo jazyka [Raccolta sulla teoria del lin-guaggio poetico], vyp. i [fascicolo i], Pietrograd, 1916, cui segue il ii nel 1917. Nel 1919 esce Poètika. Sborniki po teorii poètic ˇeskogo jazyka, Pietrograd. Un’altra serie di fascicoli di Poètika esce dal 1926 al 1929 : Poètika, Sbornik statej [raccolta di articoli], Leningrad, Academia (Vremennik Otdela slovesnych iskusstv / giii) [periodico del Dipartimento di arti verbali del giii], vyp i – 1926 ; vyp. ii – 1927 ; Vyp. iii – 1927 ; Vyp. iv – 1928 ; vyp. v – 1929.
stefania sini64
In seguito il Dipartimento si sviluppò e visse di vita propria, e non solo raggiunse signifi-cativi risultati scientifici, ma esercitò persino un’influenza sulla creazione letteraria di quel tempo. Poeti e scrittori vi partecipavano accanto a studiosi, e in questo modo la scienza e l’arte si arricchivano reciprocamente l’una con l’altra. Come esperienza interessante ricorderò il laboratorio di studio del discorso artistico (Kabinet izucenija chudožestvennoj reci) (che gli studenti rapidamente battezzarono con la parola barbara « Kichr »). Lì le voci dei poeti venivano registrate sui cilindri del fonografo, che in seguito erano fatti girare lentamente in relazione con le esigenze dell’analisi. 1
Eppure, nel giro di un paio di anni, cominciano a emergere contrasti e lacerazio-ni. In questo periodo si consuma infatti la frattura tra Èjchenbaum e Žirmunskij, sino ad allora amici fraterni. 2 Anche Vinogradov, come Žirmunskij, viene guarda-to con crescente sospetto. La presenza all’interno dell’Istituto di studiosi « meno radicali rispetto all’Opojaz nelle loro formulazioni teoriche », giacché « non sen-tivano così acutamente l’esigenza di separare l’opera letteraria dal materiale del mondo esterno », 3 spinge i formalisti a rinserrarsi orgogliosi all’interno del pro-prio drappello e ad alzare il tono della polemica. E così amplificano e inaspriscono la « visione di se stessi non come “una tra” le scuole concorrenti, prima tra pari, ma come gli unici difensori dello spirito di scientificità, circondati da retrogradi, invidiosi, epigoni, classificatori, rinnegati, carrieristi, ecc. (il diario di Èjchenbaum e la corrispondenza dei formalisti nella prima metà degli anni ’20 contengono uno spettro di enunciazioni di tal genere ». 4
1 Zubov, op. cit., p. 104.2 « La rottura tra i formalisti e Žirmunskij – che peraltro non aveva mai fatto parte del gruppo – si fa
solitamente risalire al 1923, anno in cui uscì a Pietrogrado la traduzione russa del saggio di Oscar Walzel Das Form des Kunstwerk con un’introduzione di Žirmunskij Sulla questione del metodo formale. L’autore osservava criticamente che alcuni formalisti consideravano il proprio metodo « la sola teoria scientifica legittima », mentre occorreva un pluralismo metodologico, ed elencava alcuni approcci all’arte non me-no legittimi di quello formalista. La semplice elencazione di elementi degni di indagine che potevano coesistere in un’opera d’arte, o il tentativo di conciliare un’impostazione storico-letteraria tradizionale con le più recenti acquisizioni formali non costituivano una soluzione alternativa ai problemi teorici che i formalisti si ponevano e provocarono, appunto, l’accusa di eclettismo accademico » (Rossana Platone, Introduzione a Saggi russi di teoria letteraria, cit., p. 15). L’intenso rapporto di amicizia che aveva unito per molti anni i due studiosi e la dolorosa rottura sono testimoniati dal loro epistolario. Cfr. Perepiska B. M. Èjchenbauma i V. M. Žirmunskogo [Corrispondenza tra B. M. Èjchenbaum e V. M. Žirmunskij], in Tynjanovskij sbornik. Tret’i tynjanovskie ctenija [raccolta tinjanoviana. Terze letture tynja-noviane], Riga, Zinatne, 1988, pp. 256-329. Sul conflitto tra i due studiosi, cfr. in particolare l’introduzio-ne di E. A. Toddes, ivi, pp. 266 ; 268 ; E. A. Toddes, A. P. C µudakov, M. O. C µudakova, Kommentarii, in Ju. N. Tynjanov, Poètika. Istorija literatury. Kino [Poetica. Storia della letteratura. Cinema], Moskva, 1977, pp. 442-443 ; 535-536. 3 Any, op. cit., p. 44.
4 Dmitriev-Levc ˇenko, op. cit., p. 219. « I formalisti reagirono in modo estremamente negativo ai ten-tativi di “neutralizzazione” di quella nuova conoscenza che essi avevano introdotto nella scienza della letteratura. Proprio da ciò, in particolare, fu condizionata l’asprezza della loro separazione da Vinogra-dov e soprattutto da Žirmunskij, il quale cercava di giocare nella contrapposizione tra accademismo e poetica dell’Opojaz il ruolo di pacificatore e di arbitro » (ivi, p. 203). Il dissidio con Žirmunskij si trascina per lunghi anni, come testimoniano le velenose incomprensioni che dal 1927 contrapporranno da una parte Èjchenbaum e Tynjanov e dall’altra la loro allieva Lidja Ginzburg, proprio a causa di Žirmunskij. La giovane studiosa riferisce l’episodio in un’accorata lettera a Šklovskij del 17 gennaio 1929, in cui leg-
di nuovo sul formalismo russo 65
È come se l’istanza di « specificazione », caratteristica precipua del loro sguardo sull’opera letteraria, si riversasse dall’impianto teorico alla definizione della scuo-la, per esibirne a gran voce l’inconfondibile e inoppugnabile fisionomia (in una sorta di movimento inverso rispetto a quello indicato da Medvedev). 1 Lo spirito corporativo, già oltremodo vigoroso al sorgere del movimento, viene ulterior-mente radicalizzato in una pericolosa intransigenza settaria. È il momento, que-sto, in cui la polemica dei formalisti contro la tradizione accademica si trasforma nella (fatale) battaglia con i critici sovietici marxisti. In una simile congiuntura, dove potrebbero trarre vantaggio dal sostegno di non pochi intellettuali in circo-lazione nei loro paraggi, gli insofferenti opojazovcy si sbarazzano invece di qualsia-si offerta di collaborazione che non abbia impresso quell’inequivocabile marchio della ‘differenza specifica’ che li distingue dal resto del mondo. 2
5. A Mosca, intanto
Tra i più vicini ai pietrogradesi certamente vi sono i filologi moscoviti del mlk, tanto che la tradizione li ha collocati quasi senza residui sotto l’insegna unifican-te del formalismo russo. Accomunati dal sodalizio con Vladimir Majakovskij, che frequenta assiduamente il Circolo e invita i suoi membri a collaborare con la rivista « Lef », come anche dalla ripetuta presenza a Mosca di Brik, Šklovskij, Tomaševskij, in meno di un decennio i due gruppi mostrano tuttavia di percor-rere direzioni inesorabilmente divergenti. Jakobson ha lasciato la Russia nel 1920 per non farvi più ritorno, e il suo destino è sostanzialmente eccentrico rispetto a quello dei suoi compagni. Di fatto, dalla metà degli anni Venti, i membri del Circolo linguistico « si trasformano sempre più agli occhi degli opojazovcy da com-pagni di lotta in apostati e conformisti ». « La causa di ciò fu la resa dei moscoviti all’“accademismo”, ivi comprese le forme dell’organizzazione dell’attività scien-tifica ». 3
All’Istituto di Storia delle Arti, « forma di istituzionalizzazione e di riproduzio-ne della scuola formale », 4 corrispondeva a Mosca l’Accademia Statale di scienze artistiche (Gosudarstvennaja Akademija chudožestvennych nauk - gachn), 5 presso
giamo dell’« atmosfera degli ultimi due anni, nel corso dei quali Jurij Nikolaevic ˇ [Tynjanov] mi ha osti-natamente sospettata di žirmunismo (žirmunizm) e di tradimento della tradizione (pridatel’stvo tradicii) [dove non si può non notare il richiamo alla tradizione da parte dell’opojazovec !] […] Viktor Borisovic, Voi mi avete criticata aspramente perché non Vi piacciono i miei lavori ; Tynjanov mi ha criticata aspra-mente perché bevo il tè con Žirmunskij… » (Pis’mo L. Ja. Ginzburg B. V. Šklovskogo 1929 goda [Lettera di L. Ja. Ginsburg a B. V. Šklovskij del 1929], « Novoe literaturnoe obozrenie », cit., p. 316).
1 Cfr. supra, par. 3.2 « L’inclusione nella lotta generale per il primato, la profonda convinzione nella veridicità della loro
conoscenza delle necessità della contemporaneità (e di conseguenza nel loro diritto di dettare le priorità euristiche) […] resero praticamente impossibile la cooperazione sia intellettuale, sia, cosa non meno importante, organizzativa, tra i formalisti e le forze a loro persino più vicine, privando la loro comunità di quel grado di tolleranza e di pluralismo interno che avevano avuto luogo nell’Opojaz degli anni ’10 e dell’inizio degli anni ’20 » (Denis Ustinov, Materialy disputa « marksizm i formal’nyj metod » 6 marta 1927, cit., p. 250). 3 Dmitriev – Levc ˇenko, op. cit., p. 203. 4 Ibidem.
5 In origine rachn (Rossijskaja Akademija chudožestvennych nauk).
stefania sini66
il Narkompros (Narodnyj Komissarjat po Prosvešc ˇeniju) [commissariato popolare per l’istruzione], alla quale partecipavano attivamente i membri del mlk. Se il gruppo pietrogradese, per la sua « marginalità extra-accademica », si qualifica co-me ‘rivoluzionario’, l’ambiente moscovita appare di contro piuttosto ‘élitario’, orientato verso la tradizione e il rispetto del ruolo storico e istituzionale della filologia. 1
La gachn viene fondata nel 1921 « come istituzione scientifica alternativa, con lo scopo di coltivare le discipline non rappresentate nell’Accademia russa delle scienze (Rossijskaja akademja nauk), e precisamente : filosofia e psicologia, teoria e storia della pittura e dell’architettura, storia generale dell’arte, teoria e storia della musica e interazioni tra le arti ». 2 Nel febbraio del 1922 si costituisce il Di-partimento di filosofia, dove presto emerge con forza la personalità di Gustav Gustavovic Špet (1879-1937). Membro dell’Accademia dal 1921, Špet vi trova un terreno fertile per i suoi molteplici interessi intellettuali e un efficiente laboratorio per le sue riflessioni estetiche. Già da qualche anno il filosofo si è fatto conosce-re come divulgatore e sostenitore del pensiero husserliano in terra russa ; 3 ora, insieme all’autorevolezza scientifica, afferma e consolida il suo ruolo organizza-tivo all’interno dell’istituzione : dirige il Dipartimento di filosofia ; per un certo periodo è anche vicepresidente dell’intera Accademia. La gachn è strutturata in dipartimenti ; ogni dipartimento svolge autonomamente il proprio lavoro, ma si organizzano anche incontri interdisciplinari. 4 Špet caldeggia e promuove concre-tamente questi scambi fecondi di punti di vista e metodi. Elabora un programma dettagliatissimo di attività, in cui l’interesse trascorre dal cinema all’estetica, dal metodo formale allo statuto dell’immagine, dagli stili ai fattori extraestetici del-l’arte. 5 Un altro progetto avviato dal Dipartimento di filosofia sotto l’egida di
1 (« vi partecipavano anche filologi del tutto tradizionali come N. N. Durnovo., D. N. Ušakov e B. Poržezinskij, cosa assolutamente inimmaginabile nell’Opojaz ») (ivi, p. 204 e n).
2 « Venivano pubblicati bollettini informativi (l’undicesimo e ultimo numero uscì nel 1928) e la rivista “Iskusstvo” [Arte]. Oltre a ciò, i collaboratori della GACHN partecipavano alla vita artistica contem-poranea, all’organizzazione e alla valutazione di mostre d’arte in Russia e all’estero » (M. V. Zubova, Predislovie [Premessa], in Vasilij Pavlovic ˇ Zubov, Izbrannye trudy po istorii filosofii i èstetiki. 1917-1930 [Opere scelte sulla storia della filosofia e l’estetica], Moskva, Indrik, 2004, p. 11.). Cfr. Gosudarstvennaja Akademija chudožestvennych nauk i sovremennoe iskusstvoznanie [L’Accademia Statale delle scienze artisti-che e lo studio dell’arte contemporaneo], « Voprosy iskusstvoznanija » xi, n. 2, 1997.
3 È del 1914 l’edizione di Javlenie i smysl. Fenomenologija kak osnovnaja nauka i eë problemy [Fenomeno e senso. La fenomenologia come scienza dei fondamenti e i suoi problemi]. Špet aveva frequentato le lezioni di Edmund Husserl a Gottingen negli anni 1912-1913.
4 Parteciparono alle attività della gachn personalità come Sergej M. Èjzenštein, Konstantin S. Stani-slavkij, Vsevolod È. Mejer’chol’d, Pavel A. Florenskij, Aleksej F. Losev.
5 Cfr. « Il 23 settembre 1924, nella riunione allargata del Presidium del Dipartimento filosofico, Špet, alla presidenza, sottolineò che per l’elaborazione di un programma dei lavori a lungo termine era ne-cessario stabilire stretti legami con gli altri dipartimenti e le altre sezioni della RACHN, mentre per il Dipartimento filosofico occorreva proporre temi propri. Da parte sua Špet presentò i 5 temi seguenti : Il cinema come arte. Fattori extraestetici dell’arte. Sono possibili la definizione e l’analisi dell’arte senza riferimento all’estetico ? Il metodo formale. Che cos’è l’immagine » (V. S. Mjasnikov, Gustav Špet : trudy i gody [lavori e anni], in G. G. Špet, Istorija kak problema logiki [La storia come un problema della logica] reprint izadanija 1916 [ristampa dell’edizione 1916], Moskva, Pamjatniki istoric ˇeskoj mysli, 2002, pp. 9-10).
di nuovo sul formalismo russo 67
Gustav Gustavovic ˇ riguarda « i problemi dell’interrelazione tra i diversi tipi di arti e scienze », laddove il piano di lavoro è il seguente : « allestimento ed edizione di un dizionario della terminologia artistica ; studio del problema dello spazio e del tempo nell’arte e nella letteratura ; edizione dei classici della teoria e della storia dell’arte. Successivamente si comincia a dedicare grande attenzione al problema dello stile ». 1
Il ruolo di coordinatore e ‘supervisore’ svolto da Špet nell’Accademia condu-ce alla sussunzione di una tale disparata multiformità di interessi ed esperienze disciplinari sotto l’egida dell’estetica e della filosofia. Di conseguenza, anche il metodo formale ne diviene un settore tra gli altri, perdendo così quel primato epistemologico su cui gli opojazovcy avevano da sempre tanto insistito. Non solo riemerge prepotente la speculazione filosofica bandita dai programmi dei pietro-burghesi, ma tutti gli sforzi innovatori dell’opojaz vengono neutralizzati dal suo reinserimento forzoso nell’alveo della tradizione filologica. « Il circolo moscovita di Gustav Špet, orientato alla riduzione del metodo formale in una parte della generale metodologia estetico-filosofica, includeva coerentemente il formalismo all’interno della tradizione filologica ». 2
Un ulteriore fattore di disaccordo concerne il modo di intendere lo studio della lingua : all’empirismo caldeggiato dai formalisti viene contrapposto l’orizzonte assai più ampio, inizialmente fenomenologico, e poi storico-ermeneutico, indica-to da Špet. Il filosofo è in prima fila nelle discussioni del mlk, che vedono Jakobson (prima della sua partenza), Brik, B. O. Kušner, A. A. Buslaev, M. M. Geningsberg, N. N. Volkov e altri interrogarsi sui possibili indirizzi metodologici delle ricerche svolte dalle discipline linguistiche. « Uno schieramento, costituito dai fondatori del metodo formale nella scienza della letteratura (V. B. Šklovskij, O. M. Brik, R. O. Jakobson, Ju. N. Tynjanov e altri), difendeva l’approccio empirico alla ricerca delle discipline linguistiche nella loro varietà, inclusa la fonetica, basandosi sul materia-le concreto della poesia e della prosa. L’altro gruppo, al centro del quale si collo-cava Špet, insisteva sull’integrità di un approccio storico-concreto e metodologico alla lingua in generale, vedendo nella semiotica (Špet la chiamava “semasiologia”) una originale “logica della lingua”, cioè il fondamento di fondamenti di qualsiasi conoscenza scientifica ». Sta di fatto che il pensatore fu uno dei frequentatori del Circolo « la cui attività condusse alla secessione di una parte degli studiosi nel
1 Zubova, op. cit., p. 11. « La maggior parte del lavoro del dipartimento consisteva nella partecipa-zione di tutti i collaboratori alle sessioni plenarie, alle letture e alle discussioni sulle conferenze. […] Nell’estate del 1923, all’interno del Dipartimento di filosofia, fu creata una commissione per la prepa-razione dei materiali per il dizionario dei termini estetici e artistici, in breve trasformata nella commis-sione per lo studio della forma artistica. Presidente della commissione era G. G. Špet, assistito da N. N. Volkov, A. G. Cires, B. V. Gornung. Nella commissione entrarono V. P. Zubov, A. S. Achmanov, A. A. Buslaev, G. O. Vinokur, A. G. Gabricevskij, A. A. Guber, N. I. Žinkin, M. M. Kenigsberg, S. Ja. Šor, S. N. Èkzempljarskij, e altri. Entro il 1925 fu pronto il primo tomo dei Lavori della commissione per lo stu-dio della forma artistica (Trudy komissii po izuceniju chudožestvennoj formy) (in veste assai ridotta appar-ve nel 1927 nella raccolta “Chudožestvennaja forma” » (ibidem). Cfr. ora Gosudarstvennaja Akademija chudožestvennych nauch, Slovar’chudožestvennich terminov 1923-1929, Moskva, Logosfera, 2005.
2 Dmitriev-Levc ˇenko, op. cit., p. 204.
stefania sini68
gruppo indipendente “Ars Magna” ». 1 Queste discussioni durano già da qualche anno, se all’inizio del 1920, come ricorda il poeta e filologo Boris Gornung nelle sue memorie, « Špet lesse al Circolo linguistico di Mosca il testo della conferenza “Momenti estetici nella struttura della parola” (pubblicato in seguito come terza puntata dei suoi Frammenti estetici (Èsteticeskie fragmenty) : lo contestò duramente O. M. Brik, portavoce ufficiale del circolo, mentre a rappresentare la linguistica accademica c’era D. N. Ušakov ». 2
Nell’arco di breve tempo le defezioni dal plotone dei formalisti si moltiplicano. Una delle più significative è senz’altro quella di Grigorij Vinokur. Membro fin da studente del mlk, di cui ricopre anche la carica di segretario, attivo collaboratore del Lef, specialista del discorso poetico di Majakovskij, al quale dedica un volume « che resta ancor oggi una delle migliori analisi linguistiche della poesia majako-vskiana », 3 intorno alla metà degli anni ’20 Vinokur svolge a fianco di Jakobson il ruolo di araldo della supremazia della linguistica sulle discipline letterarie. E con-tro tale inopinato « imperialismo linguistico », a difesa dell’autonomia della loro scienza, gli opojazovcy non possono che insorgere violentemente. 4
1 Tat’jana G. Šcedrina, « Ja pišu kak ècho drugogo… » : Oc ˇerki intellektual’noj biografii Gustava Špeta [« Io scrivo come eco dell’altro ». Lineamenti della biografia intellettuale di Gustav Špet], Moskva, Pro-gress-Tradicija, 2004, pp. 216-217.
2 Ivi, p. 271, con rinvio a B. V. Gornung, Pochod vremeni. Stat’i i èsse [La marcia del tempo. Articoli e saggi], Moskva, 2001, p. 360. Purtroppo non è possibile in questa sede soffermarsi sui contenuti di questa relazione špetiana, che ha un rilievo teorico davvero straordinario. È qui infatti che il filosofo espone una serie di riflessioni che saranno proprie della semiotica della seconda metà del Novecento. E soprattutto, in queste pagine, Špet sembra inaugurare lo strutturalismo : « Per struttura della parola si intende una costruzione non morfologica, sintattica o stilistica, tanto meno la sua disposizione “in superficie”, ma, al contrario, organica, in profondità : dall’oggetto percepibile sensibilmente all’oggetto ideale-formale (eidetico), attraverso tutti i gradi delle relazioni che si dispongono fra questi due termini. La struttura è un costrutto concreto, le cui singole parti possono cambiare di “misura” e anche di qua-lità, ma nessuna delle parti dell’intero in potentia può essere eliminata senza la distruzione dell’intero. In actu alcuni “elementi” possono rivelarsi non ancora sviluppati, allo stato embrionale, o degenerati, atrofizzati. Lo schema della struttura non ne risente. La struttura deve essere distinta da ciò che è “com-plesso”, sia esso divisibile concretamente, o scomponibile in elementi astratti. La struttura si distingue anche dall’aggregato, la cui massa complessa ammette l’annullamento e la scomparsa da essa di una qualsiasi delle sue parti costitutive senza che cambi la sostanza qualitativa dell’intero. La struttura può essere solo smembrata in nuove strutture chiuse in se stesse, la cui composizione inversa ristabilisce la struttura originaria. Le formazioni spirituali e culturali hanno un carattere sostanzialmente strutturale, perciò si può affermare che lo stesso “spirito” o la cultura sono strutturali » (Gustav Špet, Èsteticeskie fragmenty [1922], Moskva, Pravda, 1989, p. 382 ; trad. it., Frammenti estetici, a cura di Margherita De Mi-chiel e Stefania Sini, Torino, Trauben, Filosofi russi, in corso di pubblicazione).
3 Cfr. Platone, op. cit., pp. 259-260.4 Essi infatti si ostinavano a respingere « la normalizzazione del loro sistema teorico attraverso la
sua inclusione nella scienza tradizionale in qualità di parte costitutiva, poiché pretendevano che il for-malismo fosse l’autentica scienza della letteratura nella sua interezza, a differenza di tutta la conoscen-za precedente in quanto prescientifica. Oltre al rifiuto, naturale per i rivoluzionari nella scienza, del riformismo intradisciplinare, i formalisti pietrogradesi insistevano, in polemica con i moscoviti, sul principio dell’autonomia dell’oggetto della scienza della letteratura. Da un lato, questo era un attacco contro l’imperialismo linguistico di Jakobson o di Vinokur all’inizio degli anni ’20 (con lo scopo del dissolvimento della scienza della letteratura nella linguistica), dall’altro, contro i tentativi di fare del formalismo una parte della generale metodologia estetico-filosofica (il circolo di Špet nella gachn) ». (Dmitriev-Levc ˇenko, op. cit., p. 211).
di nuovo sul formalismo russo 69
Dal canto suo, Grigorij Osipovic matura un cambio di rotta nel suo percorso teorico, in direzione di una critica sempre più aspra del metodo formale. Recen-sendo nel giugno del 1924 su « Russkij sovremennik » la raccolta di Èjchenbaum Skvoz’ literatury [Attraverso la letteratura], ne rileva le contraddizioni metodologi-che, giacché da un lato vi sono contenuti saggi ispirati all’« estetica gnoseologica-mente fondata » e dall’altro testi che difendono e mettono in pratica i principi del formalismo. L’origine di questo contrasto tra « filosofia » e « morfologia » sarebbe ascrivibile, secondo il recensore, alla sottovalutazione da parte di Èjchenbaum « della parola poetica nella sua struttura integrale ». Per evitare simili errori è dun-que indispensabile un impianto filosofico di vasto respiro :
se c’è bisogno dell’estetica come giustificazione filosofica, allora tale necessità non scom-pare davanti all’analisi delle concrete forme estetiche, poiché il fondamento filosofico del-l’estetica stessa sarà anche, evidentemente, la specificazione di queste forme estetiche. 1
L’imputazione di fragilità teorica mossa da Vinokur contro gli opojazovcy si spiega con la sua adesione sempre più convinta alle proposte filosofiche di Špet, il quale in questo periodo sta lavorando alla monografia sulla filosofia del linguaggio di Humboldt La forma interna della parola (Vnutrennaja forma slova), che uscirà nel 1927 per le edizioni della gachn, ma che è già nota ai moscoviti, almeno nei suoi lineamenti sostanziali, sin dal 1923. 2 Non è un caso, forse, che parallelamente al rifiuto della Weltanschauung degli « specificatori », il linguista spezzi il suo legame con il futurismo e il Lef, denunciandone lo spirito « nichilistico », con il quale ora esclude qualsiasi genere di « compromesso ». 3 E contro il futurismo si era espresso con parole assai virulente Gustav Gustavovic nei Frammenti estetici :
Il futurismo è teoria dell’arte senza l’arte stessa. […]. Quando coloro che si autoproclama-vano futuristi incitavano « gli incendiari con le dita annerite » non si aveva paura ; simpatici ragazzi si pensava. Quando ordinavano : « demolite le fondamenta delle città gloriose » era-no incomprensibili e curiosi – incomprensibili, giacché tutti sapevano che quelle « fonda-menta » erano da tempo ormai demolite, curiosi, perché il « manifesto » si rivolgeva a noi : chi di noi, si pensava, – guardando di traverso il « prossimo » – gente pratica, avrebbe ab-bandonato il padre e la madre per andare a demolire ciò che da tempo era demolito e non si poteva perciò demolire ? Ma subito si avvertirono un cattivo gusto e un cattivo odore […]. Coloro che affermano il primato della poetica sulla poesia sono futuristi.
Il futurismo « crea » in base alla teoria, esso non ha passato ; la gravidanza dei futuristi è falsa. […] I futuristi, che non hanno assimilato alcuna scuola, non assimilano nemmeno l’arte, in essa saranno non padroni ma commessi, sia pure statali.[…]. Insincerità e artifi-ciosità significano una cosa semplice : il gioco di prestigio non è riuscito. […].
1 Grigorij Vinokur, Filologiceskie issledovanija. Lingvistika i poètika [Ricerche filologiche. Linguistica e poetica], Moskva, 1990, pp. 81-82.
2 Gustav Špet, Vnutrennaja forma slova. Ètjudy i variacii na temy Gumbol’dta [La forma interna della parola. Studi e variazioni sul tema di Humboldt], Ivanovo, Ivanovskij Gosudarstvennyj Universitet, 1999. Nell’introduzione si legge : « L’origine di questo lavoro è costituita da una relazione letta dal-l’autore nel 1923 alla Commissione per lo studio della forma artistica presso il Dipartimento filosofico dell’Accademia delle scienze Artistiche » (ivi, p.8).
3 Cfr. Dmitriev-Levc ˇenko, op. cit., pp. 209-210 n.
stefania sini70
Il futurismo, dunque, è disintegrazione, putrefazione, concimazione. Il terreno è pron-to. 1
L’itinerario intellettuale di Vinokur si dispiega d’ora in avanti nel campo, a lui da sempre congeniale, dello studio scientifico della lingua, dal quale trae frutti impor-tanti e degni di venire menzionati. Fine conoscitore della linguistica europea, in particolare delle nuovissime proposte di Ferdinand de Saussure, di cui è in grado di cogliere con notevole acutezza le potenzialità, ma anche le aporie soggiacenti, Grigorij Osipovic rivolge l’attenzione alle dicotomie saussuriane « langue/parole » « sincronia/diacronia », privilegiandone le parti a suo parere trascurate dal mae-stro ginevrino. 2 Intraprende dunque lo studio diacronico della parole, e traccia i lineamenti una stilistica storica intesa come « storia degli stili linguistici » (istorija jazykovych stilej), diretta all’analisi dell’« uso individuale della tradizione linguistica nelle più diverse condizioni del byt socio-culturale ». 3 Il contributo di Vinokur non
1 Gustav Špet, Èsteticeskie fragmenty, cit., pp. 361-362 (traduzione di M. De Michiel).2 La fondamentale aporia latente nel Corso di linguistica generale colta da Vinokur, e in cui sembrano
consistere le difficoltà presto incontrate dai formalisti nel momento in cui devono fare i conti con la storia della letteratura, è quell’« ambiguità fondante lasciata da Saussure in eredità alla linguistica e alla semiotica, tra una langue “considerata in se stessa e per se stessa” e una langue che non può essere con-cepita né afferrata se non nelle sue relazioni con l’attività e la memoria storica di una “massa parlante” » Franco Brioschi, Filosofia del linguaggio ed estetica letteraria, Milano, Università degli Studi, p. viii. Cfr. Ferdinand de Saussure, op. cit., pp. 14 n. 282.
3 Vale la pena di riportare, nonostante la sua lunghezza, un passo dal saggio degli anni Venti Prakticeskaja stilistika kak problema [La stilistica pratica come problema] per la sua penetrante lettura del pensiero saussuriano e per l’interesse teorico delle proposte avanzate. Le brillanti pagine di Vinokur, poco note in Italia (ma cfr. i due saggi Lingua della letteratura e lingua letteraria e La lingua dell’opera lettera-ria tradotti in Platone, op. cit., pp. 97-123), meriterebbero, si crede, l’attenzione da parte degli studiosi di linguistica e teoria letteraria, oltre che di slavistica. « Tuttavia Saussure non si è accorto di un suo errore metodologico. Dai suoi enunciati non ha tratto la necessaria deduzione, che io mi permetto di fare qui per lui […]. Bisogna porgere attenzione al fatto che nel sistema saussuriano delle due linguistiche spet-tano alla linguistica “storica” esclusivamente i suoni, e che la storicità di questa linguistica viene intesa nello spirito di quella stessa evoluzione esterna. E inoltre, per la scienza del parlare (govorenie), della cui scoperta siamo debitori a Saussure, nella sua classificazione delle discipline linguistiche non c’è nessun posto ! È evidente che ciò non è assolutamente possibile dal punto di vista dei presupposti che costitui-scono, per così dire, l’anima dello studio di Saussure, il suo nucleo fondamentale e prezioso. Se la langue è la lingua stabilizzata (prebyvajušcij), mentre la parole è la lingua che vive nella realtà e che cambia, allora proprio queste devono essere le due linguistiche : una statica (sebbene il termine non sia molto felice : le forme della lingua, anche in un loro segmento temporale non sono statiche e si comprendono solo nella loro dinamica di senso […]), che studi la lingua nel suo sistema, come meccanismo di forme grammaticali e di correlazioni che conferiscono loro senso, e un’altra storica, ma già senza virgolette, cioè che studi la lingua in quanto fatto reale della vita sociale, nel suo concreto essere storico, detto altrimenti, la storia della lingua in senso proprio. D’acchito, questa identificazione tra storia sociale della lingua e scienza del parlare può sembrare incomprensibile, dal momento che sopra proprio alla lingua era stato contrapposto il parlare, in quanto principio individuale rispetto a un principio generale e collettivo. Ma l’incomprensione qui è solo apparente. Giacché perfino per de Saussure la langue è solo uno schema ideale, la cui vita reale e concreta è data comunque dalla parole. Perciò bisogna soltanto ricordarsi che la parole non è un processo automatico e meccanico, bensì attivo. In questo modo, il parlare di Saussure può avere un senso reale solo nel caso in cui lo si interpreta propriamente come manifestazione sociale della lingua per mezzo di una iniziativa individuale, che agisce nei limiti di un data collettività linguistica. Di conseguenza è importante innanzi tutto il fatto che l’individualità, anche se parla a modo suo, dà vita comunque a ciò che è generale, così che il materiale discorsivo che trova la
di nuovo sul formalismo russo 71
si esaurisce peraltro nella brillante formulazione di una teoria degli stili, bensì risponde operativamente a esigenze affatto pratiche, affrontando in particolare il problema, a quel tempo assai spinoso e urgente, di una politica linguistica il cui campo d’azione è l’immenso territorio della neonata Unione Sovietica.
6. La capitolazione. Il lavoro continua
Il carisma esercitato da Špet nell’ambiente moscovita e la forza delle sue convin-zioni teoriche, responsabili tanto della frustrazione delle mire epistemologiche dei formalisti, quanto delle riprovevoli defezioni dal loro movimento, generano nei leningradesi un crescente senso di fastidio e rafforzano il loro arroccamen-to difensivo. Ne è testimone Viktor Vinogradov, che assiste all’arrivo in città dei moskvici :
In quel tempo a Mosca iniziò l’infatuazione per i lavori estetici del professore Gustav Gu-stavovic Špet. Quando i moscoviti arrivarono a Leningrado, già si conoscevano queste posizioni, ma da noi i nostri giovani collaboratori – allora tutti noi eravamo più o meno ancora giovani – accolsero ciò molto negativamente (al punto che all’Istituto di storia delle arti appesero un manifesto con il seguente calembour : « meglio Špet che mai » (lušce Špet, c ˇem nikogda). 1 In ogni caso, né i Frammenti estetici, né la successiva Forma interna della parola ci potevano a quel tempo in alcun modo soddisfare. 2
Da un tono ben diverso rispetto allo scherzoso calembour sono pervase le anno-tazioni di Boris Èjchenbaum, che il 22 marzo 1927 registra le proprie impressioni dopo la lettura degli scritti dei collaboratori della gachn :
Oggi mi sono accostato alla scienza moscovita. Mosca viene verso di noi – la raccolta « Chudožestvennaja forma » [La forma artistica], la raccolta « Ars poetica ». Ma come tutto ciò è triste, povero, pretenzioso, cerimonioso ! I riferimenti sono quasi tutti esclusivamente alla scienza tedesca – i teorici moscoviti riconoscono soltanto Špet (per il cognome tedesco ?) e i tedeschi. Di noi parlano con disprezzo, con ironia, come di bambini. Che insolenza ! Né un riferimento a Tynjanov, né a me. Un paio di volte balena Žirmunskij – questo si può, lui è « dottore ». Eppure ci hanno sgraffignato tutto, gli sfacciati ! Loro non hanno altro che maniere e l’« erudizione » che non serve a nessuno. […] Com’è ripugnante l’epigonismo che non si riconosce tale ! Questa « Ars poetica » mi ha condotto direttamente all’idrofobia
propria espressione nel parlare è comunque la langue stessa. Ma non meno importante è che il parlare in quanto atto del discorso individuale non è per nulla un atto esclusivamente di una sola persona. In relazione proprio alla lingua in quanto generale patrimonio sociale, sarà parlare qualsiasi discorso nel quale proprio la lingua venga specificamente manifestata da un qualsiasi membro di questo insieme sociale. E la nozione di membro dell’insieme sociale può essere ristretta o estesa quanto si vuole : se è possibile il parlare come discorso individuale di un singolo individuo sociale, è anche possibile come discorso individuale di un gruppo di individui, per esempio, la lingua di famiglia, di ceto, di classe, di professione, ecc. Per rendere il mio pensiero definitivamente chiaro, dirò semplicemte che la contrap-posizione di Saussure tra langue e parole si deve intendere come contrapposizione tra lingua e stile. » (Grigorij Vinokur, Prakticeskaja stilistika kak problema, in Id., Kul’tura jazyka [Cultura della lingua] (1924), Moskva, Labirint, 2006, pp. 20-21).
1 Il calembour sostituisce nel proverbio la parola « pozdno » (= tardi) con il cognome del filosofo, il qua-le è quasi omofono al verbo « spet’ » (= maturare, o anche essere pronto, detto di una vivanda.
2 Viktor Vinogradov, Iz istorii izucenija poètiki, cit., p. 268.
stefania sini72
– sono pronto a sfidare a duello tutta questa compagnia di « accademici delle scienze arti-stiche ». 1
Qui, più che mai, l’etichetta unificante di « formalismo russo », utilizzata da sem-pre nella storia della critica e della teoria letteraria, appare in tutta la sua flagrante problematicità. Certo, si tratta di un momento oltremodo critico per i fondatori del metodo formale. Il 1927 è infatti l’anno del cedimento e della resa alle aggres-sioni, non solo verbali, della cultura ufficiale. Nella medesima sala del Teniševskoe Ucilišce dove, tredici anni prima, il nascituro opojaz e i baldanzosi futuristi avevano gettato lo scompiglio tra studenti e professori, 2 la sera del 6 marzo 1927 si svolge la drammatica disputa che vede schierati da una parte i critici e gli accademici marxi-sti, e dall’altra Tomaševskij, Tynjanov, Šklovskij, Èjchenbaum. La riunione, che si protrae dalle 10 di sera alle 3 di notte, prende avvio in un’atmosfera relativamente tranquilla, fino al momento in cui non interviene Šklovskij, il quale, con le sue tipiche movenze oratorie, ora aggressive, ora sprezzanti, ora buffonesche, eccita l’uditorio e surriscalda l’ambiente. La maggior parte del pubblico è costituita dagli studenti dell’Istituto di storia delle arti, che con il loro vociare contribuiscono a tra-sformare la sala in un « chiassoso mercato ». 3 Così Lidja Ginburg ricorda la serata :
Allora compresi l’entusiasmo gregario, l’entusiasmo di sentirsi un nulla, folla che saluta il capo e il grande uomo. […]
Apparve chiaro che in ogni formalista è racchiuso un teppista, e che lo scandalo rinfre-sca l’anima. (A proposito di teppismo : uno dei giovanotti di Gorbacëv 4 da lui collocato sul palco, gridò a Šklovskij : « Criminale ! » (Cµubarovec), 5 dopodiché Tynjanov gli si scagliò contro brandendo il bastone). 6
L’insulto a Šklovskij incarna con tutta evidenza l’effetto scatenato dalla sfrontatezza pro-terva con la quale Viktor Borisovic apostrofa gli avversari. Eccone un esempio :
Noi siamo autentici scrittori, il che non si può dire di nessun marxista. Noi non costruia-mo un metodo sociologico, noi ci occupiamo di letteratura. Purtroppo, i compagni marxi-sti non possono essere attratti verso questo lavoro per mancanza di qualifica. 7
1 Citato in Denis Ustinov, Materialy disputa « marksizm i formal’nyj metod » 6 marta 1927, cit., p. 250. Èjchenbaum si riferisce a Chudožestvennaja forma. Sbornik statej di N. I. Žinkin, N. N. Volkova, M. A. Petrovskij, A. A. Guber, sostavitel’ di A. G. Ciresa, Moskva, 1927 e ad Ars poetica, I, Moskva, 1927.
2 Cfr. supra, par. 3.3 Per la ricostuzione dell’evento, la presentazione dei testi dei relatori, le reazioni della stampa e le
importanti considerazioni sul significato storico di questa disputa, cfr. Denis Ustinov, Materialy disputa « marksizm i formal’nyj metod » 6 marta 1927, cit. Cfr. anche Curtis, op. cit., pp. 151-162.
4 Georgij Efimovic Gorbacëv (1897-1937) studioso di letteratura e critico di scuola marxista, partecipa alla disputa contro i formalisti, in difesa del metodo sociologico.
5 L’epiteto violentemente spregiativo significa letteralmente « abitante del C µubarovskij pereulok », vicolo di Leningrado, in cui all’inizio del 1927 era stato compiuto uno stupro di gruppo su una giovane donna in seguito suicidatasi. Il processo ebbe larga risonanza, e a maggior ragione, a pochi mesi dall’ac-caduto, la qualifica risuona come offesa bruciante.
6 Lidja Ginzburg, Zapisnye knižki.Zapisi, ne opublikovannye pri žizni [Libretti di appunti. Appunti non pubblicati in vita], in Idem, Zapisnye knižki. Vospominanja. Èsse, cit., p. 380.
7 Denis Ustinov, Materialy disputa « marksizm i formal’nyj metod » 6 marta 1927, cit., p. 257.
di nuovo sul formalismo russo 73
In quell’alba di marzo gli opojazovcy escono dal Teniševskoe con la sensazione di avere riportato una vittoria. In effetti, al di là degli oltranzismi šklovskiani e delle urla degli astanti, in sede argomentativa i formalisti si sono difesi bene, hanno sa-puto far fronte a ogni obiezione e accusa. Ma la realtà dovrà smentirli ben presto. Le conseguenze della « Notte di San Bartolomeo » (così la chiamerà Èjchenbaum) non tardano. Cominciano gli attacchi sulla stampa. Il 22 marzo Boris Michajlovic paventa « repressioni ». Tra il 6 e l’8 maggio annota sul suo diario :
All’Università è imminente la liquidazione del dipartimento letterario – l’insegnamento della letteratura si concentra a Mosca, e da noi resta solo la linguistica. Il mio lavoro al-l’Università è evidentemente finito. […]
[…] suona il telefono. È appena terminata la seduta del consiglio in Università – è stato stabilito : eliminare il dipartimento letterario. Questo è il risultato della disputa. 1
« Nel 1927 Èjchenbaum e Tynjanov smisero di insegnare al lgu 2 (il primo tempo-raneamente, il secondo per sempre), e, nonostante tutto il loro sarcasmo verso la “professoralità”, non si può non riconoscere che questo fu un evento importante nel destino della scuola formale ». 3
In un clima politico sempre più fosco, gli studiosi proseguono le loro ricerche e la loro attività critica, filologica e creativa, sebbene gli ideali, i progetti, le parole d’ordine dell’opojaz appaiano davvero lontani. In questo periodo Èjchenbaum riflette sul byt e sul ruolo sociale degli scrittori e delle istituzioni legate alla lette-ratura – salotti, accademie, circoli, riviste, almanacchi, case editrici – nella storia e nel loro legame con il sistema delle correnti e dei generi letterari. 4 Nel 1928 su « Novyj Lef » escono i Problemi di studio della letteratura e del linguaggio firmati da Juryj Tynjanov e Roman Jakobson, 5 in cui vengono affrontati con lucida chia-rezza i nodi problematici che avevano minato ab origine le basi teoriche della scuola formale : la storia della letteratura, la dialettica tra diacronia e sincronia, il nesso con le altre serie. Com’è noto, questi nove punti costituiscono il var-co che collega il formalismo russo allo strutturalismo praghese. La concezione « sistemica » tynjanoviana, già sostanzialmente attiva in Il problema del linguaggio poetico, si approfondisce attraverso lo studio dell’evoluzione letteraria e delle in-tersezioni fra letteratura e vita, che agli occhi di Tynjanov, come di Èjchenbaum, rappresentano un problema sempre più pressante. Un problema che inquieta da tempo le meditazioni dei più avvertiti opojazovcy : il loro tenace interrogarsi sul rapporto tra la letteratura e le altre costruzioni del reale – non meno importanti di quelle d’invenzione, e in fondo anch’esse innervate da procedimenti, intrecci, ritmi e orchestrazioni – mostra l’ineludibilità di un confronto con quei fattori
1 Ivi, p. 274.2 Leningradskij Gosudarstvennyj Universitet [Università Statale di Leningrado].3 Ivi, p. 277.4 Boris Èjchenbaum, Literaturnyj byt, in Idem, Moj vremennik, cit., pp. 49-86 (edizione 2001, pp. 49-
87).5 Problemy izuc ˇenija literatury i jazyka, « Novyj Lef » n. 12, 1928, pp. 35-37 ; trad. it. di Vittorio Strada, in
I formalisti russi, cit., pp. 147-149.
stefania sini74
extra-testuali che la teoria e il metodo avrebbero voluto estromettere dal proprio campo d’indagine. Nella varia alternanza di messe a punto della questione, di ripensamenti, approfondimenti, passi indietro, prende corpo una nuova e lungi-mirante idea di storia della letteratura che fa perno sul concetto di genere, esso stesso considerato come spettro di possibilità evolutive, i cui confini sono elastici e reversibili, in continua, feconda osmosi con il byt, lo spazio biografico, l’oriz-zonte sociale. 1
La rigida barriera edificata dai giovani fondatori della scienza della letteratura a protezione dell’autarchica insularità dell’opera d’arte si è da tempo sgretolata : tra il testo e il mondo passano innumerevoli correnti, destini, scenari ; gli orizzonti si incontrano e sovrappongono, risucchiano e trasmettono ; e gli scambi sono sem-pre più intensi, ininterrotti, quasi senza soluzione di continuità. Se agli albori del metodo formale era balenata l’illusione di potersi attenere all’indagine sincronica di una parola bastante a se stessa, la storia ha travolto questa fragile pretesa : la sto-ria come problema teorico e la storia degli eventi traumatici, degli scossoni, delle perdite, dei sopravvissuti, dalla Rivoluzione allo stalinismo, che in questi decenni hanno attraversato la Russia.
Abstract
Il formalismo russo viene generalmente considerato come l’antecedente della corrente strutturalistica, soprattutto francese, che ne ha decretato il successo in Europa. Tuttavia, la dipendenza genealogica tra le due scuole si è non di rado trasformata in un’identifica-zione senza residui, che oggi sembra meritare una revisione critica ; tanto più che lo stesso movimento formalista presenta al suo interno un vistoso pluralismo metodologico, diffi-cilmente riconducibile a un denominatore comune. Il primo passo, allora, per approfondi-re la conoscenza delle singole personalità – troppo spesso omologate in un’unica fisiono-mia sovra-individuale – consiste nella ricostruzione della vicenda storica del movimento, a partire dalla diversa esperienza dei centri di Pietroburgo e Mosca. Da questa attenzione al contesto d’origine emerge un quadro vivace, attraversato da conflitti, inversioni di rotta, maturazioni di prospettive, che mostra la problematica ricchezza di quell’apparato teorico e metodologico a cui si deve la fondazione della teoria della letteratura.
Russian formalism is generally considered to be the forerunner of structuralism; French structuralism in particular made it widely known across Europe. However, genealogical interdependence between the two schools has occasionally been turned into full iden-tification, a fact which seems to deserve critical revision today, the more so because the formalist movement itself is characterised by a plurality of methodological approaches difficult to reduce to a common denominator. In order to enhance our knowledge of formalism – a current too often considered like a single super-individual physiognomy – and to highlight the specificity of its many faces, in the first place, it is important to pay
1 Cfr. Tynjanov, Literaturnyj fakt [Il fatto letterario] « Lef », n. 2, 1924, pp. 101-116, O literaturnoj èvolucii [Sull’evoluzione letteraria], « Na literaturnom postu », n. 10, 1927, pp. 42-48, poi in Archaisty i novatory, Leningrad, 1929 ; trad. it., in Idem, Avanguardia e tradizione, Bari, Dedalo, 1968 ; O literaturnoj èvolucii [Sul-l’evoluzione letteraria], « Na literaturnom postu », n. 10, 1927, pp. 42-48. Cfr. Idem, Formalismo e storia let-teraria. Tre studi sulla poesia russa, introduzione e traduzione di Maria Di Salvo, Torino, Einaudi, 1973.
di nuovo sul formalismo russo 75
attention to its historical vicissitudes, starting from the different experiences of the St. Petersburg and Moscow centres. Focusing on the original context in which formalism developed its critical stances helps trace a lively portrait of it, full of conflicts, reversals and evolving perspectives. Its theoretical and methodological apparatus thus reveals the complex and problematic theoretical organism to which we owe the foundation of liter-ary theory.