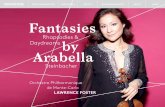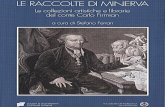Definizioni del Logos in Carlo Diano
Transcript of Definizioni del Logos in Carlo Diano
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIA
Titolo dell’elaborato
DEFINIZIONI DEL LOGOS IN CARLO DIANO
Relatore: Chiar.mo Prof. ADONE BRANDALISE
Laureando: Francesco Taddio
561624
Anno Accademico 2010/2011
[…] se l'uomo ancora una volta deve ritrovare la vicinanza all'essere, deve prima imparare a esistere nell'assenza di nomi […] Prima di parlare, l'uomo deve innanzitutto lasciarsi reclamare all'essere, col pericolo che, sottoposto a questo reclamo, abbia poco o raramente qualcosa da dire.
M. Heidegger, Lettera sull'«umanismo», Adelphi, Milano 1995, pp. 39-40
1
INDICE
INTRODUZIONE ----------------------------------------------------------------------------- pag. 5
§1 TYCHE, MOIRA ED HEIMARMENE --------------------------------------------------- pag. 11
§ 2 I CONFINI DEL LOGOS ---------------------------------------------------------------- pag. 15
§ 3 EVENTO E FORMA NEL LINGUAGGIO. IL NOME E IL VERBO ------------- pag. 17
§ 4 IL LOGOS DI DIANO TRA VITA E RAPPRESENTAZIONE --------------------- pag. 23
§ 5 POSSIBILI CONCLUSIONI ------------------------------------------------------------- pag. 29
3
INTRODUZIONE
Il percorso che si seguirà in questo elaborato su Carlo Diano proverà a mostrare,
attraverso l'analisi delle due categorie fenomenologiche della forma e
dell'evento, che emergono come momenti di interpretazione del pensiero greco
antico (e non solo), il modo di concepire e di fare uso del logos - in altre parole,
di definirlo - nell'autore padovano.
Diano, dopo aver scritto la ricerca Forma ed Evento, che espone il significato
delle due categorie, seppur definendo questa come “estremamente sommaria ed
in gran parte provvisoria” e dicendo però che “potrebbe avere valore di metodo”,
nel successivo testo Il pensiero greco da Anassimandro agli Stoici ci riferisce
inoltre rispetto alla forma e all'evento che, seppur “ricavate dal pensiero, dalla
religione e dall'arte greca, queste due categorie [...] appaiono oggi sufficienti
all'analisi strutturale di qualsiasi civiltà”. Nel secondo testo, infatti i riferimenti
fatti si espandono anche oltre i limiti della grecità antica. Trattando qui, in effetti,
di aspetti strutturali, come presto si vedrà, Diano non può che trattarli
'attraverso' il logos che è insito in essi, che li compenetra e che ha permesso il
loro stesso pervenirci nel modo in cui li conosciamo, ma soprattutto 'nel' logos,
ossia muovendosi in un ambiente che ha molto da spartire con la grecità antica.
Ma volendo ora addentrarsi nell'ambito delle potremmo iniziare dall'analisi
dell'evento. Scrive Diano:
“Evento è preso dal latino e traduce, come spesso fa il latino, il greco tyche.
Evento è perciò non quicquid èvenit, ma quod cuique èvenit, ὅ τι γίυεται
ἑχάστῳ, come scrive il poeta comico Filemone ricalcando le definizioni di
Aristotele. Che qualcosa accada non basta a farne un evento: perché sia un
evento è necessario che codesto accadere io lo senta come un accadere per
me. E però, se ogni evento si presenta alla coscienza come accadimento, non
ogni accadimento è evento”1.
Tyche è il caso, quel caso che, volendo riferirsi ad Aristotele, decide il destino
1 C. Diano, Il pensiero greco da Anassimandro agli Stoici, Bollati Boringhieri, Torino 2007, pag. 37.
5
individuale, il corso degli eventi, i quali hanno il loro principio nella materia e
sfuggono alla necessità propria della forma, che d'altronde “è la sola che valga in
assoluto e permetta la previsione e il sillogismo”. Tyche è il caso, è ciò che
permette l'esaurirsi, per modo di dire, della ricerca nel famoso sillogismo di
Aristotele riguardo a Corisco, il quale, essendo uomo, sappiamo che un giorno o
l'altro necessariamente morrà: ma da dove proviene questa necessità? “Dalla
essenza, in cui Corisco ha la sua forma: una forma che in sé contiene i contrari e,
come tutte le forme del nostro mondo sublunare, non ha realtà se non nella
successione degli individui che nell'ordine del tempo la rivestono”.
Riformulando: l'essenza di Corisco, da cui viene esplicitata la sua forma non è
sufficiente a sussistere a livello di realtà se non attraverso un intervento
temporale che appunto la realizzi.
Tuttavia riguardo al “quando” e al “come” Corisco morrà – riferisce Diano - né
uomini né dei possono affermare nulla: possiamo qui solo ipotizzare che morte
gli accadrà solo se, ad esempio, uscirà, e uscirà se, facciamo caso, avrà sete, e
avrà sete se... “Ma non si va lontano”. “A un certo punto la serie si arresta: si
arriva a un 'se' che 'non dipende più da altro', e delle due possibilità che
l'alternativa comporta, si realizzerà ὁποτέρ ἔτυχεν'... e cioè? Quello che si
realizzerà: o, se volete sostituire un nome al verbo e parlare per figura, quella
che il caso o la tyche vorrà”2. Ed è qui, nella tyche, che come dicevamo si
esaurisce la ricerca. Si tratta di un esaurirsi ipotetico, e la cui ipotesi finale
risiede, rispetto a noi, in un periferia infinita dell'accadimento in generale che -
distinto dall'evento perché corrisponde a 'ciò che accade' (non per forza a me) -,
rispetto alla centralità dell'evento come consapevolezza del accadere,
formalmente chiamiamo ἄπειρον περιέχον, che “Anassimandro e i teologi greci
identificavano col 'divino', e da cui facevano 'governare il tutto'”. “Vi sono
eventi ed eventi e ciascuno ha la sua dimensione e la sua direzione, ma tutti sono
caratterizzati dalla vissuta presenza dell'apeiron periechon”3. Ciò per Diano è
provato in tre modi: 1) attraverso l'esperienza, la quale si può dire che “ciascuno
sa che ogni evento, nell'atto in cui lo vive, è almeno per un istante tutto quanto vi
2 C. Diano, Forma ed evento, Neri Pozza, Venezia 1952, pag.10-11. Corsivo mio.3 C. Diano, Il pensiero greco da Anassimandro agli Stoici, Bollati Boringhieri, Torino 2007, pag.39.
6
è di un evento al mondo”; 2) attraverso la fenomenologia delle religioni4, dato
che è noto il mana5 che, “se da un lato si presenta sempre localizzato e
particolare, dall'altro ha carattere di universalità tale che a ragione si è vista in
esso adombrata la prima idea dell'unicità e della cosmicità del 'divino'”; 3) nei
sistemi più tipici dell'evento dello stoicismo (nella maniera della chiusura) e
dell'esistenzialismo (nella maniera dell'apertura).
L'apeiron periechon governa il tutto e caratterizza tutti gli eventi grazie alla sua
“vissuta presenza”, eppure sorge un'altra questione - o se vogliamo un altra
estensione del problema - ossia quella della coscienza della variabilità dell'hic et
nunc, anche nel discorso. Infatti, in base alla definizione di evento, quindi
secondo l'id quod cuique èvenit, l'evento stesso appare definibile solo in un caso,
ossia in quello in cui, secondo un sorta di petitio principii, noi poniamo
l'esperienza testuale che lo enuncia e concepiamo questa come evento stesso. Il
testo è quindi naturalmente qualcosa che ci accade, e il termine evento si pone di
oltrepassare il piano linguistico in maniera forte. Ciò appena affermato mette in
luce un aspetto fenomenologico che guida la possibilità - affermata da Diano - di
comprendere con un'analisi strutturale anche e necessariamente l'autore stesso.
Detto in altro modo, la suddetta risulta un'azione circolare sterile, nel senso che
si tratta di una semplice interpretazione testuale guidata dalla ricerca di riscontri
dell'interpretato sul testo stesso, tuttavia lo Diano ci induce a farla, col semplice
porre il quod cuique èvenit in riferimento al hic et nunc di cui parla e che ci vede
hic et nunc partecipi del suo testo. In questa circostanza la vissuta presenza
dell'apeiron periechon viene ad essere mossa rispetto al piano di lettura
precedente poiché cambia il nostro sguardo sul quod cuique éventit.
Sono emersi qui i fattori spazio e tempo, e data l'importanza che hanno nei
confronti dell'evento sarebbe bene soffermarci brevemente su questo punto per
vedere come a riguardo ne parla Diano. La tyche, intesa come evento, proprio
essendo ciò che a qualcuno avviene “è sempre hic et nunc” nel senso che nella
misura in cui quella cosa accade a qualcuno, lo spazio e il tempo di quel
qualcuno sono un tutt'uno con quelli della cosa, nel momento del suo mostrarsi.
4 Cfr. G. Van der Leeuw, Fenomenologia della religione. Bollati Boringhieri, Torino 1975, pag 514.5 C. Pignato, Totem, mana, tabù. Archologia di concetti antropologici. Meltemi, Roma 2001, pag. 59 ss.
7
Diano mostra l'esempio dell'albero colpito nella notte dal fulmine e che io vedo
al mattino. L'evento sta nella realizzazione di quel fatto che non avevo notato e
che in quanto non notato non era ancora propriamente evento. Potremmo dire
che senza l'accorgercene l'evento non sarebbe evento, ma appunto solo
accadimento, e in questa prospettiva:
“non sono l'hic et nunc che localizzano e temporalizzano l'evento, ma
l'evento che localizza l'hic e temporalizza il nunc”.6
L'evento ha un azione attiva nel disegnare il mondo 'che ci si riferisce' attraverso
l'uso della nostra esperienza, secondo un individuazione del luogo e del tempo.
L'evento è così decisivo in questa direzione che localizzando l'hic e
temporalizzando il nunc rende capitale l'attività che ce li crea. Infatti, attraverso
Diano emerge un'esposizione linguistica (come appunto attività) che è principio
dell'evento che ci viene fatto presente. Diano è su questo piano l'evento che ci si
autodisvela nel modo di un'interpretazione, e in un certo senso, attraverso la
pregnanza che è propria al termine 'evento' epura ogni costruzione incoerente
facendoci aderire - in ogni caso - alla elementarità del evento stesso. Tuttavia
l'evento in sé, per essere codificato necessita dell'intervento immediato che
realizzi la pura interpretazione dell'evento accadutoci, in altre parole della forma.
“La forma è ciò che i Greci da Omero a Plotino chiamarono eidos, ed eidos
è la 'cosa veduta' e assolutamente veduta. Ciò che la caratterizza è l'essere
per sé. Solo essa è per sé (ϰαθ᾽αὑτό), e tutto quello che è lo è in sé stessa e
per sé stessa, ed esclude la relazione: l'assolutamente 'separato' (τò
χωριστόν). Come tale, essa esaurisce la sua essenza nella contemplabilità:
tutto quello che essa è, è contemplabile, e ciò che in essa non è
contemplabile, non è.”7
In quanto “'cosa veduta' e assolutamente veduta” e in quanto essente “per sè” la
forma non può essere in relazione con nulla se non con con sé stessa - il “per sé”
6 C. Diano, Il pensiero greco da Anassimandro agli Stoici, pag.38.7 Ivi pag.42.
8
- e quindi facendo perdere senso alla relazione della forma con il resto. Eppure
quella 'cosa veduta' deve esserci fatta vedere. Però “Come eidos o 'cosa veduta'
[la forma] non è veduta se non da sé stessa”, e questo perché “La forma è
assolutamente e per eccellenza speculare e assolutamente identica”, aggiunge
Diano, dato che “Ciò per cui la 'forma' opera nella forma eventica e ne rende
possibile la costituzione, è la specularità, ma è specularità di una polarità che
non giunge all'identità”8. La mancanza di relazioni tocca il problema del veicolo
che fa emergere la forma a sé stessa, e che potremmo dedurre essere, in modo
più immediato e iconico la vista9, oppure l'idea specchio10, come icona del
vedersi e quindi della speculazione. Ma nel modo più evidente il veicolo è il
logos, ossia ciò che ci permette, almeno apparentemente, il nominarsi
dell'oggetto della vista, del sé stesso che si vede (attraverso il suddetto specchio)
ma che non può parlare di sé stesso secondo rigore logico se non fermandosi
bruscamente dialettica di opposti tipica di Eraclito, che non solo secondo questo
peculiare aspetto è stata una figura che ha fatto molto discutere su 'come è il
logos' secondo la logica. La contraddizione in cui il logos non può parlare di sé
stesso e contemporaneamente rientrare in un ordine di tipo logico in questa
attività, emerge nel logos di Diano quando ci parla della forma dicendo: “La
forma è [...]”. E pronunciandosi in questo modo pone il “principio proprio della
'forma'”, ma della forma, paradossalmente non dice nulla - né potrebbe -
dovendoci parlare della “'cosa veduta' e assolutamente veduta” che “non è
veduta se non da sé stessa”11. Ne segue che, siccome pare che Diano qualcosa
dica, possiamo 'vedere'-ed-essere forma (perché questa è l'unica possibilità
concessa dal discorso precedente) solo se ci riconosciamo, secondo una sorta di
speculazione infinita in cui ci si perde per forza, nella forma. In termini di
conoscenza puramente logica questo sarebbe contraddittorio perché, dato che
non possiamo dire di essere forma, cioè di essere senza relazioni, perché ci
relazioniamo con le cose, che allora devono essere per forza 'non-forme', non
8 Ivi pag. 47.9 Cfr. ivi pag.42. La vista è il veicolo semplice che permette alla cosa veduta di essere veduta.10 In quanto la vista non basta ad accorgersi del chi guarda è necessario porre lo specchio. Cfr. ivi Pag.47 dove Diano
si riferisce in particolare all'idealismo affermando: “È solo nella sfera della forma che esiste l''oggetto', e vi esiste perché il soggetto non ne è che lo specchio”. In questo modo appare in maniera ancora più radicale il fatto suddetto.
11 Ivi pag. 42, corsivo mio.
9
possiamo dire nulla sulla forma, né tantomeno sarebbe accettabile questo
presunto nostro riconoscimento nel pensiero di Diano in maniera da rientrare
nella forma stessa, intesa come appunto 'esclusiva della relazione'. Senza
relazione, nessun concetto può essere infatti da altri concetti correttamente
dedotto.
10
§1 I TYCHE, MOIRA ED HEIMARMENE
Diano espone tre modi di intendere la tyche quando la forma la riveste: la tyche-
caso, la tyche-dea e la tyche-destino. La prima è propriamente la tyche che
muove senza alcuna mediazione né speculazione che ne permetta la
rappresentazione. Essa è quindi l'evento immediato e pure quell'apertura che
com-prende l'uomo stesso e che è definita dalla periferia dell'apeiron periechon.
La tyche-caso come concetto va intesa proprio nel significato di caso, e proprio
divenendo concetto si chiude in un'espressione definitiva della sua realtà che
significa “evento senza causa o, comunque, [...] una causa che non operi in vista
del fine”. Quando emerge il concetto siamo già lontani rispetto alla tyche
originaria la quale d'altronde, quando si realizza, rigetta il concetto perché
incompetente a coglierla.
In questo senso, se il concetto di caso può “essere tenuto fermo solo dalla
ragione”, “il sentimento lo rifiuta” perché né lo riguarda, né gli compete. “Per il
sentimento l'evento è sempre aureolato di mistero, rinvia a una potenza che lo
trascende”, e questa potenza è proprio la tyche-dea (personificata nella Moira). Il
terzo modo di intendere la tyche invece, ossia la tyche-destino (heimarmene)
consiste nel caso in cui “ogni residuo d'indeterminazione è annullato”. “Tra
tyche come caso, ed heimarmene - tyche-destino - non v'era altra differenza se
non quella che l'aspetto soggettivo e particolare dell'evento ha nei confronti della
legge che lo piega e ne fa manifestazione di un ordine universale e soggettivo”.
In altre parole sembra che la tyche-destino appaia come la 'legge' che porta
l'evento manifesto ad un ordine, appunto, universale e sempre riferibile a quel
qualcuno che, poiché a lui avviene l'evento, è soggetto12, ed a sua volta il
soggetto naturalmente si riferisce a quell'universalità. Le suddette
“interpretazioni dell'evento” non sono però solo tre interpretazioni, ma anche, se
diamo uno spessore ulteriore al termine evento, “atteggiamenti” e “visioni della
vita”13 e in questo senso rappresentano dei paradigmi irriducibili.
12 Il soggetto si rapporta in maniera speculare rispetto all'oggetto e il rapporto che ne risulta ha valore di “polarità che non giunge all'identità” e questa specularità è ciò che rende possibile la costituzione della forma eventica nell'operare della forma. Cfr. ivi Pag. 42.
13 C. Diano, Forma ed evento, pag.26-27.
11
Abbiamo visto che i tre tipi d'evento (tyche, Moira ed heimarmene) mostrano
nella spiegazione data da Diano un percorso storico della concezione della
categoria eventica, attraverso l'apposizione 1) di un momento immediato nella
tyche, 2) di uno mediato dal divino nella Moira, e 3) di quello dell'heimarmene,
che è immanentizzato rispetto al divino che alberga nella Moira e che attua nella
sua ultima e massima manifestazione il potenziale di un logos in espansione.
A parità dell'evento, anche la forma, come abbiamo visto più su, manifesta tre
modi. Tuttavia per fare chiarezza su questo è necessario eliminare ogni traccia di
temporalità e spazialità dallo sfondo del discorso. 1) La forma, quando può
essere solamente veduta, non concede di essere riportata attraverso qualcosa,
altrimenti sarebbe altro rispetto alla forma, secondo un principio di tipo riduttivo
che Diano indica in maniera ricorrente con la parola “chiusura” e che impiega un
modo opposto rispetto all'apertura della “contemplabilità” che essa ci si concede.
Quando il 'contro-fenomeno' (soggetto) apertosi nel vedere si vede
(oggettualmente), ecco allora il secondo momento, ossia quello della
speculazione. È il momento in cui si costituisce la forma eventica e in cui si ha
coscienza di un rapporto con una polarità che in noi non giunge all'identità14 e in
cui il vedere puro viene soppiantato dal vedersi in maniera mediata attraverso
una specularità che “è specularità di una polarità e non giunge all'identità”. La
forma pura “è assolutamente e per eccellenza speculare e assolutamente
identica”, ed è proprio per questo che nella speculazione compare la privazione
dell'assolutezza. Ciò che rende ancora meno adatta ogni definizione della cosa
vista o della speculazione è l'accadere della definizione, che avvenendo sul
presumibilmente 'visto' o 'speculato' non può che allontanarci dal seno della
forma, portandola verso l'altro.
Ecco allora che l'heimarmene come evento spiegato e reso da una legge
“manifestazione di un ordine universale e oggettivo”15, assume, in rapporto alla
spinta definitoria dell'evento sulla forma, il significato di una forma che può
venire rivestita dall'evento. In altra parole l'evento che tenta di essere afferrato
secondo logos assume un'affinità rispetto al logos che emerge dalla necessità di
14 Cfr. C. Diano, Il pensiero greco da Anassimandro agli Stoici, pag. 47.15 C. Diano, Forma ed evento pag. 26-27.
12
estrapolare dall'assolutezza della forma una sua rappresentazione coerente. Il
discorso da un lato spinge per annullare “ogni residuo d'indeterminazione”16 e
dall'altro si dà alla pacata ricerca di un punto d'incontro tra l'attività speculativa e
la cosa puramente vista (la forma pura).
L'impressione che emerge sul logos è che esso sia da un lato una manifestazione
eventica di una forma auto-riflettente, mentre dall'altro una forma che aspira nel
tentare specularmente di vedersi unitariamente e che diventa duale, e lo diventa
per quell'aspirazione. Ma a livello eventico e formale come è possibile concepire
l'attività del logos? In altre parole, come è possibile de-finire senza chiudere in
un concetto il logos?
A livello dell'evento si può dire, in un senso particolare, che è sempre nella
relazione di due termini: “il cuique” e “la periferia spazio temporale da cui
l'èvenit è sentito provenire”. “Il primo termine è finito, il secondo è infinito e
come ubique et semper comprende tutto lo spazio e tutto il tempo: è in esso che
ha sede il divino”. All'infinitezza spaziale del dovunque e temporale del sempre
corrisponde l'infinitezza della circostanza del divino, e la relazione del cuique
con essa è “sentita e non pensata, e solo come relazione sentita è reale”17. La
modalità di quello iato che c'è tra il cuique (finitezza) e èvenit (infinitezza) è
proprio ciò che mette in moto l'interpretazione del finito sull'infinito, ossia il
logos. In altre parole l'attività che crea l'hic et nunc, nel 'vedere' del cuique, o, in
altro modo il veicolo che fa vedere/specchiare la forma, altro non può essere che
il logos, ossia, quel logos, che detto alla maniera di Diano, permette di
riprodurre l'evento. Il logos in questo modo non soggiace a definizioni a mo' di
chiusura ma è libero di rappresentarsi dall'infinitezza del èvenit alla finitezza del
cuique secondo un rapporto speculativo di un finito e un infinito distinti.
16 Ivi pag. 26.17 C. Diano, Il pensiero greco da Anassimandro agli Stoici, pag. 39.
13
§ 2 I CONFINI DEL LOGOS
Come abbiamo visto nell'introduzione, evento e forma sono due categorie che
significano rispettivamente l'accaderci delle cose (evento) e la contemplazione
immediata o mediata (forma); tuttavia, abbiamo anche evidenziato che nel
veicolare queste due categorie nel discorso compaiono, come abbiamo visto
sopra in breve, due aspetti limitanti.
Nel caso dell'evento, il limite è insito nel fatto che la stessa concezione eventica
di Diano è qualcosa che mi accade quando si fa mia, e tanto più si fa mia, tanto
più essa emerge potentemente. Ecco allora che secondo logica l'evento mi
risulterà rientrare nel azione speculativa della forma, ossia nella sua prima
mediatezza: la speculazione appunto. Ma in che senso? Nel semplice senso che
la speculazione si fa evento. Ciò si spiega nel fatto che evento, può essere
'fenomeno sentito' oppure 'parola usata' da Diano. Non è in gioco banalmente un
livello di significato di un termine, ma l'interpretazione del evenire del segno in
modo 'esterno' o 'interno' al luogo terminale in cui è stato posto, che è lo stesso
luogo in cui è chiamato a emergere rispetto al nostro iniziarlo nuovamente. Il
problema è decisivo, e nello stile di Diano emerge potentemente, perché il
suddetto confronto mette in chiaro ancora una volta lo iato tra evento e forma.
L'apertura dell'evento accostata al nostro aprirsi quando la cogliamo - beniteso:
la stessa apertura -, non può essere veicolata solo da uno statico dire, perché essa
è preceduta dal dinamico sentire l'incandescenza di quella parola che dal piano
linguistico-logico si trova poi su un piano eventico. E la presenza di un piano
linguistico e di uno eventico è riconducibile ad una una messa in discussione
della “presunta originaria equivalenza tra Logos e Logik” che emerge secondo
Massimo Cacciari18 in Diano ed Heidegger19 e tale messa in discussione appare,
in luce di quanto detto più su, confermata.
L'esclusione della relazione fra Logos e sue parti fa infatti emergere l'importanza
di un richiamo ad Eraclito, il quale lo stesso Cacciari ci riferisce essere lo 'stretto
18 Ivi in Introduzione, pag.10: “si tratta di comprendere, storicamente e fenomenologicamente il tempo della krisis, l'Achenzeit, in cui il logos, il temine 'fatale dell'occidente, 'diviene' logica, argomentazione discorsiva, e in tale dimensione e in tale senso acquista 'chiarezza', staccandosi dall'enigma”.
19 Cfr. M. Hiedegger, Eraclito, trad. it., Adelphi, Milano 1993, pp. 147-149.
15
sentiero' che sembra, in maniera più estesa, essere necessario al pensiero
contemporaneo e che è particolarmente importante in rapporto alla ricerca di
Diano20 e, aggiungo, su Diano. A proposito del logos, Diano, parlando di
Eraclito, ci riferisce che esso è ciò che coglie l'armonia dei suoi contrari, proprio
perché essa “è e non può che essere 'invisibile'”, e il logos stesso, cioè il discorso
“in quanto discorso non si ferma in nessuna parola, ma passa dall'una all'altra, ed
è sempre in tutte ed in ciascuna, e le unifica in qualcosa che non si lascia ridurre
allo spazio, e che si muove col tempo”. Ecco allora profilarsi Eraclito come
lontanissimo ma speculativamente densissimo interlocutore dello stile filosofico
di Diano, almeno in riferimento alla parte che ne riguarda lo stile e alla volontà
di oltrepassare il piano del semplice e sedimentato detto per avvicinarsi in
maniera forte al Logos. Nel prossimo paragrafo ci si soffermerà sul modo in cui
l'autore padovano concepisce le basi speculative del discorso ed il rivolgersi di
questo alle categorie di forma ed evento.
20 Ib.: “Inoltrarsi per lo 'stretto sentiero' dell'Oscuro sembra necessario per il pensiero contemporaneo. E Diano (con Colli) è forse chi in Italia ne ha più drammaticamente avvertito l'esigenza”.
16
§ 3 EVENTO E FORMA NEL LINGUAGGIO. IL NOME E IL VERBO
Come dicevamo più su sull'attività che in Diano è propria della forma e che la
'lega' nel discorso che è all'evento nel suo modo del 'vedere' e che permette la
speculazione della forma stessa21, è manifestamente e per eccellenza proprio
quella del logos, non inteso come logica (Logik)22 che Diano apre in un dire che
si fa nome divenendo così “chiusura”23, nel senso che il nome, “Specificando la
potenza che si rivela nell'evento, […] ne supera l'infinità, rendendo così
possibile all'uomo di liberarsi dal thambos (stupore) e di dare una direzione alla
propria azione”24. Detto in altri termini più specifici rispetto alla generale
formulazione di Diano il nome, facendoci interpretare l'evento e superandone
l'infinità, raggiunge un indefinibile oltre, riconducendoci ad una determinazione
e a un azione25. “Ma questo medesimo nome, che dà forma all'evento, permette
anche di riprodurlo”26, ossia di riportare alla memoria l'evento, a patto che
naturalmente la memoria stessa, in un certo modo, già esista o nasca con il suo
farsi riportare l'evento. C'è una forma di relazione dunque solo in questa
specificazione che è il nome e compare nel darsi della forma all'evento. La
forma, che nel suo stato puro è ciò che riveste l'evento, è paradossalmente
proprio ciò che lo rende definitivamente evento.
Riguardo al termine Tyche si può dire che è emblematico del rapporto nome-
verbo, poiché in un certo senso ha un suo irradiare, dovuto al suo uso come
sostantivo dell'aoristo ἔτυχεν. Tuttavia questo “rapporto di causa” tra verbo e
nome non è pensabile se non “dopo la costituzione del nome nella sfera della
rappresentazione, nella quale sola il nome può apparire come separato dal verbo,
21 Cfr. C. Diano, Il pensiero greco da Anassimandro agli Stoici, pag. 39.22 Cfr. M. Fattal, R. Radice, Ricerche sul logos: da Omero a Plotino,Vita e Pensiero, Milano 2005, pag. 69:
“L'Occidente sembra aver preferito la pura razionalità del logos-ratio, che analizza e discrimina per mezzo della scienza, piuttosto che la via prospettata da Eraclito, la quale considera la realtà in un maniera che è tanto razionale quanto irrazionale, senza avvertire il bisogno di porre 'la scissione del logos e della phusis' oppure 'il primato del logos di fronte all'essere' di cui parla Heidegger.
23 Cfr. C. Diano, Il pensiero greco da Anassimandro agli Stoici, pag 42: “La più semplice forma di chiusura è il nome”.24 Ivi pag. 42.25 Riguardo al origine del thambos (stupore), e al momento incondizionato precedente al nome è interessante il
rapporto con un passaggio rilkiano: “I. Vedi, siamo appena al principio / Come prima di ogni cosa, con / mille e un sogno dietro di noi e / senza azione” in R. M. Rilke, Appunti sulla melodia delle cose, Passigli Editori, Firenze-Antella 2006, pag. 25.
26 C. Diano, Il pensiero greco da Anassimandro agli Stoici, pag. 42.
17
e quindi come causa di esso”. In altre parole si può comprendere che il rapporto
di causa che vede il nome 'Tyche' (eventus), come risultante dal verbo 'ἔτυχεν'
(evènit), sia una costituzione e chiusura dell'effetto dello stesso nome il quale
rientra in un livello di 'non realtà' o per lo meno di separatezza dalla realtà. La
separazione che in questo senso vede nettamente distinti il nome dal verbo, “In
ipso eventu, sia quando dal verbo si passa al nome, sia quando in virtù della
ripetizione la forma eventica costituita dal nome si rifà evento e ritorna verbo,
[...] non c'è e neanche l'idea di causa”27. Se dunque il nome e il verbo sono visti
nella sfera della rappresentazione, ossia del livello che proietta la realtà su un
piano dove vigono con forza le categorie logiche - ossia dove esse sono le cause
a guidare il logos - quindi dove i principi sono le cause prime e in potenza la
conoscenza definitiva, essi (nome e verbo) non possono che cristallizzarsi e
interrompere il loro divenire eventico, quindi la loro dimensione temporale, così
sospendendosi nella loro non separatezza, fino a quando 'poi' rientrano dalla
sfera della rappresentazione a quella della realtà diventando distinti rispetto a
quando erano rappresentazione. La rappresentazione stessa qui allora, separando,
mette chiarezza, leva i veli che oscurano, però appunto non può che avvicinarci
al finito e farci scomparire la realtà che invece affiora come 'dio' nella citazione
fatta da Diano riguardo all'unità, in questo caso non separata, tra nome e verbo
dai Götternamen di Usener28: “La cosa singola, che tu vedi davanti, essa e
null'altro è il dio”. Il nome e il verbo in questo senso rimangono distinti, proprio
perché altrimenti non se ne potrebbe parlare. Nella frase citata l'unità del
particolare (“la cosa singola”) e dell'universale (“dio”) necessita incontrarsi nella
stessa forma, che semplicemente è l'immediato significato della frase dell'Usener
nel contesto di Diano. Il nome e il verbo possono essere accostati, nel senso
della dinamica che li lega, rispettivamente alla cosa singola e al dio, nella misura
in cui essi sono ancora il termine e l'inizio del vedere, inteso come rispetto alla
definizione della forma.
Diano afferma che “Tutto quello che c'è di rappresentabile è la puntualità
aoristica del redire [ritornare] ipostatizzata in un nome e fatta causa di quel
27 Ivi. pag. 45.28 Cfr. H. Usener, I nomi degli dei: saggi di teoria della formazione dei concetti religiosi, Morcelliana, Brescia, 2008.
18
singolo rediit [ritornò] che è stato sentito come evento”. Diano ci dice poi che il
nome, ipostatizzando l'idea di redire - quindi il fatto che il nome sia ripetibile -,
se fosse causa, “essendo causa del rediit, e in generale dell'evenire dell'evènit,
“tutto si ridurrebbe a un rediit quia rediit, evènit quia evènit”. Ma prosegue:
“Ora dobbiamo togliere il quia. Che resta? Rediit-rediit, evènit-evènit. Una
tautologia? Sì, se la riducete al piano spaziale della rappresentazione, ma qui
siamo nel hic et nunc di un evento, e l'hic nasce dal nunc. Non si ha quindi
una tautologia, ma una ripetizione”29.
In questo passaggio di Diano emerge un particolare modo di parlare dell'origine
del logos, secondo la prospettiva di chi assimila ad esso uno dei suoi aspetti
appunto particolari, ossia quelli della logica e della ricerca delle cause. Infatti
non è possibile mostrare l'aspetto causale del 'quod cuique èvenit' se non
annullando la necessità definitoria del quia (perché), che chiama in campo ciò
che è causa. Il quia porta su un piano rappresentativo, nel senso che appunto
'vuole' che lo iato temporale fra eventi sia portato sul “piano spaziale della
rappresentazione”, rendendo piatti gli eventi stessi, ossia atemporali, quando
nell'evento non lo sono. Se allora estendessimo la ricerca delle cause al tempo
tutto, rappresenteremmo un logos che diventa logica, formeremmo un veicolo
privo del tempo dell'evento, con il carattere di produrre una sospensione che solo
apparentemente è assoluta. Quindi, non appena tolgo il perché, cioè il 'B perché
A', ovvero l''A che è causa di B' rimangono 'A' e 'B', due elementi che ancora
permettono la possibilità di essere visti come logici, ma solo perché possono
ancora fungere da estremi per un nesso causale, tuttavia quello che ci interessa è
che essi sono hic et nunc eventi che rientrano da un piano logico ad uno appunto
eventico. Ad un certo punto di questo passaggio Diano si chiede che cosa
succeda quando risalgo oltre la ricerca delle cause, annullando il quia del rediit
quia rediit e del evènit quia evènit, e lo fa con le seguenti parole: “Che resta?
Rediit-rediit, evènit-evènit. Una tautologia?” E risponde: “Sì, se la riducete al
piano spaziale della rappresentazione”.
29C. Diano, Il pensiero greco da Anassimandro agli Stoici, pag. 45.
19
Diano, dopo aver chiamato in causa l'aspetto logico che qui potrebbe apparire
'incompetente'30 perché esaurisce la sua portata chiarificatrice sul problema
facendolo rientrare nei termini della tautologia, è necessario ristabilire che anche
'qui e ora' siamo “nell'hic et nunc dell'evento, e l'hic nasce dal nunc”, e quindi
dal “Rediit-rediit, evènit-evènit”. In quest'ottica però “Non si ha [...] una
tautologia, ma una ripetizione” e c'è da dire che “Di tali ripetizioni ne facciamo
di continuo”, continua Diano. Ecco un esempio di questo tipo di evento:
Viene uno e dice: - È morto il tale. - È morto?! Esclamiamo. - È morto!
Risponde. E il circolo è chiuso. Che cos'è che lo chiude? La specularità che
la ripetizione istituisce tra i due verbi e che adombra quell'identità che è il
principio proprio della forma. Da questa specularità nasce il nome.31
In questo contesto compare con evidenza ciò di cui si parlava sopra: un discorso
che, dietro la 'mono-dimensionalità' della logica, mette in evidenza una sola
faccia dell'evento - quella del hic -, che da sola sappiamo non basta a renderlo
evento, anzi, essendo l'hic addirittura derivato del nunc32, non è che parziale e
provvisorio, eventicamente parlando. Tuttavia attraverso la ripetizione di
proposizioni nel testo scritto il peso del fattore tempo emerge nella dinamica di
una conversazione possibile, e questo grazie alla forma del dialogo33.
Diano ci parla nell'esempio anche di un “circolo” che si chiude. Avvicinandoci
per un momento all'istantaneo dialogo sul tale che è morto si può evidenziare di
come la scelta di questo esempio si presti particolarmente ad essere accostata
alla chiusura di un cerchio. Ma non è come sembra. Comunemente il fatto in sé
che un tale sia morto non si presta propriamente ad interpretazioni eventiche
(cioé non ci accade fattualmente come individuo), ma è la risonanza periferica di
quel accadimento che ci provoca l'idea di morte facendola divenire esperienza
eventica. Il risultato di questo chiarimento non è che di mostrare ancora una
30 Cfr. ivi in Introduzione, pag.10, dove Cacciari evidenzia di come “Per Diano, come per Heidegger, è proprio la presunta equivalenza tra Logos e Logik a essere posta in discussione”.
31 Ivi pag. 45.32 Cfr. ib.:“l'hic nasce dal nunc”.
33 Cfr. su come si parla della forma 'dialogica' in: A. Le Moli, Heidegger e Platone: essere, relazione, differenza, Vita e Pensiero, Milano 2002, pag. 28.
20
volta di come il nome nasca dal verbo, tramite una dinamica speculare, secondo
una speculazione in cui è il riconoscimento dell'attività del verbo (evento) a
tramutarsi chiusura del nome (in forma di evento-linguistico) ossia nella faccia
mediata logos.
Il logos che qui parla attraverso Diano o, come più comunemente si dice, Diano
che parla attraverso il logos sono lo stesso evento per me che leggo Diano, nel
senso che l'evento precede nella sua completezza di hic et nunc, il parlare
dell'evento. Infatti quando parlo dell'evento non posso che fare accadere un
evento, almeno perché compare il verbo: il parlare dell'evento è di per sé evento
e ciò che lega i due piani del dire e del detto34 altro non è che il rapporto tra
verbo e nome. La causa del chiudersi del circolo è una speculazione che si itera
all'infinito nell'èvenit del dire di Diano, nella sua massima evidenza. È l'èvenit,
quindi il verbo, che può essere accostato al redeit del nome in questo modo.
34 E. Lévinas, Altrimenti che essere o al di là dell'essenza, Jaca Book, Milano 1983, pag. 10.
21
§ 4 IL LOGOS DI DIANO TRA VITA E RAPPRESENTAZIONE
Abbiamo visto un modo di interpretare l'evento e la forma, in primis nella loro
portata, da un lato fenomenica (immediata) e, dall'altro fenomenologica
(mediata) e, in secondo luogo, a livello di rappresentazione linguistica. In questo
ultimo caso evento e forma vengono estratti nel verbo e nel nome proprio
attraverso un logos e una dinamica che vede coinvolti 'eventi vissuti' ed 'eventi
rappresentati', mediati dall'aspetto più o meno eventico o formale che li
distingue. E questo 'più o meno' vorrebbe porre una continuità verso lo stabilirsi
in evento o forma della dinamica stessa che qui prende atto. Cito Diano:
Evento, ripetizione, specularità, forma eventica: ma la forma eventica non è
reale se non nell'atto in cui la ripetizione si riapre all'evento. Che rapporto
c'è tra questa ripetizione e la prima? E precisamente: il principio da cui la
prima si genera è il medesimo che rende possibile l'altra? Evidentemente
dev'essere. E qual è questo principio? La polarità dell'hic et nunc e
dell'ubique et semper vissuta in atto nell'evento. Prima ancora che la
coscienza intervenga e ne abbia la rappresentazione, l'èvenit si è già riflesso
dal centro alla periferia, e dalla periferia è tornato al centro, e poi di nuovo
torna alla periferia, e di nuovo al centro, in un moto che non ha sosta finché
non si è usciti dall'evento. La ripetizione non fa che riprodurre questo moto,
e ne è la conseguenza, ma, trasportandolo dal 'vissuto' al 'rappresentato', si
muta da ripetizione in specularità e si arresta. Ed ecco il nome. Ma – e qui è
il punto – questa specularità non è di due identici, giacché il 'rappresentato'
non toglie il 'vissuto'. I due èvenit non sono solo rappresentati, sono
innanzitutto parlati, e, come parlati, hanno alone e accento diverso: sono
appunto l'uno l'hic et nunc, e l'altro ubique et semper, e però mantengono
intera la polarità che li genera. La medesima polarità è nel nome. Di qui la
sua natura di simbolo e la labilità che lo riapre alla ripetizione e all'evento.35
Diano in questo passaggio mostra attraverso la sequenza dei nomi “Evento”,
“ripetizione”, “specularità” e “forma eventica” il percorso che appunto l'evento
35 Ivi pag. 45-46.
23
percorre fino a divenire - appunto - forma eventica, ossia di come l'attuazione
chiusa dei nomi possa produrre seppur nella rappresentazione un tempo virtuale
nel discorso. E la ripetizione di più nomi, che si conclude con la forma eventica,
non rende quest'ultima reale “se non nell'atto in cui la ripetizione [di nomi] si
riapre all'evento”. Ma questa non è la chiusura di un circolo, quindi di una figura
piana, bensì piuttosto lo svilupparsi tridimensionale di una vite, in cui la
rappresentazione dell'evento dataci dal nome e il vissuto evento si trovano nella
stessa posizione su un ipotetico asse verticale ma ad altezze differenti dello
spazio. Nella ripetizione infatti, in questo senso, l'evento non è mai lo stesso,
seppur può portare lo stesso nome. Inoltre, la ripetizione pur producendo
dall'accostamento di elementi dello stesso genere, non può, a questo punto,
divenendo, chiamarci al riconoscimento di ciò che diviene nella forma eventica.
Questa, avendo sussistenza come forma che giunge dall'evento, proprio per
questa sua origine, all'evento ritorna. Ecco la ripetizione. Ma la successiva
puntualissima domanda riguardo a questa ripetizione è: “il principio da cui la
prima [ripetizione] si genera è il medesimo che rende possibile l'altra?”. Qui il
logos prende piede potentemente, infatti in luce dell'immagine della vite si può
profilare una possibile risposta in due frammenti di Eraclito, da lui tradotti e da
cui sembra risolutiva la stessa idea della vite, più su anticipata: “una e la
medesima è la via in su e la via in giù” (fr. 60) e “la via retta e la curva sono una
e la medesima” (fr.103).
Quando è Diano a rispondere alla domanda sul principio ci dice in maniera
precisa cosa avviene nel riproporsi dell'evento secondo ripetizione e attraverso la
forma eventica che qui chiameremo logos. Quel principio è rappresentabile
come un riflettersi del èvenit dal centro dell'hic et nunc alla periferia dell'ubique
et semper, un riflettersi non ancora cosciente, dice Diano, ed è la ripetizione a
produrre questo 'moto' – e di esso è pure conseguenza -, tuttavia non appena esso
passa da 'vissuto' a 'rappresentato' “muta da ripetizione in specularità e si
arresta”. Ed ecco il nome36.
Il 'vissuto' e il 'rappresentato' sono apponibili come due vettori che pur
36 Ib.
24
procedendo nella stessa direzione, hanno versi opposti, e proprio in virtù di
questo, parlando per modelli, potremmo dire schematicamente che al crescere
dell'uno l'altro decresce. Riassumendo dall'ultima citazione di Diano: la
ripetizione fa riflettere l'èvenit dal centro dell'hic et nunc alla periferia
dell'ubique et semper, trasportando questo moto riflessivo “dal 'vissuto' al
'rappresentato'”. Come punto di arrivo di un ragionamento che oltrepassa tutto
ciò (quello che abbiamo più su chiamato: la ripetizione, la riflessione, l'èvenit,
l'hic et nunc, l'ubique et semper), il vissuto e il rappresentato possono in questa
prima approssimazione fungere da guide del discorso.
Ecco profilarsi allora un modo di descrivere il discorso di Diano in maniera da
sfruttarne l'innegabile contrazione temporale che innesca, in particolare tra
forma ed evento. Ciò che sembra essere stato definito fin ora sotto i nomi di
forma ed evento può acquisire un chiarificazione formale che proviamo a
mostrare comprimendo il tempo nello spazio e definendo questi secondo
discretezza, che compare nell'uso del numero e di elementi semplici, appunto
secondo il seguente possibile disegno esemplificativo.
Compare in Disegno 1 un tentativo di formalizzare il come pare svilupparsi nel
suo principio il modello forma/evento (orizzontalmente) con quello
vissuto/rappresentato (verticalmente). Estraendo le informazioni sull'evento e la
forma, si può risalire ad un momento che vede un evento/forma originario
(rappresentato simbolicamente dallo '0' a sinistra, che può appunto significare la
25
Disegno 1:
Rappresenta to
...
( Evento1 / Forma
1 )
(0)
↗
↗ )1
(Vis
suto
“vissuta presenza dell'apeiron periechon”37 e che si traduce nella prima
rappresentazione (vd. pedice '1'), ossia '(Evento1
/ Forma1)'. Qui 'Evento
1' è
appunto l'id quod cuique èvenit e la 'Forma1' è la cosa veduta e assolutamente
veduta, ma soprattutto è una cosa senza relazione. Questo secondo le definizioni
delle categorie principali di Diano. Ma il senza relazione della forma non si
esaurisce in 'Forma1' perché quest'ultima è già rappresentazione eventuale
(attraverso il vedere '↗', che innalza di un livello di rappresentazione, ossia in
base all'apposizione del nome-chiusura) e non, come dire, forma pura coerente
con '0', appunto origine/essenza delle due categorie. Quindi, come nomi-
chiusura, forma ed evento sono qui (ripeto: nella rappresentazione) relazionabili,
è non perché lo siano originariamente, ma perché nella stessa rappresentazione
non rispettano l'assolutezza del punto di vista dell'origine stessa.
Eppure, nell'ottica di Diano parlando di ciò, del concetto unico di cui abbiamo
parlato in questo paragrafo, facciamo un altro salto 'verso' il rappresentato e
'lontano' dal vissuto, ossia stabilendo che di quella cosa se ne possa parlare
dandola per assodata. L'unico risultato possibile è che tutto ciò che sta sotto la
parentesi di pedice '1' venga ad essere appunto 1. Ossia che si realizzi in un solo
numero-chiusura. Ciò che è stato detto viene ora ripreso nel Disegno 2 che
segue.
Volendo sviluppare queste interpretazioni dagli elementi del discorso a quelli del
37 Ivi pag. 39.
26
Disegno 2:
...
Vis
suto
R
appresenta to
( Evento1 / Forma
1 )
0
( Evento2 / Forma
2)
↗
↗ )1
( )2
(
↗
disegno, si può notare che '(Evento1 / Forma
1)' è di per se una rappresentazione
che non tiene conto di come possa oltre ad ovviamente esserci rappresentata
(secondo forma), ad accaderci (secondo evento), attraverso significato stesso
delle due categorie. Quindi ritorna fuori l'evento, in particolare quello che
chiamiamo “Evento2”, ossia il vissuto di 1 come ancora come quod cuique èvenit
e “Forma2” come la rappresentazione della sua - seppur spuria - contemplazione.
Di per sé, sembra che ci troviamo al punto di prima, a parte il fatto che stiamo
'sollevandoci' (detto convenzionalmente) dall'aspetto del vissuto, tendendo verso
una più forte rappresentazione (vd. le verticali del Disegno 2). Ma è proprio
secondo questo convenzionale allontanarci dall'origine che emerge la necessità
di cambiare parole, e di qui, ancora, la necessità di chiudere quello che era 'dire'
e che ora è 'detto'. Il tutto è riassunto dalle parentesi e dal pedice '2' appostovi
fuori.
È però necessario dare un nome ai numeri e alle rispettive ripetizioni a cui essi si
riferiscono, perché è attraverso il concepimento più o meno avvertito del numero
che la ripetizione acquisisce uno sviluppo diveniente. Se la ripetizione fosse
vista in maniera a-temporale o extra-temporale, come secondo il punto di vista
sulla rappresentazione logica che più su è emerso, essa avrebbe l'effetto della
tautologia38, mentre, se la concepiamo come un ripetersi secondo un divenire
numerabile allora essa emerge dal discorso e si fa logos, ed è questo logos che
vuole riferirsi con quei punti di sospensione messi convenzionalmente nei
disegni, che di per sé sono già una risposta, dato che quando resi eventuali nel
linguaggio rientrano essi stessi nell'attività formale del logos. In ogni caso come
si può intendere, nel logos ci siamo sempre dentro, proprio per il “moto”
riflessivo vigente tra hic et nunc e ubique et semper. Infatti, a questo punto,
sembra importante richiamare la precedente citazione, “I due èvenit [del vissuto
e del rappresentato] non sono solo rappresentati, sono innanzitutto parlati, e,
come parlati, hanno alone e accento diverso: sono appunto l'uno l'hic et nunc, e
l'altro ubique et semper, e però mantengono intera la polarità che li genera. La
38 Cfr. ivi, pag. 17 (fine secondo paragrafo).
27
medesima polarità è nel nome. Di qui la sua natura di simbolo e la labilità che lo
riapre alla ripetizione e all'evento.”
Ora, dato il punto raggiunto lasciamo questa brevissima e forse un po' esigente
analisi, sperando che sia stata sufficientemente evidente, per avviarci verso delle
possibili - e sicuramente provvisorie - conclusioni dell'elaborato.
28
§ 5 POSSIBILI CONCLUSIONI
La definizione delle due categorie principali di forma ed evento non può che
avvenire ricostituendo più o meno integralmente le molteplici facce di quei
poliedri che sembrano rappresentare39. E queste facce non sono che gli ambiti
culturali che Diano mette in comunicazione, mediati dall'astrazione che rende
quella figura un'unità con alcune proprietà, più che molteplici figure elementari
accostate, che peraltro non risolverebbero la questione alla sua origine. Se
l'origine di questo modello interpretativo può essere considerata il 'concetto'
primitivo del punto, allora la logica lo accoglierebbe come ciò che dà inizio ad
una costruzione di forme più complesse veicolate nella metafora del punto e del
poliedro dall'idea di geometria che li descrive. Nella prospettiva del rapporto
problematico fra logos e logica e risalendo all'evento come proveniente
dall'aspetto della radialità della tyche, troviamo che questo stesso sviluppo
radiale è a generare le possibilità delle forme a partire dal punto, che
eventicamente è allora proprio l'origine dell'evento stesso. Il logos nell'ottica di
Diano risulta essere allora, più che il processo che porta l'infinita possibilità del
punto a divenire un'altra forma più complessa, quello stesso divenire forma di
altro genere. Il logos è un discorso diveniente, che viviamo in un accaderci di
forme da un lato, e che, dall'altro rappresentiamo, come attività in una o l'altra
forma.
Per Diano l'evento è a livello temporale l'origine, e questo proprio perché il
tempo ha una priorità sul momento spaziale. Lo spazio extra-temporale è
insufficiente a muovere verso una realizzazione il Logos, il quale quando si tenta
di definirlo lo si fa divenire logos e successivamente - in un modo del tutto
particolare - logica. Non si discute sulla fisiologia del linguaggio in Diano su
questo livello, e neppure sul linguaggio, bensì si cerca di farlo, di produrlo e
immediatamente contemplarlo, di viverne l'evento e di vederne rappresentata la
forma che solo allora crediamo avvolga lo stesso evento.
Diano si avvicina cautamente ad un accurata definizione del logos proprio
39 Cfr. R. Bodei, Prefazione in C. Diano, Forma ed evento, Marsilio, Venezia 1993, pag. 8. In seguito riferendoci a C.Diano Forma ed evento ci riferiremo all'edizione Neri Pozza, Venezia 1952.
29
seguendone le nervature risultato della sua decifrata “storia”, attraverso le
generali tyche, moira ed heimarmene, nelle loro facce eventiche e formali. Se
l'aspetto eventico non è riconducibile ad una formulazione evidente, nel seno
dell'aspetto formale è stato detto nei tre modi di visione pura, di speculazione e
di accadere della definizione, attraverso un'interpretazione di come Diano si
pone eventicamente nel suo discorrere, ossia nel 'fenomeno' Diano, nel suo 'dire'
e nel suo 'detto'40.
Ecco che, ritornando alla fenomenologia della forma e dell'evento, non possiamo
che considerarle l'una la spinta che porta ad una rappresentazione perfettiva e
provocata dal 'vedere greco', mentre l'altra, ancora una volta, come l'accaderci di
qualcosa secondo un'origine che, come risultato della forma, non può che risalire
circolarmente alla parola caso, quindi tyche, quindi ancora una volta evento. E
quando allora tentiamo di completare l'evento con una definizione ci ingraziamo
l'evenire della forma, che a sua volta, quando spinge per realizzarsi sfuma verso
una chiusura. Questa chiusura è insita nella necessità di porre il nome, che
appunto conclude questa volta l'avvenire dell'evento appunto e liberando il
dialogo fra le forme del linguaggio.
Ma il logos in tutto questo dov'è? Il logos, oltre che quello più su abbiamo
provato a cogliere attraverso Diano, e un rimando ad una chiusura più generale
di quella del nome. Diano mostra il λόγος - appoggiandosi alla posizione stoica -
come “ragione o discorso d'eventi”, a fronte di cui c'è “il Dio degli Stoici”, ossia
l'“evento o [la] concatenazione ciclica e provvidenziale d'eventi”. Inoltre però
non va dimenticato di come invece il Dio aristotelico sia “forma e
contemplazione di forma”41, mentre “la scienza” non sia che “θεωρία,
contemplazione di forme”42. Ecco che, essendoci indirizzati verso la scelta di
un'interpretazione del logos che, avendo potentemente a che fare con l'evento,
può essere colto in maniera circolare attraverso la forma, distanziandosi
ulteriormente dall'“evento”, dalla “concatenazione ciclica e provvidenziale
d'eventi” che dir si voglia, oppure vedendolo nella sua eventicità, come un id
40 Cfr. E. Lévinas Altrimenti che essere o al di là dell'essenza, Jaca Book, Milano 1983, pag. 10.41 Cfr. P. Scarpi et al., “Forma ed evento”. Il contesto filosofico, in L'esilio del sapiente. Carlo Diano a cent'anni dalla
nascita, Esedra, Padova 2003, pag. 23.42 C. Diano, Forma ed Evento, Neri Pozza, Venezia 1952, pag.17.
30
cuique èvenit. Tuttavia rimane una sorta di questione apparente irrisolvibile, una
sorta di enigma che pervade anche il modo di scrivere di Diano nelle sue opere.
Egli pone nelle due categorie principali un'impossibilità di dialogo, se non al
prezzo di perdere quella da cui partirebbe quel dialogo stesso per rimanere
intrappolati nella categoria a essa opposta. Più infatti ci allontaniamo dal vissuto
eventico facendone discorso, più astraiamo verso la forma. Viceversa, partendo
dal un piano puramente rappresentativo in cerca di fondamenti eventici
rischiamo di perderne l'aspetto contemplativo originario. Diano a questo punto ci
viene incontro per quanto mostrato nei suoi scritti su Eraclito, che affronta in
maniera incredibilmente coerente rispetto all'evento e alla forma:
Ma, come ogni contrario è insieme l'altro, questo moto [il muoversi del
logos nel tempo] non procede in avanti se non per tornare indietro, e non
prima va e poi ritorna, ma è in ogni punto insieme andata e ritorno: 'una e la
medesima è la via in su e in giù? (fr. 60). Il che non significa che sia sempre
al medesimo punto, ché allora non sarebbe più moto ma che in ogni punto è
insieme arrivato e si parte, e congiunge la retta ed il cerchio. Ciò che
Eraclito esprime con l'immagine della vite, dove 'la via retta e la curva sono
una e la medesima' (fr. 59). Che è la condizione stessa del cerchio, ove lo si
guardi non nell'immobilità del suo centro, ma nel moto inarrestabile e
continuo della 'periferia, dove ogni punto è principio e fine' (fr. 103). E
questo cerchio è la realtà, ed e perciò che noi 'entriamo e non entriamo nello
stesso fiume, e insieme siamo e non siamo' (fr. 49). E questo è anche il
tempo, mobile e insieme immobile, identico sempre e diverso sempre, e di
cui è simbolo il sole, che 'è sempre nuovo' (fr. 6), ma è sempre anche il
medesimo, perché 'ogni giorno è identico all'altro' (fr. 106).43
Ecco che allora il logos44 può e quasi vuole diventare evento tra eventi, e tanto
più esso è consapevole della forma tanto più potrà essere evento, senza fungere
da spola tra realtà (vissuto) e rappresentazione, bensì essendole tutt'e due
contemporaneamente. Evento e forma possono allora parere categorialmente
43 C. Diano, Il pensiero greco da Anassimandro agli Stoici, pag. 59.44 Cfr. M. Heidegger, Essere e tempo, Longanesi, Milano 1971, pag. 47.
31
come l'arco e la lira eraclitei, e congiungersi attraverso un logos che ne veicola il
complessivo e fenomenologico dispiegarsi. In altre parole se evento e forma non
sono formalmente in comunicazione tra loro tuttavia, a livello di manifestazione
discorsiva, sviluppano un azione che nasce da un'opposizione che in maniera più
pervasiva, accade anche in Eraclito. In questo senso, se non c'è dialogo tra forma
e evento, si può dire che però il discorso (logos) nella sua eventicità permette al
suo essere formulato e recepito di mostrarne una strutturazione che richiama
verso la forma, cioè verso ciò che riveste l'evento e ne contempera l'accadere. Il
logos è in questo modo evento come movimento delle forme linguistiche ed è
forma come espletazione e coglimento di un avvenuto.
Ritornando al punto, intendibile come concetto primitivo della geometria, va
detto che esso è un esempio della possibilità di ogni forma, qualora si disponesse
di una funzione a muoverlo come retta, cerchio, poliedro etc., e quindi in affinità
con l'evento che radialmente ci accade può aprire infinitamente alle possibilità
del nostro divenire, proprio come al suddetto punto geometrico accade la
possibilità di essere nuove forme o di derivarne. In questo modo forma ed evento
appaiono coronati da una affinità nel discorso che Diano mette in atto, discorso
che d'altronde è proprio quello che congenera le due categorie fenomenologiche.
Il logos nella ricerca di Diano non può allora generalmente essere ridotto ad un
approssimarsi dell'evento alla forma o viceversa, perché questi sono già
radicalmente nel logos, almeno perché il logos stesso ne ha disegnato
fenomenologicamente i lineamenti fondamentali, che Diano sembra aver pensato
in modo che possano mostrare la pregnante oscurità dell'accadere delle cose e
nel contempo l'aurorale luminosità riscontrabile nella contemplazione greca, che
da uno stato di imprendibile purezza tende a flettersi per la forza dell'evento
stabilendosi in una potente e unitaria armonia.
32
I miei ringraziamenti vanno al Prof. Adone
Brandalise in qualità di relatore, inoltre alla mia
famiglia e al supporto intellettuale di tutti coloro
con cui è stato possibile fare della filosofia in
questi anni di studi indipendentemente dal
contesto in cui ci siamo trovati a dialogare e a
conoscerci.
F. T.
35
BIBLIOGRAFIA
R. Bodei, Prefazione in C. Diano, Forma ed evento, Marsilio, Venezia 1993.
M. G. Ciani et al., Il segno della forma. Atti del convegno di studio su Carlo Diano
(1902-1974), Antenore, Padova 1986.
C. Diano, Forma ed evento, Neri Pozza, Venezia 1952.
C. Diano, Il pensiero greco da Anassimandro agli Stoici, Bollati Boringhieri, Torino 2007.
C. Diano, Linee per una fenomenologia dell'arte, Neri Pozza, Vicenza 1967.
C. Diano, Studi e saggi di filosofia antica, Antenore, Padova 1973.
M. Fattal, R. Radice, Ricerche sul logos: da Omero a Plotino,Vita e Pensiero, Milano 2005.
M. Heidegger, Eraclito, Adelphi, Milano 1993.
M. Heidegger, Essere e tempo, Longanesi, Milano 1971.
M. Heidegger, Lettera sull'«umanismo», Adelphi, Milano 1995.
A. Le Moli, Heidegger e Platone: essere, relazione, differenza, Vita e Pensiero, Milano 2002.
E. Lévinas, Altrimenti che essere o al di là dell'essenza, Jaca Book, Milano 1983.
R. M. Rilke, Appunti sulla melodia delle cose, Passigli Editori, Firenze-Antella 2006.
P. Scarpi et al., L'esilio del sapiente. Carlo Diano a cent'anni dalla nascita, Esedra, Padova 2003.
H. Usener, I nomi degli dei: saggi di teoria della formazione dei concetti religiosi, Morcelliana, Brescia, 2008.
G. Van der Leeuw, Fenomenologia della religione. Bollati Boringhieri, Torino 1975.
37