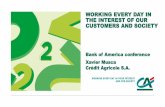Dall’esperienza di campo all’analisi delle criticità nella valutazione dei danni da fauna alle...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Dall’esperienza di campo all’analisi delle criticità nella valutazione dei danni da fauna alle...
I problemi ecologici ed economici dell’esplosione demografica del cinghiale: quali soluzioni per le Aree protette e l’agricolturaAlessandro RossettiFrancesca GianniniGisella MonterossoAlessandra SomaschiniAndrea Monaco Giuseppe PudduValeria Gargini
Strumenti applicativi per la valutazione della gestione delle Aree protette: la metodologia MEVAP applicata ai Parchi regionali della ToscanaDavide MarinoAngelo MarucciMargherita PalmieriPierluca GaglioppaPaolo Pigliacelli
Le trasformazioni territoriali tra spazio urbano e spazio rurale in Colombia: la sfida di un progetto urbanistico a MedellínMario Tancredi
I territori, i paesaggi e la cultura del vino: Franciacorta, Chianti, BolgheriAntonella Anselmo
Anno XIX n.4/2013 - €22,00Poste Italiane S.p.A. Spedizione in Abbonamento Postale - DL 353/2003 (conv. in L 27/02/2004 n. 46) Art. 1 comma 1 - DCB - Perugia
Edizioni Alpes Italia
Via Cipro 77 – 00136 RomaTel./Fax: 06.39738315
Edizioni Alpes Italia
Via Cipro 77 – 00136 RomaTel./Fax: 06.39738315
An
no X
IX n
.4/2
013
ISSN 1123-5489
Bimestrale sull’ambiente e il territorio con il patrocinio del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Redazione
Direttore responsabileRaffaele Fiengo
Direttore editorialeGiuseppe Fiengo
CondirettoriAntonella Anselmo, Roberto Sinibaldi
Responsabile settoreRifiuti e risanamento ambientaleMaurizio Pernice
Responsabile settore Aree protette e sostenibilitàRoberto Sinibaldi
CaporedattoreSusanna Tomei
Hanno scritto sul n 4/2013:Antonella Anselmo, Pierluca Gaglioppa, Valeria Gargini, Francesca Giannini, Davide Marino, Angelo Marucci, Andrea Monaco, Gisella Monterosso, Margherita Palmieri, Paolo Pigliacelli,Giuseppe Puddu, Alessandro Rossetti,Alessandra Somaschini, Mario Tancredi
Comitato scientificoGiuseppe Campos Venuti, Sandro Amorosino, Lorenzo Bardelli, Marco D’Alberti, Stefano Grassi, Fabrizio Lemme, Franco Gaetano Scoca, Roberto Sinibaldi, Gianfranco Tamburelli, Giuliano Tallone, Marcello Vernola
RedazioneVia Cipro, 77 - 00136 - RomaTel. Fax: 06.39738315 [email protected]
Con il contributo di:
Convenzioni di collaborazione scientifica con:
Editore
L’Editore è a disposizione degli aventi diritto con i quali non gli è stato possibile comunicare, nonché per eventuali involontarie omissioni o inesattezze nella citazione delle fonti dei brani e delle illustrazioni riprodotti nel seguente volume.
ABBONAMENTO E ACQUISTO
Per abbonamenti e numeri correnti/arretratiPrezzo del fascicolo euro 22,00 Abbonamento annuale euro 120,00 Abbonamento annuale estero: euro 190,00. Prezzo del fascicolo arretrato euro 32,00
Modalità di pagamentoBonifico bancario su Banca Popolare di MilanoIBAN IT13U0558403236000000000800beneficiario: ALPES ITALIA SRLe-mail: [email protected] tel/fax 06. 39738315
Finito di stampare nel mese di novembre 2013 daTipolitografia Petruzzi Corrado & C. s.n.c.via Venturelli, 7 Zona industriale Regnano 06012 Città di Castello (PG)
Reg. Trib. N. 286 del 27 giugno 1994 (ai sensi della Decisione della Corte d’Appello di Roma, I Sez. Civile del 10 febbraio 1999)
Edizioni Alpes Italia
Via Cipro 77 – 00136 RomaTel./Fax: 06.39738315
Edizioni Alpes Italia
Via Cipro 77 – 00136 RomaTel./Fax: 06.39738315
Università Taras Shevchenko-Kiev
41Gazzetta ambiente n4 / / 2013
Aree protette
Dall’esperienza di campo all’analisi delle criticità nella valutazione dei danni da fauna alle colture agricoledi Giuseppe PudduTecnico forestale del Sistema delle Aree naturali protette e dell’Assessorato Ambiente della Regione Lazio
PremessaI danni da fauna alle colture agricole sono un piccolo argomento dell’ampio capitolo della gestione faunistica, intesa come complesso di materie che vanno dalla biologia ed eco-logia della specie che compie il danno, alle misure gestionali adottabili per prevenirlo.Il tema è stato trattato nel dettaglio da poche pubblicazioni, quasi sempre prive del necessario approccio olistico in grado di spaziare dal contesto socio-economico in cui il danno si inserisce, agli aspetti bio-ecologici della specie agraria danneggiata e della specie faunistica danneggiante.Il più delle volte la trattazione dei danni da fauna selvatica nasce da spinte legate alla necessità di porne in evidenza la presenza o proporli all’attenzione di un più ampio pubblico e di quantificarlo al fine di sollecitare interventi finanziari.Ricondurre l’argomento su canali scientifici non è facile, sia per la mancanza di ap-procci condivisi tra i tecnici, sia perché l’adozione di criteri metodologici rigorosi finisce spesso con lo scontentare chi lamenta i danni o essere sottovalutata da chi propone soluzioni “muscolari” e populiste per la loro eliminazione.Chi propone soluzioni drastiche legate al prelievo venatorio (meglio se fuori stagione o in Aree protette) parte o si focalizza sulla specie considerata danneggiatrice per ec-cellenza: il cinghiale. Ciò è dovuto sia all’assenza di dati attendibili derivanti da proce-dure di raccolta standardizzate a livello nazionale sulle specie che producono danno, sia perché la spinta “al cinghiale”, disconoscendo tutte le altre specie portatici di dan-no, viene da due mondi, quello agricolo e quello venatorio, spesso connessi tra loro.Va ricordato che i dati raccolti dalle diverse Banche Dati Ungulati prodotte da INFS-ISPRA espongono dati forniti dalle Amministrazioni, che a monte non utilizzano al-cun protocollo di rilevamento che presenti aspetti di standardizzazione o condivisio-ne con altre realtà simili. Ogni Provincia o Regione, basandosi su propri approcci e metodi che derivano dalle più svariate fonti (deliberazioni, determinazioni, regola-menti, protocolli o semplice esperienza del rilevatore) produce un dato diverso.Eppure, in questo campo così disarticolato nei suoi approcci, vengono quantificati ed erogati milioni di euro in danni.Il primo, trascurato, aspetto dei danni da fauna selvatica è chi possa avere diritto al ristoro, rimborso, risarcimento o indennizzo del danno1. Fatto che si porta appresso un secondo aspetto cruciale: come definire l’agricoltore ai sensi del danno.
1 Va ricordato che sui termini danno e rimborso, ristoro, indennizzo o risarcimento esistono una serie di sen-tenze delle diverse corti (Cassazione, Cassazione Sezioni unite, Corte costituzionale) oltre una certa quantità di dottrina che ha cercato di ricondurre il danno da fauna selvatica a tre fattispecie distinte del Codice Civile: art. 2043, 2051 e 2052.
42I problemI ecologIcI ed economIcI dell'esplosIone demografIca del cInghIale
Aree protette
Già queste due sole sfaccettature dei danni da fauna selvatica aprono un mondo infi-nito di aspetti legali, legislativi, di consuetudini, di aspetti sociali ed antropologici. E di leggende. La più diffusa è quella del “buon agricoltore”2 che, con la sua paziente opera, difende il territorio dai disastri idrogeologici (che invece cinghiale o nutria, giusto per citare due specie “dannose”, provocherebbero), che genera agrobiodiver-sità che poi difende con pratiche colturali altamente sostenibili, che è in rapporto ecologico, quasi francescano, con il resto del creato, che è vessato da Enti Parco, Comuni, Province o Regioni, che gli negano i dovuti nullaosta, gli impongono vincoli quali SIC o ZPS, o gli impediscono l’accesso ai giusti fondi per allargare la sua attività e renderla più proficua, attraverso lungaggini legate a vari PSR).Poiché è noto che ogni leggenda abbia “sempre” un fondo di verità, gli aspetti appe-na citati generano indecisione o indifferenza nel decisore politico che deve affrontare una questione articolata come i danni da fauna selvatica.Un ulteriore tema importante è come rilevare i danni da fauna selvatica e quali meto-di di stima utilizzare per il loro calcolo, inclusi quali prezzi e quantità utilizzare come produzioni di confronto.Sulla base di un’esperienza decennale in varie realtà territoriali, su molteplici ti-pologie di produzioni agricole e nell’ambito di diversi contesti di studio, ricerca e gestione, si prova di seguito ad affrontare in modo critico i temi enunciati delineando un ragionamento esplicito. Infine, si propone un approccio metodologico originale al rilevamento e alla stima del danno.
2 Si veda il recente scritto di Francesco Petretti su Oasis n. 204: “Braccia rubate all’agricoltura!”.
Recinzione elettrificata a protezione di una coltivazione di cocomeri. (Foto di Andrea Monaco).
43Gazzetta ambiente n4 / / 2013
Aree protette
Quale agricoltore, quale agricolturaStabilire quale sia la figura di riferimento a cui concedere l’eventuale ristoro del danno3 attraverso una valutazione da parte dell’ente o del perito, non è facile, a cau-sa dell’articolata definizione di agricoltore, di agricoltura e del dettato legislativo inerente la rifusione dei danni sia che si parli di legge sulla fauna (e caccia), sia che si parli di Aree protette.Una definizione di agricoltore quanto mai larga, si trova nell’art. 1 del D.Lgs. n. 228 del 2001 (“È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”).L’attività agricola viene perciò definita solo in maniera indiretta, ai sensi di tale arti-colo; ne segue, quindi, che quasi tutto quello che avviene nelle campagne può essere definito attività agricola o assimilato ad essa (per coltivazione del fondo, per selvi-coltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine)4.Le leggi nazionali sulla fauna e sulle Aree protette rimangono vaghe su cosa sia il danno e cosa vada indennizzato. Questo, potenzialmente, comporta che, per gli arti-coli 15 della L. 394/1991 e 26 della L. 157/1992, quasi tutto sia indennizzabile. Molte leggi regionali ampliano questo dettato includendo o specificando altre fattispecie indennizzabili in maniera maggiormente inclusiva.Le cose si complicano ulteriormente quando viene introdotta nel sistema la variabi-le agricoltura biologica. Infatti, parte di questo approccio colturale è organizzato in campi piccoli e/o semi-marginali (sia come ubicazione, sia come attitudine produt-tiva). L’estensione ridotta del campo agricolo si porta inevitabilmente appresso un maggiore peso del danno, per questioni geometriche legate all’incidenza della lun-ghezza del margine sulla superficie complessiva dell’appezzamento. Inoltre, buona parte dell’agricoltura biologica gode di misure di incentivazione, per il motivo prin-cipale che l’agricoltore biologico sopporta un maggior danno alla produzione non ri-correndo a difese provenienti dalla sintesi chimica. Sembrerebbe, quindi, che nell’in-centivo sia già inserita una aliquota che ripagherebbe il danneggiato che conduce i terreni in biologico, dalla maggior presenza di fauna, più frequente perché meno avvelenata, effetto che si vuole, appunto accentuare, con il sostegno alla produzione.
Quale dannoIl rilievo del danno, ai fini della sua quantificazione, è il primo momento di una se-rie di azioni che porteranno l’amministrazione a formulare una proposta di ristoro economico.Come nelle indagini criminologiche, il rilievo del danno è un fatto “irripetibile”. Spes-so l’accertamento del danno avviene appena prima della raccolta (per motivi diffe-
3 Che l’ente deputato possa riparare al danno nella sua interezza o in una determinata percentuale è fatto anch’esso sancito da una serie di sentenze.
4 Per lo stesso articolo di legge si considerano attività connesse: le attività, svolte dallo stesso imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’alle-vamento di animali; vi rientrano, inoltre, le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazio-ne prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale nonché le attività di agriturismo.
44I problemI ecologIcI ed economIcI dell'esplosIone demografIca del cInghIale
Aree protette
renti dovuti all’organizzazione dell’ufficio oppure per una scoperta all’ultimo istan-te da parte dell’agricoltore) e pertanto diventa “momento unico”. In altri casi può essere ripetuto, ma poiché le condizioni di campo possono cambiare rapidamente, quanto costatato in precedenza resta solo come base conoscitiva generale, influendo generalmente poco sulla nuova perizia.Vedere un campo in piena coltivazione, danneggiato anche sino alla distruzione tota-le del prodotto, fa nascere nel conduttore del campo rabbia e rassegnazione, ma non lascia indifferente nemmeno il tecnico incaricato della valutazione, poiché ognuna delle due parti (danneggiato e valutatore), entrambi provenienti o legati alla cultura agricola, “avvertono” interiormente una “aggressione” a qualcosa che è percepita anzitutto come fonte di cibo e di sostentamento piuttosto che di introito monetario.Per questo il rilievo del danno in campo è un momento che vede una elevata concen-trazione di istanze contrapposte in pochi istanti: il coltivatore che vorrebbe il mas-simo possibile di denaro come indennizzo, ritenendo le proprie coltivazioni come uniche ed irripetibili (esattamente il contrario del famoso motto “l’erba del vicino è sempre la migliore”), l’amministrazione che ha l’aspirazione a spendere il meno possibile ed il soggetto valutatore, che personalmente vorrebbe pure essere par-tecipe, che si trova a dover assumere tutti gli elementi utili alla stima in un tempo ragionevolmente breve (sugli elementi della stima si veda Puddu, 20105.Questo porta alla necessità di avere se non schemi predefiniti, almeno similarità di approcci per tentare una certa equiparazione del risultato finale su larga scala.Se per il rilievo non esistono schemi predefiniti, resta comunque fondamentale capi-re e/o conoscere quale sia l’unità di rilievo (metri quadri danneggiati, peso del pro-dotto danneggiata, n. di ceppi o piante). Data l’unicità del momento, al sopralluogo dovrebbe sempre partecipare il danneggiato (cosa non sempre scontata) e magari un tecnico di parte con il quale convenire almeno l’unità di rilievo (anche questo, fatto non scontato).A tal riguardo, sarebbe di stringente necessità la predisposizione, su scala naziona-le, di schede di rilievo divise per coltura o colture analoghe con le quali rilevare e de-scrivere il danno. Ad esempio, il rilievo puntuale di ogni metro quadrato danneggiato in colture come i cereali autunno-vernini, gli erbai, i prati da sfalcio comporta un dispendio di tempo, che il rilevatore non può permettersi a fronte di una stima visiva per classi che altera certamente il valore finale dell’indennizzo, ma meno del costo orario impiegato per la stima, specie se in un giorno si compiono più sopralluoghi.
Quale indennizzoIn mancanza di una modalità universalmente accettata, i metodi di calcolo e valu-tazione dell’ammontare dell’indennizzo finale adottati dalle diverse amministrazio-ni preposte all’erogazione delle somme sono molteplici e riassumibili in tre grandi categorie, ognuna con difetti e pregi: l’approccio “caso per caso”, l’approccio “con prezzario standard” e l’approccio “semi-estimativo”.L’approccio “caso per caso” è tutto basato sull’esperienza di campo del rilevatore che deve conoscere l’agricoltore, la coltura, le condizioni agronomiche della zona e deve saper valutare in un tempo congruo tutti i fattori utili alla perizia. In questo caso spesso si ricorre a prezzi quasi “fai da te” con la formula “alle condizioni di mercato
5 Puddu G., L’approccio alla perizia per la valutazione del danno alle colture agricole. In: Monaco A., Carnevali L., Toso S., 2010, Linee guida per la gestione del Cinghiale nelle Aree protette, 2° edizione. Quaderni Conservazione Natura, 34, Ministero dell'ambiente-ISPRA.
45Gazzetta ambiente n4 / / 2013
Aree protette
locale” per stabilire il prezzo, oppure a giornali e testate di settore o a rilevazioni ge-neriche su mercati nazionali, non opportunamente contestualizzate. È evidente che questo è l’approccio migliore per stabilire l’indennizzo nei casi in cui il valutatore si specializza su una o poche colture (caso frequente per i comprensori specializzati), ed è anche il migliore se si riesce a stabilire un contatto perito-agricoltore che aiuta a sensibilizzare verso i problemi gestionali dell’ente (Provincia, ATC o Area protetta che sia). È altrettanto evidente, tuttavia, che questo approccio, che prescinde dal-le condizioni di mercato per scendere nello specifico caso, si presta alla “casistica personalizzata” e finisce nell’ingenerare disparità tra perizie con favoritismi e valu-tazioni personalistiche che possono fuorviare l’ente nelle scelte gestionali e nell’e-rogazione degli indennizzi. Di segno assolutamente opposto è l’approccio “con prezzario standard” redatto dall’ente pagatore che facilità il rilevatore che deve solo valutare in linea generale l’estensione dell’appezzamento e del danno, per poi fare unicamente delle molti-plicazioni. In questo caso, si evita certamente l’approccio personalistico e tutte le eventuali deviazioni da esso derivanti, ma si spersonalizza tutto il complesso “dan-no-perizia-stima” che conta sulla professionalità del rilevatore, sulla conoscenza del contesto sociale in cui opera, della biologia delle specie danneggiate e che pro-vocano il danno. La “contrattazione” del valore delle colture viene poi stabilita con concertazioni di alto livello (politici e dirigenti sia degli enti che delle associazioni di categoria) che finisce per tagliare fuori la realtà operativa che viene dal campo. Il risvolto positivo è che le valutazioni rimangono confrontabili di anno in anno perché quasi tutti i fattori che condizionano l’indennizzo rimangono costanti come “condi-zioni al contorno”; le variazioni annuali degli importi, pertanto, sono strettamente correlate con le variazione dell’entità del danneggiamento.Frutto di elaborazione personale, maturata dopo decine di valutazioni e perizie nel Sistema delle Aree protette della Regione Lazio, è il terzo approccio, denominato “semi-estimativo”, che si sperimenta da tempo in particolare nella sua forma più lineare sui cereali autunno-vernini, erbai e prati, quale ragionevole compromesso tra l’approccio “caso per caso” e quello “con prezzario standard”, con l’uso dei mer-curiali delle Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura. In campo, il tecnico rileva tutte le condizioni per inquadrare l’azienda nell’ordinarietà (o fuori da essa). Poi rileva il danno per classi di danneggiamento, adottando ove possibile la conosciuta scala di Braun-Blanquet che prevede 5 classi che raddoppiano di super-ficie (la prima classe può essere modificata considerando il danno fino al 10% della superficie).Si ottiene che per grandi appezzamenti si ha un veloce rilievo anche se si possono commettere delle sottostime del danno, mentre sui piccoli appezzamenti si hanno modeste sovrastime del danno con un aumento dell’indennizzo a vantaggio del pic-colo agricoltore, spesso extramarginale, che di frequente non ha capacità di organiz-zare prevenzione e difesa. In ufficio, alla superficie danneggiata viene applicata la produttività media provin-ciale come rilevata dall’ISTAT e quindi moltiplicata per il prezzo medio rilevato dai mercuriali su base provinciale.Nel contesto dell’accertamento dei danni da fauna selvatica alle colture agricole, occorre valutare attentamente anche un particolare “fattore umano”: il contatto tra la figura che perizia e chi ha subito il danno. In questo breve momento dall’alto “va-lore aggiunto”, si sostanzia un contatto efficace tra utente ed amministrazione. Nella persona dell’accertatore e nelle sue competenze tecniche complessive si concretiz-
46I problemI ecologIcI ed economIcI dell'espansIone demografIca deI cInghIalI
Scheda
Aree protette
Accertamento e stima in campo dei danni da fauna selvaticaLa valutazione del danno nel suo complesso passa per fasi successive, da svolgersi sempre, per arri-vare ad una definizione critica della somma da rifondere al danneggiato. Ognuna delle fasi può esse-re scomposta in momenti, ciascuno dei quali è dedicato alla valutazione di un parametro particolare che influisce, nel complesso, sulla redazione della perizia tecnica di accertamento finale del danno. L’iter procedurale può essere didatticamente scomposto in tre fasi principali:
� 1) L’accertamento, o constatazione “dei fatti”. In questa fase si trovano gli elementi impor-tanti e necessari all’inquadramento generale del danno come l’assunzione dei dati generali aziendali (es.: ubicazione dentro/fuori del confine d’interesse o la presenza di vincolistica par-ticolare limitante le produzioni), l’identificazione degli elementi che conducono al riconosci-mento di una determinata specie (tracce/fatte) e l’identificazione di problematiche differenti (ad es. fitopatologie), unitamente alla valutazione generale della misurabilità del danno (dan-no presente e misurabile, danno ipotizzato e/o difficilmente misurabile).
� 2) La stima, momento della raccolta degli elementi in un quadro logico, da cui trarre le debite conseguenze. Qui entra in gioco la valutazione della qualità e quantità del prodotto perso o danneggiato, la valutazione delle produttività medie ed il confronto con la situazione di riferimento, data dal contesto produttivo locale, la formulazione di una prima valutazione (anche se generica) e la sua illustrazione al “portatore di interessi”. In questa fase si concen-trano diverse criticità, e per evidenti ragioni, è qui che occorre raccogliere, per la valutazione, elementi tanto più oggettivi e misurabili.
� 3) La perizia, quale momento della formalizzazione dell’attribuzione di valore al bene sti-mato. I dati quali-quantitativi prima assunti generano una scala delle produttività a cui rap-portare i prezzi di mercato, desunti da mercuriali o prezziari regionali. Resta il problema del reperimento dei prezzi di mercato per quelle produzioni di nicchia o poco commercializzate, o ancora fuori dal grande mercato per le loro particolarità. Anche il momento finale della reda-zione della perizia propone delle difficoltà operative, che nascono sia dalla lentezza generale, tipica del mercato agricolo, nel formare il prezzo di riferimento, che dalla necessità di redigere una perizia tecnicamente corretta, ma pienamente comprensibile al “portatore di interessi” che effettua l’accesso ai dati.
L’applicazione di un tale protocollo pone il problema di quale la figura possa o debba seguire le fasi del protocollo, dal primo accertamento alla redazione finale della perizia, quale atto a carattere tecnico-economico.Dichiarata la “stima del danno” un problema tecnico-economico, la cui risoluzione necessita di in-formazioni e competenze, cultura e metodi/tecniche, la risposta alla domanda precedente non può che portare verso quella figura tecnica agronomica, che dalle evidenze di campo può trarre quegli elementi “necessari e sufficienti” alla formulazione di una stima corretta, poiché assomma nel pro-prio bagaglio culturale tutti gli strumenti utili, sia all’approccio di campo, che alla redazione della perizia finale tenendo conto delle difficoltà e criticità del percorso di accertamento/valutazione, an-che al fine della redazione dell’atto dell’amministrazione competente a pagare.
Scheda
47Gazzetta ambiente n4 / / 2013
Aree protette
Casi esplicativi
1) Il danno alle colture cerealicole autunno-vernineUn caso comune sono i danni alla semina sulle colture cerealicole autunno-vernine con asporta-zione del seme da parte della fauna selvatica. In questo caso si ritiene opportuno e corretto verifi-care, con un primo sopralluogo, che abbia avuto luogo la semina e quale sia la prima estensione del danno che poi sarà quantificato definitivamente prima della raccolta.Anche questo caso si presta a diverse considerazioni: si constata se dopo il danneggiamento sia possibile proporre una ri-semina, qualora la ridotta estensione del danno e l’accessibilità generale dell’appezzamento lo permettano; si constata quali parametri siano più utili per il calcolo del rim-borso; si constata quali spese maggiori o minori eventualmente aggiungere o detrarre.A parte i casi di mancata o semina rada per ottenere comunque un’integrazione economica, la seconda verifica in pre-raccolta, dopo il primo accertamento, permette anche di assumere ulteriori dati sull’incidenza del danno e sui possibili fattori condizionanti (vicinanza a fossi, siepi o boschi) per eventuali future misure di prevenzione o mitigazione del danno. Nel caso di una integrazione della semina, quando fatta in un tempo agronomicamente utile, il rimborso può essere fatto sul solo prezzo di mercato delle sementi, mentre le spese di semina, arti-colandosi su superfici ridotte non sarebbero da valutare, a fronte di un ottenimento di produzione alla raccolta.La valutazione della mancata produzione piuttosto che su prezzari stabiliti a priori dall’ente ero-gante, andrebbe fatta sui prezzi medi realizzati sul mercato a fine raccolto (anche in questo caso tramite Camera di Commercio) data la forte alternanza del valore dei cereali stagione per stagione; un prezzo stabilito a priori potrebbe causare forti sperequazioni per l’agricoltore anche se in un contesto di indennizzo.Dato il contesto di indennizzo, spese accessorie in aumento o diminuzione come le concimazioni, il diserbo o le irrigazioni che andrebbero inserite in un corretto quadro di anticipazioni colturali o frutti pendenti, sono da escludersi poiché esulano dagli aspetti generali che il rimborso del danno può assumere.
Danno da fauna selvatica ad un campo di mais prossimo alla maturazione.Si evidenzia l'atterramen-to completo di parte della produzione.(Foto di Stefano Sarrocco).
48I problemI ecologIcI ed economIcI dell'espansIone demografIca deI cInghIalI
Scheda
Aree protette
2) I danni da cinghiale sul noccioletoIl noccioleto è coltivato con sistemi di allevamento a cespuglio che accentuano la presenza di rami giovani (polloni) su cui si articola la produzione. Il frutto si sviluppa in estate, momento in cui si può verificare una scarsità di piogge e una carenza alimentare (ghiande) nei sistemi forestali. Questo può spingere il cinghiale (ma anche altra fauna) verso i noccioleti. Tipico comportamento del cinghiale è la ricerca di nocciole fresche sui rami produttivi (Figg. 1 e 2), che possono essere spezzati dall’animale che si impenna nel tentativo di raggiungere le parti più distali del pollone su cui cresce il frutto. Questa azione di ricerca ed alimentazione può rompere il ramo produttivo con una perdita produttiva netta nell’anno e nell’ambi-to di un orizzonte temporale futuro che va stabilito secondo le osservazioni di campo.Nell’idea del “giusto indennizzo” si presenta, quindi, al perito la necessità di valutare, oltre la produzione persa per l’annata in corso, anche quale sia la produzione media per ramo per l’anno, e più in generale come inserire questa in un quadro produttivo medio con cui stimare la perdita per il futuro. Da ciò di-scende la necessità di valutare, localmente, quanto sia la durata media produttiva di un pollone. Valutata la produzione media dell’anno per branca produttiva, contando il numero di rami rotti sull’ap-pezzamento si risale ad una produzione potenzialmente persa per l’annata produttiva in corso; valutato l’orizzonte produttivo medio di una branca e la produzione media per anno (da dati storici o misurati) si può estendere la produzione persa e quindi esplicitare un rimborso che supera l’indennizzo (che come
Figg. 1 e 2.Cinghiale adulto che piega un pollone di nocciolo.(Disegni di Paola Marunizzi).
Scheda
49Gazzetta ambiente n4 / / 2013
Aree protette
idea non prevede il lucro cessante o futuro mancato guadagno), per definire meglio un “giusto in-dennizzo”.Su questa base logica di procedimento si possono inserire alcune valutazioni a contorno, per chiarire la differenza tecnica tra un indennizzo ed un risarcimento. Dal punto di vista economico-estimativo e del risarcimento occorrerebbe ancora prendere in considerazione la spese in sovrappiù sostenute per la produzione e le mancate spese dovute alla riduzione dell’apparato produttivo che si realizza dopo il danno ed inserirli in un contesto di valutazione dei frutti pendenti (ovvero di ricerca del tasso di interesse con cui portare al momento della perizia le mancate produzioni).Considerando però che ci si trova in un contesto di rimborso e non di risarcimento è possibile valutare come congruo il valore prima calcolato (danno al prodotto più quantità della produzione persa per le branche spezzate) che copre comunque solo una parte delle perdite subite. Nell’ambito del processo logico di valutazione occorre comunque verificare se ci siano ulteriori costi macrosco-pici generati dal danno e che possono essere inseriti a pieno titolo nella valutazione. Nel caso del nocciolo, la presenza di rami rotti sulla pianta e sul terreno crea un discreto impedimento all’ap-prontamento del letto di raccolta per la meccanizzazione del raccolto, per cui essi vanno eliminati prima di questa operazione. Questo comporta un extra-costo macroscopico di cui tenere anche un indennizzo deve tenere conto. Analizzando i diversi prezziari regionali è possibile desumere una voce generale di potatura/rimonda di cespugli con cui calcolare un addendum al rimborso.
50I problemI ecologIcI ed economIcI dell'esplosIone demografIca del cInghIale
Aree protette
za, nei fatti, l’Ente gestore (e pagatore!). Le differenti politiche gestionali passano, e possono prendere corpo, con diverso grado di efficacia e risultati, anche attraverso questo contatto. Ridurre l’accertamento del danno ad un momento di sola “misura” affidato a terzi esecutori, magari un perito estimatore di una compagnia di assicu-razioni a cui un Ente ha affidato la valutazione e liquidazione del danno, del tutto estranei alla gestione complessiva, svilisce completamento questa possibilità che può anche essere produttiva di contatti positivi e non solo di contrapposizioni tra agricoltura e fauna.
Campi di lenticchie al Parco nazionale dei Monti Sibillini: un contesto potenzialmente molto critico per i danni da fauna selvatica.(Foto di Alessandro Rossetti).
51Gazzetta ambiente n4 / / 2013
Aree protette
Il “giusto indennizzo”Con formule più o meno esplicite giurisprudenza e dottrina hanno delimitato il campo dei rimborsi monetari al danneggiato, definendo in maniera maggioritaria il ristoro economico quale “indennizzo”, ovvero come parte del tutto rispetto al più universale ed omnicomprensivo “risarcimento”. Il corpus interpretativo delle norme è stato poi definitivamente inquadrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2001, che ha sancito due principi cardine di tutto il discorso danni da fauna
52I problemI ecologIcI ed economIcI dell'esplosIone demografIca del cInghIale
Aree protette
selvatica. Il primo punto del ragionamento è che la fauna selvatica soddisfa, con la sua presenza del tutto naturale ed indipendente dall’uomo, l’intera collettività (ad es. cacciatori o watchers, ma anche l’omeostasi ecosistemica). Il secondo punto è che il legislatore, nel contemplare il ristoro del danno, ha previsto una somma che copra l’incomodo del danno stesso, ma detta cifra, l’indennizzo, è moderata dal fatto che tutta la società ritiene meritevole di tutela la fauna nell’ambito di un equilibrio naturale. Della società civile fa parte anche il danneggiato ed anche egli gode dei be-nefici dell’interazione della fauna con gli altri componenti ecosistemici che assieme strutturano un insieme armonico.Al freddo ragionamento appena esposto occorre affiancare l’idea dell’esistenza di un “giu-sto indennizzo”, che spetta all’Amministrazione proporre. Serve un approccio che porti ol-tre la somma derivante da una mera moltiplicazione di cifre da prezzario senza per que-sto arrivare alle somme derivanti da un approccio “ad personam”. In sintesi è opportuno mirare, in alcuni casi, ad una cifra che vada oltre la sola rifusione della produzione persa, ma che dimostri al coltivatore che è inserito in un contesto che dà valore alla sua attività.Volendo concretizzare l’idea di un giusto indennizzo la stima “caso per caso” e quella “con prezzario standard” creano due estremi, mentre al centro si posiziona la valuta-zione “semi-estimativa” poiché abbastanza flessibile da essere adattata in campo ed in ufficio alle situazioni di intramarginalità o extramarginalità aziendale, pur rima-nendo inserita entro binari delimitati di prezzo e produttività media, soprattutto per la “collaudata” capacità di “autocorrezione”. Dal punto di vista psicologico la pro-duttività media soddisfa il grosso produttore o il produttore intramarginale che vede nell’indennizzo cosi calcolato, comunque un ristoro non lontano dalla sua capacità di produrre, mentre il piccolo produttore vede nella produttività media un’alta soglia remunerativa soprattutto degli sforzi profusi nella produzione.Per esplicare meglio questa parte si offrono alcuni spunti derivati dalla valutazione pratica attuata in campo, senza avere la pretesa di fornire una completa risoluzione, ma solo un approccio su cui discutere.
La perizia estimativa e l’approccio “semi-estimativo”Un corretto approccio estimativo al danno, nell’ambito dell’“estimo formale”, do-vrebbe prendere in considerazione una serie di fattori produttivi al fine di istituire il bilancio “ordinario” della coltura per poi verificare lo stato “attuale” e portarlo a sot-trazione al fine di definire il danno. Inoltre, a seconda del periodo del danno andreb-bero portate in aggiunta le anticipazioni colturali o i frutti pendenti. Nel complesso, il metodo, estremamente corretto, si scontra con una serie di fattori di diversa natura che lo rendono troppo rigido rispetto alla realtà dei danni in campo, come ad esem-pio lo stillicidio di chiamate del danneggiato che lamenta continui aumenti del danno tra un sopralluogo ed un altro, oppure la mancanza di una reale confrontabilità tra un tasso di fruttuosità interno difficilmente calcolabile e quello, estremamente ale-atorio, che l’imprenditore otterrebbe da investimenti alternativi.Inoltre, tutto il procedimento proveniente dall’”estimo formale” si scontra con il con-cetto di indennizzo che giurisprudenza e dottrina hanno sancito per il caso “danni da fauna selvatica”.È questo l’errore principale che si riscontra nella letteratura in materia. La definizio-ne “conforme alla legge” di indennizzo porta la valutazione verso un “estimo legale”, cioè verso una valutazione fortemente condizionata dal dettato legislativo e dalle sue interpretazioni, piuttosto che verso l’applicazione delle formule estimative classiche dell’”estimo formale”.
53Gazzetta ambiente n4 / / 2013
Aree protette
L’approccio “semi-estimativo”, per contro non tende ad esaminare il caso specifico, se non per l’estensione percentuale del danno, valutata per classi visive, e per tipi-cizzare eventuali fatti macroscopici tipici della coltura a cui poi assegnare un sovra-costo (ad esempio rami rotti di nocciolo che intralciano la raccolta meccanizzata).Il metodo rimane rigoroso, ma non rigido, conferisce speditezza di campo e presenta una certa ripetibilità anche per diversi osservatori. Inoltre, lavorando per classi, per-mette di ammortizzare quei piccoli aumenti del danno che si possono verificare tra il sopralluogo e la raccolta o la formulazione della perizia e del quantum del rimborso, senza dover per forza tornare per una nuova valutazione di campo.Poiché produttività media provinciale e prezzi medi provinciali, ad ogni modo, risen-tono del mercato, la stima non è prefissata, potendo variare di anno in anno anche di molto, rispetto agli andamenti dei mercati globali.
ConclusioniLa mancanza di una concreta definizione di agricoltura non aiuta chi deve approc-ciarsi alla valutazione dei danni da fauna alle colture agricole. Infatti, la definizione di cosa possa essere agricoltura si ricava solo indirettamente, a partire dalla defi-nizione di agricoltore: tutto ciò che fa l’agricoltore sarà, nella pratica, agricoltura.Occorre sottolineare che, in differenti ma frequenti casi, la valutazione del danno è orientata verso produzioni di nicchia, o casalinghe, o comunque fuori dal grosso mercato per cui è difficile verificare standard produttivi, produzioni medie locali o comprensoriali.In questa carenza di definizione sembra utile proporre una sorta di declaratoria (ela-borata nell’ambito di un lavoro di approfondimento sul tema svolto con altri tecnici delle Aree protette laziali) su cosa come possa essere l’agricoltura: “è una attività produttiva in cui ogni imprenditore ripone la sua esperienza nella combinazione che ritiene ‘ottimale’ dei fattori produttivi. Cionondimeno, in quanto attività produttiva essa deve rispondere a criteri di razionalità da cui non si può prescindere per otte-nere una produzione ‘potenzialmente economica’, intesa come ritraibile secondo gli scopi del produttore, e non piuttosto come puro piacere ludico. Detta attività non può che basarsi su criteri validi, che includono un paradigma scientifico riconosciuto, o comunque delle ‘buone pratiche agricole formalizzate’ o almeno il ‘criterio della parsimonia e del buon padre di famiglia”.Una tale definizione permetterebbe di distinguere una agricoltura “professionale”, anche se di piccola taglia, dall’“hobbismo domenicale” (caso assolutamente fre-quente nell’approccio di campo). La divisione non porta a scartare il secondo a solo vantaggio della prima, ma serve a distinguere due casistiche gestionali completa-mente diverse, che si portano appresso due approcci differenti.Per i due casi occorre mettere in campo idee e forze differenti sia come portata fi-nanziaria, sia come strategie di prevenzione. Nel primo caso basandosi soprattutto sulla gestione “scientifica” delle specie che portano danno attraverso piani impostati su scala comprensoriale, e su sistemi di calcolo del danno e dell’indennizzo, mentre per il secondo possono valere approcci che eliminino “alla radice” il problema, ad esempio con apposite recinzioni o con cattura e traslocazione del singolo individuo, così da ridurre e ricondurre la pressione sociale alla vera entità del danno.Nella esperienza di campo si apprezza meglio il perché l’agricoltore (e molto meno l’hobbista) accetta l’indennizzo (meglio se “giusto indennizzo”), anche quando gli si spiega la reale differenza giuridica e monetaria rispetto al risarcimento. L’attitudine a combinare i fattori produttivi contro l’inclemenza ambientale (solo per citazione,
54I problemI ecologIcI ed economIcI dell'esplosIone demografIca del cInghIale
Aree protette
terreni poveri o impoveriti o poco adatti, piogge e temperature non prevedibili) pre-dispongono il vero agricoltore ad un alto rischio imprenditoriale, molto maggiore rispetto ad altre attività produttive (ed è qui la differenza reale con l’hobbista).La motivazione che spinge all’“accettazione dell’indennizzo” si inquadra nella tipica conduzione aziendale per cash-flow sulla quale l’agricoltore, marginale o extramar-ginale, incentra la sua attività, tralasciando ogni conto, pur corretto estimativamen-te, di fruttuosità del capitale investito. Il ristoro finanziario, anche se sotto forma di indennizzo, si inserisce in questo filone ad una sola condizione: che sia il più rapido possibile nell’erogazione.La rapidità di erogazione compensa i danni da cinghiale più di ogni altro aspetto. Spesso gli altri danni, provocati da specie più carismatiche o belle o considerate rare, vengono compresi molto più facilmente (“… anche loro devono mangiare…”) fino al punto di non richiedere danni o indennizzi.Un approccio condiviso e standardizzato permetterebbe anche di dare il giusto peso al danno da cinghiale, certamente prevalente in linea generale, ma che localmente può essere minoritario rispetto ad altre specie (Puddu et al., 2008a e 2008b6), per-mettendo di quantificare e qualificare il danno diviso per specie “danneggianti” a prescindere dalla loro carismaticità.Va aggiunta, infine, una sottolineatura su un aspetto che le trattazioni accademiche sul tema trascurano: l’agricoltore spesso ignora quanto produce. Se il peso di una nocciola è conosciuto, si ignora quante ce ne siano in un ramo rotto e quindi si igno-ra il reale valore della perdita; se le autunno-vernine, gli erbai, i prati, le orticole crescono su terreni a giacitura complessa (fatto comune tranne che per le poche pianure italiane), l’agricoltore sa quanto falcia, affiena o raccoglie, ma scambia le ore-lavoro del trattore realmente impiegate per percorrere le articolate morfologie del suo terreno, con la reale superficie cartografico-catastale, quindi non riesce a fornire dati di produttività riportata all’ettaro, ma a dare solo dati di produzione.In diverse occasioni, occorre purtroppo sfatare il mito del buon agricoltore, per ripor-tarlo a quello di un produttore non sempre capace di combinare quei fattori che può gestire (semine, concimazioni, lavorazioni). Questo tipo di agricoltori spesso inter-preta l’indennizzo come un’ennesima prebenda elargita sullo stile dei vari fondi re-gionali o dai PSR, che lo hanno abituato ad erogazioni monetarie per delle operazioni gestionali. In una realtà “non drogata” forse potrebbe percepire meglio l’indennizzo come un riconoscimento dei suoi sforzi ed una spinta a prevenire il danno stesso
6 Puddu G. & Scarfò F. (2008a) Wild boar damage’s on hazelnuts: an approach for economic evaluation; Puddu G., Pierucci P., Scarfò F. (2008b) Wild boar vs other fauna: damages in natural protect areas. In: 7th International Symposium on Wild boar and on Sub-order – Sopron 2008.
I problemi ecologici ed economici dell’esplosione demografica del cinghiale: quali soluzioni per le Aree protette e l’agricolturaAlessandro RossettiFrancesca GianniniGisella MonterossoAlessandra SomaschiniAndrea Monaco Giuseppe PudduValeria Gargini
Strumenti applicativi per la valutazione della gestione delle Aree protette: la metodologia MEVAP applicata ai Parchi regionali della ToscanaDavide MarinoAngelo MarucciMargherita PalmieriPierluca GaglioppaPaolo Pigliacelli
Le trasformazioni territoriali tra spazio urbano e spazio rurale in Colombia: la sfida di un progetto urbanistico a MedellínMario Tancredi
I territori, i paesaggi e la cultura del vino: Franciacorta, Chianti, BolgheriAntonella Anselmo
Anno XIX n.4/2013 - €22,00Poste Italiane S.p.A. Spedizione in Abbonamento Postale - DL 353/2003 (conv. in L 27/02/2004 n. 46) Art. 1 comma 1 - DCB - Perugia
Edizioni Alpes Italia
Via Cipro 77 – 00136 RomaTel./Fax: 06.39738315
Edizioni Alpes Italia
Via Cipro 77 – 00136 RomaTel./Fax: 06.39738315
An
no X
IX n
.4/2
013
ISSN 1123-5489