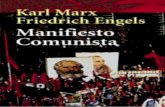Da turgot a Marx
Transcript of Da turgot a Marx
CAPITOLO 4
ANNE ROBERT JACQUES TURGOT (1721- 1781)
Nacque a Parigi da una famiglia con una tradizione legata alla magistratura. Era destinato a una carriera ecclesiastica, ma alla morte de padre ebbe una grossa eredità e intraprese la carriera amministrativa. Contribuì alla formazione dell’Enciclopedy con proposte di riforma delle istituzione come la corvee e la milice. Intorno agli anni 60 scrisse REFLEXION SUR LA FORMATION ET LA DISTRIBUTION DES RICCHESSES, un libro breve con note sulla pubblica amministrazione con principi teorici.
LE CLASSI SOCIALI, INNOVAZIONI SULLA FISIOCRAZIA
Turgot è considerato un fisiocratico perché introdusse delle misure a favore della liberalizzazione del commercio del grano e abolì alcune tasse, egli però non accettò la visione che l’industria è sterile . Inoltre non condivide le politiche dei fisiocratici sul despotismo legale. Turgot suggerisce ai fisiocratici che dovrebbero insistere sul principio della concorrenza e del libero scambio, che deriva dal diritto alla proprietàprivata e dalla quantità speciale che ogni individuo ha, perché conosce i propri interessi meglio di chiunque altro.
Nella sua opera REFLEXION SUR LA FORMATION ET LA DISTRIBUTION DES RICCHESSES scritte in occasione della visita di 2 ragazzi cinesi che volevano sapere
della nuova scienza dell’illuminismo. Come Petty e Cantillon anche per egli esiste il sovrappiù in agricoltura che è la base della divisione del lavoro e della specializzazione delle attività. I salari sono al livello di sussistenza e nella divisione del lavoro identifica: la classe productive, ovvero che produce beni salario e materie prime cioè l’agricoltura, l’attività industriale o classe stipendè e i proprietari terrieri o la classe disposable. La classe stipendiata caratterizzata dall’attività industriale non è considerata sterile anche se è mantenuta dalla classe occupata dall’agricoltura. All’interno delle prime due classi egli distingue : i dipendenti dagli imprenditori. Questi ultimi sono coloro che organizzano e dirigono la produzione, ossia i coltivatori- capitalisti in agricoltura o gli imprenditori nell’industria. I proprietari sono liberi di scegliere come impiegare il proprio reddito. Come in Smith egli parla di stadi.
LA TEORIA DELLA DISTRIBUZIONE
Nella società ci sono 3 classi principali e due di esse sono costituite da datori di lavoro e impiegati.Vediamo come il prodotto è distribuito tra queste classi. Egli distingue il sovrappiù di un paese dalcapitale impiegato dalla produzione. Quindi secondo egli il prodotto complessivo è diviso in 2 parti: quella destinata alla riproduzione successiva dell’anno seguente che include anche i salari da
pagare a tutti i lavoratori, gli interessi sulle anticipazioni; e quella disponibile, ossia il prodotto netto che il coltivatore da al proprietario sotto forma di rendita. L’aumento del sovrappiù è legato all’aumento del prezzo del grano. La produttività della terra per egli è data da un’appropriata tecnologia nella coltivazione, non è data dalla terra.
RENDIMENTI E INVESTIMENTI
Turgot vede il capitale come un insieme di mezzi di produzione, come una quantità di valore che può essere impiegata in differenti attività. Il capitalemonetario può essere investito in diversi modi: una persona può comprare un pezzo di terra e divenire proprietario; comprare mezzi di produzione e impiegarli nell’industria, diventando così un imprenditore; può essere dato in prestito contro interesse. Il denaro dato in prestito in agricoltura,in industria, nelle imprese è destinato a procurare più interesse di quello dato in prestito. Inoltre neivari impieghi è diverso il rendimento. Aggiunge che l’interesse non deve essere tassato perché è la base dei prestiti ed usa tale concetto come una percentuale e non come un valore assoluto( profitto).
Parla di rendimenti di agricoltura afferma che si devono adottare tecniche di produzione che richiedono una enorme quantità di anticipazioni, questo conduce a rendimenti crescenti di scala. Quindi grazie al progresso tecnico e al maggior
capitale aumenterà in una proporzione molto maggiore che la spesa. Se le anticipazioni aumentano, il prodotto aumenta ancora, ma molto meno e progressivamente sempre meno fino a che un’aggiunta all’anticipazione non aggiungerà niente di più alla produzione. In agricoltura prima abbiamo i rendimenticrescenti e poi quelli decresciuti.
TEORIA DEL VALORE
Può sembrare come un seguace di Quesnay o un precursore della teoria soggettiva del valore come lo intendono i neoclassici. Nelle Reflexion il prezzo corrente è definito come il prezzo medio tra quello della domanda e quello dell’offerta. Dice che il valore fondamentale è permanente e stabile del prezzo di mercato. Il prezzo fondamentale ( o punto naturale di sosta) è quello riconducibile a quanto ilbene costa al lavoratore( salari, materie prime, anticipazioni) non include la rendita. È un minimo aldi sotto del quale il valore non può scendere. C’è unequilibrio tra le due nozioni di prezzo( fluido).la concorrenza determina il profitto al tasso più basso e il valore venale tende ad avvicinarsi al valore fondamentale e non può allontanarsi da esso. Non include la rendita nel prezzo fondamentale, che quindi è definito come insieme di elementi fisici della produzione.
Parla di valore estimativo cioè la natura soggettiva del valore e di valore apprezzativo.
Descrive uno scambio di merci contro merci, grano contro legno e dice che ci sarà uno scambio, solo se le due parti contraenti avranno valutazioni diverse.
ADAM SMITH
Nacque a Kirkcaldy nel 1723, all’età di 14 anni studiava già all’università di Glasgow che lasciò successivamente per fare il borsista presso il Balliol college a Oxford. Fu docente di logica e di filosofia morale e durante questo periodo pubblicò la teoria dei sentimenti nel 1759. Nel 1776 scrisse la sua più grande opera a Kirkcaldy UN’ INDAGINE
SULLA NATURA E LE CAUSE DELLA RICCHEZZA DELLE NAZIONI; FU COMMISSARIO DELLE DOGANE. Morì nel 1790, dopo aver dato delle istruzioni ai suoi amici Black eBacon per dover bruciare i suoi scritti.
La sua opera la ricchezza delle nazioni rappresenta la maggiore perché è il primo lavoro che supera la concezione mercantilistica della richezza e qui vediamo l’economia come una scienza; l’opera forniscedelle risposte per le problematiche di quel tempo. In Smith abbiamo due concezioni sul principio fondamentale che guida il comportamento umano: una altruistica nella TEORIA DEI SENTIMENTI UMANI e una egoistica nella RICCHEZZA. Ci sono dei dubbi se l’opera di Smith appartiene al sovrappiù o alla tradizione neoclassica, basata sul meccanismo di offerta e domanda. L’opera di Smith era divisa in 2 periodi: dauna parte i suoi scritti di quando andò in Francia come tutore del duca e poi il periodo della RICCHEZZA.
La teoria di sentimenti morali
Nella teoria dei sentimenti morali sostiene che il comportamento simpatetico dei membri di una comunità è la base principale per la sopravvivenza della stessa; la maggior parte della felicità umana sorge dalla consapevolezza di essere amati e quindi la società non può sussistere tra coloro che sono prontia danneggiarsi e a farsi male uno con l’altro. L’autore usa il concetto dello spettatore imparziale per descrivere che ogni uomo dovrebbe vedere se
stesso nella luce in cui è consapevole che lo vedranno gli altri. Ogni umano infatti è più capace eadatto di ogni altra persona nel prendersi cura di sestesso.
LEZIONI DI GIURISPRUDENZASono state scritte prima del suo viaggio in Francia, rappresentano un tentativo dispiegare la storia delle società civili: usa la teoria dei 4 stadi per spiegare la comparsa dello stadio commerciale. L’opera è composta da appunti presi da studenti cinesi nel 1762-64. Ta gli argomenti principali abbiamo quelli della divisione sociale del lavoro, che dipende dalla capacità produttiva degli artigiani di produrre beni di sussistenza. Abbozzò la teoria del valore dove si nota la distinzione tra prezzo di mercato e prezzo naturale e la tendenza di quest’ultimo verso il prezzo naturale per effetto della concorrenza.
LA RICCHEZZA DELLE NAZIONIIl titolo definisce chiaramente quale deve essere per Smith l’oggetto dell’ economia ovvero una scienza che deve generare una teoria della crescita della ricchezza nazionale. Le tematiche affrontano sia argomenti dei suoi predecessori che dei suoi successori. Smith è il primo autore a porre così tanto l’accento sulla divisione del lavoro come principio principale della
ricchezza nazionale. Il primo libro ha il seguente titolo:
- Delle cause di miglioramento dei poteri produttivi del lavoro e dell’ordine secondo il quale la sua produzione è naturalmente distribuita tra le diverse classi delle persone.Tale titolo fornisce una risposta alla questione della ricchezza e la risposta sta nella crescita della produttività del lavoro. Smith afferma chela ricchezza è la produzione annuale della terra e del lavoro della società e usa il termine reddito come sinonimo di ricchezza. La ricchezza è fatta di merci e non di metalli preziosi ed è la fine del processo produttivo; come nella fisiocrazia la ricchezza è un concetto di flusso e il prodotto annuale è più o meno l’equivalente del prodotto nazionale lordo di oggi.
- Il 2° libro “ della natura, dell’accumulazione e dell’impiego dei fondi”, qui dice che il grande obiettivo di un paese è di aumentare la ricchezzae il potere di quel paese.
- Nel 3° libro “ del diverso sviluppo della prosperità delle diverse nazioni”
- Nel 4° libro “dei sistemi di economia politica, ossia il sistema commerciale e quello agricolo dei fisiocratici” qui fornisce la definizione dieconomia politica o della natura e delle cause della ricchezza delle nazioni.-Dell’entrata del sovrano e della repubblica.
La ricchezza delle nazioni è condotta con un metodo deduttivo(È un metodo didattico che porta ad una conclusione di un ragionamento procedendo dall'universale al particolare. È un metodo utilizzato sia in matematica che in fisica, in questi casi leggi e principi sono preesistenti e non è necessaria una verifica sperimentale, addirittura le stesse teorie prescindono dall'esperienza a questo punto le verità sono di tipo assiomatico, si tratta di deduzioni, appunto. Ad esempio data una regola, un principio, una teoria (argomento generale o universale, come è meglio dire), si produce un esempio, un caso, un'applicazione (si è quindi nell'ambito del particolare)..
L’economia politica è una scienza che deve generare una teoria della crescita della ricchezza naturale. la ricchezza delle nazioni viene identificata tramiteil reddito pro capite ossia col tenore di vita dei cittadini di un paese. La società viene composta dalle seguenti classi sociali: lavoratori, capitalisti e proprietario terrieri.
Smith afferma i vantaggi che porta la divisione del lavoro: la ripetizione della stessa cosa migliora la destrezza del lavoratore, fa risparmiare tempo e consente l’introduzione di piccole invenzioni. Egli fa la distinzione tra lavoratori produttivi e non: - è produttivo colui che genera beni fisici: lavoro nell’agricoltura, nelle manifatture ma non nei servizi. È produttivo quel lavoro che reintegra i fondi impiegati nella produzione e genera profitto( prodotto netto). È produttivo quel lavoro in cui il salario viene dal capitale( processo di
accumulazione capitalistico). È improduttivo quel lavoro la cui retribuzione( lavoro domestico) viene dal reddito del padrone.
TEORIA DEL VALORE
Distingue il valore d’uso e quello di scambio; il primo indica l’utilità di un oggetto; il valore di scambio esprime il potere di acquistare altri beni mediante il possesso di un oggetto( diamanti che hanno scarso valore di uso ma alto valore di scambio e l’acqua che ha un basso valore di scambio ma un alto valore di uso).
TEORIA DEL VALORE LAVORO
Parla di teoria di valore lavoro: contenuto e comandato.
- Il primo dice che per la teoria del lavoro contenuto i rapporti di scambio tra le 2 merci sono proporzionali alla quantità di lavoro necessario per produrli( esempio di cervi e castoro). Se si richiedono 2 giorni per uccidere un castoro e uno per un cervo, allora il prezzo possibile è di 2 cervi per un castoro.
- Il secondo invece, il valore di una merce, per chi la possiede e non intende scambiarla con altre merci, è uguale alla quantità di lavoro cheessa la mette in grado di comprare o di comandare.
Il lavoro è la misura reale del valore di scambio di tute la merci.
IL PREZZO
Distingue il prezzo naturale da quello di marcato:
- Il primo è quel prezzo sufficiente a pagare la rendita delle terra, i salari del lavoro e i profitti de fondi impiegati dal coltivatore, preparare e portare al mercato la merce stessa secondo i loro saggi naturali( costi di produzione)
- Il secondo è regolato dal rapporto tra la quantità che viene portata al mercato e la domanda di coloro che siano disposti a pagare il prezzo naturale della merce.
Il prezzo naturale dipende da due insieme di elementiovvero:
- Le tecniche di produzione- La distribuzione del reddito tra salari, profittie rendita.
Inoltre il prezzo naturale non dipende dalla domanda effettiva che può variare a seconda del prezzo naturale. l’esistenza del reddito porta
all’accumulazione di capitale quando il reddito è risparmiato e investito. L’accumulazione del capitalederiva da risparmi e profitti, o da parte del redditorisparmiata. Per egli l’accumulazione del capitale deve essere antecedente alla divisione del lavoro e produce grande miglioramento nei poteri produttivi del lavoro. Le cause della crescita sono 2: la destrezza dei lavoratori e l’aumento del numero di questi lavoratori produttivi.( lav prod e improd)
LA DOTTRINA DEL FONDO SALARI
Si sostiene che esiste un fondo fisso di capitale peril pagamento di salari. Il rapporto fondo- salari e la dimensione della forza lavoro determina il saggio di salario che è il livello di sussistenza e riproduzione.
Il saggio naturale della rendita è:
- Il prezzo pagato per l’uso della terra- Il prezzo che il proprietario può ottenere in conseguenza di un monopolio che la proprietà della terra stessa gli conferisce( rendita di monopolio)
- Il prezzo dipende dalla fertilità o dalla destinazione del terreno rispetto al mercato( rendita differenziale).
CRITICA AL MERCANTILISMO NEL LIBRO 4 DELLA RICCHEZZA DELLE NAZIONI
Le restrizioni all’importazione dei paesi esteri di merci che potrebbero essere prodotte all’interno sonogiustificate per consentire di far nascere all’interno una manifattura, per proteggere un’industria che sia essenziale per la difesa nazionale, quando esiste all’interno un’imposta sullaproduzione di un’industria nazionale.
IL RUOLO DELLO STATO ( LIBRO 5°)
Classifica le spese pubbliche in spese per la difesa,l’amministrazione della giustizia, le opere pubbliche e le pubbliche istituzioni. Evoca i 4 principi dell’imposta e cioè: capacità contribuitiva,certezza nel tempo, pagamento, modo e somma, riscossione nel tempo e modo più comodo al contribuente. Smith parla di commercio internazionalenel I libro. Per egli la divisione del lavoro è limitata all’estensione del mercato. Il commercio estero, permettendo di vendere la produzione del commercio nazionale, favorisce i miglioramenti dellaproduttività del lavoro. Il commercio estero porta vantaggi ai paesi che scambiano e riguardano la possibilità di realizzare rendimenti crescenti su scala. Ovviamente i paesi poveri hanno difficoltà sulmercato internazionale per il loro commercio non sviluppato.
Capitolo 5
SAY SUL VALORE DI SCAMBIO E L’UTILITA’
Nacque da una famiglia protestante, fu sostenitore della rivoluzione francese e fu nominato membro del tribunato. Fu insegnante all’Athenee di economia politica e nel 1815 scrisse il CATèCHISME D’ECONOMIQUE POLITIQUE. Il suo lavoro più famoso fu TRAITE’ D’ECONOMIQUE POLITIQUE del 1803 e nel 1828 COURS COMPLET D’ECONOMIE POLITIQUE PRATIQUE. Say si considera come l’interprete del pensiero di Smith. Egli sostiene che i prezzi dipendono sia dal costo di produzione che dall’utilità.
Per Say il valore, non dipende da caratteristiche intrinseche della merce, ma è una nozione relativa: il valore deriva dall’abilità di beni a soddisfare determinati bisogni e di procurare utilità,è la quantità delle cose che si possono ottenere, da momento che sono desiderate in cambio della cosa di cui si ci vuole disfare. Il valore è un dato oggettivo, nasce “ per lo scambio e nello scambio”. Ècausato dal’utilità che il bene arreca al soggetto che lo possiede
Per egli la creazione di oggetti utili corrisponde alla creazione di valore e quindi della ricchezza. L’utilità non determina il prezzo,lo scambio avviene nel momento in cui per ciascun soggetto l’utilità delbene che si acquisisce è maggiore di quello che si cede e termina quando questi due termini di confrontosi pareggiano. Definisce la differenza tra utilità soggettiva( relativa ai beni che si cedono) e quella oggettiva( relativa ai beni che acquisiscono).
Differenti utilità sono le condizioni necessarie per lo scambio. Affinchè avvenga ciò ciascun bene deve avere una determinazione e accattata valutazione sulmercato, così il suo valore può essere realizzato, questo viene da egli chiamato prix courant che è indipendente dalle valutazioni specifiche dei contraenti , per avere un valore di scambio sono necessari frequenti scambi e molti operatori. Per descrivere il funzionamento del mercato usa la metafora della bilancia. Domanda e offerta costituiscono i due bracci, mentre il prezzo è la posizione di equilibrio. Da smith prende la nozione di prezzo naturale e considera il costo di produzione come un punto di riferimento attorno al quale il prezzo corrente può fluttuare.
OBIETTIVI DI SAY E ANALOGIE CON QUESNAY, HUME E SMITH
Gli obiettivi e le tappe salienti si Say sono:
- Elevare le condizioni di vita di un popolo,studiare l’equilibrio economico governato da transazioni in moneta;
- Aumenta il prezzo del cotone a causa degli alti dazi doganali.
Da Quesnay riprende il concetto di ordine naturale che è prestabilito rispetto relazioni sociali. Compito dell’economia politica è la scoperta della natura intima delle leggi che governano tale ordine, perciò si propone di individuare le regole che generano la formazione , la distribuzione e il
consumo della ricchezza lasciando al di fuori i problemi politici . A differenza di Quesnay le leggidell’ordine naturale dovevano essere dettate dai fatti e da questi confermate mediante verifica sperimentale. Dei fisiocratici condivide la naturale tendenza dell’equilibrio tra settori produttivi , la perfetta corrispondenza tra produzione e distribuzione.
Da Hume ricava il ruolo della moneta, egli riteneva che la moneta non svolgeva un ruolo rilevante nella riproduzione ma era soltanto una intermediaria nello scambio.
Da Smith ricava insegnamenti per la costruzione del sistema analitico, condivide il suo ottimismo per lo sviluppo della società, adotta un metodo fondato su osservazione ed esperienza, ma è diversa la nozione di valore e distribuzione.
Afferma che la scienza economica individua le regole generali che governano la formazione, la distribuzione , il consumo e la ricchezza, lasciando fuori dal proprio campo dell’indagine i problemi politici e sociali.
TEORIA DELLA DISTRIBUZIONE
Il reddito viene determinato dalle forze di mercato enon dalla produzione, il salario,l’interesse, la rendita hanno un livello minimo dato dal contributoche ciascun soggetto titolare del reddito dà alla produzione e un livello effettivo determinato dalla domanda di mercato.
- Il salario, pur essendo caratterizzato da oscillazioni dalla domanda e dall’offerta di lavoro, è determinato in seguito alla sovrabbondanza dei lavoratori, dalla quantità dibeni che consentono di mantenere lo stesso numerodella classe operaia.
- Il profitto, il compenso dell’imprenditore per lasua attività di organizzazione, per i rischi assunti, per la funzione di intermediario tra chidona le innovazioni e chi ne fa uso.
- Rendita, il compenso per il contributo produttivodeterminato dalla capacità naturale del suolo, inrealtà commisurata alla dimensione della domanda di prodotti agricoli, che a loro volta dipendono dall’aumento della popolazione.
- Interesse, il compenso per il contributo produttivo, dato dai capitali presi a prestito, commisurato ai rischi delle diverse forme di impiego o alla buona amministrazione del paese, ossia dipende da fattori esterni dell’impresa.
la Legge di Say o legge dei mercati, che disponeva la vendita delle merci a prezzi convenienti, dal momento che la produzione avrebbe favorito la creazione di nuovi mercati. La legge non nega ovviamente che si possa verificare un'eccedenza del prodotto, ma presuppone che essa si limiti ad alcuni settori, mentre esclude una crisi generale di sovrapproduzione. Tale risultato è la diretta conseguenza di un assunto teorico sul valore della moneta, peculiare dell'economia classica: la moneta ,infatti, è considerata come oggetto neutro, la cui funzione intermediaria nella circolazione delle mercine rende impossibile la trasformazione in bene, così che sembra essere eliminato il rischio di una paralisi dei mercati dal momento che solo i beni verranno scambiati. Nel XX secolo, la legge di Say è stata duramente criticata da Keynes, che ne ha evidenziato l'astrattezza dei presupposti.
Lavoro prod( beni durevoli, spese per strada riproduttivo)nn prod( beni consumo)
MALTHUS
Nacque nella contea di Surrey dal padre Daniel che aveva un forte interesse letterario e scientifico. Egli non fu influenzato molto dal padre e non condivise la sua visione filosofica. Si laureò in matematica nel 1788 e nel 1804 fu nominato primo professore di storia ed economia politica e divenne prete nel 1791. Nel 1807 iniziò i dibattiti pubblici
sulla legge sui poveri e sulle leggi sul grano. Il suoi lavori furono:
- Un saggio sul principio della popolazione nel 1798
- Un’indagine sulla causa dell’attuale alto prezzo dei viveri nel 1800
- Principi di economia politica nel 1820- Definizioni di economia politica nel 1827- Visione riassuntiva del principio della popolazione.
La situazione economica inglese tra il 1780 e il 1825
Nella metà del 1790 si verificarono cattivi raccolti,nel 1797 la banca di Inghilterra sospese la convertibilità della valuta e questo significò la svalutazione della sterlina rispetto all’oro e ciò segno la cosiddetta controversia bullionista. Fallirono molte banche verso la fine delle guerre napoleoniche e , per il pagamento della guerra vi fu un alto deficit. Alla fine delle guerre il prezzo deigeneri alimentari scese anche per effetto dei buoni raccolti. Vi fu una riduzione dei salari dei lavoratori, della rendita, dei proprietari terrieri edei profitti e aumentò la disoccupazione.
Secondo egli la scienza dell’economia politica ha somiglianza con la scienza della morale e della politica e non con la matematica; in essa si ci deve aspettare di raggiungere un accordo universale su tutte le conclusioni importanti, la causa principale
dipende dagli errori e dalla divergenze e l’autore stesso crede di poterla individuare nel prematuro tentativo di semplificare e generalizzare. L’obiettivo finale è quello di scoprire le leggi di generale validità, essendo l’economia una scienza pratica, trova applicazione nei normali affari della vita dell’uomo.
MALTHUS SULLA POPOLAZIONE
La tesi di fondo riguarda il fatto che la popolazionecresce più velocemente dell’offerta degli alimenti. Ifattori che lo spinsero a trattare la popolazione furono: pressione della popolazione sull’offerta di cibo in Inghilterra, consapevolezza dell’impoverimento progressivo delle classi a basso reddito. Egli afferma che la popolazione è più grandedel potere della terra di produrre mezzi di sussistenza per l’uomo. Fornisce un esempio numerico per la sua tesi e afferma che la popolazione tende acrescere secondo una progressione geometrica(1,2,4,8,16); mentre l’offerta del cibo tende a crescere in una dimensione aritmetica( 1,2,3,4,5,6).Le risorse naturali quindi non vanno a passo con l’aumento della popolazione, egli parla di freni naturali che derivano da miseria o vizi che derivano da una popolazione in rapida
crescita e, di freni preventivi e positivi che derivano dall’aumento della popolazione eccessivo. Il disagio e la povertà della popolazione sono dovutia cause naturali e secondo Malthus la popolazione deve fare ricorso a restrizioni morali per evitare unaumento eccessivo della popolazione le sue terribili conseguenze. Parla di controlli positivi che incidonosul tasso di mortalità: guerre e carestie. Controlli negativi e preventivi che incidono sul tasso di natalità, ritardo di età matrimoniale.
Crisi del sistema capitalistico Lo sviluppo economico è caratterizzato da frequenti crisi che nel lungo periodo portano a rallentamenti di crescita economica. La crisi ha carattere intrinseco ed è dovuta alla caduta della domanda effettiva. L’autore afferma che per egli la ricchezza è dovuta dalla capacità di comandare lavoro, cioè di produrre occupazione ovvero dal valore dei prodotti e, i beni che hanno valore sono quelli da cui si può ottenere un guadagno maggiore dei costi spesi nella produzione.
Malthus parla di lavoro produttivo e improduttivo:
- Il primo produce ricchezza materiale utile che sivende sul mercato, crea un’eccedenza di valore ossia un profitto per il capitalista
- Il secondo invece non produce valore ossia un profitto e, si concretizza in servizi per le persone
Sposta l’attenzione dalla produzione alla valorizzazione e individua nel profitto il momento dell’espansione produttiva.
Per Malthus il reddito dei lavoratori produttivi è destinato alle spese per i consumi, mentre il reddito dei capitalisti(profitto) al risparmio.
In sintesi per egli il lavoro impiegato nel processo di produzione al fine di valorizzare il capitale investito è produttivo, mentre il lavoro impiegato per le attività di consumo è improduttivo. Tale distinzione è legata al processo di accumulazione delcapitale.
TEORIA DEL VALORE
Come si misura il valore di una merce? E da quali cause dipende?
La causa è il lavoro contenuto, mentre la misurazioneavviene tramite la quantità di lavoro-tipo( lavoro comandato,di cui si può disporre nello scambio)vedi smith. La misura è fatta in termini di acquisto anziché di costo.
TEORIA DELLA DISTRIBUZIONE
Il reddito netto è distribuito tra salari,profitti e rendite. La distribuzione del valore dipende dalla domanda e dall’offerta del lavoro, di terra e di capitale sui diversi mercati. Secondo egli il prezzo naturale del lavoro è quel prezzo che nelle circostanze attuali della società è necessario per
suscitare un’offerta media di lavorator, sufficiente per soddisfare la domanda media. Nei principi sostiene che il salario è determinato in base all’offerta di lavoro, quindi il salario naturale è quello che mette in equilibrio l’offerta rispetto la domanda.
- La rendita è un sovrappiù definito come quella parte del valore globale del prodotto che rimane al proprietario del fondo dopo aver pagato tutte le spese, compreso il profitto che si rileva in un certo momento nell’impiego del capitale agricolo.
- È il prezzo di valore di scambio del lavoro. In esso è configurabile il livello minimo, fissato dall’ammontare di beni di prima necessità indispensabili per i lavoratori e le loro famiglie secondo lo standard comune di vita.
- Profitto: deriva dalla differenza fra due valori;quello della merce prodotta e quello delle anticipazioni( salari,imposte, interessi), pagatedall’imprenditore per raggiungere un dato obiettivo.
DAVID RICARDO(1772-1823)
Nacque a Londra da genitori ebraici. Ebbe molti interessi per la matematica e la geologia. Nel 1799 divenne interessato all’economia grazie alla lettura dell’opera Ricchezza delle Nazioni. Le sue due prime
opere furono: IL PREZZO DELL’ORO NEL 1809; L’ALTO PREZZO DELL’ORO IN LINGOTTI, UNA PROVA DEL DEPREZZAMENTO DELLE BANCONOTE. Quando nel 1815 la questione delle leggi protezionistiche sul grano arrivò in Parlamento, Ricardo pubblicò il suo SAGGIO SULL’INFLUENZA DEL BASSO PREZZO DEL GRANO SUI PROFITTI DEL CAPITALE; MOSTRANDO L’INUTILITA’ DELLE RESTRIZIONI ALL’IMPORTAZIONE( SAGGIO SUI PROFITTI).
Il suo lavoro principale fu nel 1817 ovvero: SUI PRINCIPI DEL’ECONOMIA POLITICA E DELLA TASSAZIONE, nel 1819 entrò in parlamento. Durante la sua ultima settimana di vita era interessato al valore e stava lavorando su uno scritto che poi sarà pubblicato da Straffa come NOTA SU VALORE ASSOLUTO E VALORE DI SCAMBIO.
Nel suo metodo mostra fin dalla giovane età interessesui ragionamenti astratti prima di arrivare a una conclusione; è un puro teorico e il suo obiettivo è di determinare leggi che determinano la distribuzionedel reddito tra proprietari terrieri, lavoratori e capitalisti. La sua teoria economica si basa sulla politica economica e i problemi sono:
- Le tariffe sull’importazione del grano- L’offerta di esso sulla distribuzione del reddito.
PROBLEMI ECONOMICI AI TEMPI DI RICARDO
Il prezzo del grano continuava a salire e vi erano mutamenti strutturali dell’economia inglese, in
quanto l’industria cresceva a spese dell’agricoltura;gli agricoltori chiedono la protezioni, i capitalistile libertà.
TEORIA DEL VALORE E SAGGIO DI PROFITTO
Il saggio di profitto nel 1825 scritto da Ricardo conlo scopo di esaminare le cause che determinano il saggio di profitto e la previsione del suo andamento nel tempo. In questa opera Ricardo afferma il principio che il saggio del profitto nell’intera economia è determinato dal saggio del profitto che sistabilisce in agricoltura. Le leggi sul grano di queltempo erano caratterizzate da un blocco continentale avvertitosi durante le guerre napoleoniche che fecero innalzare il prezzo del grano. Da qui nacque un dibattito se abolire i dazi sul grano o no, Ricardo era favorevole, in quanto l’aumento del prezzo del grano comportava un rallentamento nello sviluppo dell’economia; abolendolo era favorita la libera importazione. Le ipotesi per arrivare a tale saggio sono:
- Nel settore agricolo la specificità della produzione permette di calcolare il rapporto tra profitto e capitale anticipato( iniziale) come rapporto di grandezze omogenee; inizialmente non c’è capitale fisso , ma solo circolante, che è
costituito dai salari anticipati dai capitalisti ai lavoratori;
- I salari sono a livello di sussistenza;egli accetta la teoria di Malthus sulla popolazione, quindi i salari di mercato, quindi i salari di mercato sono portati verso il loro livello naturale, cioè il livello che garantisce la sussistenza dei lavoratori; la popolazione tende ad aumentare quando il salario supera i termini di sussistenza.
- La quantità delle terre fertili è limitata e i beni prodotti in settori diversi da quello agricolo avessero un valore di scambio espresso in grano, il capitale anticipato è il grano.
L’agricoltura è l’unico settore in cui la produzione e i mezzi di produzione sono costituiti dagli stessi prodotti, il grano e quindi il sovrappiù può essere misurato in termini fisici senza prezzi relativi. Questo è il modello tutto grano. Abbiamo:
- w è il salario, in termini di grano per ogni lavoratore
- L:numero di lavoratori impiegati nella coltivazione del grano
- Y : produzione agricola.
Quindi in questo caso avremo:
- wL è il capitale complessivo impiegato in agricoltura
- (Y – wL) prodotto netto o sovrappiù.
Il saggio di profitto può essere definito come:
R = ( Y – wL )/ wL = [ ( Y/L) – w] / w= (pg – w) / w
Il saggio di profitto dipende da:
- Il saggio salario reale, w, cioè la quantità di grano annualmente necessaria per la sussistenza di un lavoratore. Il saggio di profitto varia direttamente con le variazioni nella produttivitàe inversamente rispetto ai salari reali.
IL SAGGIO DI PROFITTO DELL’AGRICOLTURA DETRMINA QUELLO DELL’INTERA ECONOMIA
Nei settori non agricoli, il prodotto e i suoi mezzidi produzione sono merci differenti, quindi è necessario un sistema di prezzi relativi per misuraresovrappiù e saggio di profitto. Consideriamo il tessile dove è prodotta stoffa. Il suo saggio è dato da :
rs = (psYs – wLs) / wLs=( ps –wls)/wls
s indica che ci riferiamo alla produzione di stoffa eps è il prezzo di unità di stoffa in termini di grano. Supponiamo w=10 unità di grano. Ciascun settore impiega un lavoratore; 10 metri è la produzione dei tessuti e 12 unità di grano quella dell’agricoltura. Il saggio di profitto dell’agricoltura è pari al 20%. Per vedere il saggio del settore tessile dobbiamo vedere il valore di
scambio tra stoffa e grano. Si suppone che ps = 1,3 ovvero 1,3 unità di grano per ottenere 1 metro di stoffa, in questo caso rs=30 %.
FASI DELLO SVIPLUPPO CON DIVERSI TIPI DI TERRA
I FASE
Abbondanza di terre fertili
In questo caso il salario agricolo si sarebbe diviso in due parti: salario che è misurato dal costo dei beni salario, caratterizzato dai beni del paniere di consumo del lavoratore che gli assicurano la sussistenza; il profitto dal surale produttivo del settore agricolo.
II FASE
L’aumento della popolazione determina la messa a coltura delle terre meno fertili. Ciò avrebbe determinato un aumento del costo del lavoro e quindi un aumento del capitale anticipato, portando ad un ribasso del saggio di profitto delle terre meno fertili. Quindi il saggio di profitto delle terre piùfertili sarebbe calato a causa della concorrenza frai capitalisti per accaparrarsi le terre più fertili.Tale ribasso si mostra in un aumento della rendita proporzionale ai costi di produzione sostenuti nelle terre meno fertili. Ciò significa che i proprietari terrieri avrebbero acquisito sotto forma di rendita
residuale il sovraprodotto determinato dalla compressione dei profitti..la rendita sulla terra messa precedentemente a coltura aumenterebbe e diminuiscono i profitti.
III FASE
Il maggior costo di produzione del grano, avrebbe indotto un aumento proporzionale dei prezzi dei beni prodotti in altri settori. In ciascun settore, essendo il grano il bene tipicamente acquistato col salario, si sarebbe verificato un rincaro dei costi dei fattori di produzione, da qui la diminuzione del saggio di profitto in ogni industria.( i profitti dipendono dal prezzo o dal valore dei viveri). La teoria dei salari di sussistenza indica il livello minimo di profitto per cui n capitalista è disposto aprodurre.
Allegare la dispensa
TEORIA DEL VALORE
Ricardo definisce il valore di una merce come la quantità di ogni altra merce con la quale si scambierà e dipende dalla quantità di lavoro necessario per la sua produzione. Esso dipende non dall’abbondanza ma dalla facilità o dalle difficoltà del processo produttivo. È importante non solo il lavoro per la produzione di merci , ma anche quello impiegato per costruire gli attrezzi( lavoro diretto + indiretto).
TEORIA BASATA SUL COSTO DEL LAVORO
Tale teoria misura la quantità di lavoro ( h di lavoro), diversa abilità dei lavoratori impiegati ( isalari misurano la produttività); influenza dei prezzi dei beni capitali ( lavoro accumulato) ; come includere la terra tra i fattori che determinano i prezzi ( il prezzo determinato al margine dove la rendita è uguale a 0); come includere i profitti trai fattori che determinano i prezzi ( le variazioni dei prezzi relativi nel tempo dipendono dai cambiamenti nelle quantità relative di lavoro incorporato nei beni.
LIMITI DELLA TEORIA DEL VALORE
I prezzi relativi dati dal rapporto tra lavoro diretto e indiretto, violano le condizioni di uniformità nel saggio del profitto nei vari aspetti per i seguenti motivi:
- Diversa durata dei processi produttivi
- Variazione del rapporto tra capitale fisso e circolante
- Differente durata del capitale fisso nei diversi settori.
TEORIA DELLA DISTRIBUZIONE
A fondamento di essa c’è la quantità di lavoro incorporato. La ripartizione del prodotto fra le quote che partecipano alla distribuzione è determinato da fattori tecnici, economici e demografici. Per ogni quota è possibile determinare un valore naturale e un valore di mercato.
Il valore naturale della rendita dipende dalla fertilità della terra. Dipende dal costo impiegato per produrre nel modo meno efficiente una data quantità di grano. La rendita è data dal prezzo, altoprezzo del grano: alta rendita.
Il livello naturale del salario dipende da situazioni storicamente determinate e dagli aumenti demografici. In particolare è determinato dalla quantità di lavoro necessaria a produrre quel panieredi beni ( beni salario) che consentono di soddisfare le esigenze dei lavoratori e delle loro famiglie per vivere e riprodursi.
Il livello naturale del profitto è un reddito di natura residuale che dipende dall’ammontare del sovraprodotto dell’intera economia.
TEORIA DEI COSTI COMPARATI
VANTAGGIO ASSOLUTO
Se una nazione ha un vantaggio assoluto nella produzione di una merce e un’altra nazione ha un vantaggio assoluto nella produzione di un’altra merce, ciascun paese guadagna se si specializza nellaproduzione della merce che costa meno produrre.
VANTAGGIO COMPARATO
Quando un paese è più efficiente di un altro nella produzione di tutte le merci conviene che si specializza nella produzione del bene per il quale ha il maggior vantaggio comparato, ossia il costo comparato più basso, cioè la più elevata produttivitàdel lavoro.
I vantaggi sono espressi attraverso i prezzi relativio costi di opportunità in base alla teoria del valore- lavoro.
Si può avere commercio internazionale tra due paesi anche se tutti i beni hanno un costo maggiore in un paese rispetto all’altro.
DIFFERENZE TRA SMITH, RICARDO E MALTHUS
- Per Smith lo sviluppo dipende dall’accumulazione di capitale e le condizioninecessarie sono: il risparmio e la libertà. Nel 3° libro della ricchezza delle nazioni distingue l’iter seguito dallo sviluppo nella teoria e nella realtà: nella teoria i capitali si formano nell’agricoltura dove si investono, poi vanno nelle manifatture e infine nel commercio; in realtà il percorso avviene è l’inverso. La storia è in contraddizione con la teoria ed è la storia adaver torto. Lo stato stazionario viene allontanato tramite il commercio con l’estero.
- Per Ricardo lo sviluppo dipende dal saggio medio del profitto, ne tratta nel capitolo delcommercio coloniale. Le condizioni che lo favoriscono sono : l’aumento occupazionale ed il miglioramento delle tecniche produttive. Lostato stazionario per lui va abbandonato mediante la meccanizzazione e le scoperte agronomiche oltre alla libertà di importazionedall’estero. Il commercio estero è utile ma non necessario, allo sviluppo economico adottale leggi di Say.
- Per Malthus lo sviluppo economico è caratterizzato da frequenti crisi,m che nel lungo periodo rallentano l’economia. La crisi
è intrinseca nel capitalismo sin dalla nascita ed è dovuta alla caduta della domandaeffettiva. Per egli il reddito dei lavoratori produttivi è destinato alle spese per consumi,mentre il reddito dei capitalisti( profitto) èrisparmiato. La produzione è costituita da beni di consumo. Lo squilibrio è dato dal fatto che i lavoratori producono valore alla somma dei loro salari più i profitti dei capitalisti, mentre la loro domanda è stata uguale ai salari. La soluzione è la differenzatra produzione e consumo, tipico del capitalismo, può essere colmata con l’aggiuntaal consumo dei lavoratori, del consumo di classi e categorie redditiere tipiche della realtà pre-capitalistica.
Malthus afferma che lo sviluppo dipende sempre dalla domanda effettiva e ne parla nei Principi di economia.
KARL MARX ( CAPITOLO 6)
Nacque il 5/5/1818, figlio di un rabbino ebraico e avvocato Heinrich Marx. Intraprese la carriera di giornalista e fu direttore della RHEINISCHE ZEITUNG, un giornale liberale di Colonia. Egli non mostra interesse per i teorici del socialismo francese e conobbe Engels a Parigi quando dovette emigrare lì
per sfuggire alla censura prussiana. La sua formazione avviene tramite i testi di Smith. Andato Bruxelles poiché fu espulso dalla Francia conobbe varie associazioni del lavoro come LA LEGA DEI GIUSTI, divenuta la lega comunista. Si trasferì definitivamente a Londra senza dover più tornare in Francia o Germania. Tra il 1860 e 1873, elabora lo studio delle leggi del movimento della società capitalistica che culmina col primo volume del capitale. È tra i fondatori dell’associazione dei lavoratori( la prima internazionale). Nel suo pensiero vediamo 3 influenze: quella dell’idealismo di HEGEL, quella delle idee socialiste che dominavanoin durante la rivoluzione francese e le idee di Ricardo. Fu il primo autore a parlare di economia politica classica.
Gli scritti
- 1843 CRITICA AL DIRITTO STATUALE HEGELIANO;I MANOSCRITTI ECONOMICO- FILOSOFICI
- 1845 TESI SU FENERBACH e nel 1846 L’IDEOLOGIA TEDESCA entrambi scritti assieme ad Engels
- 1847 MISERIA DELLA FILOSOFIA- 1848 IL MANIFESTO DEL PARTITO COMUNISTA- 1850 le lotte di classe in FRANCIA- 1852 LINEAMENTI FONDAMENTALI PER LA CUBICA DELLA ECONOMIA POLITICA
- 1856 PER LA CUBICA DELL’ECONOMIA POLITICA- 1867 IL CAPITALE( I VOLUME)
- 1885- 1894 IL CAPITALE( II E III VOLUME A CURADI ENGELS)
- 1904-1910 IV VOLUME DEL CAPITALE COL TITOLO DI “STORIA DELLE TEORIE ECONOMICHE E TEORIE DEL PLUSVALORE” PUBBLICATO DA KAUTSKY
Gli elementi che influenzarono il suo pensiero furono: il superamento delle tesi hegeliane sull’evoluzione della storia( tesi, antitesi e sintesi), la lettura di classici britannici e assimilazioni delle tesi di Engels sulla condizione operaia
Per Hegel la storia non procede in modo ciclico, ma si evolve in modo lineare e progressivo secondo la teoria della tesi, antitesi e sintesi. La storia trova la sua evoluzione in una catena ininterrotta diidee fino ad approssimarsi alla verità( metodo dialettico). Marx è influenzato da Hegel, ma si differenzia dal fatto che lo considera idealista per le connotazioni materialiste. Per Hegel il cambiamento avviene nelle idee, per Marx avviene nella materia( materialismo dialettico)La concezione di Marx nella storia viene evidenziata nel ” manifesto del politico comunista” e nella prefazione a “ per la critica dell’economia politica”.
La società per Marx è caratterizzata da aspetti economici generali ovvero: lo scambio, la produzione,la distribuzione e il consumo.La Formazione Sociale
FS è il sistema complesso di relazioni fra gli individui che caratterizza la società di un’epoca. Marx distingue:
- La struttura economica della società che include i 4 elementi generali in cui si dividono le relazioni economiche, ovvero quelli di prima. La struttura a sua volta è composta dai modi di produzione ( mp). Ogni modo di produzione è diverso dall’altro e include due diversi elementiovvero:il primo è composto da lavoro, risorse naturali, mezzi, strumenti e tecniche di produzione; il secondo invece dalle relazioni sociali di produzione.
- La sovrastruttura invece : la politica, la religione, l’arte e l’etica.
Marx distinse 3 mp:
- Antico: basato sulla prp privata della schiavitù,il lavoro è vincolato sia nella sfera della circolazione che in quella della produzione
- Feudale, basato sulla proprietà della terra e delle risorse naturali; la manodopera è divisa daparte del proprietario( le corveè) e da parte deilavoratori che possono decidere da soli. Questa parziale libertà ha fatto nascere gli artigiani.
- Capitalistico: in cui c’è la proprietà privata dei mezzi di produzione. Nella sfera di circolazione i lavoratori sono liberi di impiegarsi presso qualsiasi impresa, ma una volta
diventati lavoratori salariati ed entrati nella sfera di produzione allora sono diventati vincolati. Tale sistema offre una libertà parziale, perché i lavoratori non hanno libertà nel sistema di produzione.
Ogni società è caratterizzata dalla coesistenza di più di un mp. Un mp può dominare sugli altri, il capitalismo è la fase della storia dove il mp capitalista è dominante; cioè che il mp impone le sueleggi, e in particolare quella sul valore, su tutti gli atri mp. Per esempio i prezzi internazionali sonostabiliti secondo il mp capitalistico anche se in altri luoghi lo stesso bene è prodotto in condizioniprecapitalistiche. Marx analizza il funzionamento del mp capitalistico; quali siano le forme che caratterizzano sia la struttura che la società nel tutto, vuole dimostrare che il capitalismo non è eterno col CAPITALE. Nella dialettica di Marx i rapporti di produzione equivalgono alla tesi, le forze della produzione all’antitesi; dallo scontro diqueste emergerà un nuovo insieme di rapporti che rappresenta la sintesi.
Differenza tra socialismo e comunismo
Il socialismo è un ampio complesso di ideologie, orientamenti politici, movimenti e dottrine che tendono ad una trasformazione della società in direzione dell'uguaglianza di tutti i cittadini sul piano economico e sociale, oltre che giuridico. È l’insieme di rapporti di produzione che sarebbe
successo al capitalismo, del quale ne avrebbe contenuto delle tracce. Ciascuno avrebbe contribuito al processo economico con la propria abilità
Per comunismo si intende in primo luogo una realtà sociale che presuppone la comunanza dei mezzi di produzione e l'organizzazione collettiva del lavoro, a cui si accompagna l'assenza dello Stato. Sarebbe subentrato al socialismo con differenze: nessun incentivo al lavoro, scomparsa delle classi sociali. Ciascuno avrebbe contribuito al processo economico secondo l’abilità, ma avrebbe consumato secondo i propri bisogni.
SIGNIFICATO DEL COMUNISMO COME EMERGE DAL MANIFESTO DEL PARTITO COMUNISTA DI MARX
Per comunismo si intende l’abolizione della proprietàfondiaria e l’utilizzo delle rendite sulla terra per scopi pubblici con una tassazione sui redditi che andava aumentando e l’abolizione del diritto di successione. Si ebbe la confisca della proprietà di tutti gli emigranti e i ribelli e la concentrazione dei crediti era nelle mani dello Stato, come anche i mezzi di comunicazione e di trasporto. Tutto era nella mani dello Stato , ma vi furono delle cose
positive come l’istruzione gratuita, l’abolizione dellavoro minorile nelle fabbriche e l’integrazione tra istruzione e produzione industriale.
ANALISI DI MARX PER IL CAPITALISMO
Obiettivo : scoprire le leggi di movimento tipiche del capitalismo e cogliere le contraddizioni esistenti nel sistema tra le forze della produzione ei rapporti di produzione.
Leggi marxiane: formazione di un esercito industriale di riserva( disoccupati) caduta del saggio di profitto, crisi economiche, progressiva concentrazione industriale in un numero sempre più piccolo di imprese, impoverimento progressivo del proletariato.
Ipotesi di lavoro: i prezzi relativi sono caratterizzati ricorrendo alla teoria del costo del lavoro; la moneta è neutrale; nelle manifatture i rendimenti sono decrescenti e i mercati operano in regime di libera concorrenza; l’uomo economico è razionale e calcolatore.
Ma se una sovrappopolazione operaia è il prodotto necessario della accumulazione ossia dello sviluppo della ricchezza su base capitalistica, questa sovrappopolazione diventa, viceversa, la leva dell'accumulazione capitalistica e addirittura una delle condizioni d'esistenza del modo di produzione
capitalistico. Essa costituisce un esercito industriale di riserva
TEORIA DEL VALORE LAVORO
Il valore di scambio per Marx è dato dalla quantità di lavoro necessario( ovvero le ore). Un bene ha valore perché all’interno di esso viene oggettivato esoggettivato il lavoro umano, ovvero vengono inseritideterminati elementi.
La quantità d lavoro è data misurando la durata del lavoro che è necessario per produrre la merce stessa,Marx misura la quantità di lavoro richiesta dalla produzione attraverso il tempo di lavoro socialmente necessario. Per SOCIALMENTE NECESSARIO si intende laquantità di lavoro necessario nelle condizioni medie di produttività del lavoro esistenti in un’epoca e inun paese determinati. Egli supera la diversa abilità o specializzazione dei lavoratori, perché il lavoro specializzato è considerato come un multiplo del lavoro semplice e si ottiene moltiplicandolo per un coefficiente determinato. Sull’influenza esercitata dai beni capitali sulla formazione dei prezzi relativi, ritiene che il tempo di lavoro socialmente necessario alla produzione risulta composto dal numero di ore di lavoro diretto e indiretto.
Sull’esistenza di terre di diversa fertilità dice chela superiore produttività del lavoro svolto sulla terra più fertile è assorbita dal proprietario terriero come rendita differenziale , e la concorrenza farebbe si che la rendita pagata sulle terre migliori fino a che il saggio di profitto risulti lo stesso su tutti gli appezzamenti. Così è la rendita ad essere determinata dal prezzo e non viceversa; a tal proposito dell’influenza dei profitti sulla determinazione dei prezzi delle imprese ad alta o minore intensità di capitale, Marx ritiene che tutte le industrie e imprese hanno la stessa intensità di capitale.
Nel Capitale Marx analizza le leggi che regolano il mp capitalistico e analizza anche:
- Il baratto M contro M, dove m sta per merce; - Economia monetaria: M D M; vendo merce, ottengo denaro e compro altra merce;
- Economia capitalistica: D M D1; si dispone di denaro, si investe per la produzione di merci cheportate sul mercato verranno vendute, con l’aspettativa che costino di più di quanto si sia speso per produrle, ottenendo profitto. D1 >D, perché sarebbe assurdo scambiare due somme di
denaro uguali. Inoltre D1-D è un’eccedenza sul valore originale ovvero il plusvalore.
Il valore complessivo di una merce è uguale a : c + v+ s …C= capitale costante: spesa dei capitalisti per le materie prime e deprezzamento di capitale fisso. V= capitale variabile: somma spesa per salari e stipendi. S = plusvalore: valore residuo ottenuto dalla differenza tra il ricavo lordo del capitale e le spese sostenute per capitale costante e variabile.
Fare esempio.
Il plusvalore assoluto è dato dal prolungamento della giornata lavorativa ovvero v + s . plusvalore relativo invece è dato dalla riduzione del tempo- lavoro necessario e dalla corrispondente modifica nelle lunghezze rispettive dei due componenti della giornata lavorativa.EVOLUZIONE DEL PROCESSO LAVORATIVO Avvenne grazie alla riduzione del tempo per costruire la forza lavoro; prolungamento delle giornate lavoro e intensificazione del lavoro: aumentando la velocità della macchina o ampliando il volume di macchine sorvegliate da uno stessooperaio.
IMMI SERIMENTO PROGRESIVO DEL PROLETARIATO è visto:
- In termini assoluti se si considera che il reddito reale della magg parte della popolazione diminuisce con lo sviluppo del capitalismo( marx si era sbagliato)
- In termini relativi, perché la quota di RN che spettaal proletariato diminuisce nel corsoi del tempo e se
anche il reddito reale aumenta quello relativo diminuisce.( nei paesi sviluppati i salari hanno rappresentato una quota proporzionale del Rn che è stata costante nel tempo per cui marx si è sbagliato
- L’immiserimento non riguarda gli aspetti economici della vita economica ma bensì la qualità della vita,di miseria e degradazione morale.
CRISI DEL CAPITALISMO PER LA CADUTA DEL SAGGIO DI PROFITTO
Per smith il saggio del profitto cade per incremento delle difficoltà di smercio dei prodotti o per la difficoltà di trovare nuove opportunità di investimenti redditizi. Per Ricardo il saggio di profitto cade per le difficoltà di produrre beni salario.Per Marx il progresso delle tecniche produttive ha per effetto di aumentare il rapporto tra capitale costante( c ) e capitale variabile ( v ). Se il saggio del plusvalore ( S/V ) rimane uguale diminuisce quello del profitto.
Il saggio di profitto è dato da S/ C + V e dividendolo per V avremo:
(S / V) / ( C + V / V) che è uguale a (S / V) / C/V + 1
C / V = composizione organica di capitale o C / C + V; S/ V = saggio di sfruttamento.
Se poniamo x = C / V avremo (S / V) / X + 1
Moltiplichiamo per V il nume e deno e il saggio di profitto sarà:
S/ V ( X+1) = S/V . 1/ X+1 per definizione S/V ossia il saggio del plusvalore non muta, ma se si aumenta x avremo 1/ 1 + x diviene più piccolo e cosi come il prodotto S/V = 1/ 1+X.
La caduta tendenziale del saggio di profitto è una formula dell'analisi economica marxiana.Con caduta t del saggio di profitto Marx ne Il Capitale identificò quel fenomeno secondo cui l'aumento progressivo degli investimentisui macchinari a scapito degli investimenti sui salari avrebbe prodotto come risultato tendenziale del processo produttivo un saggio di profitto sempre minore. Marx giunse a questa conclusionesulla base della teoria del valore: essendo il capitale sotto forma di salari (capitale variabile) ad essere l'unica fonte di plusvalore, l’aumento della composizione organica del capitale riferita agli investimenti sulle macchine e sul continuo aggiornamento tecnologico (capitale costante) avrebbe dato come risultato del processo produttivo dei profitti progressivamente decrescenti in proporzione agli investimenti complessivi.In particolare il saggio del plusvalore è nella teoria marxiana il rapporto tra plusvalore e capitale variabile, e il saggio di profitto è invece il rapporto tra il plusvalore e l’insieme del capitale investito, ovvero capitale variabile e costante (salari più macchinari, materie prime e ausiliarie). In formule:
Saggio del plusvalore: Saggio di profitto:
Dove Pv è il plusvalore, C il capitale costante e V il capitale variabile.Secondo questa formulazione infatti nel calcolo del saggio di profitto, con V e Pv costanti, all’aumentare di C il saggio di profitto Sp diminuisce. La conclusione teorica suggerisce quindi che, all’aumentare degli investimenti complessivi sulla produzione, se aumenta la sproporzione tra capitale costante e capitale variabile in favore del primo il profitto diminuisce, e questa diminuzione è progressiva all’aumento della forbice tra i due tipi di investimenti.
CIRISI DI SOVRAPPRODUZIONE Nel libro il capitale Marx vede l’economia composta da 2 settori e indaga sulle condizioni di riproduzione del sistema
capitalistico. Dei 2 settori il primo produce merce 1 che comprende ogni parte del capitale ovvero c; il secondo produce merce due che comprende solo i beni salario ovvero v. entrambi sono anticipati dal capitalista all’inizio del ciclo produttivo. C1 e c2 sono il capitale costantenei 2 settori; v1 e v2 sono i valori del capitale variabile s1 e s2 sono i plusvalori dei due settori. Lo schema di riproduzione è il seguente :
m1 = c 1 + v 1 + s 1
m 2 = c 2 + v 2 + s 2
marx dice che la riproduzione semplice è quella in cui il surples è interamente consumato e non c’è investimento netto. Il rendimento del capitale costante è uguale alla quantità che è usata nella produzione come mezzi di produzione m 1= c 1 + c 2 e m2 = v1+ v2 + s1+ s2
affinchè l’economia sia in grado di riprodursi, è necessario che il settore 1 compri beni salario dalsecondo, e che il secondo compri mezzi di produzione dal primo. Quindi la struttura e la dimensione del capitale determinano le condizioni tecniche della riproduzione e il prezzo relativo, orapporto di scambio, c2 = v1 + s1. Vi possono essere delle crisi come per esempio l’aumento sproporzionato dei due settori; per esempio un’eccedenza del capitale costante rispetto al
capitale variabile; che deriva dall’eccedenza di produzione di un settore dall’altro.
TEORIA DELLA DISTRIBUZIONE IN MARX
RENDITA : è un sovrappiù definito come quella parte che rimane al proprietario del fondo dopo aver pagato tutte le spese, compreso il profitto che si rivela nell’impiego del capitale agricolo.
Salario : è il prezzo o il valore di scambio del lavoro. In esso è configurabile un livello minimo fissato nell’ammontare dei beni di prima necessità indispensabile per i lavoratori e le loro famiglie secondo lo standard di vita comune considerando lediverse circostanze storiche.
Profitto:differenza tra due valori: merce prodotta e anticipazioni ( salari, imposte interessi) pagate dall’imprend per raggiungere il suo obiettivo. (sk)