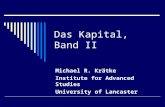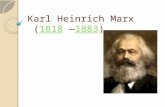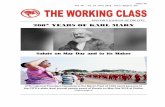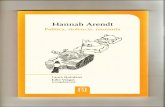Karl Marx: un'idea di logica
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Karl Marx: un'idea di logica
4
INDICE
Introduzione………………………………………………………… pag. 5
Capitolo primo: Ricostruzione storica: le due tendenze principali nella storia del marxismo
La tendenza continuistica ………………………………………………………….. pag. 9
L’ipotesi della rottura epistemologica …………………………………………....... pag. 28
Capitolo secondo: Idee di logica, a partire dall’idealismo
Feuerbach, l’ inversione e la logica delle cose……………………………..…….. pag. 37
Una approssimazione alla dialettica: opposizione e contraddizione……………... pag. 47
Verso il Capitale……………………………………………………………………pag. 61
Capitolo terzo: La problematica fondamentale e la logica del Capitale
La nuova problematica e il “civettare”……………………………….………….. pag. 82
Il lavoro astratto, la merce e il problema dell’inizio…………………………….. pag. 95
Contraddizione, determinazione, astrazione……………………………………...pag. 105
Ancora su merce e lavoro astratto………………………………………........... pag. 118
Capitolo quarto: I gradi della storia: teleologia e mito del soggetto
La storia orientata………………………………………………………………… pag. 144
Dall’estraneazione allo scomparire del soggetto…………………………….……..pag. 160
Bibliografia……………………………………………………………………… pag. 181
Ringranziamenti………………………………………………………………… pag. 187
5
INTRODUZIONE
Il presente lavoro è il frutto di una ricerca intorno a due temi fondamentale della critica
marxista: il problema della logica specifica elaborata dal filosofo di Treviri, e quello della
storia.
L’analisi di questi due problemi è stata anticipata da una ricostruzione storico-critica delle
principali posizioni degli interpreti marxisti, che serve per orientarci e soprattutto renderci
conto delle caratteristiche peculiari dei due paradigmi ermeneutici sorti nel Novecento:
quello che abbiamo definito come continuista, e che pone l’accento sui temi della
reificazione dei rapporti umani all’interno del modo di produzione capitalistico, e che vede
in Marx un pensatore futuro-centrico, che guarda alle ricerche scientifiche come all’ambito
dimostrativo di una precisa filosofia della storia che ha nel soggetto e nella teleologia i
propri concetti cardine, mutuando così categorie dal suo grande maestro Hegel; e quello
della rottura epistemologica, i cui autori ricostruiscono l’itinerario formativo di Marx
rintracciando una forte rottura, un cambio di campo ontologico e di metodo, un abbandono
di una problematica fondamentale in favore di un altro. Il nostro approccio è teso verso
questo secondo modello ermeneutico perché del primo paradigma, come mostreremo nel
dettaglio, non si condivide quasi nulla. I risultati della tesi, mi auguro, avranno messo in
luce che:
Marx non è un pensatore hegeliano, nel senso che la problematica fondamentale di Marx
non è la medesima di Hegel, e ciò accade a partire dal 1845. Prima di questa data Marx era
un esponente della sinistra hegeliana perché la problematica che affrontava era la stessa di
Feuerbach e soci: l’alienazione umana declinata in tutte le forme che erano proprie a
questo movimento. Lo vediamo bene nei Manoscritti economico-filosofici, che non sono
un testo vero e proprio e che di certo non sono un’opera di economia politica: essi
rappresentano l’ultimo tentativo di applicazione dell’equipaggiamento filosofico ad un
campo ontologico differente da quello dell’idealismo tedesco: l’economico. La differenza
con le categorie del Capitale è radicale. Infatti, in questo capolavoro l’alienazione non
gioca un ruolo rilevante e nemmeno secondario; al centro dell’opera non v’è l’uomo ma i
rapporti di produzione.
Una rottura epistemologica ha dei riflessi naturalmente sull’idea di logica che Marx aveva
elaborato. Se nella Critica della filosofia hegeliana aveva, contro Hegel, abbozzato l’idea
di una logica specifica dell’oggetto specifico, e se questa logica della cosa doveva opporsi
6
alla cosa della logica del filosofo di Stoccarda, nella Miseria della filosofia e nei testi della
maturità non vi sarà più traccia di questa idea logica. Se infatti la logica specifica
dell’oggetto specifico è un tentativo di raddrizzamento e di rovesciamento di quella
hegeliana, che tramite la proposizione speculativa e la costruzione idealistica non riusciva
ad afferrare il verso corso del reale, perché trasformava il soggetto in predicato e il
predicato in soggetto, un simile approccio, tramontata la problematica hegeliano-
feuerbachiano dall’orizzonte di Marx, verrà abbandonata. A questa sorta di distacco dalla
problematica dell’idealismo segue un netto rifiuto per la categoria dell’astrazione così
come concepita da Hegel, e inoltre l’uscita dalla problematica del rapporto metafisico di
soggetto e oggetto.
Sappiamo che nella seconda metà degli anni ’50 Marx rilegge le opere di Hegel, e riscopre
alcune cose degne d’interesse nel sistema del grande filosofo tedesco. A tratti nel Capitale
civetta con il linguaggio hegeliano. Abbiamo individuato e messo in confronto tutti i punti
affini alla Scienza della logica, e questa operazione porta ad un risultato estremamente
interessante: Marx ha cambiato ambito di ricerche, non è più un pensatore idealista, non
ragiona più in quei termini e non persegue le finalità di questi, ma riconosce, dopo aver
formato una propria filosofia, che Hegel aveva posto alcune questioni in modo corretto,
seppur in una forma idealistica che ne aveva impedito la risoluzione. La teoria sulla rendita
fondiaria ne è l’emblema!
Ma ciò non vuol dire che Marx torni sui suoi passi circa il metodo utilizzato e circa le
finalità perseguite. Si vedrà nel dettaglio come le categorie logiche del Capitale, persino
quella di contraddizione, che i filosofi dell’approccio continuistico considerano come la
più affine, in realtà divergano radicalmente. Lo stesso vale per il cominciamento dell’opera
con l’analisi della merce. I caratteri di semplicità e di astrattezza di Hegel non hanno nulla
a che vedere con la semplicità di Marx né tantomento con il concreto. La merce non è il
punto di maggior accumulo delle contraddizioni capitalistiche, e non è dilaniata dalla
contraddizione tra valore d’uso e valore di scambio. Questi sono degli schemi di letture che
appartengono ad un approccio continuistico, approccio che ha bisogno di continuo di
individuare una contraddizione che animi il mondo, che porti avanti la storia verso il
proprio Fine e che liberi l’uomo dal male dello sfruttamento. L’ umanismo di queste tesi è
centrale e ha delle conseguenze in sede di logica, poiché essi pensano a questa ancora in
termini di rovesciamento di soggetto e predicato e di raddrizzamento. L’indagine di Marx
sarebbe allora animata da una visione che fa dell’uomo il prius di ogni cosa e che il modo
di produzione capitalistico ha relegato e disgregato. Ora, il punto di massima rottura si
7
trasformerà nell’occasione di ricomposizione dell’uomo dilaniato dalla reificazione e
dall’alienazione. Ma questo approccio ci è sembrato errato sotto tre rispetti: innanzitutto,
giudicare la formazione culturale del giovane Marx come un continuo, cioè animato
sempre dalla medesima problematica e sempre inserito in un campo ontologico specifico,
ci è sembrato ingeneroso e soprattutto non sostenibile. Il 1845 è un atto decisivo poiché
Marx rompe con un sistema ideologico ben preciso, seppure questa rottura non si consumi
in un istante: la fase della maturazione della nuova problematica durerà anni! Per questo vi
sono quasi dodici anni di silenzio da parte di Marx sul piano teorico. Inoltre, la linea
continuistica ci è sembrata misconoscere alcuni elementi logici presenti nel Capitale, e
questo perché gli autori di questo approccio ermeneutico continuano a vedere in Marx la
problematica della dialettica tra soggetto e oggetto. Infine, negare alla ricerca di Marx un
proprio statuto epistemologico indipendente da qualsiasi ideologia della Storia, ci è
sembrato non condivisibile.
Come è mostrato nell’ultimo capitolo, in Marx non vi è traccia di una filosofia della storia,
non vi sono categorie o dispositivi che possano far pensare a ciò e soprattutto, non era
interesse di Marx farlo. Anzi, è paradossale il fatto che Marx non abbia mai elaborato
un’opera su questo argomento e che invece si è cercato di attribuirgli. In realtà, Marx
recupera un concetto molto complesso di totalità, ove la successione dei modi di
produzione, oltre a non essere teleologicamente orientata, prevede intricati rapporti di
subordinazione e dominio. Non vi è riconosciuto, tra l’altro, un minimo statuto ontologico
ad una soggettività, o componente che dir si voglia, che sia protagonista dell’evoluzione
storica. Abbiamo visto a fondo la questione della relazione tra forze-produttive e rapporti
di produzione, e abbiamo fatto la scoperta che non sono le prime a dettare lo sviluppo alle
seconde, ma il contrario. Ma che cosa resta allora dell’uomo? Marx guarda al singolo
capitalista come mero capitale personificato. L’uomo, nel suo pensiero, è stato
detronizzato. D’altra parte, abbiamo in più punti mostrato i difetti anche di alcuni approcci
a tratti riduttivi attuati dall’altra tendenza fondamentale del marxismo, specie per quanto
riguarda i rapporti con il pensiero hegeliano. Non bisogna dimenticare, e noi non vogliamo
farlo, che Marx ed Engels hanno riconosciuto dei grandi meriti al filosofo di Stoccarda, e
una ricerca che voglia dirsi scientifica non può misconoscere queste cose, pena cadere in
un discorso ideologico.
L’abbondanza di citazioni, che a tratti rende pesante una tesi di certo non leggera, serve
proprio a cercare di non far sfuggire nulla, anche gli elementi che problematizzano e
possono mettere in difficoltà i risultati generali. Risultati che riguardano, come abbiamo
8
accennato, l’ambito della logica, e dove possiamo vedere con chiarezza che :Marx ha
utilizzato due approcci logici differenti, l’uno della logica specifica dell’oggetto specifico,
l’altro interno all’opera del Capitale, di cui contraddizione, opposizione e astrazione sono i
dispositivi principali per comprendere la natura dell’oggettualità e delle relazioni
capitalistiche; in secondo luogo, egli avrebbe voluto scrivere una logica che mettesse in
luce i meriti di Hegel sull’argomento per poi mostrare la propria di logica; progetto
incompiuto o meglio mai iniziato.
Nell’ambito storico invece possiamo affermare che: non esiste in Marx una filosofia della
Storia, e che non esiste una soggettività o una forma di astuzia della ragione che fa
avanzare la Storia stessa.
E questo perché non esiste una contraddizione orientata teleologicamente, perché non v’è
una logica che preveda un rapporto finalistico pre-orientato.
Siamo dunque giunti, per sommi capi, a delineare quella differenza specifica e radicale che
divide Marx da Hegel. Quanta fatica Marx abbia fatto nel divincolarsi dalla problematica
hegeliana è facilmente immaginabile. Se il suo pensiero suscita ancora un vivo interesse è
perché egli non è rimasto intrappolato nella cornice ideologica della sinistra hegeliana.
Altrimenti non si farebbe ricorso alla sua opera per capire, almeno parzialmente, le
dinamiche attuali. Ma questo non è oggetto della nostra indagine. Ciò che ci premeva era
di mostrare che qualsiasi appiattimento della problematica marxiana su quella hegeliana è
impossibile nonché perniciose in quanto misconosce ciò che di grande è stato prodotto dai
due pensatori.
9
CAPITOLO PRIMO
RICOSTRUZIONE STORICA:
LE DUE TENDENZE PRINCIPALI NELLA STORIA DEL
MARXISMO
I La tendenza continuistica
L’istanza fondamentale che muove e sviluppa il nostro lavoro non è immediatamente
collegabile ad una analisi genealogica del materialismo storico, alla quale sarebbe
demandato il compito di chiarirne, specificarne e, ove necessario, completarne lo statuto
teoretico.
Dominante nell'orizzonte ermeneutico della maggior parte dei marxismi novecenteschi,
una simile impostazione se da un lato garantisce la possibilità di separare gli elementi
originari da quelli mutuati da altri autori, dall'altro non riesce a rispondere completamente
alla domanda circa la problematica fondamentale sviluppata da Marx.
D’altra parte, l’immenso dibattito nato intorno alle opere di Marx è centrato
principalmente sul rapporto che intercorre tra una chiara visione filosofica della storia e
l’analisi scientifica della società capitalistica. Quale relazione intercorre tra l'analisi dei
modi di produzione e la metafisica? E' l'analisi della prima la precipua filiazione della
seconda? Le risposte rimangono diverse, e le ragioni che muovono i commentatori
antitetiche.
Sono emersi essenzialmente due modelli: da una parte una corrente che sottolinea l’unità
tematica delle opere di Marx; dall’altra un modello, sicuramente meno diffuso, ma non per
questo meno interessante, che ha problematizzato diversi aspetti del pensiero marxiano
rintracciando o comunque elaborando modelli di rottura tematica. La nostra indagine
proverà a ricostruire i punti cardine delle due visioni, e, nello specifico, a confrontarle con
un tema assai complesso, quello della logica nelle opere di Marx. In varie epistole il
10
filosofo tedesco dichiarava di voler scrivere una Logica, ma non non ne troverà mai il
tempo, “perché era domandare l’impossibile”1.
Di certo, i singoli autori che si inseriscono nelle due correnti di pensiero hanno specifici
approcci che li conducono a variegate conclusioni. Nondimeno, un atto di astrazione è
sicuramente proficuo per una sintetizzazione ed esplicitazione ulteriore di elementi comuni
rintracciabili in più autori. Inoltre, e questo vale soprattutto per i primi, gli intenti teoretici
sottesi all’analisi degli elementi logici propri della produzione marxiana rispondono ad
intenzioni che travalicano l’ambito logico. In altre parole, le categorie logico-dialettiche di
Marx risponderebbero all’intenzione di ridimostrare sotto una veste scientifica la sua
visione filosofica futurocentrica della storia. Lo sforzo perseguito negli anni della maturità
altro non sarebbe che la ricerca ossessiva di un ambito epistemologico specifico in grado di
rappresentare in veste scientifica un contenuto riconducibile all’indagine filosofica di
matrice hegeliana, da cui e con cui Marx avrebbe fatto i conti tutta la vita, senza mai
riuscire ad abbandonare la corrente hegeliana.
Ora, al di là delle specifiche modalità attuate per legittimare una qualsiasi conclusione, i
caratteri generali dei diversi modelli interpretativi che abbiamo definito continuistici del
marxismo hanno diversi elementi in comune, e questi modelli rispondono ad una visione
del ruolo della logica ben preciso. Anzi, tali elementi altro non sono che dei risultati ben
precisi di questa logica dialettica. Marx parte da un metodo, un metodo ben preciso, che ha
una sua storia evolutiva e che è in grado di cogliere ogni aspetto del reale. Ma di quale
realtà stiamo parlando? Certamente quella dell’uomo. O meglio, della storia dell’uomo.
Non dunque un metodo in grado di guardare oltre l’immanenza umana. Tantomeno in
grado di investigare il mondo della natura, poiché in essa non vi sarebbero le
determinazioni decisive della dialettica: l’interazione tra un soggetto e un oggetto, l’unità
di teoria e prassi ecc. Dunque, questo metodo riflette il movimento necessario della storia
dell’uomo. E ciò ne garantisce la più ampia estensione applicativa, ma soprattutto, disvela
ciò che rimaneva sino alla sua scoperta celato nel cielo nebuloso delle filosofie
antecedenti: i rapporti di sfruttamento dell’uomo sull’uomo. Sarebbe questo l’elemento
decisivo, il punto da cui tutto riluce, il punto cardine dell’intera indagine svolto dal filosofi
di Treviri. E questo sarebbe talmente fecondo, da risultare decisivo per la comprensione di
tutto il mondo storico prodotto dall’uomo.
1 Cfr. Louis Althusser, Sul materialismo aleatorio, Unicopli, Milano 2000, pag. 46
11
Per capire quali siano le categorie logiche utilizzate da Marx, siano esse mutuate da altri
autori oppure originali, dobbiamo allora ripercorrere il modo in cui questo processo di
sfruttamento è illustrato nelle sue opere.
Dovremo in primo luogo esporre quella che è stata la posizione più diffusa nel panorama
interpetrativo del pensiero di Marx, comune nei suoi caratteri generali sia agli apologeti sia
agli oppositori, e che vede nelle opere della maturità la diretta filiazione delle opere
filosofiche elaborate in gioventù. L'intenzione filosofica fondamentale di Marx sarebbe
stata quella di fondare scientificamente una filosofia della storia futurocentrica, il cui abito
dimostrativo risiederebbe in una visione del mondo dell'uomo ben precisa, misconosciuta
dalla maggior parte dei filosofi a lui antecedenti: i rapporti di sfruttamento.
Essi sarebbero e l'ambito e il sintomo di un movimento storico unitario a cui è sottesa una
finalità verso cui tutto tende: l'emancipazione dell'uomo in una società comunista. La storia
ha delle leggi ineluttabili, di cui le infinite contraddizioni sarebbero epifenomeni, tracce da
analizzare al fine di sondare il grado di sviluppo e le tendenze insite nei rapporti di
produzione.
Solo guardando a questa concezione della storia, che fa loro da sfondo, potremmo rendere
intelligibili le opere mature del tedesco, nelle quali sarebbero ulteriormente esplicitate
quelle decisive tesi già elaborate nelle opere giovanili sull'egemonia del momento
materiale su quello spirituale.
Lo schema espositivo dei fatti storici non si distaccherebbe di molto dalle forme di
narrazioni filosofico-teologiche della grande tradizione occidentale. La storia dell’uomo
sarebbe passata “attraverso il peccato originale della divisione del lavoro, della proprietà
privata, delle differenze di classe”2, peccato che avrebbe disgregato l’unità primigenia
della comunità senza classi e senza rapporti di sfruttamento. L’evoluzione del lavoro è la
chiave che apre così la via alla comprensione della totalità della storia. Con l’estendersi
della divisione del lavoro si intensificano i rapporti di sfruttamento e di parcellizzazione
dell’attività dei singoli uomini, divenuti gangli di una struttura impersonale e vessatoria. Il
susseguirsi di differenti modi di produzione si caratterizza con le incarnazioni di variegate
figure sociali. Divenendo proletario, l’uomo raggiungerebbe lo stato di estrema perdizione.
E “solo attraverso questa perdita totale si compirà dialetticamente il capovolgimento
nell’opposto, ossia il recupero integrale dell’uomo”3.
2 Cfr. Karl Jaspers, Ragione e antiragione nel nostro tempo, SE, Milano 1999, pag. 12
3 Ibidem, pag. 14
12
I fatti, se letti in filigrana, contengono una preziosa indicazione di ciò in vista del quale
sono accaduti, la loro chiara spinta verso il futuro in cui è riposto il senso di ogni accadere.
Marx allora è “il filosofo della storia più potente e sintetico che sia apparso nel XIX
secolo”4 . Marx diventa così un grandissimo narratore storico, e l’ Ideologia tedesca il suo
romanzo più riuscito.
Come non vedere in quelle indimenticabili pagine iniziali un tentativo ben riuscito di
romanzo storico? D’altra parte una grande narrazione di questo genere non può che
concludersi con la restaurazione della comunità primigenia perduta, arricchita di tutto il
contenuto storico accumulato e conservato. E’ questo uno degli insegnamenti che Marx
mutuerebbe dal grande maestro Hegel5.
Un’autoproduzione, un porsi dell’uomo tramite il lavoro come manifestazione del suo
essere. Un essere che è risultato sempre posto e superato dal lavoro stesso in quanto
attività, o meglio ancora come ambito di ciò che è reso reale nel risultato del lavoro, poiché
il lavoro ne è l’essenza costitutiva.
Ma Hegel ha colto questo processo in maniera unilaterale, vedendo nel lavoro solo
l’aspetto positivo. Il compito della nuova filosofia dunque ha l’obiettivo di una critica di
ciò che è compiuto non dal positum, bensì da ciò che ne scaturisce come elemento
negativo, che Marx avrebbe colto a partire da ciò che è effetto del processo di
estrinsecazione del soggettivo: il rapporto con gli altri. E Marx può farlo poiché
riguadagnerebbe quella dimensione dell’uomo come essere finito che in Hegel si presenta
come assenza. Hegel conosce e riconosce solo il lavoro spirituale astratto, non riuscendo a
dedurne il concreto. Eppure, quanto di questa visione sia in realtà presente negli scritti
marxiani della maturità è tutto ancora da stabilire.
Il processo storico marcerebbe, ineluttabile, verso il superamento delle società
antagonistiche, spinto dalle contraddizioni interne che hanno fatto perire ogni formazione
sociale storica. È stata questa una delle più grandi illusioni dei primi pensatori marxisti,
quelli che animarono la Seconda internazionale (1889-1914)6: essi ridussero il marxismo
4 François Furet, Il passato di un'illusione. L'idea comunista nel XX secolo, Mondadori, Milano 1995, p.35
5 Dell’eredità hegeliana farebbe parte anche la descrizione del processo di autoggettivazione, cifra dello
sviluppo dell’uomo. L’autoproduzione e il pensare la stessa come processualità, che porta l’oggettivazione ad
una opposizione, da pensarsi come alienazione e come soppressione della stessa.
6 Cfr. George Douglas Howard Cole, La seconda internazionale, in Storia del pensiero socialista, Laterza,
Bari 1972; AA.VV. , Il marxismo nell’età della seconda internazionale, in Storia del marxismo, Einaudi,
Torino 1979
13
da una parte a una variante del positivismo evoluzionistico (i cosiddetti ortodossi),
dall’altra a un’estensione sociale dell’etica kantiana (i revisionisti). La critica a queste, e
alle successive posizioni della scuola sovietica, che aveva visto nel pensiero di Engels e
Marx una impronta fortemente deterministica ed economicistica7 e che vide in Bucharin
uno degli autori di spicco8, segneranno una nuova epoca all’interno della teoria marxista, e
con essa si svilupparono i due grandi temi che intendiamo trattare con il presente lavoro,
cioè quello della logica specifica di Marx e la sua visione della storia, ritenuti da chi scrive
centrali per comprenderne il pensiero. In verità sin dall’inizio gli interpreti si erano posti la
questione circa lo statuto teorico della logica, ma facendola coincidere con la dialettica di
Hegel e configurandone l’utilizzo in termini di giustificazione sul piano filosofico di un
certo modo di intendere la politica. Ad esempio, durante la Seconda internazionale
Bernstein interpretò l’impianto dialettico contenuto nei testi giovanili di Marx come
elemento fondamentale per la comprensione del carattere necessario della rivoluzione
socialista, di cui l’analisi contenuta nel Capitale forniva la riprova sul terreno
dell’economia politica9.
Sempre per Bernstein, la storia tedesca ne avrebbe confutato l’impianto, disattendendo le
speranze. Né le analisi economiche né la dialettica hegeliana possono considerarsi ambiti
di dimostrazione della ineluttabilità del socialismo; solo l’etica kantiana10
, con i suoi
caratteri di assolutezza e di universalità, può farlo, a dimostrazione che il nuovo stato
socialista altro non sarebbe se non lo strumento per la realizzazione, sul piano sociale,
dell’imperativo kantiano che comanda di considerare gli altri uomini sempre come fine e
mai semplicemente come mezzo.
Invece, Kautsky, alto esponente della cosiddetta corrente del marxismo ortodosso, riduce il
materialismo storico a scienza deterministica dei fenomeni sociali, caratterizzata da leggi
lineari, ineluttabili e progressive del tutto simili da quelle biologico-naturalistiche
individuate da Darwin. La stessa opera del Capitale altro non sarebbe che la dimostrazione
scientifica del crollo ineluttabile del capitalismo, esito finale di un processo storico
impersonale durato millenni.
7 Cfr. Gustav Andreas Wetter, Il materialismo dialettico sovietico, Torino, Einaudi, 1948
8 Anche se, a onor del vero, non mancarono tendenze molto più filosofiche, improntate al carattere dialettico
di origine hegeliana dei testi marxisti, propugnate soprattutto da Deborin.
9 Cfr. Eduard Bernstein, I presupposti del socialismo e i compiti della socialdemocrazia, Laterza, Bari 1968
10 Per comprendere la diffusione del cosiddetto marxismo kantiano cfr. Marxismo ed etica, testi sul
socialismo neokantiano 1896-1911, a cura di E. Agazzi ,Feltrinelli, Milano 1975
14
Sul piano morale, il materialismo storico costituirebbe la chiave di volta per l’elaborazione
di un’etica socialistica, ma questa non andrebbe ricercata tanto negli imperativi categorici
di Kant, quanto nella totale dedizione di cui il proletario è capace nei confronti degli altri
proletari. La stessa morale sorge da un atto di proiezione dei bisogni di una determinata
classe sociale. In questo caso, la situazione di oppressione dei subalterni porterebbe ad una
nuova etica. Più in generale, una qualsiasi affermazione di una morale ha le sue ragioni nei
bisogni immanenti di chi la produce11
.
Posizione molto interessante sul piano filosofico è quella di Max Adler. Egli volle liberare
Marx dalla zavorra di un materialismo metafisico ingenuo, sconfessando l’idea per la quale
tutte le attività umane dipendano dalle condizioni materiali della produzione. Al contrario,
gli stessi processi sociali, in quanto fenomeni umani, sono per Adler sostanzialmente
spirituali. Le stesse determinazioni della realtà si scoprono come contenuti della coscienza.
Ma questo non porta necessariamente alla rinuncia del marxismo come scienza sociale, né
alla posizioni di fini, in quanto , dopo aver messo completamente in luce dall’esame
scientifico, l’ingranaggio causale della storia si tramuterà direttamente in una forma di
teleologismo12
.
Chi dedica molta attenzione allo studio della logica in generale e della Scienza della logica
di Hegel è sicuramente Lenin 13
. Egli cerca di capire la specificità del metodo marxiano,
cioè la dialettica materialistica. Successivamente mi soffermerò su questo tipo di
operazione ermeneutica, che ha avuto un peso davvero notevole e una diffusione senza pari
tra gli interpreti di Marx, generando risultati infinitamente vari e in certi casi affascinanti.
Ora, tornando a Lenin, possiamo notare come il suo intento fondamentale sia quello di
liberare la dialettica marxiana non tanto dal giogo della metafisica, bensì dagli abissi del
materialismo volgare, che riduceva da un lato a forme ingenue e dall’altro meccanicistiche,
rispettivamente, il rapporto tra il soggetto conoscente/operante e l’oggetto in vista del
quale si opera, e le relazioni tra la sfera economica e gli altri ambiti della vita umana. La
dialettica materialistica è l’unico metodo in grado di elaborare una compiuta gnoseologia,
nello specifico una teoria della conoscenza come riflesso; ed è l’unico metodo capace di
cogliere i salti qualitativi della storia, le rotture profonde che gli altri metodi non riescono a
cogliere.
11 Cfr. Karl Kautsky, Etica e concezione materialistica della storia, Feltrinelli editore, Milano, 1958
12 Per un’illustrazione preliminare delle posizioni di Adler cfr. Iring Fetscher, Il marxismo, storia
documentata,I, Milano, Feltrinelli 1969, p. 119 e ss.
13 Cfr. Vladimir Lenin, Quaderni filosofici, Editori Riuniti, Roma 1970
15
Fatta eccezione per Lenin, tutte le impostazioni e gli autori che abbiamo menzionato sopra,
divengono ben presto il bersaglio polemico di un’altra generazione di marxisti, concordi
nell’intento di restituire al marxismo la sua autonoma consistenza filosofica. E sarà proprio
questa seconda generazione a problematizzare radicalmente le concezioni di Marx sulla
storia, la dialettica e la logica. Per questo esporremo, seppur in maniera sommaria, le
posizioni che hanno caratterizzato e, in qualche modo, determinato il dibattito.
Non potremo non iniziare che da Lukacs, filosofo ungherese che pose l’accento
sull’incidenza dei fattori soggettivi nella determinazione della dialettica storica. Al di là
della complessa evoluzione del suo pensiero, e dei molteplici settori verso cui i suoi
interessi vertono, Lukacs è convinto che un recupero autentico dell’opera di Marx possa
avvenire solo alla luce dell’influenza della dialettica hegeliana. Concepisce la sua opera
principale, Storia e coscienza di classe14
, tra il 1919 e il 1922, anni in cui non circolavano
ancora le opere giovanili di Marx (pubblicate nel ‘27) e i Quaderni filosofici di Lenin,
incentrando la propria analisi sul recupero del metodo marxiano di ricerca. Tale metodo è
quello dialettico, che consente di integrare fatti singoli della vita sociale nella totalità dello
sviluppo storico, e perciò nel conoscerli non come determinazioni statiche quanto come
momenti dinamici di una totalità che ha nel divenire la sua caratteristica principale. Non il
metodo sperimentale mutuato dalle scienze empiriche, bensì quello dialettico è in grado di
comprendere i fenomeni sociali così come essi stessi sono. Per questo rifiuta l’applicazione
della dialettica alla natura. La dialettica è immanente a questo sviluppo poiché non è una
intelaiatura schematica separata dal suo oggetto; essa è invece l’espressione concettuale di
quella oggettualità. E l’oggetto inverato dalla dialettica è lo sviluppo storico, non riducibile
a mero ente affianco ad altri enti empirici. La stessa totalità cui Lukacs fa riferimento ha in
sé lo sviluppo, o meglio può esser tale, solo grazie allo sviluppo di un nuovo modo di
produzione, quello capitalistico. L’epifania della totalità è garantita da questo reificarsi
dall’avvento del capitale che penetra non solo l’uomo e le relazioni che esso genera, ma
ogni spazio esistenziale, fino ad insinuarsi nella coscienza stessa dell’uomo. Da questo
farsi tutto del capitale deriva la sua predicabilità di condizione eterna e insuperabile poiché
il suo avvento finisce per occupare ogni fase del tempo ed ogni relazione. In altri termini, il
capitale si vorrebbe come unico principio storico, occultando così lo stesso carattere
storico che lo rende transeunte, superabile, e, forse ancor più importante, prodotto
originato da un altro modo di produzione.
14 Cfr. Gyorgy Lukacs, Storia e coscienza di classe, Sugarco edizioni, Milano 1991
16
Questa condizione mistificata verrebbe colta come tale dal metodo dialettico. E’ questo
sarebbe il grande merito di Hegel che sviluppò la tale disciplina in maniera sistematica.
Ma Hegel non seppe andare oltre. Non seppe riconoscere nei rapporti economici le forze
vive che realmente creano il movimento storico, per due ragioni: sia perché il grado di
dispiegamento storico non era ancora sufficientemente chiaro, sia perché rimase
prigioniero e vittima delle dualità che aveva inteso sopprimere. Ma il limite di Hegel, sia
storico che umano, verrà riscattato in seguito, da chi è davvero soggetto-oggetto identico
dell’evoluzione storica: il proletariato. Giunto alla piena consapevolezza della propria
condizione e del proprio compito, esso trasformerà il mondo. E potrà farlo solo quando ve
ne saranno le possibilità oggettive.
Lukacs vede nella dialettica il vero metodo di indagine di Marx per tentare di sottrarlo
dagli sterili schemi evoluzionisti in cui era stato confinato. Eppure, in questo tentativo
perde le istanze materiali che avevano mosso invece Marx, poiché fa coincidere l’orizzonte
della coscienza con quello della realtà. Nell’opera del 1938 Il giovane Hegel 15
e i problemi
della società capitalistica, egli afferma che: “chi considera questa evoluzioni con occhi
marxisti deve constatare che si tratta di un’importantissima fase del sorgere della dialettica
in Germania”. Hegel sarebbe stato fortemente influenzato dalla rivoluzione francese, ma
anche dalla rivoluzione industriale tedesca. Nel periodo di Francoforte, cioè nel periodo in
cui Hegel è sfiduciato verso la rivoluzione, la lettura dei classici dell’economia politica lo
porterà ad elaborare il primo abbozzo di dialettica. Nella Fenomenologia egli pone alla
base il lavoro, per poi dialetticamente dedurre ogni aspetto del reale.
Questo testo di Lukacs, e in generale la sua impostazione, risentono moltissimo della
lettura dei Manoscritti economico-filosofici, editi per la prima volta nel 1930. Da essi
comprende che l’oggettività non coincide sempre con l’alienazione, la reificazione, ma
invece indica una modalità specifica di espressione del soggetto umano in un ambiente
sociale. La reificazione esiste solo dove le forme dell’oggettività, anziché esprimere
l’essenza che è propria dell’uomo, si pongono in modo ostile ed oppressivo di fronte ad
essa. Sempre dal concetto di reificazione deriva una nuova modalità di intendere
l’ontologia: “Se vogliamo capire i fenomeni in senso genetico, la via ontologica è
inevitabile e si deve giungere ad estrarre, dalle molte circostanze che accompagnano la
genesi di un fatto qualsiasi, i momenti tipici, necessari per il processo stesso”16
.
15 Cfr. Gyorgy Lukacs, Il giovane Hegel, Einaudi, Torino 1960, p.13
16 Cfr. (a cura di) Wolfgang Abendroth, Hans Heinz Holz e Leo Kofler, Conversazioni con Lukacs, De
donato, Bari, 1968, pag. 15
17
Il sapere circa le proprietà e le relazioni dell’essere è ontologia. L’essere ha tre forme:
inorganica, organica, sociale. Tra l’una e l’altra v’è un rapporto discontinuo, vi è un salto,
in cui la casualità ha un ruolo importante, misconosciuto dalla scienza. Il lavoro è la
caratteristica principale della vita sociale, lavoro che è sintesi di teleologia e casualità.
L’uomo interviene teleologicamente sulla casualità della natura, rifiutando così la
concezione meccanicistica della storia. Per questo il passaggio al socialismo e
l’affermazione dello stesso necessitano di condizioni 17
.
Sempre nell’ambito sovietico Isaak Rubin insiste sulla centralità della teoria del feticismo e
della reificazione, collegandola alla teoria del valore. Sotto il velo della reificazione, la
presenza di rapporti umani nell’economia mercantile è necessariamente un rapporto che
prende forma di cose e tramite queste si esprime. La stessa forma sociale dei prodotti,
risultato di “ innumerevoli atti di scambio tra i produttori, si trasforma in un potente mezzo
di pressione sulle loro motivazioni individuali, e li spinge ad adattare il proprio
comportamento produttivo ai rapporti dominanti in una data società”18
. Rubin individua
due differenti definizioni del concetto di feticismo in Marx: la prima, esposta nella Sacra
famiglia, dove Marx contrappone l’elemento umano e quello materiale. L’uomo è
schiacciato dall’elemento materiale, cioè dal capitale, piombando in una dimensione
inumana. Ma l’essere dell’uomo deve essere ricondotto al suo dover-essere. Dunque la
contraddizione è opposizione tra l’idealità e la realtà. La seconda fase è quella della
reificazione dei rapporti sociali, caratterizzata dal feticismo delle merci. Marx “doveva
percorrere il cammino del socialismo dall’Utopia alla Scienza, passare dall’apprezzamento
di Proudhon a un’aspra critica di esso […]. Se l’opposizione che aveva prima descritto
come contraddizione tra i rapporti umani e la loro forma <materiale> era una opposizione
tra essere e dover-essere, ora entrambi gli elementi della contraddizione vengono riferiti
alla realtà sociale effettuale. […]. La contraddizione tra i rapporti di produzione sociali e la
loro forma <materiale> è il contenuto della nuova opposizione, che deriva da quella
precedente tra l’elemento umano nell’economia e le sue forme <alienate>. In tal modo si
arriva a una prima formulazione del feticismo della merce”19
.
17 Fortemente critico di queste posizioni, Lucio Colletti afferma che Lukacs non è saputo andare mai oltre
Hegel, e quindi non è riuscito in alcun modo a conoscere il pensiero di Marx. Cfr. Lucio Colletti, Il marxismo
e Hegel, Laterza, Bari, 1969, pag. 317 e ss.
18 Cfr. Isaak Rubin, Saggio sulla teoria del valore di Marx, Feltrinelli, Milano 1976, pag. 20
19 Ibidem, pag. 48
18
Ora, Marx non ha mai inteso come cose denaro, capitale e altre categorie economiche. Egli
l’ha sempre pensate all’interno di rapporti di produzione specifici, sin dal periodo di
stesura della Miseria della filosofia, così come tutte le categorie economiche non sono che
le espressioni teoriche dei suddetti rapporti.
Nel Capitale Marx teorizzerebbe il feticismo a partire dall’assenza di una regolazione
diretta del processo sociale di produzione, che condurrebbe necessariamente a una forma
indiretta di regolazione mediante le leggi di mercato, i prodotti del lavoro e le cose. Non si
tratta dunque di mera mistificazione ideologica bensì di una materializzazione dei rapporti
di produzione: qui non si tratta di un fenomeno della coscienza morale, ma dell’essere
sociale stesso.
Se nelle prime pagine del Capitale Marx passa con metodo analitico dal valore di scambio
al valore, e dal valore al lavoro, l’autentica fondazione di tipo dialettico della teoria del
valore si ritroverebbe “soltanto nella complessiva teoria del feticismo della merce, che
prende in esame la struttura generale dell’economia mercantile”20
.
La centralità della teoria del feticismo della merce non riposa nel fatto, di per sé rilevante,
della presenza di determinati rapporti sociali di produzione dietro l’apparenza delle
categorie materiali, ma nell’affermazione che nel modo di produzione capitalistico tali
rapporti tra persone assumono necessariamente forma materiale, e possono venir
rappresentati soltanto sotto questa forma. Per Rubin la formulazione di questa teoria è che
il valore della merce dipende dalla quantità di lavoro sociale necessario per la sua
produzione. Ma sarebbe più appropriato ribaltare questa formulazione ed affermare che nel
capitalismo i rapporti di produzione tra persone assumono necessariamente la forma del
valore delle cose, e possono apparire solo in questa forma reificata; così il lavoro sociale
può esprimersi solo nel valore21
.
Gli studi di Rubin sull’economia mercantile e sull’interpretazione del Capitale sembrano
oggi alquanto datati. Non per questo noi rinunceremo qui ad una esposizione sintetica delle
questioni del duplice carattere del valore e del lavoro, che ci torneranno molto utili nel
secondo capitolo. Potremmo chiederci quale sia la differenza tra valore e valore di
scambio, sapendo che la risposta più diffusa è che il valore è considerato il lavoro
necessario per la produzione di una determinata merce, quello di scambio un prodotto
distinto, dato in cambio della merce. Ma il valore è determinato dal lavoro o è il lavoro
stesso?
20 Ibidem, pag. 51
21 Idem
19
Nella prima edizione del Capitale Marx analizza il valore nei termini di forma, sostanza e
grandezza”. I primi due punti sono affrontati nel § 1 del I capitolo del I libro del Capitale,
il terzo nel § 3. La visione più diffusa vede nel lavoro astratto umano la sostanza del
valore. Dunque non un lavoro concreto, la tessitura in quanto tessitura ad esempio, genera
valore, poiché essa è figura particolare del lavoro astrattamente umano. E il valore sarebbe
dato dalla quantità di lavoro incorporato nella merce. “Marx intende per sostanza o
contenuto di valore il lavoro socialmente uguale in genere, o il lavoro astrattamente
universale? In altri termini, quando parliamo del lavoro come contenuto del valore,
includiamo in questo concetto le caratteristiche proprie del lavoro astratto, o intendiamo
piuttosto il lavoro socialmente equivalente, senza le particolarità che esso acquista
nell’economia mercantile?”22
. L’approccio seguito anche da Rubin vede nella forma-valore
il problema reale affrontato da Marx, così come proverebbe anche la convulsa stesura di
questo capitolo, più volte rivisitato dall’autore mentre era in vita.
Valore è “la forma adeguata ed esatta per esprimere il contenuto di valore, ossia il
lavoro”23
.
Il valore come tale non è misurabile dalla quantità di tempo di lavoro necessario per
produrre la merce, bensì dalla sua forma sociale, quella dello scambio. Senza questa
mediazione il prodotto non ha valore. Infatti “la forma di valore è definita come forma di
scambiabilità, la forma cioè che acquista il prodotto per il fatto di poter essere scambiato
con qualsiasi altra merce, in base alla quantità di lavoro necessario”24
. Questo sul piano
qualitativo. Sul versante opposto, quello quantitativo, invece la grandezza di valore
dipende dalla quantità di lavoro astratto, socialmente necessario. Ma, dato il duplice
carattere del lavoro, le variazioni nella quantità di lavoro astratto sarebbero a loro volta
determinabili dalle variazioni nella quantità del lavoro concreto, ossia dallo sviluppo del
processo tecnico-materiale della produzione. Dunque tutto il sistema del valore si
baserebbe su di un processo equiparativo dei differenti lavori privati, che altro non
sarebbero che segmenti del lavoro sociale astratto complessivo. A sua volta, il sistema del
lavoro sociale astratto complessivo avrebbe nello sviluppo delle forze produttive il proprio
motore, cioè il fattore che in ultima istanza risulta l’anello determinante dello sviluppo
sociale. In tal modo la teoria marxista del valore si connette, ancora una volta, alla
concezione materialistica della storia.
22 Ibdem, pag. 93
23 Ibidem, pag. 95
24 Ibidem, pag. 93
20
Così Marx avrebbe tenuto insieme due definizioni di valore, quella dell’espressione
materiale dei rapporti di produzione e quella del valore inteso come grandezza determinata
di tempo di lavoro, fondando l’analisi dell’aspetto quantitativo su quello qualitativo. Per
molti marxisti l’aspetto della quantità di lavoro era la scoperta decisiva fatta da Marx. Lo
stesso autore, nel primo capitolo del Capitale, affermava orgoglioso: “questa duplice
natura del lavoro contenuto nella merce è stata da me per primo indicata in maniera
critica”25
; nell’opera Per la critica dell’economia politica, ove per la prima volta viene
mostrato che mentre “il lavoro che crea il valore di scambio è lavoro astrattamente
generale e uguale, il lavoro che crea il valore d’uso è lavoro concreto e particolare, che a
seconda della forma e del materiale, si scompone in tanti tipi di lavoro infinitamente
diversi”26
. L’economia politica non avrebbe afferrato appieno la nozione di valore poiché
non in grado di comprendere la forma in cui rientra il contenuto quantistico del valore
stesso.
Ma l’analisi della forma valore è l’elemento che congiunge due estremi, che senza di esso
rimarrebbero separati: lo sviluppo delle forze produttive e i fenomeni che accadono nel
mercato. E ciò vorrebbe dire separare l’analisi delle variazioni, ad esempio, dei prezzi sul
mercato senza tener conto delle trasformazioni del processo lavorativo.
La forma di valore va sempre collegata al suo contenuto: il lavoro astratto; e la grandezza
di valore con la quantità di lavoro necessario. Molti autori hanno interpretato il concetto di
lavoro astratto come lavoro fisiologico, dispendio di energia umana, che nel lavoro
concreto è dispendio in forma specifica, e in astratto è da considerarsi indipendentemente
da queste forme particolari 27
.
In effetti nel Capitale Marx dichiara che “ogni lavoro è, da una parte, dispendio di forza-
lavoro umana in senso fisiologico e in questa proprietà di lavoro umano uguale, ovvero di
lavoro astrattamente umano, esso costituisce il valore delle merci. Ogni lavoro è, d’altra
parte, dispendio di forza-lavoro umana in forma particolare, determinata a scopo, e in
questa proprietà di lavoro utile concreto produce valori d’uso” 28
25 Cfr. Marx-Engels-Opere-Complete, Il capitale, libro primo 1863-90, Vol. XXXI, tomo I, La città del sole,
Napoli 2011, pag. 52-3
26 Cfr. Karl Marx, Per la critica dell’economia politica, Newton compton, Roma 1972, pag. 48
27 Su tutti Kautsky, Cfr. Karl Kautsky, La dottrina economica di Carlo Marx, Bocca editore, Torino 1898,
pag. 24
28 Cfr. Meoc, op. cit., pag. 57
21
Ma Rubin sembra non comprenderlo, perché finisce per affermare che il valore, essendo
fenomeno sociale, non contiene nulla di materiale. Da ciò conseguirebbe che il lavoro
astratto, creatore di valore, deve anch’esso venire considerato una categoria sociale in cui
la materialità è rimossa: o esso è “dispendio di energia umana in forma fisiologica, e allora
anche il valore assume un carattere deificato e materiale”, oppure “il valore è un fenomeno
sociale, e come tale va considerato anche il lavoro astratto, legato a una forma di
produzione socialmente determinata. Non è possibile affermare contemporaneamente il
carattere fisiologico del lavoro astratto e quello storico del valore da esso creato”29
, poiché
il dispendio fisiologico muta in ogni epoca.
Per questo, poichè il valore ha un significato storico e sociale, anche il lavoro astratto va
inquadrato negli stessi termini. Naturalmente non per negare che il lavoro umano si
esplichi come dispendio di energie. Semmai esso è il presupposto del lavoro astratto.
Distinguendo il lavoro fisiologicamente uguale, il lavoro socialmente equivalente e il
lavoro astratto, e individuando due condizioni per trasformare i lavori socialmente
equivalenti in lavoro astratto, quest’ultimo diviene espressione del carattere sociale dei
lavori privati nei diversi tipi individuali di lavoro, e in secondo luogo l’equiparazione in
forma materiale dei carattere di valore dei prodotti. Detto in altri termini, Marx, secondo
Rubin, considererebbe il lavoro astratto
col lavoro sociale nella forma specificamente capitalistica, un lavoro che include in sé la
definizione delle forme sociali di organizzazione del lavoro umano. Se il lavoro ha due
caratteri, uno privato e l’altro sociale, la trasformazione del lavoro privato in sociale può
verificarsi solo nella contemporanea traduzione da concreto in astratto, che è socialmente
equivalente, omogeneo e impersonale, astrazione da ogni proprietà concreta, ma
affermantesi come sociale solo in questa forma impersonale”. Capiremo in seguito cosa
voglia dire, da un punto di vista logico, un simile fraintendimento30
. Per concludere, si
29 Cfr. Rubin, op. cit. pag. 108
30 Sui caratteri di privato e sociale del lavoro è interessante un passo presente in Per la critica dell’economia
politica:
“Prendiamo le prestazioni personali e i tributi in natura del Medioevo. Qui sono i lavori determinati dei
singoli nella loro forma naturale, è il carattere specifico, non generale, del lavoro ciò che costituisce il legame
sociale. O prendiamo infine il lavoro collettivo nella sua forma primordiale, così come lo troviamo alla soglia
della storia di tutti i popoli civili. Qui evidentemente il carattere sociale del lavoro non è dato dal fatto che il
lavoro del singolo acquista l’astratta forma della generalità o il suo prodotto la forma di un equivalente
generale. E’ la comunità, come presupposto della produzione, che fa sì che il lavoro del singolo non sia
lavoro privato e che il suo prodotto non sia prodotto privato; in essa il lavoro singolo appare piuttosto
22
deve sottolineare che da questa impostazione solo il lavoro astratto, che presuppone
determinati rapporti di produzione tra persone, crea valore, e non il lavoro in senso tecnico-
materiale o fisiologico. I rapporti tra lavoro astratto e valore non possono venir pensati alla
stregua di relazioni tra cause ed effetti di natura fisica”.E siccome il lavoro astratto è una
sostanza sociale, la sua grandezza sarà anch’essa sociale. Nell’economia mercantile
l’uguaglianza sociale di due quantità di lavoro si realizza mediante lo scambio, e tale
uguaglianza tra due quantità di lavoro astratto vorrebbe dire che tali quantità si
equivarrebbero come parti del lavoro sociale complessivo.
Proseguendo nel nostro itinerario storico-critico, non possiamo non parlare di un altro
pensatore e politico coevo a Rubin e Lukacs, Karl Korsch. Egli insistette molto sul
contenuto filosofico del pensiero di Marx, ritenendolo misconosciuto dai predecessori. Ciò
era dovuto ad una incomprensione della dialettica hegeliana e per comprendere Marx e la
sua filosofia bisognava studiare Hegel, la sua dialettica. Al centro del discorso è posta la
nozione di totalità. Garante di questa totalità è l’atteggiamento de-idelogizzante di Marx, il
suo intervento critico sulle scienze e su ogni fenomeno materiale e culturale del reale. Una
critica engagè, non pura e imparziale come presentata dagli autori borghesi. E lo strumento
che consentirebbe a Marx di mantenere la totalità, è la dialettica tra teoria e prassi. Lo
stesso sorgere della teoria marxista è solo l’altra faccia “del sorgere del reale movimento
proletario di classe; solo se presi insieme i due lati formano la totalità concreta del
processo storico”31
La dialettica consente di non vedere in modo meccanicistico il rapporto tra teoria e prassi,
e soprattutto il nesso tra i vari livelli della teoria – economica, politica, ideologica. Korsch
polemizza con Engels, che avrebbe ridotto la dialettica ad una logica generale, applicabile
sia alla natura che alla storia. La dialettica marxiana è diversa da quella hegeliana perché è
il proletariato che se ne impadronisce. Nel Karl Marx, Korsch scrive che i principi
metodologici di Marx sono tre: la specificazione storica, il principio del mutamento, e la
teoria come espressione di un movimento sociale pratico. Marx formula categorie
economiche sempre relative ad ogni epoca; il secondo principio vede nelle formazioni
direttamente come funzione esercitata da ciascun membro dell’organismo sociale. Il lavoro che si manifesta
nel valore di scambio è ,per presupposto, lavoro del singolo preso isolatamente. Esso diventa sociale
acquistando la forma del suo diretto contrario, cioè la forma dell’astratta generalità” Cfr.Karl Marx, Op. Cit.,
Pag. 44-5 31 Cfr. Karl Korsch, Il materialismo storico: AntiKautsky, Laterza, Bari 1971, pagg. 47-8
23
economiche pre-capitalistiche non la preparazione del capitalismo, bensì forme storiche
indipendenti.
Korsch finisce dunque per accentuare il carattere di scienza sociale del pensiero del
filosofo tedesco a discapito di quella impostazione filosofica illustrata ne Il materialismo
storico. Marx ed Engels avrebbero rotto con Hegel, avrebbero solo “occasionalmente
civettato, nella forma esterna di esposizione, con il modo di esprimersi proprio della
filosofia hegeliana”32
.
Chi invece ha continuato a porre in continuità il pensiero di Marx ed Engels con quelli di
Hegel è sicuramente Ernst Bloch, per il quale il nucleo centrale del pensiero di Marx non
era individuabile nell’analisi economica e sociale del modo di produzione capitalistico, né
tantomeno nell’uso di una metodologia scientifica, quanto nel principio speranza. La
speranza ha un carattere ontologico e non relegabile nel mondo psicologico dell’io: la
speranza è la nostra identità autentica, si apre all’uomo nel continuo trascendimento che
l’uomo opera sul mondo e su di sé. Nel futuro l’uomo si scoprirà per quello che è
realmente.
La stessa dialettica, strutturalmente, implica un’apertura a ciò che deve essere, un
irrefrenabile impulso al cambiamento di ciò che è. Anche se è presente il tema della
staticità e della contemplatività del pensiero, l’avvenire deve essere però utopia concreta.
E’ quindi un chè non scindibile dal dato materiale reale in cui si è inserito. Questa
materialità gode di un carattere oggettivo. E il suo essere in questo dato modo è il maggior
garante della stessa speranza poiché la materia ha, per propria costituzione, un grado di
possibilità. Ma questa possibilità non va pensata come una modalità attuabile
meccanicisticamente, come una estrema conseguenza ineluttabile e antecedente al processo
stesso. L’uomo come soggetto è deputato ad inverarla. Bloch parla a proposito di arco
utopia-materia33
. Il rapporto è dunque biunivoco, e ciò che ha scoperto questo rapporto ed
è in grado di spiegarlo è il materialismo storico-dialettico.
Bloch finisce così per dividere il marxismo in una corrente fredda, scientista, modellata sul
modello della biologia darwiniana, e una calda, quella che va oltre lo sguardo analitico e
distaccato della scienza e muove il cuore dell’uomo. Nel testo Karl Marx34
insiste sulla
presenza di una escatologia nel pensiero marxiano, presente addirittura in ogni aspetto e
figurazione nonché in ogni fase del pensiero del tedesco.
32 Cfr. Karl Korsch, Karl Marx, Laterza, Bari, 1969, pag. 71
33 Cfr. Ernst Bloch, Il principio speranza, Vol. I, Garzanti, Milano 2005, pag. 392 e ss.
34 Cfr. Ernst Bloch, Karl Marx, Il mulino, Bologna 1972
24
Marx avrebbe visto nella materia il luogo delle potenzialità infinite, sulla scorta della fisica
aristotelica andando oltre sia alla visione meccanicistica della materia, tipica dei
razionalisti del settecento, sia a quella idealistica, propugnata da Hegel, il quale vedeva in
essa la negatività assoluta. A fianco alla materia c’è il novum, come possibilità di ciò che
non è ancora cosciente; il fronte del futuro che inizia a delinearsi. Oltre alla visione della
materia, Bloch tenta una interpetrazione innovativa dei rapporti tra struttura e
sovrastruttura, negando una qualsiasi forma deterministica della prima sulla seconda,
arrivando a vederle come due poli di un’unica entità, e quindi riconducendola ad unità.
Ma qual è il rapporto tra Marx ed Hegel? Bloch insiste particolarmente sulla continuità tra
i due pensatori, credendo così di salvare il marxismo dal meccanicismo e
dall’economicismo. Lo stesso atteggiamento di critica che ha infervorato le opere marxiane
è messa in secondo piano rispetto alla categoria dell’Utopia, che Bloch identifica con ciò
che Marx chiama regno della libertà. Rovesciando la dialettica hegeliana per meglio
comprendere il rapporto tra soggetto e oggetto, Marx sarebbe andato oltre l’apparenza
idealistica del movimento dialettico, così da far emergere il processo reale, inteso come
movimento della materia. Una materia processuale, che non ha il proprio “ totum
nell’orizzonte del passato, come lo spirito che ricorda interiorizzando di Hegel, ma anche
come la materia meccanicisticamente intesa da Democrito in poi; lo tiene invece,
nell’orizzonte del futuro”35
Come conseguenza di questo ribaltamento, Marx
concepirebbere in modo nuovo la stessa umanità dell’uomo, analizzandola in relazione al
suo fare. Se Hegel aveva concepito l’autogenerazione dell’uomo come un processo,
intendendo l’essenza del lavoro e l’uomo come scaturenti dal lavoro, nell’analisi di questo
processo è data la chiave interpetrativa del reale. Ma Marx è andato oltre il maestro:
seppur Hegel aveva sviluppato la sua dialettica sempre da un apriori logico, egli invece era
riuscito nell’impresa di rendere la dialettica non un mero “metodo secondo cui manipolare
la storia, [ma] è la storia medesima”36
.
Marx dunque aveva compreso che il soggetto di Hegel, nonostante i suoi connotati astratti,
non mancherebbe di forza materiale, finendo necessariamente per rendere intelligibile che
quel pensiero che legge il rapporto tra soggetto-oggetto in termini di rapporti pratici di
trasformazione, cioè come rapporti di lavoro. Naturalmente bisogna pensare oltre la realtà
immediata, in vista di ciò che verrà. In tal senso l’utopia concreta è non la mera
anticipazione del futuro, ma la progettazione di esso a partire da premesse materiali
35 Cfr. Ernst Bloch, Soggetto-oggetto, commento a Hegel, Il Mulino, Bologna 1975, pag. 427
36 Ibidem, pag. 431
25
storicamente date. Esse sono necessarie ma non sufficienti per realizzare la progettualità
utopica. Ciò che serve la tensione al trascendimento del dato immediato. Non è prerogativa
solo dell’uomo ma della realtà intera.
In questa concezione blochiana gioca un ruolo decisivo, a nostro avviso, la categoria di
scopo presente nella Scienza della logica, cioè la “relativa esaltazione del mezzo
(strumento) sul valore d’uso immediato dello scopo”37
. Così come il lavoro mediatore del
servo sopravanza il godimento immediato del risultato del processo lavorativo da parte del
padrone, allo stesso modo il mezzo è “un che di superiore agli scopi finiti della finalità
esterna”38
. Lo scopo che agisce nel suo mezzo, che lo utilizza come mediazione, dirige
ordinandolo quel continenente chiamato storia umana. Dobbiamo però fare una ulteriore
considerazione circa il tema della materia. Bloch si richiama apertamente alle Lezioni di
storia della filosofia di Hegel, e agli apprezzamenti diretti a Leucippo e Lucrezio, segno
che Hegel rifiuterebbe solo il materialismo meccanicistico, e non il materialismo in
generale: il primo infatti fa agire esclusivamente le circostanze sugli uomini e non
l’inverso. Il rapporto reciproco hegeliano di soggetto-oggetto riuscì a superare questa
concezione, di cui il materialismo dialettico è il degno erede. E se rimane materialismo,
spiegando l’interno a partire dall’esterno, è perché fa partire prima l’essere e poi la
coscienza.
Ora, bisogna constatare che la recezione del marxismo è molto differente di nazione in
nazione.
Si pensi alla Francia. Nel 1928 Politzer, Lefebvre, Guterman, Morhange, Nizar fondano la
Revue marxiste. Sul loro passaggio al marxismo ha influito moltissimo la lettura degli
scritti giovanili di Marx ( fu Lefebvre a tradurli e pubblicarli nel 1934).
Lefebvre, nel suo Il materialismo dialettico, presenta il marxismo come metodo di
conoscenza e di trasformazione della realtà. Hegel si è reso conto che la logica formale,
con la sua affermazione che ogni essere è ciò che è e non altro, impedisce di pensare le
contraddizioni presenti e nel reale e nel pensiero. Dopo la scissione tra pensiero e realtà
provocata dal Kant della prima Critica, è Hegel l’autore che tenta di ricomporre ciò che era
stato diviso. Egli comprese che il reale, non scindibile dal pensiero, si arricchisce mediate
la negazione e il proprio superamento, fino a costituirsi come altro. Ma non altro dal reale,
bensì come realtà che diventa altra da come era prima del processo di rea-lizzazione. Hegel
ha quindi compiuto una fondamentale scoperta. Eppure ciò non gli ha impedito di
37 Cfr. George W. F. Hegel, Scienza della logica, Laterza, Roma-Bari 1994, pag. 442-3
38 Ibidem, pag. 848
26
compiere un grave errore: confondere il metodo dialettico, in grado di descrivere il
movimento del reale così come esso stesso si dà, con la costruzione schematica del reale.
La dialettica è da considerarsi un metodo, non uno schema costruttivo. Qui Lefebvre
recupera una importante distinzione fatta da Engels nel suo Ludwig Feuerbach, tra metodo
e sistema39
. Marx riprenderebbe questo metodo. E di certo un simile atto di recupero non è
un’operazione innocua, specie se la tradizione da cui si attinge è quella dell’idealismo
tedesco. Lefebvre sa bene che il recupero non voleva dire accettazione completa, anzi egli
stesso ricorda come in un primo momento Marx abbia rifiutato la logica hegeliana; e tale
rifiuto coincide con il tentativo di formulare una nuova concezione, quella del
materialismo storico, che porrebbe, secondo Lefebvre, l’uomo reale, con la sua materialità
e socialità, al centro del corso storico. Un uomo inserito in un contesto sociale costellato da
limiti naturali,in cui e verso cui esercita le proprie attitudini pratiche. La complessità del
soggetto umano e del reale in cui esso agisce, avrebbe spinto Marx a rigettare la dialettica
hegeliana. Eppure, proprio nella preparazione del Capitale, Marx avrebbe riscoperto e
valorizzato questo metodo, svuotandolo del suo contenuto astratto e rivolgendone la
capacità esplicativa al mondo dell’economia e alle sue categorie. Perciò, conclude
Lefebvre, “il metodo dialettico si è dunque aggiunto al materialismo storico e all’analisi
del contenuto economico […]. Elaborato per la prima volta in forma idealistica […] ;
rielaborato ora partendo dalle determinazioni economiche, il metodo dialettico perde la
forma idealistica ed astratta, senza per questo dissolversi: diventando anzi più coerente per
la congiunzione col materialismo approfondito. Nel materialismo dialettico, idealismo e
materialismo non solo vengono riuniti, ma trasformati e superati”40
. Ma il materialismo
dialettico non si applica solo all’economia: esso è una Weltanschauung.
Il materialismo dialettico arriva così ad abbracciare ogni aspetto del mondo. Per quanto
riguarda invece l’itinerario filosofico di Marx, il materialismo dialettico è da considerarsi il
punto cardine, il garante della sua unità concettuale, il filo rosso che unisce il giovane
umanista a quello del Capitale, i cui concetti fondamentali sono quelli di prassi,
alienazione e uomo totale. È la prassi l’attività umana per eccellenza, l’alfa e l’omega
dell’umano che ha nell’alienazione il suo aspetto principale41
. Si dà alienazione in ogni
attività umana in cui l’oggettivazione delle stesse attitudini umane esplicate concretamente
39 Cfr. Friedrich Engels, Ludovico Feuerbach e il punto di approdo della filosofia classica tedesca, Edizioni
in lingue estere, Mosca 1947, pag. 11 e ss.
40 Cfr. Henry Lefebvre, Il materialismo dialettico, Einaudi, Torino 1948, pag. 66
41 Nell’accezione che Marx ne dà nei Manoscritti del ‘44
27
non riporti ad una maggiore umanizzazione dell’uomo. O meglio, quando un’attività
umana crei una disumanizzazione dell’umano. Essa dunque non riguarda solo l’uomo
inserito in un’attività produttiva, ma può presentarsi in ogni attività dell’uomo stesso, che è
il Soggetto.
Ci è sembrato del tutto esatto, anzi necessario, insistere su questo termine della tradizione
filosofica, Soggetto, in quanto la stessa alienazione può essere superata solo dal fare stesso
di chi compie la storia. Lefebvre respingi qualsiasi forma di determinismo, in nome del
concetto di Uomo totale, traslazione peculiare del concetto di presa di coscienza utilizzata
da altri autori. L’uomo totale è il Soggetto. E ciò vuol dire che è il soggetto anche del suo
riscatto. E’ un soggetto in grado divenire soggetto-oggetto, totalità.
Ma come si possono pensare le scienze specifiche e il rapporto che esse instaurano con la
dialettica? E come porre in relazione scienze empiriche e scienze umane?
Le scienze chimico-fisiche studiano un complesso di fenomeni esterni agli uomini; le
scienze umane hanno per oggetto le azioni stesse degli uomini, gli avvenimenti storico-
sociali. Tra queste la sociologia sarebbe deputata ad analizzare le motivazioni che
spingono il singolo a compiere una determinata azione riguardo al rilievo oggettivo che
quelle azioni assumono in rapporto alla formazione sociale ove esse avvengono. Beninteso
la sociologia si occupa solo di quei fatti che hanno un determinato impatto nella storia
dell’uomo. Dunque, in essa v’è una parziale identità di soggetto ed oggetto. L’uomo stesso
che compie le azioni rende, o almeno tenta di rendere, ragione di ciò che compie. Non v’è
però comprensione senza lenti di lettura. Eccoci dunque giunti al complesso problema non
tanto di come si legge il reale, ma di quali lenti stia utilizzando l’interprete. Naturalmente,
senza saperlo. Siamo giunti al problema delle ideologie, che non solo influenzano la
risposta ad un evento; ma costituiscono la chiave stessa di creazione dell’indagine. Ma
torniamo al nostro tema.
Per ricostruire la genesi del pensiero di Marx, anche Golddmann si affida alla categoria di
totalità. Influenzato da Lukacs, egli spiegherà Marx, e lo stesso Hegel, in base alla
categorie della totalità. La totalità è l’unico garante delle parti singole. Queste non esistono
al di fuori del rapporto con la totalità e viceversa. Il metodo dialettico riesce a mostrare
come le ideologie siano relazionate dalla produzione materiale dell’uomo. Ogni fatto si
presenta con una sua significativa struttura unitaria. Nell’indagine di una ideologia
finiremo, se vogliamo comprenderla fino in fondo, sempre per giungere alla dimensione
produttiva materiale, poiché è la stessa dialettica ideologica a non avere un proprio statuto
autonomo di nascita e sviluppo. L’analisi di Goldmann ha un forte connotato umanistico,
28
sintesi delle tre idee fondamentali alla base del socialismo: assenza della divisione in
classi, prerogativa della società antica; il carattere qualitativo del rapporto tra uomo e uomo
e uomo e natura; i valori della libertà uguaglianza e universalità, che la borghesia esplica
solo sul piano formale. Il socialismo ha come obiettivo non tanto l’aumento del livello
della vita materiale, quanto il sottrarre la vita umana alla reificazione, ridando all’uomo un
rapporto significativo con gli altri uomini e con la natura 42
.
II L’ipotesi della rottura epistemologica
Finora abbiamo esposto il pensiero di alcuni dei maggiori autori della linea interpretativa
che definimmo continuistica. Adesso invece vogliamo presentare alcuni dei pensatori che
hanno sottolineato il carattere di conflittualità e rottura dell’opera di Marx rispetto
all’hegelismo e all’idealismo in generale. Tra i pensatori più innovativi ed interessanti che
sono stato in grado di problematizzare le tematiche marxiane c’è sicuramente il filosofo
francese Louis Althusser.
Per Althusser la rottura epistemologica riguarda due discipline teoriche distinte: “Creando
la teoria della storia (materialismo storico) Marx, con un unico e medesimo gesto, aveva
rotto con la sua coscienza filosofica ideologica anteriore e gettato le basi di una nuova
filosofia (materialismo dialettico)” 43
. Il fatto che una nuova filosofia sia sorta dall’atto
stesso della costituzione della scienza e tale scienza sia quella della storia pone il problema
del perché la fondazione della teoria scientifica della storia dovesse implicare e una
rivoluzione teorica nella filosofia.
L’atto di rottura epistemologica suddivide il pensiero di Marx in due grandi periodi
essenziali: quello ancora ideologico, anteriore al 1845, e quello scientifico, posteriore alla
rottura.
Althusser designa le opere del primo periodo, cioè dalla Tesi di Laurea ai Manoscritti del
‘44 e alla Sacra famiglia, come opere giovanili. Le Tesi su Feuerbach e l’ Ideologia
tedesca sarebbero propriamente le opere della rottura. Le opere della maturazione coprono
42 Cfr. Lucien Goldmann, Socialismo e umanesimo, in L’umanesimo socialista, a cura di Erich Fromm,
Dedalo, Bari 1970
43 Cfr. Louis Althusser, Per Marx, Editori Riuniti, Roma 1969, pag. 16
29
l’arco che va dal 1845 al 1857. In questo lasso di tempo di oltre 10 anni Marx avrebbe
sviluppato in termini positivi una propria terminologia ed una serie di concetti adeguati al
suo intento teorico.
Queste due grandi fasi sono a loro volta suddivisibili in altrettanti momenti specifici: per
quanto riguarda le opere antecedenti la rottura, vi sarebbero a) il momento razionalista-
liberale rappresentato dagli articoli della Gazzetta renana (fino al 1842), b) il momento
razionalista-comunitario degli anni 1842-45. Se nel primo momento la problematica
marxiana sarebbe di tipo Kantiano-Fichtiano, la seconda si poggerebbe sull’indagine
antropologica di Feurbach.
Ne seguirebbe allora che l’unico testo in senso stretto hegeliano, sarebbe quello
denominato come Manoscritti economico-filosofici del ’44 . Tranne dunque che
nell’ultimo dei testi giovanili, Marx non sarebbe mai stato hegeliano.
Nella seconda fase invece vi sarebbero rispettivamente i momenti della maturazione
teorica e della maturità.
Nello specifico, la critica elaborata da Marx contro Hegel nel secondo momento della
prima fase altro non sarebbe che il prosieguo e lo sviluppo della geniale critica mossa al
filosofo di Stoccarda da parte di Feuerbach: “Una critica condotta in nome dei principi
della problematica antropologica dell’alienazione: una critica che si appella, contro
l’astratto-speculativo, al concreto-materialista, ossia una critica che resta schiava della
stessa problematica idealista di cui si vuole liberare, una critica che appartiene dunque di
diritto alla problematica teorica con cui marx romperà nel ‘45”44
; “Articoli come Sulla
questione ebraica o la Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico, non sono
intelligibili che nel contesto della problematica feuerbachiana […]. Gli schemi e la
problematica teorica sono gli stessi” 45
.
Marx non fece altro che applicare una problematica etica, la teoria dell’alienazione, alla
politica e all’attività concreta degli uomini, prima di estenderla, come fece nei Manoscritti
del ’44, all’economia politica. E’ di fondamentale importanza il comprendere chiaramente
che l’origine dell’intero impianto concettuale di questi scritti è mutuato da Feuerbach, così
da capire che Marx accetta una problematica specifica, che non è la sua e che è mutuata
altrove, e che tale problematica è integralmente acquisita da Marx, cosi da comprendere
meglio il concetto di rottura.
44 Ibidem, pag. 20
45 Ibidem, pag. 29
30
E quando Marx parla della resa dei conti con la sua coscienza filosofica anteriore46
, indica
apertamente l’adozione di una nuova problematica costruita su di un nuovo elemento;
diremmo, su di un altro campo.
Meticolosa è da parte di Althusser la ricostruzione dei dispositivi attuati dagli interpreti
continuistici, culminante nella teoria delle fonti e delle anticipazioni, e poggiante su tre
presupposti teorici. Il primo, di carattere analitico, rende ogni sistema teorico riducibile ai
suoi elementi; condizione questa che consentirebbe di pensare separatamente un elemento
del sistema e di accostarlo ad un altro elemento simile appartenete ad un altro sistema. Il
secondo è teleologico: giudicare le idee tramite la dissoluzione degli altri sistemi nei loro
elementi per poi riprendere questi elementi e commisurarli alla verità del proprio sistema.
Il terzo poggia sull’illusione che il mondo dell’ideologia abbia in sé il proprio principio
d’intelligenza.
Nel caso del giovane di Treviri, per analizzarne il sistema, questo sarebbe stato scomposto
in tanti elementi riconducibili a due insiemi: quelli materialistici e quelli idealistici. E
questa discriminazione in elementi avulsi dal contesto interno si baserebbe proprio sui
presupposti teorici sopra illustrati.
“Questo metodo che non smette di giudicare, è incapace di pronunciare il benché minimo
giudizio su una totalità diversa da lui. Come potere confessare meglio di così che questo
metodo non fa che giudicare se stesso, riconoscere se stesso sotto gli oggetti, che pensa,
che mai esce da sé […]?”47
Per questo non ci si può addentrare in uno studio marxista delle opera giovanili di Marx
senza avere rotto con le tentazioni elaborate da questo metodo analitico- teleologico. Se si
vuole porre
correttamente il problema degli elementi, si dovrà riconoscere che tutto dipende da una
questione preliminare: quella della natura della problematica a partire dalla quale essi sono
effettivamente pensati, in un dato testo.
Questo schema ermeneutico è stato largamente utilizzato per comprendere lo sviluppo
teorico di Marx soprattutto per il tema del valore. Anche Tuchscherer, uno tra più seri
studiosi della teoria economica marxiana, la riutilizza. A tal proposito egli afferma che
“contrariamente al nostro metodo espositivo che riproduce il processo evolutivo, l’analisi
che ne sta alla base ha dovuto partire dalla teoria del valore nella sua forma matura per
poter poi stabilire a ritroso quali elementi e cognizioni sono contenuti nei vari lavori di
46 Cfr. Karl Marx, Op. cit. , pag. 32
47 Cfr. Louis Althusser, Op. cit. , pag. 44
31
Marx che precedono l’esposizione della teoria del valore nella sua compiutezza e per poter
sintetizzare i risultati ottenuti mediante l’analisi. Nella ricerca, dunque, abbiamo avuto
sempre presente la teoria del valore di Marx nella sua forma compiuta”48
. L’utilità di
questo metodo si paleserebbe anche nell’analisi degli elementi incompiuti della teoria del
valore che possono, a detta dell’interprete tedesco, essere intesi correttamente solo se già si
conosce la teoria sviluppata, e a patto di non assolutizzare le affermazioni di Marx risalenti
al periodo iniziale di studio. In questi scritti vi sarebbe invece un accenno in forma di
anticipazione a qualcosa di superiore.
Questa modalità di ricostruzione, a detta di chi scrive, non riesce però non solo a vedere il
cambio di campo d’indagine, ma soprattutto a cogliere i motivi e i dispositivi che
portarono Marx a dedicarsi agli studi economici. Sappiamo che gli studi di economia
iniziano già dalla fine del ’43 e che l’influenza di Engels è stata in questo senso
determinante. Ma trovare i motivi per i quali Marx rompa con la gabbia ideologica che lo
imprigionava è operazione assai complessa. Tuchscherer è convinto che furono le nuove
cognizioni filosofiche “ la causa decisiva che spinse Marx a dedicarsi allo studio
dell’economia politica. Le cognizioni in tal modo acquisite influenzarono a loro volta le
concezioni filosofiche di Marx, spingendolo a riesaminarle, a correggerle, a precisarle e a
svilupparle ulteriormente. Questo processo trovò alla fine espressione nell’elaborazione del
materialismo storico che a sua volta costituì il punto di partenza di nuove ricerche nel
campo dell’economia politica”49
. Ma tutto ciò in realtà è una non spiegazione. Da questo
errore ne deriva un altro, che attanaglia l’intera linea continuistica quando si tratta di
definire se le singole opere di Marx siano di carattere filosofico, politico o economico,
arrivando a descriverle con connotati definibili sotto la categoria dell’eclettismo, come
diretto riflesso dell’ossessivo mantenimento di un carattere unitario del pensiero di Marx.
Considerare il materialismo dialettico e il materialismo storico già sostanzialmente
enucleati nella Sacra famiglia, e la teoria economica già tratteggiata nel corso della
seconda metà degli anni quaranta (quindi dopo la presunta sistematizzazione del
materialismo dialettico e storico), ci sembrano affermazioni non solo non provabili, ma
anche perniciose per la comprensione dei contenuti del Capitale, perché nel periodo della
giovinezza le nozioni di economia politica abbozzate non vengono riportate nelle opere
48 Cfr. Walter Tuchscheerer, Prima del capitale: la formazione del pensiero economico di Marx (1843-1858),
La nuova italia, Firenze 1980, pag. 6
49 Ibidem, pag. 200
32
della maturità, salvo modificazioni sostanziali che non permettono nemmeno di
considerarle come meglio delineate50
.
Ma nonostante queste interessanti osservazioni, i teorici continuistici negano risolutamente
lo statuto teorico del cambio di problematica fondamentale. Sempre Tuchscherer51
, che, è
bene ricordarlo, rimane tra questi comunque un’interprete di gran lunga superiore per
serietà di studi e conoscenze della materia, nega che un raffronto diretto tra le concezioni
dei Manoscritti del ’44 e la stessa Miseria della filosofia possa portare alla conclusione che
nell’evoluzione delle concezioni economiche di Marx, particolarmente nella sua
concezione del valore, si sia verificata una rottura.
Il mutamento di paradigma tra il Marx del ’44, che interpreta la produzione mercantile
mediante la teoria dell’estraneazione del lavoro, e quello della Miseria, che si dice
sostenitore della teoria del valore-lavoro, viene letto in termini di sistematizzazione di
nuove nozioni all’interno di una struttura concettuale elaborata su una problematica
specifica, e dal superamento di vecchie concezioni nel corso degli studi economici
successivi alla fine del 1845. In altri termini, non vi sarebbe cambio alcuno della
problematica di fondo, ma solo una sua nuova, e più chiara, focalizzazione.
Ma torniamo ad Althusser, per fare alcune precisazioni. Egli ha più volte rivisto le
posizioni esposte in Per Marx, e ha cambiato più volte idea circa il ruolo della filosofia. Se
infatti nel testo di esordio questa era definita teoria della pratica teorica, distinta dalle altre
pratiche ideologiche52
e inequivocabilmente foriera di una svalutazione del ruolo del
materialismo dialettico53
, lasciando alla filosofia stessa un dubbio spazio sulla quale
50
Lo stesso Engels, anni dopo la prima apparizione de La situazione della classe operaia, afferma
perentoriamente che è “appena necessario osservare che il punto di vista teorico generale di questo libro – in
senso filosofico-economico e politico- non si identifica del tutto col mio punto di vista odierno. Nel 1844 non
esisteva ancora il moderno socialismo internazionale, che da allora si è costituito in scienza, soprattutto e
quasi esclusivamente grazie ai lavori di Marx. Il mio libro rappresenta soltanto una delle fasi del suo sviluppo
embrionale”. Cfr. Meoc, Vol. IV, pag. 673
51 La morte lo strappò giovanissimo dal mondo, proprio mentre stava lavorando sui testi de Il capitale, che
aveva escluso da quella che rimarrà la sua opera-capolavoro. Incalcolabile, a detta di chi scrive, sarebbe stato
il suo contributo per la corretta interpretazione dell’opera principale di Marx.
52 Cfr. Louis Althusser, Op. Cit., pag. 150
53 Che ricordiamo essere termine che non è mai presente nei testi di Marx e che venne comunque
sistematizzato e dogmatizzato da Stalin.
33
esercitare un proprio spazio, nella risposta a Lewis intitolata I Marxisti non parlano mai al
vento, la filosofia diviene “lotta di classe nella teoria”54
.
Fatta eccezione per l’introduzione a Per la critica dell’economia politica, la dialettica la
troviamo nei testi del Marx maturo allo stato pratico, ma non allo stato teorico55
.
L’ideologia come sistema di rappresentazioni si distingue dalle scienze per il fatto che in
essa la funzione pratico-sociale prevale su quella teorica. Nelle scienze l’ambito del teorico
si sviluppa solo a cose fatte, quando i sistemi e i dispositivi utilizzati sembrano entrati in
crisi. Nel pensiero di Althusser c’è sempre una costante: l’ossessione per il fatto nudo e
crudo che Marx non abbia scritto una dialettica 56
. Non possiamo qui seguire le evoluzioni
del pensiero di Althusser, che giudico in assoluto l’autore più interessante nella storia del
marxismo del dopoguerra, anche se, a tratti, il Marx di Althusser sembra essere più un
Marx riadattato a ciò che esso avrebbe dovuto essere per i posteri e non ciò che Marx è
realmente stato. Possiamo però vedere come l’esercizio di lettura collettiva del Capitale,
raccolta nel testo Leggere il Capitale, ponga maggiormente in rilievo i cambi di oggetto e
problematica, che permisero al filosofo di Treviri di andare oltre i divieti fondanti le teorie
a lui contemporanei. Oggetti invisibili perché respinti in linea di principio e rimossi dal
visibile del campo d’indagine dell’economia politica57
. Potremmo dire, andando oltre le
intenzioni althusseriane, che quei divieti e quell’invisibile, nel momento in cui furono
illuminati dai testi della maturità di Marx, rimasero non indagati anche dalla filosofia
stessa. Rimasero in una paradossale non-indagine: cioè segnati dal tentativo di ricondurli
nel campo del già indagato per svilirne lo statuto, in una operazione di riconduzione del
nuovo nel già sempre noto, pena la crisi di quelle discipline basate sul divieto
dell’indagine. Il costo della rottura e dell’appropriazione di un nuovo spazio è il costo del
carattere d’intelligibilità che è proprio della fondazione di una nuova scienza che guardi al
di là delle opzioni “metafisiche” della tradizione occidentale. Tra queste, un ruolo
preliminare è occupato dal rapporto tra ordine storico e ordine logico, che impegna Marx
54 Cfr. Louis Althusser, I marxisti non parlano mai al vento, Mimesis, Milano 2005, Pag. 64
55 A tal proposito, è bene leggere un passo molto convincente: “Si pensi a Marx. Ha scritto dieci libri e quel
monumento che è Il capitale senza mai scrivere una «Dialettica». Parlò di scriverla, ma non ne fece niente.
Non ne trovò mai il tempo. Il che significa che non lo cercò, perché la Teoria della sua pratica teorica non era
allora essenziale allo sviluppo della sua teoria, ossia alla fecondità della sua propria pratica” Cfr. Louis
Althusser, Op. Cit., pag. 153
56 Oltre alla citazione riportata nella nota precedete Cfr. Louis Althusser, Leggere il Capitale, Mimesis,
Milano, 2006, pag. 31; Cfr. Louis Althusser, Sul materialismo aleatorio, Op. Cit., pag. 46
57 Cfr. Louiss Althusser, Leggere il capitale, Op. Cit. pag. 27
34
nel Capitale. È questo il problema di sapere se c’è identità tra l’ ordine detto “logico”, cioè
l’ ordine di “deduzione” delle categorie nel Capitale, e l’ ordine “storico” reale. “La
maggior parte degli interpreti non arriva veramente a “uscire” da questo problema, perché
si rifiuta di porre la domanda nei suoi termini adeguati, cioè nel campo della problematica
richiesta da questa domanda […]. Il Capitale ci dà tutta una serie di risposte sull’identità e
la non identità dell’ordine “logico” e dell’ordine “storico”. Queste risposte sono risposte
senza domanda esplicita, a questo titolo ci pongono il problema della loro domanda” non
posta58
.
Il porre la domanda è simultaneamente produzione del quesito e definizione del campo
investito dalla problematica. La maggior parte degli interpreti ha svolto questa operazione
o nel campo dell’empirismo o in quello perimetrato dall’hegelismo, tentando di dimostrare
rispettivamente che l’ ordine logico, coincidendo con quello reale, non può che esistere in
questo e da questo prendere le mosse per seguirne le evoluzioni; gli altri hanno detto
l’opposto. Althusser teorizzò l’uscita da questo orizzonte definito “ideologico”, per
ricondurlo alla distinzione tra oggetto reale e oggetto della conoscenza, a cui fa seguito la
distinzione radicale tra l’ordine di apparizione delle categorie nella conoscenza e nella
realtà storica.
La domanda del modo di appropriazione dell’oggetto reale deve esser posta in termini che
escludano il ricorso alla soluzione “ideologica” che produce i personaggi “ideologici” di
soggetto e di oggetto, orientandosi su un tipo di problematica che sappia distinguere
oggetto reale ed oggetto di conoscenza, potendo così comprendere quella radicale
differenza tra l’ordine di apparizione da una parte delle categorie nella conoscenza e
dall’altra nella realtà storica.
Nel Capitale, pur sapendo che l’attuale società è un prodotto, Marx si occupa di questo
prodotto, studiandone il meccanismo che ne permette l’esistenza e la possibilità di
interpretarla come risultato della produzione della storia “le [cui] forme d’ordine (forme
della dimostrazione nel discorso scientifico) sono la “diacronia” di una “sincronia”
fondamentale”59
.
I risultati teorici di questa impostazione furono oggetto di una critica feroce in Francia e in
Europa. Anche autori come Michael Lowy, che avevano sostenuto l’ipotesi della rottura
epistemologica, non seguirono le evoluzioni del pensiero di Althusser. In questo caso
Lowy ri-propose un’idea di rottura di carattere soprattutto politico, condizionato sempre da
58 Ibidem, pag. 44
59 Ibidem, pag. 61
35
quello epistemologico 60
Sempre Althusser elaborò varie autocritiche,che ricevettero non
poche critiche feroci perché interpretate come autoapologie61
. In Italia, in forma almeno
inizialmente autonoma, già Galvano Della Volpe elaborò interessanti prospettive contro le
prospettive continuistiche, incentrando le sue ricerche su un nuovo ambito logico che
sarebbe stato inaugurato da Marx62
.
In Logica come scienza positiva individua nella critica materialista dell’apriori moderno la
conclusione di un processo di pensiero antidogmatico che percorrerebbe tutta la storia della
logica e della filosofia, vedendo, a differenza di Althusser, nella Critica della filosofia
hegeliana del diritto il lavoro in cui Marx distrugge il procedimento tautologico della
dialettica hegeliana, abbozzando una nuova concezione scientifica di matrice materialista
per la conoscenza dell’oggetto, in grado di spiegarne sia le contraddizioni insite sia la
genesi e necessità storica.
Anche in Miseria della filosofia Marx attacca la metafisica economicistica di Prodhon,
opponendogli una dialettica scientifica, cioè analitica, che si esplicherebbe totalmente nella
introduzione e nella prefazione Per la critica dell’economia politica, opera nella quale
verrebbe esplicitato quel metodo circolare di concreto-astratto-concreto che è la
fondamentale struttura di una dialettica scientifica. Ci troveremmo dunque di fronte ad una
“logica il cui simbolo resta il suddetto circolo concreto-astratto-concreto: circolo che ci
indica i tre aspetti logico-gnoseologici comuni ad ogni sapere in quanto scienza – e quindi
non più mero sapere o contemplazione: a) il dato problematico o istanza storico-materiale;
b) l’ipotesi o istanza storico-razionale (istituzione di ipotetiche risolutive medie di
antecedenti-conseguenti); c) l’esperimento o saldatura del circolo della funzionalità
60 Cfr. Michael Lowy, Il giovane Marx e la teoria della rivoluzione, Massari, Bolsena 2011
61 Cfr. Alain Lipietz, Da Althusser a Mao?, Aut Aut, Milano 1977
62 Sottolineo il fatto che spesso gli autori della rottura abbiamo posto Marx ed Engels in contrapposizione,
vedendo nelle opere di quest’ultimo evidenti influenze, che rasentano il condizionamento, sia dal positivismo
che dall’hegelismo. La cosa non mi vede del tutto d’accordo, in quanto Engels, oltre a concepire opere più
facilmente accessibili, per motivi squisitamente politici, e a compiere profonde analisi politiche e militari, ha
il grande merito di aver condotto Marx sul terreno dell’economia politica e giocato un ruolo fondamentale
nell’elaborazione dei concetti del Capitale come testimoniano svariate epistole scambiate con l’amico.
D’altra parte, Marx ed Engels non hanno mai posto in antitesi i loro pensieri. Ed è difficile credere che tra i
due si possano rintracciare delle radicali differenze, tant’è che un loro contemporaneo, Ludwig Simon, ne
parlava al singolare, suscitando l’ilarità di Marx: “E’ stranissimo come il tipo ci consideri al singolare” (Cfr.
Meoc, Op. Cit., vol. XL, pag. 68). Sui rapporti tra Marx ed Engels cfr. Gustav Mayer, Friedrich Engels, la
vita e l’opera, Einaudi, Torino1969, pag. 54 e ss.
36
reciproca di dato e ipotesi o materia e ragione (conversione dell’ipotesi in legge)”63
. È
questo un metodo di conoscenza che ricomprende nella sua positività la duplice istanza
della logica classica: l’istanza platonica, cioè quella della ragione o della dialettica delle
cose, e la istanza aristotelica, quella della materia o della positività del molteplice, che il
principio di non contraddizione esprime in modo incontrovertibile. E’ questo rapporto tra
ragione e materia un rapporto dialettico diadico, in opposizione alla triade di Hegel.
Marx applicherà questa logica all’economia e alle scienze umane in genere. La logica di
Della volpe è antimetafisica ma non antifilosofica, senza quindi cadere nel positivismo
logico. Egli vuole rovesciare la fondazione kantiana della logica: “rovesciare la fondazione
logica che la soluzione humeana e kantiana hanno in comune – cioè la non-
contraddittorietà o non assurdità della negazione64
. In seguito, proprio per mostrare la
differenza radicale con l’intero idealismo tedesco, Della Volpe, tornerà a criticare lo stesso
Kant, reo di aver perso di vista “la vera struttura del trascendentale proprio in quanto pose
sullo stesso piano indifferentemente la possibilità logica e la possibilità reale”65
.
L’empirico, in questa impostazione, finiva per avere un ruolo gratuito e surrettizio nella
costruzione dialettica, in una concezione dogmatica dell’unità dell’empirico e della
filosofia che porta ad una sostantificazione di un’astrazione, ossia logicamente nel
rovesciamento del naturale predicato (l’universale) in soggetto.
Sempre in ambito logico Marino Centrone ha sostenuto le ragioni di una revisione radicale
dei caratteri di riappropriazione del reale concreto, non mistificato dai caratteri della
sussunzione nelle strutture formali della logicistica. Per Centrone la complessità
dell’analisi marxista ha come intento ed esito la ricomprensione delle categorie logiche
nella contestualità dello storico come processo appropriativo del reale.
Ma i fondamenti non possono essere quelli dell’uomo e del suo mondo, che sarebbero da
considerarsi “residui semantici di concezioni ideologiche borghesi”66
. Pertanto se
l’appropriazione del reale è il risultato di un processo complessivo che si svolge attraverso
la contraddizione specifica fra forze produttive e rapporti di produzione, e se questa
contraddizione si basa su una contraddizione complessa e non semplice, allora è proprio
attraverso di essa che deve essere affrontato il problema dei fondamenti.
63 Cfr. Galvano della Volpe, Logica come scienza positiva, Messina, Firenze 1950, pag. 211
64 Ibidem, pag. 51
65 Cfr. Galvano della Volpe, Logica come scienza storica, Editori riuniti, Roma 1969, pag. 40
66 Cfr. Marino Centrone, Logica formale e materialismo , Dedalo, Bari 1977, pag. 66
37
CAPITOLO SECONDO
IDEE DI LOGICA, A PARTIRE DALL’IDEALISMO
I Feuerbach, l’ inversione e la logica delle cose
Dopo questa breve ricostruzione delle linee di interpretazione, svolgeremo la nostra
indagine su alcuni dei dispositivi interni al metodo marxiano. Per orientare la nostra ricerca
sul tema del significato delle nozioni di astratto e concreto, dell’uso della dialettica e
dell’oggetto specifico dell’analisi marxiana, dobbiamo innanzitutto porci la domanda circa
il senso di una simile operazione. Marx non ha mai scritto un’opera sul metodo utilizzato
nelle sue indagini, ma questo di certo non può portarci all’assurda conclusione che non ne
avesse adottato uno. Tuttavia se consideriamo l’intero corpus delle sue opere, ci
accorgiamo che il ruolo e l’estensione di tali nozioni sono mutati radicalmente. Non tutti
sono d’accordo su questo. Ma, per così dire, la posta in gioco che legittima e dà senso alla
ricostruzione che seguirà, riposa su questa negazione di un’ipotesi di rottura. Presentare
come continue e sostanzialmente omogenee le categorie di astratto, concreto, cosi come
quelle dell’oggetto tematizzato, della dialettica e del ruolo della filosofia, implica in primo
luogo che il metodo sia considerato in un modo o nell’altro al di sopra o quantomeno
esterno al processo analitico, e che il campo d’indagine a cui Marx l’abbia applicato sia il
medesimo.
Dobbiamo quindi ricostruire l’itinerario del filosofo tedesco attraverso le opere, per
comprendere in quale fase si consumi la rottura, e quale ne sia la portata. Operazione di
certo resa più complessa da una tradizione marxista che ha, in ultima analisi, interpolato
nozioni e termini estranei al pensiero marxiano. Ciò non vuol dire però che la ricostruzione
che qui operiamo sia una sorta di riscoperta di una radice pura da recuperare depurandola
da ogni elemento giustapposto o scaturito successivamente poiché, nel momento in cui si
volesse legittimare questo atteggiamento, si entrerebbe in contraddizione con una nozione
presente già nell’insieme teorico di cui si anela il recupero, quello del carattere perfettibile
38
e degli aspetti specifici e del tutto analitico. Atteggiamento che caratterizza ogni scienza
rispetto a qualsivoglia formulazione dogmatizzata di un assunto teorizzato dal fondatore
della scienza sociale marxista.
Ad avviso di chi scrive, l’ipotesi di un cambio di direzione d’indagine rende intelligibile il
carattere di pensabilità non solo della rottura stessa, ma consente di accertare la relazione
che intercorre tra la disciplina sviluppata e l’humus culturale in cui essa si afferma. Non
che autori come Lukacs, Bloch o Badaloni abbiano occultato il complesso e angoscioso
rapporto che Marx ebbe con i contemporanei. Ma il loro approccio ha sottovalutato la lotta
svolta da Marx per l’affermazione della propria filosofia. Una filosofia esiste non tanto
perché elabora risposte più adeguate rispetto alle altre su problemi posti da una tradizione,
ma perchè si afferma imponendo nuove domande e una forma di dominio efficace
all’interno di un campo epistemologico. E una di queste forme è quella della ricerca di un
nuovo linguaggio. Bisogna comprendere allora il contesto conflittuale in cui un nuovo
pensiero sorge, la storicità dell’opera che ne condiziona sin dall’inizio l’esistenza, avendo
così un quadro ben più ampio che ci permette di comprenderne il grado di differenza
conflittuale.
Per questo non dobbiamo dimenticare che Marx ha iniziato i propri studi filosofici sotto
l’influenza di Hegel e degli hegeliani. Tra questi Ludwig Feuerbach, con il suo progetto di
ribaltamento della dialettica, ha avuto un ruolo preminente. E’ noto infatti come il filosofo
di Landshut abbia avuto un enorme impatto sulla cultura tedesca, criticando la deriva
speculativa della logica hegeliana. Nelle Tesi preliminari per la riforma della filosofia
afferma che la questa era una “teologia resa razionale e presenziale, la teologia fatta
logica. Come l’ente divino della teologia è la quintessenza ideale o astratta di tutte le
realtà, cioè di tutte le determinazioni, di tutte le finitezze, così è la Logica. Come tutto ciò
che si trova sulla terra si ritrova poi di nuovo nel cielo della teologia, così tutto ciò che è
nella natura si ritrova nel cielo della logica divina: qualità, quantità, misura, essenza,
chimismo, meccanismo, organismo”67
.
Hegel avrebbe il merito di essere andato oltre la contraddizione tra essere e pensiero così
come era stata espressa dalla filosofia kantiana, ma di aver dissolto tale contraddizione solo
nel pensiero stesso. Perciò in Hegel “ il pensiero è l’essere – il pensiero è il soggetto, e
l’essere il predicato. La logica è il pensiero nell’elemento del pensiero, ossia del pensiero
che pensa se stesso – il pensiero è inteso come soggetto senza predicato […]. Hegel si è
67 Cfr. Ludwig Feuerbach, Tesi preliminari per la riforma della filosofia in, Id. Scritti filosofici, a cura di c.
Cesa, Bari, Laterza 1976, pp.179-80
39
limitato a pensare gli oggetti come predicati del pensiero che pensa se stesso”68
. Compito
della nuova filosofia è quello di riformulare correttamente il rapporto tra essere e pensiero
facendo del primo il soggetto e del secondo il predicato. In questo deve essere espressa
l’essenza di quello, in quanto “il pensiero deriva dall’essere, ma non l’essere dal
pensiero”69
. Il rovesciamento non doveva investire solo il sistema hegeliano, ma tutto
l’ambito della speculazione moderna. In tal senso, Feurbach rivendicava il ruolo
preminente della sensibilità, facoltà umana in grado di andare oltre ogni concezione
astratta dell’uomo, che in filosofia si esprimeva nella figura dello spirito autocosciente. E il
carattere di separatezza e privazione di questo ente riposava sulla sottrazione della realtà e
dell’oggettività. Solo mediante i sensi un oggetto si dà in modo autentico, e solo in questo
modo si può conoscere l’essere non solo come una essenza pensante ma come una essenza
realmente esistente. La “vecchia” metafisica che attribuiva indistintamente l’essere ad ogni
cosa, poiché tutte le cose hanno in comune il fatto di essere, finiva per ricavarne un
pensiero senza realtà.
E’ noto che le novità introdotte da Feuerbach ebbero una fortissima influenza sullo
sviluppo intellettuale di Marx: nei Manoscritti del ‘44 , in polemica con Strauss e Bauer,
rei a suo avviso di essere ricaduti nella logica di Hegel, egli afferma che “tanto nelle sue
Tesi, negli Anekdota,che, in dettaglio, nella Filosofia dell’avvenire, [Feuerbach] ha
sradicato la vecchia dialettica e filosofia […]. Feuerbach è il solo che sia in un rapporto
serio e critico con la dialettica hegeliana, e che abbia fatto delle vere scoperte in questo
campo e sia insomma il vero vincitore della vecchia filosofia”70
. Egli avrebbe avuto il
merito di rifiutare la speculazione, e di aver riconosciuto il ruolo del positivo che
autofondandosi legittima il ruolo della certezza sensibile, opponendosi al cammino della
negazione della negazione, apostrofata come “l’espressione astratta, logica, speculativa
del movimento della storia, che non è peranco la storia reale dell’uomo come soggetto
presupposto” 71
.
Ma già nella Critica alla filosofia hegeliana del diritto, egli rifiutava l’atteggiamento di
fondo della speculazione hegeliana, che concepisce l’idea come origine del reale sensibile
e il reale sensibile come ambito in cui l’idea stessa si realizza. Nel momento in cui si
analizza un evento o un’istituzione tramite la lente speculativa, il filosofo idealista cerca
68 Ibidem, 191-2
69 Idem
70 Cfr. Meoc, Manoscritti economico-filosofici del ’44, vol. IV, pag. 202
71 Ibidem, pag. 357
40
nelle determinazioni reali le determinazioni corrispondenti del concetto puro, riducendo
così gli enti a vuoti nomi e reiterando la medesima intelaiatura categoriale a fronte della
proteiforme e variegata natura degli enti e delle relazioni. Così nella Logica il passaggio
dalla sfera dell’essenza a quella del concetto è identico al trapasso della natura inorganica
alla vita, illustrata nella filosofia della natura. Le deduzioni si trasformano così in mere
tautologie, come mostra l’analisi del diritto costituzionale.
In esso il “concreto contenuto, la determinazione reale, appare come formale; la
determinazione formale, del tutto astratta, appare come il contenuto concreto. L’essenza
delle determinazioni statali non è già di poter essere considerate determinazioni statali, ma
di poter essere considerate, nella loro forma più astratta, come determinazioni logico-
metafisiche. Non la filosofia del diritto, ma la logica è ciò che veramente interessa. Non
che il pensiero prenda corpo nelle determinazioni politiche, ma bensì che le esistenti
determinazioni politiche si volatilizzino in astratti pensieri, questo è il lavoro filosofico.
Ciò che è il momento filosofico non è la logica della cosa, ma la cosa della logica”72
.
L’atteggiamento hegeliano viene definito “misticismo logico, panteistico”73
. L’analisi dello
Stato ne mostra l’impianto: Hegel assegna ad esso un ruolo del tutto immaginario,
storicamente insussistente. Il reale non è più espressione di sé ma di altro. E’ l’idea che
diventa soggetto, e il rapporto reale tra esso, la famiglia e la società civile finisce per
diventare attività interna ed immaginaria dello Stato. Dunque i soggetti reali, cioè famiglia
e società civile, finiscono per diventare delle oggettualità spettrali e, potremmo dire,
impotenti. Dunque, analizzando i fatti desunti dall’esperienza come fenomeno dell’idea, si
finisce per trasformare il predicato in soggetto, e così facendo “ la condizione viene posta
come il condizionato, il determinante come determinato, il producente come prodotto del
suo prodotto”74
. L’idea di Hegel “viene rappresentata come se agisse secondo un principio
determinato e per un’intenzione determinata”75
e il suo unico scopo coincide con lo
“scopo logico”76
. Ma la sfera della logica così intesa, e con essa il consequenziale sviluppo
dell’idea, è e rimane astratta. Le determinazioni individuate restano scevre da aderenza al
dato desunto dal reale e l’idea è concepita come pensiero logico astratto.
72 Cfr. Meoc, Op. Cit. , pag. 102
73 Ibidem, pag. 8
74 Ibidem, pag. 9
75 Ibidem, pag. 7-8
76 Ibidem, pag. 10
41
Dobbiamo però ricordarlo ancora una volta: ad Hegel non interessa la logica della cosa
ma la cosa della logica. Per questo nei Lineamenti della filosofia del diritto può affermare
che “la necessità nell’idealità è lo sviluppo dell’Idea entro se stessa”77
.
Così facendo, Hegel pone i predicati nella loro esistenza come scissi, slegati dal soggetto.
È questo il carattere astratto, in senso etimologico, della sua filosofia. Prescindendo da
questo soggetto, e sapendo che non si danno predicati senza almeno un soggetto, egli
finisce per mettere in una relazione fittizia i predicati stessi con un soggetto precipuo:
l’idea. E questa diventa così il supporto dei predicati. Ma così facendo anche il supporto è
scisso, astratto da ciò che dovrebbe supportare. L’idea non è in grado di darsi la realtà,
finisce solo per darsi una volgare empiria. Hegel vorrebbe spiegare la realtà e i dati che la
compongono riconducendo le loro ragion d’essere ad un processo che parte sempre da
un’origine e che ad essa ricondurrebbe nell’analisi del loro sviluppo, insistendo sul
carattere necessario della derivazione dello sviluppo, sotto il rispetto del contenuto
determinato, concreto. L’essere predicato si spiegherebbe sempre a partire dal soggetto.
Ma Marx rifiuta questa formulazione di giudizio che per Hegel era produttrice effettiva dei
enti reali determinati, e il rifiuto è formulato in base alla convinzione che i due elementi
del giudizio rimangono irrelati. Nello specifico, Marx prende ad esempio il passaggio della
famiglia e della società civile a Stato politico , passaggio non derivato dall’essenza
specifica della famiglia e dall’essenza specifica dello Stato, ma dall’universale rapporto
relazionale di necessità e libertà78
. Ma un tale rapporto è del tutto estraneo alle strutture
peculiari della famiglia e della società civile. Per questo, il filosofo di Treviri può
concludere che “Hegel fa dappertutto dell’Idea il soggetto e del soggetto propriamente
detto, reale, fa il predicato; ma lo sviluppo procede sempre dalla parte del predicato”79
. La
forma della deduzione che è errata in sé, porta inevitabilmente ad una errata comprensione
del contenuto da dedurre, che in questo caso è il mondo empirico. Sappiamo che Hegel
rende soggetti la realtà astratta, la necessità e la sostanzialità, cioè tre categorie logiche80
,
lasciando indipendenti i predicati per trasformarli, in guisa mistica, nei loro soggetti. In
verità erano, secondo Marx, i soggetti da concepirsi come indipendenti81
.
77 Cfr. George F. W. Hegel, Lineamenti della filosofia del diritto, Laterza, Bari 1954, pag. 219
78 Cfr. Meoc, Op. cit. , pag. 11
79 Idem
80 Ibidem, pag. 18
81 Ibidem, pag. 26
42
Per questo Marx parla di un inevitabile rovesciamento della speculazione in empiria,
riferendosi alla necessità con cui il processo ideale interpola gli elementi dell’esperienza, e
di rovesciamento dell’ empiria in speculazione, del dato empirico che viene elevato a
risultato speculativo. La nuova filosofia deve quindi essere in grado di partire dal reale
soggetto e considerare il suo oggettivarsi. L’idea non è in grado di darsi la realtà, e
l’idealismo finisce per darsi una volgare empiria. Di contro, bisogna ripartire dalla logica
della cosa, concependo la logica specifica dell’oggetto specifico. Emerge dunque con
chiarezza da questo ampio quadro che abbiamo fornito che compito della filosofia è pur
sempre quello di elaborare una logica “cioè di uno specifico apporto filosofico, di una
<spiegazione> e <comprensione> della realtà. Il reale non è privo di in senso, di un
significato, di una sua <legge>, di una sua <essenza> che si tratta di intendere
filosoficamente; e se Hegel ha torto non è tanto perché dà al reale empirico un senso, un
significato, quanto perché il senso che egli conferisce al reale non è conforme al reale, non
è suo proprio […] ma gli viene sovrapposto dall’esterno e gli risulta trascendente”82
.
La dialettica marxiana poggia qui integralmente sulla distinzione di soggetto e predicato.
Marx ha detto che il soggetto, o sostanza, è l’esistente determinato e ad esso devono essere
ricondotti i predicati e tutte le determinazioni. Il soggetto a cui Marx qui guarda è l’uomo,
ossia il reale autore del mondo storico-sociale. Tutto ciò che esiste, sia esso lo Stato, la
società civile o la famiglia ecc, è solo per mezzo dell’uomo, che è ciò che determina, ciò
che condiziona, ciò che realizza.
Quando qui Marx parla dell’uomo non parla dell’individuo umano, bensì dell’uomo preso
come genere. E l’uomo va indagato nel suo processo di oggettivazione, partendo dal reale
soggetto empirico per analizzarne il divenire inteso come sviluppo intrinseco delle
determinazioni contenute nel suo esser sostrato. È questo un ambito in cui vediamo
applicata quella logica specifica dell’oggetto specifico delineata come dialettica dello
sviluppo della sostanza, e che molto risente sia dell’impostazione aristotelica della
sostanza-sostrato e delle sue qualità83
sia dello schema hegeliano, qui rovesciato per ri-
acquisire ciò che Hegel non riesce ad afferrare: l’empiria.
La distinzione tra il sostrato e le determinazioni che ad esso ineriscono apre al superamento
dell’inversione di soggetto e predicato e al recupero del dato empirico reale: di fatto o il
sostrato è un ente reale e il pensiero ne è una determinazione, oppure a partire da
82 Cfr. Mario dal Pra, Op. cit., pag. 73
83 Ibidem, pag. 82 e ssg.
43
determinazioni astratte si costruisce un sostrato e i reali soggetti vengono declassati a mere
determinazioni.
Questo chiaro richiamo ad Aristotele ha portato Galvano della Volpe a sostenere che
l’aristotelismo di Marx è riconducibile “alla critica aristotelica della platonica
classificazione aprioristica dei generi empirici”84
. Anche le analisi di Dal Pra convergono
sostanzialmente su questo punto:
“La possibilità di configurare una realtà ideale deriva infatti, anche a giudizio di Marx
come a giudizio di Aristotele, da quel procedimento di astrazione per cui le determinazioni
di concrete sostanze non vengono considerate come attributi delle sostanze cui ineriscono,
ma vengono rese indipendenti dal rispettivo sostrato e considerare per se stesse; dando a
questa operazione del pensiero una portata reale, si finisce per ritenere che quella
indipendenza dal sostrato che una determinazione acquista soltanto perché il pensiero la
considera isolatamente, le compete anche sul terreno reale. Così, per esempio, rileva Marx,
la soggettività è una determinazione del soggetto e la personalità è una determinazione
della persona; ciò significa che la soggettività, anche se può essere considerata per se
stessa in relazione al carattere di un soggetto concreto esistente, non può esistere da sola
indipendentemente da quel soggetto di cui è appunto una determinazione. Ora Hegel,
invece di concepire le determinazioni come predicati dei loro soggetti, fa indipendenti i
predicati e li lascia tramutarsi, in guisa mistica, in soggetti”85
. Alla radice è sempre
l’attribuzione di preminenza reale al pensiero, che gabella i predicati come indipendenti
rispetto al proprio soggetto, lasciandoli tramutare in soggetti reali, e che trasforma la logica
in una scienza di astrazioni arbitrarie e non oggettive. Si tratta quindi di un problema
cardine, sul quale Marx dovrà attardarsi anche in seguito. Non bisogna dimenticare che lo
sforzo qui attuato di riconfigurazione del problema risponde ad interessi e motivazioni che
vanno ben oltre la pura teoria, come testimoniano i passi dell’opera sopra riportati.
Con l’ascesa al trono di Federico Gugliemo IV, tra le file dell’intellighenzia progressista
tedesca si era diffusa la speranza in una nuova epoca. Finalmente, ci si augurava, il re
avrebbe concesso quelle tanto agognate libertà politiche (come il costituzionalismo, la
libertà di stampa, la riduzione della censura ecc.) che in Francia erano già legalizzate da
tempo. Inoltre tra i vasti strati della borghesia liberale, ceto sociale che si andava
affermando in quelli anni soprattutto in territorio renano grazie alla diffusione del modello
84 Cfr. Galvano della Volpe, Per una metodologia materialistica della economia e delle discipline morali in
genere, in Rousseau e Marx, Editori Riuniti, Roma 1957, V edizione 1997, pag. 103-10
85 Cfr. Mario dal Pra, op. cit., pag. 49, corsivi miei
44
industriale e commerciale importato dall’Inghilterra, si sperava e in un riconoscimento
politico da parte della corona e in un alleggerimento della burocrazia statale che tanto
minacciava la libertà d’impresa.
I neohegeliani avevano visto il nuovo monarca come colui il quale avrebbe compiuto i
primi e significativi passi verso la trasformazione della Prussia in uno Stato razionale. Uno
dei più eminenti esponenti del movimento, Bruno Bauer, saluta l’incoronazione con parole
di encomio: “ Un alba di speranza si riflette su tutti i volti”, “ la primavera ringiovanisce
tutti i cuori”86
. Le speranze vennero ben presto deluse. Nel campo dell’istruzione
universitaria, dopo la morte del ministro dell’istruzione Altenstein87
, lungimirante politico
che aveva favorito l’insediamento dei giovani hegeliani nella facoltà di Berlino, che
divenne baluardo del movimento progressista tedesco non solo in campo filosofico,
Federico Guglielmo IV nomina ministro del culto Eichhorn, compiendo a parer loro una
svolta decisamente reazionaria. Il re in pochi mesi affidò a molti teorici antihegeliani
prestigiose cattedre: si pensi alla successione dell’illustre discepolo di Hegel Gans,
sostituito dal giurista del movimento romantico della Scuola storica Stahl. Ma soprattutto
si pensi all’assegnazione della cattedra al vecchio Schelling. Il re credeva opportuno
rimuovere dai punti nevralgici dell'istruzione tutti gli hegeliani. Venne inoltre imposta una
rigidissima censura su tutte le pubblicazioni e la persecuzione dei dissidenti crebbe in
maniera esponenziale. L’acme fu raggiunto con la destituzione dal ruolo di insegnate di
Bruno Bauer nel 1842. Soprattutto a Berlino divenne complesso per i giovani che si
professavano o che almeno simpatizzavano per l’hegelismo concludere il corso di studi88
.
E’ in un simile contesto che nacquero le prime significative frizioni tra le diverse tendenze
dell’hegelismo89
. Frizioni che si trasformavano in aperte e complete rotture quando si
passava dal piano teorico a quello pratico-politico90
.
86 Cfr. Michael Löwy, op. cit. , pag. 50
87 Karl Freiherr vom Stein zum Altenstein (1770-1840), dal 1817 al 1838 ricoprì la carica di ministro
dell’istruzione nel governo prussiano
88 Lo stesso Marx fu costretto a presentare la sua tesi di laurea a Jena
89 Che non a caso Strauss nel suo Streitschriften zur Verteidigung meiner Schrift uber das Leben Jesu aveva
denotato, con un linguaggio di chiara matrice politica, rispettivamente come destra, centro e sinistra.
90 A tal proposito Löwith afferma: "La divisione della scuola hegeliana in hegeliani di destra e di sinistra fu
di fatto resa possibile dalla fondamentale equivocità dei <superamenti> dialettici di Hegel, che potevano
essere interpretati tanto in un senso conservatore quanto in un senso rivoluzionario". Cfr. Karl Löwith, Da
Hegel a Nietzsche, La frattura rivoluzionaria nel pensiero del secolo XIX, Einaudi, Torino 2000, pag. 114
45
Le tendenze di destra " volevano conservare, con l'idea dell'unità della natura divina ed
umana, tutta quanta la storia evangelica", il centro soltanto una parte, la sinistra finiva per
sostenere che "partendo dall'Idea, le notizie storiche dei Vangeli non si potevano
mantenere né in tutto né in parte"91
. Nel panorama universitario, ricopriva una posizione
considerevole una libera associazione di giovani dottori, denominata Doktorclub, animata
da filosofi del calibro di Bauer, Koppen, Rutenberg e Marx. Il Doktorclub, ispirandosi agli
elaborati di Heine, faceva propria l'eredità hegeliana attraverso una commistione tra
svariati elementi della filosofia classica tedesca e i principi della rivoluzione francese,
ergendo la ragione a facoltà normativa verso cui la realtà deve per forza di cose adeguarsi.
La filosofia doveva in questo senso ricoprire il ruolo di critica delle condizioni politiche
esistenti. Una simile impostazione non poteva non sfociare in un vivo interesse per la
politica. Da ciò si spiega il perché essi abbiano ricondotto la questione del contrasto tra
filosofia e religione all'analisi dello Stato, e non l'abbiano affrontata su di un piano
puramente teoretico. Da Hegel appresero che la filosofia era destinata a " comprendere ciò
che è [...] perché ciò che è, è la ragione"92
, e che alla fine del percorso filosofico il
risultato da raggiungere era il mostrare come stesso Stato fosse " immagine e realtà della
ragione"93
. Un simile risultato finiva immediatamente per generare un nuovo compito.
In ultima analisi, il problema che ora la filosofia doveva risolvere era quello di individuare
cosa fosse razionale nel reale, partendo dall'analisi della realtà pensata come razionale.
In altri termini, bisognava comprendere quali elementi presenti nella realtà dell'epoca
fossero conformi allo sviluppo della razionalità dello Spirito.
Come abbiamo detto, Hegel afferma che ciò che è reale è razionale e ciò che è razionale è
reale94
. Se ci si attesta sulla prima parte dell'enunciato si finisce inevitabilmente nel
giustificazionismo storico, e in un atteggiamento conservatore. Se invece si fa leva sulla
seconda parte, allora si cerca di superare ciò che ormai è totalmente irrazionale nello
sviluppo dello spirito.
Per Marx, solo con la riformulazione dell’impostazione dettata da Hegel si può arrivare a
cogliere il reale nella sua vera forma. A ben vedere, si cadrebbe in un pernicioso errore se
identificassimo la consequenziale volontà di cambiamento della realtà che scaturisce da
quanto detto, con temi politici presenti nel Marx maturo. I termini in cui la questione è
91 Cfr. Karl Löwith, op. cit. , pag. 89-90
92 Cfr. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, op. cit. § 15
93 Cfr. Ivi, § 360
94 Cfr. Ivi, § 14
46
posta, lo ripetiamo ancora una volta, è legata all’atmosfera culturale hegeliana, a cui
rimane legato anche durante la stesura della Sacra famiglia, ove torna sul difetto della
nozione di idea così come concepita dall’idealismo, e sul carattere di separatezza che non
riesce a dar conto della effettiva ricchezza delle determinazioni. In tal senso è celebre il
passo nel quale viene mostrato il dispositivo speculativo hegeliano: “Se io, dalle mele,
pere, fragole, mandorle - reali - mi formo la rappresentazione generale «frutto», se vado
oltre e immagino che il «frutto» - la mia rappresentazione astratta, ricavata dalle frutta reali
- sia un'essenza esistente fuori di me, sia anzi l'essenza vera della pera, della mela, ecc., io
dichiaro - con espressione speculativa - che «il frutto» è la «sostanza» della pera, della
mela, della mandorla ecc. Io dico quindi che per la pera non è essenziale essere pera, che
per la mela non è essenziale essere mela. L'essenziale, in queste cose, non sarebbe la loro
esistenza reale, sensibilmente intuibile, ma l'essenza che io ho astratto da esse e ad esse ho
attribuito. [...] [L'hegeliano] vede nella mela la stessa cosa che nella pera, e nella pera la
stessa cosa che nella mandorla, cioè «il frutto». Le particolari frutta reali non valgono piú
che come frutta parventi, la cui vera essenza è «la sostanza». [...] Questo avviene, risponde
il filosofo speculativo, perché «il frutto» non è un'essenza morta, indistinta, immobile, ma
un'essenza vivente, auto-distinguentesi, in moto […]. Le diverse frutta profane sono
estrinsecazioni vitali diverse dell'«unico frutto», sono cristallizzazioni che «il frutto» stesso
forma. Il filosofo […] ha compiuto un miracolo, ha prodotto dall'essere intellettuale irreale
«il frutto», gli esseri naturali reali, la mela, la pera, ecc.; cioè, dal suo proprio intelletto
astratto - che egli si rappresenta come un soggetto assoluto esistente fuori di sé – […] ha
creato queste frutta”95
. A questa problematica descrizione che potremmo definire di
creazione dell’idea, si affianca il processo di ritorno al reale. Come si “ritorna”
dall’astrazione alla molteplicità del concreto? Non che una simile operazione sia di per sé
impossibile. Ma la forma dialettica utilizzata impedisce questo atto di ritorno, finendo per
considerare il molteplice come ambito del darsi, del porsi del generale come particolare,
dunque come atto di auto-differenziazione del generale nel particolare. Così, non solo
l’astratto rimane tale, ma anche il particolare reale finisce per acquisire un carattere
distorto, “un significato soprannaturale”96
. Se la nascita dell’idea hegeliana viene spiegata
con un richiamo al processo dell’astrazione, la successiva attribuzione di realtà alla stessa
astrazione la si ottiene ricorrendo all’isolamento della determinazione e del predicato dal
sostrato a cui inerisce. Mentre nella Critica Marx aveva considerato l’astrazione come
95 Cfr. Meoc, Karl Marx, La sacra famiglia, Vol. IV, pagg. 62-3-4
96 Idem
47
l’operazione del distacco del predicato dal soggetto che presuppone l’esistenza stessa del
predicato, qui egli fa appello più espressamente ad un processo di formazione dell’idea
generale ricavabile dalle realtà concrete particolari. Ma questo non impedirebbe ad Hegel,
“malgrado il suo peccato originale speculativo”, di offrire entro l’esposizione speculativa
“una esposizione reale”97
che coglie la cosa stessa così come essa si presenta nel concreto,
come nel caso della descrizione dei rapporti umani. La nuova dialettica ha il compito di
riprendere il tema dell’alienazione e dell’emancipazione dell’uomo sfruttando la possibilità
teorica dischiusa da Proudhon98
di applicare la dialettica rovesciata in economia politica, e
mettendola al servizio di una nuova figura della storia: il proletariato. Si tratta di sapere
“che cosa esso è e che cosa esso sarà costretto storicamente a fare in conformità a questo
suo essere”99
. L’affermazione che abbiamo riportato, forse meno celebre di altre coniate in
questo periodo giovanile, mostra chiaramente come Marx ancora non avesse una reale
conoscenza di ciò che denotava con il termine proletariato, e che il modello analitico a cui
si richiama ha un robusto connotato ontologico, tramite cui il proletariato è già pre-
investigato e pre-definito come un soggetto il cui concetto va 1etto in conformità alla
propria essenza ipostatitizzata, che in sé già ingloba le determinazioni eterologiche dei
predicati di attribuzione, includendo così di fatto il concreto-storico che esso è chiamato a
realizzare. E la teoria, se vuole essere all’altezza della storia, deve riuscire a rendere
pensabile ed intelligibile una realtà che si è compreso essere stata mistificata da un’analisi
speculativa. Siamo così risospinti nuovamente sul terreno della logica.
II Una approssimazione alla dialettica: opposizione e contraddizione
Dobbiamo quindi orientare la nostra indagine sul sentiero della dialettica, delucidandone lo
statuto teorico. Ma partiamo da un assunto fondamentale, formulato con estrema chiarezza
da Mario dal Pra: “Si può certo riconoscere che lo sviluppo del pensiero di Marx non è al
97 Ibidem, pag. 215
98 Marx riconosce a Proudhon grandi meriti. Tra questi, l’aver preso sul serio i rapporti economici
descrivendoli e rappresentandoli così come essi stessi sono, Cfr. Ibidem pag. 34. Ben presto però, Marx
cambierà radicalmente idea. Sul rapporto tra Marx e Proudhon cfr. Henri Arvon, L'anarchismo, Casa editrice
D'Anna, Messina-Firenze 1973; Hans Magnus Enzensberger, Colloqui con Marx ed Engels, Einaudi, Torino
1977
99 Ibidem, pag. 38
48
riguardo rigorosamente monolitico ed univoco; e se la dialettica è sempre presente nelle
sue pagine, dalla Tesi di dottorato al Capitale, non è ovunque presente allo stesso modo e
con una formulazione rigorosamente identica”100
. Potremmo aggiungere a questa lucida
considerazione che la stessa intensità dell’uso della dialettica è mutevole: assai evidente
nei Manoscritti del ‘44 e nella Critica della filosofia hegeliana, quasi assente nei lavori
successivi fino alla Miseria della filosofia; tornata in uso nell’introduzione a Per la critica
dell’economia politica del 1857, e fortemente presente nei Grundrisse. Solo chiarendone
però la portata e lo statuto teorico, possiamo comprendere cosa Marx intenda per dialettica
e che cosa significa propriamente accettare una logica dialettica101
. La difficoltà principale
rimane quella della comprensione della sua nozione essenziale, cioè quella di
contraddizione. Massimo Mugnai ha pensato la contraddizione come una effettiva
contraddizione logica! E’ noto infatti che secondo la logicistica l’uso logico dialettico della
contraddizione denota un atteggiamento antiscientifico, in quanto, secondo la celebre
definizione dello Pseudo-Scoto, a contradictoriis sequitur quodlibet. D’altronde, lo stesso
Karl Popper, uno dei più grandi detrattori dell’uso logico della dialettica, ha chiamato in
causa proprio il principio pseudo-scotiano per bollare il marxismo come una pseudo-
scienza102
.
Anche tra le file del marxismo molti autori hanno respinto, con finalità eterogenee e per
certi versi extra-filosofiche, l’uso della contraddizione intesa in termini strettamente logici.
Tra questi, Lucio Colletti, richiamandosi apertamente alla distinzione kantiana di
opposizione reale e opposizione logica o contraddittoria, ha posto l’accento sul fatto che le
scienze procederebbero non per contraddizioni dialettiche, ma per opposizioni reali:
“Poiché ciò che i Diamatiker presentavano e presentano come contraddizioni nella realtà,
sono in effetti contrarietà cioè opposizioni reali e, dunque, non-contraddizioni, il marxismo
può e deve continuare a parlare di conflitti e di opposizioni oggettive nella realtà, ma senza
che per questo esso debba rivendicare a sé (e, tanto meno, cercare di imporre alla scienza)
una propria logica speciale (la dialettica) a differenza e contro la logica seguita dalle
100 Cfr. Mario Dal Pra, La dialettica in Marx: dagli scritti giovanili all'Introduzione alla critica
dell'economia politica, Laterza Bari,1965, pag. IX
101 Come ha fatto Massimo Mugnai; Cfr. Massimo Mugnai, Il mondo rovesciato: contraddizione e valore in
Marx, Il Mulino, Bologna, 1984, pag. 67
102 Cfr. Karl Popper, Congetture e confutazioni: lo sviluppo della conoscenza scientifica, Il mulino, Bologna
1972, pag. 539
49
scienze che esistono”103
. La contraddizione è solo ed esclusivamente logica, del pensiero.
E quindi parlare di una realtà autocontraddittoria sarebbe un non-senso104
. La
contraddizione non riguarderebbe la natura né i conflitti nella società. Dunque nessun
processo reale avrebbe un carattere contraddittorio. La negazione, l’annullamento insito
nella opposizione reale sarebbe di un genere affatto diverso da quello della contraddizione,
poiché gli opposti reali sarebbero entrambi positivi-reali e non poli negativi105
.
Sarà bene individuare i luoghi dove Marx parla di opposizione, per comprenderne il
significato. Partiremo dalla Critica della filosofia hegeliana del diritto, dove Marx procede
alla distinzione di tre differenti concetti di opposizione: una opposizione che si verifica
all’interno di una data essenza; una per astrazione e conseguente ipostatizzazione; una in
cui sono in gioco estremi reali106
. Nel primo caso trattasi di una opposizione tra maschio e
femmina in quanto termini interni allo stesso genere, alla stessa essenza, e di questa
essenza sono determinazioni differenziate. Nel secondo caso e nel terzo caso, quelli delle
opposizioni di estremi reali, abbiamo di fronte due enti con una differenza di esistenza
(polo e non-polo) colti rispettivamente in astratto e in concreto.
Mentre nel primo caso entrambi i termini erano attivi ed equivalenti per grado di forza
nell’opposizione, nel terzo,e di conseguenza anche nel secondo, uno dei due termini
prevarica, e sotto due rispetti: dei due solo uno dei termini può essere posto come il cardine
dell’opposizione, di cui l’altro è mera opposizione; uno dei due termini riesce a sopraffare
l’altro.
103 Cfr. Lucio Colletti, Intervista politico-filosofica, Laterza, Roma-Bari 1974, pag. 94
104 Cfr. Lucio Colletti, Tramonto dell’ideologia, Laterza, Roma-Bari 1980, pag. 89
105 Colletti ha insistito a lungo sul fatto che vi sarebbero due Marx, quello della prefazione al Capitale, che si
presenta come il continuatore dell’economia politica come scienza inaugurata da Smith e Ricardo, e un altro,
critico di questa scienza, che intreccia il discorso dei due autori sopra menzionati con una teoria
sull’alienazione dell’uomo. Cfr. Lucio Colletti, Intervista politico-filosofica Op. Cit. pag. 100. L’idea di un
Marx sdoppiato ha affascinato non pochi autori, e, per così dire, la doppiezza ha riguardato ambiti molti
diversi. Ad esempio Guido Carandini ha insistito su questo carattere tentando di separare un Marx scienziato
da uno utopista. Cfr. Guido Carandini, Un altro Marx: lo scienziato liberato dall’utopia, Laterza, Roma,
2006
106 “Per ciò che concerne il primo punto, polo nord e polo sud sono entrambi dei poli; la loro essenza è
identica […]. Nord e sud sono opposte determinazioni di un’unica essenza: la differenza di un’essenza al suo
più alto punto di sviluppo. Sono l’essenza differenziata. Sono ciò che sono soltanto come una determinazione
differenziata, e cioè come questa differenziata determinazione dell’essenza. Veri reali estremi sarebbero il
polo e il non-polo […]. La differenza è qui una differenza dell’esistenza; là una differenza dell’essenza, di
due essenze”). Cfr. Meoc, Dalla critica della filosofia hegeliana del diritto, vol. III, pag. 100
50
Dunque solo nel primo caso abbiamo vera opposizione, perché solo in esso abbiamo
correlazione all’interno di una medesima essenza, e questo porta ad una non
subordinazione dei due termini.
Ecco dunque mostrata la differenza con la Realrepugnanz di Kant. Infatti per il filosofo di
Königsberg le forze che si oppongono all’interno della Realrepugnanz sono entrambe reali
e salde all’interno di un genere.
Ma soprattutto, queste pagine ci aiutano a comprendere un carattere del lavoro intellettuale
di Marx da cui non si può prescindere: quello del conflitto. Marx sta pensando ad una
opposizione reale, che vada oltre le soluzioni elaborate da Hegel. Infatti il filosofo aveva
attribuito all’opposizione tra estremi reali delle proprietà relative all’opposizione interna ad
un genere. E questo porta, secondo Marx, ad una mistificazione del carattere essenziale
della lotta reale, una lotta in cui i due termini sono coinvolti in un conflitto che può dirsi
reale perché entrambi i termini risoluti alla lotta rischiano di perire. Hegel invece aveva
voluto mantenere il conflitto dei termini solo all’interno di un medesimo genere, cosicché
il conflitto stesso possa essere mediato e risolto senza il decadere di uno dei due
contendenti. Sempre nella Critica della filosofia hegeliana del diritto Marx rivendica
l’esigenza di costruire una logica peculiare dell’oggetto che di volta in volta è sottoposto
all’analisi. Emerge in queste pagine la necessità di elaborare una logica, una struttura
razionale che rifletta e comprenda il movimento e lo sviluppo del fenomeno considerato,
definito da Marx logica della cosa107
, cioè come una costruzione mentale svolta secondo la
cosa stessa, in opposizione a quella cosa della logica, che coincide con la dialettica
hegeliana. Il pensiero deve regolarsi secondo la natura della cosa, comprenderne l’attività
secondo la sua specifica natura.
Marx non si appaga di rilevare l’esistenza di contraddizioni nella realtà: egli vuole
comprenderne la genesi e la necessità e per questo vuole fondare una “logica specifica
dell’oggetto specifico”108
. Solo nella comprensione dell’oggetto e delle sue proprietà
empiriche si può comprendere lo sviluppo delle relazioni di questo oggetto109
. Per farlo
però ha bisogno di pensare alla contraddizione logica.
L’impostazione di Colletti sembra quindi non essere del tutto convincente.
Sotto un determinato aspetto, la posizioni di Mugnai sembra più probante. E’ noto che nel
suo Il mondo rovesciato, ha insistito particolarmente su una visione della dialettica di tipo
107 Ibidel, pag. 19
108 Ibidem, pag. 103
109 Ibidem, pag. 101 e ss.
51
processuale, costantemente in divenire, la cui molla è il conflitto. A tal proposito, un passo
dei Manoscritti del ‘44 sembrano venire in aiuto per comprendere il senso del concetto di
opposizione: “Il rapporto della proprietà privata è lavoro, capitale e nesso di entrambi. Il
movimento che hanno da percorrere questi elementi è: Primieramente – l’unità immediata
oppure mediata dei due. Capitale e lavoro sono da prima ancora uniti: poi invero sono
separati e resi estranei, ma reciprocamente si sostengono e sollecitano come condizioni
positive.
[In secondo luogo -] Opposizione di entrambi: essi si escludono vicendevolmente:
l’operaio conosce il capitalista come la propria inesistenza e viceversa. Ognuno cerca di
togliere all’altro la sua esistenza.
[In terzo luogo - ] Opposizione di ognuno contro se stesso. Capitale = lavoro accumulato =
lavoro. Come tale, si scompone in sé e nei suoi interessi, come questi, di nuovo, in
interessi e profitto. Sacrificio continuo del capitalista […]. Lavoro decomposto in sé e nel
salario. Collisione di reciproche opposizioni”110
.
Certo è che l’esempio portato da Mugnai è davvero paradigmatico: qui possiamo
constatare davvero cosa voglia dire accostarsi all’economia politica con l’armamentario
filosofico. Molto spesso si è guardato a questi Manoscritti come al primo grande
laboratorio del Capitale. Categorie e concetti presenti sono sembrati, a prima vista, gli
stessi: proprietà privata, salario, operaio, capitale, merce, denaro ecc. Ma quello che forse
rende ancora più suggestiva la lettura di queste pagine è l’uso esplicito, quasi provocatorio,
della terminologia filosofica nell’approccio al mondo dell’economia. Per la prima volta
Marx studia l’economia politica e i suoi autori classici, entrando in un campo a lui del tutto
estraneo. La filosofia qui non fa semplicemente da filtro. Essa è invece lo strumento con il
quale egli ingaggia questa battaglia.111
E la battaglia nasce dalla constatazione che all’analisi condotta nel campo dell’economia
nei termini posti dagli autori dell’economia politica sfugga da sempre un presupposto,
oseremmo dire il presupposto, il fondamento (tanto per rimanere in termini filosofici). La
presa d’atto dell’esistenza di un campo e di una modalità specifica di analizzarlo passano
entrambe sotto un terzo aspetto, quello della critica non tanto dell’esistenza quanto del
modo con il quale il primo è investigato. E’ in fondo la genialità di Marx. D’altra parte egli
110 Ibidem, pag. 316
111 Ha osservato con lungimiranza Louis Althusser che questo Marx, “prima della rottura, e per consumarla,
avesse sentito il bisogno di dare alla filosofia tutte le sue possibilità, l’ultima possibilità” cfr. Louis Althusser,
Op. cit. pag. 137
52
ha una sua eredità intellettuale, meglio ancora un suo bagaglio culturale, e con esso tenta
un’investigazione, destinata al naufragio. Detto in altri termini, quando egli scopre questo
nuovo campo, quello economico, egli non rompe con la propria impostazione di pensiero
né con la stessa problematica di fondo che la caratterizzava bensì tenta una sorta di
traslitterazione di questa nella nuova.
Dicevamo poc’anzi che l’economia politica avrebbe omesso dalle proprie analisi un tema
fondamentale, e che il suo stesso esistere può considerarsi come la storia di un’ assenza. E’
forse il lavoro alienato ciò che manca e che porta, con la propria privazione, a tutti i
fraintendimenti della teoria economica? Con l’individuazione del carattere obnubilato
dall’economia politica si potrebbe ricostruire la storia dell’uomo, lo scandalo della
produzione capitalistica che da un lato genera ricchezza e dall’altro consegna i produttori
reali alla pauperizzazione. Posto l’uno come la negazione dell’altro e per questo in una
correlazione immediata e mediata, capitale e lavoro in un primo tempo sono da
considerarsi uniti e opposti, e successivamente separati, come la storia insegna. Ma in
questa loro scissione essi rimangono altresì relati nell’unica possibile relazione che si da in
una antinomia: quella dell’opposizione reciproca. La posta in gioco è dunque la loro stessa
esistenza, e in questa opposizione il lavoro finisce per scomporsi in sé e nel salario, mentre
il capitale, almeno non esplicitamente, rimane indiviso. Forse Marx crede che la
scomposizione sia la conseguenza in senso temporale, e la condizione in senso logico della
subalternità del lavoro al capitale. Ed è per questo che conclude il passo con la collisione di
opposizioni reciproche.
Sinora il conflitto tra capitale e lavoro è designato dal carattere di opposizione (Gegensatz).
Non v’è ancora alcuna menzione della contraddizione (Widerspruch). Ma non dobbiamo
arrivare a conclusioni affrettate. Basta sfogliare le pagine dei Manoscritti per trovare un
passaggio in cui il Widerspruch è presente. Si legge: “ Ma l’opposizione fra non-proprietà
e proprietà è un’opposizione ancora indifferente, non còlta nella sua relazione attiva, nel
suo rapporto interno, e non ancora come contraddizione, finchè non è concepita come
opposizione di lavoro e capitale. Anche senza il progredito movimento della proprietà
privata, nell’antica Roma, nella Turchia ecc., questa opposizione può esprimersi nella sua
prima forma: e così essa non appare ancora come posta dalla proprietà privata stessa. Ma il
lavoro, l’essenza soggettiva della proprietà privata, in quanto esclusione della proprietà, e
il capitale, il lavoro oggettivato, in quanto esclusione del lavoro, sono la proprietà privata
come sviluppato rapporto di contraddizione e però rapporto energico, motivo di
53
risoluzione”112
. Ora è chiaro che solo nelle formazioni sociali in cui sussiste l’opposizione
tra capitale e lavoro, il conflitto è da interpretarsi nei termini di una vera e propria
contraddizione. Essi infatti mostrano l’intimo nesso che li unisce, quella relazione attiva in
rapporto con il proprio interno che li pone in un reciproco contrasto in cui i termini si
respingono a vicenda pur sussistendo solo in quel legame, contraddittorio, senza il quale
essi non sarebbero ciò che sono. Possiamo qui fissare con chiarezza due concetti: in primo
luogo Marx utilizza con irrefutabile chiarezza la nozione di contraddizione di Hegel; in
secondo luogo, la nozione di opposizione utilizzata nei Manoscritti e nella Critica della
filosofia hegeliana del diritto indica un tipo di conflitto che non sviluppa ancora una
contraddizione oppure un’opposizione che non conoscerà mai uno sviluppo in tal senso.
A questo punto non possiamo eludere la domanda circa l’origine degli opposti, e a questa
far seguire una riflessione circa l’uso di queste nozioni così come le abbiamo ora delineate.
Dobbiamo cominciare dalle nozioni presenti nei Manoscritti del ‘44, ove è scritto con
chiarezza che proprio in seguito alla separazione dell’operaio dalla natura, espropriata dai
capitalisti e dai proprietari fondiari, l’operaio per sopravvivere deve lavorare. L’operaio,
giuridicamente libero, è costretto economicamente a vendere se stesso113
al capitalista.
L’operaio diventa merce, “la più miserabile merce”, “ente disumanato sia spiritualmente
che fisicamente”, “ la merce auto-cosciente e automatica, […] la merce umana ”114
. Il
termine lavoro è utilizzato in due accezioni: una con la quale indica il lavoro in una
situazione sociale fondata sulla proprietà privata, e qui affianca alla parola lavoro il
termine estraniato; in una seconda accezione Marx parla di un lavoro consapevole, come
una attività libera: è il lavoro in una società che ha abolito la proprietà privata115
.
Ma a differenza del lavoro estraniato teorizzato negli Estratti da James Mill, Marx in
questo lavoro concepisce il lavoro estraniato come lavoro salariato. Parlando del capitale si
chiede innanzitutto, proprio come prima domanda: su che cosa si fonda il capitale e come
si diventa proprietari di capitali produttivi? Marx qui si accontenta della risposta fornitagli
da Say e cioè: per eredità.
112 Cfr. Meoc, Op. Cit., pag. 320-1
113 Qui Marx non ha capito ancora che vende la forza-lavoro. E di certo non è una differenza che sul piano
teoretico conti poco.
114 Ibidem, pag. 296
115 “attività completamente estranea a se stessa, all’uomo e alla natura, e perciò alla coscienza e alle
manifestazioni vitali” Cfr. Ibidem, pag. 301
54
Dopo questa breve digressione, torniamo a chiederci a quale delle tre opposizioni indicate
nella Critica alla filosofia del diritto di Hegel si fa riferimento? Di certo alla seconda e
soprattutto alla terza. Avevamo visto inoltre che bisognava studiare un approccio in grado
di tenere conto dell’oggettualità e delle relazioni antagonistiche in cui un ente è inserito.
Questa concezione però, già a partire dall’ Ideologia tedesca, sembra modificarsi. Non
sembra però pensarla così Mugnai, il quale ritiene che proprio in quest’opera Marx elabori
uno “schema generale di sviluppo della società che mantiene uno stretto rapporto con idee
e concezioni caratteristiche della dialettica hegeliana. E per di più si tratta di uno schema
che rimarrà invariato, in alcuni tratti essenziali, fin nelle opere della maturità”116
.Questo
non sembra essere del tutto esatto. Ma analizziamo le cose in modo preciso.
I temi centrati da Mugnai in questo paragrafo sono: il rapporto di questo schema storico,
rapporto quasi derivato e comunque similare, con la concezione dialettica hegeliana; lo
schema stesso scandito da fatti storici individuati da Marx. Partiamo da quest’ultimo. Qui
il richiamo è chiaramente al rapporto di concatenazione tra i vari modi di produzione
presentati nell’ Ideologia tedesca. Sappiamo già che il manoscritto venne riordinato in un
determinato modo da Rjazanov117
per finalità politiche precise. E la prima parte, quella che
parlava di Feuerbach e alla quale seguivano i risultati raggiunti da Marx nella sua
investigazione, in realtà era l’ultima, e tra l’altro, a detta dello stesso Engels, la critica al
filosofi tedesco rimase incompleta. Sarebbe semplicistico pensare che lo schema lì presente
sia rimasto identico nell’evoluzione del pensiero di Marx, e questo per una serie di ragioni
che affronterò, facendo parlare lo stesso autore. Ma per capirne il cambiamento, dobbiamo
tornare alla prima osservazione di Mugnai, quello sullo schema generale di sviluppo della
società. In effetti e a ben vedere, Marx nell’Ideologia tedesca per descrivere i concetti di
processo e mutamento storico porta in causa il rapporto tra le forze produttive e mezzi di
relazione118
. Nello sviluppo delle forze produttive “si presenta uno stadio nel quale
vengono fatte sorgere forze produttive e mezzi di relazione che nelle situazioni esistenti
fanno solo del male”119
. La contraddizione di questo rapporto porta ad una fase di
116 Cfr. Massimo Mugnai, Op. Cit., pag. 87
117 Sui successivi approcci filologici all’ Ideologia tedesca cfr. Marcello Musto, Vicissitudini e nuovi studi
dell’Ideologia tedesca, in Critica Marxista, 6, 2004
118 Marx non utilizza ancora il termine rapporto di produzione
119 Cfr. Meoc, Ideologia Tedesca, vol. V, op. cit. , pag. 37
55
collisione che sfocia in una rivoluzione. Per questo, “tutte le collisioni della storia hanno la
loro origine nella contraddizione tra le forze produttive e la forma di relazioni”120
.
“Queste diverse condizioni, che appaiono dapprima come condizioni della manifestazione
personale e più tardi come delle catene per essa, formano in tutto lo sviluppo storico una
serie coerente di forme di relazioni, la cui connessione consiste in questo, che al posto
della forma di relazioni precedente, diventata una catena, ne viene sostituita una nuova,
corrispondente alle forze produttive più sviluppate e quindi al modo più progredito di
manifestazione personale degli individui, e questa forma à son tour diventa poi una catena
e quindi viene sostituita con un’altra. Poiché ad ogni stadio queste condizioni
corrispondono allo sviluppo contemporaneo delle forze produttive, la loro storia è altresì la
storia delle forze produttive che si sviluppano e che sono riprese ad ogni nuova
generazione, e pertanto è la storia dello sviluppo delle forze degli individui stessi”121
.
Per capire il passaggio di campo e metodologico, insomma la rottura consumata con
l’idealismo, in nome di un empirismo esasperato e a tratti riduzionista, possiamo partire da
un testo del 1847. A due anni dal “taglio” (che, lo ricordiamo, Althusser colloca nel 1845)
di fronte ad un problema apparentemente vecchio, afferma: “C’è da meravigliarsi forse se,
eliminando a poco a poco tutto ciò che costituisce l’individualità di una casa, facendo
astrazione dai materiali di cui essa si compone, dalla forma che la distingue, voi arrivate a
non avere più che un corpo; se facendo astrazione dai contorni di questo corpo, ben presto
non avrete più che uno spazio; e se facendo infine astrazione dalle dimensioni di questo
spazio, finirete per non avere più che la quantità in sé, la categoria logica? A forza di
astrarre in questo modo, da ogni soggetto, da tutti i pretesi accidenti, animati o inanimati,
uomini o cose, abbiamo certo ragione di dire che, in ultima astrazione, si arriva ad avere
come sostanza soltanto le categorie logiche. Così i metafisici, i quali, facendo queste
astrazioni, si immaginano di far dell’analisi, e che, a misura che si staccano sempre più
dagli oggetti, si immaginano di avvicinarsi a loro fino a penetrarli, questi metafisici hanno
a loro volta ragione di dire che le cose di quaggiù sono dei ricami, di cui le categorie
logiche formano l’ordito. Ecco ciò che distingue il filosofo dal cristiano. Il cristiano
conosce una sola incarnazione del Logos, a dispetto della logica; il filosofo non la finisce
più con le incarnazioni”122
. Qui non si fa più riferimento all’inversione soggetto-predicato.
Cosa è accaduto?
120 Ibidem , pag. 61
121 Ibidem, pag. 68
122 Cfr. Meoc, Op. cit., vol. VI pag. 170
56
Marx descrive un processo di astrazione errato, ma non lo fa più tenendo presente
l’inversione.
Critica in Proudhon il procedimento di astrazione con la quale ogni cosa viene ridotta a
categoria logica, depurando gli elementi costitutivi dell’individualità per creare una figura
astratta.
Marx è dell’avviso che mettendo insieme la quantità indeterminata che è un’astrazione,
con lo spazio che è un’altra astrazione, con una terza astrazione che è la corporeità e con
una quarta astrazione che è costituita dal concetto dei materiali di cui è fatta una casa, non
si ottenga affatto una casa reale nella quale abitare, ma soltanto una casa astratta, cioè
l’astrazione o il pensiero di una casa. L’astrazione, invece di raggiungere il reale per altra
via, riduce questo reale stesso a pura categoria logica. L’errata concezione del ruolo della
logica porta Proudhon ad avere una falsa rappresentazione delle categorie economiche. Ma
in quest’opera non si fa nemmeno più menzione non solo del cattivo uso della logica
dialettica hegeliana, ma nemmeno della prefigurazione hegeliana del processo del lavoro
come autoproduzione dell’uomo. Si è dunque passati da una concezione per la quale la
categoria hegeliana del negativo svolgeva un ruolo determinante, ad un’altra concezione
che individua negli intricati rapporti produttivi materiali il motore del reale. Da questa
scoperta fondamentale ogni aspetto analitico, sia esso in ambito logico, ontologico,
epistemologico ecc. , cambia radicalmente.
L’attenzione di Marx si è insomma spostata dal piano filosofico a quello economico-
storico, poiché Marx si accorge che “la storia non procede per categorie, la determinazione
della categoria non può farsi a priori, rispetto allo sviluppo storico, ma in sua funzione”123
124.
Le categorie economiche “non sono che le espressioni teoriche, le astrazioni dei rapporti
sociali di produzione”125
. L’astrazione non può essere arbitrariamente condotta come atto
di separazione dai rapporti materiali cui necessariamente corrispondono e di cui sono, in
ultima analisi, espressioni. E’ ciò che fa Proudhon nella sua opera. Solo questa è la vera
origine delle categorie economiche.
E queste hanno un carattere storico, dettato dallo sviluppo del rapporto tra forze produttive
e le forme sociali in cui esse sono inserite.
123 Cfr. Mario Dal Pra, Op. cit. , pag. 258
124 A tal proposito Cfr. Meoc, Vol. XXXVIII, Op. Cit., pag. 459, dove Marx definisce l’economia politica
come una scienza storica che comprende gli sviluppo economici.
125 Cfr. Meoc, Op. cit. , vol. VI, pag. 172-3
57
L’esigenza che ora si impone è quella di considerare le categorie economiche come
espressioni teoriche dei rapporti di produzione, di non conferir loro, in quanto formule,
portata reale e di muover piuttosto dal piano contenutistico, a differenza di ciò che faceva
Proudhon, che finiva così per trasfigurare il concreto in astratto. Ciò vuol dire non già che
non si possano ricavare categorie con uno spettro molto più ampio del singolo dato
empirico, ma che bisogna attenersi alla realtà, individuarne rapporti e nessi effettivi. Un
caso specifico in cui una categoria astratta, cioè mutuata e trasferita in maniera surrettizia
nell’indagine di un fatto, funge da spiegazione ad un fatto reale è quello dell’intervento del
libero arbitrio per la decisione del valore di scambio di una merce.
Qui si fa intervenire un fattore estrinseco a un fatto. Ma non bisogna nemmeno credere che
Marx rimanga un empirista ingenuo. Tutt’altro! Il dato materiale raccolto non va mai
assunto cosi come esso si presenta, ma va sempre indagato. Altro errore criticato da Marx è
quello di utilizzare la contraddizione come categoria, concependola al di fuori del piano
effettivo sociale che la genera, finendo così per fornire, ad un problema concepito
nell’analisi in modo astratto, una soluzione altrettanto astratta. Ma il ruolo dell’astrazione
non viene respinto in toto. Piuttosto l’autore distingue una astrazione che presume di valere
come principio costitutivo della realtà e un’altra che funge da strumento per la
sistemazione dei risultati scientifici della ricerca sulla realtà.
Inoltre è sintomatico l’allontanamento da Feurbach126
. Già a Ruge aveva confessato la sua
insoddisfazione per quella filosofia che “fa troppo riferimento alla natura e troppo poco
alla politica”, vedendo in quest’ultima “l’unica connessione mediante la quale la filosofia
possa diventare una verità”127
.
Ma nel passo della Miseria non si sta parlando di politica, bensì di filosofia. E di filosofia
nei rapporti con una logica. E allora, cosa è cambiato? Marx ha compreso che il problema
su cui faticosamente sta spendendo tutte le sue forze non è nemmeno pensabile con
categorie che gli sono estranee. V’è bisogno di un indagine nuova. E a questa indagine
Marx già pensa nelle Tesi su Feuerbach nel 1845, senza però formulare su quale aspetto di
una cosa bisognerà indagare. Ha solo il sentore che nel reale vi è un questione che sfugge,
e che non è stata ancora individuata. Sarà il lavoro di una vita. L’utilizzazione
dell’inversione di soggetto-oggetto avrebbe il carattere di mero succedaneo. Ma per un
126 Nell’ottobre del 1843 Marx scrisse a Feuerbach due epistole, nelle quali lo esortava a fornire un contributo
critico contro Schelling dalle colonne del Deutsch-Franzosische Jahrbücher. Feurbach declinò l’invito,
deludendo le aspettative del giovane Marx. Cfr. Meoc, op. cit. , vol. , pag. 377 e ss.
127 Cfr. Meoc, op. cit., vol. I pag. 419
58
autore che ha fatto dell’acribia il proprio pregio, ma anche il peggiore dei difetti, questa via
è già preclusa. L’inversione nel 1847 è sparita perché non è più utilizzabile sul problema
nuovo che lo affanna.
E’ questo un passaggio decisivo. Questo ci svela che Marx, obnubilando la categoria
dell’inversione, ha praticamente abbandonato tutti i problemi che essa svelava e risolveva:
l’inversione di astratto e concreto, di determinato e determinante, di soggetto e oggetto.
Prima di giungere a conclusioni affrettate è bene sottolineare, anche per non dar adito a
fraintendimenti, che l’abbandono della categoria dell’inversione è legata principalmente a
un tema nuovo, a cui essa risulta inapplicabile perché incapace di rendere intelligibile la
problematica stessa. In secondo luogo, sarebbe errato dedurne che col suo abbandono
decadano anche i tre temi ai quali essa era applicata e che ho ricordato. O meglio che
decadano tutti. In realtà la questione dell’astratto e del concreto, e di determinato e
determinante, rimangono. Eppure, non vengono più letti in termini di inversione, ma
problematizzati sotto altri rispetti. Invece, per l’inversione fra soggetto e oggetto, la
questione è molto più complessa, poiché essa sembra scomparire del tutto128
.
E’ vero che la contraddizione in Hegel ha un forte riferimento al metodo del calcolo
infinitesimale, come sottolineato da Badaloni129
, e di fatto il filosofo di Stoccarda si è
sforzato, ricavando i fondamenti filosofici del calcolo, di rovesciare quest’ultimo nell’uso
della ragione, rendendolo così dialettico, e la condizione necessaria è riposta nello svanire
del sensibile ed il suo affermarsi come realtà solo in rapporto al fondamento. Ma per il
Marx della Miseria della filosofia questa operazione è da respingere e da condannare. Ora,
chiediamoci che cosa ha spinto Marx ad abbandonare il problema dell’inversione tra
soggetto e predicato. Problema non da poco visto che categorie che prima avevano un
ruolo ben delineato nell’economia del testo e nell’impianto speculativo ora cambiano di
significato oppure svaniscono. Il legame con l’indagine storica è molto serrato: così come
128 Salvo riapparire, in verità, in una pagina del terzo libro del capitale. Ma da qui a dire che il problema del
soggetto- oggetto è presente in Marx è un’esagerazione.
129 Lo svanire del sensibile “dipende dalla assunzione in sede logica di un procedimento simile a quello della
analisi infinitesimale”. Anzi le grandezze infinitamente piccole sarebbero grandezze determinabili solo a
partire da questo sparire. Contro tale concetto “ è stato obiettato e poi sempre ripetuto che tali grandezze o
sono qualcosa oppure non sono nulla; che fra l’essere e il non essere non si dà uno stadio medio […]Anche
qui si ammette la seperazione assoluta tra l’essere e il nulla. Contro di ciò si è invece mostrato che l’essere ed
il nulla son nel fatto lo stesso, o, per parlare secondo quel linguaggio, che non si dà addirittura nulla, che non
sia uno stato medio fra l’essere e il nulla. La matematica deve i suoi brillanti successi nell’aver ammesso
quella determinazione cui l’intelletto contraddice” Cfr. Hegel, Op. Cit. p. 102.
59
era pensata da Hegel e dagli epigoni, essa finisce per diventare una storia di sedicenti idee.
Così si finisce per perdere ciò verso cui si muoveva, cioè la realtà empirica.
In tal senso, oltre ad abbandonare il presupposto per il quale la storia è mossa da un
principio non immanente, le categorie logiche di contraddizione, opposizione, negazione
ecc. sono utilizzate e presenti nell’affresco dello sviluppo storico dei modi di produzione.
Di certo, come evidenza anche Dal Pra, “non compare, come nei Manoscritti, in un
contesto filosofico che faccia esplicito riferimento alla Fenomenologia hegeliana e che
utilizzi la portata logica della negazione come elemento di propulsione del movimento
dialettico; Marx ha costantemente cura, ora, di far emergere gli aspetti reali e determinati
dell’opposizione e della contraddizione e di far scaturire la spinta del movimento storico
reale dall’effettiva posizione di contrasto che in esso si delinea”130
. Per questo la matrice
dell’opposizione in questo testo non è di carattere logico, bensì è ricavata dagli opposti
concreti, a riprova del fatto che, nell’opera della rottura con Hegel, Marx nega qualsiasi
possibilità ad una contraddizione logica, in nome di una concezione empiristica che
esclude qualsivoglia operazione che vada oltre la datità immediata. Perciò Marx non parla
mai di opposizione o di contraddizione in termini generali, ma delle contraddizioni e
opposizioni determinate che si presentano nel corso storico; e se tenta di giungere ad una
prospettiva di ordine più generale, essa viene ricercata non certo in una dimensione logica,
ma ancora in una direzione concretamente storica. La caratterizzazione più generale è data
dalla contraddizione tra le forze produttive e le forme di relazione, poiché ciò si è
manifestato più volte nella storia. Questa sarebbe una contraddizione che è antecedente,
reiterata e sovrastante in potenza le altre. In un certo senso, Marx la considera fonte
originaria delle altre. Eppure c’è un luogo dell’opera in cui Marx torna a parlare della
proposizione speculativa. Dopo aver criticato abbondantemente la fraseologia filosofica, le
espressioni filosofiche tradizionali, egli accenna a quella forma di proposizione che riesce
a cogliere l’identità di soggetto e predicato senza annullarne le differenze ma
esprimendone l’unità in modo armonico, unità in cui il “predicato esprime la sostanza” e
mediante cui “il soggetto stesso viene assorbito nell’universale”131
; e la proposizione
speculativa è inserita nel rapporto teleologico.
Nella visione speculativa si interpreta “la frase finale come perfezionamento della prima
epoca della serie ed i membri intermedi come gradi di sviluppo in ordine ascendenti verso
130 Cfr. Mario dal Pra, Op. cit., pag. 213
131 Cfr. George Hegel, Fenomenologia dello spirito, Bompiani, Milano 2006, pag. 127
60
la frase ultima e perfetta”132
. Questa finalizzazione aprioristica viene respinta da Marx
senza appello, nonostante l’avesse utilizzata nella Critica, seppur in parte, con il concetto
di essenza e il rapporto che essa ha con le qualità dell’uomo, e nei Manoscritti per spiegare
il rapporto tra emancipazione ed alienazione. Dunque questo ribaltamento del rapporto
teleologico è di certo fondamentale e conferma l’allontanamento dall’idealismo sotto un
altro rispetto, oltre a quello già accennato per il quale non l’idea, bensì il reale manifesto è
il punto iniziale della storia: quello della concezione del ruolo e dello status dell’uomo.
Marx vuole ripartire dall’uomo empirico, calato in un determinato contesto storico e
relazionale con altri uomini, in opposizione alla configurazione idealistica. Da qui la
necessità di tornare ad indagare le relazioni umane, a partire dalle attività svolte. Marx ne
individua tre: produzione dell’uomo da parte dell’uomo, mezzi per soddisfare i bisogni,
creazione di nuovi bisogni, senza porli in una successione logica necessaria.
L’essenza dell’uomo, il suo essere sostrato-sostanza, così come concepito nella Critica e
nei Manoscritti per rivendicarne la priorità rispetto allo Stato, alla società civile e alla
famiglia, e per ricondurre lo sviluppo e il pieno dispiegarsi di questi ad essa, viene ora
considerata una astrazione. Non si tratta qui di ribaltare ciò che era stato in precedenza
rovesciato, riponendo l’idea come soggetto e l’uomo come predicato. Marx è andato oltre
questa scelta dicotomica perché è uscito dal terreno del problema hegeliano. Adesso il
problema è il rapporto tra forze produttive e forme di relazioni sociali e non più quello
dell’uomo di Feuerbach133
.
Siamo dunque in un clima radicalmente diverso rispetto a quello della Critica e dei
Manoscritti, dove si nutriva la speranza di poter costruire la logica specifica dell’oggetto
specifico, cioè di poter elaborare una comprensione del reale in cui avesse la sua parte
specifica la ricerca filosofica. Ora, per contro, l’intervento della filosofia viene bandito. E
con esso le categorie di alienazione, essenza, sostanza ecc. poiché considerate troppo
complesse rispetto all’approccio empiristico.
132 Cfr. Meoc, Op. Cit., pag. 266
133 Segno tangibile della condanna del sistema feuerbachiano lo ritroviamo anche in alcune epistole inviata da
Engels a Marx, che dopo aver letto l’ Essenza della religione, afferma : “Ancora una volta non c’è altro che
l’Essenza, l’Uomo ecc.” Cfr. Meoc, Op. Cit., Vol. XXXVIII, pag. 35. “Questo è davvero un capolavoro di
tautologia strombazzata con voce di tuono” Cfr. Ibidem, pag. 36. “ Per un certo senso di ripugnanza finora
non mi sono saputo decidere a fare gli estratti di Feuerbach. Qui a Parigi tutta questa roba mi sembra tanto
insulsa” Cfr. Ibidem, pag. 50
61
Addirittura, in precisa opposizione con quanto teorizzato nella Critica, Marx afferma che
ogni profondo problema filosofico si risolve con la massima semplicità in un fatto
empirico.
Il termine empirico non è più usato, come nella Critica,nella stessa accezione adottata da
Hegel, “ossia come equivalente d’una realtà immediatamente attestata dall’esperienza, ma
bisognosa d’una ulteriore comprensione e spiegazione; ora l’empirico compare come il
termine ultimo ed autonomo della realtà, non più bisognoso d’un significato da ricercare al
di là del suo stesso piano; perciò Marx dichiara che di fronte al rilievo dell’empirico non
c’è più spazio per l’ulteriore posizione di un problema filosofico”134
. Dunque, siamo al di
fuori del problema della filosofia di Feuerbach. L’avevamo visto in precedenza: questi
criticava l’idealismo hegeliano che erroneamente guardava al pensiero come soggetto e
all’essere come predicato; mentre il vero rapporto tra pensiero ed essere non può che essere
il contrario, e coloro i quali non abbandonerebbero questo modo di intendere la filosofia,
non riuscirebbero a rinunciare alla teologia in quanto, muovendosi nel solco tracciato da
Hegel, ricadrebbero nella falsa visione che fa della realtà il risultato, o meglio il positum
dell’idea, “espressione in termini razionali della dottrina teologica, secondo cui la natura è
creata da Dio è l’essere materiale è creato da un essere immateriale, cioè astratto”135
. Marx,
che già in precedenza aveva abbandonato l’hegelismo, esce anche dal sentiero del
materialismo feuerbachiano. Questa via d’uscita dalla filosofia tedesca porta ad un cambio
di significato delle categorie di opposizione, negazione, contraddizione ecc. , largamente
presenti nella delineazione dello sviluppo storico fatta dall’Ideologia tedesca; ma essa non
compare, come nei Manoscritti, in un contesto filosofico che faccia esplicito riferimento
alla Fenomenologia hegeliana e che utilizzi la portata logica della negazione come
elemento di propulsione del movimento dialettico; Marx ha costantemente cura, ora, di far
emergere gli aspetti reali e determinati dell’opposizione e della contraddizione e di far
scaturire la spinta del movimento storico reale dall’effettiva posizione di contrasto che in
esso si delinea. Ma abbiamo visto che in un certo modo la problematica fondamentale di
Marx è cambiata. La logica rifletteva questo cambiamento. Ora bisogna vedere che cosa
accade nel Capitale. Ma prima bisogna ricomporre di nuovo il puzzle perché c’è un
ventennio di ricerche che vanno ricostruite.
III Verso il Capitale
134 Cfr. Mario Dal Pra, Op. Cit., pag. 208-9
135 Cfr. Ludwig Feuerbach, Tesi provvisorie, in Principii della filosofia dell’avvenire, Torino 1948, pag. 62-3
62
Dopo la Miseria della filosofia dovremo attendere ben dodici anni per avere un’altra opera
di carattere prettamente teorico. Dal 1847 al 1859, oltre all’impegno politico, sfociato nella
tragica sconfitta dei movimenti del ’48, Marx si dedicherà con acribia allo studio
dell’economia politica. Le monumentali descrizioni che ci sono pervenute presentano un
Marx dedito a giornate di studio impareggiabili per intensità ed estensione degli argomenti,
lontano ormai dalla sua terra natia, molto arretrata rispetto alla moderna Inghilterra e
comunque arcaico rispetto a buona parte d’Europa. Nonostante tragici e drammatici
episodi famigliari, le disperate condizioni economiche in cui la sua famiglia versava, la
salute cagionevole a causa di una penosa dieta, e fiaccata dalle tremende e febbrili notti di
studi, Marx continua imperterrito nel suo ambizioso progetto: capire il segreto
dell’economia e stendere finalmente la sua grande opera136
.
Dodici anni sono davvero un’eternità, e il tempo non è stato il suo miglior amico.
Tutt’altro137
!
Sarà necessario comprendere che cosa è accaduto e come Marx è arrivato a stendere Per la
critica dell’economia politica. Ci dedicheremo ora alla ricostruzione dei risultati
dell’Introduzione, che, per molteplici e controverse ragioni, Marx non pubblicò mai; così,
confrontandone le novità rispetto al passato, potremo ri-valutare i due paradigmi principali
del marxismo per poi affrontare finalmente il Capitale.
Dunque, avevamo lasciato Marx nella diatriba con Proudhon, e avevamo acquisito due
nozioni cardine inequivocabili: la rottura con Hegel, la sinistra hegeliana e la problematica
che animavano l’idealismo da un lato, e dall’altra il rifiuto del metodo dialettico, diretta
conseguenza del cambio di campo ontologico. Se da giovane aveva guardato all’economia
come una nuova frontiere il cui carattere di intelligibilità era garantito dall’esperienza
diretta con un nuovo mondo, quel mondo che avrebbe modificato, invadendolo, anche ciò
che prima ne era escluso, tuttavia questo nuovo era ancora pensato con linguaggi, metodi e
prospettive vecchie e non del tutto appropriati: i rapporti economici letti in termini di
136 Marx però non smise mai di pubblicare pamphet e articoli, nonché dedicarsi all’impegno politico
137 Marx viveva in condizioni economiche disastrose: senza un lavoro, con molti figli, in una misera casa. Le
infinite peripezie vissute, e un carattere non certo facile (aveva un inclinazione alla polemica insuperabile, al
cui confronto non reggerebbero nemmeno le satire menippee), unite ad un’acribia analitica senza pari,
influenzarono e non poco i tempi e la stesura del suo grande capolavoro, la cui stesura venne interrotta più
volte a causa di terribili malattie o per partecipare a polemiche con diversi suoi contemporanei. Le biografie
di Marx lo mostrano con precisione. Cfr. Franz Mehring, Vita di Marx, Editori riuniti, Roma, 1972; Francis
Wheen, Marx, vita pubblica e privata, Mondadori, Milano, 1999
63
alienazione di un soggetto che fa, produce alienando la propria essenza in altro da sé, in
una oggettualità inerme da cui si era separato; la liberazione che era ritorno all’origine, a
un passato seguito da una caduta di cui il moderno sistema di fabbrica rappresentava il
segno del massimo allontanamento dalla condizione primigenia; insomma, avevamo
lasciato un Marx erede di una metafisica da ribaltare, pur rimanendo all’interno di quel
perimetro. In seguito, la negazione di ogni metafisica aveva portato Marx a posizioni di
radicale empirismo e riduzionismo.
Adesso, dobbiamo però ricostruire quello che potremmo definire il passaggio dei passaggi,
l’anello decisivo che apre la via al progetto di comprensione del modo di produzione
capitalistico, e non solo.
In una lettera ad Engels leggiamo: “Del resto faccio dei bei passi avanti. P.es. tutta la teoria
del profitto, quale è stata finora, l’ho mandata a gambe all’aria. Quanto al metodo del
lavoro mi ha reso un grandissimo servizio il fatto che by mere accident – Freiligrath trovò
alcuni volumi di Hegel appartenenti a Bakunin e me li mandò in dono – mi ero riveduto la
“logica” di Hegel. Se tornerà mai il tempo per lavori del genere, avrei una gran voglia di
render accessibile all’intelletto dell’uomo comune in poche pagine, quanto vi è di
razionale nel metodo che Hegel ha scoperto ma nello stesso tempo mistificato”138
. Desta
stupore il fatto che per caso Marx abbia riletto la Scienza della logica e ne abbia tratto gran
giovamento specie per il metodo espositivo. Tale operazione chiaramente è foriera di
significatività e ambiguità, soprattutto alla luce del fatto incontestabile che egli aveva rotto
proprio con Hegel e che da questa sorta di parricidio139
si era potuto aprire un nuovo
sentiero di ricerca. Fare i conti con la dialettica inoltre non è mai cosa semplice, come è
ammesso nella stessa epistola in riferimento al metodo utilizzato da Lassalle per la sua
opera sul pensiero di Eraclito140
:
138 Cfr. Meoc, Op. Cit., Vol. XL, pag. 273
139 L’espressione parricidio è stata utilizzata ultimamente da Roberto Finelli, che sostiene che Marx avrebbe
consumato un parricidio troppo frettoloso nelle opere giovanili, finendo per generare un parricidio mancato.
Questo atto mancato sarebbe rappresentato dalla questione del soggetto. Marx finirebbe per disconoscere la
realtà degli esseri umani, i loro bisogni ecc. In una parola: Marx negherebbe all’antropologia uno statuto
proprio all’interno delle scienze, e questo porterebbe il filosofo tedesco in una condizione di arretratezza ed
arcaicità rispetto alle scienze contemporanee. Cfr. Roberto Finelli, Un parricidio mancato, Hegel e il giovane
Marx, Bollati Boringhieri, Torino 2004
140 L’opera non è stata tradotta in italiano, ma si possono comunque conoscerne i caratteri teorici, oltreché
studiarne ampli stralci, nell’interpretazione offertaci da Raffaele Marino. Cfr. Raffaele Marino, Lassalle e il
suo Eraclito, saggi di filosofia egheliana, Tipografia dei successori Le Monnier 1865
64
“Si trova un detto di <Eraclito l’oscuro>, in cui, per chiarire il trapassare di tutte le cose nel
loro contrario, dice: <così l’oro si tramuta in tutte le cose, e tutte le cose si tramutano in
oro>. L’oro, dice Lassalle, è qui il denaro (c’est juste) e il denaro è il valore. Dunque
l’ideale è universalità, l’uno (il valore), e le cose sono il reale, la particolarità, la
molteplicità. Questa idea sorprendente la adopera per dare in una lunga nota an earnest of
his discoveries in the science of political economy. Ogni parola è uno strafalcione, ma
presentato con notevole presunzione. Da questa sola osservazione vedo che il tipo ha
l’intenzione di esporre l’economia politica alla Hegel in un suo secondo grande opus.
Imparerà a sue spese che ben altra cosa è arrivare a portare per mezzo della critica una
scienza al punto da poterla esporre dialetticamente, ed altra applicare un sistema di logica
astratto e bell’è pronto a presentimenti per l’appunto di un tale sistema”141
.Sono molteplici
i luoghi dell’epistolario in cui Marx ed Engels, parlano della dialettica, spesso per
metafore, mutuate da Hegel e dalla sinistra hegeliana. Sarà utile per perseguire i nostri fini
compiere una breve digressione sull’argomento.
Tra le diverse metafore utilizzate quella di mettere sulla testa (Auf den Kopft stellen) ha
sicuramente una posizione centrale. Con essa Engels142
e Marx143
denunciavano l’errore di
capovolgimento del rapporto tra il soggetto e il predicato, che portava ad interpretare la
realtà a partire da rapporti ideali144
.Come abbiamo visto in precedenza, se nei testi
141 Cfr. Meoc, Op. Cit., pag. 288
142 Cfr. Meoc, Friedrich Engels, La situazione dell’Inghilterra. Il secolo diciottesimo, Op. Cit. , vol. III, pag.
527
143 Ibidem, pag. 12-3, 15, 144, 181; Cfr. Meoc, Op. Cit., vol. IV, pag. 20, 153, 181, 214
144 L’espressione del mettere sulla testa fu utilizzata dallo stesso Hegel (anche se è difficile stabilire se sia
stata coniata o mutuata da autori a lui precedenti). Nell’introduzione all’ Antiduhring Engels riporta in nota
un passo tratto dalle Lezioni sulla filosofia della storia, relativo alla Rivoluzione francese, dove è presente
questa metafora: "Il pensiero, il concetto del diritto, si fece valere di punto in bianco, né l'antico edificio
dell'ingiustizia poté opporre resistenza alcuna. In nome del diritto è stata proclamata adesso una Costituzione
sulla quale tutto deve poggiare. Da che il sole sta nel firmamento e i pianeti gli girano intorno, non si era mai
visto che l'uomo si rizzasse sulla testa, cioè sul pensiero, e che su questo costruisse la realtà. Anassagora
aveva detto per primo che il nous, la ragione, dirige il mondo; ma solo ora, per la prima volta, l'uomo è
pervenuto a riconoscere che tocca al pensiero dirigere la realtà spirituale. È stato un meraviglioso levar del
sole. Tutti li esseri pensanti hanno solennizzato quest'epoca. Una sublime commozione ha regnato in
quell'età, un entusiasmo dello spirito ha scosso il mondo, quasi si fosse per la prima volta venuti alla
conciliazione del divino con il mondo"; per concludere: “Non sarebbe tempo di mettere in moto la legge
contro i socialisti nei riguardi di queste pericolose dottrine sovversive del defunto professor Hegel?” Cfr.
Meoc, Friedrich Engels, Antidhuring, Vol. XXV, op. cit., pag. 16. La citazione è individuabile anche nelle
65
giovanili l’uso di questa metafora era molto assidua in quanto essa esprimeva un ruolo
primario nell’apparato analitico marx-engelsiano, tanto da far arrivare a dire al primo che
“la trasformazione del soggetto in predicato e del predicato in soggetto, lo scambio tra il
determinante e il determinato, è sempre la rivoluzione prossima”145
, nei testi della maturità
tende a scomparire.
Nella costellazione delle metafore utilizzate ce n’è una che nella sua finta chiarezza ha
generato più di un fraintendimento, quella del nocciolo e del guscio, strettamente legata
alla prima146
.
In una recensione a Per la critica dell’economia politica, dopo aver elogiato il profondo
spirito storico di Hegel nonostante la pecca della sua forma astratta e idealistica, che finiva
per dare un rapporto “ arrovesciato e con la testa all’ingiù”147
. Engels dichiara: “Marx era
ed è il solo che si poteva accingere al lavoro di estrarre il nocciolo che racchiude le vere
scoperte fatte da Hegel in questo campo, e di stabilire il metodo dialettico spogliato dei
suoi veli idealistici, nella forma semplice in cui è la sola forma giusta dello sviluppo del
pensiero”148
. Lo stesso Marx, nel poscritto alla seconda edizione del Capitale, a proposito
della dialettica, affermò che essa sarebbe in Hegel mistificata, ma che comunque egli fu il
primo ad “esporre ampiamente e consapevolmente le sue forme generali di movimento. In
lui essa sta in piedi sulla testa. Bisogna rovesciarla per scoprire il nocciolo razionale entro
il guscio mistico”149
150
.
La metafora del nocciolo la si ritrova anche in alcune lettere di Engels: In una epistola del
1865 a Friedrich Albert Lange, il quale negava che Hegel avesse una profonda conoscenza
scientifica e matematica, egli risponde: “Naturalmente il nonsenso nei dettagli della
filosofia della natura ve lo concedo volentieri, mentre la sua vera filosofia della natura sta
edizioni italiane di queste opere : Cfr. George W. F. Hegel, Filosofia della storia, Tipografia e libreria
Elvetica,Capolago1840, pag. 535; Cfr. George F.W. Hegel, Lezioni sulla filosofia della storia, Laterza,
Roma-Bari 2008, pag. 362
145 Cfr. Meoc, Nota sulla concezione hegeliana dello Stato, Op. Cit. , vol. III, pag. 144
146 Forse di derivazione hegeliana. Cfr. Mario Rossi, Da Hegel a Marx, 4 voll., Vol. IV, Feltrinelli, Milano
1975, pp. 356-7.
147 Cfr. Meoc, Friedrich Engels, Karl Marx, <Per la critica dell’economia politica>, op. cit., vol. XVI, pag.
478
148 Ibidem, 478-9
149 Cfr. Meoc, Op. Cit., vol. XXXI, pag. 22
150 Nell’edizione francese il passo è modificato: “In lui essa cammina sulla testa; basta rimetterla sui piedi per
trovarle una fisionomia del tutto ragionevole” cfr. Ibidem, pag. 1201
66
nella seconda parte della Logica, nella dottrina dell’essenza, vero e proprio nòcciolo
dell’intera dottrina. La teoria scientifica moderna dell’azione reciproca delle forze naturali
[…] non è altro che un’espressione diversa, o piuttosto la dimostrazione positiva, dello
sviluppo hegeliano attraverso causa, effetto, azione reciproca, forza ecc. Naturalmente io
non sono più hegeliano, ma continuo a nutrire una grande pietà e simpatia per quel vecchio
colossale”151
; in un’altra del novembre 1891 si legge: “In nessun caso però Lei può leggere
Hegel […] per scoprirvi paralogismi e oziosi trucchi che gli servivano da supporto alla
costruzione […]. Assai più importante è scoprire, sotto la forma erronea e nella artificiale
correlazione tra le parti, ciò che è giusto e geniale […]. Il rovesciamento della dialettica in
Hegel si basa sul fatto che essa deve essere <autosviluppo del pensiero>, e perciò la
dialettica delle cose ne è solo il riflesso, mentre la dialettica nella nostra testa è ancora e
soltanto il riflettersi dello sviluppo reale, che si compie nel mondo naturale e umano,
rispondente a forme dialettiche. Confronti lo sviluppo della merce con quello dall’essere
all’essenza in Hegel, e avrà un parallelo perfetto: qui lo sviluppo concreto come risulta
dalle cose, là la costruzione astratta, in cui pensieri altamente geniali e passaggi talvolta
assai corretti, come quello della qualità alla quantità e viceversa, sono elaborati come
apparente autosviluppo di un concetto da un altro”152
. Qui v’è una forte opposizione tra
dialettica dei fatti e autosviluppo del pensiero. Ed è interessante il richiamo del passaggio
dall’essere all’essenza posto in parallelo con la dialettica delle merci153
. Per Engels vi
sarebbe dunque sia una validità generale di una forma specifica della dialettica, da ri-
formulare in un senso aderente allo sviluppo del reale, sia un nucleo della dialettica
hegeliana che è comunque detentore di un contenuto valido. Ma come dovremmo
considerare questa validità? E soprattutto, rispetto a cosa essa contiene un contenuto
valido? Verso il pensiero stesso che ne vidima e ne garantisce l’intelligibilità? In secondo
luogo, come può un pensiero avvolto dall’idealismo centrare contenuti validi per chi aveva
voluto rompere i ponti con l’idealismo stesso, facendo di questo rifiuto motivo addirittura
di vanto154
. Se attingiamo all’immenso epistolario, troviamo in più luoghi, e in differenti
151 Cfr. Meoc, Op. cit. , vol. XLII, pag. 513
152 Cfr. Meoc, Op. cit., vol. IL, pag. 209
153 Ci sembra errato il giudizio elaborato da Mugnai per il quale in queste due lettere Engels cadrebbe in una
autocontraddizione sul tema del passaggio dall’essere all’essenza. A ben vedere Engels parla di due cose
differenti: l’individuazione della sezione sull’essenza come il vero nucleo razionale della Logica e nella
seconda missiva del modo idealistico di trattare le categorie logiche. Cfr. Massimo Mugnai, Op. cit. pag. 51-2 154 “Ho criticato il lato mistificatorio della dialettica hegeliana quasi 30 anni fa, quando era ancora la moda
del giorno” cfr. Meoc, Op. cit., vol.XXXI, pag. 22
67
periodi, riferimenti espliciti alla dialettica e al suo progetto di riforma. Non solo, ma è lo
stesso Marx ha palesare l’intenzione di rendere accessibile al senso comune ciò che di
razionale, relativamente al metodo, Hegel aveva scoperto155
. Ancora, nel maggio del 1858,
in una lettera destinata a Lassalle, il filosofo di Treviri osserva che proprio in quanto la
dialettica si presenta come l’ultima parola in senso assoluto della filosofia bisognava
liberarla dall’apparenza mistica156
. Quasi dieci anni dopo, in due lettere del 6 marzo 1868 a
Kugelmann e del 9 maggio 1868 a Dietzgen157
, torna ancora sulla forma mistica nei
medesimi termini e con l’intenzione di scrivere una Dialettica 158
. Dunque per Marx il
rovesciamento è il modo per spogliare la dialettica dalla forma mistica. Sempre nel
poscritto alla seconda edizione del Capitale afferma: “Per il suo fondamento, il mio
metodo dialettico è non solo differente da quello hegeliano, ma ne è il diretto contrario.
Per Hegel il processo del pensiero, che egli trasforma addirittura in un soggetto
indipendente sotto il nome di Idea, è il demiurgo della realtà effettuale, che costituisce solo
la sua esterna manifestazione fenomenica. Per me, viceversa, l’ideale non è altro che il
materiale trasferito e tradotto nella testa umana”159
160
. L’errore fondamentale di Hegel
finiva così per compromettere la relazione tra contenuto e forma, anche se, nonostante
l’inversione, a tratti riuscirebbe a cogliere i nessi reali dello sviluppo storico. Sarebbe
errato credere che solo in Hegel e solo con una esposizione dialettica si possa incappare in
una simile confusione. Anche Adam Smith era caduto in alcuni casi nell’errore di
concepire e presentare in modo rovesciato la relazione tra il valore e il rapporto di questo
con salario, prezzo e rendita fondiaria. La confusione lo portava a non esporre sempre nella
sua interna connessione il rapporto, finendo per averne una falsa rappresentazione161
.
155
Cfr. Meoc, Op. cit , Vol. XL , pag. 273
156 Ibidem, pag. 588
157 Riferendosi proprio a Dietzig, Marx dirà ad Engels: “E’ una disdetta per lui che non abbia studiato
proprio Hegel” cfr. Meoc, Op. cit., pag. 213
158 Cfr. Meoc, Op. cit. , Vol. XLIII, pag. 582; : “Quando mi sarò scrollato di dosso il peso dell’economia,
scriverò una “dialettica”. Le vere leggi della dialettica sono già contenute in Hegel, sebbene in forma mistica.
Bisogna eliminare questa forma” Cfr. Ibidem, pag. 592
159 Cfr. Meoc, Op. cit., vol. XXXI, pag. 21
160 In una missiva a Kugelmann risalente al 1868 fa un’affermazione molto simile: “Egli sa molto bene che il
mio metodo di svolgimento non è quello di Hegel, perché io sono materialista, Hegel idealista. La dialettica
di Hegel è la forma fondamentale di ogni dialettica, ma soltanto dopo l’eliminazione della sua forma mistica,
ed è appunto questo che distingue il mio metodo.” Cfr. Meoc, Op.cit., Vol. XLIII, pag. 582
161 Cfr. Meoc, Teorie sul plusvalore, Vol. XXXV, pag. 103
68
Anche nella Critica alla filosofia hegeliana del diritto si era pronunciato sull’argomento:
“La differenza risiede non nel contenuto, ma nel modo di considerare, ossia nel modo di
dire. E’ una storia duplice, esoterica e essoterica. Il contenuto risiede nella parte essoterica.
L’interesse della parte esoterica è sempre quello di ritrovare nello Stato la storia del
concetto logico. Ma appartiene al lato essoterico che avanzi lo sviluppo propriamente”162
.
Ciò che è reale è razionale per Hegel perchè richiama ad un “significato altro da se stesso.
il fatto da cui si parte non è inteso come tale, ma come risultato mistico”163
. Ma a ben
vedere nulla ci è detto circa questo nocciolo razionale da liberare. La cosa si complica
ulteriormente sapendo che Marx in un’epistola del 1870 parlò del suo metodo critico di
applicazione della dialettica164
.
Engels, che forse più di Marx ha apertamente confessato il debito verso il maestro165
, è
molto più esplicito in tale senso, come abbiamo visto nella missiva a Lange del 1865.
E questo non detto da parte di Marx ci crea non pochi problemi appena noi andiamo fuor di
metafora166
. Di certo, molti degli autori della tendenza continuistica hanno inteso queste
formule alla lettera. Al contrario, Althusser ha particolarmente insistito sul significato della
metafora del rovesciamento e del nocciolo, per mostrare come, dopo la rottura
epistemologica del 1845, il tentativo di un raddrizzamento della filosofia speculativa non
avesse più senso. Il problema così ci rimanderebbe alla ricerca delle differenze delle
strutture specifiche tra la dialettica di Marx e quella di Hegel e non più al cambio di
direzione. Categorie come negazione della negazione, identità dei contrari, contraddizione
possiedono “ in Marx (nella misura in cui anch’egli se ne serve, il che non sempre è il
caso!) una struttura diversa da quella che posseggono in Hegel”167
. Le affermazioni di
Althusser sono largamente condivisibili, ma a condizione di ripensare in parte la rottura
162 Cfr. Meoc, Op. cit., vol. III, pag. 8
163 Ibidem, pag. 10
164 Cfr. Meoc, Op. cit., pag. 739
165 Cfr. Meoc, Op. cit., vol. XLIV, pag. 259
166 Il lettore mi scuserà dei tanti riferimenti che appesantiscono la lettura. Eppure, per non rendere vaghi i
nostri intenti peregrini, ho dovuto farlo. Anche senza questa abbondanza di riferimenti, Lenin colse il tutto
con molto acume: “Non si può comprendere appieno il Capitale di Marx, e in particolare il suo primo
capitolo, se non si è studiata attentamente e capita tutta la logica di Hegel. Di conseguenza, dopo mezzo
secolo, nessun marxista ha capito Marx” Cfr. Vladimir Lenin, Op. cit., pag. 165; “anche se Marx non ci ha
lasciato una Logica, ci ha lasciato però la logica del Capitale, che bisognerebbe utilizzare al massimo” Cfr.
Ibidem, pag. 341
167 Cfr. Louis Althusser, op. cit., pag. 75
69
epistemologica. E’ innegabile infatti che ciò che è stata intesa come contraddizione
principale, cioè quella tra capitale e lavoro, presenta un carattere estremamente complesso
(Althusser la definirà surdeterminata) se posta in confronto a quella contraddizione che in
Hegel muove e orienta già-da-sempre la storia, illustrata nelle pagine delle sue Lezioni. Ma
anche l’impalcatura althusseriana entra in difficoltà quando si palesano nel Capitale alcuni
atteggiamenti che richiamano ad Hegel. Vedremo in seguito quali e quanti essi siano. Per
ora ci limiteremo ad attestare la presenza di una sorta di dualità o meglio di ambivalenza
nell’opera di Marx ed Engels, riconosciuta dal filosofo francese nei frammenti scritti negli
ultimi anni168
, su come intendere i modi di produzione e gli elementi che li compongono:
se pensarli come il risultato di un incontro tra elementi che danno per così dire vita ad una
struttura; oppure al considerare la struttura stessa come antecedente gli elementi.
L’identificazione di un processo come costituzione di una rete strutturale-relazionale tra
elementi in precedenza indipendenti che posseggono corsi propri di sviluppo e che
collimano finendo per creare una struttura in grado di dominarli e trasformarli, è cosa del
tutto diversa da una ricostruzione storico-filosofica dei passaggi da una struttura all’altra
(nello specifico da un modo di produzione all’altro). Fornire un carattere di intelligibilità
storica scevra da qualsivoglia teleologia è sicuramente esercizio impervio, e a cui Marx
non è riuscito ad essere sempre fedele. Se sono giustificabili, e quindi non invalidanti la
nostra ipotesi, alcuni tentativi di semplificazione sul piano espositivo di nodi teorici
difficilmente comprensibili ai più e la cui formulazione linguistica è nondimeno da
considerarsi insufficiente rispetto alla novità del pensiero proposto, problematici restano
alcuni atteggiamenti del filosofo renano, che lasciano pensare ancora una volta ad una
influenza idealistica. Si pensi ad esempio a quando Marx afferma, nella prefazione al
Capitale, che il “paese industrialmente più sviluppato non fa che mostrare a quello meno
sviluppato l’immagine del suo avvenire”169
, concetto questo che fa pensare ancora una
volta ad un chiaro impianto teleologico, e che sembra mostrare una evidente
contraddizione all’interno del capolavoro di Marx proprio nel denso capitolo
sull’accumulazione originaria, dove è oggetto d’indagine la storia della nascita del modo di
produzione capitalistico. Marx afferma che “il rapporto capitalistico ha come presupposto
la separazione fra i lavoratori e la proprietà delle condizioni di realizzazione effettuale del
lavoro. Una volta autonoma, la produzione capitalistica non solo conserva quella
separazione, ma la riproduce su scala sempre crescente. Il processo che crea il rapporto
168
Cfr. Louis Althusser, Sul materialismo aleatorio, Unicopli, Milano 2000, pag. 105 e ss.
169 Cfr. Meoc, op. cit. , pag. 10
70
capitalistico non può dunque essere null’altro che il processo di separazione del lavoratore
dalla proprietà delle proprie condizioni di lavoro, processo che da una parte trasforma in
capitale mezzi sociali di sussistenza e di produzione, dall’altra trasforma i produttori
diretti in lavoratori salariati”170
. Dunque l’incontro di due “specie diversissime di
possessori di merci, da una parte proprietari di denaro e di mezzi di produzione e di
sussistenza, ai quali importa valorizzare attraverso l’acquisto di forza-lavoro altrui la
somma di valori posseduta, dall’altra parte lavoratori liberi”171
è la condizione necessaria
per l’avvio del processo di produzione, a cui però vanno sommate altre, fondamentali,
condizioni172
. L’assenza di queste altre condizioni rende l’intero processo impossibile. Per
questo l’evento dell’accumulazione originaria non si presenta in tutti i paesi nei medesimi
termini. Il caso dell’Italia è emblematico: già nel XIII secolo sono presenti proprietari di
denaro, manodopera libera e tecnologie. Eppure il processo accumulativo abortì173
. È
chiaro dunque che non si danno medesime condizioni attuative, e con molta probabilità in
alcuni paesi il processo produttivo può essere un particolare effetto di un processo
riproduttivo che l’investe. La mistificazione di questa profonda concezione materialistica
antiteleologica e antideterministica ha avuto molte conseguenze nel dibattito teorico
intorno allo statuto epistemologico del marxismo da un lato, e dell’interpretazione
economica di eventi storici rilevanti. Non è casuale infatti che i marxisti siano stati insidiati
sul loro terreno da autorevoli avversari teorici, e che riuscirono a mettere in scacco proprio
quei modelli marxisti continuisti (dichiarati o meno non importa)174
.
170 Cfr. Karl Marx, op. cit. , pag. 788 171 Idem
172 In verità non sempre Marx ed Engels pensarono il rapporto tra liberi produttori e possessori di mezzi di
produzione in questa maniera che, lo si sarà compreso, è un rapporto chiaramente contraddittorio. Esiste
almeno una formulazione, che implica un misconoscimento della reale portata della contraddizione fra i due
soggetti, che vede nel proletariato il risultato, meglio il prodotto del processo di industrializzazione. È chiaro
che qui si sta ragionando nei medesimi termini dell’idealismo hegeliano, che faceva avanzare la storia
tramite il dispositivo della negazione: “ il proletariato è sorto in seguito alla rivoluzione industriale, avvenuta
in Inghilterra nella seconda metà del secolo scorso e che da allora in poi si è ripetuta in tutti i paesi civili del
mondo” Cfr. Meoc, Principi del comunismo, vol. VI, pag. 360
173 Ibidem, pag. 790 nota 189
174 Si pensi al dibattito sul processo di industrializzazione italiana. Alexander Gerschenkron ha in più di una
occasione mostrato diversi casi in cui “i processi di industrializzazione avviati in un paese arretrato,
differirono sostanzialmente da quelli dei paesi più progrediti dal punto di vista non solo della rapidità dello
sviluppo ( e cioè per il saggio di espansione industriale) ma anche del tipo di strutture produttive e
organizzative dell’industria emerse nel corso del processo”. Cfr. Alexander Gerschenkron, Il problema
71
Per questo preferiamo parlare di cambio di regione ontologica e di metodo, senza celare
ulteriori caratteri ostici che un simile approccio porta con sé. E’ innegabile infatti, come
abbiamo in parte mostrato in precedenza ricostruendo quel complesso fenomeno
dell’abbandono della tematica dell’inversione tra soggetto e predicato, che è una risposta
nata in contrapposizione all’idealismo hegeliano, ma che comunque rimane sul medesimo
campo ontologico spostando l’asse dall’Idea all’Uomo, che Marx sia uscito da determinati
schemi ideologici di cui era inizialmente imbevuto. Ma rimane il fatto che egli, anni dopo
aver sancito la rottura col maestro, cercò di recuperarne alcuni metodi espositivi utilizzati
proprio da lui, che vedremo in seguito nel dettaglio. Ciò non vuol dire naturalmente un
ritorno all’hegelismo, ma di sicuro Marx seppe guardare, dopo aver cambiato terreno
d’indagine con meno veemenza all’opera di Hegel, sicuro del dominio sul campo
d’indagine che aveva acquisito. Le stesse citazioni che abbiamo appena riportate ne sono la
riprova.
E a ben vedere, lo spettro oggettuale del capovolgimento non riguarda esclusivamente
Hegel. Anzi è molto più ampio. Riproduco una citazione che ritengo molto importante e
che suffraga quanto ho appena detto: “per Epicuro invece si può dimostrare nei particolari
che egli, sebbene prenda le mosse dalla filosofia naturale di Democrito, ne capovolga in
tutti i punti il vero significato. Non si può certo rimproverare a Cicerone e a Plutarco non
aver visto ciò, dato che persino tipi intelligenti come Bayle e anche ipsissimus Hegel non
ne hanno avuto sentore. Quanto a quest’ultimo del resto non si può pretendere, proprio da
lui che per primo comprende tutta la storia della filosofia, che non faccia errori nei
particolari ”175
. In altre parole, forse anche spinto dalla situazione intellettuale
contemporanea che giudicava misera176
, Marx riconosce a Hegel meriti importanti. Ma, a
ben vedere, i meriti furono da questi conseguiti in altri campi, e di certo non in quello
dell’economia politica.
storico dell’arretratezza economica, Einaudi, Torino 1965, pag. 8-9. A riprova di ciò che sostengo si vedano
i termini in cui è stato posto il dibattito sul risorgimento: Cfr. Antonio Gramsci, Il risorgimento, Einaudi,
Torino 1954; Rosario Romeo, Risorgimento e capitalismo, Editori Laterza, Roma-Bari 2008
175 Cfr. Meoc, Op. cit., vol. XV, pag. 576
176 “Hinc illae lacrimae. Qui signori in Germania credono (ad eccezione dei reazionari teologici) che la
dialettica di Hegel sia <un cane morto>. A questo riguardo Feuerbach ha molte colpe sulla coscienza”, Cfr.
Meoc, Op. cit., vol. XLIII, pag. 20
72
Per questo Lefebvre aveva affermato che “da questo carteggio risulta che il metodo
dialettico è stato ritrovato e riabilitato da Marx al tempo dei lavori preparatori a Per la
critica dell’economia politica e al Capitale: l’elaborazione delle categorie economiche e
dei loro nessi intimi ha superato l’empirismo e raggiunto il livello del rigore scientifico, ed
ha preso allora la forma dialettica”177
.
Dunque la forma dialettica è da considerarsi come scientifica, e come forma precipua
dell’esposizione marxiana. Rimane aperta la questione: cosa si denota con il termine
dialettica?
Per rispondere, ci sarà di aiuto la famosa Introduzione del ‘57, rimasta inedita quando
Marx era in vita, articolata in tre paragrafi rispettivamente dedicati a produzione, consumo,
distribuzione, scambio (circolazione); rapporto generale tra produzione, distribuzione,
scambio e consumo; il metodo dell’economia politica. E’ facile immaginare che queste
pagine abbiano dato vita ad un dibattito infinito sul metodo del tedesco, specie intorno alla
questione centrale di astratto e concreto. Per alcuni, tra i quali Ilenkov, astratto e concreto
sono due categorie della dialettica, e la “dialettica è la logica del marxismo”178
. Certo, la
visione della scienza sovietica, il cui pilastro fondante era rappresentato dalla nozione delle
due culture e delle due scienze, quella borghese e quella proletaria, considerava la
dialettica marxista de facto diversa da quella di Hegel e dell’intera riflessione filosofica
occidentale. Il punto massimo di distanza nel campo della teoria era proprio quello del
rapporto tra astratto e concreto. I sovietici giudicavano l’astrazione in Kant e nei suoi
seguaci alla stregua di una mera operazione logica mediante la quale ci si innalza dal dato
sensibile a una rappresentazione generale, separando dalle singolarità ciò che è analizzato
come differente. Il concreto è l’immediato, l’intuito. Il concetto concreto si risolve nel
denotare, nel significare mediante un simbolo i singoli oggetti percepiti sensibilmente.
Rimane però aperto il nostro quesito: cosa voglia dire il termine dialettica! Possiamo
leggere la sterminata produzione letteraria al riguardo, ma difficilmente si troveranno
risposte esaurienti: non basta sostenere che la realtà è dinamica e che solo la dialettica
possa comprenderla come tale poiché supera la fissità degli enti e delle relazioni a cui il
principio di non contraddizione li blocca. Non è nemmeno sufficiente, a mio modesto
parere, affermare che dal punto di vista di Marx il problema di cosa sia un ente si porrebbe
in modo affatto diverso, in quanto egli focalizzerebbe la sua analisi nel rapporto
177 Cfr. Henry Lefebvre, il materialismo dialettico, Einaudi, Torino 1949, pag. 65
178 Cfr. Evald Vasilevic Ilenkov, La dialettica dell’astratto e del concreto nel Capitale di Marx, Feltrinelli,
Milano 1975, pag. 4
73
“dell’oggetto con sé medesimo, cioè del rapporto reciproco dei vari momenti della realtà
oggettiva entro una data totalità concreta”179
. A ben vedere, questa affermazione è ancora
una volta la riconferma della non uscita dal problema del rapporto tra soggetto e oggetto.
Legando la logica alla gnoseologia, si finisce per trasfigurare le definizioni di astratto e
concreto usate da Marx: il secondo diventa una mera forma intuitivo-sensibile del
rispecchiamento dell’oggetto nella coscienza, e il primo, nel nome del materialismo
dialettico, diventa una sintesi mentale “di singoli momenti della realtà oggettiva afferrati
analiticamente”180
.
Dunque per Ilenkov il concreto è tale perché sintesi di molteplici determinazioni, quindi
l’insieme internamente articolato delle varie forme d’esistenza dell’oggetto. L’unità
sintetica si realizza non attraverso la somiglianza dei fenomeni tra loro, ma, al contrario,
attraverso la loro differenza e opposizione. Si tratta dunque di una operazione agli antipodi
rispetto a quella della logica formale, che vede nell’unità della molteplicità non il concreto,
bensì l’astrazione da ogni differenza specifica, svolta in una operazione di depurazione del
carattere comune da quelli eterogenei. Il concreto viene a coincidere con la totalità (termini
usati spesso come sinonimi). Per Ilenkov, il pensare ad un sistema organico i cui elementi
sono in grado di condizionarsi vicendevolmente, si realizza non attraverso la somiglianza
dei fenomeni tra loro, ma, al contrario, attraverso queste differenze oppositive. Ma qui, mi
pare, nonostante i toni trionfalistici della sedicente scienza sovietica del Diamat181
, ancora
non siamo molto lontani da Hegel. Discorso simile per l’astrazione. Ma come dovrebbero
essere le astrazioni? Per Ilenkov esse dovrebbero essere sia formalmente complete sia
ricche di contenuto. Soltanto in questo caso esse saranno vere, oggettive182
. Ma cosa
significa tutto ciò?
“Abbiamo già visto che la completezza dell’astrazione presuppone che in essa si esprimano
non i caratteri generali astratti propri a tutti i fenomeni particolari cui l’astrazione
universale si riferisce, bensì le proprietà concrete dell’elemento oggettivante elementare e
non ulteriormente scomponibile del sistema di interazione, ossia le proprietà della “cellula”
della totalità analizzata. Nel caso del sistema capitalistico di interazione fra gli uomini nel
179 Ibidem, pag. 5
180 Ibidem, pag. 94
181 Abbreviazione di Dialekticeckij materializm
182 Ibidem, pag. 180
74
processo di produzione sociale della vita materiale questa cellula è la merce, la forma
mercantile semplice di interazione”183
.
A queste considerazioni dovrebbe seguire la domanda che verte intorno all’attività che, in
ultima analisi in senso ontologico, è primaria e da cui scaturiscono tutte le altre, tramite
una sorta di derivabilità necessaria. E Ilenkov, mostrandoci senza mezzi termini il carattere
fortemente ideologico del Diamat184
, non solo la pone in questi termini, ma va oltre,
mostrando come il carattere dialettico della logica di Marx permetta di trovare una
soluzione che la logica astratta dell’intelletto non potrebbe trovare, poiché la risposta stessa
risulterebbe troppo concreta e solo la logica elaborata da Marx riuscirebbe a scorgervi un
autentico concetto universale. E dunque, possiamo dedurre, che l’universale in Marx è
sempre un concreto, e la sua universalità sarebbe ricavata dalla propria estensione
onnicomprensiva, finendo così per inglobare il molteplice reale e coglierlo come
processo185
. Ma proseguiamo nella nostra ricerca, e analizziamo l’Introduzione del ’57. Nel
primo paragrafo Marx tende ad integrare la funzione di astrazione agli elementi dello
sviluppo storico. Mentre nella Miseria aveva rifiutato l’uso di categorie economiche come
espressioni astratte dei reali rapporti di produzione, in favore di una concreta storia dei
rapporti di produzione, nell’Introduzione Marx rivaluta l’uso delle categorie astratte.
Questo non vuol dire che Marx individui e delinei delle categorie eterne, così come in
Proudhon e negli economisti volgari, bensì egli comprende, forse per la prima volta nella
sua vita di studioso, che vi possa essere un uso astratto di elementi determinati che non
inficino e trasvalutino i dati empirici, ma anzi che ne agevolino la comprensione
inquadrandone lo statuto teorico finalizzato alla conoscenza del reale stesso. Anche per
questo l’ Introduzione si apre col paragrafo dedicato alla produzione.
183 Ibidem, pag. 181
184 Perché il Diamat, a parere di chi scrive, è tutto fuorché una scienza. O meglio, essa è una sistematica ri-
costruzione in termini negativi dei caratteri dell’idealismo praticati in senso opposto a quelli patrocinati da
quest’ultimo. In altri termini, studiando i testi della scuola sovietica, si ha la sensazione che le pretese di
materialismo radicale avanzate siano invece un tentativo, a volte preciso a volte lacunoso e risibile, di presa
di posizione contro una determinata visione dominante, e che trova nella dottrina delle due culture e delle due
visioni la sua legittimazione. Ma ciò rimane una pretesa. Si vedano in tal senso le affermazioni di Stalin sul
materialismo di Engels e Marx e la banalizzazione delle loro teorie Cfr. Iosif Vissarionovič Stalin, Principi
del leninismo, Edizioni dell’unità, Roma 1944; Iosif Vissarionovič Stalin, Questioni del leninismo, Mosca,
edizioni in lingue estere 1946
185 Cfr. Evald Vasilevic Ilenkov, op. cit., pag. 35
75
Non che la categoria di produzione sia eterna, ma le diverse determinazioni storiche dei
molteplici modi di produzione possono avere un rapporto fra il grado della loro generalità e
quello dei diversi caratteri discriminanti. In altri termini, che vi è un’articolazione
proteiforme che comunque consenta un pensare i caratteri generali. Rispetto alla categoria
astratta di produzione, si danno altre categorie, sempre astratte, di produzione, ma con
un’estensione minore: quella schiavistica, quella feudale, quella capitalistica ecc. Certo, i
caratteri presenti nell’estensione più ampia non vanno né ipostatizzati né considerati come
ciò che in ultima analisi generano e mantengono in vita un modo di produzione, cioè come
gli elementi che alternando i loro ruoli di dominio danno vita ai grandi mutamenti che la
storia testimonia. Marx non ritorna semplicemente a Hegel, come potremmo credere
vedendo il recupero dell’astrazione186
. Nella realtà si danno solo ed esclusivamente delle
singolarità. Ma in esse possiamo riscontrare delle costanti che possono essere oggetto di
trattazione nella teoria che va dall’astratto al concreto determinato. Lo sforzo richiesto ad
una impostazione materialista è nell’individuazione da un lato dei dispositivi che inverano
il fenomeno che si vuole analizzare e dall’altro di ricavare una conoscenza da queste
generalità, senza mai perdere di vista le reali e discriminanti differenze. Altrimenti si
cadrebbe in un errore tipico dell’economia politica, come sottolinea lo stesso filosofo
tedesco riferendosi a Rossi: “è come se il fisiologo dicesse che le forme determinate di vita
sono equivalenti, che tutte sono semplicemente forme della materia organica. Ma sono
appunto solo queste forme che contano, quando si tratta di determinare il carattere
specifico di un modo sociale di produzione. Un vestito è un vestito. Ma fate che lo scambio
avvenga nella prima forma e avrete la produzione capitalistica e la moderna società
borghese; fate che avvenga nella seconda, e avrete una forma di lavoro manuale
compatibile coi rapporti asiatici o con quelli medievali ecc”187
. Che l’astrazione sia utile ai
fini di una fondazione epistemologia appare innegabile. Marx lo riconosce, e nella maturità
è riuscito a pensare il carattere di saldatura di una scienza mediante un procedimento di
chiarificazione ed estensione conoscitiva dei medesimi saperi saldi ricavati dalle categorie
astratte, mediante le quali si potevano addirittura superare caratteri ideologici derivanti da
approcci che partendo dal concreto determinato rimanevano in esso imbrigliati tramite una
produzione tautologica di una vuota generalità. Si pensi ad esempio ai fisiocratici, i quali
concepivano “legge materiale di una determinata fase storica della società come legge
186 Mario dal Pra in tal proposito ha parlato di una svolta dal metodo storico-descrittivo ad uno
maggiormente aderente all’organicismo hegeliano. Cfr. Mario dal Pra, op. cit., pag. 293
187 Cfr. MEOC, Teorie sul plusvalore, op. cit. , vol. XXXIV, pag. 372
76
astratta che domina uniformemente in tutte le forme sociali”188
. Di contro, si possono re-
inquadrare quelle stesse leggi astratte al fine di progredire verso un sapere fondato, come
storicamente mostra l’opera di Smith189
. A Marx non è sconosciuta nemmeno la difficoltà
opposta: quella di partire da un’astrazione formale per ordinare una serie di fenomeni
concreti a partire da un principio metafisico ad essi estranei190
. Questo ci aiuta a
comprendere il perché sia nella Miseria della filosofia che qui vengono respinte quelle
false concezioni che pongono l’individuo come principio dell’attività economica, che sono
il riflesso e il compimento di una determinata organizzazione sociale dei rapporti giuridici
di proprietà e delle forze produttive. Lo schema si presenta ribaltato: l’individuo isolato,
invece che come risultato storico, lo si vedrebbe come punto di partenza. Ma questo errore
è dato da un’ illusione e da una profonda assenza di senso storico che permea una simile
visione dei fatti.
Nel secondo paragrafo, Marx compie un ulteriore passo in avanti: se nel primo capitolo
egli aveva individuato la totalità organica nella struttura dell’astrazione, ora individua
quella totalità organica nei rapporti che congiungono i vari momenti del ciclo economico,
arrivando ad affermare che la relazione tra produzione, distribuzione, scambio e consumo
formano un sillogismo in piena regola: la prima è la generalità, distribuzione e cambio
sono la particolarità e il consumo l’individualità 191
. Questo collegamento precisa,
delineandole, le nature specifiche delle figure, le cui prime due sono rispettivamente
determinate da leggi naturali generali e da contingenze sociali. Lo scambio si colloca tra
queste in quanto movimento formalmente sociale, e il consumo, concepito come scopo
finale, si colloca al di fuori dell’economia, salvo quando è in grado di reagire sulla
produzione192
.
Quanto di hegeliano ci sia in queste pagine è facilmente intuibile: non sosteneva forse
Hegel che il sillogismo autentico è quello speculativo, e che l’oggetto nella sua totalità è il
188 Ibidem, pag. 11
189 Ibidem, pag. 12
190 Ibidem, pag. 63
191 Cfr. Karl Marx, Op. cit., pag. 232
192 Quanto sia decisiva nell’impianto del capitale questo esser posto del consumo al di fuori dell’economia lo
vedremo in seguito, quando analizzeremo il duplice carattere delle merci
77
sillogismo, in cui il termine estremo dell’universalità è connesso con quello della
singolarità mediante la particolarità?193
Ma soprattutto, la riflessione di Marx ci fa pensare fortemente alla dottrina dell’azione
reciproca come causalità di sostanze che si condizionano vicendevolmente e mantenendo
in pari tempo i caratteri di passività e attività, posizione ed effetto. L’azione reciproca
togliendo nella negazione le determinazioni poste e tramutandole nel loro opposto, finisce
così per nullificarle. Pensando questa causalità nel concetto assoluto, essa è necessità reale,
assoluta identità con sé, così da far scomparire le stesse necessità e causalità. Essendo
forma assoluta, la sostanza assoluta, distinguendosi da sé, si distingue da un lato nella
totalità , “ come semplice tutto che contiene in se stesso il suo esser posto e in ciò è posto
come identico con sé, l’universale, - dall’altro lato poi si distingue nella totalità […] come
nella riflessione parimenti dalla determinatezza in sé alla determinatezza negativa, la quale
come determinatezza identica con sé è così anch’essa il tutto, ma posto come la con sé
identica negatività, il singolo”194
.
Questo recupero del concetto dell’azione reciproca contiene però un elemento di
distinzione che dovrà essere approfondito in seguito, nel Capitale. Hegel afferma che “
immediatamente però, poiché l’universale non è identico con sé che in quanto contiene in
sé la determinatezza come tolta, ed è dunque, il negativo come negativo, esso è quella
medesima negatività, che è la singolarità; e la singolarità, poiché è parimenti anch’essa il
determinato, il negativo come negativo, è immediatamente quella medesima identità, che è
l’universalità”195
ed è tale perché ha in questa loro identità la particolarità che riesce a
contenerne l’unità. Per questo in Hegel universalità, particolarità e singolarità sono tre
totalità congiunte in una medesima riflessione. In Marx invece, lo abbiamo letto prima, non
si dà sempre, per così dire, ritorno dalla singolarità alla generalità. Anzi, nulla è detto dei
casi nei quali ciò avviene. Potrebbe sembrare un fatto trascurabile, ma su di essa riposa
ancora una volta quello scarto con la concezione presente nei testi giovanili animati da
un’altra problematica, poiché qui è in gioco la stessa idea di scienza (o l’idea di quella che
Marx riteneva essere la discriminante di una scienza rispetto ad una ideologia). Se fosse
193 “Nella sua totalità, l’oggetto è il sillogismo, cioè il movimento che dall’universale, attraverso la
determinazione, giunge alla singolarità, e che, viceversa dalla singolarità, attraverso la rimozione di questa –
attraverso la determinazione -, giunge all’universale” Cfr. Hegel, Fenomenologia dello spirito, op. cit. , pag.
1037
194 Cfr. Hegel, Scienza della logica, op. cit. , pag. 645
195 Idem
78
avallata la possibilità di pensare al consumo come ad una forma anch’essa generale, si
finirebbe per ripiombare in una visione per la quale la merceologia è equipollente, almeno
in una topica delle scienze, all’indagine economica, reinserendo surrettiziamente l’ambito
soggettivo in un discorso che ha guardato al di là di quel rapporto metafisico. In questo
senso, non era forse Hegel a concludere il primo volume della Scienza della logica con la
constatazione che la semplice determinatezza delle tre totalità sono da pensarsi tramite
quella come unica e medesima identità, che è il concetto, “il regno della soggettività o
della libertà”?196
. Proseguendo nella lettura, il terzo paragrafo ci pone di fronte a
considerazioni molto interessati circa il metodo specifico utilizzato da Marx. Vale la pena
riportarlo quasi integralmente per facilitare la valutazione:
“Quando consideriamo un dato paese dal punto di vista politico-economico, cominciamo con la sua
popolazione, la distribuzione di questa in classi, città, campagna, mare, con i diversi rami della produzione,
esportazione e importazione, produzione e consumo annui, prezzo delle merci ecc.
Sembra corretto cominciare con ciò che è reale e concreto, con il presupposto reale,e quindi per es. in
economia con la popolazione, che è la base e il soggetto dell’intero atto sociale di produzione. Ma ad un
esame più approfondito ciò si dimostra erroneo. La popolazione è una astrazione se io per es. tralascio le
classi da cui essa è composta. E a loro volta queste classi sono una parola vuota se io non conosco gli
elementi sui quali esse si fondano, per es. lavoro salariato, capitale ecc. E questi presuppongono scambio,
divisione del lavoro, prezzo ecc. Il capitale per es. è nulla senza lavoro salariato, senza il valore, il danaro, il
prezzo ecc. Se dunque comincio con la popolazione, mi trovo davanti una rappresentazione caotica del tutto
e, cercando di meglio precisare, perverrei sempre di più, in via analitica, a concetti più semplici; dal concetto
che mi ero rappresentato ad astrazioni sempre più rarefatte, fino a giungere alle determinazioni più semplici.
Da qui bisognerebbe poi fare a ritroso il viaggio, per arrivare infine di nuovo alla popolazione, questa volta
però non come ad una rappresentazione caotica di un tutto, ma come ad una ricca totalità di molte
determinazioni e nessi. La prima via è quella che storicamente l’economia politica ha imboccato al suo
nascere. Gli economisti del XVIII secolo, per es., cominciavano sempre con il tutto vivente, la popolazione,
la nazione, lo Stato, più Stati, ecc; però finivano sempre col ricavare mediante l’analisi alcuni concetti
generali astratti determinanti come divisione del lavoro, danaro, valore ecc. Non appena questi singoli
momenti furono più o meno fissati e astratti, cominciarono i sistemi economici, che risalgono dal semplice,
come lavoro, divisione del lavoro, bisogno valore di scambio, allo Stato, allo scambio tra le nazioni e a
mercato mondiale. È evidente che il metodo scientificamente corretto è quest’ultimo. Il concreto è concreto
perché è la sintesi di molte determinazioni, cioè unità del molteplice. Nel pensiero esso appare perciò come
processi di sintesi, come risultato, non come punto di partenza, anche se è esso il reale punto di partenza e
quindi anche il punto di partenza dell’intuizione e della rappresentazione. Per la prima via la
rappresentazione piena si dissolve in astratta determinazione; per la seconda le determinazioni astratte
conducono alla riproduzione del concreto lungo il cammino del pensiero. Fu perciò che Hegel cadde nella
illusione di concepire il reale come il risultato del pensiero che si raccoglie, affonda in se stesso e da se solo
196 Ibidem, pag. 646
79
si muove, mentre il metodo di risalire dall’astratto al concreto, è il solo modo per il pensiero di appropriarsi
del concreto, di riprodurlo come concreto nello spirito. Mai però il processo di genesi del concreto stesso. Per
es. la categoria economica più semplice, diciamo per es. il valore di scambio, presuppone una popolazione, e
una popolazione produca secondo determinati rapporti; nonché un certo tipo di organizzazione familiare o
comunitaria o statale ecc. Esso non può esistere mai se non come nesso astratto, unilaterale di un tutto già
dato, concreto, vivente. Come categoria, invece, il valore di scambio ha un’esistenza antidiluviana”197
.
Queste dense pagine sono state naturalmente oggetto di un intenso dibattito. Nel suo Per
l’ontologia dell’essere sociale Lukacs ha affermato che la tipologia e il senso delle
astrazioni in Marx sono determinati non dal punto di vista logico né metodologico ma dalla
cosa stessa, cioè dall’essenza ontologica della materia trattata198
categorie semplici che
esprimono determinazioni dell’esistenza. Ma questa definizione sembra non essere del
tutto adeguata, o meglio sembra molto parziale. Infatti, l’idea di qualificare le astrazioni
come determinate dalle cose sembra richiamare a quella logica specifica dell’oggetto
specifico della critica alla filosofia del diritto hegeliano, ignorando così come quella
tematica fosse stata abbandonata da Marx. Un altro autore, Josè Chasin invece ha
individuato una serie di funzioni che le astrazioni svolgerebbero nell’economia della
metodologia marxiana199
: cioè mettere in evidenza le diversità precipue, derivanti dal
criterio ontologico d’indagine e punto di partenza dell’elaborazione teorica, che sappiano
evitare una rappresentazione caotica dell’insieme vivo. Chasin si richiama apertamente a
questo terzo paragrafo, per spiegare come, se si parta dalla totalità o da qualche altro
segmento di questa, si rischi di cadere in vuote astrazioni se non sono considerati come
vettori che la compongono, cadendo così in una rappresentazione definibile caotica poiché
composta da astrazioni svuotate dalla loro orditura. Si deve quindi iniziare con queste
astrazioni ragionevoli per raggiungere il concreto che è risultato. E questo ci
permetterebbe quantomeno di non cadere nelle difficoltà che invece attanagliano Lukacs,
che alla fine è costretto ad appellarsi ad una presunta assenza della categoria della
mediazione da parte dell’economia borghese, che comporterebbe così per i pensatori di
questa classe sociale ad arrestarsi alle immediate rappresentazioni200
. Per Lukacs
oltrepassare l’immediato vuol dire afferrare e comprendere gli oggetti “come momenti
della totalità, cioè come momenti della società complessiva, che si trasforma nella storia.
197 Cfr. Karl Marx, op. cit., pag. 245-6
198 Cfr. Gyorgy Lukacs, Ontologia dell’essere sociale, 3 volumi, Editori riuniti Roma, 1976-81, vol. I, pag.
302
199 Cfr. Josè Chasin, Marx ontologia e metodo, Mimesis, Milano 2010, pagg. 99 e ss.
200 Cfr. Gyorgy Lukacs, Storia e coscienza di classe, op. cit. , pag. 206
80
La categoria della mediazione come leva metodologica per il superamento della mera
immediatezza dell’empiria non è quindi qualcosa che interviene dall’esterno
(soggettivamente) negli oggetti, non è un giudizio di valore o un dover essere che si
contrappone al loro essere, ma è il rivelarsi della loro stessa struttura oggettuale autentica
ed oggettiva”201
, poiché l’azione della categoria della totalità si estrinseca molto prima
delle altre categorie.
E’ chiaro che per Marx nel percorso che va dal semplice al complesso, dall’astratto al
concreto, queste astrazioni ragionevoli devono perdere generalità attraverso un movimento
di specificazione, acquisendo i dati della particolarità e della singolarità 202
. Ma bisogna
tener presente per non fraintendere il ragionamento di Marx, che ogni determinazione del
reale, sia essa particolare o singolare, è, presa per sé, densa di connotati, quasi una pluralità
caleidoscopica e marezzata, che per essere afferrata nella comprensione teoretica necessita
di una astrazione che sappia separare singoli aspetti per comprendere meglio questi e il
tutto. Quindi quella visione per la quale Marx negherebbe l’esistenza di un universale, che
non si dia universale se non nel particolare, come tesi dettata dal fatto che le contraddizioni
che scindono e muovono il reale siano sempre specifiche e che questa specificità
appartenga universalmente alla sua essenza, tesi sostenuta da Mao Zedong203
e ripresa,
seppur in modalità nuove e con sviluppi non propriamente identici da Althusser204
, - finisce
per traviare ciò che voleva inseguire: la complessità del reale.
201 Ibidem, pag. 216
202 Hegel aveva rimproverato ai materialisti di interpretare l’universale in modo errato, finendo per
trasformarlo in uno dei tanti particolari affianco degli altri particolari: “Un hegeliano, leggendo le prime
sezioni del Capitale, direbbe che per determinazioni universali del valore sono prese le determinazioni di una
forma particolare e che perciò le determinazioni non sono universali” (cfr. Evald Vasilevic Ilenkov, Op. cit. ,
pag. 41), ma “ogni singolo passo dell’analisi, ogni singolo atto di riduzione del concreto all’astratto deve
avere di mira sin da principio il <tutto> che aleggia nella rappresentazione, nella viva intuizione e il cui
rispecchiamento è il fine massimo del lavoro teorico […]. In ciò sta il profondo senso dialettico della tesi
marxiana che il “passaggio dall’astratto al concreto” è il carattere specifico del processo teorico” (Ibidem,
pag. 97-8)
203 Cfr. Mao Zedong, Sulla contraddizione, Casa editrice in lingue estere, Pechino 1968
204 “Quando [Marx] dimostra che l’uso di concetti generali [ come produzione, lavoro ecc] è indispensabile
alla pratica teorica scientifica, questa prima generalità non coincide con il prodotto del lavoro scientifico: non
ne è il risultato ma la premessa. Questa prima generalità ( che chiameremo Generalità I) costituisce la
materia prima che la pratica teorica della scienza trasformerà in «concetti» specificati, ossia in quell’altra
generalità (che chiameremo Generalità III) «concreta» che è una conoscenza” (Cfr. Louis Althusser, Per
Marx, op. cit., pag. 161-2. Sempre per Althusser, quando Marx sostiene “ che ogni processo di conoscenza
81
L’uso di concetti generali, come quelli di produzione, lavoro ecc., sono indispensabili per
chi si occupa di scienza. Ma, per dirla con le parole del filosofo tedesco, hanno una
“esistenza storica o naturale indipendente, prima di quelle più concrete?”205
. La risposta è:
“Ca dèpend. […]. Il danaro può esistere, ed è storicamente esistito prima che esistesse il
capitale, prima che esistessero le banche, prima che esistesse il lavoro salariato ecc. .Da
questo punto di vista si può quindi dire che la categoria più semplice può esprimere
rapporti dominanti di un tutto meno sviluppato o rapporti subordinati di un tutto più
sviluppato, i quali ultimi storicamente già esistevano prima che il tutto si sviluppasse nella
direzione che è espressa in una categoria più concreta. Sotto questo aspetto il cammino del
pensiero astratto, che dal più semplice risale al complesso, corrisponderebbe al processo
storico reale.”206
Ma possono darsi anche società molto sviluppate nelle quali operano alte e complesse
forme di economia, come la cooperazione, un’ampia divisione sociale del lavoro senza che
esista danaro.
“Dunque questa categoria affatto semplice non appare storicamente nella sua piena
intensità che ai livelli più sviluppati della società. E mai comunque permeano tutti i
rapporti economici”207
.
Dunque le categorie più semplici, nonostante siano esistite storicamente prima di quelle
maggiormente concrete, possono appartenere solo a società complesse, mentre per quelle
concrete accade l’inverso. Per questo le astrazioni si danno solo dove il concreto è davvero
ricco e variegato, dove l’ambito del carattere comune tra i diversi è diffuso. E questo per
ribadire che l’astrazione si dà solo come prodotto, e come prodotto di una contingenza
storica nella quale il concreto è complesso ma dal quale si possono separare elementi
generali. Ma dire che l’astrazione sia un prodotto non vuol dire di certo pensare ad essa
come ad un particolare o singolare astratto dai concreti, o peggio al vero e più alto ordine
di realtà.
scientifica incomincia con un astratto, con una generalità, e non con concreti reali, egli mostra di avere
effettivamente rotto con l’ideologia e con la denuncia della sola astrazione speculativa, ossia con i suoi stessi
presupposti” ( Ibidem , pag. 168). Dovrà però ricredersi come testimoniano le riflessioni contenute nel
manoscritto Marx nei suoi limiti. Cfr. Louis Althusser, Marx nei suoi limiti, Mimesis, Milano 2004,
soprattutto pagg. 61 e ss. )
205 Cfr. Karl Marx, Op. cit., pag. 247
206 Ibidem, pag. 247-8
207 Idem
82
Eravamo partiti dal problema dell’opposizione e di quello della contraddizione, e siamo
giunti ad un’altra categoria logica: quella dell’astrazione. Sappiamo che cosa Marx abbia
abbandonato e ciò che ha scoperto o ritrovato nel suo percorso. E’ giunto il momento di
rintracciare queste tematiche nella sua grande opera: Il Capitale.
CAPITOLO TERZO
LA PROBLEMATICA FONDAMENTALE E LA LOGICA DEL
CAPITALE
I La nuova problematica e il “civettare”
Vedremo quanto il recupero del metodo delle astrazioni sia stato proficuo per le grandi
scoperte presenti nel Capitale, e quanto sia stato fondamentale, per un autore che aveva
rotto con la tradizione hegeliana, l’utilizzo di quella forma di esposizione che aveva rivisto
di passaggio dopo anni. Prima di addentrarci nello specifico, vogliamo mostrare come già
nei Grundrisse, nell’individuazione del ruolo del denaro come equivalente generale dei
valori delle merci, Marx segua un procedimento molto simile a quello adottato da Hegel
nella Logica, a proposito del rapporto qualità quantità. Leggiamo: “ E’ la merce come
denaro, e cioè non come denaro in generale, ma come una determinata somma di denaro,
giacché, per rappresentare il valore di scambio in tutte le sue distinzioni, il denaro deve
essere numerabile, quantitativamente divisibile”208
.
E’ chiaro che un valore d’uso, l’insieme delle sue qualità ( sempre per qualcuno ma mai
considerate per sé), qui si trasformano, nel rapporto con le altre merci, in una quantità
determinata, perdendo così le proprietà che discriminavano la merce in questione rispetto a
tutte le altre, “qualcosa di generico in cui ogni individualità, proprietà è negata e
208 Cfr. Karl Marx, Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica, La nuova Italia, Firenze
1968, Pag. 108
83
cancellata”209
, e dove il valore di scambio stabilisce il nesso sociale “degli individui
reciprocamente indifferenti”210
.
E’ evidente che qui Marx civetta con il metodo espositivo del filosofo di Stoccarda,
giocando più o meno esplicitamente con la visione contenuta nel capitolo sull’esser per sé,
in cui si sostiene che l’uno indifferenziato è principio della quantità, e dalla quantità stessa
sorgerebbe la qualità come risultato del rapporto tra qualità determinate211
, ma con la non
trascurabile, anzi fondamentale differenza che per Hegel le qualità, sono da pensarsi
dapprima come diverse e irrelate, e successivamente come una esprimentesi nell’altra. E
divenendo altra, l’eguaglianza che esiste tra queste diverse qualità, in quanto ognuno è
altro, rende possibile quell’espressione degli eterogenei tra loro. Al contrario, per Marx i
prodotti avrebbero una natura inizialmente diversa, che nello scambio mercantile, proprio
perché il singolo prodotto diventa per un altro in una dinamica processuale aperta alla
molteplicità delle merci, il valore di queste è riferibile al valore di ogni altra, perché
fondati su di un elemento comune: il lavoro oggettivato. La merce-denaro come misura in
cui si esprime il valore di scambio della merce è necessaria, data la differenza fra prezzo e
valore, tra la merce commensurata mediante il tempo di lavoro occorsa a produrla e il
prodotto del tempo di lavoro con la quale si scambia.
Infatti, proprio perché valore e prezzo sono diversi, l’elemento che determina il primo non
può essere l’elemento in cui vengono espressi i prezzi, perché altrimenti il tempo di lavoro
dovrebbe esprimersi contemporaneamente come ciò che determina e ciò che non
determina, come identico e non-identico di se stesso. Ciò sarebbe potuto forse andare bene
per Hegel, ma non per il campo relazionale analizzato da Marx.
L’unica utilità che un oggetto può avere in generale per il capitale può essere soltanto
quella di conservarlo o di moltiplicarlo. Il denaro non ha altro movimento all’infuori di
questa spasmodica volontà di moltiplicazione quantitativa. Dal punto di vista concettuale,
esso è l’insieme di tutti i valori d’uso; ma in quanto è pur sempre una determinata quantità,
il suo limite quantitativo è in contraddizione con la sua qualità. Ma il capitale è volontà di
rompere ogni misura, di andare oltre il limite quantitativo dando vita ad un processo
infinito212
. Siamo di fronte ad un altro esempio tipico del “civettare”. Sembra forte il
richiamo alle pagine sull’infinità quantitativa: “Il quanto si muta e diventa un altro quanto.
209 Ibidem, pag. 97
210 Idem
211 Cfr. Georg W. F. Hegel, Op. cit. , pag. 185
212 Cfr. Karl Marx, Op. cit. , pag. 47 e ss.
84
L’ulteriore determinazione di questo mutamento, che cioè prosegue all’infinito, sta in ciò
che il quanto è fissato come contraddicentesi in se stesso. Il quanto diventa un altro; ma nel
suo esser altro si continua; l’altro è dunque anch’esso un quanto. Questo però è l’altro non
soltanto di un quanto, ma del quanto stesso, il negativo suo come di un che limitato,e
perciò è la sua illimitatezza, la sua infinità”213
. “La determinazione della finità del quanto,
il rimandare al di là di sé a un altro, nel quale risiederebbe la sua determinazione, è in pari
tempo determinazione dell’infinito”214
, e nell’incontro “ il finito quantitativo si riferisce e
trasporta nel suo infinito, per avere in esso la sua assoluta determinazione. Questa loro
relazione ci è innanzitutto offerta dal progresso infinito quantitativo”215
. Ma il quanto ha
sempre di fronte a sé un nuovo limite, in ultima analisi, insuperabile, e questo desidero
spasmodico di tramutarsi in infinito rimane deluso.
I riferimenti ad Hegel potrebbero moltiplicarsi all’infinito. Per questo dobbiamo fare
chiarezza sull’impianto generale dell’opera e alla sua interna articolazione, prima di
continuare l’analisi degli aspetti particolari. Il capitale, frutto di un lavoro ventennale, si
articola in tre libri, di cui gli ultimi due incompleti216
, più un voluminoso libro, che fu
213 Ibidem, pag. 246
214 Idem
215 Ibidem, pag. 247
216 L’elaborazione del Capitale ha impegnato Marx – com’è noto- per oltre vent’anni. In questo lasso di
tempo ha rivisto più volte il piano di lavoro e quello espositivo. Inizialmente Marx aveva pensato di
pubblicare la sua opera in sei fascicoli: Per la critica dell’economia politica fu il primo. In alcune lettere del
1858 troviamo preziose indicazioni sulla strutturazione e suddivisione del suo capolavoro : “il tutto è
suddiviso in 6 libri. Del capitale (contiene alcuni capitoli preliminari). 2 Della proprietà fondiaria. 3. Del
lavoro salariato. 4. Dello Stato. 5. Commercio internazionale. 6. Mercato mondiale. […]. Nel complesso però
la critica e la storia dell’economia politica e del socialismo dovrebbe essere l’oggetto di un altro lavoro.
Infine il breve schizzo storico sullo sviluppo delle categorie e delle relazioni economiche un terzo lavoro.
After all, ho il vago presentimento che proprio ora, nel momento in cui dopo 15 anni di studi sono arrivato al
punto di por mano alla cosa, movimenti tempestosi dall’esterno probabilmente sopravverranno a
interrompermi” Cfr. Meoc, Op. cit. , vol. 40, pag. 578; Ibidem, pag. 329; Ibidem Pag.601-2. Alla fine della
Introduzione Marx abbozza un piano per la divisione della sua opera in tre parti, ancora sulla falsa riga
concepita anni addietro, di scrivere un’opera economica che trattasse la critica dell’economia politica, la
critica dei socialisti, e una storia dell’economia politica: La prima parte doveva suddividersi in 5 grandi
sezioni. All’inizio si dovevano esaminare le determinazioni generali-astratte più o meno comuni a tutte le
forme sociali, seguite da una trattazione specifica del modo di produzione capitalistico, analizzandone le
categorie economiche peculiari nonché le relazioni tra le tre grandi classi sociali che la compongono:
capitalisti, proprietari fondiari e proletari. Il terzo libro doveva affrontare in particolare lo Stato, con l’analisi
delle colonie, dell’immigrazione, delle classi improduttive, delle imposte ecc. Seguivano due libri che
85
diviso in tre tomi, sulla storia delle teorie217
: nel primo si affronta la tematica della
produzione, sotto il duplice ambito logico e storico. Per questo, ogni categoria presente nel
libro, se dal punto di vista storico può essere considerata concreta, dal punto di vista della
esposizione logica va considerata nel suo carattere astratto. Quindi nel primo libro le
categorie con le quali si analizza il processo storico di formazione del sistema capitalistico,
viste nella loro genesi storica, sono tutte concrete; le stesse, nel rapporto logico, diventano
astratte, quando vengono considerate unilateralmente. Il nesso astratto-concreto non si
pone tra un prima e un dopo storico della stessa categoria. Questa duplicità non può
verificarsi nel secondo libro, dedicato alla circolazione del capitale, in cui manca la
dimensione storica218
. L’uso delle categorie logiche del secondo libro è diverso rispetto al
primo, poiché se in quest’ultimo si passa dall’analisi della merce alla deduzione del
denaro, dal denaro al capitale e al lavoro salariato per poi analizzare il plusvalore,
nell’analisi della circolazione abbiamo una più semplice esposizione del modo di relazioni
rispettivamente avrebbero dovuto trattare la divisione internazionale del lavoro e lo scambio internazionale, e
il mercato mondiale e la crisi. Nel dicembre del 1862 annunciava, ancora a Kugelmann la prosecuzione dei
lavori di pubblicazione della sua opera in fascicoli. Cfr. Meoc, op. cit. , vol. XLI, pag. 695. Ma nel 1865 il
piano dell’opera è mutato radicalmente come possiamo intuire da una lettera inviata ad Engels, Cfr. Meoc,
op.cit., vol XLII, pag. 142. Indicazioni più precise le fornisce direttamente Marx a Kugelmann l’anno
successivo: “Io suddivido l’intera economia politica in 6 libri: Capitale; Proprietà fondiaria; Lavoro salariato;
Stato; Commercio estero; Mercato mondiale.” cfr. Meoc, Op. cit. , vol. 42, pag. 58: “Tutta l’opera si divide
nelle parti seguenti:
Libro I. Il processo di produzione del capitale.
Libro II. Il processo di circolazione del capitale.
Libro III. Formazione del processo complessivo.
Libro IV. Contributo alla storia della teoria
[…].
Ho ritenuto necessario ricominciare nel primo volume ab ovo, cioè dal riassumere il mio scritto apparso
presso Duncker [ si tratta del testo Per la critica dell’economia politica] in un unico capitolo sulla merce e il
denaro. Ho ritenuto necessario ciò non solo per essere completo, ma perché anche delle teste capaci non
hanno compreso appieno la cosa, e dunque vi doveva essere nella prima esposizione qualche cosa di
manchevole, specialmente nell’ analisi della merce” Cfr. Ibidem, pag. 580. Nell’epistolario non abbiamo
ulteriori indicazioni sugli indici delle opere, fatta eccezione per una dettagliata descrizioni della suddivisione
del terzo libro. Cfr. Meoc, op. cit., vol. 43, pag. 80-1. Per un’attenta e dettagliata ricostruzione della
problematica non si può non leggere la monumentale opera di Roman Rosdolsky cfr. Roman Rosdolsky,
Genesi e struttura del <capitale> di Marx, Laterza, Bari 1971).
217 Anch’esso rimasto incompiuto, e di cui Marx ci offre un indice particolareggiato. Cfr. Meoc, Op. cit. , vol.
XXXV, pag. 3-4-5
218 Probabilmente l’assenza di una trattazione storica è spiegabile con l’incompiutezza del secondo libro
86
delle figure già, per così dire, formate nella produzione, tentando di ricostruire i rapporti
tra le parti e la loro sussunzione in un tutto. Il secondo libro è segnato dalla dinamica tutto-
parti sulla base non di una deduzione di carattere storico o logico ma in base alle relazioni
dei rapporti interni ai singoli capitali sino ai rapporti con il capitale complessivo. Per
questo astratta non è la categoria ma il tipo di relazione.
Ritroviamo questo aspetto già nell’analisi del ciclo del capitale monetario, la cui formula è
D-M…P…M’-D’,cioè denaro, merce, capitale produttivo, merce delta, denaro delta. I
puntini indicano che il processo di circolazione d’ è interrotto219
. Nel libro primo Marx
aveva trattato il primo e il terzo momento. Non il secondo, che rappresenta il processo di
produzione del capitale, con le diverse forme che nei suoi vari stadi il capitale assume e
delle quali esso, quando si rinnova il ciclo, a volte si riveste a volte si disfa. Il primo ciclo
D-M indica il convertirsi di una somma di denaro in una somma di merci; dalla parte
dell’acquirente, trasformazione del suo denaro in merce, da quella dei venditori,
trasformazione delle loro merci in denaro. La merce è dunque uguale a L + Pm, forza
lavorativa più mezzi di produzione.
In genere D-L è ritenuto caratteristico del modo di produzione capitalistico, ma non perché
l’acquisto della forza lavorativa sia stata acquistata tramite un contratto in cui ci si accorda
sulla fornitura d’una quantità di lavoro maggiore a quella necessaria per rimpiazzare il
prezzo della forza lavorativa, espressa nel salario, ma grazie alla sua forma, dato che nella
forma del salario la forza lavoro, presentantesi come merce, e non come lavoro in sè, viene
acquistata tramite una data quantità di denaro. Il rapporto di classe è già insito allorché
capitalista e salariato si contrappongono nell’atto D-L, come figure che posseggono
rispettivamente mezzi di produzioni e forza-lavorativa220
. Un simile rapporto rende il
219 Cfr. Karl Marx, Il Capitale , Newton, Milano, 1996, pag. 579
220 A proposito di certe considerazioni metafisiche circa le origini Marx nota: “A questo punto non ci
interessa quale sia stata l’origine d’una tale separazione. Allorchè si attua D-L, essa esiste” Cfr. Ibidem, pag.
583-4. La medesima considerazione la possiamo fare a proposito del rapporto tra D…D’ che “può essere il
primo ciclo d’un capitale; può essere l’ultimo; può valere come forma del capitale sociale complessivo; è la
forma del capitale che viene investito per la prima volta, sia come capitale accumulato per la prima volta
sotto forma di denaro che come vecchio capitale convertito tutto in denaro perché venga trasferito da un ramo
della produzione a un altro” Cfr. Ibidem, pag. 601.
Chiaramente manca qui qualsiasi interesse verso l’inizio assoluto, o a fine assoluta del processo.
“La circolazione generale comprende sia il connettersi dei cicli dei diversi frammenti autonomi del capitale
sociale, che è l’insieme dei singoli capitali, sia la circolazione del valori immessi sul mercato non come
capitale, che cioè fanno parte del consumo individuale” pag. 607
87
denaro una funzione del capitale, e non la considerazione di una potenzialità naturale del
denaro stesso che sarebbe in grado di garantire un simile rapporto.
Ciò vale anche per i modi di produzione passati: esistendo la schiavitù, il denaro può essere
speso nell’acquisto di schiavi. Ciò che discrimina il modo di produzione capitalistico da
quelli precedenti è che esso produce merci. In D-M-D’ è presente sia la riconversione
finale del valore capitale nella sua primitiva forma di denaro, e questa è una funzione del
capitale merce, sia, in un secondo aspetto, questa funzione comprende la prima
conversione del plusvalore dalla sua primitiva forma di merce nella forma di denaro. Qui il
denaro ha un duplice ruolo: da una parte è la forma ricorrente di un valore anticipato
all’origine sempre in denaro, quindi è un ritorno alla forma di valore che era all’inizio del
processo; d’altra parte essa è la prima forma trasformata di un valore che all’origine
s’immette nella circolazione sotto forma di merce, e che in essa si raccoglie come
plusvalore.
Per questo al termine del processo il valore capitale si trova nuovamente in quella forma in
cui s’era immesso, e quindi di nuovo può iniziare e concludersi come capitale monetario,
essendo qui all’inizio e alla fine capitale monetario. Questo ciclo è modificato non nella
forma, bensì nella grandezza del valore anticipato. Credo che qui Marx sia deciso ad
insistere sull’aspetto quantitativo di riproduzione del capitale, perché le parti di valore
valorizzato non si differenziano qualitativamente come tali l’una dall’altra, se non
apparendo come valori di articoli diversi, quindi in forme d’uso diverse, come corpi di
merci diverse, distinzione che non è dovuta a loro stesse. E queste distinzioni qualitative
spariscono, o meglio si celano, dietro lo scambio mediante denaro, essendo questo la forma
di equivalente comune a tutte le altre merci. Ciò comporta il ripensamento della distinzione
tra qualità e quantità, reso possibile dalla considerazione che gli elementi sono creati, non
semplicemente inseriti, all’interno di una struttura specifica e con carattere che potremmo
denotare con il termine di dominante. Il termine universale sarebbe fraintendibile e
soprattutto non corretto, per ragioni che capiremo nel prossimo capitolo. Dunque capitale
monetario e capitale merce sono modi d’esistere del capitale. L’uno come capitale sotto
forma di denaro, l’altro sotto forma di merce. Entrambi nel processo di circolazione.
Quando vengono presi nel processo di produzione la loro forma è quella di capitale
industriale. Il capitale industriale è la sola maniera d’esistere del capitale in cui la funzione
del capitale stesso non consiste unicamente nel far proprio rispettivamente il plusvalore e il
plusprodotto, ma allo stesso tempo consiste nella sua creazione. Esso condiziona il
carattere capitalistico della produzione, e rispetto ad esso gli altri generi di capitale apparsi
88
prima di esso in seno ad altri modi di produzione passati o non dominanti, non solo gli
sono subordinati e trasformati a seconda delle mutevoli esigenze, ma agiscono oramai
unicamente sulla base e oseremmo dire in funzione di esso. Il loro medesimo perdurare è
sempre legato al signoreggiare di questo. E questo non è affatto un aspetto secondario della
nostra analisi.
Da quanto detto infatti è chiarissimo che se nel primo libro il denaro, quando è preso a sé, è
considerato astratto o unilaterale dal punto di vista logico, in questo secondo libro
l’astrazione è riconducibile al rapporto tra due parti del capitale (D-M) se autonomizzato
rispetto al rapporto inverso (M-D) e questi due rapporti insieme rimangono astratti nei
confronti di rapporti decisivi che rendono la struttura del tutto del capitale assai più
complessa rispetto a qualsiasi altro modo di produzione preso di per sè. Ma questo ci
impegna immediatamente in un’altra problematica, che potrebbe nascere già con la lettura
di questa ricostruzione che abbiamo presentato. Marx non ha di certo pensato né tantomeno
attuato un processo apparentemente contraddittorio tra due opposti quale lo sviluppo
storico che va da forme primitive di produzione e di scambio a forme sempre più
complesse, e uno logico che parte dalla merce, dallo scambio e dal denaro per dedurne il
plusvalore e il salario. Nel terzo libro, dove viene ricordato che “il processo di produzione
capitalistico, preso in sé, è unità di produzione e di circolazione”221
Marx tenta di enucleare
le forme concrete che nascono da questo processo complessivo del capitale, di cui
produzione e circolazione sono solo dei momenti particolari. Nel III libro lo stesso
significato di astrazione è diverso, ed è usato per indicare le false rappresentazioni circa la
produzione delle merci, il capitale monetario e la divisione delle quote di plusvalore. E’
chiaro che il termine astrazione ha una forte valenza polisemantica. Prima di esporle,
dobbiamo fare ulteriori precisazioni. Questa duplicità espositiva venne particolarmente
apprezzata da Engels222
, e questo per varie ragioni: innanzitutto l’intreccio tra logico e
storico sconfessa la trattazione delle leggi economiche contemporanee come eterne ; in
secondo luogo, questo metodo duplice avrebbe avuto il grande merito di rimettere in luce il
metodo dialettico, spogliandolo dai veli idealistici ed estraendo il nocciolo che racchiude le
grandi scoperte fatte dal precursore Hegel,223
e di applicarlo ad una scienza come quella
l’economia politica; infine, tenta di giustificare il metodo logico di Marx, mostrando come
le categorie economiche appaiono nello stesso ordine e con la stessa coesione interna sia
221 Ibidem, pag. 929
222 Cfr. Meoc, Op. cit., Vol. XX, pag. 212 e ss.
223 Engels segnala qui, e lo individua come nocciolo, il senso storico dell’impostazione hegeliana
89
che ci si attenga ad uno sviluppo logico, sia che si segua la ricostruzione della successione
storica. La direzione è la stessa: quella di passare dal meno complesso al più complesso.
Nasce però un problema del tutto peculiare: Potremmo credere che l’esposizione sia
qualcosa di diverso rispetto alla ricerca, e che il metodo utilizzato sia diametralmente
opposto al modo di narrare i risultati. Ciò porterebbe a non poter comprendere la logica
sottesa a questa grande opera. Anzi a doverla cercare altrove, non nelle dense pagine dei
volumi bensì nelle minute, negli appunti e negli abbozzi. Ma non è forse accaduto proprio
questo? Non ci si è sbizzarriti intorno alle pagine dei Grundrisse per legittimare
qualsivoglia interpretazione? Non si è cercato nei Manoscritti del ’44 la vera filosofia di
Marx? Di fronte all’imponente ricerca esposta ne Il Capitale, la critica ha troppo spesso
approfittato dei fogli di appunti per tentare di rendere intelligibili alcune concezioni e
alcuni risultati o peggio ancora per snaturarli e diluirli in altri concetti assenti nell’opera
principale, anzi nel capolavoro del pensatore di Treviri? Si è potuto pensare addirittura che
il vero Marx fosse in quelle pagine di appunti, quei fogli pieni di cancellature, di
modifiche, che invece attestano esclusivamente una reale ossessione maniacale per la
scienza, e che quelle pagine di appunti simboleggiassero un atteggiamento volutamente
non sistematico di Marx, e i lavori che egli lasciò inediti custodirebbero i pensieri più
fecondi.
Invece, la logica di Marx va cercata nelle pagine di questo capolavoro, il Capitale, perché è
in esse che si palesa. Pensiamo al carattere dell’opposizione. Nei termini della dialettica
hegeliana essa implica l’unità dell’identità e della diversità: “L’opposizione è l’unità
dell’identità e della diversità; i suo momenti son diversi in una sola identità; così sono
opposti. L’identità e la differenza sono i momenti della differenza contenuti dentro lei
stessa; sono momenti riflessi della sua unità” 224
. Senza remore, bisogna mostrare i luoghi
e gli ambiti dove Marx continua a “civettare” con le modalità espressive di Hegel, così da
poterne coglierne meglio lo scarto radicale.
La merce non è un che di naturale. Ciò vuol dire che essa non solo è un prodotto, ma
soprattutto è il risultato di una meccanismo di produzione specifico che ha in sé un
carattere sociale storicamente determinato. Non si presenta in ogni modo di produzione
esistente o esistito.
Marx dimostra che la merce ha una articolata struttura interna di due determinazioni non
convertibili reciprocamente. Da una parte è valore d’uso, dall’altro supporto del valore.
La prima risponde ad un bisogno umano del singolo; l’altra è un rapporto sociale.
224 Cfr. Georg W. F. Hegel, op. cit., pag. 473
90
Possono esserci enti prodotti dal lavoro e con valore d’uso senza essere merci, ma è
impossibile invece che una merce non sia e valore d’uso e prodotto per lo scambio. Il
valore d’uso non è oggetto dell’economia politica, ma della merceologia, salvo il caso in
cui essa riesce a modificare i rapporti di produzione – ma nulla ci è detto in favore di questi
casi. È probabile che Marx l’abbia solo menzionata come possibilità logica.
Le merci possono essere scambiate, ed esser misurate reciprocamente, perché possiedono
un’identica qualità, sono valore. Ma non semplicemente valore. Esse sono
specificatamente valore quantitativamente determinato. Ma nello scambio il loro essere
valore di scambio e valore non sono reciprocamente convertibili. Qui la merce deve
confermarsi come unità di entrambe le determinazioni, altrimenti si ricadrebbe in una
contraddizione tra le qualità naturali ed economiche della merce stessa. E non dobbiamo
nemmeno cadere nella facile illusione che vi sia, nell’atto dello scambio, una sorta di
trasformazione del valore d’uso in valore di scambio, cioè una conversione di una qualità
intrinseca di un prodotto in una quantità. La cosa va vista in modo assai diverso.
Se la merce è distinta da se stessa in quanto valore, in quanto valore essa è distinta da se
stessa in quanto prodotto. Il carattere qualitativo d’esser valore deve acquisire un’esistenza
diversa dal suo carattere naturale,e questo garantirebbe la loro scambiabilità nel mercato.
Altrimenti si finirebbe nella situazione logicamente assurda di permutare merci
quantitativamente e qualitativamente eguali. Nello scambio tutte le qualità delle merci
sono cancellate. Per essere scambiabili le merci devono ricevere la loro denominazione in
un’unità. Tra due merci da scambiare, la valutazione dell’atto dello scambio si ha con una
terza merce che funge da elemento comune su cui poter confrontare il valore delle due
merci. Il valore non si esprime semplicemente in tempo di lavoro, ma una determinata
oggettivazione di tempo di lavoro.
La merce “si espone come questo doppio che essa è, non appena il suo valore possiede una
propria forma fenomenica diversa dalla sua forma naturale, quella del valore di scambio,
ed essa non possiede mai questa forma considerata isolatamente, bensì sempre solo nel
rapporto di valore, ovvero di scambio con una seconda merce di genere diverso”225
.
La merce A ha un valore qualitativo, che assume sul mercato, nei confronti di un'altra
merce, un valore quantitativo, essa si esprime nell’altra merce. Essa è se stessa, ma si
esprime in B. E viceversa: “ La considerazione più precisa dell’espressione di valore della
merce A contenuta nel rapporto di valore con la merce B ha mostrato che, all’interno di
esso, la forma naturale della merce A vale solo come figura del valore d’uso, la forma
225 Cfr. Meoc, Op. cit., Vol. XXXI, pag. 71
91
naturale della merce B vale solo come forma di valore o figura di valore. L’opposizione
interna, chiusa dentro la merce, di valore d’uso e valore viene dunque esposta attraverso
un’opposizione esterna, cioè attraverso il rapporto di due merci in cui una merce, il cui
valore deve essere espresso, vale immediatamente solo come valore d’uso, l’altra merce
invece, in cui il valore deve essere espresso, vale immediatamente solo come valore di
scambio”226
. L’attenta lettura di queste pagine richiama alcuni concetti espressi nella
Logica. Infatti Hegel quando tratta dell’esser determinato, sotto l’aspetto della finità,
afferma che se noi chiamassimo “un certo determinato essere A, e l’altro B, in sulle prime
è B, che è determinato come l’altro. Ma anche A è a sua volta l’altro di B. Tutti e due sono
in pari maniera altri”227
. A dunque contiene già in sé l’essere dell’altro, ma essendo
separato, è posto “ in relazione col suo esser altro; non è puramente il suo esser altro.
L’esser altro è in pari tempo contenuto in lui, e in pari tempo ancora da lui separato; è esser
per altro”228
.
Rimandi al metodo espositivo hegeliano li ritroviamo anche nell’analisi della forma
relativa di valore della merce, che per Marx rimane incompiuta perché la serie che la
rappresenta non si chiude mai. Ad ogni catena che esprime la forma relativa di valore di
due o più merci possiamo sempre aggiungere altre e nuove merci, e se “il valore relativo di
ogni merce viene espresso in questa forma dispiegata, la forma relativa di valore di ogni
merce è una serie senza fine di espressioni di valore, diversa dalla forma relativa di valore
di ogni altra merce”229
. La forma relativa di valore sviluppata consiste nella sommatoria di
espressioni relative di valore semplici. Anche qui, come non pensare alle pagine della
Logica dedicate al passaggio del finito nell’infinito: il finito nel perire “non è perito; è
divenuto dapprima soltanto un altro finito, il quale però è a sua volta il perire come passare
in un altro finito e così via, in certo modo all’infinito”230
, poiché soltanto il “cattivo infinito è
l’al di là, essendo negazione astratta, la negazione prima. Determinato soltanto come negativo, cotesto
infinito non ha in sé la determinazione dell’esserci. Anzi, fissato soltanto come un negativo, non deve esserci;
dev’essere irraggiungibile. Questa irraggiungibilità non è però la sua sublimità o il suo pregio, ma il suo
difetto, che ha il suo ultimo fondamento in ciò, che al finito come tale si attribuisce un fermo essere. Il non
ero è l’irraggiungibile; e si può vedere che un infinito simile è il non vero. – L’immagine del progresso
all’infinito è la linea retta. Solo ai due limiti di questo infinito è e continua sempre ad essere, là dove la linea,
226 Ibidem, pag. 72
227 Cfr. Hegel, Op. cit., pag. 113
228 Ibidem, pag. 114-5
229 Cfr. Meoc, Op. cit., vol. XXXI,- pag.75
230 Cfr. Hegel, Op. cit. , pag. 137
92
che è esserci, non è , mentre poi la linea stessa esce in questo suo non esserci, vale a dire nell’indeterminato.
Come vera infinità, ripiegata in sé, la sua immagine diventa il circolo, la linea che ha raggiunto se stessa, che
è chiusa e intieramente presente, senza punto iniziale né fine”231
.
Quella cattiva infinità delle merci si supera selezionando un’unità di misura, di riferimento
che regoli lo scambio tra le merci. E questo è possibile solo perché la stessa unità è merce,
ossia in essa ritroviamo il lavoro come elemento in comune con tutte le altre poste sul
mercato.
Queste merci dunque hanno un elemento di identità forte, e simultaneamente anche un
carattere di diversità esprimente le qualità peculiari.
Anche nel secondo libro del Capitale vi sarebbero aspetti molto simili con il secondo libro
della Logica232
. La categoria più caratteristica sarebbe quella della reciprocità e dell’azione
reciproca. Produzione e circolazione per Marx si compenetrano costantemente. Per questo
siamo conviti che l’analisi della circolazione ci offrirebbe nuove determinazioni del
concetto di valore. Il capitale sotto il rispetto della circolazione cambia continuamente
forma. Nel passare dalla produzione alla circolazione subisce varie metamorfosi. Infatti,
cambia forma quando da forma denaro diventa forma lavoro o forma merce, o quando da
forma merce per la produzione assume la forma definitiva di merce per la vendita. Per
questo Marx afferma che “i cicli dei capitali individuali si intersecano gli uni con gli altri,
si presuppongono e si condizionano a vicenda, e proprio con questa sovrapposizione
formano il movimento del capitale sociale complessivo”233
.
Infine, nel terzo libro essendo la produzione ad assegnare i ranghi, ma il saggio medio del
profitto che stabilisce dove, come e quanto produrre, potremmo trovare un’interessante
analogia circa il manifestarsi del concetto e le sue figurazioni. Se per Hegel il concetto, pur
comparendo alla fine, è l’intima sostanza di tutto ciò che lo ha preceduto, per Marx ciò che
si presenta per ultimo nell’esposizione è la superficie del sistema, nascondendo in sé la
vera sostanza.
Il saggio medio non è un effetto della produzione in quanto tale. Se per un verso quindi il
profitto è regolato dalla produzione che è la base di tutto, per un altro verso il profitto
regola la produzione. Dice Hegel: “Da questo lato il concetto dev’essere anzitutto
riguardato in generale come il terzo rispetto all’essere e all’essenza, rispetto all’immediato
e alla riflessione. Essere ed essenza son pertanto i momenti del suo divenire, ed esso è la
231Ibidem , pag. 153
232 Con i capitoli sull’azione reciproca. Cfr. Hegel, Op.cit. , pag. 643
233 Cfr. Karl Marx, Op. cit. , pag. 799
93
base e verità, come l’identità in cui quelli son tramontati e contenuti. Quei momenti son
contenuti nel concetto, perché questo è il lor risultato, ma non son più contenuti come
essere e come essenza, questa determinazione non l’hanno che in quanto non sono ancora
rientrati in questa loro unità”234
.
Il concetto rispetto all’essere e all’essenza è il fondamento, di cui essere ed essenza sono
momenti. Esso li subordina, e nella sua articolazione come un tutto, che appare solo alla
fine nonostante sia presupposta dall’inizio, mantiene l’unità tra i 2 momenti. Nel Capitale
invece il saggio di profitto “senz’ombra di dubbio è un risultato e non un punto di
partenza”235
, e soprattutto in Marx produzione, consumo, distribuzione, circolazione si
compenetrano reciprocamente, ma non svaniscono né vengono contenute e riassorbite in
un risultato superiore ad essi.
In conclusione, prima di addentrarci nelle specifiche ricostruzioni della complessa analisi
del valore e delle categorie di astratto e concreto, abbiamo voluto mostrare gli ambiti
all’interno del Capitale dove Marx recupera e utilizza ai fini dell’esposizione quel modo
hegeliano di civettare , e ciò è voluto non solo dal fatto che le modalità espositive sono
inscindibili dal discorso intorno alla logica elaborata dal filosofo di Treviri, ma perché non
vogliamo sottrarci a riconoscere alcune problematiche che possono sorgere da quel
modello ermeneutico che abbiamo deciso di seguire: il paradigma della linea non
continuistica. È chiaro dunque che con questa esposizione non si vogliono riabilitare né
legittimare vecchi modelli che vedevano in Marx un mero epigono di Hegel, incapace di
compiere sino in fondo il parricidio del maestro, perché,e credo lo sia visto in modo
quantomeno sufficiente, le riflessioni dei due filosofi si svolgono su domini differenti e
autoescludentesi. E non è affatto casuale in tal senso che la rilettura della Scienza della
logica sia avvenuta nello stesso periodo in cui Marx distruggeva la teoria della rendita
fondiaria di Ricardo. Infatti, nel terzo libro del Capitale, quasi come se avesse ricordato
questo fatto, in una lunga nota afferma senza mezzi termini il “carattere ridicolo” della
spiegazione di Hegel sull’argomento. Se Marx fosse rimasto imbrigliato dalla logica del
maestro e dalla problematica a cui essa veniva applicata, sarebbe ricaduto nello stesso
errore di Hegel. Riporterò questa lunga citazione integralmente, perché ci aiuta a
comprendere ancora una volta cosa voglia dire l’aver cambiato dominio ontologico: “Non
v’è nulla di più ridicolo della spiegazione di Hegel riguardo alla proprietà privata della terra. L’uomo in
quanto persona deve attuare la sua volontà come anima della natura esterna, e quindi deve prendere possesso
234 Cfr. Georg Hegel, Op. cit. , pag. 651
235 Cfr. Karl Marx, Op. cit. , pag. 1030
94
di questa natura come sua proprietà privata. Se questo è il destino <della persona>, dell’uomo in quanto
persona, si deve ricavare che ogni essere umano dovrebbe essere un proprietario fondiario per potersi
realizzare come tale. La libera proprietà privata della terra – un prodotto assai moderno- non è per Hegel un
certo rapporto sociale, ma un rapporto tra l’uomo, preso quale persona, e la <natura>, <il diritto assoluto
dell’uomo di appropriarsi di tutte le cose>236. E’ chiaro in primo luogo, che il singolo individuo non può
grazie alla sua <volontà”>affermarsi come proprietario contro la volontà di altri che intendono ugualmente
impossessarsi dello stesso pezzo di terra. Per questo non basta certo la buona volontà. Non si può senz’altro
valutare dove <la persona> intenderà porre i limiti alla realizzazione delle proprie volontà, se quest’ultima
vorrà realizzarsi in un intero paese o se le occorrerà tutto un complesso di paesi per <manifestare>,
prendendone possesso, <la supremazia della mia volontà nei confronti dell’oggetto>. Qui Hegel sbaglia
completamente. <La presa di possesso è di natura affatto individuale; io prendo possesso solo di ciò che si
trova a contatto con il mio corpo, ma è vero che le cose al di fuori di esso hanno un’estensione più larga di
quanto io possa comprendere. Quando posseggo un oggetto, vi è anche un’altra cosa che è unita ad esso. Io
prendo possesso con la mano, ma il campo di azione della mia stessa mano può essere allargato>. Ma
quest’altra cosa è nuovamente unita a un’altra, e così viene meno il limite entro il quale la mia volontà può
attuarsi come anima nella terra >se io posseggo qualcosa, con la mia ragione deduco immediatamente che mi
appartiene non solo quanto posseggo tra le mani, ma anche ciò che è collegato ad esso. Qui deve affermarsi il
diritto positivo, in quanto nient’altro può dedursi dal concetto>. Questo rappresenta una connessione
veramente ingenua del <concetto> e dimostra che il concetto, il quale a priori sbaglia nel ritenere come
assoluta una concezione giuridica della proprietà terriera ben determinata e inerente alla società borghese,
non comprende <nulla> delle reali forme di questa proprietà privata. Allo stesso tempo è racchiusa in ciò
l’ammissione che le mutevoli esigenze dello sviluppo sociale, vale a dire economico, possono e debbono
portare a un cambiamento del <diritto positivo>”237
. Un’analisi corretta della rendita fondiara deve
dunque fondarsi su di un altro suolo: non più partire dal rapporto lacerato fra uomini e
natura, con tutto quello che una simile dicotomia metafisica comporta nell’interpretazione.
Lo potevamo già intuire quando abbiamo parlato della formula del capitale monetario: nel
secondo atto, D-M, l’unico problema che investe Marx è il sapere come questo garantisca
la sopravvivenza del salariato e come l’atto del consumo ricada non nella circolazione del
capitale individuale bensì nella circolazione generale delle merci, essendo acquisto da parte
dell’operaio dei propri mezzi di sostentamento. E’ un dato di fatto, che Marx ha ribadito in
modo chiarissimo: il suo metodo non parte dall’uomo, ma da una struttura economica
determinata238
, e di conseguenza ogni visione metafisica che comporti conflitti con la
natura o discorsi circa le opposizioni della volontà, i conatus ecc. come quelli da cui
partiva o giungeva Hegel, in Marx non hanno nessun ruolo.
236 Cfr. Georg Hegel, Lineamenti fondamentali della filosofia del diritto, op. cit. par. 44
237 Cfr. Karl Marx, Il capitale, op. cit. , pag. 1331
238 Cfr. Karl Marx, Scritti inediti di economia politica, Editori riuniti, Bologna 1963, pag. 178
95
Altrimenti Marx non sarebbe riuscito a comprendere le caratteristiche peculiari della
rendita fondiaria. Ma ciò è accaduto solo perché egli ha abbandonato una problematica che
avrebbe letto sempre in una determinata modalità la questione, senza mai risolverla, poiché
incapace di comprenderne le cause e le conflittualità intrinseche.
II Il lavoro astratto, la merce e il problema dell’inizio
Abbiamo voluto mostrare nel modo più ampio possibile i luoghi nei quali Marx “civetta”
con lo stile hegeliano. Abbiamo visto che quasi tutti i riferimenti sono presi dalla Scienza
della logica. Dobbiamo ora compiere un ulteriore passo nella nostra indagine, ponendoci
un quesito di certo non semplice ma sicuramente decisivo ai fini della comprensione di
quella che è una ricerca degli aspetti logici utilizzati da Marx: perché il capitale inizia con
l’analisi della merce?
Con questa domanda è in gioco l’intera ipotesi su cui si regge la nostra tesi, e anche le due
linee di tendenza ermeneutiche che abbiamo in più punti chiamato in causa. Iniziare
un’analisi scientifica, che si pensava essere andata oltre l’idealismo, dovrebbe far
ridiscutere integralmente le ragioni di chi sostiene l’ipotesi della rottura. La circostanza in
cui Marx “civetta” con Hegel e con il suo stile precipuo è nulla rispetto a questa difficoltà.
Marx era stato un giovane aderente alla sinistra hegeliana, e da giovanissimo aveva rotto
con essa. Il campo sul quale aveva ingaggiato la sua battaglia era altro rispetto a quello
idealistico, e di esso era arrivato a rifiutare persino il concetto di astrazione.
Successivamente, dopo anni, rileggendo la Logica, decide di riutilizzarla ai fini
dell’esposizione. Per questo, prima di affrontare questa difficoltà, abbiamo deciso di
esporre i brani che sembrano richiamare ad Hegel. Ma questo non vuol dire che Marx sia
tornato sui suoi passi. Al massimo, il suo atteggiamento ci svela un carattere peculiare di
molte scienze che nascono da una rottura epistemologica con una ideologia. Marx
riconosce, con il distacco di chi ha acquisito un proprio statuto teorico, alcuni aspetti che di
Hegel possono , a mò di un classico, continuare a dire ancora qualcosa. Hegel è pur sempre
colui che ha esposto la logica in un modo compiuto, anzi è stato il più alto esponente di un
certo modo di intenderla. Non bisogna avere paura di porre in confronto le pagine de Il
96
capitale con nessuna opera filosofica, come se si andasse alla ricerca di alcuni elementi che
possano suffragare la tesi per la quale Marx non sia mai andato oltre l’idealismo tedesco.
Ma allora perché Marx inizia la sua opera con l’analisi della merce? Ciò porta
immediatamente al difficile compito di comprensione del valore, e sappiamo bene che
Marx ha rivisto più volte proprio la prima sezione del Capitale perché ne era rimasto
insoddisfatto. Ulteriore complicazione era data dall’esposizione dialettica della materia
trattata239
.
La trattazione di questa tematica era lo scoglio più grande con il quale il filosofo di Treviri
si è imbattuto, e qui è riposta la chiave d’accesso al mistero dell’economia politica, la
quale non aveva mai saputo spiegare il meccanismo della valorizzazione della merce
perché incapace di comprendere i rapporti di produzione, finendo così per non spiegare
ulteriormente in che modo si accumulasse capitale in mano a chi deteneva i mezzi
produttivi. Sia le determinazioni del valore, articolate in sostanza, grandezza e forma di
239
Già Engels, all’indomani della pubblicazione, non fece mistero delle eccessive difficoltà della prima
sezione (nella prima edizione chiamata ancora capitolo): “Tu però disponi di tanti materiali al proposito, che
di certo potrai ancora fare una buona digressione che dimostri al filisteo con argomenti storici la necessità
della formazione del denaro e il processo con cui essa avviene. Tu hai commesso il grosso errore di non
rendere evidente la linea del pensiero di questi sviluppi più astratti mediante un maggior numero di piccole
ripartizioni e di sottotitoli separati. Avresti dovuto trattare questa parte al modo dell’ “Enciclopedia” di
Hegel, con brevi paragrafi, rilevando ogni passaggio dialettico con speciali titoli” Cfr. Meoc, Op. cit., vol.
XLII, pag. 333. Marx, civettando per celia anche in questa lettera, in parte seguirà i preziosi consigli
dell’amico. Riportiamo la sua risposta: “Per quanto concerne lo sviluppo della forma di valore, ho seguito e
non seguito il tuo consiglio, per mantenere anche a questo riguardo una linea dialettica. Cioè, 1) ho scritto un
appendice [Cfr. Karl Marx, L’analisi della forma valore, Laterza, Bari 1976 ] in cui espongo la medesima
cosa nel modo più semplice e nel modo più da maestro di scuola che mi sia possibile; 2) ho ripartito ogni
gradino dello sviluppo in paragrafi […] Nella prefazione dico poi al lettore “non dialettico” che può saltare a
piè pari le pagine X- Y ed invece di queste leggere l’appendice. Qui si tratta non solamente di filistei, bensì
anche della gioventù avida di sapere ecc. Inoltre la cosa è d’importanza troppo decisiva per tutto il libro. I
signori economisti non hanno finora badato all’estrema semplicità del fatto, che la forma: 20 braccia di tela
= un vestito è il fondamento non ancora sviluppato di 20 braccia di tela= 2 sterline, che dunque la più
semplice forma della merce, in cui il suo valore non è ancora espresso come rapporto con tutte le altre merci,
ma invece soltanto come distinzione dalla sua propria forma naturale, contiene tutto il segreto della forma
denaro e con ciò in nuce, di tutte le forme borghesi del prodotto del lavoro.[…]. Riguardo a Hofmann, tu hai
perfettamente ragione. Del resto, dalla chiusa del mio II capitolo, dove viene accennata la trasformazione del
maestro artigiano in capitalistica, in conseguenza di cambiamenti puramente quantitativi, vedrai che ivi cito
nel testo la scoperta di Hegel della legge della modificazione del cambiamento puramente quantitativo in
qualitativo come ugualmente confermata nella storia e nella scienza naturale”Cfr. Ibidem, pag. 336-7.
97
valore, sia il valore d’uso sono elementi interni al concetto di merce, e sul loro rapporto
Marx ha basato tutta la prima parte del libro. Per questo ha dovuto riscrivere più volte la
parte sulla forma di valore.
Nella prima edizione egli usa ancora ambiguamente i termini valore e valore di scambio.
Solo nella seconda arriverà a porre in forma distinta valore d’uso e valore, precisando che
il carattere della merce non consiste nel rapporto tra valore d’uso e di scambio240
, ma che
la stessa sostanza del valore esiste solo perché si danno merci in relazioni tra loro. Come
afferma Fineschi “La sostanza di valore (e la sua determinazione quantitativa, la
grandezza) esiste solo perché c’è una relazione di valore in cui essa si manifesta, la forma
di valore (o valore di scambio)”241
e questa è da considerarsi come la manifestazione
fenomenica della sostanza di valore. Per questo il valore “è inseparabile dalla forma di
valore”242
. Da questo dato si apre la possibile comprensione del ruolo del denaro come
equivalente, che Marx ricostruisce con una “ sorta di necessità logica”243
244
. Ma
l’economia politica borghese non poteva rispondere ad una tale domanda, anzi non poteva
nemmeno porsi la domanda stessa in quanto il punto di partenza della loro indagine aveva
un vizio di fondo, di carattere ideologico, che celava questa possibilità. In una parola, essi
credevano che il modo di produzione capitalistico fosse eterno, naturale, e quindi le
ricerche circa i caratteri distintivi del modo di produzione capitalistico, divenendo ricerca
dei caratteri naturali, non riuscivano ad afferrare alcune decisive forme di quello
capitalistico. Non bisogna credere che il superamento di queste concezioni sia stato
semplice per il pensatore di Treviri. Segno tangibile di tali difficoltà sono anche i tanti
mutamenti di impostazione per il cominciamento della sua analisi. Nei Lineamenti ad
esempio si inizia con il capitolo sul denaro. Marx, come abbiamo visto sopra, voleva
inizialmente trattare in un unico capitolo le determinazioni generali-astratte come valore,
scambio, prezzo, denaro ecc. Tuttavia, nel corso della stesura si convinse di dover trattare
il valore di scambio prima del denaro, in un capitolo separato, per poi pervenire alla
conclusione che anche il capitolo del valore di scambio in quanto tale doveva a sua volta
240 Cfr. Meoc, Op. cit. , vol. XXXI, pag. 71
241 Ibidem, pag. XXIV
242 Ibidem, pag. 146
243 Cfr. Massimo Mugnai, Op. cit. , pag. 122
244 La problematizzazione dell’esistenza di un equivalente era già stata esposta nei Grundrisse: “Ora il
problema reale è questo: non è lo stesso sistema di scambio borghese a rendere necessario uno specifico
mezzo di scambio? Non crea esso necessariamente un equivalente particolare per tutti i valori?” Cfr. Karl
Marx, Op. cit. , pag. 58
98
essere preceduto da un altro capitolo, ossia quello della produzione in generale. In questo
dovevano essere trattate le condizioni generali, cioè astratte, di ogni produzione
indipendentemente dalle diverse forme sociali specifiche della produzione stessa. Ma
torniamo al nostro tema.
Già nella Miseria della filosofia il carattere duplice della merce è implicitamente accettato
in quanto, dopo che nelle pagine iniziali del testo erano stati elencati i quattro nodi
principali della teoria di Proudhon, Marx non sottoporrà a critica proprio il secondo, quello
relativo al rapporto tra valore d’uso e di scambio245
, i quali sarebbero in rapporto inverso; e
nel testo Per la critica dell’economia politica affermava che “la merce è valore d’uso,
grano, tela, diamante, macchina ecc. ma come merce allo stesso tempo non è valore
d’uso”246
.
Nella seconda edizione del Capitale però, è bene ricordarlo, la caratterizzazione del valore
in sostanza, grandezza e quantità viene eliminata e non sostituita con alcuna ulteriore
caratterizzazione. Non bisogna nemmeno pensare che il valore sia misurabile
esclusivamente con la quantità di lavoro cristallizzata nella produzione. La teoria del
valore-lavoro non è nata nell’ambito del marxismo e tantomeno Marx l’ha mai teorizzata,
cosciente com’era dei grandi problemi che una simile impostazione avrebbe portato. E non
è casuale che molti dei detrattori abbiano attaccato una teoria come quella del valore-
lavoro, che non era di Marx, spacciandola come tale. Ad esempio Croce insiste a più
riprese arrivando alla conclusione che “il valore-lavoro del Marx non è una logica
generalità, ma anzi è un fatto pensato ed assunto come tipo, ossia cosa diversissima da un
concetto logico”247
. Marx invece analizza il concetto di valore fondandolo sui rapporti di
produzione e sul duplice carattere del lavoro. Il valore diventa così anche espressione del
lavoro astratto. E ad esso e con esso si possono esplicare sia la forma sociale del processo
di produzione che il suo contenuto. Considerazione non da poco, perché essa sarà decisiva
per comprendere cosa voglia dire che Marx ha rotto con l’umanesimo e con la teoria
dell’estraneazione. Infatti le categorie economiche non esprimono rapporti umani generici,
disegnati a tinte più o meno fosche a seconda del grado di materialismo dell’autore, ma
rapporti di produzione specifici. Dunque i due aspetti del valore, qualitativo e quantitativo,
cioè forma e grandezza di valore, ci conducono al lavoro astratto che a sua volta come il
245 Cfr. Meoc, Op. cit. , vol. VI, pag. 112
246 Cfr. Karl Marx, Op. cit. , pag. 24
247 Cfr. Benedetto Croce, Materialismo storico ed economia marxista, Sandron, Milano-Palermo 1900, pag.
92
99
concetto di valore ci appare sia in forma qualitativa, cioè come lavoro sociale, sia in forma
quantitativa, come lavoro socialmente necessario.
Dobbiamo quindi, prima di esporre la forma del valore, analizzare il duplice carattere del
lavoro.
Ma prima ancora dobbiamo ricostruire, seppur per sommi capi, l’itinerario che porta Marx
all’analisi della forma di valore. Questo ci aiuterà a comprenderne meglio l’evoluzione del
pensiero.
Già nell’Estratto su Stuart Mill si parla proprio di prezzo valore248
, e Marx afferma che il
rapporto tra offerta e domanda non coincide sempre, e che dunque valore e costo di
produzione non sono posti in un rapporto necessario e la vera legge dell’economia politica
è il caso. Approfondendo gli studi delle opere teoriche di Ricardo egli individua una
contraddizione: da una parte questi proclama il lavoro come fonte di tutti i valori,
considerando la quantità relativa di lavoro come il criterio di misura che regola il valore
relativo delle merci, mentre dall’altra segue Smith identificando costi di produzione e
valore. Marx non vede ancora il problema che si nasconde dietro questa confusione fra
valore e costi di produzione e che in seguito risolverà nella sua teoria del prezzo di
produzione. In queste pagine il termine capitale indica i mezzi di produzione, e la proprietà
privata è intesa come la determinazione economica formale che i mezzi di produzione
assumono nelle condizioni del modo di produzione capitalistico; mentre negli economisti
borghesi nel concetto di capitale rientrano sia i mezzi sia la proprietà. Per Marx, in linea
dichiaratamente favorevole all’impostazione proudhoniana, il prezzo supera sempre i costi
effettivi della produzione. E non sostiene ancora che i costi reali siano il valore. Anzi,
Marx accoglie interamente la determinazione del valore come rapporto fra i costi di
produzione e l’utilità di una cosa, definizione questa già data da Engels nei Lineanementi
fondamentali dell’economia politica, dove questi riconosceva che “assumendo che due
cose abbiano lo stesso costo di produzione, sarà la loro utilità l’elemento decisivo per
determinarne il valore relativo”249
. Di fatto il valore rimane ancora una categoria posta al
di fuori della produzione e degli intricati rapporti che la caratterizzano.
Marx respinge la teoria del valore-lavoro di Ricardo non solo perché ritiene che nelle
condizioni della proprietà privata il prezzo sia sempre superiore ai costi reali di
produzione. Si volge contro la teoria del valore-lavoro perché Smith e Ricardo da una parte
determinano il valore sulla base dei costi di produzione indipendentemente dalla
248 Cfr. Meoc, Op. cit. , Vol. III, pag. 229
249 Ibidem, pag. 462
100
concorrenza, mentre dall’altra considerano il cosiddetto saggio naturale della rendita, del
profitto e del salario non come fondato sulla natura della terra, del capitale e del lavoro, ma
come del tutto dipendente dalla consuetudine o dal monopolio, e in ultima istanza dalla
concorrenza. In realtà quindi, nella teoria smithiamo-ricardiana i costi di produzione non
sarebbero determinati dalla produzione, ma dalla concorrenza; l’unico valore che mantiene
nei Manoscritti è quello del valore commerciale stabilito nello scambio, ossia il prezzo di
mercato, ancora indistinto dal valore.
Il fatto che i prezzi oscillino continuamente in dipendenza dall’offerta e dalla domanda
viene considerata una prova del fatto che il valore non è determinato dal lavoro e non si
può quindi parlare di un valore diverso dai prezzi: solo il prezzo determinato dalla
conoscenza ha un significato reale, finendo così per ritenere che il valore reale e il prezzo
naturale nella teoria di Smith e di Ricardo siano una finzione teorica e, come Engels pensa
in un primo tempo, che il valore reale sia una pura astrazione dalla realtà, - non vedendo
ancora il nucleo razionale del metodo di astrazione adottato da Ricardo, il quale nella
determinazione dei valori astraeva dalle oscillazioni dei prezzi di mercato, che gli
permetteva di interpretare il valore di scambio come il prezzo naturale, prescindendo dagli
elementi accidentali della concorrenza, ossia dalle oscillazioni dei prezzi di mercato in
quanto diversi dal prezzo naturale. Queste deviazioni, infatti, erano ritenute come prodotti
da cause solo transitorie o casuali e nel loro movimento incapaci di impedire alla merci di
livellarsi continuamente sul prezzo naturale. Ricardo è da individuarsi come fonte che
muove Engels ad affermare che il valore astratto e la sua determinazione attraverso i costi
di produzione sono appunto semplici astrazioni, cose non esistenti250
. L’economista astrae
il valore reale dal movimento dei prezzi, e questo non è altro che una determinazione del
prezzo, ossia il prezzo nel momento in cui il rapporto di concorrenza si equilibra, in cui
domanda e offerta coincidono. Forse per questo nei Manoscritti del ‘44 Marx, nel
respingere simili teorie, è stato influenzato dalla critica mossa alle astrazioni prodotte nel
sistema hegeliano, che lo portò ai limiti di una sorta di iperrealismo o, perché no, realismo
ingenuo. Tuttavia, quello che poteva essere un risultato ottenuto negativamente in filosofia,
si svelerà non riproponibile in sede economica. E questo non senza creare conseguenze in
filosofia! Il giudizio affrettato sul carattere astratto della filosofia hegeliana, separato cioè
dalla base mondana che in realtà è il prius di ogni ente, si dimostrerà infecondo nello
studio dell’economia politica. Partendo dalla conquista feuerbachiana di un dominio della
sfera materiale su quella sovrasensibile, e andando oltre Feuerbach, Marx si getta nello
250 Ibidem, pag. 461-2
101
studio dell’economia politica, poiché trova nell’economia la contraddizione radicale da cui
tutto il resto è derivato. Ma l’armamentario teorico di cui si era dotato per l’impresa
risulterà del tutto insufficiente.
Marx nega in generale il valore reale o prezzo naturale teorizzato dai ricardiani, ma solo un
valore di scambio delle merci, l’equivalente contro cui la merce viene scambiata, ovvero il
suo prezzo di mercato che è determinato dalla legge della domanda e dell’offerta.
I racardiani, cercando di ridurre i fenomeni misurabili a medie, astraggono sempre dagli
uomini e dalla vita reale. queste medie sono veri e propri oltraggi, offese ai singoli
individui reali.
Qui per Marx il costo della merce umana è stabilito dalla legge della domanda e
dell’offerta251
.
Non parla ancora di valore e per questo l’analisi sul salario è viziata da un errore di fondo,
una mancanza che cerca di colmare con una visione umanista tanto generica quanto
ostacolante la comprensione del meccanismo economico, come testimonia questo passo.
“Un forzato aumento del salario (prescindendo da tutte le altre difficoltà, prescindendo dal
fatto che,essendo un’anomalia, esso potrebbe anche essere mantenuto solo con la forza)
non sarebbe dunque altro che una migliore retribuzione degli schiavi e non sarebbe la
conquista né per l’operaio né per il lavoro della loro umana vocazione e dignità”252
.
Nei Manoscritti del ’44 parlando del capitale si chiede innanzitutto, proprio come domanda
di prolusione, su che cosa si fondi il capitale e come si diventa proprietari di capitali
produttivi?
Marx si accontenta della risposta mutuata da Say: per eredità. E’ chiaramente un
impostazione metafisica: si cerca qui il fondamento originario col quale spiegare la realtà
contemporanea.
Sempre nei Manoscritti Marx usa il termine lavoro in due accezioni: una con la quale
indica il lavoro in una situazione sociale fondata sulla proprietà privata, e qui affianca alla
parola lavoro il termine estraniato; in una seconda accezione Marx parla di un lavoro
consapevole, come una attività libera: è il lavoro in una società che ha abolito la proprietà
privata.
Nella Sacra famiglia la posizione di Marx circa la concezione del valore oscilla. Infatti
all’inizio afferma che “il valore è una determinazione puramente casuale, la quale non ha
251 Ibidem, pag. 255
252 Ibidem, pag. 307
102
bisogno di stare in alcun rapporto né coi i costi di produzione né con la utilità sociale”253
; e
subito dopo che “in rapporto alla produzione immediatamente materiale, la decisione se un
oggetto debba essere prodotto o no, cioè la decisione sul valore dell’oggetto, dipenderà
essenzialmente dal tempo di lavoro che costa la sua produzione”254
. Nell’Ideologia tedesca
Marx ed Engels giungono a formulare in maniera piuttosto delineata e completa il concetto
di modo di produzione, il quale è caratterizzato da forme della proprietà o rapporti di
produzione storicamente diversi che corrispondono di volta in volta ad un determinato
grado di sviluppo delle forze produttive della società. Ogni modo di produzione ha leggi
specifiche e categorie economiche peculiari. Nell’ Ideologia tedesca Marx ed Engels
abbandonano l’opinione che il prezzo determinato dalla concorrenza fosse assolutamente
casuale: nella polemica con Stirner infatti si legge: “dalla concorrenza egli non ha neppure
imparato […] che nell’ambito della concorrenza il prezzo del pane è determinato dai costi
di produzione e non dal piacimento del fornaio”255
.
Qui essi fanno propria la teoria del valore lavoro, abbandonando anche la falsa visione del
profitto come eccedenza di prezzo. Anche la moneta è vista come “un mezzo di scambio
fondato sul lavoro”256
, e vedono nella moneta un valore “unicamente determinato dai costi
di produzione, ossia dal lavoro”257
e questo è sintomatico della presenza di un concetto di
lavoro specifico, che non è più riconducibile alla condizione di estraniazione. Anche se poi
non affrontano il problema di quale tipo di lavoro determini il valore; e non viene distinto
ancora valore d’uso e di scambio.
Dopo questa breve ricostruzione potremmo davvero chiederci quale rapporto esiste tra il
Capitale e il progetto di ricerca del 1844? Secondo Marx l’economia politica partirebbe dal
fatto della proprietà privata, senza spiegarla, finendo per esprimere un processo materiale
in formule generali ed astratte che vengono tramutate in leggi, svincolandole così dalla loro
origine: la proprietà stessa!258
Comprendere ciò che veniva lasciato come impensato: ecco
il compito della critica. L’analisi di questo nuovo approccio parte dal fenomeno della
pauperizzazione, la quale è una manifestazione di un fenomeno molto più vasto che
attanaglia e svilisce l’uomo: l’alienazione. Il dramma attuale che dilania l’umano e il suo
253 Cfr. Meoc, Op. cit., vol. IV, pag. 50
254 Ibidem , pag. 53
255 Cfr. Meoc, Op. cit. , vol. V, pag. 381
256 Ibidem, pag. 413
257 Idem
258 Cfr. Meoc, Op. cit., vol. III, pag. 296-7
103
mondo è che l’operaio “diventa tanto più povero quanto più ricchezza produce […]. Il suo
prodotto, gli si erge contro come un essere estraneo, come una potenza indipendente dal
produttore. Il prodotto del lavoro è il lavoro che è fissato, concretizzato in un oggetto, è
l’oggettivazione del lavoro”259
.
Posta in questi termini, l’analisi ci mostra che l’oggetto prodotto appare come un oggetto
in senso feuerbachiano, cioè come prodotto dell’oggettivazione di un’essenza specifica:
quella umana 260
.
L’economia politica con la quale abbiamo a che fare qui non è certo quella sviluppata e
compiuta del Capitale. Anzi, essa non ha nulla in comune con quest’ultima. E per una
ragione specifica: in quest’ultimi il capitale è un rapporto di produzione, e negli appunti
del ’44 è un campo tratteggiato dalla presenza di caratteristiche che potremmo in ultima
analisi definire come antropologiche
Per questo in esso la contraddizione principale è quella dell’uomo che perde i propri
caratteri nel suo oggetto, l’alienazione dell’essenza umana nella proprietà privata dei mezzi
di produzione.
Nel Capitale invece il processo di desoggettivizzazione delle categorie economiche è già
compiuto e, finalmente, l’analisi marxiana offre risultati con un contenuto valido dal punto
di vista scientifico.
Possiamo adesso riprendere la nostra analisi sul Capitale nel punto dove la lasciammo.
Marx distingue un aspetto concreto del lavoro, col quale si producono valori d’uso, e un
lavoro definito astratto, che, ad una lettura superficiale, è “dispendio di forza-lavoro
umana in genere”261
. La vecchia forma di interpretazione mostrerebbe che il lavoro sociale
sia imposto dall’esterno. Dobbiamo però indagare ulteriormente la questione.
Ogni concreto processo lavorativo è svolto privatamente ed ogni prodotto concreto è
oggettivazione di un lavoro privato. Questi lavori privati sono nel contempo
interdipendenti in quanto parti di una divisione sociale del lavoro. I lavori sono
immediatamente lavori privati, e sono da considerarsi sociali solo in quanto i loro prodotti
oggettivano tempo di lavoro socialmente necessario. Non bisogna trascurare un carattere
fondamentale, e cioè che il lavoro sociale svolge una funzione, per così dire, antagonista
rispetto al lavoro privato, in quanto il tempo di lavoro socialmente necessario alla
259 Ibidem, pag. 298
260 “L’oggetto dell’uomo non è nient’altro che la sua essenza stessa presa come oggetto”. Cfr. Ludwig
Feuerbach, L’essenza del cristianesimo, Laterza, Bari 1997, pag. 36 261 Cfr. Meoc, Op. cit. , vol. XXXI, pag. 54
104
produzione di una merce si presenta come una vera e propria coercizione. In questo senso
Marx afferma che dal momento che i lavori privati non sono immediatamente sociali,
questa forma sociale è “distinta dalle forme naturali dei lavori utili reali, ad esse estranea e
astratta, e in secondo luogo tutte le specie di lavoro privato ricevono il loro carattere
sociale soltanto antagonisticamente, venendo tutti equiparati ad una specie esclusiva di
lavoro privato”262
.
Il lavoro sociale è antagonista al lavoro privato, e la conflittualità peculiare è la matrice
dell’astratta uguaglianza che lo discrimina, diretto risultato della frattura tra carattere
sociale e privato del lavoro. Il lavoro astratto è quindi qualcosa di differente dai lavori
privati, e ha in sé una duplice determinazione: da un lato esso è lavoro antagonistico
sociale preso nella sua opposizione ai lavori privati; d’altra parte esso ha un carattere
normativo verso i molteplici lavori privati esprimendone le diverse determinazioni creatrici
di valore. La medesima divisione del lavoro, che rende i produttori privati indipendenti,
finisce per rendere altrettanto indipendente il processo sociale di produzione e quella
indipendenza si scopre, per così dire, subordinata ad un sistema di dipendenza263
. Il
carattere sociale del lavoro emerge nell’atto dello scambio, perché in esso l’elemento
equivalente viene dedotto da Marx non dai caratteri dei molteplici lavori privati concreti,
bensì dal lavoro astratto cristallizzato nella produzione. Scambiando merci si frantumano
limiti individuali e locali e si intrecciano forme relazionali che sono “fuori del controllo
delle persone che agiscono”264
. Detto in altri termini, è il carattere relazionale imposto
dall’esterno nell’atto dello scambio a frantumare ogni limite presente. E ciò non si
rifletterà, come potrebbe sembrare a prima vista, esclusivamente sotto il rispetto dello
scambio.
Infatti, se in esso si raccoglie il plusvalore, il prodotto che lo contiene avrà di certo subito il
condizionamento a sua volta patito dal singolo produttore privato, che deve finire per
adeguarsi ai caratteri normativi del lavoro astratto, pena la scomparsa.
Quella del duplice carattere del lavoro è una scoperta la cui scoperta è incalcolabile. Lo
intuì lo stesso Marx, quando ad Engels scrisse che “il carattere della scoperta della natura
duplice del lavoro, cioè lavoro concreto ed astratto, è questo realmente tutto il mistero
della concezione critica”265
. Questa distinzione in primo luogo permette di pensare l’unità
262
Cfr. Karl Marx, L’analisi della forma valore, Laterza, Bari 1976, pag. 40-1 263 Cfr. Meoc, Op. cit. , vol. XXXI, pag. 121
264 Ibidem, pag. 125
265 Cfr. Meoc, Op. cit., vol. XLIII, pag. 14
105
delle due determinazioni dell’equazione, poiché ciò che determina la connessione dei
rapporti tra le merci non è il lavoro simpliciter, bensì il rapporto normativo del lavoro
astratto su quello concreto, nella misura in cui l’estensione del primo esprime la struttura di
un modo di produzione capitalistica con le sue continue rivoluzioni delle forze produttive
che vengono fatte accrescere dai rapporti di produzione.
Dunque, si sbaglia chi considera il lavoro astratto come una categoria utilizzata da Marx
per individuare l’insieme delle proprietà comuni a tutti i lavori concreti.
Come ha sottolineato chiaramente Porcaro “è proprio l’esistenza antagonistica del lavoro
sociale a rendere nello stesso tempo necessaria e possibile l’equiparazione delle merci:
necessaria perché essa è l’unica via per realizzare il carattere sociale dei lavori; possibile
perché, in quanto prescinde dal carattere privato dei lavori individuali, il lavoro sociale
prescinde anche dalle differenze tra le loro caratteristiche concrete e consente in tal modo il
loro confronto”266
.
Solo dopo aver posto la distinzione tra lavoro sociale e privato si può dunque afferrare il
complesso significato del lavoro astratto come “effetto specifico di una forma specifica del
lavoro sociale e non come generalizzazione del carattere comune ai diversi lavori concreti
in quanto tali”267
.
Non la comparazione dei vari lavori, ma il loro comune carattere sociale rende eguali i
lavori.
Porcaro ha condotto, con un approccio condivisibile, la sua analisi non muovendosi dallo
scambio tra merci, bensì dal carattere antagonistico del lavoro sociale. Se si parte dal
lavoro e non dallo scambio, le domande vanno riformulate. Nello specifico, non si chiederà
più se il lavoro sia sostanza comune delle merci, ma come queste riescano a realizzare la
connessione del lavoro sociale.
III Contraddizione, determinazione, astrazione
Non bisogna però credere che tra lavoro concreto e astratto, così come tra valore d’uso e
valore, si dia una contraddizione vera e propria. Valore d’uso e lavoro concreto da un lato,
e valore e lavoro astratto dall’altra appartengono a due campi distinti. Un termine non
266 Cfr. Mimmo Porcaro, I difficili inizi di Karl Marx, Dedalo, Bari 1986, pag. 37
267 Idem
106
implica l’altro come suo necessario opposto. Per avere una contraddizione “il valore d’uso
dovrebbe opporsi al valore come una forma sociale di un’altra forma sociale”268
.
Ma è evidente che nessuno dei due termini è l’opposto specifico dell’altro. Eppure, come è
facile immaginare, la maggior parte degli interpreti ha pensato al duplice carattere delle
merci in termini contraddittori. Ma allora che cos’è una contraddizione? E soprattutto, si dà
una contraddizione logica per Marx? Avevamo riportato l’affermazione di Lefebvre nel
quale egli afferma che dal carteggio del nostro “risulta che il metodo dialettico è stato
ritrovato e riabilitato da Marx al tempo dei lavori preparatori a Per la critica dell’economia
politica e al Capitale: l’elaborazione delle categorie economiche e dei loro nessi intimi ha
superato l’empirismo e raggiunto il livello del rigore scientifico, ed ha preso allora la
forma dialettica”269
. Ma adesso dobbiamo verificare direttamente sui testi questo passaggio
dall’empiria alla forma dialettica perché ci è chiaro cosa voglia dire il passaggio, ma non la
meta. Forma dialettica di per sé è una espressione ambigua. In Hegel infatti essa indica
tanto la negazione270
, quanto l’intero processo comprensivo dei tre aspetti di astratto o
intellettuale, dialettico o negativo razionale e speculativo o positivo razionale271
. La cosa
poi si complica ulteriormente se vogliamo scoprire che cosa sia la contraddizione.
Il termine contraddizione in Hegel può avere tre significati: innanzitutto con essa possiamo
riferirci
all’ unità delle determinazioni opposte, ma vedendo questa unità non propriamente
contraddittoria, e i termini opposti non identici. “Per sè non costituisce ancora, per così
dire, uno scapito, una mancanza o un difetto per una cosa, il fatto che vi si possa mostrare
una contraddizione. Anzi, ogni determinazione, ogni concreto, ogni concetto è
essenzialmente una unità di momenti distinti e distinguibili, che diventano contraddittori
mediante la differenza determinata, essenziale"272
.
L'oggetto è da considerarsi come un’insieme di determinazioni, ma esso " è indifferente di
fronte alle determinazioni come singole e determinate in sè e per sè, come le
268 Ibidem, pag. 54
269 Cfr. Henry Lefebvre, Il materialismo dialettico, Einaudi, Torino 1949, pag. 65
270 “ La dialettica, per contrario, è questa risoluzione immanente, nella quale l’unilateralità e la limitatezza
delle determinazioni intellettuali si esprime come ciò che essa è, ossia come la sua negazione” Cfr. G. W. F.
Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, Laterza, Roma-Bari 2009, par. 81, pag. 96
271 “La dialettica ha un risultato positivo, perché essa ha un contenuto determinato, o perché il suo verace
risultato non è il vuoto ed astratto niente, ma è la negazione di certe determinazioni, le quali sono contenute
nel risultato appunto perché questo non è un niente immediato, ma è un risultato” cfr. Ibidem, pag. 97
272 Cfr. Georg W. F.. Hegel, Scienza della logica, op. cit. , pag. 494
107
determinazioni sono indifferenti tra loro."273
. Dunque le determinazioni di quest'oggetto
sono non sussistenti fra loro, e la relazione che le compenetrerebbe non sarebbe una
componente relazione ad essa interna. Dunque non si tratta di una contraddizione: le
determinazioni distinguono solo due aspetti di un oggetto. Nient'altro. Potremmo, in tal
caso, parlare di una giustapposizione di determinazioni indifferenti.
In secondo luogo, contraddizione fa riferimento a strutture logiche contraddittorie, nel
senso che queste sono errori dell'intelletto, che vanno risolte. In altri termini, la
contraddizione va rimossa. Sappiamo che la dialettica per Hegel si struttura in tre momenti
: astratto, dialettico o negativo razionale e speculativo o positivo razionale. La
contraddizione indica l’errore delle determinazioni astratte poste dall’intelletto, errore
riconosciuto dalla ragione: L’intelletto determina e tiene ferme le determinazioni. La
ragione è negativa e dialettica, perché dissolve in nulla le determinazioni dell’intelletto.
Essa è positiva, perché genera l’universale e in esso comprende il particolare274
. Non si da
progresso scientifico senza considerare che “ il negativo è insieme anche positivo, ossia
che quello che si contraddice non si risolve nello zero, nel nulla astratto, ma si risolve
essenzialmente solo nella negazione del suo contenuto particolare, vale a dire che una tal
negazione non è una negazione qualunque, ma la negazione di quella cosa determinata che
si risolve, ed è perciò negazione determinata. Bisogna, in altre parole, saper riconoscere
che nel risultato è essenzialmente contenuto quello da cui esso risulta […]. Quel che
risulta, la negazione, in quanto è negazione determinata, ha un contenuto. Cotesto
contenuto è un nuovo concetto, ma un concetto che è superiore e più ricco che non il
precedente. Essa è infatti divenuta più ricca di quel tanto, ch’è costituito dalla negazione, o
dall’opposto di quel concetto. Contiene dunque il concetto precedente, ma contiene anche
di più, ed è l’unità di quel concetto e del suo opposto”275
.
Nel definire qualcosa come A, l’intelletto ha astratto, cioè separato, ciò che è altro da A,
non A. L’astrazione è quindi “una divisione del concreto ed un isolamento delle sue
determinazioni. Per mezzo suo vengono colte soltanto delle proprietà e dei momenti
singoli, poiché il suo prodotto deve contenere quello ch’essa stessa è”276
. Ed è l’astrazione
che crea la contraddizione. A è riconosciuto come A dall’intelletto poiché è stato separato
da ciò che era altro da sé. E reso, per così dire, rigido. Ciò che è non A non è da
273 Ibidem, pag. 810
274 Ibidem, pag. 6
275 Ibidem, pag. 36-7
276 Ibidem, pag. 702
108
considerarsi come un generico negativo, ma sempre come negativo determinato: “se il
negativo viene tenuto fermo nella determinazione affatto astratta dell’immediato non
essere, il predicato non è che l’affatto indeterminato non-universale”277
. L’intelletto genera
dunque una contraddizione perché fissa, irrigidisce le determinazioni e tende a slegare ciò
che in realtà è interconnesso. L’intelletto così finisce per non afferrare il reale. Da qui
possiamo vedere il secondo momento dialettico, dove la ragione mostra e risolve quelle
determinazioni finite nel loro opposto, poiché il contraddirsi dell’intelletto non si risolve
mai nel nulla, nel mero vuoto, e ciò perché “ un contenuto determinato[…] essendo
determinato, sta in una molteplice relazione verso un altro contenuto”278
. Se una cosa è
determinata tramite l’altro vuol dire che essa è determinabile mediante l’altro. Il momento
positivo razionale o speculativo riesce a mantenere l’unità di queste determinazioni
opposte. E quindi la dialettica è, in tal senso, non la trasgressione del principio di non
contraddizione, bensì, il metodo col quale la stessa contraddizione è risolta, uno sradicare
del falso generato da quella sorta di peregrinazione dell’intelletto tra le determinazioni. La
contraddizione quindi è un che di complesso che da un lato mostra il limite dell’operazione
intellettuale e dall’altro l’ostacolo che la ragione deve superare. Ma questa contraddizione
è reale? A ben vedere no, e soprattutto l’unità degli opposti non è una unità tra
contraddittori in senso logico. Quando Hegel afferma che “tutte le cose sono in se stesse
contraddittorie”279
vuol dire che le cose stesse, nell’ambito logico, hanno un carattere
contraddittorio sotto il rispetto dell’analisi compiuto dall’intelletto. Ciò lo vediamo
chiaramente quando Hegel tematizza il cattivo infinito, che è contraddittorio in quanto il
suo esser infinito è simultaneamente un finito280
. Ma la valenza dell’affermazione
hegeliana sopra riportata ha anche un altro significato: all'interno del sistema vi sarebbero
strutture logiche effettivamente contraddittorie, e la contraddizione ha valenza sia logica
che ontologica. Questo è un terzo senso del termine contraddizione. Quando ad esempio
Hegel indaga la finità negli elementi di destinazione, costituzione e limite, afferma che il
qualcosa “non è diverso dal suo altro; è soltanto esserci, ha dunque la stessa
determinazione che il suo altro;ciascuno è soltanto qualcosa in generale, oppur ciascuno è
altro. Quindi tutti e due son lo stesso.”281
. Il finito si determina come esser sé stesso con il
277 Ibidem, pag. 723
278 Ibidem, pag. 74-5
279 Ibidem, pag. 490
280 Ibidem, pag. 140 e ss.
281 Ibidem, pag. 126
109
proprio altro: “ L’altra determinazione è l’inquietudine del qualcosa, che consiste
nell’essere, nel suo limite in cui e immanente, la contraddizione, che lo spinge oltre se
stesso”282
. Dunque, la contraddizione intesa in senso logico denota una struttura complessa
delle cose che vengono animate da una contraddizione interna. Le cose non sono uguali a
se stesse, esse divengono e in questo divenire processuale la cosa si scopre come diversa da
sé. Il finito, così come l’universale, l’uno, l’essenza ecc ecc. sono comprese nel loro vero
essere solo se pensato in quella formula speculativa di “identità dell’identità e non identità”
283: finito è dunque identità del finito e del non finito e così via.
A mio modesto avviso non dovremmo pensare questo aspetto della dialettica in antitesi a
quella che vedeva coinvolto l’intelletto e la ragione. Anzi, bisognerebbe, senza confondere
i rispettivi ambiti e i dispositivi specifici, guardare ad essi come compenetrati e soprattutto
fare riferimento alla facoltà interpellata all’individuazione di questi ambiti e dispositivi: la
ragione. E ciò vuol dire, di riflesso, come le stesse strutture ontologiche del reale
prevedano, anzi meglio, siano costituite dalla contraddizione, che è pensata e formulata sul
metro della negazione, che per Hegel è sempre una negazione determinata, cioè una
negazione che determina la costituzione delle determinazioni attribuibili ad un ente. La
negazione è una relazione di esclusione. “La determinatezza è negazione; questo è il
principio assoluto della filosofia spinozistica. Cotesta veduta vera e semplice fonda
l’assoluta unità della sostanza. Se non che Spinoza resta fermo alla negazione come
determinatezza o qualità; non si avanza fino alla conoscenza di essa come negazione
assoluta; vale a dire come negazione che si nega”284
. Ciò ci svela che la negazione
hegeliana esplica la funzione di escludere da sé le determinazioni altre e nel contempo si
riferisce a sé, e facendo ciò si auto-nega. Con l’autonegazione, che è il farsi altro da sé,
essa realizza il proprio sé. Prendiamo ancora per esempio il finito. Nella Scienza della
logica si legge: “le cose finite sono, ma la loro relazione a se stesse è che si riferiscono a se
stesse come negative, che appunto in questa loro relazione si mandano al di là di se stesse,
al di là del loro essere”285
. Ecco dunque un caso di negazione determinata che presenta il
carattere dell’autonegazione: il finito è compreso in tale atto di riferimento a sé come se
stesso e il suo altro. E’ questo un caso in cui si esplica quella figura dell’unità di identità e
282 Ibidem, pag. 127
283 Cfr. Hegel, Differenza fra il sistema filosofico di Fichte e quello di Schelling, in Primi scritti critici,
Mursia, Milano 1990, pag. 79
284 Cfr. Georg F. W. Hegel, Scienza della logica , op. cit. , pag. 604
285 Ibidem, pag. 128
110
non identità. Siamo di fronte ad una determinazione contraddittoria. Naturalmente tutto ciò
ripugna al senso comune e all’intelletto stesso che non riesce ad elevarsi al movimento
della contraddizione286
. “La contraddizione non è poi da prender semplicemente come
un’anomalia che si mostri solo qua e là, ma è il negativo nella sua determinazione
essenziale, il principio di ogni muoversi, muoversi che non consiste se non in un
esplicitarsi e mostrarsi della contraddizione. Persino l’esterior moto sensibile non è che il
suo esistere immediato. Qualcosa si muove, non in quanto in questo Ora è qui, e in un altro
Ora è là, ma solo in quanto in un unico e medesimo Ora è qui e non è qui, in quanto in pari
tempo è e non è in questo qui”287
. Dunque, come dovrebbe esser chiaro, esistono delle
determinazioni che non sono poste in una contraddizione esterna, cosa che equivale a dire
che esse sono tenute nella loro diversità, ma si ha identità di determinazioni opposte; non
un mero sussistere ma una vera e propria contraddizione. Ma non dobbiamo dimenticare la
cosa fondamentale. Hegel pone al centro del suo sistema l’assoluto, ed esso si presenta al
pensiero come contraddittorio
E Marx? Avevamo visto in precedenza che egli aveva pensato ad una logica della cosa in
contrapposizione alla cosa della logica hegeliana, e che nella Critica alla filosofia del
diritto aveva individuato tre tipo di opposizioni: una opposizione che si verifica all’interno
di una data essenza; una per astrazione e conseguente ipostatizzazione; una in cui sono in
gioco estremi reali. Mentre nel primo caso entrambi i termini erano attivi ed equivalenti
per grado di forza nell’opposizione, nel secondo e nel terzo uno dei due termini prevarica,
e sotto due rispetti: dei due solo uno dei termini può essere posto come il cardine
dell’opposizione, di cui l’altro è mera opposizione; uno dei due termini riesce a sopraffare
l’altro. E quindi l’opposizione vera e propria si dava solo nel primo caso. Ad esse si
aggiungeva un quarto tipo di opposizione che Marx utilizza nell’ Ideologia tedesca e che si
riferisce a estremi reali288
. Marx conosce perfettamente la distinzione tra Realrepugnanz
kantiana e la contraddizione dialettica. Si tratta di due tipi di opposizione molto differenti:
la prima non viola il principio di non contraddizione, l'altro invece produce una
opposizione dialettica: " due cose, di cui l'una annulla ciò che è posto dall'altra, sono
opposte. Tale opposizione è duplice: o logica per contraddizione, o reale, cioè senza
contraddizione. La prima opposizione, quella logica, è la sola di cui si sia tenuto conto
finora. Consiste nell'affermare e negare contemporaneamente un predicato di una cosa. La
286 Ibidem, pag. 240; Enciclopedia , op. cit. , par.89, pag. 108
287 Cfr. Hegel, Scienza della logica ,op. cit. , pag. 491
288 Cfr. Meoc, op. cit. , vol. V, pag. 244
111
conseguenza di tale nesso logico è nulla (nihil negativum irrepraesentabile), come è detto
nel principio di contraddizione [...]. La seconda opposizione, reale, è quella in cui due
predicati di una cosa siano opposti, ma non per il principio di contraddizione. Anche qui
l'uno annulla ciò che è posto dall'altro, ma la conseguenza è qualcosa (cogitabile)"289
.
Infatti, nell'opposizione reale, gli opposti sono reali ed esistenti per sé e l'unica relazione
tenuta in conto è quella in cui vi è una relazione per la quale i due termini non si negano
reciprocamente, ma affermano "ambedue i predicati A e B"290
.
Tale distinzione è recuperata da Kant nella Critica della ragion pura, quando nella nota
all'anfibolia dei concetti della riflessione afferma: Il principio, che i reali (come semplici
affermazioni), non sono mai tra loro logicamente opposti, è una proposizione verissima
rispetto al rapporto dei concetti, ma non ha nessun significato rispetto alla natura, né
rispetto a una qualunque cosa in sé (di cui non possediamo verun concetto).
Infatti,l’opposizione reale, ha luogo dovunque A – B = 0, ossia dove un reale, unito con
altro in un soggetto, annulla l’effetto dell’altro"291
. E' evidente che per Kant non esistano
oggetti contraddittori in natura, e quindi tale opposizione può darsi nell'ambito concettuale,
nel quale due termini, uno positivo l'altro negativo, vengono attribuiti al medesimo
oggetto, finendo così per annullarlo. L'opposizione reale, invece, non nega il principio di
non contraddizione, poichè i due termini attribuiti al medesimo oggetto, non portano al suo
annullamento, poichè l'uno annulla gli effetti dell'altro. Allo stesso modo Kant conosce
profondamente il pensiero di Aristotele, e sa che lo stagirita nelle Categorie individua
quattro tipi di opposizioni: i correlativi, per i quali i due termini pur negandosi si implicano
reciprocamente292
; i contrari, che sono i termini più distanti ma all'interno di uno stesso
genere, e si escludono reciprocamente293
; possesso e privazione, che indicano una
relazione tra termini all'interno di uno stesso genere di cui uno si dà sempre senza l'altro294
;
i contraddittori, cioè due termini di cui l'uno rappresenta la negazione dell'altro295
. Nel X
libro della Metafisica questi quattro tipi di opposti sono presentati in ordine inverso, dal
grado più esteso a quello meno esteso. Gli opposti soggiacciono secondo lo Stagirita al
289 Cfr. Immanuel Kant, Il concetto delle quantità negative, in Scritti precritici, Laterza, Bari 1953, pag. 263
290 Ibidem, pag. 264
291 Immanuel Kant, Critica della ragion pura, Laterza, Roma-Bari 2007, pag. 220-1
292 Cfr. Aristotele, Categorie, Rizzoli, Milano, 2000, pag. 359-361
293 Ibidem, pag. 361-363
294 Ibidem, pag. 363-365
295 Ibidem, pag. 365
112
principio di non contraddizione: “ è impossibile che la stessa cosa, ad un tempo,
appartenga e non appartenga a una medesima cosa, secondo lo stesso rispetto”296
Ma cosa vuol dire nel Capitale contraddizione? Ha Marx trasgredito il più saldo dei
principi? In ciò ha seguito Hegel? In che senso la realtà, per Marx, è contraddittoria?
Possiamo notare in via preliminare che all’interno dell’opera egli distingue nettamente ed
esplicitamente due tipi di contraddizioni. Durante l’analisi della trasformazione del
plusvalore in capitale, in una nota afferma: “Il signor John St. Mill da un lato fa estratti
della teoria del profitto di Ricardo e dall’altro si annette la <remuneration of abstinence>
di Senior. Quanto gli è ignota la <contraddizione> hegeliana, fonte di ogni dialettica, tanto
si trova a suo agio in contraddizioni banalissime”297
. E’ chiaro che Marx, richiamandosi al
principio di non contraddizione aristotelico, sottolinea che le banali contraddizioni sono
sinonimo di incoerenza logica e per questo la scienza le rifiuta. Tale definizione della
contraddizione torna più volte nelle Teorie sul plusvalore: “ Ricardo concepisce la
produzione borghese […] come forma assoluta della produzione, i cui determinati rapporti
di produzione non possono quindi mai entrare in contraddizione od ostacolare lo scopo
della produzione in assoluto […]. In realtà, ciò che egli ammira nella produzione borghese
è che le sue forme determinate danno luogo ad uno sviluppo delle forze produttive che è
illimitato in confronto alle precedenti forme di produzione. Quando esse cessano di far
questo, o quando compaiono le contraddizioni entro cui creano questo sviluppo, egli nega
le contraddizioni entro cui creano questo sviluppo, egli nega le contraddizioni o meglio
esprime la contraddizione in forma diversa […]. Sismondi ha il profondo intuito del fatto
che la produzione capitalistica si contraddice; che le sue forme, i suoi rapporti di
produzione, da un lato spingono allo sfrenato sviluppo della forza produttiva e della
ricchezza; ma che dall’altro lato questi rapporti sono a loro volta condizionati e che le loro
contraddizioni […] assumono dimensioni tanto più grandi quanto più si sviluppa la forza
produttiva. Egli avverte specialmente la contraddizione principale: da un lato lo sfrenato
sviluppo della forza produttiva e l’accrescimento della ricchezza […] dall’altro, come
fondamento, la limitazione della massa dei produttori ai necessaries. Anche per lui le crisi
non sono, come per Ricardo, semplici accidenti, ma esplosioni essenziali, su grande scala e
in determinati periodi, delle contraddizioni immanenti”298
. In questa lunga citazione
possiamo saggiare la distinzione tra i due termini della contraddizioni. Da una parte vi è
296 Cfr. Aristotele, Metafisica, op. cit. , pag. 143-5
297 Cfr. Meoc, op. cit. , vol. XXXI, pag. 661
298 Cfr. Meoc, op. cit. , vol. XXXVI , pag. 50 -1 ; Ibidem, pagg. 4, 20 , 23, 30
113
l’incongruenza logica di Ricardo e dall’altro un approccio ad un altro senso di
contraddizione, che è quello di Sismondi. Il primo caso, comune sia a Ricardo che a Mills,
ci fa pensare ad una vera e propria inconseguenza logica, rappresentata dalla presenza di
una contraddizione tra due asserzioni giustapposte e incompatibili. Delle tre definizioni di
contraddizione hegeliana nessuna ci sembra uguale ad essa: nemmeno nella prima
accezione, che potrebbe ad un primo momento mostrare una certa somiglianza, poiché qui
se è vero che vi siano due elementi diversi giustapposti in una teoria, che è l’equivalente
dell’unità sopraindicata, non si da il caso che tale unità di opposti sia indifferente ad esse e
che queste altrettanto indifferenti tra loro. Qui si indica un’incapacità da parte di un tutto
unitario, nello specifico una teoria economica, di tener conto della coerenza interna
eliminando le contraddizioni. Ora, la seconda accezione della contraddizione marxiana è
molto più complessa. Con essa viene mostrato come un modo di produzione sia animato da
rapporti di produzione che generano effetti opposti: i rapporti di produzione spingono
all’incremento della forza produttiva e quindi ad un incremento delle ricchezze e dall’altro
ad acuire quella contraddizione che genera da un lato la ricchezza prodotta dalle forze
produttive e dall’altra la riduzione in miseria delle stesse. E questo accade in molti luoghi.
Una chiara disfunzione nell’ambito delle relazioni reali è rappresentata dal ruolo della
doppia espressione di valore: “ Se, perciò, due merci diverse, per es. oro e argento, servono
contemporaneamente da misure di valore, tutte le merci possiedono due espressioni diverse
di valore, prezzi in oro e prezzi in argento, che marciano tranquillamente l’uno accanto
all’altro fintanto che il rapporto di valore fra argento e oro resta invariato, per es. 1:15.
Ogni cambiamento di questo rapporto di valore disturba però il prezzo fra prezzi oro e
prezzi in argento delle merci e dimostra così, di fatto, che il raddoppiamento della misura
del valore contraddice la sua funzione”299
. In ultima analisi, il movimento contraddittorio
del capitalismo è quello di generare delle determinazioni tra loro contraddittorie, e l’acuirs i
di queste scissione è il riflesso di un movimento di sviluppo di aspetti che erano stati posti
come reali da un altro atto contraddittorio.
Di certo qui non siamo di fronte ad una vera e propria contraddizione logica. Essa la
troviamo invece nel paragrafo dedicato alla trasformazione del denaro in capitale: “il
capitale non può dunque sorgere dalla circolazione e altrettanto non può non sorgere dalla
circolazione. Esso deve, allo stesso tempo, sorgere e non sorgere in essa. Si è quindi
ottenuto un doppio risultato. La trasformazione del denaro in capitale deve essere
299 Cfr. Meoc, op. cit. , vol. XXXI, pag. 109; Ibidem, 115, 233 440, 444-5, 482, 531, 547, 710
114
sviluppata sul fondamento delle leggi immanenti allo scambio di merci di modo che lo
scambio di equivalenti valga come punto di partenza. Il nostro possessore di denaro, qui
ancora solo bruco di capitalista, deve comprare le merci al loro valore, eppure, alla fine del
processo, deve ricavarne più valore di quanto non ve ne abbia immesso”300
. La
contraddizione ha qui origine dagli stessi presupposti con i quali le argomentazioni erano
state svolte. E la soluzione della contraddizione è trovata in un elemento affatto unico: la
forza-lavoro, cioè quella merce il cui valore d’uso è quello di produrre valore. Tale
contraddizione quindi non è nelle cose, ma è una conseguenza di un certo modello
argomentativo che le genera. Perciò, la funzione che essa svolge è quello di “introdurre a
un superiore livello della trattazione e – sotto questo riguardo- ha l’aspetto di una sorta di
reductio ad absurdum”301
.
Ma il processo di scambio ci mostra un altro carattere oppositivo, in quanto implica
relazioni che si contraddicono e si escludono reciprocamente. In esso, le merci e, per così
dire, il loro raddoppiamento in merci e denaro, svelena “un’opposizione esterna in cui esse
espongono la propria opposizione immanente di valore d’uso e valore. In
quest’opposizione le merci, come valore d’uso, compaiono di fronte al denaro, come
valore di scambio. D’altro lato, entrambi i lati dell’opposizione sono merci, quindi delle
unità di valore d’uso e valore. Ma quest’unità di distinti si espone in maniera inversa a
ciascuna dei due poli e, grazie a ciò, espone allo stesso tempo la loro relazione reciproca.
[…]. Il processo di scambio delle merci si compie, dunque, in due metamorfosi che sono
contrapposte e che si integrano reciprocamente – trasformazione della merce in denaro e
sua ritrasformazione da denaro in merce”302
. Si badi bene: non è che il valore d’uso si
tramuta nel suo opposto tramite il denaro, poiché valore d’uso e valore non sono opposti,
ma sono due determinazioni di un medesimo oggetto. Si danno dunque relazioni molto
complesse: la circolazione delle merci spezza i limiti geografici e temporali dello cambio
poiché essa scinde, nell’opposizione di acquisto e vendita, proprio l’identità immediata fra
il dare il prodotto del proprio lavoro in cambio del prodotto del lavoro di un altro. Ma ciò
indica che i processi che costituiscono una unità interna si muovono in una opposizione
esterna. Le opposizioni immanenti alla merce, così come le altre, ricevono “ nelle
opposizioni della metamorfosi delle merci le proprie forme di movimento sviluppate”303
.
300 Ibidem, pag. 182-3
301 Cfr. Massimo Mugnai, op. cit. , pag. 132
302 Cfr. Meoc, op. cit. , vol. XXXI, pag. 117-8
303 Ibidem, pag. 126
115
Il valore d’uso è definibile indipendentemente da quello di scambio, poiché esiste
indipendentemente da questo, ma nell’atto dello cambio essi si implicano a vicenda.
Nell’atto dello scambio essi si intersecano, poiché la permuta di due merci non potrebbe
avvenire senza la loro stretta correlazione: il valore d’uso posseduto dalla merce in mano
ad uno dei contraenti deve configurarsi come valore di scambio nei confronti dell’altro e
viceversa. Ciò spiega in sede logica anche la genesi della merce-denaro. Non solo, in più
punti Marx mostra che già nella metamorfosi della merce si dà una prima avvisaglia della
crisi: queste forme implicano quindi la possibilità, ma anche solo la possibilità, delle crisi.
Lo sviluppo di questa possibilità in realtà effettuale richiede un intero ambito di rapporti
che ancora non esistono affatto dal punto di vista della circolazione semplice di merci”304
.
Nella crisi “ l’opposizione fra la merce e la sua figura di valore, il denaro, monta a
contraddizione assoluta”305
. L’estensione dello scambio è la condizione principale della
realizzazione della crisi, poiché, così come esiste per “ una singola merce la difficoltà di
attraversare questa metamorfosi, così essa può esistere per tutte. La natura generale della
metamorfosi delle merci […] è piuttosto la possibilità di un general glut”306
. La
separazione fra vendita e acquisto contiene la possibilità della crisi, e contro essa il denaro
non può supplire, poiché ne è risucchiato. Ma per farla esplodere, devono intervenire altri
fattori.
Infine vi è un ultimo significato di contraddizione: contraddizione si ha tra una legge
economica e ciò che si manifesta fenomenicamente307
.
Ora è più chiaro che, fatta eccezione per quest’ultima accezione, non vi è molto in comune
con la contraddizione hegeliana. Ciò è dato da tre motivi: innanzitutto, i campi di indagine
non sono i medesimi. In secondo luogo, non coincidono le problematiche di fondo e per
questo, in definitiva, non coincidono nemmeno i metodi. E’ chiaro infatti che Marx si
occupa dell’analisi del modo di produzione capitalistico mentre Hegel si muove negli
ambiti di una scienza di concetti oggettivi e pensieri oggettivi. È chiaro dunque che i campi
sono radicalmente diversi. La problematica di Hegel è quella racchiusa nella Scienza della
logica, come “ il regno del puro pensiero. Questo regno è la verità, com’essa è in è e per
sé senza velo. […] l’esposizione di Dio, com’egli è nella sua eterna essenza prima della
304 Ibidem, pag. 126-7
305 Ibidem, pag. 151
306 Cfr, Meoc, Op. cit. , vol. XXXV , pag. 552
307 Cfr. Meoc, Op. cit. , vol. XXXI, pag. 333
116
creazione della natura e di uno spirito finito”308
. Marx invece affronta la questione del
valore e della genesi del capitale. Dal suo orizzonte quindi certe problematiche non hanno
alcuna importanza. Ad esempio, non è affatto un problema, per chi ha rotto con la
metafisica idealistica, analizzare il rapporto tra intelletto e ragione né chiedersi come
queste conoscono un oggetto, poiché ciò, inevitabilmente, riporterebbe Marx a pensare la
relazione “metafisica” di soggetto-oggetto. Ma la rottura con l’idealismo si era consumata
da tempo, e le marcate differenze delle varie accezioni del termine contraddizione sono lì a
testimoniarlo. C’ è un ambito nel quale Marx esprime, in via critico-negativa, una
comprensione profonda della dialettica hegeliana e arriva a rifiutarne l’impianto poiché
conscio delle conseguenze di cui è foriera quella impostazione. Quando nel terzo libro
delle Teorie sul plusvalore deve tratteggiare la differenza essenziale fra l’economia
classica e quella volgare, egli afferma che la prima cerca di ricondurre analiticamente le
differenti forme rigide e reciprocamente estranee della ricchezza alla loro intima unità e
spogliarle della figura di indifferente giustapposizione; vuol comprendere il nesso
interiore, a differenza della molteplicità delle forme di manifestazione309
e così riduce la
rendita al sovraprofitto, finendo inevitabilmente per separarla dalla sua fonte apparente, il
suolo. Lo stesso vale per le altre forme di reddito, che vengono ridotte all’unica forma del
profitto, e ciò vuol dire che l’economia classica tende a ridurre la diversità nell’identità di
una sorgente unica. E storicamente ciò porta ad affermare che la forma fondamentale del
capitale, cioè l’appropriazione di plusvalore, non è una forma storica bensì naturale della
produzione sociale.
La considerazione della possibilità della crisi a partire dalla metamorfosi delle merci e gli
aspetti contraddittori del capitalismo ci mostrano come, a ben vedere, la filosofia marxiana
ha elaborato una comprensione della realtà differente da quella di Hegel. Anzi potremmo
dire: Hegel e Marx non hanno nemmeno guardato la stessa realtà. Da qui si spiega la
differenza tra le due logiche. Prendiamo ad esempio la categoria di astrazione. Nel
Capitale essa possiede un ampio numero di significati e svolge altrettante funzioni. Ne
distinguiamo sei310
: come ipotesi di lavoro311
, come astrazione forzata e falsificante312
,
308 Cfr. Hegel, Scienza della logica, op. cit. , pag. 31
309 Cfr. Meoc, Op. cit. , vol. XXXVI, pag. 535
310 La classificazione che segue riporta i riferimenti all’edizione di Eugenio Sbardella, che avevamo sinora
utilizzato per il secondo e il terzo libro.
311 “ con un prezzo di produzione e con differenze costanti la rental e la rendita media per acro o il saggio
medio di rendita per capitale possono aumentare nella rendita differenziale; tuttavia la media non è che
117
come esposizione complessiva di un risultato acquisito o di un’analisi per inquadrare un
aspetto prossimo313
, come metodologia di separazione di fattori diversi e contraddittori, o
di determinazioni secondarie in un ente o in una relazione al fine di comprenderne un
singolo aspetto e, soprattutto, quello decisivo che può essere ricondotto e tematizzato in
ambito scientifico314
(perché non tutti gli aspetti, non tutte le determinazioni possono
rientrare nell’ambito dell’analisi del Capitale) e da non confondersi con il mero atto di
separazione dal concreto e pensato in questo carattere di separazione315
. Infine l’ultimo
significato è relativo ad una duplicità insita nel lavoro. E l’astratto qui ci indica quella che
un’astrazione” Cfr. Karl Marx, Il capitale, op. cit. 1376; 900, 970, 1075, 1154, 1156 , 1223, 1421,1439,
1475,
312 “L’economia classica, sebbene non abbia mai formulato questa legge, ne fa per istinto il suo punto fermo,
in quanto è necessaria conseguenza della legge del valore generale, e cerca di trarle fuori dalle sue apparenti
contraddizioni tramite una forzata astrazione” Cfr. Ibidem, pag. 233; è in primo luogo una falsa astrazione
considerare una nazione, il cui modo di produzione si basa sul valore, e inoltre organizzata in maniera
capitalistica, come un corpo collettivo che lavora soltanto per i bisogni della nazione” Cfr. Ibidem, pag. 1488,
313 “Quanti ritengono che tale rendersi autonomo del valore sia una semplice astrazione, dimenticano che il
movimento del capitale è questa astrazione in actu” Cfr. Ibidem, pag. 631, “ Nel Libro I furono analizzati i
fenomeni che il processo di produzione capitalistico, considerato in se stesso, presenta come processo
produttivo diretto, prescindendo da ogni influenza secondaria di circostanze che gli sono estranee. Questo
processo produttivo diretto, tuttavia, non esaurisce il corso di vita del capitale. Esso nella realtà delle cose
viene integrato dal processo di circolazione, il quale ha formato l’oggetto dell’indagine del Libro II” Cfr.
Ibidem, pag. 929, Pag. 54, 60; 150, , 277, 372
314 “ Lo scambio delle merci ai loro valori, o all’incirca ai loro valori, comporta quindi un grado di sviluppo
molto più basso che non lo scambio ai prezzi di produzione, che richiede un certo grado di sviluppo
capitalistico. Comunque i prezzi delle varie merci vengono fissati o regolati all’inizio tra di loro, il loro
movimento viene determinato dalla legge del valore. i prezzi calano allorchè diminuisce il tempo di lavoro
occorrente alla loro produzione; aumentano allorchè questo tempo di lavoro aumenta, rimanendo immutata
ogni altra circostanza. Seppur prescindiamo dall’influsso determinante della legge del valore sui prezzi e sul
movimento di essi, viene imposto dalle cose di considerare i valori delle merci non soltanto da un punto di
vista teorico bensì anche torico, come il prius dei prezzi di produzione” Cfr. Ibidem, pag. 1032, 579, 815,
828, 865, 876, 1054, 1061, 1079, 1082, 1097, 1098, 1102, 1104, 1105, 1121, 1126, 1130, 1131, 1133,
1162,1163, 1174, 1184, 1204, 1212, 1240, 1244, 1272,1321, 1334, 1336,1350, 1354, 1432, 1442, 1450,
1452, 1473, 1477, 1479, 1481, 1486, 1502, 1505
315 “da un punto di vista astratto, ossia se non si considerano le circostanze che non derivino dalle leggi
immanenti della circolazione semplice delle merci, non si verifica in quest’ultima, oltre la sostituzione d’un
valore d’uso con un altro, nient’altro che una metamorfosi, un semplice mutamento di forma della merce”
Cfr. Ibidem , pag. 132, 60, 63, 103, 132, 143, 160, 162, 198, 226, 246, 331, 332, 389, 415, 1038, 1356, 1463
118
definiamo come realizzazione di un concreto tramite una relazione astratta normativa
determinante316
. Stiamo parlando del lavoro umano astratto.
È evidente che la molteplicità di senso e di applicazione dell’astrazione è sintomo
dell’importanza che Marx gli attribuiva. Senza corrette astrazioni non si da una giusta
comprensione dei fenomeni concreti e la scienza incappa in errore, come testimonia
l’analisi del saggio medio di profitto di Ricardo, il quale non riesce a cogliere la verità di
questo saggio in quanto è incapace a separare i valori dai profitti per una “mancanza di
forza nell’astrazione”317
.
IV Ancora su merce e lavoro astratto
Ma torniamo per un attimo sulla merce e sulla presunta contraddizione interna.
Nicola Badaloni ha sostenuto come la merce non solo fosse caratterizzata da “una interna
contraddizione” , ma che da questa ne seguiva “l’estendersi di tale contraddizione”318
ad
ogni ambito e ad ogni aspetto della società:
Capitale monetario, produttivo, capitale-merce sono figure di tale estensione,
rispettivamente punto di partenza, intermedio e di ritorno. Il capitalista punterebbe al
modello ideale della prima figura vedendo le altre come intralcio. “Di qui la sua
irrefrenabile tendenza pratica a subordinare il ciclo produttivo e quello della circolazione
delle merci al modello ideale del capitale monetario il cui scopo e motivo è il far
denaro”319
. E’ questo un modello ermeneutico che non riesce a problematizzare né ad
individuare le difficoltà insite nell’analisi della merce nel Capitale, finendo per fare di
questa il risultato semplice e nel contempo enigmatico e intricatissimo320
da cui riluce
316
“un valore d’uso o bene ha valore solo in quanto viene oggettivato, o materializzato, in esso astratto
lavoro umano” Cfr. Ibidem, pag. 55; 63; “ per dimostrare che la tessitura costituisce il valore della tela non
nella sua concreta forma del tessere, ma nella sua generale proprietà di lavoro umano, le si contrappone come
effettiva forma di realizzazione di astratto lavoro umano la sartoria, il concreto lavoro che diviene produzione
dell’equivalente della tela. Quindi una seconda particolarità della forma di equivalente consiste nel fatto che
lavoro concrete diviene forma fenomenica del suo contraria, di astratto lavoro umano” Cfr. Ibidem 59,
63,64, 68, 81, 88, 103, 161, 963
317 Cfr. Meoc, Teorie sul plusvalore, op. cit. vol. XXXV, pag. 196
318 Nicola Badaloni, Per il comunismo, Einaudi, Torino, 1972, pag. 108
319 Ibidem , pag. 100
320 Giusto per continuare ad essere autocontraddittori
119
l’intero modo di produzione. Insomma, la merce per autori come Badaloni finisce per
diventare un punto di vista privilegiato sul mondo complesso del capitale.
Ma, come afferma lo stesso Marx nei Lineamenti, “non si può affermare che il valore di
scambio si realizza nella circolazione semplice, poiché il valore d’uso non gli si
contrappone come tale, come valore d’uso determinato dal valore di scambio”321
. Questo
rapporto si realizzerà invece successivamente nella determinazione del concetto di capitale,
dove al valore si opporrà un valore d’uso specifico, determinato dal valore: il valore d’uso
del lavoro in quanto creatore di valore. Ma ciò è fuori dall’orizzonte di Badaloni, e il suo
discorso sembra sconfessato dallo stesso Marx.
All’inizio del Capitale, valore d’uso e valore non sono da pensarsi come rispettivamente
contenuto materiale e forma sociale. Nella produzione di merci, il cui presupposto è la
divisione sociale del lavoro, i singoli produttori entrano fra loro in rapporti sociali solo
mediante lo scambio dei prodotti del loro lavoro. E’ nello scambio che l’utilità di una
merce la rende socialmente necessaria.
Per questo il rapporto fra produttori nei loro lavori assume un carattere di rapporto tra cose,
fra i valori scambiati. E proprio questa modalità di relazione se da un lato fa emergere
fenomeni specifici come il “potere apparentemente trascendentale del denaro”322
dall’altro
fa sì che, a livello generale, i rapporti vengano concepiti solo come rapporti fra cose.
Nemmeno gli economisti classici sono alieni dall’interpretare i rapporti sociali in questo
modo, finendo per ripiombare in un “idealismo altrettanto rozzo, anzi un feticismo, che alle
cose attribuisce relazioni sociali come loro determinazioni immanenti, e così le
mistifica”323
.
Ciò che fonda il carattere dei produttori singoli è certamente la divisione sociale del lavoro.
Ma quest’ultima ha come fondamento la proprietà privata dei mezzi di produzione.
Nel capitale l’agente della produzione è considerato personificazione o supporto dei
rapporti di produzione. Ma questo agente cerca di spiegarsi il mondo in cui è inserito e in
cui “agisce”.
Ecco un paio di esempi: Nella realtà il profitto è interconnesso al plusvalore, cioè alla
massa di lavoro non pagato. Il profitto non riguarda la produzione ma la ripartizione della
massa di plusvalore estorto. Il capitalista invece, che coglie gli eventi fenomenici, crede
che la ripartizione del plusvalore sia l’attimo in cui questo si costituisce. “Soltanto il
321 Cfr. Karl Marx, Lineamenti, op. cit. , pag. 1133
322 Ibidem, pag. 83
323 Ibidem, vol. II, pag. 382
120
capitalista trascura – o meglio non comprende, dato che la concorrenza non glielo fa
vedere – che tutti questi motivi di compensazione, calcolati dai capitalisti nella valutazione
dei prezzi delle varie branche produttive, stanno a mostrare soltanto che tutti, pro rata del
loro capitale, hanno diritto ad una porzione identica del bottino comune, che è il plusvalore
totale. Giacché il profitto che egli ottiene è differente dal plusvalore che egli estorce, gli
sembra magari che i suoi fattori di compensazione non determinino la sua partecipazione
al plusvalore totale, bensì creino proprio il profitto, e che questo tragga origine
semplicemente dall’aggiunta che egli opera per una ragione o per un’altra al prezzo di
costo delle merci”324
.
Le forme del feticismo sono le forme stesse nelle quali il processo del capitale esiste per gli
agenti della produzione. “Se si considera il singolo capitale o anche il capitale complessivo
di una sfera particolare, il profitto, adesso, non solo sembra ma è effettivamente differente
dal plusvalore. Capitali di ugual grandezza forniscono profitti uguali, ossia il profitto sta in
rapporto alla grandezza dei capitali. Ossia il profitto è determinato dal valore del capitale
anticipato. In tutte queste espressioni, il rapporto fra profitto e composizione organica del
capitale è completamente cancellato, irriconoscibile. Ciò che è immediatamente visibile è
piuttosto il fatto che capitali di uguale grandezza, che mettono in movimento quantità
molto differenti di lavoro e quindi comandano quantità molto differenti di pluslavoro e
quindi producono quantità molto differenti di surplus value, danno profitti di uguale
grandezza. Anzi, con la trasformazione dei valori in prezzi di costo, la base stessa- la
determinazione del valore delle merci mediante il tempo di lavoro in esse contenuto-
sembra soppressa. In questa forma del tutto estraniata del profitto, e nella stessa misura in
cui la figura del profitto ne nasconde il nocciolo interno, il capitale assume una figura
sempre più materiale, da un rapporto si trasforma sempre più in una cosa, ma in una cosa
che ha incorporato, ingoiato il rapporto sociale, una cosa che si rapporta a se stessa con una
vita e un’autonomia fittizie, un essere sensibilmente soprasensibile; e in questa forma di
capitale e di profitto appare alla superficie come un compiuto presupposto. È la forma
della sua realtà o piuttosto la sua vera forma d’esistenza. Ed è la forma in cui vive nella
coscienza dei suoi portatori, i capitalisti, in cui si rispecchia nelle loro idee ”325
.
Il carattere astratto del lavoro richiama immediatamente alla divisione sociale del lavoro,
che è la condizione necessaria per la produzione delle merci. C’è da dire però che non ogni
divisione sociale del lavoro porta alla produzione delle merci. Perché? Di certo la risposta
324 Cfr. Karl Marx, Il capitale, op. cit. , pag. 1055
325 Cfr. Meoc, Op. cit., vol. XXXVI, pag. 518
121
è presente nelle pagine del Capitale, quando Marx, a più riprese, sottolinea il passaggio da
M-D-M a D-M-D. Ma per arrivare a questo cambio che segna un’epoca , sono intercorsi
dei fatti storici che hanno portato ad essere alcune determinazioni precipue ancora latenti
nel modi di produzione differenti. Tuttavia questa latenza non era propriamente
un’assenza, bensì rappresentava ed era inserita in un ambito fattuale subordinato ad altre
condizioni di produzione dominanti. L’uscita da un dominio ha portato di fatto a nuovi
rapporti giuridici di proprietà e con essa ad una trasformazione delle forze produttive e
della distribuzione sociale del lavoro complessiva molto differente rispetto ad una
economia di sussistenza. I singoli lavori privati sono ricondotti ad una logica re-
distributiva del lavoro complessivo. E la mediazione tra gli infiniti caratteri particolari e la
somma complessiva di essi, dunque la stessa distribuzione, è svolta dal valore di scambio e
non più da quello d’uso. La stessa legge del valore rende manifesto ai singoli il loro
carattere di dipendenza dalla produzione sociale generale,e regola la distribuzione nei
diversi settori, correggendo mediante il meccanismo dei prezzi le continue deviazioni dalla
distribuzione proporzionata del lavoro sociale. Questa è, in fin dei conti, la spiegazione
della sussunzione del singolo pensato astrattamente nel concreto che lo rende pensabile
anche nel suo aspetto separato. Ma il carattere di separatezza ha un ruolo solo nell’analisi
teorica, e non nel movimento storico di ciò che è dato. Anzi, è proprio nel loro carattere di
produttori privati e nelle loro individuali collisioni reciproche che si scopre il loro essere
assoggettati ad un potere sociale estraneo che li sovrasta. L’esistere stesso dei singoli
produttori è determinato in tutto e per tutto dalla formazione sociale a cui essi servono.
Maggiore è il grado di sviluppo della divisione sociale del lavoro, maggiore è la
dipendenza dei primi rispetto al secondo. Venendo meno l’utilità della merce prodotta dal
singolo da parte della società, viene meno anche la sua ragione di esistere come produttore.
Per questo la creazione di valore tramite il lavoro deve essere oggettivato in un valore
d’uso che sia scambiabile. Se ciò non accade il lavoro impiegato non conterrebbe lavoro
creatore di valore, rendendo la merce senza valore. E’ facile intuire che Marx perviene a
questa conclusione riesaminando il motivo per cui il tempo di lavoro non può essere
direttamente espresso in denaro.
Il tempo di lavoro non è solo quantitativamente ma anche qualitativamente determinato.
Nella produzione delle merci quindi il lavoro del singolo è sempre lavoro particolare,
qualitativamente particolare, e non identico. Il suo carattere sociale è posto solo come
122
determinazione ideale. Per questo sulla base dei valori di scambio il lavoro presuppone che
“né il lavoro del singolo né il suo prodotto siano immediatamente generali”326
.
Ma cosa vuol dire lavoro generale? Certo è che Marx utilizza questo concetto in un modo
duplice: sia come lavoro in forma immediatamente scambiabile (è questo il caso dei
lavoratori che producono oro, in quanto questo è immediatamente generale dato dalla
stessa funzione di mediazione universale di scambio – e questo ci fa comprendere quanto
questo aspetto sia certamente determinato ad un modo di produzione, comunque comune
ad ogni formazione sociale basata sulla proprietà privata dei mezzi di produzione e sulla
conseguente divisione sociale del lavoro) sia in senso più complesso che vede
nell’universalità quell’unione di universale e particolare. In altri termini, il lavoro generale
è sia totalità delle particolarità sia indifferenza di queste particolarità. E l’indifferenza si
predica non della particolarità come tale, bensì alla singola o isolata particolarità. Dunque
il lavoro generale ha in sé un carattere proprio sia ad ogni lavoro singolo sia a qualcosa di
estraneo ad ogni lavoro singolo, giacché questo lavoro è sempre particolare e
oggettivizzabile solo in un prodotto determinabile, ma come lavoro generale deve potersi
rappresentare contemporaneamente in tutti i prodotti del lavoro.
Qui il denaro è la merce che riesce a risolvere questo duplice aspetto contraddittorio,
poiché il carattere generale si individualizza contrapponendosi agli altri prodotti nella sua
forma di denaro al di là di ogni forma di merce in cui è oggettivato. Nello scambio ogni
lavoro oggettivato nella merce deve qualitativamente e quantitativamente confrontarsi con
il lavoro oggettivato nel denaro.
Ma il lavoro che crea valore è sempre lavoro del singolo. Che però porta con sé questo
carattere generale solo in quanto si oggettiva in una merce e quindi nel valore. Non ogni
lavoro è produttore di valore, sebbene in ogni produzione venga speso lavoro e
materializzato tempo di lavoro. Allora ne deduciamo non solo che il lavoro creatore di
valore è socialmente determinato, ma che lo stesso valore è qualcosa di puramente sociale.
Il carattere sociale del valore e del lavoro va ora analizzato. Ma il primo aspetto da
considerare è riposto in un sostrato, in una sostanza come dice Marx in più punti327
, che è il
lavoro semplice. Per questo “l’equivalenza è determinata dall’uguaglianza del tempo di
326 Cfr. Walter Tuchscheerer, op. cit. , pag. 118
327 Cfr. Karl Marx, Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica, op. cit. , vol. I pagg. 113,
164, 228, 251, vol. II pag. 596
123
lavoro o della quantità del lavoro”328
. Questa nozione è utilissima perché la sua
moltiplicazione rappresenta nel valore delle quantità di lavoro semplice, identico.
Ma abbiamo in precedenza affermato che la nozione di lavoro astratto non è da pensarsi
come la sommatoria dei caratteri comuni a tutti i lavori. Questo concetto non terrebbe
conto del carattere antagonistico e normativo che esso possiede rispetto ai lavori
particolari. Per questo la nozione di lavoro astratto non raccoglie semplicemente le diverse
determinazioni del lavoro creatore di valore in una categoria comune329
.
La prima proprietà del lavoro astratto non è affatto quella di diventare sociale solo in
quanto equivalente e rappresentante una mera equiparazione dei singoli lavori concreti;
astrazione che si compirebbe tramite una selezione dei caratteri comuni di questi ultimi di
cui le merci sarebbero il prodotto. Dobbiamo capire meglio questo suo essere dispositivo
normativo nella sua estensione. Vediamo in concreto cosa vogliamo dire: Ogni produttore
è formalmente libero di produrre ciò che vuole, con qualsiasi metodo e con qualsivoglia
strumenti. Ma quando porta la merce sul mercato, non è più libero di determinare la misura
dello scambio, ma deve sottomettersi alle condizioni e alle fluttuazioni del mercato stesso.
Ma quindi già nel processo di produzione diretto è costretto a confrontarsi alle condizioni
previste del mercato. In tal modo il produttore viene a dipendere da tutti gli altri
componenti della società. Tra queste condizioni, quella principale che riguarda la
produzione è identificabile con il processo lavorativo. Il lavoro astratto detta i tempi della
produzione. E questi tempi risultano soggiogare ed imporre determinate condizioni
lavorative non solo ai lavoratori, ma anche ai capitalisti. Ma esso non è astratto nel senso
che sia separato dalle condizioni di sviluppo delle forze produttive. Tutt’altro! In esso
invece si riflette il grado di sviluppo di queste. Ma allora che relazione ha il lavoro astratto
con i rapporti di produzione? Dietro questa domanda si staglia con tinte più nitide il difetto
principale della linea continuistica. Arriveremmo a capire in seguito il significato di questa
affermazione. Continuiamo ancora il nostro ragionamento. Il valore non può essere
espresso direttamente in tempo di lavoro, ma deve trovare espressione in una merce diversa
328 Ibidem, pag. 556
329 Lo avevamo già accennato, ma conviene ripeterlo: Marx considera il duplice carattere del lavoro una
delle sue più importanti scoperte. In un’altra lettera ad Engels engels infatti dice: “Il meglio del mio libro è:
1) (su ciò riposa tutta la comprensione dei fatti) il doppio carattere del lavoro subito messo in rilievo nel
primo capitolo, a seconda che esso si esprima in valore d’uso o in valore di scambio; 2) la trattazione del
plusvalore indipendentemente dalle sue forme particolari quali il profitto, l’interesse, la rendita fondiaria,
ecc.” Cfr. Meoc, Op. cit., vol. XLII, pag 357.
124
dal tempo di lavoro, oppure, in altre parole, perché il valore deve trapassare nel valore di
scambio come sua forma fenomenica e nel prezzo come sua espressione monetaria330
.
La merce è dunque qualitativamente distinta dal tempo di lavoro in cui viene misurata e
posta in una relazione commensurabile rispetto alle altre merci. La merce non è tempo di
lavoro, bensì tempo di lavoro materializzato; il risultato di un lavoro determinato. La
distinzione tra le merci viene posta tramite il porre stesso in un’unità comune tutte le
merci, in lavoro qualitativamente uguale. E le differenti merci inglobano diverse quantità
di questa stessa qualità, così da poter essere commisurabili e scambiabili sul mercato. Ma
ciò che è uguale nei due rispetti qualitativamente non lo è quantitativamente.
Ma il valore di una merce non è semplicemente tempo di lavoro, ma tempo di lavoro
oggettivato. E questo ci fa comprendere che per Marx non è il lavoro una merce, poiché se
fosse tale allora dovremmo trovarla sempre in una forma oggettivata. Invece il lavoro nel
rispetto del tempo di lavoro come tale è sempre in forma potenziale e soggettiva che può
attualizzarsi e configurarsi come valore solo in un rapporto di produzione storicamente
determinato, e dunque oggettivarsi in una merce dando ad essa valore. Solo
l’oggettivazione crea valore.
Sebbene il tempo di lavoro sia la misura del valore e stia alla base del rapporto di scambio
tra due merci, non può servire direttamente come espressione di valore né essere la misura
dei prezzi.
La merce deve esprimere il proprio valore in un’altra oggettivazione di tempo di lavoro. E
se questa oggettivazione è la merce denaro universale, il valore della prima è espresso
come prezzo. Ma siccome la merce deve effettivamente scambiarsi con una determinata
quantità di merce-denaro, allora il suo scambio è il prezzo reale che essa ottiene, che non è
determinabile semplicemente dal suo valore, perché il valore e il prezzo sono
sostanzialmente diversi. Mentre il primo è determinato dalla quantità di lavoro oggettivato
nelle merci, il prezzo è determinato dal rapporto tra domanda e offerta. E questo rende
plausibile realmente lo scambio con una merce che abbia una quantità o maggiore o minore
rispetto al valore che essa stessa possiede. Solo nell’astrattezza della coincidenza tra
domanda e offerta valore e prezzo coincidono. Il valore delle merci dunque non appare
così com’è esso stesso, bensì si manifesta come prezzo medio in un lungo periodo, è “una
media che figura come una astrazione estrinseca finchè viene ricavata addizionalmente
come cifra media di un periodo”, ma che comunque “è molto reale quando viene
330 Marx dice che “ciò che determina il valore non è il tempo di lavoro incorporato nei prodotti, bensì il
tempo di lavoro attualmente necessario” Cfr. Karl Marx, Lineamenti, op. cit. , pag. 69,
125
contemporaneamente individuata come la forza impulsiva e il principio motore delle
oscillazioni a cui vanno soggetti i prezzi delle merci durante un periodo determinato”331
. Il
valore è quindi un che di nascosto che non trova espressione direttamente nel prezzo, ma
resta, per così dire, celato dietro gli infiniti movimenti dei prezzi. Anche se Marx pensa che
nel lungo periodo il valore e prezzo medio si eguaglino. Il secondo è “la legge dei
movimenti percorsi dal primo”332
.
Se questa distinzione è sostanzialmente quantitativa, Marx cerca di indagarne anche le
differenze in senso qualitativo procedendo dalla forma fenomenica all’essenza del valore,
ossia dal prezzo al valore, e non viceversa dal lavoro al valore e dal valore al valore di
scambio, come potrebbe sembrare dall’esposizione della teoria del valore sia da Per la
critica dell’economia politica e sia dal primo libro del Capitale. Proprio dal movimento dei
prezzi delle merci egli “astrae il valore come legge che sta alla base della determinazione
dei prezzi delle merci”333
.
Il capitalista non paga il valore del lavoro, come credevano gli economisti classici, bensì il
valore della capacità lavorativa dell’operaio. Questo consente di rispondere alla domanda:
perché se il valore del lavoro, ossia il salario, non è uguale al valore prodotto dal lavoro?
Il fatto che il valore d’uso della capacità lavorativa sia l’elemento del valore e della
moltiplicazione del valore, non può modificare la legge generale per la quale nello scambio
le merci si contrappongono come equivalenti e nessuno può derivare dallo scambio un
valore maggiore di quello che vi ha immesso. Di più, le leggi dello scambio tra equivalenti
vengono corrisposte pienamente alle leggi dello scambio.
Il processo di produzione del capitale ha un carattere duplice. Esso appare da una parte
come un processo di produzione semplice ossia come processo materiale della produzione
puro e semplice, quale è proprio di tutte le formazioni sociali costituendo una condizione
basilare per l’esistenza di una formazione sociale, e dall’altra come processo di
valorizzazione. Il processo di produzione è processo di produzione del capitale.
Nei Lineamenti Marx afferma che dal punto di vista del processo di produzione semplice,
il processo di produzione del capitale non differisce affatto da altre forme di produzione.
E’ invece il secondo aspetto ad essere discriminante del modo di produzione capitalistico.
La forza lavoro ha un valore di scambio che è tracciabile e riconoscibile in base al tempo
di lavoro necessario a riprodurla. Il suo valore d’uso è quello di creare valore. Posta in
331 Ibidem, pag. 71
332 Ibidem, pag. 72
333 Cfr. Walter Tuchscheerer, op. cit., pag. 303
126
determinati rapporti di produzione, essa è capace, nella realizzazione delle merci e nello
scambio seguente, di produrre merci il cui valore di scambio è superiori al salario pagato
per la riproduzione del lavoratore .
Pur creandolo, il lavoro non ha valore. Questo carattere contraddittorio del lavoro viene
offuscato dalla categoria fenomenico/ideologica del valore del lavoro, quando invece è la
forza-lavoro a possedere il carattere del valore. Ogni sistema di divisione del lavoro è allo
stesso tempo un sistema di distribuzione del lavoro. Nella comunità del comunismo
primitivo, nel sistema schiavistico e in quello feudale, il lavoro dei membri di una
determinata unità economica è distribuito razionalmente tra le varie funzioni a seconda del
tipo di bisogni dei membri del gruppo e del livello di produttività del lavoro. Il modo di
produzione capitalistico invece si caratterizza per una forte anarchia della divisione sociale
del lavoro334
, conseguenza diretta dell’anarchia della produzione335
, che a sua volta
presuppone uno sfruttamento sfrenato della forza-lavoro da parte del capitale336
.
Nell’economia capitalistica non vi è nessuno controllo nella distribuzione del lavoro tra i
vari rami della produzione e le imprese private. Nessun produttore, ad esempio, di vetture
conosce in anticipo la domanda sociale esistente per tale merce, né la quantità
contemporaneamente prodotta dalle altre imprese tessili. L’equilibrio tra la sua produzione
particolare e quella del suo ramo, e quella di questo con gli altri rami è continuamente
interrotto. Viene da chiedersi come possa continuare a funzionare un simile modo di
produzione. Ma l’anarchia della produzione trova, oltre ai diversi dispositivi esterni come
quelli delle norme statali e quelle interne al mercato come la concorrenza, un forte
elemento di coercizione: quello del lavoro astratto. Esso stabilisce, non dall’interno come
potrebbe apparire superficialmente, ma esternamente, le modalità di produzione e i tempi.
Il tempo di lavoro socialmente determinato è uno strumento di controllo che viene stabilito
all’interno del concetto-contenitore del lavoro astratto. Ciò lo comprendiamo
maggiormente se lo poniamo direttamente in relazione con l’accentramento del capitale
monopolistico-finanziario e con la centralità dei ritmi asfissianti delle industrie moderne.
Bisogna criticare la tesi che identifica l’esteriorità del nesso sociale come carattere
specifico del modo di produzione capitalistico. In realtà, questo nesso è comune ad ogni
modo di produzione. Certo è che ogni modo di produzione ha una forma specifica di nesso.
334 Cfr. Meoc, Op. cit. , vol. XXXI, pag. 391
335 Ibidem, pag. 521
336 Non è affatto casuale che Marx sottolinei in entrambi i luoghi il carattere di sfruttamento selvaggio della
forza-lavoro nel modo di produzione capitalistico
127
E nel capitalismo risiederebbe nella divisione sociale del lavoro autonomizzatasi,
generatrice del carattere conflittuale tra lavoro sociale e privato, tra denaro, come prodotto
sociale, e merce come prodotto privato. Ed è la legge della riduzione del tempo di lavoro
necessario ad imporsi dall’esterno.
A livello fenomenico esistono svariati capitali individuali, che in realtà costituiscono un
unico capitale, di cui i singoli capitali sono espressione337
. La struttura generale del
capitale detta le proprie leggi su quelli individuali ed è per questo che il lavoro astratto
detta i tempi e i modi sui lavori concreti. Chi esce fuori dalle norme produttive dei tempi e
delle modalità di scambio finisce per soccombere ed essere riassorbito da altre frazioni del
capitale maggiori o uguali.
Avevamo detto poc’anzi che esistono diversi capitali individuali che sono da considerarsi
segmenti di un unico capitale. Con ciò arriviamo a comprendere cosa voglia dire l’uscita
dall’umanismo. Gli attori della Storia non sono da ricercarsi nei soggetti umani: al centro
della teoria di Marx sono posti i rapporti di produzione. Il capitalista “ è soltanto capitale
personificato”338
, il proprietario fondiario “si presenta come la personificazione di una
delle più importanti condizioni della produzione”339
, e l’operaio “come proprietario e
venditore della sua forza lavorativa, riceve come salario una porzione del prodotto che
rappresenta la porzione del suo lavoro definita lavoro necessario, vale a dire lavoro
necessario per la conservazione e riproduzione di questa stessa forza lavorativa, sia che le
condizioni di una simile conservazione e riproduzione siano abbondanti oppure scarse”340
.
Il capitale crea lavoro salariato. Il lavoro infatti è precedente al capitale, ma non il lavoro
salariato. Questo è fondamentale. Il lavoro esiste in ogni epoca storica, ma la forma di
lavoro salariato l’acquista solo nei rapporti di produzione capitalistici. Naturalmente, qui
non si assiste ad un semplice mutamento della forma, ma anche del contenuto stesso del
lavoro, innanzitutto perché il lavoro, come capacità produttiva, viene modificato in ogni
337 “Sia nella prima che nella seconda sezione tuttavia abbiamo sempre parlato solo d’un capitale individuale,
del movimento di una parte autonoma del capitale sociale. Ma i cicli dei capitali individuali si intersecano gli
uni con gli altri, si presuppongono e si condizionano a vicenda, e proprio con questa sovrapposizione
formano il movimento del capitale sociale complessivo. […]. Dobbiamo esaminare adesso il processo di
circolazione (che nel suo insieme è forma del processo riproduttivo) dei capitali individuali in quanto
elementi del capitale sociale complessivo, vale a dire il processo di circolazione di questo capitale sociale
complessivo” Cfr. Karl Marx, Il capitale , op. cit. , pag. 799
338 Ibidem, pag. 1467
339 Ibidem, pag. 1469
340 Idem
128
modo di produzione, asservito ai rapporti stessi di produzione in vista di ciò che deve esser
prodotto. Aspetto non secondario di questo meccanismo è l’intenso processo di restrizione
dell’ambito dell’applicazione della forza-lavoro conseguente alla parcellizzazione dei
lavori particolari assoggettati nella grande industria che porta ad una sempre maggiore
specializzazione, e quindi affinamento delle capacità stesse, e nel contempo ad una crescita
generale astratta delle stesse capacità lavorative complessive delle . Ma la classe sociale
che detiene i mezzi di produzione non è certo la creatrice della classe che detiene questa
forza-lavoro.
Il sottovalutare quell’atteggiamento di sottrazione del campo metafisico non può essere
colto nelle sue profonde implicazioni da chi ha pensato lo sviluppo della teoria marxiana in
linea continuativa con le sue origini, finendo così per pensare la concreta essenza umana
non nelle proprietà comuni ad ogni individuo, ma nel processo totale della vita sociale e
nelle leggi del suo sviluppo, facendo dell’uomo stesso un prodotto non della natura bensì
del lavoro341
: proprietà e caratteri individuali sarebbero in ultima analisi prodotti del lavoro
sociale, e solo così possono definirsi specificamente umani. Nemmeno la riconduzione
dell’ambito umano nei rapporti mercificati riescono a cogliere questo radicale scarto del
pensatore tedesco. Il valore sarebbe considerato un rapporto umano che acquista la forma
di cosa e in questa forma si lega al processo della distribuzione sociale del lavoro.
insomma, si tratta di un processo reificazione di un rapporto di produzione tra persone” e
la reificazione del lavoro come valore è l’esito decisivo cui giunge la teoria del feticismo.
Ma è stato Lukacs ha sottolineare come, nella complessa struttura della merce, sia
contenuto “il modello di tutte le forme di oggettualità e di tutte le forme ad esse
corrispondenti della soggettività nella società borghese”342
. La reificazione dal capitale
sarebbe deducibile da questo arcano della forma di merce che in ultima analisi è uno
specchio rovesciato del reale, cioè dei reali rapporti tra uomini.
L’essenza di questa struttura consisterebbe nel fatto che una relazione tra persone riceve il
carattere della cosalità, o meglio di una oggettualità spettrale, che obnubila nella sua
legalità autonoma, “rigorosa, apparentemente conclusa e razionale, ogni traccia della
propria essenza fondamentale: il rapporto tra uomini”343
. Così l’universalità della forma di
merce determinerebbe una astrazione del lavoro umano oggettualizzato nelle merci sia dal
341 Tradizione inaugurata da Engels, e di cui Ilenkov è uno dei più espliciti assertori tra gli scienziati
sovietici, Cfr. Evald Vasilevic Ilenkov, Op. cit. , pag. 30
342 Cfr. Gyorgy Lukacs, Storia e coscienza di classe, op. cit. ,pag. 107
343 Ibidem, pag. 108
129
punto di vista oggettivo e soggettivo: della prima in quanto la forma di merce come forma
d’eguaglianza tra oggetti differenti e formalmente eguali si può inverare solo andando oltre
la forma, verso quel contenuto identico che è identificato col lavoro; della seconda in
quanto tale uguaglianza formale del lavoro umano astratto si trasformerebbe in principio
reale della produzione di merci durante un processo di sviluppo del modo di produzione
capitalistico che lo porterebbe ad essere commisurato con esattezza al tempo di lavoro
socialmente necessario344
.
Ma davvero Marx continua a ragionare in termini di soggetto-oggetto? Soprattutto, non ci
troviamo di fronte ad una concezione che vede nella merce l’elemento assolutamente
semplice che contiene in sé tutte le contraddizioni del capitalismo? Ma se così fosse,
crollerebbe l’intera impalcatura del Capitale. Infatti, lì è posta quella distinzione tra valore
d’uso, valore di scambio e valore, dalla quale non si dovrebbe prescindere, soprattutto alla
luce del fatto che il valore d’uso non è trattato nell’opera (a ciò è demandata, a detta dello
stesso autore, un’analisi merceologica, cosa che non è al di fuori dei suoi interessi), non
perché esso sia non determinato dal modo di produzione capitalistico, anzi potremmo dire
che ciò che spinge e muove un consumatore all’acquisto di un oggetto possedente valore
d’uso affonda in decisioni che sono comunque determinate storicamente ed eterodirette,
ma perché questa sfera è al di fuori di una trattazione di carattere economico. Lo afferma
nettamente lo stesso Marx nelle sue Glosse a Wagner, il quale lo aveva criticato proprio
per il fatto di aver allontanato dalla scienza la trattazione del valore d’uso. Qui Marx
dichiara apertamente di non essere partito da concetti e quindi neppure dal concetto di
valore. Così egli non dovrà dividere lo stesso in diverse parti; invece la sua impostazione
parte dalla forma sociale più semplice, dal “concreto economico più semplice”345
, cioè la
merce, descrivendola come essa stessa appare: da una parte, nella sua forma naturale,
come oggetto d’uso, e dunque valore d’uso, dall’altra portatrice di valore di scambio, e da
questo punto di vista come valore di scambio. Analizzando ulteriormente quest’ultimo
aspetto, vediamo che anche il valore di scambio è una forma fenomenica, un modo di
presentazione indipendente del valore contenuto nella merce. Da qui l’ulteriore passaggio
all’analisi della merce. In effetti, è lo stesso Marx ad affermare che la scienza consiste
nell’esibizione del modo in cui la legge del valore si impone346
. Ma il valore d’uso non
rappresenta di certo l’opposto del valore; anzi, dice Marx, il valore stesso non ha niente in
344 Ibidem, pag. 113 e ss.
345 Cfr. Karl Marx, Op. cit. ,pag. 176
346 Cfr. Meoc, Op. cit. , volume XLIII, pag. 598
130
comune con esso se si fa eccezione dal termine valore347
. Di più, Marx afferma che nella
sua analisi è tralasciato anche il valore di scambio, poiché esso è solo forma fenomenica
del valore. Non dividendo dunque il valore in valore d’uso e di scambio come opposti
scissi dal valore preso in senso astratto. È “ bensì la concreta figura sociale del prodotto
del lavoro, la “merce”, da una parte valore d’uso e dall’altra “valore”, non valore di
scambio, poiché questo è semplicemente forma fenomenica, non il suo proprio
contenuto.”348
349
. È altresì rifiutata la concezione per la quale vi è una sostanza sociale
comune del valore di scambio. Piuttosto afferma che “i valori di scambio (il valore di
scambio al singolare non esiste) rappresentano qualcosa di comune fra loro – il “valore”
appunto” 350
. Ma soprattutto, l’analisi della merce ha permesso a Marx di mostrare come in
questo carattere duplice si presenti il duplice carattere del lavoro, di cui la merce è il
prodotto. Il valore della merce esprime in una forma storicamente determinata ciò che
esiste anche in tutte le altre forme storiche di società, sebbene con un carattere precipuo:
quello sociale del lavoro, in quanto esso esiste come dispendio di forza-lavoro sociale. E
qui è chiamato in causa di nuovo il lavoro astratto, poiché è esso il dispositivo dominanti in
questo ambito.
Se guardiamo invece al valore, ci accorgiamo che esso non può essere espresso
direttamente in tempo di lavoro, ma deve trovare espressione in una merce diversa dal
347
Il fraintendimento circa la presunta contraddizione tra valore d’uso e di scambio ha portato a compiere
errori perniciosi, a livello teorico, nella storia del marxismo. Persino Vigotsky ha creduto a ciò, tanto da
dedurne da essa il denaro: “Questa contraddizione fra l’omogeneità economica delle merci e la loro diversità
naturale, cioè, come si può anche dire, questa contraddizione tra valore e valore d’uso, conduce nel processo
di scambio alla separazione del valore delle merci dalla merce stessa, allo sdoppiamento della merce in merce
e denaro” Cfr. Vitalij Vigotsky, Introduzione ai Grundrisse di Marx, La nuova Italia, Firenze, 1974, pag. 54.
L’interna contraddizione della merce troverebbe la sua “soluzione esterna nel processo di scambio, nello
sdoppiamento della merce in merce e denaro, nel fatto che il valore della merce acquista esistenza autonoma
in una merce particolare, nel denaro” Ibidem, pag. 55. Ma l’analisi del denaro è fondamentale perché la sua
comprensione rappresenta il criterio per comprendere l’essenza del valore. E gli economisti classici non ne
capirono l’essenza. Ad esempio, Ricardo “di fatto si occupò del lavoro solo come misura di grandezza di
valore e perciò non trovò alcun nesso fra la sua teoria del valore e la natura del denaro” Cfr. Karl Marx,
Glosse marginali al Manuale di economia politica di Adolph Wagner, op. cit. , pag. 168
348 Ibidem, pag. 175
349 E’ interessante notare come Marx rifiuti la critica mossagli da Wagner relativa al fatto che la teoria del
valore sia la pietra angolar del suo sistema, poiché, egli dice, non ha mai elaborato un sistema.
350 Ibidem, pag. 167
131
tempo di lavoro, oppure, in altre parole, perché il valore deve trapassare nel valore di
scambio come sua forma fenomenica e nel prezzo come sua espressione monetaria.
Le merci possono essere scambiate, ed esser misurate reciprocamente perché possiedono
un’identica qualità, sono valore. Ma non solo valore. Esse sono specificatamente valore
quantitativamente determinato. Ma nello scambio il suo essere valore di scambio e valore
non sono reciprocamente convertibili. Qui la merce deve confermarsi come unità di
entrambe le determinazioni, altrimenti si ricadrebbe in una contraddizione tra le qualità
naturali ed economiche della stessa merce. Nello scambio tutte le qualità delle merci sono
cancellate. Per essere scambiabili le merci devono ricevere la loro denominazione in
un’unità. Tra due merci da scambiare, la valutazione dell’atto dello scambio si ha con una
terza merce che funge da elemento comune su cui poter confrontare il valore delle due
merci. Il valore non si esprime semplicemente in tempo di lavoro, ma in una determinata
oggettivazione di tempo di lavoro. E questo ci risospinge alla soluzione del problema che
inaugurava il nostro paragrafo, e che ci mostra, ancora una volta, il carattere di differenza
radicale tra Marx ed Hegel. Lo faremo proprio investigando la forma del valore, così da
comprendere la genesi del capitale. Eviteremo sin da subito di vedere nello scambio diretto
di una merce con un’altra una forma embrionale che cela e spiega tutte le forme più
complesse e più sviluppate dei rapporti di produzioni capitalistici: non bisogna mai
dimenticare che nello scambio intervengono infiniti dispositivi e che la merce non è da
vedersi come una cosa semplice. Ecco lo scarto che intercorre e separa Marx da Hegel!
L’iniziare dalla cosa più semplice segna sicuramente un punto di comunanza tra i due,
poiché di fatto nella Logica Hegel afferma che “il cominciamento è logico, in quanto
dev’esser fatto nell’elemento del pensiero che è liberamente per sé, cioè nel sapere
puro”351
e il sapere puro è quello che non ha in sé alcuna differenza, la “semplice
immediatezza”352
. E così il cominciamento dev’essere un “cominciamento assoluto o, ciò
che in questo caso significa lo stesso, un cominciamento astratto”353
.
Ma questo carattere di semplicità in realtà è davvero così simile a quello hegeliano? Se la
merce ha due determinazione interne, valore d’uso e di scambio, donde la semplicità? Di
più, si dà un ente del tutto semplice nell’ambito del concreto? In realtà Marx inizia il
capitale non dalla merce, bensì da come essa appare. E nel suo apparire essa si mostra
come cosa utile, valore d’uso, e come portatrice di valore di scambio. Un’ulteriore analisi
351 Cfr. Georg W. F. Hegel, Scienza della logica, op. cit. , pag. 53
352 Ibidem, pag. 55
353 Idem
132
di quest’ultimo carattere “mi indica che il valore di scambio è soltanto una forma di
manifestazione, autonomo modo di presentarsi, del valore contenuto nella merce, e allora
io procedo all’analisi di quest’ultimo”354
.
I caratteri di semplicità e concretezza della merce rimandano all’essere della merce come
risultato di un processo complesso. Ma il presentare questo risultato come iniziale
nell’esposizione non deve trarci in inganno circa la sua natura. In essa non troviamo, posta
come forma particolare derivata del processo, tutti gli elementi di questo procedere, che è
anche un precedere rispetto all’esistere concreto della merce. Di più, in essa tutte le
contraddizioni non sono affatto riflesse, come se dovesse contenerle di necessità in quanto
risultato. L’iniziare il Capitale con l’analisi della merce ha portato molti autori a credere
che Marx fosse così ripiombato nell’idealismo. Soprattutto Althusser ha insistito su questo
aspetto355
, perché riteneva problematico il carattere astratto della merc. Carattere tra l’altro
immediatamente superato nel secondo libro del Capitale, dove la si vede concretizzarsi
nella circolazione. Ma soprattutto, qui va detto che Marx pensa la merce nel suo apparire,
manifestandosi un immediatamente concreto che però, a ben vedere, è tutto fuorché
semplice. Anzi, è il precipuo carattere estremamente composito che permette l’uscita da
quella sorta di velo di cui è rivestita, e che apre ad un’analisi dei caratteri che ne celano il
segreto della formazione. Quando Marx affermava la semplicità della merce, troppo spesso
si è pensato a questo attributo in termini molto simili a quelli della tradizione filosofica
occidentale. Qui non si parla di una semplicità assoluta, non ulteriormente divisibile, un
antecedente al composito, bensì si guarda ad un prodotto di un’attività complessa e
strutturata che forgia prodotti. In definitiva, la merce non è un oggetto assolutamente
semplice, ma il più semplice prodotto di un modo di produzione. Dal punto di vista della
logica di Marx, prendendo in esame un altro modo di produzione, il partire dalla merce
sarebbe stato uno errore abnorme poiché solo il capitalismo li produce.
L’analisi astratta della merce nel modo di produzione capitalistico si concentrerebbe quindi
sull’esplicazione delle leggi immanenti del fenomeno dato, dell’aspetto astratto in grado di
rappresentare nell’immediato lo stesso fenomeno preso nel rispetto del concreto ma
separato da altre determinazioni in cui esso è inserito. Se il nostro si fosse abbandonato al
metro logico di Hegel, avremmo dovuto considerare ogni fenomeno capitalistico come
generato dalla merce e dalla sua intricata struttura. Così accumulazione, concorrenza,
354 Cfr. Karl Marx, Glosse, op. cit. , pag. 175
355 Cfr. Louis Althusser, Marx nei suoi limiti, Mimesis, Milano 2004, pag. 63 e ss.
133
feticismo ecc. sarebbero delle filiazioni dilatate di una presunta contraddizione insita della
merce, la quale avrebbe gettato i propri riverberi all’esterno creando, tramite la dilatazione
di quella contraddizione, relazioni e figurazioni sempre più concrete e complesse. La stessa
analisi del lavoro sarebbe stata altra da quella che stiamo esponendo, perché la sua forma
sociale è da considerarsi come il rapporto reciproco tra i diversi individui presa nel rispetto
del lavoro eguale e determinati da una forma specificamente sociale, l’uguaglianza che
esprime lo scambio deducibile in un primo momento dello scambio stesso, a sua volta
dedotta dal carattere sociale del lavoro. Avendo Marx esposto all’inizio il valore dal
confronto tra i tanti valori d’uso e il lavoro astratto da quelli concreti, questa impostazione
ha generato innumerevoli critiche. Böhm-Bawerk ad esempio affermava che il confronto
tra valori d’uso può metter capo solo al valore d’uso in generale356
. Invece, la genesi della
forma valore è da ricondurre alla contraddizione tra lavoro sociale e privato. Ponendo
l’impossibilità teorica dello scambio della forma relativa con quella equivalente di valore,
cioè la non riduzione del valore della merce al proprio valore d’uso, spingendo questo
confronto ad un altro valore d’uso che fa da merce equivalente, il valore della merce
relativa si delinea in una determinata quantità di valore d’uso che assume la forma di
valore di scambio. Il valore è l’esistenza sociale delle merci, la condizione formale dello
scambio. Ma così come il lavoro privato non è immediatamente sociale, allo stesso modo il
prodotto del lavoro non è immediatamente valore. Per esser sociale, il valore deve
esprimersi in una forma scissa dal valore d’uso, e così facendo può dimostrare il suo
carattere sociale, o meglio, può acquisirlo. Ciò che abbiamo detto per il carattere semplice
della merce vale anche per il rapporto di valore: ne esiste uno più semplice che esprime
tale rapporto con una sola merce.
Nel rapporto x merci A = y merci B, dove i due poli dell’espressione indicano
rispettivamente la forma relativa di valore e la forma di equivalente, l’uguale nasconde una
differenza radicale. Il rapporto è identità di contrari. E nell’equazione il termine identico
non appare. Prima andare avanti, dobbiamo precisare che l’analisi del valore e dello
scambio è da pensarsi chiaramente in termini prima di tutto logici; non bisognerebbe
pensare ad essi come ad una ricostruzione sul piano teorico di quanto accade nel reale357
.
Qui sono fondamentali i risultati nell’ambito logico. Secondo un approccio logistico le
determinazioni del valore in generale, secondo i suoi principi, andrebbero formate
356 Cfr. Böhm-Bawerk, La teoria dell’interesse di Marx, in Paul Marloro Sweezy, La teoria dello sviluppo
capitalistico, Boringhieri, Torino 1970, pagg. 316-9
357 E’ questo un altro errore fatto da Rubin, cfr. Isaak Rubin, Op. cit. , 88
134
astraendo dalle particolarità di tutte le specie di valore, la circolazione semplice delle merci
compresa, e gli stessi caratteri particolari della forma mercantile del valore sarebbero
considerati inutili. Dunque il generale sarebbe stato preso separatamente dal particolare. In
Marx le cose stanno altrimenti e questo per via di quell’intricato rapporto tra l’universale,
il particolare e il singolare che avevamo visto precedentemente. L’universale infatti non si
dà mai come separazione dal particolare. Il valore della prima merce è dato come valore
relativo nel senso che esso è espresso in altra merce, quella equivalente. Marx qui ci
ricorda che l’equazione può essere rovesciata, e quindi la stessa merce “non può quindi
comparire contemporaneamente nella stessa espressione di valore in entrambe le
forme”358
359
. Il senso dello scambio sta nella sostituzione reciproca di valore di scambio e
di valore d’uso, di forma relativa ed equivalente. In questa trasformazione, si realizza il
valore. Ecco perché Marx nel primo libro afferma che le due merci non possono
presentarsi simultaneamente nelle due forme nella medesima espressione di valore.
L’opposizione interna alla merce nello scambio si esprime in forma esterna.
Se il valore di scambio è la forma fenomenica del valore è anche vero che il valore può
presentarsi soltanto nel rapporto sociale tra merce e merce cosicché deve esser analizzato
nella forma di valore, o valore di scambio. Prendendo due merci poste in scambio x merce
A = Y merce B, i due termini sono momenti inseparabili, ma nello stesso tempo sono
estremi escludentisi l’un l’altro, ossia opposti”. Allora, nello scambio l’opposizione tra
valore d’uso e valore viene rappresentata in una opposizione esterna, cioè dal rapporto fra
due merci, che sono uno lo specchio dell’altro, ossia il valore della merce A è espresso in
forma relativa rispetto alla merce B. In altri termini è posta come equivalente.
Il rapporto di valore mostra il valore nella relazione tra il valore di una merce e il corpo
dell’altra, nel suo valore d’uso. Il termine che ne fissa l’eguaglianza è da identificare con il
lavoro, perché i valori sono cristallizzazioni di lavoro umano. Ma non è sufficiente
esprimere tale carattere del lavoro: il lavoro umano, che non è valore, ma produce valore,
diviene valore solo nella sua forma oggettivata, “che sia distinguibile, coralmente, dalla
tela stessa e che, al tempo stesso, sia ad essa in comune con le altre merci”360
. Ma la merce
non è solo espressione delle qualità del lavoro umano, bensì è valore determinato
quantitativamente, grandezza di valore. Dunque l’espressione dell’eguaglianza indica una
medesima grandezza, cioè che le merci siano state prodotte con il medesimo tempo di
358 Cfr. Meoc, Op. cit. , vol. XXXI, pag. 59
359 E’ questo uno dei casi in cui Marx fa intervenire il principio di non contraddizione
360 Ibidem, pag. 61-2
135
lavoro necessario. Il tempo di lavoro necessario subisce spesso delle variazioni, e ciò si
riflette sull’espressione di valore.
Ma torniamo alla nostra equazione, e indaghiamo la forma di equivalente. L’avevamo
considerata nella sua posizione come valore d’uso che “diventa forma fenomenica del suo
contrario, del valore”361
. Ma la forma di equivalente ha una seconda peculiarità, quella di
rendere il lavoro concreto “forma fenomenica del suo contrario, del lavoro astrattamente
umano”362
poiché entrambe le merci poste nel rapporto di equazione possiedono la
proprietà universale del lavoro.
Marx sottolinea qui l’importanza dei rapporti sociali nella determinazione valore. Se ad
esempio identifichiamo la merce a con la tela e quella equivalente con un abito, vediamo
che la prima esprime da un lato il suo esser valore come un che del tutto differente dal suo
corpo e dalle sue proprietà e dall’altro l’abito, nel suo corpo merce, esprime il valore della
tela e questo fatto è immediatamente riconducibile ad un rapporto sociale. La proprietà
dell’abito di fungere da equivalente non appartiene di certo alla natura dell’abito. Solo
guardando oltre la forma naturale della merce si più comprendere la possibilità stessa
dell’equivalenza. E la soluzione è riposta nel duplice carattere del lavoro, che rende la
merce prodotto di un lavoro concreto e contemporaneamente come lavoro umano astratto.
E siccome un lavoro concreto come la sartoria, caratterizzato dal dispendio di lavoro
umano indifferenziato, e come tale è commisurabile a qualsiasi altro lavoro, tale lavoro
privato diventa sociale. Ecco la terza peculiarità della forma di equivalente: la
trasformazione del lavoro privato nel suo opposto, nel lavoro sociale.
È chiaro che la forma semplice di valore sia nella pratica che nella teoria trapassa in una
più completa e complessa definita forma di valore totale, che si esprime così: z merce A=
n merce B= v merce C = w merce D ecc. Il valore di ogni singola merce è espresso in
innumerevoli altri elementi del mondo delle merci. La merce A può essere equiparata non
solo alla tela ma a tutte le altre merci. Ci troviamo di fronte ad una catena di equazioni
infinita. Così, ci troviamo di fronte ad una serie incompleta. Se invertiamo ora la serie, si
ottiene la forma generale di valore: tutte le merci divengono equivalenti ad una sola merce,
la tela. Se le prime due forme di valore, quella semplice e quella totale esprimevano
entrambi il valore di una merce sia riferendosi ad una singola merce, sia in riferimento a
una serie di merci, ora la forma generale del valore esprime il mondo delle merci a cui è
comune il lavoro umano. Una merce diviene espressione generale di valore solo perché
361 Ibidem, pag. 67
362 Ibidem, pag. 69
136
tutte le merci simultaneamente esprimono il loro valore in essa. Nel nostro esempio
abbiamo messo la tela. Se ora al posto di questa mettiamo l’oro, abbiamo finalmente la
forma di denaro che si esprime nella equazione di tutte le merci nell’unica merce denaro,
l’oro. E’ questa la quarta forma, che si distingue dalla terza solo perché invece della tela, a
fare da equivalente generale c’è l’oro. Ma che cosa determina la necessità del passaggio
dallo scambio semplice di una merce con un’altra allo scambio mediato dal denaro? Tale
necessità viene dedotta immediatamente dall’impossibilità di risolvere la contraddizione
della forma semplice di valore, rimanendo nel suo ambito.
Già nella prima figura le determinazioni universali del valore coincidono immediatamente
con l’espressione delle particolarità della circolazione semplice delle merci, e ciò perché la
particolarità della circolazione semplice delle merci sta proprio nel fatto che essa è la prima
forma reale di manifestazione del valore in generale. Esaminando questo caso particolare
Marx scopre le determinazioni universali del valore. L’analisi dello scambio di una tela
con un abito dà come conclusione determinazioni non singolari, ma universali. Si vede
subito che questa elevazione del singolare nell’universale si differenzia radicalmente da
semplice atto di astrazione formale. “Qui non sono respinte come inessenziali le
particolarità dello scambio semplice delle merci che lo distinguono dal profitto, dalla
rendita e da altre forme di valore. Al contrario: l’analisi teorica di queste particolarità
conduce alla formazione del concetto universale. È questo il cammino dialettico in cui il
singolare viene innalzato a universale”363
. Così come nel movimento del mercato il denaro
sorge in qualità di mezzo naturale di soluzione delle contraddizioni dello scambio diretto
delle merci, allo stesso modo nel Capitale le determinazioni teoriche del denaro sono
elaborate come mezzo di soluzione delle contraddizioni nella determinazione del valore :
questo è un momento di passaggio dall’astratto al concreto.
Proprio il passaggio dalla considerazione del denaro da un punto di vista astratto alla forma
concreta riesce ad esprimere la natura storica concreta del denaro come fenomeno
particolare.
Dobbiamo adesso comprendere la trasformazione del denaro in capitale, per comprendere
dove si realizzi il plusvalore. È certo che lo scambio tra due merci differenti si basa su un
valore quantitativamente eguale. La legge del valore come espressione generale della
equazione tra lavoro e prodotti del lavoro, aveva trovato nello scambio una sua prima
storica concretizzazione fenomenica. Quella successiva riguarda uno scambio più
complesso che riguarda sia i capitali sia le merci di uno stesso ramo di industria. Questi
363 Evald Vasilevic Ilenkov, op. cit., pag. 39
137
due casi, per quanto riguarda il valore, vanno interpretati in una consequenzialità di cui il
primo è il prius logico del capitale. Esaminando astrattamente la merce, cioè prescindendo
da ogni altro fenomeno della produzione capitalistica, si esprime logicamente la sua forma
concreta di interdipendenza dal sistema dei rapporti di produzione. l’analisi puramente
astratta della merce e delle sue leggi immanenti manifesta in pari tempo la determinazione
teorica universale di tutto sistema in generale da cui esprime la legge universale concreta.
Marx ricava le determinazioni teoriche del valore dall’analisi concreta dello scambio
semplice delle merci, lasciando da parte tutti gli aspetti derivati e le categorie che li
esprimono. Questa è chiaramente un’astrazione realmente completa e ricca di contenuto,
non formale. Il valore è decodificato non come astrazione di elementi comuni ma come
realtà economica specifica, la cui scoperta esprime nel contenuto reale della forma di
valore non la semplice identità quantitativa astratta dei diversi lavori, come credeva
Ricardo, bensì l’identità degli stessi pensate nelle forme relativa e equivalente di
espressione del valore di ognuna delle merci messe sul mercato.
Ora, abbiamo visto che il denaro è la prima forma fenomenica del capitale, e la forma
immediata della circolazione delle merci è M-D-M, cioè merce trasformata in denaro per
essere ritrasformata in merce, vendere per acquistare. Ma accanto ad essa ne abbiamo una
seconda, D-M-D, cioè denaro trasformato in merce e ritrasformato in denaro, acquistare
per vedere. La differenza è molto notevole! Nel primo caso lo scambio serviva per
acquisire valori d’uso differenti; nel secondo si scambia per ottenere, tramite esso, una
differenza quantitativa. Dunque la formula vera è D-M-D’. ma come è possibile che
scambiando merci equivalenti si possa ricavare un plusvalore? dalla circolazione non
dovremmo avere nessun plusvalore. Siamo in una condizione paradossale, che Marx
esprime con un ottimo linguaggio hegeliano: “Il capitale non può dunque sorgere dalla
circolazione e altrettanto non può non sorgere dalla circolazione. Esso deve, allo stesso
tempo, sorgere e non sorgere in essa”364
. E la trasformazione del denaro in capitale deve
essere sviluppata analizzando le leggi dello scambio di merci equivalenti.
Che il plusvalore non possa scaturire dal denaro stesso è chiaro, dato che esso realizza il
prezzo della merce che compera. Dunque il cambiamento si deve verificare nella merce
comperata con il primo atto, D-M, ma non nel valore di essa, poiché vengono scambiati
sempre degli equivalenti. Quindi l’incremento va ricercato nel valore d’uso della merce. “
Il plusvalore stesso viene dedotto da uno <specifico> valore d’uso della forza-lavoro, che
364 Cfr. Meoc, op. cit., vol. XXXI, pag. 182
138
spetta esclusivamente ad essa”365
. Ci troviamo di fronte ad una merce speciale! Come ogni
merce essa ha un valore che è dato dal tempo di lavoro necessario alla sua produzione e
riproduzione: l’insieme dei mezzi di sussistenza necessari per la sopravvivenza del suo
possessore. Ora, se questa merce è pagata al suo valore, realizzando così la formalità dello
scambio degli equivalenti, il suo carattere speciale risiede nel suo valore d’uso, con la
quale, chi la possiede è in grado di produrre valori maggiori rispetto alla somma dei valori
delle merci necessarie alla produzione. Il valore di una merce è dato del tempo di lavoro
socialmente necessario per produrla. In una fabbrica il capitalista acquista il cotone al
prezzo di 10 scellini, i quali rappresentano dieci libbre di cotone. I mezzi di produzione
invece hanno un valore di 2 scellini. Per produrre un abito ci vogliono circa sei ore, e il
valore di queste ore equivale a 3 scellini per il possessore di forza-lavoro. Dunque il costo
per la realizzazione di un abito è di 15 scellini. A questo punto il valore del prodotto è
identico al valore del capitale anticipato: il denaro non si è trasformato in capitale. Ma il
capitalista aveva acquistato forza-lavoro per una giornata intera, e rientra nella formalità
dello scambio tra gli equivalenti far prolungare la giornata lavorativa oltre le sei ore.
Dunque il processo lavorativo viene prolungato: se in sei ore lavorative erano state filate
dieci libbre di cotone in dodici ne saranno filate venti, il cui valore sarà sempre pari a 15
scellini, ma con la differenza che i tre scellini pagati per la prima filatura valevano per
un’intera giornata lavorativa. Ecco dunque la trasformazione del denaro in capitale. Il
capitalista vendendo successivamente la merce al mercato, sottrae dalla circolazione tre
scellini in più di quanti ve ne aveva immessi. Questo processo dunque “ha luogo e non ha
luogo nella sfera della circolazione. Vi ha luogo grazie alla mediazione della circolazione,
perché ne è condizione la compera della forza-lavoro sul mercato delle merci. Non ha
luogo nella circolazione perché essa solo introduce il processo di valorizzazione che ha
luogo nella sfera della produzione”366
.
In questo stato embrionale il rapporto è ancora molto comprensibile L’unica difficoltà
consiste nello scoprire in che modo questa appropriazione di lavoro senza equivalente
derivi dalla legge dello scambio delle merci – dal fatto cioè che le merci si scambiano i
rapporto al tempo di lavoro in esse contenuto-, e in un primo momento non contraddica
questa legge, perché, come afferma lo stesso Marx “il processo di circolazione già
cancella, già offusca la connessione. Poiché la massa del plusvalore qui è determinata
365 Cfr. Karl Marx, Glosse, op. cit. pag. 177-8
366 Cfr. Meoc, Op. cit. , vol. XXXI, pag. 214
139
anche dal tempo di circolazione del capitale, sembra che s’introduca un elemento estraneo
al tempo di lavoro”367
.
Il processo di produzione del capitale ha un carattere duplice. Esso appare da una parte
come un processo di produzione semplice ossia come processo materiale della produzione
puro e semplice, quale è proprio di tutte le formazioni sociali costituendo una condizione
basilare per l’esistenza di una formazione sociale, e dall’altra come processo di
valorizzazione. Il processo di produzione è processo di produzione del capitale.
Nei Lineamenti Marx affermava che dal punto di vista del processo di produzione
semplice, il processo di produzione del capitale non differisce affatto da altre forme di
produzione. E’ invece il secondo aspetto ad essere discriminante del modo di produzione
capitalistico. Il lavoro individuale non appare direttamente come lavoro sociale. Diventa
sociale solo in quanto equivale a qualche altro lavoro, il che si verifica nello scambio, Così
il lavoro sociale, socialmente equivalente, e quantitativamente distribuito, ora svela un
nuovo carattere: quello di lavoro astratto e socialmente necessario. Il valore delle merci è
determinato in base al lavoro socialmente necessario, cioè alla quantità di lavoro astratto.
Ma se il valore è determinato dalla quantità di lavoro socialmente necessario per unità di
prodotto, questa quantità dipende a sua volta dalla produttività del lavoro. Questo dal punto
di vista quantitativo, cioè della grandezza del valore; ora bisogna passare al piano
qualitativo, cioè alla forma di valore. Non è il valore ad avere un ruolo di regolatore nella
distribuzione del lavoro, e non ogni tipo di distribuzione del lavoro sociale dà ai prodotti la
forma di valore. La distribuzione del lavoro è nel capitalismo non pianificata. I prodotti
hanno valore solo dove il prodotto è specificamente concepito per la vendita e per
l’acquisto, cioè quando questo prodotto è una merce. Non il lavoro preso in sé, ma solo il
lavoro organizzato in una certa forma sociale attribuisce valore ai prodotti. E questo vuol
dire chiaramente che il valore non è una proprietà dei prodotti, bensì una certa forma
sociale che lega i produttori privati ai rapporti sociali di produzione. Certo, lo stesso Marx
in Per la critica dell’economia politica aveva affermato che “ il modo e la forma specifici
in cui il lavoro che crea valore di scambio, e produce quindi merci, è lavoro sociale”368
, ma
“il lavoro che crea il valore di scambio è quindi un lavoro astrattamente generale”369
, cioè
lavoro umano in generale, “astrazione che esiste nel lavoro medio che ogni individuo
367 Cfr. Meoc, Op. cit., vol. XXXVI, pag. 517
368 Cfr. Karl Marx, Per la critica dell’economia politica, op. cit. , pag. 41
369 Ibidem, pag. 40
140
medio di una data società può assolvere. Esso […] è lavoro semplice”370
che varia esso
stesso “a seconda dei paesi e delle epoche culturali, ma appare come dato in una società
esistente”371
. E nel valore di scambio “il tempo di lavoro del singolo individuo appare
direttamente come tempo di lavoro generale, e questo carattere generale del lavoro isolato
appare come carattere sociale del lavoro stesso”372
, e questo lavoro “ è il tempo di lavoro
necessario, che ogni altro impiegherebbe a produrre la stessa merce”373
.
Siamo ritornati alla produzione. Se la formula generale del capitale è D-M-D’, il processo
che genera tale somma di valore più alta è la produzione capitalistica; il processo che la
realizza è la circolazione del capitale. Il capitalista produce della merce non per se stessa
né per il suo valore d’uso né allo scopo del consumo personale, ed è in grado di
trasformare in valore più alto il valore del capitale anticipato solo tramite lo scambio di
quest’ultimo con lo sfruttamento del lavoro vivo; non solo, egli è in grado di farlo poiché
“allo stesso tempo anticipa le premesse per l’attuazione di quel lavoro […] ossia solo in
quanto converte una somma di valore di sua proprietà nella forma di condizioni della
produzione; così anche, in genere, egli è capitalista e può accingersi a sfruttare il lavoro
unicamente in quanto, essendo proprietario delle condizioni di lavoro, si contrappone al
lavoratore quale semplice possessore della forza lavorativa”374
.
Il processo lavorativo non può essere indagato solo da un punto di vista astratto, separato
dalle sue forme storiche, come processo tra uomo e natura. Adesso il processo lavorativo
viene concretizzato, cioè visto come lavoro sociale, così come è sociale il suo prodotto. Per
questo non è più sufficiente che l’operaio produca in genere. Deve produrre plusvalore,
perché è questa l’unica condizione che rende un lavoro produttivo: quello che crea
plusvalore, che contribuisce all’autovalorizzazione del capitale. E’ facile immaginare,
dopo questa ricostruzione, il perché il capitale tenda ad abbassare sempre di più il tempo di
lavoro necessario alla riproduzione della forza lavoro, che è pagato tramite salario, e
aumentare i ritmi di produzione. Lo stesso Marx nel terzo libro lo dice chiaramente: “Lo
scopo di ridurre al minimo il prezzo di costo diviene l’incentivo più grande per l’aumento
della forza produttiva sociale del lavoro, che tuttavia si presenta qui unicamente come un
370 Idem
371 Ibidem, pag. 42
372 Ibidem, pag. 43
373 Idem
374 Cfr. Karl Marx, Il capitale, op. cit. , pag. 938
141
costante aumento della forza produttiva del capitale”375
. Quando egli ha analizzato la
merce, il denaro e la produzione mercantile, ha messo in risalto anche il carattere
mistificatore che stravolge i rapporti sociali, tramutando oggetti in merci e trasformando il
modo di produzione capitalistico in una oggettualità entificabile come il denaro. Simile
trasformazione è comune ad ogni altra forma sociale di produzione che abbia come
connotato una circolazione monetaria e una produzione mercantile. Ma nel modo di
produzione capitalistico “questo mondo misterioso e rovesciato si sviluppa ancor di
più”376
. Il capitale finisce per trasformarsi in qualcosa di affatto misterioso “dato che tutte
le forze produttive del lavoro sembra siano sorte da lui stesso, come forze che concernono
proprio il capitale e non il lavoro in quanto tale” 377
.
Il capitale tende dunque a ridurre il tempo di lavoro socialmente necessario alla
riproduzione della forza lavoro. Di più, per incrementare la produzione, stravolge e
rivoluziona, migliorandoli, i mezzi di produzione e le tecniche. Questa è una
considerazione molto importante, che ci permette di andare oltre una visione non proprio
corretta dell’analisi del valore di Marx, perché è vero che dalla lettura del primo libro può
sembrare che il valore della merce è dato dalla quantità di lavoro oggettivata. Ma egli nel
terzo precisa che “il capitale complessivo, ossia tanto i mezzi di lavoro e le materie di
produzione quanto lo stesso lavoro […] entra materialmente nel reale processo lavorativo
anche se solo una sua porzione entra nel processo di valorizzazione. Senz’altro proprio qui
sta il motivo per cui esso contribuisce solo in parte alla costituzione del prezzo di costo e
totalmente invece alla costituzione del plusvalore. In ogni caso sta per certo che il
plusvalore proviene allo stesso tempo da tutte le parti del capitale impegnato”378
. E questo
a discapito dei sostenitori della teoria del valore-lavoro. Ma non solo. Anche Proudhon e
gli economisti volgari non avevano compreso esattamente a cosa corrispondesse la natura
del valore, poiché credevano che le merci fossero vendute al loro valore se vendute al loro
prezzo di costo, cioè al prezzo dei mezzi di produzione utilizzati nella produzione e salario.
Finivano così per non capire che un elemento altrettanto importante al lavoro non pagato è
il lavoro retribuito. Dunque essi non sapevano a cosa corrispondesse il salario379
.
375 Ibidem, pag. 1507
376 Ibidem, pag. 1472
377 Idem
378 Ibidem, pag. 935
379 Cfr. Meoc, Op. cit., pag. 623
142
Purtroppo non possiamo approfondire ulteriormente la questione, ma nel III libro anche le
differenze nella composizione organica dei vari capitali perdono ogni valore rispetto al
saggio di profitto, cioè il saggio del plusvalore calcolato in rapporto del capitale
complessivo, da non confondere con il saggio di plusvalore che è calcolato in rapporto al
capitale variabile380
. La concorrenza ha questa funzione unificante. Se infatti nel primo e
nel secondo libro i capitali individuali avevano leggi proprie, nel terzo libro assistiamo ad
un rovesciamento, in quanto, in un sistema capitalistico non sviluppato le merci si
scambiano al loro valore, ma in un sistema sviluppato, non conta più la composizione
organica del capitale singolo, cioè la sua individualità astratta: il capitale conta nel suo
complesso, come se fosse un unico capitale che produce, dal quale le singole frazioni del
capitale sono distinguibili solo sulla base delle loro grandezze. La circolazione del capitale
individuale è insufficiente, in questo senso astratta, nei confronti del capitale sociale
complessivo. Il saggio di profitto è rappresentabile tramite questa formula: pv/C = pv /c +
v’ e si distingue dal saggio del plusvalore rappresentabile tramite la formula pv/v. Nel
saggio di profitto manca allora il capitale costante, indicato come c , ed esso quindi è
calcolato solo in rapporto al capitale variabile, mentre nel saggio di profitto viene
considerato tutto il capitale anticipato, in quanto C= c + v.
Esso può rimanere immutato e allo stesso tempo esprimere saggi differenti del plusvalore.
D’altra parte, ciò che interessa il singolo capitalista è il rapporto del plusvalore. E come
afferma perentoriamente il pensatore tedesco: “l’esatto rapporto invece di questa eccedenza
e le sue intrinseche connessioni con i particolari elementi costitutivi del capitale non solo
non gli stanno a cuore, ma anzi è suo interesse confondere le idee a tale riguardo, ricoprire
di un velo questi rapporti”381
. Il saggio generale del profitto è dato dal rapporto tra
plusvalore totale e capitale totale anticipato. Stabilito il saggio, ne possiamo ricavare il
profitto che spetta al capitalista, e se sommiamo questo profitto al prezzo di costo
otteniamo il prezzo di produzione della merce. Naturalmente questi prezzi di produzione
nei vari rami della divisione sociale del lavoro potranno essere uguali, maggiori o inferiori
ai valori delle merci. Ma le oscillazioni dal loro valore finiranno per compensarsi nel
totale. Da un lato è vero che i prezzi non corrispondono ai valori e che il profitto di chi
detiene il capitale è diverso dal plusvalore ricavato dallo sfruttamento della forza-lavoro;
ma dall’altro lato il profitto totale è uguale al plusvalore totale e prezzi totali sono
380 Esse sono due misure differenti della medesima grandezza. Data la diversità dei termini posti in relazione,
tali due misure indicano rapporti o relazioni differenti della medesima grandezza.
381 Cfr. Karl Marx, Il capitale, op. cit. , pag. 939
143
equivalenti ai valori totali. Così è ancora possibile non perdersi nel gioco delle parvenze
che celano il plusvalore dietro il profitto e del valore dietro al prezzo. Ma questo discorso
ci fa comprendere che la legge del valore è in contraddizione diretta con la legge del saggio
del profitto medio, e ciò vuol dire che tra legge generale e il suo darsi empirico vi è una
contraddizione. E ciò non può che destare scandalo, poiché una legge universale logica
dovrebbe essere veritiera se e solo se la sua applicazione è estesa all’intero ambito
dell’empirico. E’ una cosa che Marx aveva già colto. E lo studio del campo economico
mostra chiaramente di cozzare contro tutto questo. Non è ipotizzabile che i reali,
quotidiani rapporti di scambio e le quantità di valore siano “immediatamente identici. Il
senso della società borghese consiste appunto in questo, che a priori non ha luogo nessun
cosciente disciplinamento sociale della produzione. Ciò che è razionale e necessario per la
sua stessa natura, si impone soltanto come una media che agisce ciecamente”382
.
Ma c’è ancora qualcosa da dire intorno plusvalore, che non abbiamo analizzato e che ora ci
sarà molto utile per mostrare sotto un altro rispetto un importante ruolo ricavato dal cambio
di paradigma della filosofia marxiana. Molto interessante da notare è che il capitale non
migliora solo i mezzi di produzione e le tecniche, ma tende a migliorare anche la qualità
della forza lavorativa da impiegare, e questo rovescia un altro mito del marxismo
novecentesco: quello della predominanza delle forze produttive sui rapporti di produzione.
382 Cfr. Meoc, Op cit., vol. XLIII, pag. 598
144
CAPITOLO QUARTO
I GRADI DELLA STORIA : TELEOLOGIA E MITO DEL
SOGGETTO
I La storia orientata
E’ innegabile che gli epigoni “idealisti” di Marx, così come gli avversari, abbiano
sottovalutato e declassato il poderoso intento espresso nel Capitale definendola come una
ricerca che muove da intenti utopici e che risponda a presupposti extrascientifici383
. Ci si
potrebbe stupire del fatto che anche i cosiddetti epigoni ed interpreti “marxisti” abbiano
condiviso queste affermazioni, a loro modo di vedere con altri intenti, ma comunque
sempre finendo per svilire le ricerche del Capitale, anche quando nelle loro opere ne
presentavano ampi stralci e citazioni divenute poi celebri. Perché il ridurre le ricerche
383 Se è vero che ogni metodologia utilizzata nelle scienze non è mai neutrale, nemmeno i canoni
interpretativi si sottraggono a questo schema. Essi, almeno nel caso del marxismo, spesso rispondono ad
interessi di carattere strettamente politico
145
economiche a ricerche mosse e orientate dall’utopica fine della storia è in qualche modo
uno svilire i risultati di una indagine nel campo dell’economia politica. Gli appunti
giovanili del ’44, insieme a qualche articoletto giornalistico dell’adolescenza, qualche
lettera, a mio modesto parere, melensa e flautata scritta a Ruge: ecco le ancore con le quali
si è cercato e si cerca ancora oggi di trattenere lo sviluppo della teoria marxista. Poca roba
a ben vedere! Eppure in questa operazione di rendere Marx irriconoscibile, o forse sarebbe
meglio dire il più riconoscibile possibile entro categorie che non erano più le sue, si sono
comprese anche le pagine dell’ Ideologia tedesca, rendendo le ricerche e le critiche nella
prima sezione, quella dedicata a Feuerbach, delle grandi e innocenti narrazioni storiche384
.
A tal proposito, nelle pagine dell’ Ideologia tedesca, Engels e Marx sarebbero stati di una
chiarezza disarmante: E’ la divisione del lavoro all’interno di una nazione che porta alla
strutturazione di un determinato gruppo sociale385
, e i diversi stadi di sviluppo della
divisione del lavoro sono “altrettante forme diverse della proprietà”386
.
Da questo elemento potremmo tracciare una linea retta che procede per gradi e inglobare le
diverse fasi storiche di forme di proprietà. Il primo corrisponde a quello della proprietà
tribale, nel quale ancora non è sviluppata una vera e propria produzione, e la divisione
sociale non è che “prolungamento della divisione naturale del lavoro nella famiglia”387
. La
schiavitù in essa latente si svilupperebbe con il crescere della popolazione e dei bisogni. La
seconda forma è la proprietà della comunità antica e dello Stato, che ha origine dall’unione
di più tribù in una città. In essa nasce, affianco a quella comune, la proprietà privata. Si
presentano già qui le contraddizioni che caratterizzeranno anche i successivi modi di
produzione: città e campagne, industria e commercio ecc. La terza forma è la proprietà
feudale, a cui segue l’affermazione del modo di produzione capitalistico. Alle quattro fasi
384
Prima di Marx, già Kant aveva avvertito il rischio, quando si formulava una storia dal punto di vista di
una finalità, di tramutare la ricostruzione filosofica in un romanzo. La filosofia non è in nessun modo una
forma di narrativa. Cfr. Immanuel Kant, Idea per una storia universale dal punto di vista cosmopolitico, in
Scritti di storia, politica e diritto, Laterza, Roma-Bari, 2009, pag. 41. E lo stesso Engels dichiara la
pericolosità di simili approcci: “ Il metodo materialistico si rovescia nel suo contrario se non viene
considerato come il filo conduttore di uno studio storico, ma come schema fisso sul quale ritagliare pari pari i
fatti storici. […]. Il contadino norvegese non è stato mai servo della gleba, e ciò dà allo sviluppo un tutt’altro
sfondo, analogamente a quanto avviene in Castiglia” Cfr. Meoc, Op. cit. , vol. XLVIII pag. 439
385 Cfr. Meoc, op. cit., pag. 18
386 Idem
387 Idem
146
della storia Marx nei Grundrisse aggiungerà il modo di produzione asiatico388
. In
definitiva, la storia finora esistente sarebbe consistita di 5 tappe tra loro successive. Chi è
l’artefice del passaggio da una tappa all’altra? Molti dei suoi interpetri si sono affidati
direttamente alle parole di Marx. Il filosofo di Treviri, infatti, nella prefazione a Per la
critica dell’economia aveva affermato: “ Ad un certo grado del loro sviluppo le forze
produttive materiali della società entrano in contraddizione con i rapporti di produzione
esistenti, o, per usare un termine giuridico, con i rapporti di proprietà nel cui ambito si
erano mosse fino a quel momento. Da che erano forme di sviluppo delle forze produttive
questi rapporti si tramutano in vincoli che frenano tali forze. Si arriva quindi ad un’epoca
di rivoluzione sociale”389
. La storia umana allora sarebbe scandita dalla dialettica tra le
forze produttive e i rapporti di produzione. E, a ben vedere, col mutare delle condizioni
delle prime, devono di conseguenza mutare le seconde.
Di più, le stesse condizioni delle forze produttive sarebbero l’elemento realmente
predominante in ogni società, la quale senza di esse non sarebbe né esistente né
comprensibile. E’ questo insieme di attitudini psico-fisiche, prese sotto il loro aspetto
astratto che consentirebbe al filosofo critico di tastare il polso dell’epoca in cui vive. Sono
facilmente deducibili le motivazioni che avrebbero spinto Marx a porre al centro del suo
pensiero le forze produttive: esse sono, per dirla col linguaggio proprio della filosofia
tedesca, il soggetto. Ma di che cosa? Dello sviluppo del tutto in cui esse sono calate. O
meglio, esse sono il dinamico atto di accumulazione e trasformazione del loro stesso
prodotto: i rapporti sociali di produzione. Per questo, nel momento in cui questo loro
prodotto non corrisponde più alla effettualità attiva del loro incessante sviluppo, le forze
produttive si autoimpongono il superamento di ciò che è posto, instaurando così un nuovo
modo di produzione. Uno degli apologeti di questo Marx hegeliano, Bloch, che vedeva in
Marx “il novum di Hegel”390
, volava su queste e altre pagine, vedendovi il grande
“rovesciamento di Hegel in Marx: una rettifica della processione degli spiriti nel processo
terreno, dei contenuti fissi del ricordo interiorizzato nell’inesaurito fondo della materia
dialettica. In tal modo, è la logica della realtà stessa il motivo per cui nel marxismo
continua a sussistere all’ordine del giorno tanta parte del linguaggio filosofico di allora
(come estraneazione, alienazione, rovesciamento della quantità nella qualità ecc)”391
. Ma,
388 Il termine di modo di produzione era già utilizzato nella Sacra Famiglia. Cfr. Meoc, Op. cit. , pag.167
389 Cfr. Karl Marx, Op. cit. , pag. 31
390 Cfr. Ernst Bloch, Soggetto- oggetto, op. cit. , pag. 429
391 Ibidem, pag. 428
147
come mostreremo, le cose stanno in un modo del tutto differente. Nel Diciotto Brumaio di
Luigi Bonaparte Marx dichiara che “gli uomini fanno la propria storia, ma non la fanno in
modo arbitrario, in circostanze scelte da loro stessi, bensì nelle circostanze che essi trovano
immediatamente davanti a sé, determinate dai fatti e dalle tradizioni”392
.
Dobbiamo quindi ricostruire alcuni paradigmi dell’interpretazione dominante del
marxismo
D’altra parte, chi ha insistito sulla linea continuistica non può che porsi immediatamente
un problema, tralasciando la vera questione, che gli è proibita, pena il crollo: chi è il
soggetto che muove le trame della storia? E quale il suo scopo?
Bisogna tenere ben impresse nella mente queste due domande. Nel modo in cui sono
formulate, esse già svelano una modalità ben precisa di pensare questa problematica
nell’unica maniera in grado di mantenerla nel quadro più ampio della prospettiva
futurocentrica. Inoltre, solo così risulta davvero semplice l’equiparazione di Marx a Hegel.
Infatti, se per quest’ultimo il passaggio da una epoca storica all’altra era concepita come
l’avanzamento dello spirito del mondo, Marx, in virtù del sedicente rovesciamento, può
mondanizzare il passaggio senza ricorrere a nulla che esuli dall’immanenza storica
materiale. La semplicità dell’equiparazione si riflette anche da una acritica decodifica delle
frasi dello stesso pensatore. Ad esempio, per spiegare le modalità tramite le quali un modo
di produzione si avviasse al tramonto, si è spesso riportato un capoverso di Marx tanto
lucente quanto problematico: “Una formazione sociale non scompare mai finché non si
siano sviluppate tutte le forze produttive che essa è capace di creare, così come non si
arriva mai a nuovi e più evoluti rapporti di produzione prima che le loro condizioni
materiali di esistenza si siano schiuse nel grembo stesso della vecchia società. Perciò
l’umanità si pone sempre e soltanto quei problemi che essa è in grano di risolvere”393
. Che
cosa voglia dire questa frase, a pensarci bene, è tutto fuorché chiaro. Ed è per questo che le
due domande su cui la linea continuistica poggia la sua analisi rasentano la sterilità
pressocchè radicale, poiché è la stessa risposta che si vuole legittimare a far da radice
all’impianto, così da tramutare l’intero e fecondo progetto marxengelsiano ad una mera
esposizione di fasi storiche nei termini di estinzione ed alba. Di più, la conoscenza del
metodo dialettico potrà rendere intelligibili le future linee di tendenza dell’ambito al quale
viene applicato. Per questo “la dialettica materialistica è una dialettica rivoluzionaria”394
. E
392 Cfr. Meoc, Diciotto Brumaio di Luigi Bonaparte, op. cit. , vol. XI, pag. 107
393 Cfr. Karl Marx, Per la critica dell’economia politica, op. cit. , pag. 32
394 Cfr. Gyorgy Lukacs, Storia e coscienza di classe, op. cit. , pag. 2
148
la dialettica ha nella propria metodologia d’indagine dei punti cardine specifici. Anzi essa
stessa è il risultato di questo metodo, in cui la contraddizione adempie il ruolo di
animazione di ogni processo. Marx afferma che la storia intera è storia della lotta delle
classi, nella quale i detentori dei mezzi di produzione di una data epoca sono posti in
aperto contrasto con i liberi produttori. Ci sarebbe dunque un primato ben preciso delle
classi sulla lotta stessa. Non la lotta in prima istanza, bensì le classi. Dunque delle
categorie opposte ed irrelate la cui lotta è il metronomo dell’evoluzione storica. La storia
avanzerebbe tutta in questo modo, mediante la contraddizione che è il principio del
conflitto, meglio ne è l’essenza. La contraddizione in fondo è ciò che fa avanzare la storia,
ciò che anima lo scontro tra gli opposti. Ogni contraddizione conterrebbe in sé il principio
del suo superamento. Non solo, essa sarebbe sin dall’inizio orientata ad una
ricomposizione dei termini contrari. Tramite la negazione della negazione, lo sviluppo
storico procederebbe così verso forme via via più complesse e determinate. E se ad ogni
determinazione corrisponde una negazione, allora alla determinazione più netta e decisiva,
quella a cui corrisponde la più ampia lacerazione reale, sarà correlato il massimo grado di
possibilità di ricomposizione. E’ la negazione che fa avanzare la Storia. Essa porta avanti il
lato cattivo, quello della classe negata che a sua volta negherà la sua essenza negata
dall’altro polo, cioè quell’opposta polarità che si afferma e si è affermata a sua volta
negando ciò che l’aveva negata. Ma ogni atto stesso di negazione della propria negazione
avverrebbe tramite un lavoro di ricomposizione di ciò che fu lacerato. Il termine ultimo di
questo processo contraddittorio e negativo, dettato dalla stessa impostazione delle classi
sulla loro lotta, è la fine della storia.
Si apre così un doppio livello di analisi. Un livello doppio che è comunque uno, o meglio il
suo essere doppio è riconducibile al tentativo di riuscire a fondare su una base nuova,
quella dei rapporti di sfruttamento, una visione ereditata da una precisa cultura.
Se da un lato ciò dimostra immediatamente che il metodo dialettico non è un semplice
accessorio della teoria, dall’altra parte, secondo diversi autori, essa svelerebbe quella
grande intenzione fondamentale che condurrebbe Marx a fondare la nuova scienza: il
processo storico. E questa sua fondazione epistemologica nasce da un sostrato filosofico. Il
concetto di modo di produzione è da Marx pensato come una nozione scientifica, ma “ciò
non toglie che poi egli ponga i vari modi di produzione, storicamente determinati, in una
successione dinamica, progressiva e teleologica,sostenendo apertamente”395
che la storia
395 Cfr. Diego Fusaro, Bentornato Marx, rinascita di un pensiero rivoluzionario, Bompiani, Milano 2009,
pag. 112
149
dello sviluppo degli stessi modi di produzione altro non sono che “atto reale di generazione
del comunismo”396
.
Il passaggio da un modo di produzione all’altro mantiene un carattere di necessità
ineluttabile, tramite l’acutizzazione delle contraddizioni, intesa quasi come una saturazione
della potenza della contraddizione principale, a un dover-essere, che richiama alla
formulazione espressa nella Scienza della logica: “Il dover-essere è quello che, in un
ulteriore sviluppo […] si presenta dietro a quella impossibilità come il progresso
all’infinito”397
.
Se Hegel ha traslato nella storia l’essere prius del concetto, ha dedotto così facendo da
questo la storia empirica. Sorge il problema di come Marx arriverebbe a ribaltare questa
visione: perché guarda all’empirico come il prius di ogni reale e ne deduce un nuovo
impianto di ri-costruzione logica della storia? Ma il modo di porre la domanda in questi
termini, se da un lato potrebbe spianarci la strada per la comprensione di alcuni punti
discordanti con Hegel, dall’altro lascerebbe la nostra analisi ingabbiata in un terreno che in
verità non è quello su cui si staglia la problematica fondamentale di Marx. Si rimarrebbe
ancora in un terreno in cui il mero ribaltamento apre e rende comprensibile ciò che prima
era mistificato dall’inversione. Ma qui non siamo più nel sentiero dell’inversione. Il
problema è qui chiaramente logico.
Già nella Sacra famiglia Marx aveva illustrato le difficoltà del procedimento hegeliano. Di
fronte alla molteplicità di singoli oggetti particolari, Hegel ricava da questi un genere,
un’essenza comune che nella sua rappresentazione non conserva le differenze che
distinguevano i variegati oggetti. Questa essenza è dunque astratta, cioè separata, depurata
dai predicati discriminanti. Questa essenza astratta diviene così una sostanza che fonda i
singoli particolari. Ma se dobbiamo mostrare come l’astratto è il fondamento effettivo
degli enti reali, allora dobbiamo mostrare anche il cammino opposto a quello descritto
sopra. Ma come si passa dall’astratto al singolo? Per Marx, Hegel rimane incapace di
spiegarlo, o meglio la spiegazione è viziata dalla forma d’impostazione.
E’ chiaro che il grande limite di Hegel lo conduce ad un fraintendimento del ruolo
dell’astrazione per la teoria. Il genere diventa soggetto, e gli individui, insieme alle loro
determinazioni, predicati di tale soggetto. Ecco perché nel suo sistema la realtà si rovescia.
Ma se Marx fosse rimasto un semplice hegeliano, di certo sarebbe stato sufficiente - per
lui, non per la filosofia né per il reale - riformare la filosofia speculativa nei termini
396 Cfr. Meoc, Op. cit. , vol. III, pag. 111
397 Cfr. Hegel, Op. cit. , pag. 133; Cfr. I paragrafi 93-94 dell’ Enciclopedia.
150
proposti da Feuerbach, il quale sosteneva che “non si deve che fare del predicato il
soggetto e, in quanto soggetto, trattarlo come oggetto e principio -, basta, insomma,
rovesciare la filosofia speculativa per avere la verità senza veli, pura e schietta”398
. Anche
nel rispetto del susseguirsi dei modi di produzione, l’individuazione corretta del soggetto
sarebbe stata un'altra condizione magari non autosufficiente ma comunque necessaria per
far avanzare la storia, da sempre orientata teleologicamente.
Il tramonto della storia, che diventa alla luce della fine, una vera e propria preistoria
rispetto a questa è una sorta di apocatastasi, un atto di ricomposizione totale dell’uomo con
sé, con la comunità e la natura. Una idea di comunismo, molto forte in Bloch e anche in
Lukacs, che a tratti sembra richiamare ancora una volta una nozione hegeliana, quella della
vera infinità, immaginata come circolo:
“ Solo ai due limiti di questa l’infinito è e continua sempre ad essere, là dove la linea, che è
esserci, non è, mentre poi la linea stessa esce in questo suo non esserci, vale a dire
nell’indeterminato. Come vera infinità, ripiegata in sé, la sua immagine diventa il circolo,
la linea che ha raggiunto se stessa, che è chiusa e interamente presente, senza punto iniziale
né fine”399
. Quasi a dire che in fondo l’idea del comunismo come fine della storia è quasi
un’immagine di rifiuto di un cattivo infinito storico, che ricorda l’incedere nel cammino
della verità presentato nella Scienza della logica, dove è detto senza mezzi termini che
l’unico metodo per ottenere progresso scientifico si basa sulla corretta concezione del ruolo
del negativo, e che questa conoscenza scientifica è da pensarsi come “sistema dei concetti”
che ha “un andamento irresistibile, puro, senz’accogliere nulla dal di fuori”400
.
Avevamo visto precedentemente le due domande chiave di questa concezione. La prima, in
una secondaria e a tratti parziale riformulazione, potrebbe suonare anche così: donde lo
sviluppo?
Sappiamo che Hegel considera una serie di fatti sempre legati in una relazione causale.
Così facendo però inverte l’ordine della relazione. Questa successione è una successione
logica che porta all’assurdo: è il figlio che genera la madre, lo spirito che genera la natura,
il risultato genera il cominciamento401
. Marx qui critica apertamente la visione teleologica
di Hegel e dei giovani hegeliani: “Come, per i vecchi teleologi, le piante esistono per
essere mangiate dagli animali, e gli animali per essere mangiati dagli uomini, così la storia
398
Ludwig Feuerbach, Tesi preliminari per la riforma della filosofia, op. cit. , p. 178. 399 Cfr. Hegel, Scienza della logica , op. cit. , pag. 153
400 Ibidem, pag. 36
401 Cfr. Meoc, Op. cit. , vol. V, pag. 135
151
esiste per servire all’atto di consumo del mangiare teorico, cioè del dimostrare. L’uomo
esiste perché esiste la storia; la storia esiste perché esiste la dimostrazione della verità” 402
.
Se applicato alla storia, il risultato finale del processo sembra presupposto integralmente
nel processo stesso. Così la fine fonda l’inizio e guida concettualmente le tappe intermedie.
Nelle forme iniziale ed intermedie il risultato finale può esser colto già come presente, ma
naturalmente non già come risultato esplicato. E questo in quanto lo stesso porre in essere
il processo è attualizzato e dominato via via dal risultato. Le stesse forme passate hanno il
compito di realizzare l’ultima delle forme. D’altronde è questa l’impostazione logica
seguita dalla sinistra hegeliana. Max Stirner, ad esempio, affermava apertamente che il
compito degli ebrei altro non era che quello di farsi trasformare dai cristiani. I predecessori
dunque muovono il loro stesso sviluppo verso il compimento del loro compito: quello di
farsi superare dai successori403
. Qui Marx non si chiede direttamente se questo compito
possa essere rigorosamente corretto dal punto di vista logico. Porre questa domanda
riporterebbe Marx sullo stesso terreno percorso due anni prima della stesura dell’ Ideologia
tedesca. Qui è in gioco la validità della traslitterazione dell’impianto teleologico in un altro
campo, quello storico-economico. La teleologia implica un certa modalità di
configurazione di un percorso costruito e nel contempo da costruire. Ma la modalità della
costruzione non coincide certo con la scelta tra logiche differenti, che riporterebbe a sua
volta ad una modalità teoretica qui esplicitamente rifiutata, quella dell’idealismo appunto,
che parte dal pensiero per arrivare alla realtà. Eppure, seguendo questo procedimento, posti
di fronte alla storia dell’economia, ne scopriamo il non senso, o forse meglio l’assurdo.
Infatti, procedendo anche noi in una “costruzione à la san Max” ne ricaviamo che “ la
grande proprietà fondiaria moderna derivata dal sistema parcellare”, proclamatrice di fatto
del maggiorasco, ha attuato “ < […] l’ultima conseguenza> del parcellamento della
proprietà fondiaria, <e che sin dall’origine> il parcellamento <non si è proposto altro
compito che di attuare>, il maggiorasco, il vero maggiorasco. <Da ciò proviene quindi
l’illusione che> il maggiorasco <assegni un valore infinito> al pari diritto dei membri della
famiglia, <come per esempio appare> nel diritto ereditario del Code Napolèon”404
.
Ecco dunque mostrato il limite di una simile impostazione in un nuovo campo, quello
dell’economia. Sul terreno speculativo, e sotto il dominio di una cappa ideologica che
deforma il reale, sarebbe stato ancora possibile interpetrare la storia nel modo che ora
402 Cfr. Meoc, Op. cit. , vol. IV, pag. 87
403 Cfr. Meoc, Op. cit. , vol. V, pag. 135
404 Ibidem, pag. 136
152
Marx rigetta, poiché, tramite i dispositivi speculativi “è infinitamente facile dare alla storia
orientamenti unici, non facendo altro che descrivere il suo ultimissimo risultato come il
<compito> che essa <in verità si è proposta sin dall’origine>. Per questa via le epoche
passate assumono un aspetto bizzarro e mai esistito. […]. Per esempio, si dice che il vero
<compito> che <si era proposto fin dall’origine> l’istituzione della proprietà fondiaria è
stato di soppiantare gli uomini con le pecore, effetto che recentemente si è verificato in
Scozia, ecc” 405
.
Ecco dunque che la teleologia si scopre come una categoria logica applicata ad un ambito
in cui essa non è applicabile, che tramuta il corso degli eventi in una “storia di
fantasmi”406
.
Si è parlato poc’anzi di orientamenti unici. Per darsi un unico orientamento, è necessario
aver fissato e legittimato un punto-luce da cui la stessa storia riverbera.
Hegel lo aveva individuato, nelle Lezioni di filosofia della storia, nello spirito, affermando
apertamente che la storia non è semplicemente una coincidenza del processo dello spirito,
ma è questa stessa storia dello spirito, che evolve tramite un sottile gioco di astuzie
innescato dalla ragione407
. Posto lo spirito come fondamento, diviene effettivamente
semplice ritrovare dappertutto lo spirito stesso nella storia, ordinandola e modellandola su
questo spirito408
e sulla sua esplicazione. Marx contesta apertamente questo modo di
pensare la storia non perché lo spirito è inesistente nella storia stessa, bensì perché non v’è
nessun disegno che la tratteggi e la orienti, e qui siamo in punto di radicalità ben più
profonda di una mera critica dello spirito in generale che richiamerebbe posizioni, già
percorse in filosofia, di negazione irrefutabile dell’esistenza di Dio o di qualsivoglia ente
trascendente; la storia ha un carattere estremamente complesso che non può essere
ingabbiato e dedotto a partire da un principio.
Ora, abbiamo fatto vari accenni ad un nuovo campo, ad una problematica che da questo
campo sorge. A tratti ci è sembrato che questo cambio fosse davvero il passaggio decisivo
per comprendere i termini della rottura. Meglio, che la rottura, termine forse non del tutto
aderente allo sviluppo intellettuale di Marx, fosse la conseguenza di questo cambio di
terreno, seguita da un avvicendamento di metodo di lavoro, perché l’altro, quello mutuato
405 Idem
406 Ibidem, pag. 118
407 Cfr. Georg W. F. Hegel, Lezioni sulla filosofia della storia, op. cit. , pag. 27
408 Cfr. Meoc, Op. cit. , pag. 160-1
153
da Hegel e da Feuerbach, era risultato inefficace. I Manoscritti, e i risultati lì raccolti ne
sono la resoluta testimonianza.
Viene davvero da chiedersi il perché di questi testi giovanili, del perché essi siano stati
visti come una fonte inesauribile di ricchezza, come l’abito di rivelazione dei reali intenti
di Marx, una chiave d’accesso ai suoi lavori della maturità. Ciò che sembrava
incomprensibile, il carattere di imperscrutabilità de Il Capitale e del tema fondamentale in
esso affrontato, è stato reso intelligibile tramite un dispositivo analitico che scompone
l’oggetto tematizzato in segmenti che poggiano su di un nucleo centrale che su questi si
riflette. Il tema centrale è stato individuato più volte nell’uomo e nelle sue relazioni
storiche. Ma la comprensione della complessa storia dell’uomo esplicava di necessità una
categoria metastorica ereditata da una cultura, o meglio da una tradizione culturale. In essa
allora si è trovato il criterio primo per dedurne il lavoro specifico dell’autore. Solo se
inserito in una tradizione culturale, in questo caso di matrice squisitamente filosofica,
potevamo comprendere alcuni capitoli come quelli sulla merce, sull’accumulazione
originaria, sulla caduta tendenziale del saggio di profitto; solo mutuando dalla visione
filosofica hegeliana le categorie di lavoro, alienazione, uomo, storia ecc ecc. potevamo
comprendere il giovane Marx. E che solo nel comprendere i lavori di questo giovane
filosofo, ossessionato ed ossessionante critico dei suoi contemporanei neohegeliani,
potevamo arrivare a carpire la sostanza dei volumi del Capitale che iniziano proprio col
tema dell’apparenza, del manifestarsi, per così dire, illusorio del mondo delle merci. Solo
dimostrando l’unità del percorso intellettuale del filosofo di Treviri se ne poteva ribadire la
genialità e insieme la validità epistemologica. Un’ epistemologia che però finiva per esser
considerata come una sorta di abito dimostrativo di un pensiero teleologico di matrice
filosofica. Ci si è illusi che la sola via per difendere la grande scoperta di Marx passasse
non tanto nello studio e nella esplicitazione ulteriore di questa scoperta, bensì nel tentativo
primario di difesa del suo itinerario speculativo. Non che lo studio dell’itinerario percorso
sia pernicioso ed invalidante. Questo atteggiamento sarebbe antiscientifico. Ma il fare i
conti con un itinerario non vuol dire certo negare o peggio occultare le rotture causate da
un cambio radicale delle domande fondamentali nell’indagare. Posti di fronte al problema
dell’unità, i filosofi, attingendo ad una modalità di pensiero che vede nell’unità l’unico
sistema del filosofare, hanno concentrato i loro sforzi a difesa di una unità presupposta
come carattere garante ineludibile di un pensare che non cade in contraddizione con se
stesso. E questo ci svela anche un modo di intendere la filosofia . Posti di fronte alla
difficile questione dell’oggetto specifico della filosofia rispetto alle scienze, l’unica
154
risposta possibile da parte di chi pratica la filosofia nel sentiero tracciato da Platone ed
Aristotele, e ribadito dalla Topica della Critica della ragion pura kantiana e
dall’Heidegger di Essere e Tempo, è stata quella di ribadire che nella scienza particolare
della economia politica Marx avesse tradotto e trasportato i risultati di una indagine
filosofica, la disciplina delle discipline, ricavati da una metodologia di lettura dei fatti della
storia dell’uomo calati all’interno di una cornice che metteva in risalto il movimento
contraddittorio della stessa storia dell’uomo. I risultati filosofici della gioventù vennero
quindi pensati come lo strumento con il quale accostare ad una scienza particolare, quella
dell’economia politica appunto, e ri-definirne l’ambito e l’oggetto specifico. Ma davvero
Marx ha travasato questi risultati dentro l’otre dell’economia politica? Davvero possiamo
accontentarci di pensare la contraddizione principale della storia tramite una pre-
comprensione in chiave metastorica della contraddizione? Così facendo il lavoro di Marx
sul tema del Capitale sarebbe traducibile in uno sforzo di applicazione di una concezione
filosofica su di un contenuto scientifico dedotto a partire da ciò che scientifico non è.
Infine, possiamo dirci ancora davvero così certi dell’impianto teleologico di una filosofia
della storia sviluppata da Marx? Che cosa legittima questo modo di pensare al lavoro di
Marx nei termini di un percorso unitario? Non si svela qui il grande limite di un certo
modo di fare filosofia che andrebbe invece ridiscusso, e proprio a partire dalle pagine del
Capitale? Perché se l’unica lente in grado di farci leggere oggi come ieri le dense pagine di
questa sterminata e incompleta opera sono i manoscritti economico-filosofici e gli altri testi
giovanili di Marx, questo non denota un problema immediato per comprendere Marx, ma
un problema che riguarda un certo modo, per molto dominante, di fare filosofia. E’
innegabile e sicuramente sintomatico il fatto che si siano privilegiati studi su opere
giovanili di cui lo stesso Marx non possedeva nemmeno una copia nella sua vasta
biblioteca409
a discapito di analisi approfondite del Capitale, ed ai problemi che esso pone,
al di là della legittimità della soluzione posta.
Dobbiamo indagare meglio la questione e tornare agli Estratti su Mills e ai Manoscritti
del’44, cioè a quell’insieme di appunti che sono fortemente influenzati da Feuerbach e
dalla sua problematica, partendo da un dato di fatto: Marx comincia a studiare l’economia
e l’economia politica durante l’esilio parigino. Questo incontro è insieme costatazione e
409 “Qui [da Kugelmann] ho trovato nuovamente anche la <Sacra famiglia>, che mi ha regalato e di cui
manderò a te un esemplare. Fui piacevolmente sorpreso di constatare che non abbiamo da vergognarci del
nostro lavoro, quantunque il culto di Feuerbach faccia ora un’impressione molto umoristica” Cfr. Meoc, Op.
cit. , vol.XLII, pag. 319.
155
rifiuto. La constatazione è relativa all’assenza di un fondamento di questa scienza410
e si
accompagna al rifiuto di una scienza senza fondamenti. “Di dove viene a Marx la
convinzione che l’economia politica manchi dei fondamenti? Dalle contraddizioni che essa
costata e registra, quando addirittura non accetta e trasfigura: prima di tutto dalla
contraddizione maggiore che oppone la pauperizzazione crescente dei lavoratori a quella
particolare ricchezza che l’economia politica celebra l’avvento nel mondo moderno” 411
.
L’incontro di Marx con l’economia politica è mediato dalla filosofia, la quale risolve il
problema di quella con il concetto di lavoro alienato a cui Marx attribuisce “la funzione di
fondamento originario; ma che non può esercitare questa funzione se non a condizione di
riceverla come mandato e come missione da tutta una concezione dell’Uomo che attinge
nell’ essenza dell’uomo la necessità e il contenuto dei concetti economici che ci sono
famigliari”412
. Ma, per dirla ancora con le condivisibili parole di Althusser, il Marx “più
lontano da Marx è proprio questo Marx qui, ossia il Marx più vicino, il Marx della vigilia,
il Marx della soglia: come se prima della rottura, e per consumarla, egli avesse sentito il
bisogno di dare alla filosofia tutte le sue possibilità, l’ultima possibilità […] ossia la sua
sconfitta”413
.
E la sconfitta si consuma centrando il tema dell’economico sul metro dell’individuo
estraniato nelle relazioni sociali a causa di un determinato modo di produrre. E’ bene dire
sin dall’inizio che
la teoria dell’estraniazione contenuta nei Manoscritti – per quanto il suo oggetto sia di
natura economica- va ben al di là di un’analisi economica e quindi anche di una teoria
economica, per assumere il larga misura il carattere di un’elaborazione filosofica ben più
ampia. La varietà delle fonti utilizzati non sopperisce alle carenze nozionistiche sul tema.
Anzi, la loro eterogeneità ostacola ulteriormente le speranze di Marx, aggrovigliando i
ragionamenti su piani difficilmente compatibili. Tornando all’estraneazione, possiamo
concludere che essa, nella sua formulazione, denuncia ancora chiaramente i connotati del
passato filosofico di Marx. Essa è dunque una “teoria dello sviluppo sociale, con la quale
dimostra che la storia dell’uomo non ha un Logos al di fuori di sé, ma è un processo
dialettico di autoproduzione dell’uomo per mezzo della sua attività produttiva materiale.
L’uomo è un ente naturale immediato, una parte della natura. Come “ente naturale vivente
410 Quanto in questo abbia influenzato la filosofia tedesca è facilmente immaginabile
411 Cfr. Louis Althusser, Per Marx, op. cit. pag. 135
412 Ibidem, pag. 136-7
413 Idem
156
è da una parte fornito di forze naturali, di forze vitali, è un attivo ente naturale, e queste
forze esistono in lui come disposizioni e capacità, come impulsi; e d’altra parte, in quanto
ente naturale, corporeo, sensibile, oggettivo, è un ente passivo condizionato e limitato,
come è anche l’animale e la pianta: e cioè gli oggetti dei suoi impulsi esistono fuori di lui
come oggetti del suo bisogno, oggetti indispensabili, essenziali alla manifestazione e
conferma delle sue forze essenziali”414
. L’uomo vive nella natura e la natura condiziona la
sua propria vita materiale ed intellettuale. La natura è il fondamento stesso della vita
umana in generale.
L’attività produttiva materiale dell’uomo, oltre ad essere la mediazione tra uomo e natura,
è la principale caratteristica dell’uomo, quella che lo distingue dall’animale. Non perché
questo non produca. Ma perché le produzioni in cui è impegnato rispondono a bisogni
immediati. Liberatosi dal dominio del bisogno fisico, l’uomo riesce a produrre. Anzi, è
proprio il sottrarsi al bisogno fisico che consente la produzione. Il carattere di produzione
umana riesce inoltre a ri-produrre la natura intera. Questa produzione non appartiene
direttamente al corpo fisico del produttore, ma il produttore si pone di fronte ad essa come
indipendente. Infine mentre l’animale coincide direttamente con la sua attività vitale,
l’uomo fa della stessa attività l’oggetto del suo volere e della sua coscienza415
.
Naturalmente Marx non nega che accanto all’attività produttiva materiale anche altre
caratteristiche discriminano l’uomo dall’animale: “Le attività e determinazioni essenziali
dell’uomo [sono] molteplici”416
. Con l’attività produttiva si oggettivizzano le sue forze
vitali fisiche ed intellettuali, in un oggetto diverso dal produttore. E l’oggettivazione è una
forma di appropriazione della natura. Ed è quindi una condizione essenziale, necessaria,
eterna. Ciò che si modifica nella storia allora è solo la forma sociale in cui gli uomini
producono i prodotti della loro attività. Ma l’oggettivazione non è soltanto produzione di
oggetti. Questo è solo il lato esterno del fenomeno. V’è nel contempo mediante questa
attività un autosviluppo del soggetto che produce. Con e nella sua attività l’uomo dunque
migliora se stesso. Ed essendo non un produttore isolato, bensì produttore tra i produttori,
egli producendo produce contemporaneamente anche la sua vita sociale.
Solo così egli è un ente generico, appartenente ad una specie. Dunque, anche l’oggetto
prodotto mediante il lavoro è l’ “oggettivazione della vita dell’uomo come essere
appartenente ad una specie” e la sua produzione stessa “la sua vita attiva come essere
414 Cfr. Meoc, Op. cit. , vol. III , pag. 364
415 Ibidem, pag. 303
416 Ibidem, pag. 327
157
appartenente ad una specie”417
. Per questo l’attività produttiva, l’attività vitale,
consapevole dell’uomo, in quanto vita che conserva la vita e la produce in un rapporto
sociale, è la vera vita dell’uomo in quanto tale.
Attraverso la sua vita produttiva, l’uomo si distacca dalla naturalità immediata in cui era
immerso, formando se stesso418
. E’ la natura colta qui come natura che diviene nella storia
dell’uomo, natura trasformata, campo di oggettivazioni delle forze umane, espressione
degli sviluppi di queste forze, anche quando queste forze sono estraniate, come
nell’industria. Sono “la storia dell’industria e l’esistenza oggettiva già formata
dell’industria il libro aperto delle forze essenziali dell’uomo”419
420
. In questo scritto Marx
usa il termine lavoro in due accezioni: una con la quale indica il lavoro in una situazione
sociale fondata sulla proprietà privata, e qui affianca alla parola lavoro il termine
estraniato; in una seconda accezione Marx parla di un lavoro consapevole, come una
attività libera: è il lavoro in una società che ha abolito la proprietà privata.
La natura è vista come “il materiale su cui il suo lavoro si realizza [quello dell’operaio], in
cui esso è attivo, da cui e mediante cui esso produce. Ma come la natura fornisce
l’alimento del lavoro, nel senso che il lavoro non può sussistere senza oggetti, sui quali
esercitarsi, così essa fornisce d’altra parte anche gli alimenti in senso stretto, cioè i mezzi
per la sussistenza fisica dell’operaio stesso”421
. Proprio in seguito alla separazione
dell’operaio dalla natura, espropriata dai capitalisti e dai proprietari fondiari, l’operaio per
sopravvivere deve lavorare. L’operaio, giuridicamente libero, è costretto economicamente
a vendere se stesso422
al capitalista. L’operaio diventa così merce423
. “la più miserabile
merce”, “ente disumanato sia spiritualmente che fisicamente” “ la merce auto-cosciente e
automatica, […] la merce umana ”424
. E’ chiaro che la teoria dell’estraniazione contenuta
in questi Manoscritti, seppur applicata al campo economico, va al di là di un’analisi
economica in senso stretto, per assumere un connotato filosofico ben più ampio.
417 Ibidem, pag. 303-4
418 Ibidem, pag. 370
419 Ibidem, pag. 330
420 Con il termine forze essenziali marx intende qui le forze produttive.
421 Ibidem, pag. 299
422 Qui Marx non ha capito ancora che vende la forza-lavoro
423 Ibidem, pag. 296
424 Idem
158
Se ciò rappresenta una generalizzazione delle cognizioni acquisite nel corso degli studi
economici, in essa, secondo le tendenze continuistiche, dovrebbero esser contenute, seppur
in forma embrionale, importanti elementi del futuro approccio marxiano425
.
Tornando alla storia, nei coevi Estratti a Mills, Marx dichiara: “L’economia politica –
come il movimento reale - parte dal rapporto dell’uomo con l’uomo, in quanto rapporto del
proprietario privato col proprietario privato. Se si presuppone l’uomo come proprietario
privato, cioè come possessore esclusivo, che attraverso questo esclusivo possesso
conferma la sua personalità e si distingue dall’altro uomo e,ad un tempo, si rapporta ad
essa – la proprietà privata essendo la sua personale, distintiva e perciò essenziale esistenza
– allora la perdita o il trasferimento della proprietà privata è una alienazione dell’uomo
stesso e, insieme, della proprietà privata”426
; contrapposte società della proprietà privata e
comunità, in cui la proprietà privata è superata. Tuttavia, accanto a queste condizioni
sociali contrapposte esistono anche all’interno della società della proprietà privata, diversi
stadi di sviluppo o condizioni: la condizione della “proprietà privata semplice”427
, “lo stato
selvaggio, barbarico”428
e la condizione della “proprietà privata alienata”429
. Qui la
proprietà privata è considerata dal punto di vista dell’estraneazione.
E’ da notare che già Adam Smith parla di uno “stadio primitivo e rozzo della società che
precede l’accumulazione dei fondi e l’appropriazione della terra”430
.
Nello stato selvaggio/barbarico l’uomo produce per soddisfare i propri bisogni immediati.
Tanto più ampio è il bisogno, tanto più intensa sarà la produzione. Lo scambio tra prodotti
del lavoro ancora non avviene. E’ questa sicuramente una situazione del tutto singolare,
cioè relativa ad un singolo e mai rispecchiante una forma socialmente determinante. Nel
secondo stadio, quello della proprietà privata alienata, del baratto, i proprietari producono
non solo per il proprio sostentamento, ma ricorrono ad supplemento di produzione
425
Tra questi, ci sembrano emblematiche le parole di Tuchscherer: “La teoria dell’estraniazione sviluppata
in questi manoscritti quindi, denuncia, ancora chiaramente i connotati del passato filosofico di Marx. Ciò
trova espressione sia nella teoria dell’estraniazione sia nell’utilizzazione di una quantità di espressioni
filosofiche derivate specialmente dalla filosofia feuerbachiana”, sebbene nelle maggior parte dei casi si celi
già “un contenuto del tutto nuovo”. Cfr. Walter Tuchscherer, op. cit. , pag. 160
426 Cfr. Meoc, Op. cit. , vol III, p. 236
427 Idem
428 Ibidem, pag. 243
429 Ibidem, pag. 238
430 Cfr. Adam Smith, Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni, Isedi, Milano 1973, pag.
49
159
destinato allo scambio. Così “il prodotto viene prodotto come valore , come valore di
scambio, come equivalente, non più per la sua immediata relazione personale con il
produttore” 431
. E questo porta il prodotto declinato come eccedenza a costituirsi come
lavoro retribuito, come lavoro non destinato al soddisfacimento immediato di chi lo
produce.
Lo scambio realizza un rapporto sociale fra liberi produttori di merci, separati fra loro dalla
proprietà privata. Ed è per questo che la reciprocità dell’alienazione è “il rapporto sociale
fra i due produttori privati”432
, per i quali il baratto svela il carattere sociale degli stessi
lavori privati, “l’atto tipico del genere, l’essenza comune, il rapporto e l’integrazione
sociale degli uomini all’interno della proprietà privata, e perciò è l’atto generico esteriore,
estraniato. Proprio perciò esso appare come baratto. E per la stessa ragione esso è il
contrario del rapporto sociale”433
.
Cosa vuol dire qui Marx? Che certamente lo scambio conferma il nesso sociale tra
produttori, ma nel contempo proprio a causa degli interessi particolari contrapposti dalla
stessa proprietà privata, questo rapporto sociale è da considerarsi come inumano.
Sbaglia a mio avviso Walter Tuchscheerer nel dire che nello scambio, per Marx, si
svolgono “aspri conflitti e delle lotte più dure”434
. La lotta qui non è ancora menzionata,
tanto meno le classi. Lo stesso Marx considera qui la violenza un’eccezione sporadica
tramite cui il fatto dell’alienazione non è spiegabile. Anzi, concorda pienamente con i
teorici dell’economia politica nell’individuare nel bisogno, nella necessità, le molle che
spingono all’alienazione. In altri termini, il motore di tutto è nel percepire come mancanza
un qualcosa che “mi appare come un bisogno per completare la mia esistenza e realizzare
la mia essenza”435
. Si vedono qui chiaramente in atto un insieme di nozioni di matrice
filosofica come quelle di alienazione, esistenza ed essenza calate in un discorso economico
denotabile con altre forme linguistiche: proprietà privata, bisogno ecc ecc.
Marx dunque, forte di una corazza teorica ritenuta ben salda, si getta su di un terreno
nuovo. E lo fa trascinandosi dietro l’unica armatura in suo possesso, ereditata dalla sinistra
hegeliana. Ne è la prova questo passo: “Il bisogno di una cosa è la prova più evidente e
irrefutabile che questa cosa appartiene alla mia essenza, che il suo essere per me, la sua
431 Cfr. Meoc, Op. cit. , vol III, p. 238
432 Ibidem, pag. 237
433 Idem
434 Cfr. Walter Tuchscheerer, Op. cit. , pag. 119
435 Cfr. Meoc, Op. cit. , vol III, p. 237
160
proprietà, è la proprietà, la peculiarità della mia essenza. Entrambi i proprietari privati
sono spinti dunque a rinunciare alla loro proprietà privata, ma rinunciarvi in modo che
nello stesso tempo essi sanzionano la proprietà privata; ossia essi sono spinti a rinunciare
alla proprietà privata entro il rapporto della proprietà privata stessa. Ciascuno dunque
alinea all’altro una parte della propria proprietà privata. La relazione sociale o il rapporto
sociale dei due proprietari privati è dunque la reciprocità dell’alienazione, il rapporto
dell’alienazione posto in entrambi i lati, ossia l’alienazione come rapporto dei due
proprietari privati, mentre nella proprietà privata semplice l’alienazione ha luogo
unilateralmente, solo rispetto a sé”436
. Nei successivi Manoscritti, Marx continua la sua
indagine partendo da una società capitalistica pura, quale è supposta anche da numerosi
economisti borghesi, in cui sono rappresentate solo le tre classi fondamentali, i lavoratori
salariali, i capitalisti e i proprietari fondiari, facendo quindi astrazione dai residui di modi
di produzione passati, anche se talvolta fortemente modificato.
II Dall’estraneazione allo scomparire del soggetto
E’ indubbio che le strutture economiche sono indagate in termini filosofici, sotto la
categoria di estraniazione. Ad essa dobbiamo rivolgerci per comprendere i termini della
rottura con l’umanismo giovanile. Il concetto di estraneazione è ripreso da Hegel quando
descrive il processo di estraniazione dell’idea assoluta che si oggettivizza nella natura e
nella società. Soprattutto, in Hegel il risultato del processo era fissato prima del processo
stesso. Gli uomini, in un certo qual modo, sono usati dallo spirito per far progredire la
storia. Come affermato nella Sacra famiglia, l’uomo esiste solo perché esiste la storia e la
storia esiste a sua volta solo perché la verità giunge all’autocoscienza437
.
Altresì, l’uomo è capace di autoproduzione, intesa come processo progressivo di sviluppo
dell’autocoscienza, capace quindi di autodispiegamento, che lo porta al sempre più
perfezionamento delle proprie capacità intellettuali. Ma Hegel aveva riconosciuto il lavoro
come attività intellettuale astratta. E ciò ci consente di capire il motivo per il quale aveva
insistito sull’autoproduzione dell’uomo come un processo, al quale si accompagna
l’oggettivarsi come un de-oggettivarsi, come alienazione e come successiva soppressione
436 Idem
437 Cfr. Meoc, Op. cit. , vol. IV, pag. 87-8
161
di questa alienazione. E questo è ciò che davvero è fondamentale, a detta di Marx, “nella
fenomenologia hegeliana e nel suo risultato finale, la dialettica della negatività come
principio motore e generatore”438
. Tuttavia, Hegel coglie il superamento
dell’estraneazione solo come autoriconoscimento dell’uomo nel prodotto da lui realizzato.
In una parola, egli coglie il superamento come superamento dell’esteriorità di ciò che si è
prodotto per mezzo del pensiero puro. Lo stesso oggettivarsi non è colto nella sua
drammatica disumanizzazione dell’essere dell’uomo in opposizione a se stesso, bensì come
oggettivazione e differenziazione dell’astratto pensiero in opposizione a questo stesso
astratto. Per questo in Hegel l’appropriazione di ciò che si è oggettivato è solo
un’appropriazione che accade nella coscienza, nel puro pensiero439
.
Ecco perché l’intero processo del farsi dell’uomo da sé ha come risultato un superamento
puramente formale, e non reale, dell’estraneazione. Le condizioni di vita non vengono
lasciate essere. Nella Sacra famiglia si legge: “Hegel fa dell’uomo l’uomo
dell’autocoscienza, anziché fare dell’autocoscienza l’autocoscienza dell’uomo, dell’uomo
reale, vivente quindi in un mondo reale, oggettivo, dell’uomo condizionato da questo
mondo. Hegel pone il mondo sulla testa e quindi può anche risolvere nella testa tutti i suoi
limiti, con il che naturalmente essi continuano a sussistere […] per l’uomo reale”440
441
.
Per Feuerbach l’estraneazione si presenta nel fenomeno della religione. Al contrario Hegel
concepiva l’estraneazione come un prodotto dell’autocoscienza; in Feuerbach invece è
concepita come un prodotto dell’uomo reale. Feuerbach aveva indicato come oggetto della
filosofia l’uomo sensibile e i rapporti con la natura e con gli altri uomini. Da qui egli
muoveva nell’analisi delle facoltà umane configurate nel suo carattere di genere.
438 Cfr. Meoc, Op. cit. , vol. III, pag. 360
439 Ibidem, pag. 359
440 Cfr. Meoc, Op. cit. , vol. IV, pag. 214
441 Nonostante le ottime valutazioni, Tuchscherer, uno dei più grandi interpreti in assoluto dell’economia
marxista, afferma che già qui Marx“ sulla base del suo metodo materialistico, mette a nudo il nocciolo
razionale della concezione dell’estraneazione- la concezione della storia come processo dialettico di
autoproduzione dell’uomo- che in Hegel è nascosto sotto una scorza idealistica- metafisica, fondando al
tempo stesso la propria concezione dialettico-materialistica della storia. Il concatenamento concettuale
tuttavia non conduce direttamente da Hegel a Marx, ma ha nella concezione feuerbachiana dell’estraniazione
un importante momento intermedio” Cfr. Walter Tuchscherer, Op. cit. , pagg. 106-7. Nulla da eccepire per
quanto riguarda il passaggio di Marx da Hegel a Feuerbach. L’unica cosa che mi trova in disaccordo è la
considerazione sul metodo materialistico, di cui, in verità, non si capisce il significato nei i contorni della
definizione. Sembra troppo poco considerare materialistica una trattazione sull’economia in termini di
estraneazione umana.
162
L’estraneazione è proiezione di determinati caratteri umani, di predicati che ineriscono non
al soggetto che le predica né tantomeno al soggetto da cui sono possedute. Esse invece
denotano una “creazione metafisica” denominata Dio. L’uomo, inteso qui nel proprio
carattere di genere e non come uomo singolo, esperisce i propri limiti nei confronti e della
natura e di se stesso, ciò di cui manca in Dio. Questo lo porta all’adorazione, e a non
comprendere questo essere così com’è realmente generato, comportandosi così nei
confronti dei prodotti del proprio spirito come una entità estranea, esistente
indipendentemente dalla sua potenza immaginifica. Sottomettendosi alla propria creatura
vista come creatrice.
L’uomo per Feuerbach deve combattere questa estraniazione, abolire Dio e sostituirlo con
la filantropia generale. L’emancipazione religiosa sarà dunque emancipazione umana.
Marx però vuole andare oltre, e ben oltre Feuerbach e Hess442
: “dopo che la forma sacra
dell’autoestraniazione umana è stata smascherata” si tratta di “smascherare
l’autoestraniazione nelle sue forme profane”443
. Anche nella Questione ebraica Marx
applicava già il concetto di estraniazione ai fenomeni della vita economica, senza averla
mai studiata : “Sotto il dominio del bisogno egoistico può agire praticamente, produrre
oggetti praticamente, solo in quanto pone i suoi prodotti, come la sua attività, sotto il
dominio di un’essenza estranea e conferisce loro il significato di una essenza estranea: il
denaro” 444
.
Anche nella Sacra famiglia continua a sottolineare come nelle condizioni della proprietà
privata “l’oggetto come essere per l’uomo, come essere oggettivo dell’uomo, è nello stesso
tempo l’ esistenza dell’uomo per l’altro uomo, la sua relazione umana con l’altro uomo, il
comportamento sociale dell’uomo verso l’uomo”445
446
.
442 Moses Hess svolge un ruolo importantissimo nella formazione di Marx. Hess compie la critica alla
proprietà privata in termini di moralità. Egli vuole risvegliare le coscienze morali per mostrare loro tutta
l’ingiustizia delle condizioni di oppressione e sfruttamento dei poveri.
443 Cfr. Meoc, Op. cit. , vol. III, pag. 191
444 Ibidem, pag. 189
445 Cfr. Meoc, Op. cit. , vol. IV, pag. 45
446 Sempre in questo testo Marx registra il tentativo, da parte di Edgar Bauer, di accostare al mondo
dell’economia. Un approccio che sarà un naufragio del pensiero di Bauer. In una missiva ad Engels, del 14
dicembre 1855, quindi ad oltre 10 anni di distanza dal testo sovracitato, Marx racconta all’amico
dell’incontro in Inghilterra avuto proprio col filosofo neohegeliano, che ancora “dello sviluppo industriale
non sapeva un’acca”. Cfr. Meoc, Op. cit. , vol XXXIX, pag. 492.
163
Eppure nel 1845 le cose sembrano già cambiate. E di molto! Finora abbiamo illustrato la
posizione del giovane Marx. Con l’ Ideologia tedesca le cose cambiano, come abbiamo
detto anche in precedenza. Abbiamo visto già cosa si intenda per rottura epistemologica, e
ora possiamo tornare ad illustrare questa ipotesi dell’evoluzione del pensiero del tedesco,
chiamando in gioco proprio l’uomo e la storia.
Se prima dell’ Ideologia tedesca egli era stato umanista, questo suo atteggiamento era
oscillato tra una posizione molto vicino alle idee illuministiche e kantiane di ragione e di
libertà, e un’altra di carattere più comunitario, che coincideva col periodo più
feuerbachiano. Il filosofo di Landshut rappresentò infatti una speranza per decine di
giovani hegeliani, i quali tramite le sue opere potevano ancora pensare ad una razionalità
avanzante nell’epoca oscura ed irrazionale dello Stato prussiano nell’età della
Restaurazione, che manteneva caratteri arcaici rispetto al resto d’Europa.
Ma proprio contro le visioni dei giovani hegeliani, nelle cui mani la storia diventa una
mera storia di sedicenti idee, di fantasmi, nell’ Ideologia tedesca Marx individua tre aspetti
dell’attività sociale: produzione dell’uomo da parte dell’uomo, mezzi per soddisfare
bisogni, creazione di nuovi bisogni, senza porli in una consequenzialità logica necessaria.
La spiegazione è forse rintracciabile nell’atteggiamento di negazione di certi modi della
visione speculativa, che tendeva a guardare ai nessi logici necessari come a nodi di
esplicazione di un piano metafisico. D’altra parte proprio l’idealismo interpreta gli eventi
alla rovescia, trasformando “ l’avvenimento storico posteriore” come “la causa, il creatore
dell’avvenimento anteriore”447
e così via.
Bollando questa aprioristica finalizzazione che era stata in parte utilizzata nella Critica in
relazione al concetto di essenza per esplicare le modalità con le quali si sviluppano le
qualità sociali dell’uomo, il suo essere sostrato-sostanza, Marx rigetta una modalità
interpretativa che guarda ancora ad un insieme di tecniche e canoni interpetrativi corretti
ma mal orientati, chiosati nella formula del ribaltamento e della cattiva astrazione. La
problematica diventa altra da quella sinora praticata, e chiama in causa il rapporto tra forze
produttive e forme di relazioni sociali da un lato, e un empirismo estremo dall’altro. E
questo ci fa comprendere il perché in Marx crolli la fiducia verso una logica specifica
dell’oggetto specifico, che poi era fiducia nella stessa indagine della filosofia, incentrata
ancora sui cardini di sostanza e qualità, oggettivazione ed essenza.
447 Cfr. Meoc, Op. cit. , vol. V, pag. 266
164
Anzi, nell’ Ideologia, in precisa opposizione con quanto teorizzato nella Critica, Marx
afferma che “ogni profondo problema filosofico si risolve con la massima semplicità in un
fatto empirico”448
.
Empirico non indica più, come nella Critica, ove manteneva la stessa accezione adottata da
Hegel, un reale immediatamente attestato dall’esperienza sensoriale449
, ma denota il
termine ultimo e non ulteriormente indagabile del reale. E così facendo, respinge altresì la
visione elaborata dagli empiristi del secolo XVIII.
E’ interessante vedere il modo in cui gli interpreti del Marx hegeliano abbiano vissuto
questo affronto alla filosofia, che di fatto sembra non avere più spazio per proferire parola.
Il crollo del paradigma del rovesciamento porta allo sgretolamento del mito del soggetto.
Mito che accomuna l’intera filosofia tedesca, Feuerbach incluso. Anche questo infatti
“non concepisce gli uomini nella loro connessione sociale, nelle loro presenti condizioni di
vita, che hanno fatto di loro ciò che sono, egli non arriva agli uomini realmente esistenti ed
operanti, ma resta fermo all’astrazione <uomo> ”450
. La nuova visione di Marx è dunque
caratterizzata dall’abbandono del principio della centralità dell’uomo.
Ma quindi che cosa rimane dell’umano? È davvero ancora possibile pensare all’uomo nei
termini della filosofia classica tedesca, o della filosofia in generale? Di fronte al fatto che il
modo di produzione capitalistico crea merci è errato credere che la reificazione sia un
processo di distruzione dell’uomo perché la vita dell’uomo diventa cosa. Invece, e questo è
davvero più radicale di qualsiasi analisi fondata sulla reificazione, Marx comprende che
l’uomo è impensabile, come soggetto e come categoria a sé, astraendolo dai rapporti
determinati in cui è inserito, e da cui è mosso. Ma questo non vuol dire che l’astrazione è
da ciò che l’uomo compie. D’altronde, quale valenza epistemologica avrebbe un discorso
circa l’umano in quanto tale se non quello di ribadire in un’altra sede l’argomentazione
metafisica dell’uomo come centro dell’universo, come ente caratterizzato da una
superiorità ontologica rispetto agli altri enti, superiorità che si esplica o nel possesso del
linguaggio o nell’agire pratico o nel porre delle forme relazionali tramite le quali
comprendere il proprio mondo, afferrandolo come semplicemente suo?
448 Cfr. Meoc, Op. cit. , vol. V , pag. 25
449 Cfr. Georg Hegel, Enciclopedia, op. cit. , par. 38
450 Cfr. Meoc, op. cit. , vol. V , pag. 26
165
Beninteso, questo processo di decentramento e detronizzazione del ruolo della soggettività
non vale solo per l’uomo, ma anche per i gruppi sociali. Non si dà, nel Marx maturo, una
soggettività portatrice di senso, un gruppo che ha una missione storica451
.
Ecco, il pensiero di Marx ha un proprio valore, quello di aver colto, prima di ogni altro, il
tramonto di ogni possibile umanesimo di fronte al sistema industriale, così uscendo
definitivamente dalla tradizione filosofica occidentale. Anzi, il primo passo di questa
uscita, di questa ricerca disperatissima di nuove lenti per decifrare il reale, durata oltre
vent’anni, è coincisa con l’abbandono del terreno della filosofia classica, e nello specifico
da una uscita dei sentieri tracciati dalla sinistra hegeliani. Senza questa ricerca di un nuovo
terreno fertile, senza l’individuazione di un nuovo campo prima d’allora celato dai veli
dell’impostazione idealistica, Marx avrebbe avuto la stessa sorta di Bauer e compagni. Tal
consapevolezza è derivata dall’eliminazione di una forte illusione, quella che permette di
pensare ala filosofia come ambito di ricerca scevro da qualsivoglia condizionamento.
L’adagio aristotelico della ricerca filosofica come unica scienza libera poiché incapace di
servire 452
mi sembra da questo punto di vista del tutto illusorio. La filosofia non è affatto
separata dalla contraddizione principale, non è mai separata dalla portata reale di questa
conflittualità totale, e, ereditando un linguaggio che rispecchia le idee dominanti, poiché
chi detiene il potere decreta il nome della cosa, la filosofia rispecchia in sé il conflitto tra il
capitale e il lavoro (così come rispecchiava il conflitto tra servo/padrone e schiavo/signore)
e nel momento in cui se ne decreta libera, finisce per pronunciare un discorso ideologico.
451 E questo a riprova, ancora una volta, della cambio di regione epistemologica. Si confrontino infatti i toni e
le posizioni assunti da Marx nel 1844 a proposito di Uomo, proletariato e borghesia. Cfr. Meoc, Per la critca
della filosofia del diritto di Hegel, vol. III, pag. 190 e ss.
452 “Gli uomini hanno cominciato a filosofare, ora come in origine, a causa della meraviglia: mentre da
principio restavano meravigliati di fronte alle difficoltà più semplici, in seguito, progredendo a poco a poco,
giunsero a porsi problemi sempre maggiori: per esempio i problemi riguardanti i fenomeni della luna e quelli
del sole e degli altri astri, o i problemi riguardanti la generazione dell'intero universo. Ora, chi prova un senso
di dubbio e di meraviglia riconosce di non sapere; ed è per questo che anche colui che ama il mito è, in certo
qual modo, filosofo: il mito, infatti, è costituito da un insieme di cose che destano meraviglia. Cosicchè, se
gli uomini hanno filosofato per liberarsi dall'ignoranza, è evidente che ricercano il conoscere solo al fine di
sapere e non per conseguire qualche utilità pratica. E il modo stesso in cui si sono svolti i fatti lo dimostra:
quando già c'era pressochè tutto ciò che necessitava alla vita ed anche all'agiatezza ed al benessere, allora si
incominciò a ricercare questa forma di conoscenza. E' evidente, dunque, che noi non la ricerchiamo per
nessun vantaggio che sia estraneo ad essa; e, anzi, è evidente che, come diciamo uomo libero colui che è fine
a se stesso e non è asservito ad altri, così questa sola, tra tutte le altre scienze, la diciamo libera: essa sola,
infatti, è fine a se stessa”. Cfr. Aristotele, Metafisica, Bompiani, Milano, 2000 , I,2,982b
166
Perché se la radice del termine ideologia non è eidos ma idiot, discorso privato, non è
concepibile una filosofia che possa dirsi slegata, o meglio svincolata da questo fatto
fondamentale che è il conflitto sociale e che si riverbera anche nelle teorie filosofiche e in
coloro i quali le elaborano. Di più, la filosofia condivide dell’ideologia e in parte della
scienza il fatto di avere storia, nel senso che non ha uno sviluppo indipendente da quel
motore che è il conflitto e da cui essa stessa è mossa. Semmai, la filosofia ha un carattere
autonomo col quale riesce ad arricchire un contenuto. Se Marx fosse rimasto un’umanista,
avrebbe dedicato i suoi interessi al valore d’uso, non a quello di scambio: quest’ultimo
nulla dice su che cosa sia l’uomo. Invece l’ultima possibilità che Marx aveva di fronte, per
comprendere questo mondo dell’uomo era proprio quello di distruggerne l’immagine
mitica, propugnata da diverse tendenze culturali che ponevano al centro del mondo proprio
l’umanità. Perciò già dalla Miseria della filosofia non vi sarà più riferimento alcuno alla
categoria di alienazione453
.
Per Hegel le figure della utilizzazione e del godimento rappresentano la sregolata
alienazione in sé irremovibile che trova nell’intero la sua conciliazione con se stessa.
Queste due figure dell’alienazione verrebbero da Marx criticate inizialmente perché esse
racchiudono il reale limite della concezione dell’alienazione di Hegel. Ma poi, con
l’abbandono della centralità del soggetto, la stessa categoria di alienazione scompare.
Certo, anche nella Ideologia tedesca se ne conserva qualche traccia. Di fatto, le facoltà che
gli individui umani viventi possono sviluppare si scontrano con quella borghese finalità
secondo concetti che risolvono tutti i molteplici rapporti tra uomini nel solo rapporto
dell’utilizzazione e che li sussumono “praticamente sotto l’unico rapporto astratto del
denaro e del commercio”454
, ma siamo già oltre la conformità al genere di feuerbachiana
memoria. Questo ci impone di fare una precisazione circa il termine della Rottura. Non
condivido affatto la visione per la quale una rottura si realizzi tout court e integralmente.
Nonostante il cambio di campo ontologico e di metodo, possono sempre conservarsi dei
residui delle concezioni passate, mutuate anche all’interno del campo nuovo che si sta
453 Il mio ragionamento non è una giustificazione allo storicismo. Condivido in pieno le parole di Ranciere
che trascrivo perché adamantine ed estremamente sintetiche: “L’impresa teorica d’interpretazione del
marxismo come storicismo non esce dai limiti assoluti nei quali si effettua, dopo Feuerbach, il
<rovesciamento> della speculazione nella praxis, dell’astrazione nel concreto: questi limiti sono definiti dalla
problematica empiristica, sublimati nella speculazione hegeliana e, dunque, nessun <rovesciamento> può
liberarcene” Cfr. Jacques Ranciere, Il concetto di critica e la critica dell'economia politica dai "Manoscritti
del 1844" al "Capitale, In Louis Althusser, Leggere il capitale, op. cit. , pag. 217
454 Cfr. Nicola Badaloni, Op. cit. , pag. 58
167
andando ad occupare, talvolta anche senza la volontà dello stesso autore. Questo vale
anche per la prima vera critica all’economia politica scritta da Marx, quella contro
Proudhon che tuttavia era “come la prima critica di ogni scienza […] necessariamente
prigioniera dei presupposti della scienza che essa combatte” 455
.
Nella Miseria della filosofia ritroviamo questa nuova impostazione. Non è affatto casuale
che Proudhon inizi la sua indagine dall’uomo singolo, e Marx dalla società pensata come
un tutto456
457
, per cui gli elementi che la compongono non possono essere considerati
isolati gli uni dagli altri. Al contrario, i singoli rapporti di produzione che di volta in volta
caratterizzano solo un determinato aspetto del modo di produzione devono essere
analizzati nella loro relazione reciproca con il modo di produzione.
Proudhon ignorava, a detta di Marx, questo necessario nesso interno e costruiva un sistema
di categorie economiche in cui le singole categorie si generano l’una dopo l’altra in base ad
operazioni puramente logiche.
Il metodo che usa Marx a quanto pare è questo: parte dal tutto unitario di un modo di
produzione per indagare i rapporti di produzione, sapendo che cosa essi sono, le relazioni
che tra di essi intercorrono per stabilire quale funzione adempie ogni singola categoria
economica all’interno del contesto complessivo. In una lettera ad Annenkov, ne viene
fornita una chiara e ampia illustrazione:
I rapporti materiali formano la base di tutti i rapporti mondani, non essendo altro che le
forme necessarie, nelle quali gli individui svolgono le loro attività. Presupponendo un
determinato stadio di sviluppo delle capacità produttive degli uomini si avrà una forma
corrispondente di commercio e consumo; ai gradi determinati di sviluppo della produzione,
455 Cfr. Meoc, Op. cit. , Vol. IV, pag. 32
456 “i rapporti di produzione di ogni società formano un tutto” Cfr. Meoc, Op. cit. , vol. VI, pag. 179
457 Anche Centrone, filosofo e logico italiano, che accetta apertamente nella sua opera l’ipotesi di rottura
epistemologica, cade nell’errore di attribuire ad Engels della nozione di totalità. Engels avrebbe recuperato
“la categoria fondamentale dell’hegelismo, cioè la totalità e avrebbe dato una interpretazione
metasificheggiante del marxismo” (Cfr. Marino Centrone, Op. cit. , pag. 35), ricadendo nei paradigmi
hegeliani rifiutati da Marx, perché, se vogliamo portare alle estreme conseguenze il ragionamento di
Centrone, guardare alla totalità significa guardare ancora, seppur in forme diverse, ad un sistema che, almeno
nei termini di Hegel, credendo nello sviluppo autonomo dell’idea in sé stessa, arriva a negare il molteplice e
il concreto, tanto da tramutare la storia in qualcosa di“ estrinseco e di accidentale che va ad iscriversi nelle
forme precostituite dello spirito. L’irrigidimento della dialettica implica l’immediata impossibilità di
comprenderne la natura evolutiva e problematica, avendo come sbocco finale la negazione dell’agente
storico, le forze produttive con la loro attività pratica” Cfr. Ibidem , pag. 53
168
del commercio e del consumo saranno collegate delle forme corrispondenti di ordinamento
sociale; a questa un corrispondente Stato politico. Le forme economiche sotto le quali “gli
uomini producono, consumano, scambiano sono dunque transitorie e storiche. Con nuove
capacità produttive acquisite gli uomini cambiano il loro modo di produzione, e col modo
di produzione essi cambiano tutti i rapporti economici i quali non erano che relazioni
necessarie di questo determinato modo di produzione” e questo è ciò che Proudhon “non
ha capito e ancor meno dimostrato.”458
. L’errore chiama in causa direttamente la filosofia.
Come siano letti, ora che la rottura con l’idealismo si è consumata, i rapporti tra la realtà e
il pensiero è facilmente intuibile. Proudhon avrebbe fornito una critica errata
dall’economia politica non perché è in possesso di una filosofia ridicola, bensì “egli ci
fornisce una filosofia ridicola perché non ha compreso lo stato sociale attuale nel suo
ingranaggio”459
. Per questo confonde le idee con le cose.
Le quattro fasi dell’evoluzione economica descritte da Proudhon, cioè divisione del lavoro,
le macchine, la concorrenza e la proprietà si basano sull’errore di confondere quest’ultima
come fase e non come forma di relazione sociale che include nel suo complesso le prime
tre.
Non comprendendo le istituzioni sociali come prodotti storici, né comprendendone
l’origine e lo sviluppo, non può che esercitare su di esse una critica dogmatica, che
recupera il dispositivo metafisico della caduta per spiegare lo sviluppo storico460
,
ricadendo così nella “vecchia cianfrusaglia hegeliana”461
462
. Dunque al posto di
spiegazioni reali si cercano cause mistiche per analizzare il corso storico.
458 Cfr. Meoc, Op. cit., vol. XXXVIII, pag. 460-1
459 Ibidem, pag. 458
460 “ Prouhon è costretto pure a ricorrere a una finzione per spiegare lo sviluppo. Egli si immagina che la
divisione del lavoro, il credito, le macchine ecc., tutto sia stato inventato per servire alla sua idea fissa, l’idea
dell’eguaglianza. La sua spiegazione è di una ingenuità sublime. Queste cose sono state inventate per
l’uguaglianza, ma disgraziatamente esse si sono rivolte contro l’eguaglianza. […]. Parte da una ipotesi
arbitraria e, siccome lo sviluppo reale e la sua finzione si contraddicono reciprocamente ad ogni passo, egli
ne deduce che qui deve esserci una contraddizione. Ma nasconde che questa è solo una contraddizione tra le
sue idee fisse e il movimento reale” Ibidem, pag. 463-4
461 Ibidem, pag. 461
462 “Ed è davvero come se il vecchio Hegel dalla sua tomba guidasse la storia come spirito del mondo e con
la più grande coscienzialità lasciasse che tutto si svolgesse due volte, una volta come grande tragedia la
seconda volta come farsa indegna” Cfr. Ibidem, pag. 414
169
A proposito dell’uomo, e di che cosa ne rimane di quella soggettività filosofica:“Non c’è
bisogno di aggiungere che gli uomini non sono i liberi arbitri delle loro forze produttive, la
base di tutta quanta la loro storia; infatti ogni forza produttiva è una forza acquisita, è il
prodotto di una attività precedente. Le forze produttive, dunque, sono il risultato
dell’energia pratica degli uomini, ma questa energia stessa è circoscritta dalle condizioni in
cui gli uomini si trovano situati, dalle forze produttive già acquisiste, dalla forma sociale
loro preesistente, che essi non creano”463
.
Se si considerano dunque i rapporti di produzione determinati al di fuori di questo
contesto, le categorie economiche si trasformano in vuote astrazioni.
Naturalmente i rapporti di produzione di un modo di produzione che rappresentano un tutto
unitario sono contraddittori, e queste relazioni antagonistiche trovano espressione e
fondamento all’interno dei rapporti di produzione capitalistici e nella loro totalità stessa, e
non, come pensava Proudhon, nelle categorie economiche. Per Proudhon quest’ultime
presentano ancora contraddizioni perché finora lo spirito umano ha solo inadeguatamente
ed incompletamente compreso la vera natura delle categorie economiche e anch’esse,
quindi, sono state realizzate solo inadeguatamente e contraddittoriamente. Ma egli non
riesce a trovare una soluzione per il loro superamento che non sia quella inane legata ad
un’operazione del pensiero; per Marx invece l’eliminazione delle contraddizioni reali
richiede un rovesciamento dei rapporti di produzione. Per Proudhon bisognava trovare i
mezzi per ricomporre le contraddizioni; Marx invece voleva farle esplodere.
Per questo il primo parla di un lato buono e di uno cattivo delle categorie economiche e
vuole salvare il primo ed eliminare il secondo. ma questo è illusorio in quanto “ciò che
costituisce il movimento dialettico è la coesistenza dei due lati contraddittori, la loro lotta e
il loro passaggio in una nuova categoria. Basta porsi il problema di eliminare il lato cattivo,
per liquidare di colpo il movimento dialettico”464
.
Ma la nozione di totalità ci orienta nella comprensione di cosa sia un modo di produzione.
Da ciò che segue si capirà il limite di ogni interpretazione teleologica di Marx. Ogni
formazione sociale è distinguibile da quelle coeve e da quelle passate per il modo di
produzione che vi predomina. Da qui la pluralità dei modi di produzione nella storia. Ma la
pluralità vuol dire non solo e semplicemente che vi siano stati diversi modi di produzione,
ma soprattutto che in una società ve ne siano anche diversi contemporaneamente, di cui
463 Ibidem, pag. 459-60
464 Cfr. Meoc, op. cit. , vol. VI , pag. 175
170
uno è quello dominante e gli altri subordinati. Di questi, alcuni possono essere dei residui
più o meno funzionali di quelli passati o un nuovo che sta “nascendo”.
Nel secondo libro del Capitale, descrivendo il processo di circolazione, Marx fa risaltare
gli intricati rapporti tra i vari modi di produzione mostrando con efficacia come nel
mercato delle merci si verifichi una intensa intersezione di merci e denari prodotti da
comunità o da sistemi schiavistici o da feudali con il capitale industriale immettendosi
nello stesso ciclo di questo465
.
Ma ciò non vuol dire che il modo di produzione capitalistico annulli gli altri modi diversi
dal suo.
Questa sarebbe un’interpretazione esageratamente meccanicistica che non ci trova
d’accordo. Piuttosto Marx ha voluto mostrare come tra diverse formazioni sociali una di
queste riesce a piegare ai propri interessi le economie delle altre formazioni sociali fondate
su altri modi di produzione, trasformando alcuni settori produttivi da creatori di prodotti
per il consumo a quello di merci, come testimonia il caso della storia degli stati meridionali
dell’Unione americana466
. Ciò ci mostra come
“per Marx lo sviluppo storico delle categorie non è mai così progressivo come a volte
viene rappresentato: ad es. categorie sviluppate possono comparire in epoche primitive,
anche se per lo più si affermano ai margini della società” 467
, e come sia totalmente fuori
luogo qualsiasi “poetica cronologia”468
.
Gli elementi che compongono un modo di produzione sono le forze produttive e i rapporti
di produzione. Avevamo visto Marx affermare che la mancata corrispondenza delle prime
rispetto ai secondi porti inevitabilmente ad un periodo rivoluzionario, e avevamo
denunciato qui un fraintendimento. La linea continuistica non può che pensare alle prime
come al vero elemento attivo in questa unità, poiché esse sarebbero quel famoso soggetto
che fa avanzare la storia. Ma, a ben vedere, non si danno forze produttive che sotto dei
rapporti di produzione. Un processo lavorativo è un’insieme di operazioni regolate al fine
di produrre dei prodotti da parte di individui che impiegano degli strumenti di lavoro e
465 Cfr. Karl Marx, Il capitale, op. cit. 634
466 Cfr. Meoc, op. cit. , vol. XXXI, pag. 256-7
467 Cfr. Enrico Grassi, L’esposizione dialettica nel Capitale di Marx, Basilicata editrice, Roma-Matera, 1976,
pag. 78
468 Cfr. Meoc, Op. cit. , vol. XXXI, pag. 112
171
sfruttano conoscenze tecniche e scientifiche ereditate469
. Nella produzione è impiegata
forza-lavoro viva; naturalmente questa deve possedere delle specifiche capacità e
qualifiche per svolgere una data mansione. In tal senso, c’è bisogno di una determinata
formazione470
. Come persone indipendenti, i lavoratori entrano in rapporto con il capitale,
e la cooperazione tra più lavoratori è dettato dalle condizioni di questo. “ Come cooperanti,
come membri di un organismo operante, sono essi stessi soltanto un modo particolare
d’esistenza del capitale. Dunque, la forza produttiva sviluppata dal lavoratore come
lavoratore sociale è forza produttiva del capitale. La forza produttiva sociale del lavoro si
sviluppa gratuitamente non appena i lavoratori vengono posti in certe condizioni; e il
capitale li pone in quelle condizioni”471
. Ogni generazione di individui trova ereditata da
quella precedente determinati strumenti di lavoro, che essa può migliorare. Il livello
tecnico dei lavoratori è dunque in una certa maniera determinata dalla natura dai mezzi di
produzione esistenti472
i quali sono l’elemento determinante nella produzione, come
espresso chiaramente nel Capitale: “ E’ fenomeno comune a tutta la produzione
capitalistica, in quanto non solo processo lavorativo ma anche processo di valorizzazione
del capitale, che non sia il lavoratore ad utilizzare la condizione di lavoro ma, viceversa,
che sia la condizione di lavoro ad utilizzare il lavoratore; ma soltanto con il macchinario
questo capovolgimento viene ad avere una realtà effettuale tecnicamente evidente”473
, in
quanto esso trascende qualsivoglia limite naturale del prolungamento della giornata
lavorativa474
. Ma questo ci risospinge all’analisi dei rapporti di produzione, che sono
rapporti giuridici di proprietà che determinano i rapporti tra i possessori dei mezzi di
produzione e chi possiede esclusivamente forza-lavoro. Ciò non vuol dire semplicemente
che i secondi non abbiamo mezzi utilizzati nella produzione. Ad esempio, un gran numero
di persone possiede un personal computer, ma non per questo esso riesce ad essere un
mezzo per la creazione di merci mediante lo sfruttamento di forza-lavoro. Tutt’altro! In
469
“Così come tutti gli altri processi di produzione precedenti, quello capitalistico si svolge in determinate
condizioni materiali, che contemporaneamente rappresentano determinati rapporti sociali in cui gli individui
entrano nel processo riproduttivo della loro esistenza. Queste condizioni e questi rapporti sono da una parte i
presupposti e dall’altra i risultati del processo di produzione capitalistico; essi vengono da esso prodotti e
riprodotti” Cfr. Karl Marx, Il capitale, op. cit. , pag. 1467 470 Cfr. Meoc, Op. cit. , vol. XXXI, pag. 189
471 Ibidem, pag. 365
472 Cioè l’oggetto di lavoro e lo strumento di produzione
473 Ibidem, pag. 462
474 Ibidem, pag. 440
172
una formazione sociale sviluppata ciò non rappresenta una condizione sufficiente. E ciò ci
mostra un altro carattere dei rapporti di produzione: essi sono rapporti di sfruttamento, con
i quali il processo di valorizzazione del capitale è garantito. I rapporti di produzione
determinano l’organizzazione del lavoro e la divisione sociale dello stesso, che è
strettamente legata alla divisione di classe con tutto ciò che essa implica, ovvero l’insieme
dei dispositivi di disciplina e repressione, funzionali all’estorsione di plusvalore. Il
continuo stravolgimento dei mezzi di produzione, lo sviluppo di nuove tecniche e nuove
conoscenze applicate alla produzione porta alla diminuizione del costo necessario della
forza-lavoro475
, cioè alla riduzione dei costi del valore della stessa con il conseguente
incremento della frazione della giornata lavorativa in cui essa stessa è impiega per produrre
plusvalore. Detto in altri termini, perché posa avvenire una riduzione del valore della
forza-lavoro occorre che diminuisca il valore della massa dei mezzi di sussistenza. E’
questo il concetto di plusvalore relativo che Marx introduce nel Capitale. Ma ciò non può
avvenire senza rivoluzionare le forze produttive. Se quindi nella produzione del plusvalore
assoluto si supponeva già come sviluppato il modo di produzione capitalistico, ora non è
sufficiente che il capitale si impossessi della forza-lavoro e per aumentare il plusvalore
prolunghi la giornata lavorativa.
Ora, ci è chiaro che nella diade forze produttive/rapporti di produzione i rapporti che ne
regolano l’unità sono l’opposto di quanto sostenuto dai teorici continuistici, Lukacs e
Badaloni in testa.
Le relazioni sociali possiamo vederle in diversi modi. Uno di questi è quello di leggerli in
relazione ad una utilità reciproca che rispecchia un interesse sociale e comunitario, come
ha fatto Hegel. Marx invece, secondo i teorici continuistici, li ricondurrebbe ai rapporti di
sfruttamento. Beninteso, il significato di tale termine, secondo questi autori, ha una valenza
fortemente morale, e non economica. Anche in questo modo si conferma il carattere
determinato del pensiero di ogni epoca rispetto alla realtà vissuta e che in ultima analisi
determina quel pensiero stesso. Se da un lato in Hegel si rispecchiano quei rapporti di
475 “In base alle diverse funzioni che essi adempiono nel corso del medesimo processo di produzione nella
creazione del valore, e perciò anche nella produzione di plusvalore, i mezzi di produzione e la forza
lavorativa, essendo forme d’esistenza del valore capitale anticipato, vengono distinti in capitale costante e
capitale variabile. Come parti costitutive diverse del capitale produttivo si distinguono anche per il fatto che
gli uni, posseduti dal capitalista, restano capitale di quest’ultimo pur al di fuori del processo produttivo,
mentre invece la forza lavorativa diventa forma d’esistenza d’un capitale individuale solamente in seno a tale
processo” Cfr. Karl Marx, Il capitale, op. cit. , pag. 587
173
produzione dell’epoca segnata dal dominio del modo di produzione capitalistico, finendo
per generalizzare ed universalizzare storicamente quei rapporti dominanti, dall’altro la
stessa generalizzazione ri-condurrebbe ogni interpretazione posteriore nei binari
dell’empirismo e del positivismo. Marx si vuole sottrarre a queste due alternative476
,
evitando di ricadere in una nuova visione finalistica.
Invece, Badaloni si ostina a cercare un’altra forma di finalismo che guardi al processo
storico come all’insieme delle tappe durante e per mezzo delle quali l’uomo e le sue facoltà
si arricchiscano e sviluppino maggiormente. La stessa idea di facoltà avrebbe avuto una
funzione decisiva per “confutare la hegeliana finalità secondo concetto, mostrando nella
nostra natura una disponibilità più ricca che con quella offerta dai presenti rapporti sociali;
ma esso aveva potuto avere una immediata utilizzazione pratica rivoluzionaria solo in
nesso al fenomeno del pauperismo” 477
. Con l’attenuarsi di questo fenomeno, Marx deve
compiere una nuova analisi. Ed è quello che avrebbe fatto durante la stesura dei
Grundrisse. In essi fissò “ concettualmente gli elementi di persistenza della società
capitalistica in nesso alle tendenze autodistruttive”478
.
Qui tornerebbe il tema dello svanire di hegeliana memoria, però riferito alle forme, che
assume il senso di una costrizione che si esercita su un altro, cioè il valore d’uso e la
multiforme realtà empirica, che la forma sottomette a sé. “La specificità della
contraddizione analizzata da Marx sta nel fatto che questo altro non può svanire. Così
mentre nella logica di Hegel tutto è condizionato allo svanire del concreto sensibile per dar
luogo all’astratto capace di autosvilupparsi, in Marx quando si parla dei rapporti essenziali
si intende la dipendenza della forma dalla materialità del mondo (rappresentata sia dalla
natura, sia da quel particolare valore d’uso, che è la forza lavoro); quando si parla di forma
fenomenica, invece, si intende il nascondimento di tale fonte materiale che tuttavia non
cessa di operare”479
. Ciò che crea le condizioni dell’occultamento è appunto l’apparenza
dello autosviluppo della forma. L’uscita di Marx dal finalismo senza concetti
corrisponderebbe allo spostamento di piano dalla filosofia all’economia politica, col quale
476 “Adesso, a tempo perso, studio anche Comte, perché inglesi e francesi fanno tanto chiasso intorno a
questo signore. Ciò che in lui li attrae è l’enciclopedismo, la sintesi. Ma è povera cosa in confronto a Hegel
(quantunque Comte in quanto matematico e fisico di professione gli sia superiore nei particolari, ma, quando
viene al succo, Hegel lo supera infinitamente perfino in questo). E dire che questo positivismo merdoso
apparve nel 1832” Cfr. Meoc, Op. cit. , pag. 257
477 Cfr. Nicola Badaloni, Op. cit. , pag. 74
478 Idem
479 Idem
174
si metterebbero in risalto l’inanità e la vacuità dall’interno dei rapporti sociali esistenti, la
limitatezza della utilità e del godimento cui essi costringono. Senza forzare troppo i
termini, potremmo tentare di vedere entro questo ragionamento la divisione antagonistica
del lavoro come il grande ostacolo all’arricchimento delle facoltà, con la quale ogni
individuo è trasformato in un essere estremamente limitato e parziale, sviluppando in esso
alcune capacità a scapito della possibilità di sviluppare le altre. Il comunismo quindi
diventa la via di uscita dalla limitazione, e ricomposizione organica del tutto dell’uomo
dilaniato, il cui carattere, per così dire, divelto è il riflesso della scomposizione dell’unità
primigenia della comunità.
Così, lo sviluppo delle forze produttive non potendosi perpetuare entro certe forme di
relazione sociali, imporrebbero agli uomini il superamento, mediante conservazione, dei
rapporti suddetti “senza distruggerne l’eredita accumulata. L’individuo verrebbe così
liberato dal dominio e restaurato nella innocenza della sua soggettività e in nuovi rapporti
sociali “che ridefiniscono insieme il problema della oggettività e quello della soggettività,
creando appunto, sul terreno del comunismo, nuove possibilità di relazioni”480
.
L’unità di soggetto e oggetto, pensiero ed essere ecc. possono essere ricondotti ad unità.
Ma quest’unità si rende comprensibile solo se, oltre ad essere rinviati alla storia come
luogo della solvibilità dei problemi, si può indicare un soggetto della storia.
Già Hegel lo ha individuato nello spirito del tempo, ripiombando però così nel mitologico,
proprio perché non è riuscito ad indicare l’identico soggetto-oggetto nella storia stessa. E
così è stato risospinto al di là della storia, in una visione della ragione, e del meccanismo
dell’astuzia, che fonderebbe esternamente la storia e la muoverebbe.
Certo, essi non hanno mai sostenuto che nella diade i rapporti di produzione fossero un
elemento statico. Più precisamente, hanno guardato ad essi sempre come un limite da
trascendere. E questi stessi rapporti in cui le forze produttive sono, per così dire, calate, ne
rappresentano anche le condizioni di sviluppo di partenza, che ne determinano, in qualche
maniera, segnandole profondamente, lo sviluppo delle forze produttive.
Invece sono gli stessi rapporti di produzione che hanno un carattere profondamente
conflittuale, e che determinano lo sviluppo della forza-lavoro, dei mezzi di produzione e lo
sviluppo tecnico.
Ma così scompare ogni possibilità per la costituzione di una soggettività “metafisica” che
muove la storia. E, come è detto più volte nel Capitale, l’uomo non è più il centro
gravitazionale del reale, perché esso stesso quando compare nell’opera, lo fa nelle sue
480 Ibidem, pag. 64
175
molteplici figure come “capitale personificato”481
, quando si parla dei capitalisti, e“come
proprietario e venditore della sua forza lavorativa” 482
quando si parla degli operai salariati;
le rispettive volontà e responsabilità sono di fatto inani se confrontate alla struttura
complessa del modo di produzione capitalistico483
. Inevitabile che all’interno di una società
“in cui prevale la produzione capitalistica, anche un produttore non capitalista viene
dominato dalle idee capitalistiche”484
.
Ma se un tempo egli aveva pensato che “la classe proprietaria e la classe del proletariato
presentano la stessa autoalienazione umana”485
, nelle pagine del Capitale simili
considerazioni non trovano più spazio486
. Nonostante ciò, autori come Lukacs hanno
interpretatato la questione nei medesimi termini della Sacra famiglia. Secondo l’ungherese
infatti il carattere della reificazione non si limita solo “alla mercificazione di tutti gli
oggetti del soddisfacimento dei bisogni. Essa imprime la sua struttura all’intera coscienza
dell’uomo: le sue qualità e capacità non si connettono più nell’unità organica della persona,
ma appaiono come “cose” che l’uomo “possiede” ed “esteriorizza”, alla stregua dei vari
oggetti del mondo esterno”487
. Gli individui stabiliscono rapporti di produzione diretti in
quanto proprietari di merci. La cosa svolge dunque la funzione sociale di collegare le
persone. Qui si darebbe una contraddizione: “se da un lato la forma sociale delle cose si
481 Cfr. Karl Marx, Op. cit. , pag. 1467
482 Idem
483 Cfr. Meoc, Op. cit. , vol. XXXI, pag. 293
484 Cfr. Karl Marx, Il capitale, op. cit. , pag. 937
485 Cfr. Meoc, Op. cit. , vol. IV , pag. 37
486 Quello che per me è un altro errore dell’interpretazione lukacsiana la ritroviamo in questo passo:
“All’uomo viene contrapposta la propria attività, il proprio lavoro come qualcosa di oggettivo e di
indipendente, che lo domina mediante leggi autonome a lui estranee. E ciò accade sia soggettivamente che
oggettivamente. Dal punto di vista oggettivo, sorge un mondo di cose già atte e di rapporti tra cose (il mondo
delle merci ed il loro movimento sul mercato), regolato da leggi le quali, pur potendo a poco a poco essere
conosciute dagli uomini, si contrappongono ugualmente ad essi come forze che non si lasciano imbrigliare
[…]. Benché possa indubbiamente utilizzare a proprio vantaggio la conoscenza di queste leggi, l’individuo
non può influire, mediante la propria attività, sullo stesso decorso della realtà in modo da modificarlo.
L’aspetto soggettivo consiste invece nel fatto che, in una economia compiutamente mercificata, l’attività
umana si oggettiva di fronte all’uomo stesso trasformandosi in merce, ed essendo sottoposta all’oggettività
estranea all’uomo delle leggi naturali della società, deve compiere i propri movimenti in modo indipendente
dall’uomo” Cfr. Gyorgy Lukacs, Op. cit. , pag. 112 487 Ibidem, pag. 130
176
presenta come il prodotto dei rapporti tra le persone, questi a loro volta si possono stabilire
solo in presenza di cose dotate di una forma specificamente sociale”488
.
La contraddizione si risolverebbe nel processo dialettico della produzione sociale.
Ma questa concezioni sono tutte basate su di una falsa ed illusoria immagine teleologica
della storia, che in Marx è impossibile rintracciare, per le ragioni che abbiamo espresso
poc’anzi: vi possono essere categorie sviluppate che compaiono in epoche primitive, anche
se per lo più si affermano ai margini della società, e presenti anche in più formazioni
sociali; di più, si danno simultaneamente più modi di produzione ecc.
Se in Marx fosse presente una concezione storica teleologica, dovremmo allora pensare
alla caduta tendenziale del saggio di profitto come ad una legge ineluttabile che porta
inesorabilmente alla disgregazione delle formazioni sociali il cui modo di produzione è
quello capitalistico. Dovremmo, detto in altri termini, pensare a quel processo di
accumulazione del capitale dato dall’aumento di produttività sociale del lavoro e dalla
relativa diminuzione del capitale variabile non come una tendenza ma come un incedere
inesorabile. Se guardiamo attentamente la cosa invece, ci accorgiamo che caduta del saggio
e accelerazione dell’accumulazione sono strettamente legate: se quest’ultima favorisce la
caduta poiché implica la concentrazione del lavoro e la diminuzione del capitale variabile
rispetto a quello costante, è altresì vero che la caduta tendenziale accelera a sua volta
l’accumulazione proprio tramite la concentrazione e centralizzazione del captale, creando
una serie di contraddizioni: tra la produzione totale e le capacità di consumo del corpo
sociale, tra l’estensione della produzione e la valorizzazione, tra l’eccesso di capitale e la
sovrapopolazione489
.
Queste sono tutte delle tendenze antagonistiche alla caduta del saggio di profitto, che la
rallentano o addirittura l’annullano.
Cade così anche quella visione ultradeterministica per la quale solo la struttura economica
ha un ruolo attivo, mentre la sovrastruttura è in un senso ultimo passiva. Lo stesso Engels
in una famosa lettera a Joseph Bloch del 1890 mostrerà il proprio disappunto verso simili
visioni490
.
488 Cfr. Isaak Rubin, Op. cit. , pag. 19
489 Cfr. Karl Marx, Il capitale, op. cit. , pag. 1076 e ss.
490 “Secondo la concezione materialistica della storia la produzione e riproduzione della vita reale è nella
storia il momento in ultima istanza determinante. Di più né io né Marx abbiamo mai affermato. Se ora
qualcuno distorce quell’affermazione in modo che il momento economico risulti essere l’unico determinante,
trasforma quel principio in una frase fatta insignificante, astratta e assurda. La situazione economica è la
177
Ma il feticismo non è un rapporto umano rappresentato in forma di cosa, bensì in un
rapporto sociale capitalistico, perché il fatto che esista la separazione tra lavoro sociale e
lavoro privato, porta con sé la conseguenza di una necessità dello scambio, dunque
attraverso le cose. E nel porre la merce come forma della connessione sociale tra i lavori
privati, pone insieme il suo necessario correlato: la persona giuridica proprietaria delle
merci.
Lo stesso atteggiamento di Badaloni lo ritroviamo, seppur con qualche differenza non
trascurabile, in Ilenkov491
, il quale sostiene che “la forma storicamente precedente, per
virtù della dialettica è diventata un momento complementare e subordinato della nuova
forma di movimento […]. L’antecedente storico può esistere molto prima dell’antecedente
logico e può addirittura costituire una condizione del sorgere del fenomeno universale
concreto, antecedente in senso logico, per trasformarsi poi in una sua manifestazione e in
un suo prodotto”492
. Anche qui ci troviamo di fronte ad una sorta di culto del primitivismo,
che Marx respinge sotto tutti i profili. Si pensi ad esempio a come egli considerasse coloro
i quali, invece di partire, correttamente, da uomini che producono in società, iniziavano le
loro analisi con uomini isolati e calati in una realtà astorica493
. Nelle Glosse su Wagner
base, ma i diversi momenti della sovrastruttura […] le forme giuridiche, anzi persino i riflessi di tutte queste
lotte reali nel cervello di coloro che vi prendono parte, le teorie politiche, giuridiche, filosofiche, le visioni
religiose ed il loro successivo sviluppo in sistemi dogmatici, esercitano altresì la loro influenza sul decorso
delle lotte storiche e in molti casi ne determinano in modo preponderante la forma. E’ un’azione reciproca di
tutti questi momenti, in cui alla fine il movimento economico si impone come fattore necessario attraverso
un’enorme quantità di fatti casuali (cioè di cose e di eventi il cui interno nesso è così vago e così poco
dimostrabile che noi possiamo fare come se non ci fosse e trascurarlo). In caso contrario, applicar la teoria a
qualsiasi periodo storico sarebbe certo più facile che risolvere una semplice equazione di primo grado” Cfr.
Meoc, Op. cit. , vol. XLVIII , pag. 493; “Del fatto che da parte dei più giovani si attribuisca talvolta al lato
economico più rilevanza di quanto convenga siamo in parte responsabili anche Marx ed io. Di fronte agli
avversari dovevamo accentuare il principio fondamentale, che essi negavano, e non sempre c’era il tempo, il
luogo e l’occasione di riconoscere quel che spettava agli altri fattori che entrano nell’azione reciproca” Cfr.
Ibidem, pag. 494. Giudizio molto simile lo troviamo anche in una missiva destinata Conrad Schmidt: “Se la
forma dell’esistenza materiale è il primis agens, ciò non esclude che le sfere ideali esercitino a loro volta su
di essa un’influenza di ritorno, ma secondaria” Ibidem, pag. 465 491“ Il problema è dunque di chiarire in quale forma si conservino nelle fasi più alte di sviluppo dell’oggetto
le condizioni storiche del suo sorgere e del suo sviluppo” Cfr. Evald Vasilevic Ilenkov, Op. cit. , pagg. 165-6
492 Ibidem, pag. 174
493 "Il singolo cacciatore e pescatore considerati isolatamente, da cui prendono le mosse Smith e Ricaro,
appartengono alle invenzioni prive di fantasia delle robinsonate del XVIII secolo, le quali, al contrario di
come gli storici immaginano, non esprimono affatto una semplice reazione all’eccessiva raffinatezza o un
178
afferma resoluto: “non esiste un processo sociale di produzione – del processo di
produzione in generale non è neppure da parlare – in quelle comunità molto numerose che
esistevano prima dell’apparizione dei capitalisti privati (antiche comunità indiane,
comunità familiari tra gli slavi del sud ecc)”494
.
Dunque, in conclusione l’uomo come soggetto è sparito dall’analisi del Marx maturo,
quello che ha consumato appieno la rottura con una problematica filosofica cambiando
ambito ontologico,e non è stato rimpiazzato da nessun altro ente. Ma se non v’è più il
soggetto, la storia si scopre come un processo senza origine e fine e senza finalità
intrinseche. Tornano, come un lampo, le parole di Louis Althusser: “ La storia non ha
dunque, nel senso filosofico del termine, un Soggetto, ma un motore: la lotta delle
classi”495
.
Rimane aperta una questione: se il pensiero di Marx nega la centralità della categoria del
soggetto, e muove da un presupposto non umanista, quale spazio occupa la politica in
Marx e soprattutto, quale fine si pone tale prassi politica? Come fa un pensiero
antiumanista a voler emancipare l’umano?
Il pensare la politica partendo dal presupposto antiumanista appare alquanto paradossale
per una filosofia che mira a liberare la stragrande maggioranza degli uomini dal giogo dei
rapporti mercantili. Althusser ha affermato che solo una posizione teoretica apertamente
antiumanista può rappresentare la condizione di possibilità della conoscenza del mondo
umano, così da schiuderne le possibilità di trasformazione. E ha legato il tema
dell'umanismo a quello dell'ideologia, la quale è da considerarsi un apparato ideologico
dello Stato e non il risultato di una visione deformata del reale. La chiave di tutto è forse
proprio l'ideologia.
Una posizione antiumanista non esclude di fatto la lotta per l’emancipazione del
proletariato dal giogo dei rapporti mercantili. Come afferma il filosofo francese, pensare la
storia come ad un processo senza soggetto implica che il marxista-leninista “perda di vista
per un solo istante gli uomini reali. Al contrario! Giacchè è per vederli tali come sono, e
per liberarli dallo sfruttamento di classe, che il M. L. [Marxista Leninista] compie la
ritorno ad un male inteso stato di natura” Cfr. Karl Marx, Per la critica dell’economia politica, op. cit. , pag.
225
494 Cfr. Karl Marx, Glosse, op. cit. , pag. 169-70
495 Cfr. Louis Althusser, Osservazioni su una categoria: “processo senza Soggetto né Fine(i)”, in I marxisti
non parlano mai al vento, op. cit. , pag.77
179
rivoluzione di sbarazzarsi dell’ideologia borghese de <l’uomo> quale soggetto della
storia, ovvero di sbarazzarsi del feticismo <dell’uomo>”496
.
Nondimeno vi è un aspetto storico di ampia portata che a mio parere spiega molte cose:
come si può riuscire a ri-pensare una azione politica, constantando il declino delle forze
della propria classe d'appartenenza e della propulsione della rivoluzione che tutto sembrava
spazzare, se si è convinti che la Storia abbia per forza una direzione? Oserei dire: possono
coloro i quali hanno creduto nella liberazione dell'uomo e hanno basato la loro filosofia
sulla teleologia storica ( con tutto il bagaglio teorico annesso) arrivare a constatare
l'esaurirsi di una spinta, la disgregazione di una classe sociale o l'acuirsi di una crisi di una
disciplina scientifica che si riteneva infallibile poichè fondata su di un metodo che
individuava nella storia un movimento dialettico inesorabile?
Ecco, a me sembra che Althusser si sia accorto, ben prima di altri, che il reale in cui era
inserito non corrispondeva o meglio non era mai corrisposto a determinati canoni filosofici
che il marxismo sovietico o la linea continuistica andavano sbandierando. Non a caso da
queste due correnti nasce o l'indifferenza verso la lotta politica (Kautsky) o una visione che
poggia sulla speranza (Bloch) o visioni che con la politica riescono a relazionarsi solo
tramite un filtro filosofico Althusser, e questa è la cosa che più apprezzo, è un autore
cosciente della crisi del marxismo, dei limiti di Marx e dell'impossibilità di un processo
storico lineare fondato si di un movimento di tempo omogeneo.
La vera difficoltà di pensare la politica semmai attanaglia coloro i quali hanno considerato
in modo deterministico lo sviluppo storico, e sopratutto come teleologicamente orientato.
Anche se, è bene sottolinearlo, molte di queste posizioni le si riscontra in precisi momenti
storici in cui sembrava imminente la disfatta del fronte della borghesia imperialista,
schiacciata dalla spinta politica del movimento comunista internazionale.
Althusser, forse più di ogni altro, aveva intuito l’imminente crisi della spinta
rivoluzionaria, e aveva iniziato ad individuare dei forti limiti teorici presenti in Marx ed
Engels per spiegare ed uscire dalla crisi. Compito di certo non facile. Ora, se c’è un dato
che a me pare realmente significativo da questo processo di distruzione della soggettività
idealistica e del processo teleologico, è proprio lo sforzo di pensare la politica come ad un
grande campo in cui vi siano certamente conflitti e lacerazioni, ma anche un certo grado di
indeterminazione sul quale creare le condizioni necessarie alla trasformazione. Tra il
presente e il futuro si dà uno spazio di radicale discontinuità, e solo le illusioni
socialdemocratiche o quella del Diamat possono arrivare a predicarne la continuità. Trovo
496
Louis Althusser, I marxisti non parlano mai al vento, Mimesis, Milano 2005, pag. 48
180
personalmente difficile riuscire a trovare una prassi rivoluzionaria da un pensiero che
predica la teleologia nella storia (Il più coerente di questi pensatori, Kautsky, affermava
che non vi doveva essere prassi politica per i proletari, ma che essi dovevano attendere la
morte del capitalismo) o che incentra l'analisi politica sulla categoria del Soggetto. Oggi in
effetti chi è questo soggetto del cambiamento? Chi avrebbe il compito di portar avanti la
Storia? Ecco, a me è sembrato che solo pensando alla crisi del marxismo, e anche alla crisi
del modo di produzione capitalistico, agli spazi aleatori ecc ecc. si potesse comprendere
quel "messaggio" contenuto nei testi di Marx e forse in luogo maggiore nella sua opera di
dirigente comunista. La realtà è talmente complessa che solo un nominalismo materialista
può essere di aiuto nel vagliare delle congiuture politiche, meglio degli eventi che non
sono determinati da cause originarie e che, in ultima analisi, non si dipanano da esse come
in un ente matematico. In altri termini, la costruzione delle condizioni del cambiamento
non la si ottiene con uno schema storico fondato su di un soggetto ritenuto in grado di
trasformare il reale.
181
BIBLIOGRAFIA
Opere di Engels e Marx consultate:
Marx-Engels-Opere-Complete, Editori Riuniti, Roma-Napoli 1972-2011
Friedrich Engels, Ludovico Feuerbach e il punto di approdo della filosofia classica
tedesca, edizioni in lingue estere, Mosca 1947
Friedrich Engels, Anti- Duhring, in Meoc, vol. XXV, Editori riuniti, Roma 1974
Friedrich Engels, Dialettica della natura, in Meoc, vol. XXV, Editori riuniti, Roma 1974
Friedrich Engels, Lineamenti di una critica dell’economia politica, in Meoc, vol. III,
Editori riuniti, Roma 1976
Friedrich Engels, La situazione della classe operaia in Inghilterra, in Meoc, vol. IV,
Editori riuniti, Roma 1992
Friedrich Engels, Principi del comunismo, in Meoc, vol. VI, Editori riuniti, Roma 1974
Friedrich Engels – Karl Marx, La sacra famiglia, in Meoc, vol. IV, Editori riuniti, Roma
1992
Friedrich Engels – Karl Marx, L’ideologia tedesca, in Meoc, vol. V, Editori riuniti, Roma
1992
Karl Marx, Scritti inediti di economia politica, Editori riuniti, Bologna 1963
Karl Marx, Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica, La nuova Italia,
Firenze 1968
Karl Marx, Per la critica dell’economia politica, Newton compton, Roma 1972
Karl Marx, Miseria della filosofia, in Meoc, vol. VI, Editori riuniti, Roma 1973
Karl Marx, Manifesto del partito comunista, in Meoc, vol. VI, Editori riuniti, Roma 1973
Karl Marx, Dalla critica della filosofia hegeliana del diritto, in Meoc, vol. III, Editori
riuniti, Roma 1976
Karl Marx, Sulla questione ebraica, in Meoc, vol. III, Editori riuniti, Roma 1976
182
Karl Marx, Per la critica della filosofia hegeliana del diritto. Introduzione, in Meoc, vol.
III, Editori riuniti, Roma 1976
Karl Marx, Estratti dal libro di James Mill , in Meoc, vol. III, Editori riuniti, Roma 1976
Karl Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844 , in Meoc, vol. III, Editori riuniti,
Roma 1976
Karl Marx, L’analisi della forma valore, Laterza, Bari 1976
Karl Marx, Teorie sul plusvalore, in Meoc, vol. XXXIV, XXXV, XXXVI, Editori riuniti,
Roma 1979
Karl Marx, Il diciotto brumaio di Luigi Bonaparte, in Meoc, vol. XI, Editori riuniti, Roma
1982
Karl Marx, Tesi su Feuerbach , in Meoc, vol. V, Editori riuniti, Roma 1992
Karl Marx, Il Capitale , Newton, Milano 1996
Karl Marx, Il capitale, libro primo 1863-90, in Meoc, vol. XXXI, 2 tomi, La città del sole,
Napoli 2011
Meoc, Lettere, vol. XXXVIII, XXIX, XL, XLI, XLII, XLII, XLIV, XLVIII, XIL, XL,
Editori riuniti, Roma 1972-91
Altre opere consultate:
AA.VV. , La contraddizione, Città nuova, Roma 1977
AA.VV. , La logique de Marx, presses universitaires de France, Paris1974
AA.VV. , Storia del marxismo, 4 volumi, Einaudi Torino 1979
AA.VV. , Sul marxismo e le scienze, Critica marxista, Roma 1972
AA. VV. , La teoria dello sviluppo capitalistico, Boringhieri, Torino 1970
Wolfgang Abendroth, Hans Heinz Holz e Leo Kofler (a cura di), Conversazioni con
Lukacs, De donato, Bari 1968
Emilio Agazzi (a cura di), Marxismo ed etica, testi sul socialismo neokantiano 1896-1911,
Feltrinelli, Milano 1975
Luciano Albanese, Il concetto di alienazione: origini e sviluppi, Bulzoni, Roma 1984
Luciano Albanese, Saggi su Marx , le fonti trascurate di una utopia rivoluzionaria, F.
Angeli, Milano 1987
Francesco Albergamo, La teoria dello sviluppo in Marx ed Engels, Guida, Napoli 1973
Louis Althusser, Per Marx, Editori Riuniti, Roma 1969
Louis Althusser, Leggere il Capitale, Mimesis, Milano 2006
Louis Althusser, I marxisti non parlano mai al vento, Mimesis, Milano 2005
Louis Althusser, Marx nei suoi limiti, Mimesis, Milano 2004
Louis Althusser, Sul materialismo aleatorio, Unicopli, Milano 2000
Aristotele, Metafisica, Bompiani, Milano 2000
Aristotele, Categorie, Rizzoli, Milano 2000
Henri Arvon, L'anarchismo, Casa editrice D'Anna, Messina-Firenze 1973
Jacques Attali, Karl Marx. Ovvero lo spirito del mondo, Fazi, Roma 2006
Kostat Axelos, Marx pensatore della tecnica, Sugar, Milano 1963
Kostat Axelos, Marx e Heidegger, Guida, Napoli 1978
Nicola Badaloni, Per il comunismo, Einaudi, Torino 1972
Nicola Badaloni, Dialettica del capitale, Editori riuniti, Roma 1980
Ètienne Balibar, La filosofia di Marx, Manifestolibri, Roma 2001
Adelchi Baratono, Le due facce di Carlo Marx : economismo e romanticismo : breve corso
di critica marxista, Di Stefano, Genova 1946
Giuseppe Bedeschi, Introduzione a Marx, Laterza, Roma-Bari 1983
183
Giuseppe Bedeschi, Alienazione e feticismo nel pensiero di Marx, Laterza, Bari 1972
Isaiah Berlin, Karl Marx, La nuova Italia, Firenze 1967
Paolo Bellinazzi, Forza e materia nel pensiero di Marx ed Engels, Angeli, Milano 1984
Francesco Berto, Che cos'è la dialettica hegeliana?, Il poligrafo, Padova 2005
Eduard Bernstein, I presupposti del socialismo e i compiti della socialdemocrazia, Laterza,
Bari 1968
Ernst Bloch, Il principio speranza, Garzanti, Milano 2005
Ernst Bloch, Karl Marx, Il mulino, Bologna 1972
Ernst Bloch, Soggetto-oggetto, commento a Hegel, Il Mulino, Bologna 1975
Böhm-Bawerk, La teoria dell’interesse di Marx, id. Paul Marloro Sweezy, La teoria dello
sviluppo capitalistico, Boringhieri, Torino 1970
Ludwig Borne, Un memoriale di Heinrich Heine, De Donato, Bari 1973
Ludwig Borne, Menzel il mangiafrancesi , a cura di Verrienti Virginia, Bulzioni, Roma
1983
Serge Bortkiewicz, La teoria economica di Marx, Einaudi, Torino 1971
Arrigo Bortolotti, Marx e il materialismo : dalla Sacra famiglia alle Tesi su Feuerbach,
Palumbo, Palermo 1976
Antonio Brancaforte, Marx e il problema della filosofia, Edizioni di Biopsyche , Catania
1979
Gio Batta Bucciol, Junges Deutschland e vecchia Germania. Saggio sulla Deutsche
misere, Franco Angeli, Milano 1995
Jacques Camatte, Il capitolo sei inedito del "Capitale" e l'opera economica di Karl Marx,
Edizioni International, Savona 1972
Vitalij Ivanovič Cerkesov, Logica e marxismo in Unione Sovietica, Dedalo, Bari 1976
Jose Chasin, Marx ontologia e metodo, Mimesis, Milano 2010
Guido Calogero, Il metodo dell'economia e il marxismo. Introduzione alla lettura di Marx,
Bari, Laterza 1967
Guido Carandini, Lavoro e capitale nella teoria di Marx, Mondadori, Padova 1971
Guido Carandini, L'anatomia della scimmia. La formazione economica della società prima
del capitale, Einaudi, Torino 1979
Guido Carandini, Un altro Marx: lo scienziato liberato dall’utopia, Laterza, Roma 2006
Marino Centrone, Logica formale e materialismo, Dedalo, Bari 1977
George Douglas Howard Cole, Storia del pensiero socialista, 5 volumi Laterza, Bari 1972
Lucio Colletti, Il marxismo e Hegel, Laterza, Bari 1969
Lucio Colletti, Intervista politico-filosofica, Laterza, Roma-Bari 1974
Lucio Colletti, Tramonto dell’ideologia, Laterza, Roma-Bari 1980
Auguste Cornu, Marx ed Engels dal liberalismo al comunismo, Feltrinelli, Milano 1971
Auguste Cornu, Karl Marx, l’uomo e l’opera , La nuova biblioteca, Milano 1946
Antonio Corra, Messianismo e morte in Marx, Leumann, Torino 1978
Benedetto Croce, Materialismo storico ed economia marxista, Sandron, Milano-Palermo
1900
Mario Dal Pra, La dialettica in Marx: dagli scritti giovanili all'Introduzione alla critica
dell'economia politica, Laterza, Bari 1965
Francesco De Aloysio, Karl figlio di Heinrich: il trasparente regno dell’Amenti, Libreria
dell’università, Pescara 1981
Suzanne De Brunhoff, La moneta in Marx, Editori riuniti, Roma 1973
Raimondo De Capua, Marx critico e interprete di Hegel, Peloritna, Messina 1983
Galvano della Volpe, Logica come scienza positiva, Messina, Firenze 1950
Galvano della Volpe, Logica come scienza storica, Editori riuniti, Roma 1969
Galvano della Volpe, E Marx, Editori Riuniti, Roma 1957, V edizione 1997
184
Jacques Derrida, Spettri di Marx. Stato del debito, lavoro del lutto e nuova Internazionale ,
R. Cortina, Milano 1994
Hans Magnus Enzensbesberger, Colloqui con Marx ed Engels, Einaudi, Torino 1977
Riccardo Faucci, Marx interprete degli economisti classici, La nuova Italia, Firenze 1979
Dino Ferreri, Marx, Feuerbach e l'antiumanesimo teorico, Bulzoni, Roma 1981
Iring Fetscher, Marx e il marxismo dalla filosofia del proletariato alla Weltanschauung
proletaria, Sansoni, Firenze 1969
Iring Fetscher, Il marxismo, storia documentata,I, Milano, Feltrinelli 1969
Ludwig Feuerbach, L’essenza del cristianesimo, Laterza, Bari 1997
Ludwig Feuerbach, Tesi provvisorie, in Principii della filosofia dell’avvenire, Torino 1948
Ludwig Feuerbach, Tesi preliminari per la riforma della filosofia in Id. Scritti filosofici, a
cura di Claudio Cesa, Bari, Laterza 1976
Roberto Finelli, Astrazione e dialettica dal Romanticismo al capitalismo: saggio su Marx,
Bulzoni, Roma 1987
Roberto Finelli, Un parricidio mancato, Hegel e il giovane Marx, Bollati Boringhieri,
Torino 2004
Roberto Fineschi, Marx e Hegel : contributi a una rilettura, Carocci, Roma 2006
Roberto Fineschi, Un nuovo Marx : filologia e interpretazione dopo la nuova edizione
storico-critica (mega2), Carocci, Roma 2008
Luigi Firpo, Carlo Marx. Introduzione ad una ristampa italiana del "Capitale" , UTET,
Torino 1945.
François Furet, Il passato di un'illusione. L'idea comunista nel XX secolo, Mondadori,
Milano 1995
Diego Fusaro, Bentornato Marx, rinascita di un pensiero rivoluzionario, Bompiani,
Milano 2009
Alberto Gajano, La dialettica della merce : introduzione allo studio di Per la critica
dell'economia politica di Marx, Il laboratorio, Napoli 1979
Pierangelo Garegnani, Marx e gli economisti classici, Einaudi, Torino 1981
Giovanni Gentile, La Filosofia di Marx, Spoerri Editore, Pisa 1899
Alexander Gerschenkron, Il problema storico dell’arretratezza economica, Einaudi,
Torino 1965
Antonio Gramsci, Il risorgimento, Einaudi, Torino 1954
Enrico Grassi, L’esposizione dialettica nel Capitale di Marx, Basilicata editrice, Roma-
Matera 1976
Nicolai Hartmann La filosofia dell'idealismo tedesco, ed. it. a cura di Valerio Verra,
Mursia, Milano
1960
Georg Hegel, Scienza della logica, Laterza, Roma-Bari 1994
Georg Hegel, Fenomenologia dello spirito, Bompiani, Milano 2006
Georg Hegel, Filosofia della storia, Tipografia e libreria Elvetica, Capolago 1840
Georg Hegel, Lezioni sulla filosofia della storia, Laterza, Roma-Bari 2008
Georg Hegel, Lineamenti della filosofia del diritto, Laterza, Bari1954
Georg Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, Laterza, Roma-Bari
2009
Georg Hegel, Differenza fra il sistema filosofico di Fichte e quello di Schelling, in Primi
scritti critici, Mursia, Milano 199
Jean Hyppolite, Saggi su Marx e Hegel, Bompiani, Milano 1973
Evald Vasilevic Ilenkov, La dialettica dell’astratto e del concreto nel Capitale di Marx,
Feltrinelli, Milano 1975
Karl Jaspers, Ragione e antiragione nel nostro tempo, SE, Milano 1999
185
Karl Kautsky, Etica e concezione materialistica della storia, Feltrinelli editore, Milano
1958
Karl Kautsky, La dottrina economica di carlo marx, bocca editore, Torino, 1898 Kautsky,
la dottrina economica di carlo marx, Bocca editore, Torino 1898
Karl Korsch, Il materialismo storico: AntiKautsky, Laterza, Bari 1971
Karl Korsch, Karl Marx, Laterza, Bari 1969
Immanuel Kant, Critica della ragion pura, Laterza, Roma-Bari 2007
Immanuel Kant, Idea per una storia universale dal punto di vista cosmopolitico, in Scritti
di storia, politica e diritto, Laterza, Roma-Bari 2009
Henry Lefebvre, Il materialismo dialettico, Einaudi, Torino 1949
Vladimir Lenin, Quaderni filosofici, Editori Riuniti, Roma 1970
Vladimir Lenin, Carlo Marx, Società editrice L'unità, Roma 1945
Alain Lipietz, Da Althusser a Mao?, Aut Aut, Milano 1977
Michael Lowy, Il giovane Marx e la teoria della rivoluzione, Massari, Bolsena 2001
Karl Löwyth, Da Hegel a Nietzsche, La frattura rivoluzionaria nel pensiero del secolo
XIX, Einaudi, Torino 2000
Gyorgy Lukacs, Storia e coscienza di classe, Sugarco edizioni, Milano 1991
Gyorgy Lukacs, Il giovane Hegel, Einaudi, Torino 1960
Gyorgy Lukacs, Ontologia dell’essere sociale, 3 volumi, Editori riuniti, Roma 1976-81
Cesare Luporini, Dialettica e materialismo, Editori Riuniti, Roma 1974
Rosa Luxemburg, L’accumulazione del capitale, Minunziano, Milano 1946
David McLellan, Il pensiero di Karl Marx, Einaudi, Torino 1975
David McLellan, Marx prima del marxismo : vita e opere giovanili , Einaudi, Torino 1974
Ernest Mandel, Introduzione alla teoria economica marxista, Massari editore, Grotte di
castro 2001
Gustav Mayer, Friedrich Engels, la vita e l’opera, Einaudi, Torino 1969
György Márkus, La teoria della conoscenza nel giovane Marx, Lampugnani Nigri, Milano
1971
(a cura di) Alessandro Mazzone, MEGA2: Marx ritrovato, Media print edizioni, Roma
2002
Franz Mehring, Vita di Marx, Editori riuniti, Roma 1972
Rodolfo Mondolfo, Umanesimo di Marx. Studi filosofici 1908-1966, Einaudi, Torino 1968
Michio Morishima, La teoria economica di Marx. Una teoria duale del valore e della
crescita, Isedi, Milano 1974
Massimo Mugnai, Il mondo rovesciato: contraddizione e valore in Marx, Il Mulino,
Bologna 1984
Antimo Negri, La destra hegeliana, In Grande Antologia filosofico, Vol. XVIII, Marzorati,
Milano 1973
Antimo Negri, La sinistra hegeliana, in Grande Antologia filosofica, vol. XVIII,
Marzorati, Milano 1973
Annibale Pastore, L' homo faber intellettuale nel materialismo dialettico di Carlo
Marx,L'Industria, Milano 1954
Fredy Perlman, Il feticismo delle merci. Saggio su Marx e la critica della economia
politica, Lampugnani Nigri, Milano 1972
Georgij Valentinovic Plechanov, La concezione materialistica della storia, Feltrinelli,
Milano 1972
Karl Popper, Congetture e confutazioni: lo sviluppo della conoscenza scientifica, Il
mulino, Bologna, 1972
Mimmo Porcaro, I difficili inizi di Karl Marx, Dedalo, Bari, 1986
Rosario Romeo, Risorgimento e capitalismo, Editori Laterza, Roma-Bari 2008
Siegbert Salomon Prawer, La biblioteca di Marx, Garzanti, Milano, 1978
186
Helmuth Reichelt, La struttura logica del concetto di capitale in Marx, De Donato, Bari,
1973.
Joan Robinson, L’accumulazione del capitale, Edizioni di comunità, Milano, 1961
Roman Rosdolsky, Genesi e struttura del <capitale> di Marx, Laterza, Bari, 1971
Roman Rosdolsky, Friedrich Engels e il problema dei popoli <senza storia>, Graphos,
Genova, 2005
Mario Rossi, Da Hegel a Marx, 4 volumi, Feltrinelli, Milano, 1975
Isaak Rubin, Saggio sulla teoria del valore di Marx, Feltrinelli, Milano, 1976
Ugo Rubini (a cura di), Cultura e potere nella Germania dell'800. La querelle Borne-
Heine-Menzel, Adriatica Editrice, Bari 1980
Adam Schaff, Marxismo e umanesimo. Per un'analisi semantica delle tesi su Feuerbach di
Karl Marx, Dedalo, Bari, 1975.
Adam Schaff, Il marxismo e la persona umana, Feltrinelli, Milano, 1966
Alfred Schmidt, Il concetto di natura in Marx, Laterza, Bari 1973
Alfred Schmidt, Il saggio medio del profitto e la legge marxiana del valore, Savelli, Roma,
1975
Adam Smith, Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni, Isedi, Milano,
1973
Iosif Vissarionovič Stalin, Principi del leninismo, Edizioni dell’unità, Roma, 1944
Iosif Vissarionovič Stalin, Questioni del leninismo, Mosca, edizioni in lingue estere, 1946
Tran duc thao, Fenomenologia e materialismo dialettico,Lampugnani Nigri, Milano, 1970
Walter Tuchscheerer, Prima del capitale: la formazione del pensiero economico di Marx
(1843-1858), La nuova Italia, Firenze, 1980
Ferdinando Vidoni, Natura e storia : Marx ed Engels interpreti del darwinismo, Dedalo,
Bari, 1985
Vitalij Vigotsky, Introduzione ai Grundrisse di Marx, La nuova Italia, Firenze, 1974
Paolo Vinci, La forma filosofia in Marx, Lithos, Roma, 2008
Karl Vorlaender, Karl Marx. La vita e l'opera, Leonardo,Roma, 1946
Gustav Andreas Wetter, Il materialismo dialettico sovietico, Torino, Einaudi, 1948
Francis Wheen, Marx, vita pubblica e privata, Mondadori, Milano, 1999
Mao Zedong, Sulla contraddizione, Casa editrice in lingue estere, Pechino, 1968
Riviste
Marcello Musto, Vicissitudini e nuovi studi dell’Ideologia tedesca, in Critica Marxista, 6,
2004
187
RINGRAZIEMENTI
Non sarei mai riuscito a concludere questa mia tesi di laurea senza il supporto
di molte persone, che qui desidero ringraziare.
Innanzitutto mia moglie Stefania, che in questi anni ha mostrato una
generosità senza pari per permettermi di concludere gli studi, sobbarcandosi
fatiche e solitudini.
Un ringraziamento speciale al Professor Marco Ivaldo. Pur di laurearmi con
Lui ho scelto di proseguire i miei studi a Napoli, nonostante i molti chilometri
di distanza e i disagi che una simile situazione comporta. Ma ciò che mi ha
insegnato ha ripagato completamente gli sforzi.
Rossella Acunzo, che rimane la migliore studiosa di filosofia della mia età
nonché grande amica, la cui pazienza verso le mie crisi meriterebbe molto più
di un semplice ringraziamento. Marcello D’arco, uomo sereno e musicale.
Claudio Senatore, persona la cui umiltà è pari alla sua intelligenza.
Dalia Collevecchio, con la quale condivido un grande percorso che è stato
stimolo infinito per la stesura della tesi….fino alla vittoria!
188
Danilo Sarra, compagno generoso e leale ma soprattutto capace di ascoltare:
merce rara sul mercato.
Infine, un grande ringraziamento, davvero sentito, lo faccio ai miei genitori,
coi quali riallaccio in questi giorni i rapporti dopo molto tempo. So che ci
tenevano particolarmente e mi auguro che questa tesi li faccia felici… Ad
maiorem rei memoriam!