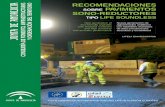(2013) The place of language among sign systems: Juri Lotman and Émile Benveniste
Ci sono una o due concezioni di enunciazione in Benveniste? Verso la cosiddetta "invenzione del...
Transcript of Ci sono una o due concezioni di enunciazione in Benveniste? Verso la cosiddetta "invenzione del...
PaciniE d i t o r e
Ricerca
Testi e Culture in Europa
sedici
a cura di Massimo Palermo e Silvia Pieroni
Sul filo del teStoin equilibRio tRa enunciato e enunciazione
La pubblicazione dei volumi della collana è sottoposta all’approvazione del comitato scientifico, composto da docenti del Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca e da studiosi di chiara fama, italiani e stranieri.
In copertina: Anonimo, Antiche Pitture di S. Michele del Sotterraneo in Borgo, di Pisa, acquaforte e bulino. Collezione Valentino Cai, Pisa.
© Copyright 2015 Pacini Editore SpA
ISBN 978-88-6315-825-0
Realizzazione editoriale e progetto grafico
Via A. Gherardesca56121 [email protected]
Rapporti con l’UniversitàLisa Lorusso
Responsabile di redazioneFrancesca Petrucci
Fotolito e StampaIndustrie Grafiche Pacini
L’editore resta a disposizione degli aventi diritto con i quali non è stato possibile comunicare e per le eventuali omissioni.
Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso di Porta Romana n. 108, Milano 20122, e-mail [email protected] e sito web www.aidro.org
indice
Introduzione » 5
Au fil de l’interaction: les «subjectivèmes» entre langue et discoursCatherine Kerbrat-Orecchioni » 11
«Lo scalpiccio operoso delle labbra». Forme dell’enunciazione nella scrittura poetica novecentescaEnrico Testa » 31
Enunciazione e punti di vista in Quer pasticciaccio brutto de via MerulanaMassimo Palermo » 49
Dinamiche enunciative nel discorso storico medievale. Il caso delle strategie evidenzialiElisa De Roberto » 65
Espressioni avverbiali di origine delocutivaAlessandro Parenti » 89
Ci sono una o due concezioni di enunciazione in Benveniste? Verso la cosiddetta «invenzione del discorso»Giovanni Manetti » 101
Contesti e forme della testualità digitaleElena Pistolesi » 119
Il testo nella lingua. Lessico, sintassi, punteggiaturaAngela Ferrari » 137
Narrazioni in seconda personaSilvia Pieroni » 157
Grammatica e tipi di testoHarm Pinkster » 175
Indice dei nomi » 185
ci Sono una o due concezioni di enunciazione in benveniSte? veRSo la coSiddetta «invenzione del diScoRSo»
Giovanni Manetti, Università di Siena
1. Introduzione
La problematica relativa alla nozione di enunciazione ha cono-sciuto un’enorme fortuna a cavallo tra gli anni sessanta e settanta del secolo scorso, in particolare dalla pubblicazione nel 1966 del primo volume dei Problemi di linguistica generale di Émile Benve-niste e del successivo saggio L’apparato formale dell’enunciazione, uscito sul numero 17 di «Langages» del 1970, interamente dedicato ad essa. Tuttavia l’effervescenza teorica che si è verificata intorno a questo tema, da una parte, non ha mancato di produrre alcune distorsioni e fraintendimenti della problematica stessa così come era stata elaborata dal suo primo ideatore1; dall’altra, ha impedito di cogliere alcuni aspetti particolari che risultano fondamentali per va-lutarne appieno la portata. Quello che vorrei sostenere è che la pro-blematica dell’enunciazione può essere affrontata e compresa solo se la si inquadra in un panorama di sviluppo genetico del pensiero di Benveniste, che deve tenere conto dei seguenti quattro punti:
1) Il primo punto è che l’idea di una teoria dell’enunciazione non scaturisce in Benveniste da una riflessione teorica generale, né ha inizialmente i caratteri della completezza, che si possono scorgere se ci si riferisce soprattutto al saggio del 1970, L’apparato formale dell’enunciazione. Tale teoria ha invece una lunghissima gestazione, che parte dal saggio del 1946 Struttura delle relazioni di persona nel verbo e culmina appunto con il saggio del 1970, nel quale vengono
1 Per un quadro complessivo della ricezione del concetto di enunciazione mi permetto di rimandare a G. Manetti, L’enunciazione. Dalla svolta comunicativa ai nuovi media, Milano, Mondadori Università, 2008. Tra le distorsioni interpretative più frequenti si pos-sono ricordare, da una parte, la sovrapposizione della nozione di enunciazione con quella di produzione (ivi, pp. 116 e sgg.) e, dall’altra, i tentativi di individuare gli equi-valenti dei deittici e delle espressioni temporali all’interno delle semiotiche non verbali, pittura e cinema innanzitutto (per cui si veda G. Manetti, Breve nota sull’enunciazione e su alcune sue estensioni all’ambito visivo, in Testure. Scritti seriosi e schizzi scherzosi per Omar Calabrese, a cura di S. Jacoviello et al., Siena, Protagon, 2009, pp. 266-282).
102
Sul filo del teSto
ripresi tutti i temi sviluppati nel corso di quasi tre decenni, talvolta separatamente, e sono messi in stretta e organica connessione, grazie anche all’approfondimento teoretico che si trova in tre saggi degli anni Sessanta: I livelli dell’analisi linguistica del 1962, La forma e il senso nel linguaggio del 1966, Semiologia della lingua del 19692.
2) In questo lungo percorso durante il quale viene elaborata la teoria dell’enunciazione si possono individuare due periodi ben distinti. Il primo è quello che va dal 1946 al 1958, anno di pubbli-cazione del saggio La soggettività nel linguaggio: in questo periodo vengono progressivamente enucleati i temi che mettono in luce le nozioni di persona e di soggetto come prodotto specifico dell’attività di linguaggio. Il secondo periodo è quello che va dal 1959, con il saggio Le relazioni di tempo nel verbo francese, al 1970, quando la nozione di enunciazione viene focalizzata in maniera sempre più chiara e posta al centro dell’interesse del linguista francese.
3) L’elaborazione delle due idee fondamentali, quella di “sog-gettività” e quella specifica di enunciazione, che caratterizzano ri-spettivamente il primo e il secondo periodo del percorso teorico di Benveniste, è determinata inizialmente in entrambi i casi da delle osservazioni che possiamo definire “di dettaglio”. Tale elaborazione arriva a delle conclusioni teoriche – e sicuramente anche filosofi-che generali – solo alla fine di un percorso. In altre parole il pro-cedimento di ricerca di Benveniste è induttivo, se non addirittura abduttivo, nel senso peirceano, di lasciarsi stupire da un particolare strano, per poi ricostruire il quadro della spiegazione in cui quel particolare trova una normalizzazione. In ogni caso non è mai de-duttivo, né scaturisce da un’idea preliminare di sistema.
4) L’ultimo punto, infine, concerne il fatto che negli scritti di Benveniste si può scorgere una duplice concezione dell’enuncia-zione, e non una teoria unitaria, come spesso è stato assunto – più o meno esplicitamente – dagli interpreti, anche se tale duplicità emerge in maniera implicita e non è tematizzata direttamente, né in modo netto dall’autore.
2 Questi tre testi non sono che le ultime tappe di un lungo percorso; anche ad Aya Ono, una delle interpreti più fini e profonde del pensiero di Benveniste sull’enun-ciazione, appaiono fortemente omogenei e collegati tra loro (cfr. A. Ono, La notion d’énonciation chez Émile Benveniste, Preface de Michel Arrivé, Postface de Claudine Normand, Limoges, Lambert-Lucas, 2007, pp. 59 sgg.).
103
ci Sono unA o due concezioni di enunciAzione in benveniSte?
2. Il metodo di Benveniste
Sono state fatte da alcuni commentatori delle osservazioni inte-ressanti circa il metodo di ricerca di Benveniste, che convalidano il quadro appena delineato. Ad esempio, Rudolf Mahrer3 ha sottoline-ato che Benveniste nel suo percorso di ricerca segue di norma tre tappe fondamentali. All’inizio ci sono alcune anomalie apparenti del sistema che lo colpiscono e che fanno scattare la molla che lo spinge all’approfondimento. Tra quelle più evidenti si possono citare alcune unità semiotiche che vengono considerate equivalenti dal punto di vista funzionale, come ad esempio i suffissi di agentività -tor e -ter in greco, le diverse forme verbali del passato francese, la duplice serie di avverbi di luogo e di tempo, l’esistenza della voce media accanto a quelle dell’attivo e del passivo, ecc. È ovviamente presente in questa fase il postulato linguistico secondo cui i sistemi linguistici manifestano normalmente un’assenza di ridondanza. In una seconda fase Benveniste analizza isolatamente queste forme dal punto di vista delle loro funzioni. In una terza fase, infine, queste forme vengono esaminate all’interno del sistema di un apparato formale specifico4.
Considerazioni non troppo distanti da quelle proposte da Mah-rer sono quelle espresse da Irène Fenoglio, animatrice dell’équipe Génétique et théories linguistiques dell’ITEM, che ha da tempo in-trapreso un’analisi dei documenti lasciati in eredità alla BNF (circa 30.000 fogli e altro materiale), la quale usa una colorita metafora per definire il metodo di pensiero e di scrittura di Benveniste:
Benveniste rumine dans les notes: parfois plusieurs “versions” de la même note, du contenu de la même note, puis écriture cursive d’une seule foulée ou presque de la théorisation énoncée. Contrairement à ce que l’on pourrait croire en observant le “brouillon” (ensemble d’un seul tenant rédac-
3 Cfr. R. Mahrer, Vers une linguistique de la parole, à partir de Benveniste, in Relire Benveniste. Réceptions actuelles des Problèmes de linguistique générale, a cura di É. Brunet - R. Mahrer, Louvain-La-Neuve, L’Harmattan/Academia, 2011, p. 216.4 È curioso che Benveniste avesse chiara consapevolezza di questo suo interesse per i dettagli, come mostra un ricordo riportato da Julia Kristeva (Émile Benveniste, un linguiste qui ne dit ni ne cache, mais signifie, in É. Benveniste, Dernières leçons. Collège de France 1968 et 1969, Édition établie par Jean-Claude Coquet et Irène Fenoglio, Préface de Julia Kristeva, Postface de Tzvetan Todorov, Paris, EHESS/Galli-mard/Seuil, 2012, p. 35) relativo a un colloquio con Benveniste, in cui il linguista di-chiarava: «Vous comprenez, moi je ne m’interesse qu’aux petites choses». La studiosa attribuisce a Benveniste uno stile di pensiero fortemente personale (“benvenistien”), «où le détail morphosyntaxique rejoint l’interrogation permanente des catégories fondamentales, linguistiques et/ou philosophiques» (ivi, p. 16).
104
Sul filo del teSto
tionnel) il ne s’agit nullement d’écriture spontanée, mais d’une écriture rumi-née, plusieurs fois énoncée dans les notes pour aboutir à un texte, à tout le moins un énoncé, cursif qui se tient et qui sera “arrêté provisoirement sur le brouillon puis définitivement dans le texte publié5.
3. La scoperta della soggettività. L’analisi delle persone verbali.
Possiamo ora focalizzare la nostra attenzione sui due grandi contributi apportati da Benveniste alla linguistica e alla semiotica, che caratterizzano i due distinti periodi della sua attività, ed entram-bi, come dicevamo e come tenteremo di dimostrare, dipendenti da intuizioni di dettaglio.
La prima di queste due intuizioni è quella che porterà allo svi-luppo del tema della soggettività e in particolare della soggettività manifestata nel e attraverso il linguaggio. Infatti, nel saggio del 1946 Struttura delle relazioni di persona nel verbo, Benveniste, applican-do a lingue moderne un metodo che gli derivava dalla sua esperien-za di comparatista, come noto, viene colpito da due fatti, apparente-mente banali, ma che, proprio per questo, hanno bisogno di essere sottoposti ad un esame critico: il primo è che delle classiche nove parti del discorso solo due (il verbo e il pronome) manifestano la categoria della persona6. Il secondo fatto notevole, di gran lunga più importante – la vera grande intuizione a questo proposito – è che l’uniformità delle tre persone verbali è solo apparente e ha bisogno di essere approfondita.
A questo proposito Benveniste attua un confronto tra la gram-matica occidentale e la grammatica araba7, mettendo in evidenza che, mentre nel metalinguaggio della grammatica occidentale (erede di quelle greca e sanscrita) le tre forme flesse sono appunto tre persone omogenee (tre personae in latino, tre prosopa, in greco e tre purusa in sanscrito; rispettivamente singolari e plurali, eventualmente duali), senza che tra esse si crei una gerarchia particolare, nella grammatica
5 Cfr. I. Fenoglio, Les notes de travail d’Emile Benveniste: où la pensée théorique nait via son énonciation, in «Langage et societé», 127, 1 (2009), p. 33.6 Nel saggio in questione Benveniste precisa che vuole occuparsi solo della nozione di persona nel verbo, tralasciando la stessa nozione nel caso dei pronomi. Come vedremo, la rimanderà a un saggio di circa 10 anni dopo.7 Cfr. É. Benveniste, Problèmes de linguistique générale, Paris, Gallimard (trad. it. Problemi di linguistica generale, Milano, Il Saggiatore, 1971, pp. 272 sgg.).
105
ci Sono unA o due concezioni di enunciAzione in benveniSte?
araba le tre persone non sono sullo stesso piano e non hanno nomi analoghi nel metalinguaggio descrittivo. Così nella grammatica araba la prima persona viene definita al-mutakallimu, cioè ‘colui che parla’; la seconda persona al-muhatabu, cioè ‘colui al quale ci si rivolge’; la terza persona al-ga’ibu, cioè ‘colui che è assente’. Ne risulta quindi una struttura nozionale organizzata per opposizioni, in cui le prime due persone si oppongono innanzitutto alla terza. Struttura che mette in evidenza una «esatta nozione dei rapporti tra le persone»8. Come ormai noto, perché vari studi vi hanno insistito, Benveniste trae dall’e-sempio del metalinguaggio della grammatica araba spunto per una prima caratterizzazione che oppone le prime due forme, effettiva-mente personali, alla terza forma, che viene definita non-persona, e individua una manifestazione di questa opposizione nella fenomeno-logia delle lingue storico-naturali, in cui di solito la terza persona ver-bale manifesta il puro tema (ovvero demarcatore zero); o, all’inverso, come nell’inglese moderno, è l’unica ad avere una desinenza.
È proprio a questo punto che interviene per la prima volta una riflessione sulla nozione di soggetto, che emerge da considerazioni che riguardano le relazioni interne alla struttura pronominale. Così Benveniste stabilisce innanzitutto un’opposizione tra le due forme personali (la prima e la seconda), da una parte, e la forma non personale (la terza), dall’altra, ma si trova di fronte al problema di caratterizzare un’opposizione interna alle due forme entrambe personali. La definizione di Benveniste che permette di distinguerle è, in qualche maniera, sorprendente per il suo carattere minimale:
Dobbiamo quindi costatare un’opposizione tra ‘persona-io’ e ‘persona non-io’. Su che base si stabilisce? La coppia io/tu possiede una speciale corre-lazione che in mancanza di meglio [corsivo nostro], chiameremo correlazione di soggettività9.
Non si può non sottolineare come la formula restrittiva «in man-canza di meglio» sia indizio del fatto che la nozione di soggettività entri in punta di piedi nell’apparato teorico di Benveniste, nel corso di un processo in cui il linguista cerca una nuova parola per il nuo-vo concetto e ne trova solo una che non lo convince pienamente. Ma, come noto, è questa la parola che era destinata ad avere – quasi malgrado la volontà del linguista – il grande successo che ha avuto.
8 Ivi, p. 272. 9 Ivi, p. 277.
106
Sul filo del teSto
3.1. L’analisi dei pronomi personali.
Nel saggio del 1946 – si deve mettere in rilievo – la nozione di enunciazione non ha ancora fatto la sua comparsa, ma comparirà, in effetti, per la prima volta nel saggio del 1956 dedicato a La natu-ra dei pronomi10. Quest’ultimo costituisce la controparte di quello precedente, in quanto, se il primo prendeva in considerazione la nozione di persona nel verbo, questo analizza la stessa nozione nel caso dell’altra parte del discorso in cui la categoria grammaticale della persona è manifestata.
Benveniste si rende conto, quando passa all’analisi dei pronomi personali, che questi ultimi hanno una caratteristica che non era emersa nella disamina delle persone verbali: e cioè che la loro refe-renza è variabile e dipende, per l’appunto dal processo di enuncia-zione. I pronomi io e tu non hanno un referente fisso, ma quest’ulti-mo dipende dalle singole istanze di enunciazione prese in carico dai singoli soggetti che le usano11. Il referente di queste forme cambia con il cambiare dei locutori e degli allocutori. Non così per la cosid-detta terza persona, il pronome egli che, come i nomi, può continua-re a designare lo stesso oggetto anche se il locutore cambia. Così la variazione referenziale delle varie occorrenze di produzione lingui-stica nel caso dei pronomi di prima e seconda persona si oppone alla permanenza del referente nel caso del pronome di terza persona.
4. Lo sviluppo della nozione di enunciazione
All’inizio accennavamo a una seconda importante intuizione di Benveniste, anch’essa originata da una osservazione di dettaglio, che si pone alla base di una particolare piega della sua riflessione linguistica. Infatti, nel saggio del 1959 Le relazioni di tempo nel verbo francese Benveniste è incuriosito dal fatto che nel sistema temporale francese si può notare una ridondanza nell’espressione
10 L’espressione è presente in due passi: «Tra io e un nome che si riferisce a una nozione lessicale, non vi sono solo differenze formali, estremamente varie, imposte dalla struttura morfologica e sintattica delle singole lingue; ve ne sono altre, derivanti dallo stesso processo di enunciazione linguistica e che sono di natura più generale e più profonda» (ivi, p. 302); «È tuttavia un fatto originale e fondamentale che queste forme «pronominali» non rimandino né alla «realtà» né a posizioni «oggettive» nello spazio o nel tempo, ma all›enunciazione, ogni volta unica, che le contiene, e rifletto-no così il loro proprio uso» (ivi, p. 304; corsivi nostri).11 Ivi, 305.
107
ci Sono unA o due concezioni di enunciAzione in benveniSte?
del passato, data dalla duplice forma, rispettivamente, del passato prossimo (riservata in francese all’espressione orale) e del passato remoto (riservata all’espressione scritta). È noto che la lingua non ammette ridondanze e di solito, quando due forme entrano in con-flitto funzionale, una di esse decade. Ma tutto ciò in francese non si è verificato e questa dunque potrebbe sembrare una pecca del sistema linguistico.
A partire da questo particolare, apparentemente di non grande rilevanza, Benveniste elabora una importante intuizione, secondo la quale i due tempi del verbo francese non sono realmente ridon-danti, perché in realtà non fanno parte di un sistema unico (quello che normalmente e banalmente è chiamato “coniugazione”), ma si distribuiscono «in due sistemi distinti e complementari […] manife-stazione di due diversi piani di enunciazione […] quello della storia e quello del discorso»12.
Il piano di enunciazione che viene definito discorso si caratte-rizza per la presenza dei tre tempi rappresentati dal presente, dal futuro e dal passato prossimo; inoltre, per il fatto che gli indici che in esso compaiono (pronomi personali di prima e seconda persona, deittici, forme della temporalità) individuano i loro referenti (sog-getti, tempi e luoghi specifici) in relazione alle coordinate dell’e-nunciazione. È l’enunciazione, ovvero l’atto del dire, che individua il riferimento del presente nella linea continua e irreversibile del tempo fisico: esso costituisce il tempo cardine dell’intero sistema, in quanto tempo coestensivo all’atto di dire, e permette di indivi-duare il riferimento del passato (prossimo) come tempo già com-piuto rispetto a esso e il futuro come tempo che deve compiersi. Il piano rappresentato dalla storia invece si caratterizza per il fatto di assumere come fulcro un tempo che esclude ogni riferimento all’atto enunciativo di un locutore, cioè l’aoristo (ovvero il ‘tempo in-definito’, in italiano chiamato passato remoto); ciò rende impos-sibile individuare i referenti di tempi e luoghi specifici se non si aggiungono delle determinazioni particolari (ad esempio, una data, un’indicazione spaziale, ecc.), in quanto le forme che vi compaiono non dipendono dalle coordinate dell’enunciazione per la determi-nazione della loro referenza. Detto in altri termini, con le parole dello stesso Benveniste, la storia «non prenderà mai in prestito l’ap-parecchiatura formale del discorso» 13.
12 Cfr. Benveniste, Problèmes de linguistique générale, cit., pp. 284-285.13 Ivi, p. 285. Si veda, per un approfondimento a questo proposito, Manetti, L’enun-ciazione, cit., pp. 34-42.
108
Sul filo del teSto
Tuttavia vale la pena di sottolineare due aspetti che spesso sono rimasti ambigui.
Il primo riguarda una confusione che spesso è stata fatta nel ritenere che l’opposizione tra storia e discorso riguardasse due ti-pologie sulla scorta delle quali analizzare dei corpora differenti di testi. Al contrario, si tratta di una descrizione del sistema sincroni-co della lingua, che organizza delle relazioni tra paradigmi verbali, pronominali, avverbiali, ecc. grazie a due sottosistemi che permet-tono due operazioni diverse: l’uno (il discorso) fa riferimento alle coordinate dell’enunciazione e presenta i fatti, su cui verte, in stretta continuità (coestensività temporale, anteriorità, posteriorità) rispet-to alle coordinate di chi parla; l’altro (la storia), permette invece di enunciare i fatti come esterni all’agente che li enuncia e alle relative coordinate spazio-temporali.
Il secondo aspetto riguarda una variazione lessicale che si ve-rifica a proposito della stessa formula nel passaggio dall’articolo del 1959 a quello del 1970. Nel saggio del 1959 Benveniste parla di «apparecchiatura formale del discorso»14; mentre il titolo dell’ultimo saggio (1970) suona come «l’apparato formale dell›enunciazione»15. Le due formule potrebbero sembrare equivalenti e potrebbero far sorgere l’idea che enunciazione e discorso debbano essere consi-derate come espressioni riferite allo stesso concetto. Se si prende in considerazione il saggio del 1959 questa supposta equivalenza sembrerebbe da respingere, perché – come abbiamo visto – in esso si parla esplicitamente di «due diversi piani di enunciazione», distinti in storia (o «enunciazione storica», «piano storico dell’enunciazione», «narrazione storica») e discorso (o «enunciazione discorsiva»)16. Se si prende invece in considerazione il saggio del 1970, enunciazione e discorso di fatto coincidono. Ci troviamo quindi di fronte a una questione intricata e complessa che richiede un approfondimento.
5. La doppia concezione della nozione di enunciazione
L’ipotesi che intendo qui proporre per risolvere la questione sollevata nel paragrafo precedente riguarda l’ultimo dei quattro punti presentati all’inizio, e cioè il fatto che in Benveniste non sia
14 Cfr. Benveniste, cit., p. 285.15 Cfr. É. Benveniste, Problèmes de linguistique générale II, Paris, Gallimard, 1974 (trad. it. Problemi di linguistica generale, Milano, Il Saggiatore, 1985, p. 96). 16 Cfr. Benveniste, Problèmes de linguistique générale, cit., p. 290.
109
ci Sono unA o due concezioni di enunciAzione in benveniSte?
presente – come dicevamo – una concezione unitaria della nozione di enunciazione, ma due diverse concezioni, variamente intreccia-te tra di loro, che in assenza di termini più adeguati suggerirei di chiamare rispettivamente “concezione debole””, o “”generalizzante” (che permette di tenere separate le due nozioni di enunciazione e di discorso) e “concezione forte””, o “”discorsivista”17 (tendente a far coincidere la nozione di enunciazione e quella di discorso).
Per far luce sull’argomento bisogna portarsi all’inizio dell’arti-colo L’apparato formale dell’enunciazione (1970), nel quale si ef-fettua una sistemazione in certo qual modo organica delle idee che erano state presentate nei saggi precedenti. Si tratta dell’articolo più citato, spesso il solo a cui viene fatto riferimento per la nozione di enunciazione in Benveniste 18.
Infatti, in esso viene innanzitutto fatta una distinzione tra «im-piego delle forme» e «impiego della lingua»: la prima pratica viene identificata con la parole, mentre la seconda propriamente con la nozione di enunciazione. Vengono poi proposti tre modi diversi di affrontare tale nozione, i quali corrispondono a tre diversi punti di vista nei confronti dell’enunciazione. Secondo il primo punto di vista, l’enunciazione consiste nella «realizzazione vocale della lin-gua», che comporta dei tratti individuali, di solito trascurati nella pratica scientifica o cancellati a favore di una descrizione media dei suoni. Da un secondo punto di vista lo studio dell’enunciazione, presupponendo la conversione della lingua in discorso, riguarda il problema di stabilire «in che modo il senso prende forma in parole» o, in altri termini, il problema della cosiddetta «semantizzazione del-la lingua»19. Da un terzo punto di vista lo studio dell’enunciazione è legato a una sua definizione all’interno del «quadro formale della sua realizzazione», che Benveniste dice essere «il tema specifico» delle pagine dell’articolo in questione.
17 Su questo punto concordo inoltre perfettamente con Rudolf Mahrer, che ha sottoli-neato come la ricezione della nozione di enunciazione sia stata spesso centrata sulla caratterizzazione che ne viene data ne L’apparato formale dell’enunciazione, che ha portato a una lettura “discorsivista”, ovvero ha portato a identificare la nozione di enunciazione con la sua “accezione forte”. Cfr. Mahrer, Vers une linguistique de la parole, cit., p. 201. 18 In esso si trovano le due più celebri formule definitorie dell’enunciazione, rispet-tivamente: «L’enunciazione è questo rendere la lingua funzionante attraverso un atto individuale di utilizzazione» e «L’enunciazione presuppone la conversione individuale della lingua in discorso» (cfr. Benveniste, Problèmes de linguistique générale II, cit., rispettivamente pp. 97 e 98).19 Cfr. Benveniste, Problèmes de linguistique générale II, cit., p. 99.
110
Sul filo del teSto
Sebbene i primi due approcci non vengano ulteriormente svi-luppati in quell›articolo, si può facilmente inferire che essi corrispon-dano complessivamente a quella che abbiamo definito come “con-cezione debole dell’enunciazione”, mentre il terzo corrisponde alla “concezione forte”. Si può tuttavia ulteriormente osservare che, se il primo approccio (la realizzazione fonica della lingua) non è stato illustrato in nessuna delle opere di Benveniste, il secondo, quello re-lativo alla «semantizzazione della lingua», era stato oggetto specifico di attenzione sia nell’articolo del 1969 Semiologia della lingua, sia nell’ultima lezione tenuta al Collège de France il 1° dicembre 1969.
6. La semantizzazione della lingua e la duplice concezione dell’e-nunciazione
A questo proposito può essere interessante osservare che anche una nota contestuale al passo in cui si parla del concetto di «seman-tizzazione della lingua», nel saggio del 197020, rimanda proprio all’ar-ticolo Semiologia della lingua, uscito in due puntate nei primi due fascicoli della rivista Semiotica nel 1969. In esso, infatti, Benveniste faceva una distinzione fondamentale tra due modi distinti di “signifi-canza”, che sono rispettivamente il modo semiotico e il modo seman-tico. Innanzitutto la significanza veniva definita come «la proprietà di significare», che è «il carattere comune a tutti i sistemi [di segni] e il criterio della loro appartenenza alla semiologia»21. Il modo semiotico, poi, veniva definito come il modo di significanza che è tipico del segno linguistico, costituendo quest’ultimo come unità all’interno del sistema22; se ne stabiliva la pertinenza rispetto alla dimensione della langue, come era stata descritta da Saussure, e lo si limitava al sistema ridotto ai suoi elementi costitutivi; infine si diceva che esso è provvisto di significanza, «ma si sbarra la via all’accesso alla lin-gua in esercizio» ed è autonomo rispetto ad ogni referenza. Il modo semantico, invece, – sosteneva Benveniste – «s’identifica nel mondo dell’enunciazione»23 ed è caratterizzato da tre aspetti24:
20 Cfr. Benveniste, Problèmes de linguistique générale II, cit., p. 98n.21 Ivi, p. 67.22 Ivi, pp. 79-80.23 Ivi, p. 81.24 Ne «La forma e il senso nel linguaggio» (1966) Benveniste precisa: «Il semiotico si caratterizza come una proprietà della lingua, il semantico invece risulta da un’attività del locutore che mette in azione la lingua» (cfr. Benveniste, Problèmes de linguisti-
111
ci Sono unA o due concezioni di enunciAzione in benveniSte?
1) comporta la presa in carico dell’insieme dei referenti.
2) si realizza nella dimensione della frase25. Una conseguenza di questo fatto è che è impossibile legarlo al singolo segno, e dunque sono da considerarsi fuorvianti quelle interpretazioni del concetto di enunciazione che legano quest’ultima in maniera biunivoca ai singoli pronomi personali e/o ai deittici, come talvolta è stato fatto.
3) comporta un «intenté», cioè un senso inteso, il voler dire26. Si tratta di un concetto nuovo, legato appunto al fatto che con la frase si può intendere qualcosa che va al di là della somma dei significati delle singole espressioni che la compongono. Il termine intenté è di ascendenza husserliana, e vari autori hanno messo in evidenza negli ultimi tempi i rapporti tra Benveniste e il pensiero husserliano27. In questa fase del pensiero di Benveniste divengono, infatti, in qualche modo chiare le ascendenze filosofiche del suo sistema. Egli adotta lo stesso punto di vista del filosofo olandese Hendrik Josephus Pos, il cui pensiero linguistico è improntato alla fenomenologia husser-liana, e compie egli stesso un’opzione chiaramente fenomenologica, stabilendo un legame tra il linguaggio e la realtà 28. Per Benveniste, infatti, la dimensione semantica è saldamente ancorata alla «réalité d’expérience immédiate qui est la langue pour le locuteur». Infatti si tratta di «établir un rapport humain entre locuteur et auditeur. Cela
que générale II, cit., p. 255). Le due modalità sono anche correlate a «due modalità fondamentali della funzione linguistica, cioè quella di significare, relativamente alla semiotica, e quella di comunicare, per quanto riguarda la semantica» (ibidem).25 Benveniste ribadisce questo concetto in modo chiaro anche in un passo dell’ul-tima lezione che tiene al Collège de France il 1° dicembre 1969: «A’ ce système [il sistema del “semiotico”] s’oppose dans la langue un autre système (est-ce vraiment un système?) celui du vouloir-dire qui est lié à la production et à l’énonciation des phrases, le sémantique». Cfr. Benveniste, Dernières leçons, cit., p. 144.26 Questo aspetto è messo bene in evidenza da una delle note manoscritte: «Avec la phrase, on énonce quelque chose, on pose une réalité ou la met en question, etc. On veut dire quelque chose. Une pensée s’énonce en mots et c’est la pensée de (du locuteur) que l’auditeur s’efforce de saisir, de comprendre». Il testo è riportato da Co-quet - Fenoglio, Introduction, in Benveniste, Dernières leçons, cit., p. 49, dalle note manoscritte PAP. OR. DON 0616 del fondo della BNF. 27 Ivi, p. 50. Si vedano anche i due saggi di M. De Palo, Le ‘je’, la phénoménologie et le discours: Bühler, Benveniste et Husserl, in «Beiträge zur Geschichte der Sprachwis-senschaft», 20 (2010) e Vaghezza, strutturalismo e fenomenologia del linguaggio, in Per Tullio De Mauro. Studi offerti dalle allieve in occasione del suo 80° compleanno, a cura di A. M. Thornton - M. Voghera, Roma, Aracne, 2012, pp. 59-79. 28 Cfr. Kristeva, Émile Benveniste, cit., p. 20; Coquet - Fenoglio, Introduction, cit., p. 49.
112
Sul filo del teSto
revient à dire que tout énoncé, étant intenté, contient du vécu. Et de ce fait il est chaque fois unique, se référant à un vécu unique et à une situation unique»29.
La dimensione della semantizzazione della lingua si configura dunque come un meccanismo generale che investe l’intera lingua, e non soltanto un apparato formale che si trova al suo interno; ed è per questo che la si può collocare alla base di quella che abbiamo definito “concezione debole”, o “generalizzante”, dell’enunciazione, che permette così di avere al proprio interno sia una enunciazione discorsiva, sia una enunciazione storica, ciascuna con il proprio ap-parato.
Si è di fronte, invece, alla concezione forte quando l’enuncia-zione è identificata specificamente con il discorso, situazione che si verifica quando si ha una struttura di dialogo, in cui due figure sono alternativamente protagoniste in uno scambio verbale, condi-videndo uno stesso spazio e uno stesso tempo. Ciò appare chiaro se si rilegge quel passo cruciale in cui viene descritto quello che Benveniste chiama il «quadro figurativo» dell’enunciazione. È infatti proprio in questo passo che è dato cogliere la saldatura tra una no-zione forte (o particolarizzante) di enunciazione e quella di discor-so. Rudolf Mahrer30 ha attirato l’attenzione sul fatto che in questo passo si crea un’opposizione tra due formule relative all’enunciazio-ne: da una parte la formula in generale, dall’altra la formula come forma di discorso; quest’ultima potrebbe ricevere un’interpretazione “restrittiva” e non definizionale, stabilendo dunque l’enunciazione come categoria generale e il discorso come una sua specie:
Ciò che in generale caratterizza l’enunciazione è l’accentuazione del-la relazione discorsiva col partner, sia esso reale o immaginato, individuale o collettivo. Questa caratteristica determina di necessità ciò che può essere chiamato il quadro figurativo dell’enunciazione. Come forma di discorso, l’e-nunciazione pone due ‘figure’ ugualmente necessarie, una fonte, l’altra meta dell’enunciazione. È la struttura del dialogo. Due figure in posizione di partner sono alternativamente protagonisti dell’enunciazione. Questo quadro è dato necessariamente con la definizione di enunciazione31.
29 I due testi sono riportati da Coquet - Fenoglio, Introduction, cit., p. 49, dalle note manoscritte PAP. OR. DON 0616 del fondo della BNF.30 Cfr. Mahrer, Vers une linguistique de la parole, cit., p. 206.31 Cfr.Benveniste, Problèmes de linguistique générale II, cit., p. 102.
113
ci Sono unA o due concezioni di enunciAzione in benveniSte?
Se ci chiediamo quali sono le condizioni che si devono verificare perché si abbia discorso, cioè enunciazione nella sua versione for-te, potremmo individuare i seguenti aspetti: (i) si deve innanzitutto avere la dimensione del semiotico, cioè una langue (un deposito di forme e di regole di concatenazione); (ii) all’interno del sistema della langue si deve poter rintracciare un insieme di classi di forme che, se assunte da un locutore, cambiano la loro referenza in funzione del-la variazione di questo locutore e delle coordinate spazio-temporali (pronomi personali, deittici, forme temporali, ecc.) che caratterizza-no la situazione di enunciazione; (iii) ci deve essere una situazione di dialogo tra un locutore e un allocutore, che scambiano i loro ruoli nei turni successivi di parola. L’insieme di classi di forme costituisce un apparato formale, cioè una serie di indici (pronomi personali, deittici, forme temporali, ecc.) che variano la loro referenza a secon-da del locutore che li usa e se ne fa carico32; ed è proprio nel discorso in senso stretto che si può rintracciare tale apparato formale.
7. Le radici della duplice concezione di enunciazione nelle note ma-noscritte
Può essere interessante cercare di rintracciare questa oscillazione tra due nozioni diverse di enunciazione analizzando le note che fan-no parte del dossier genetico derivante dal Fondo Benveniste. Fon-damentali a questo proposito sono in particolare le note, esaminate e riproposte da Irène Fenoglio33, in relazione all’articolo L’appareil formel de l’énonciation. In tale dossier figurano vari livelli di proget-tazione ed elaborazione del testo, che comprendono innanzitutto le lettere d’invito e di discussione (6 lettere) di Tzvetan Todorov, il quale aveva progettato e curato il numero monografico sull’enunciazione di Langages 17; poi ci sono i vari appunti di Benveniste su fogli sparsi; e infine ci sono anche i diversi stadi del testo manoscritto.
Ripercorrendo le varie tappe del percorso genetico che porta alla definitiva elaborazione dell’articolo di Benveniste, si può notare
32 Un ulteriore passo assai significativo della “concezione forte” ne L’apparato for-male dell’enunciazione è quello in cui si distinguono le espressioni che hanno nella lingua il loro statuto pieno e quelle che derivano il loro statuto dall’enunciazione e che l’enunciazione crea in relazione alle coordinate spazio-temporali del locutore (Cfr. Benveniste, Problèmes de linguistique générale II, cit., p. 101).33 Cfr. I. Fenoglio, Déplier l’écriture pensante pour relire l’article publié. Les manu-scrits de L’appareil formel de l’énonciation d’ Émile Benveniste, in Brunet - Mahrer, Relire Benveniste, cit., pp. 263-304.
114
Sul filo del teSto
che, in una lettera inviata da Todorov il 6 ottobre 1968 al linguista francese su quello che è il contenuto atteso dell’articolo richiesto, compaia proprio l’oscillazione tra le due nozioni di enunciazione. Nella prima parte della lettera Todorov34 presenta una versione de-bole o generalizzante dell’enunciazione:
Il faut d’abord poser la distinction entre la langue comme système for-mel de signes et le discours comme acte individuel d’utilisation de la langue. Je préfère cependant le terme d’énonciation à celui de discours, car ce der-nier peut également devenir le synonyme d’“énoncé” (par ex: “le discours politique”, “tenir un discours”). Énonciation s’oppose donc à: a) langue et b) énoncé; mais non à réception (n’est pas synonyme d’“émission”); le procès d’énonciation englobe l’émission, la transmission, la réception, l’émetteur, le récepteur, le contexte35.
Ciò che viene individuato come enunciazione, come si vede, è piuttosto un fenomeno di “produzione”, che sembra avere un carat-tere generale, fondamentalmente empirico e non legato a un appa-rato di forme specifiche. Da notare che Todorov afferma di preferire il termine enunciazione a quello di discorso. È interessante osserva-re che una analoga concezione dell’enunciazione nella sua versione generalizzante o debole è riecheggiata molto da vicino in una nota manoscritta di Benveniste, in cui la definizione di enunciazione è tutta centrata sul tema della «creazione» o della «produzione»:
Énonciation (addition)D’une manière très générale elle consiste dans la production de discours
<création de discours> <production qui est chaque fois une création> c’est-à-dire que le locuteur actualise les signes de la langue et réalise <crée> des énoncés aussi variés que les situations auxquelles ils correspondent par à partir d’un certain nombre de schémas syntaxiques et en faisant jouer incon-sciemment des règles de transformation36.
34 Come osserva Irène Fenoglio (Déplier l’écriture, cit., p. 276), è interessante osser-vare che Todorov per illustrare il problema che desiderava venisse trattato da Benve-niste si appoggiasse sulla conoscenza dei testi precedentemente scritti da Benveniste e che Benveniste rispondesse a Todorov aderendo molto da vicino alle sue richieste. È naturale che spesso un articolo scientifico prenda origine da uno scambio di idee.35 Il testo è riportato da Fenoglio, Déplier l’écriture, cit., p. 276, da PAP. OR. 53, Env. 223, f° 135.36 Ivi, p. 277, da PAP. OR. 51, env. 198, f°496). Le espressioni tra parentesi uncinate sono sovrascritte nel testo manoscritto. Ancora, indicative di questa concezione debole o generalizzante dell’enunciazione sono le due seguenti note: (1) «En réalité c’est un changement, non, pas un changement dans la matière même de la langue. Un change-
115
ci Sono unA o due concezioni di enunciAzione in benveniSte?
Nella seconda parte della stessa lettera di Todorov viene invece tematizzata quella che abbiamo definito come concezione forte, o discorsivista, dell’enunciazione, dal momento che viene prefigurata la possibilità di immaginare, senza nominarlo esplicitamente, un “apparato formale”, costituito da dei segni a carattere indiziale, da dei pronomi, degli avverbi, dei tempi e dei modi del verbo:
Cet acte individuel d’utilisation ne peut être comparé à celui de l’utilisa-tion d’un instrument quelconque, car la langue subit des transformations au moment de l’énonciation. Une série de signes particuliers, à caractère indiciel plutôt que symboliques, ne reçoivent un sens que dans le procès d’énoncia-tion. Ainsi de certains pronoms (le problème de la deixis), adverbes, temps du verbe, modes (vocatif, impératif). La description de leur fonctionnement constitue le premier pas dans l’étude de l’énonciation37.
Puntualmente Benveniste risponde a questa seconda sollecita-zione di Todorov con una nota in cui compaiono gli stessi temi e compare anche nell’intestazione l’espressione «appareil formel», che comprende, appunto, come del resto aveva già anticipato Todorov, i pronomi personali, gli indici, i tempi verbali:
Énonciation (appareil formel)Il faut bien distinguer ce qui est nécessaire de ce qui ne l’est pas.Ce qui est nécessaire, ce sont les instruments de l’appropriation: pro-
noms personnels, index, temps du verbe.Ce qui n’est pas nécessaire, ce sont les emplois <éléments> qu’on pour-
rait trouver pareils dans les structure non énonciatives.
ment <plus subtil, plus profond> du fait qu’elle est mise en mouvement, que quelqu’un s’en est emparé et qu’elle la meut, la met en action, que cet appareil qui gisait, poten-tiel, mais inerte, consistant en signes d’un côté (signes lexicaux et autres), en modèles flexionnels et syntaxiques de l’autre <s’anime soudain devient actuel> prend soudain existence <se forme en discours restituant autour de lui un mouvement vivant>; de lan-gue. Quelque chose naît au monde alors. Un homme s’exprime (lat. exprimere “faire sortir en pressant, faire jaillir à l’extérieur”), il fait jaillir la langue dans l’énonciation». (ivi, p. 301, da PAP. OR. 51, Env. 198, f° 486); (2) «Ici apparaît Le mécanisme de cette production est un <autre> aspect majeur du même problème. L’énonciation suppose la conversion individuelle de la langue en parole <discours>. Ici la question - très difficile et peu étudiée encore - est de voir comment le «sens» se forme en «mots», et dans quelle mesure on peut distinguer entre les deux notions et dans quels termes leur interaction. C’est la sémantisation de la langue qui est au centre de cet aspect de l’énonciation, et elle conduit [...]» (Il testo è riportato da I. Fenoglio Les notes de travail d’Emile Benveni-ste, cit., pp. 43-44, da una pagina della brutta copia dell’Appareil..., f° 456). 37 Il testo è riportato da Fenoglio, Déplier l’écriture, cit., p. 276, da PAP. OR. 53, Env. 223, f° 135.
116
Sul filo del teSto
Du moins est-ce une première approximation. En réalité s’il y a des degrés ou des distinctions à observer, ce sont des degrés dans l’aperception que nous avons de l’appareil nécessaire à l’énonciation38.
Stabilire, come fa nella nota sopra riportata, una distinzione tra «ciò che è necessario» e «ciò che non è necessario» rimanda a una concezione in cui il primo dei due termini dell’opposizione corri-sponde a una concezione dell’enunciazione come discorso in senso specifico ed esclusivo. Infatti compaiono tra i caratteri necessari sia i pronomi personali, sia gli indici, sia i tempi verbali, che fanno par-te appunto dell’apparato formale dell’enunciazione intesa come di-scorso. Questa distinzione è del resto ripresentata e riproposta nella nota del foglio successivo, in cui si fa una ulteriore distinzione, più precisa e completa, tra «caratteri necessari», e «caratteri frequenti» 39:
Caractères nécessaires de l’énonciation qui est une appropriation1) Personne, ostentation… <temps verbal> ayant leur point d’origine
dans le discours énoncé.2) <Assertion> Interrogation – exclamation3) Modes des verbesSituations: dialogue monologue polylogue (phatique) et metalogue
Caractères fréquents ou tendances1) Relation au partenaires: moi, je <travaille – toi, tu te promènes> –
vous, vous<les signes lexicaux phatiques>2) Hyperbole tendant à devenir affectif3) multiplication des verbes introducteursEnfin situation particulière de l’écrivain qui dans l’écriture fait une énon-
ciation au deuxième degré un monologue intérieur au... 40
38 Ivi, p. 278, da PAP. OR. 51, env. 198, f° 485.39 Ivi, p. 279, da PAP. OR. 51, Env. 198, f° 479.40 Ancora è indicativa a questo proposito la seguente nota riportata da I. Fenoglio, (ivi, p. 281, da PAP. OR. 51, Env. 198, f° 515), in cui viene messa in risalto la condizio-ne “più marcata”, appunto, dell’enunciazione: «Énonciation - Prendre le phénomène dans les conditions les plus marquées: celles où la personne en situation de récipro-cité: donc pas exactement le dialogue, mais l’allocution, la prise à témoin, la prise à partie».
117
ci Sono unA o due concezioni di enunciAzione in benveniSte?
Anche in questo testo, con maggiore approfondimento rispetto alla nota precedente, vengono riproposti come caratteri necessari la persona, i segni dell’ostensione, i tempi verbali; vengono aggiunte le tre grandi funzioni pragmatiche della lingua, quali l’asserzione, l’interrogazione, l’esclamazione e i modi verbali. Fondamentale a proposito della distinzione che stiamo proponendo è il riferimento alle “situazioni” in cui i caratteri necessari si manifestano: tra que-sti c’è il dialogo, che costituisce la situazione tipica del “discorso” in senso stretto. Nella versione definitiva del suo testo Benveniste pone il dialogo al centro:
A seguito dell’enunciazione, la lingua è resa effettiva in un’ istanza di discorso, che emana da un locutore, forma sonora che raggiunge un uditore e che suscita un’altra enunciazione in risposta.
In quanto realizzazione individuale, l’enunciazione può essere definita, in rapporto alla lingua, come un processo di appropriazione. Il locutore si appropria dell’apparato formale della lingua ed enuncia la sua posizione di locutore da una parte attraverso indici specifici e, dall’altra, per mezzo di pro-cedimenti accessori.
Ma immediatamente, non appena egli si dichiara locutore e assume la lingua, piazza l’altro di fronte a sé, quale che sia il grado di presenza che attribuisce a questo altro. Ogni enunciazione, esplicita o implicita, è un’allocu-zione che postula un allocutore-destinatario41.
È indicativo che, accanto al dialogo, tanto nella nota, quanto nel testo definitivo sia fatto riferimento anche al monologo, che comporta un interlocutore interiorizzato e simulacrale:
Il “monologo” discende senza dubbio dall’enunciazione. Esso deve esse-re considerato, malgrado l’apparenza, come una varietà del dialogo, struttura fondamentale. Il “monologo” è un dialogo interiorizzato, formulato come un “linguaggio interiore”, fra un io locutore e un io ascoltatore. A volte l’io locuto-re è solo a parlare; l’io ascoltatore resta nondimeno presente; la sua presenza è necessaria e sufficiente per rendere significante l’enunciazione del locutore. Altre volte anche l’io ascoltatore interviene con un’obiezione, una domanda, un dubbio, un insulto42.
41 Cfr. Benveniste, Problèmes de linguistique générale II, cit., p. 99.42 Cfr. Benveniste, Problèmes de linguistique générale II, cit., p. 103.
118
Sul filo del teSto
8. Conclusioni
Come ha giustamente sostenuto Gérard Dessons43, Benveniste non è soltanto il geniale linguista che ha elaborato la nozione di enunciazione, ma ha anche letteralmente “inventato” la nozione di discorso, sottraendola al dominio tradizionale della retorica e ride-finendone ex novo i caratteri peculiari. In una nota manoscritta44 Benveniste scrive: «L’énonciation installe l’univers du discours». Se ci interroghiamo su quali siano i rapporti tra le due nozioni, potrem-mo dire che una buona definizione (ispirata del resto a un passo che si trova nel saggio L’apparato formale dell’enunciazione45) del concetto di enunciazione è quella e che intende quest’ultima come meccanismo generale di attualizzazione della lingua attraverso un atto individuale di utilizzo, fenomeno che si verifica ogni volta che qualcuno parla (o scrive), rendendo ciò che dice un’entità asso-lutamente singolare, unica e irripetibile. Ciò corrisponde anche a una definizione generale o “debole” del concetto di enunciazione. Il discorso corrisponde invece a una forma specifica o “forte” del-lo stesso concetto, che comporta la presenza di una situazione di dialogo (cosa che si verifica anche con il monologo, ma non con l’enunciazione storica), in cui due soggetti si scambiano il ruolo di locutore in turni successivi di parola, condividendo uno stesso spa-zio e uno stesso tempo, che costituiscono le coordinate specifiche dell’enunciazione stessa e il suo punto di origine. È a tali coordinate che fanno riferimento le categorie del cosiddetto «apparato forma-le dell’enunciazione» (i pronomi di prima e seconda persona, le espressioni indicali, le forme temporali che fanno parte del presen-te, i performativi e le modalità). Nell’ultima fase del suo periodo cre-ativo, Benveniste sempre di più tende a identificare le due nozioni di «enunciazione» e di «discorso». Ciò non toglie che nello sviluppo del suo pensiero si possano rintracciare delle vistose oscillazioni a questo proposito; e che – ciò che più conta – per poter rendere appieno conto dei fenomeni di produzione linguistica in cui non siano utilizzate le forme dell’apparato formale (come ad esempio nell›enunciazione storica), sia necessario distinguere le due nozioni.
43 Cfr. G. Dessons, Émile Benveniste, l’invention du discours, Paris, Éditions In Press, 2006, p. 16.44 Riportata dallo stesso G. Dessons (ibidem), da PAP. OR. 51 f° 514/62.45 Cfr. Benveniste, Problèmes de linguistique générale II, cit., p. 99: «L’atto individuale col quale la lingua viene utilizzata introduce anzitutto il locutore come parametro nelle condizioni necessarie per l’enunciazione».