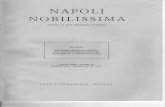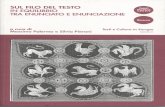SLOVENSKÉ STOPY V RÍME SLOVENSKÉ STOPY V RÍME SLOVENSKÉ STOPY V RÍME
Il discorso del re: Filippo V in Giustino ( The King's Speech: Philip V of Macedonia in Justin's...
Transcript of Il discorso del re: Filippo V in Giustino ( The King's Speech: Philip V of Macedonia in Justin's...
CONTRIBUTI DI STORIA ANTICA13
PP_Bearzot-Landucciindd 1 131115 1550
Comitato scientifico Cinzia Bearzot Franca Landucci Philip A Stadter Giuseppe Zecchini
PP_Bearzot-Landucciindd 2 131115 1550
a cura di
CINZIA BEARZOT FRANCA LANDUCCI
STUDI SULLrsquoEPITOMEDI GIUSTINOII DA ALESSANDRO MAGNO A FILIPPO V DI MACEDONIA
VITA E PENSIERORICERCHESTORIA
PP_Bearzot-Landucciindd 3 131115 1550
La pubblicazione di questo volume ha ricevuto il contribu-to finanziario dellrsquoUniversitagrave Cattolica ed egrave stata realizzata grazie al contributo del Progetto PRIN 2010-2011 del Mini-stero dellrsquoIstruzione dellrsquoUniversitagrave e della Ricerca
wwwvitaepensieroit
Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15 di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dallrsquoart 68 commi 4 e 5 della legge 22 aprile 1941 n 633Le fotocopie effettuate per finalitagrave di carattere professionale economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi Cen-tro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali Corso di Porta Romana 108 20122 Milano e-mail autorizzazioniclearediorg e sito web wwwclearediorg
copy 2015 Vita e Pensiero - Largo A Gemelli 1 - 20123 MilanoISBN 978-88-343-3107-1
PP_Bearzot-Landucciindd 4 131115 1550
INDICE
Presentazione VII
LUISA PRANDIAlessandro il Grande in Giustino 3
FRANCA LANDUCCII Diadochi 17
GIOVANNI BRIZZIGiustino e la storia di Cartagine 39
RICCARDO VATTUONEGiustino e lrsquoOccidente greco II IV-III secolo aC 55
MARIA TERESA SCHETTINOPirro in Giustino 69
FEDERICOMARIA MUCCIOLILrsquoOriente seleucidico da Antioco I ai primi anni di Antioco III in Pompeo TrogoGiustino 99
MONICA DrsquoAGOSTINI Il discorso del Re Filippo V in Giustino 121
01_indiceindd V01_indiceindd V 201115 1537201115 1537
MONICA DrsquoAGOSTINI
Il discorso del Re Filippo V in Giustino
Introduzione
Le vicissitudini del reame antigonide durante il regno di Filippo V sono trattate principalmente nei libri XXIX e XXX delle Epitome delle Storie Fi-lippiche di Pompeo Trogo Alle notizie contenute in questi libri si aggiungo-no la breve menzione dellrsquoascesa al trono del sovrano nel libro XXVIII (3 9 e 4 16) e la descrizione degli eventi relativi alla sua morte nel libro XXXII (2 3- 3 4)
Egrave chiaro dal confronto tra i Prologi e lrsquoEpitome che ampie parti dei due libri trogiani sono state omesse in Giustino in particolare quelle ineren-ti agli avvenimenti orientali poicheacute nec cognoscendi voluptate iucunda nec exemplo erant necessaria (Praefatio 4) le origini di Creta e gli scontri tra Fi-lippo e Attalo nel libro XXIX la spedizione di Filippo in Asia e le cam-pagne di Antioco III nel libro XXX
Degli eventi dei libri XXIX e XXX sono invece menzionati in forma di riassunto da Giustino i piugrave importanti scontri militari tra Roma e Fi-lippo Nella categoria dei passi lsquoepitomatirsquo rientrano la Guerra degli Al-leati la Prima Guerra Macedonica la Seconda Guerra Macedonica Ci-noscefale e le rispettive trattative di pace ovvero Naupatto Fenice Tem-pe Quando ci si trova di fronte a tali riassunti egrave spesso difficile un con-fronto puntuale con le altre tradizioni pur con lrsquoaiuto dei Prologi
Gli eventi che ricevono attenzione nei libri XXIX e XXX sono sele-zionati secondo il criterio giustineo del cosiddetto lsquoflorilegiorsquo1 ovvero per cognitione quaeque dignissima (Praefatio 4)2 Piugrave vicini allrsquooriginale tro-giano e dunque piugrave excerpta che sintesi sono da ritenersi probabilmente i passi del libro XXIX sullrsquoalleanza tra Annibale e Filippo e sulla politica filoromana di Filopemene e quelli del libro XXX sulle questioni amo-
1 Vattuone (2014) pp 261-2772 I criteri per la distinzione dei passi piugrave vicini a Trogo e quelli invece riassunti da Giustino sono stati discussi autorevolmente allrsquointerno di questo progetto da Vattuone (2014) pp 261-277 Sul rapporto tra lrsquoopera di Trogo e lrsquoEpitome vd anche recentemente Heckel (1997) pp 1-41 e Id (2012) pp 1-8 e Borgna (2014) pp 52-77
122 MONICA DrsquoAGOSTINI
rose di Tolemeo III sul patto tra Antioco e Filippo e sullrsquoira degli Eto-li che nel 196 non videro appagata la richiesta di annientare la Macedo-nia Questi passi si prestano maggiormente a un confronto con le fonti parallele bencheacute con prudenza
Centrali nei due libri sono i cinque discorsi in oratio obliqua il primo egrave quello attribuito a Demetrio di Faro seguono tre di Filippo V men-tre lrsquoultimo egrave di Flaminino Poicheacute secondo Giustino (XXXVIII 3 11) Trogo utilizzava solamente lrsquooratio obliqua e avrebbe criticato aspramen-te Sallustio e Livio per lrsquoimpiego di numerosi discorsi in oratio recta i cin-que riportati nei libri XXIX e XXX sono stati considerati trasposizioni dellrsquooriginale trogiano3 In effetti tali discorsi fungono da ossatura del percorso narrativo dei due libri e sono da considerare le sezioni di que-sti libri piugrave vicine allrsquooriginale trogiano Sono perciograve i passi che offrono maggior possibilitagrave di studio per mettere in luce la presenza o lrsquoassen-za di una tradizione alternativa su Filippo V se questa sia giagrave in Trogo e quanto in quale modo e con quale interesse Giustino abbia interpolato tale tradizione Data la complessitagrave dei due libri ritengo opportuno ana-lizzare gli avvenimenti trattati seguendo la divisione in capitoli giustinea
Libro XXIX11-11 Introduzione
Il primo capitolo del libro XXIX si presenta con precisione nei riferi-menti coerenza testuale e attenzione ai dettagli Giustino probabilmen-te ricalcando le riflessioni di Trogo alla considerazione incipitale sul ge-nerale rinnovamento dei vertici degli imperi di lsquotutto il mondorsquo alla fine del III secolo aC fa seguire la lista dei nuovi re con alcuni commenti relativi ai singoli monarchi In particolare si sottolinea la giovane etagrave di tutti i sovrani e i condottieri al momento della loro ascesa al potere os-servazione ribadita nel commento finale al capitolo (XXIX 1 8)
His regibus pueris tametsi nulli senioris aetatis rectores erant tamen in suorum quisque maiorum uestigia intentis magna indoles uirtutis enituit
Questi re fanciulli sebbene non avessero guide di etagrave piugrave anziana tuttavia se-
3 Schlicher (1933) pp 289-300 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362 partic 1309 Adler (2006) pp 383-407 e Id (2011) pp 37-40 Recentemente Ballesteros Pastor (2013) pp 52-54 commentando il discorso di Mitridate (XXXVIII 4-7) ha ritenuto che Giustino abbia dichiarato il falso a proposito dellrsquooratio obliqua a suo avviso in Trogo ci sarebbero stati infatti numerosi discorsi diretti che poi Giustino avrebbe tragravedito come discorsi indiretti nellrsquoEpitome inserendo nel passaggio alcuni errori sintattici e incon-gruenze
IL DISCORSO DEL RE 123
guirono ciascuno con impegno le orme degli antenati e in loro rifulse un gran-de innato valore4
Questa introduzione sembra modellata sul cosiddetto lsquosecondo proe-miorsquo di Polibio (IV 2) la lista dei sovrani e lrsquoordine coincidono infatti con quello del Megalopolitano se non per lrsquoesclusione dellrsquousurpatore seleucide Acheo5 Lrsquointenzione del passo nelle due opere egrave perograve diver-sa mentre il Megalopolitano nel proemio metteva in risalto il sorgere quasi in contemporanea di nuovi conflitti in diverse parti del Mediter-raneo nellrsquoEpitome il filo conduttore di questo elenco di sovrani e con-dottieri egrave la loro gloria e la grandezza degli eventi che essi compirono in giovane etagrave6 Inoltre vi sono in Trogo alcune notizie originali rispetto al Megalopolitano il fatto che lrsquoepiteto Filopatore di Tolemeo IV sia mes-so in relazione con lrsquoassassinio dei genitori del sovrano oppure che lrsquoa-scesa di Annibale al comando dei Cartaginesi sia spiegata con il suo odio per i Romani Entrambe queste notizie non appartengono alla tradizio-ne polibiana in Polibio (II 36 3) Annibale era stato eletto comandante dellrsquoesercito in Spagna per i successi ottenuti mentre il padre Amilcare gli aveva fatto giurare odio eterno ai Romani Per quanto riguarda il Fi-lopatore Polibio ritiene che egli non abbia assassinato la madre Bereni-ce vittima invece del consigliere Sosibio (Polyb V 36 1)7 La versione di Trogo egrave dunque frutto di una propaganda avversa a Tolemeo IV che lo dipinge ancora piugrave negativamente di quanto fatto dalla tradizione poli-biana che certo giagrave non era favorevole al sovrano8
NellrsquoEpitome di Giustino segue una sintesi dei primi anni di regno di Filippo V in particolare vi egrave un brevissimo riferimento allrsquoinaspettata vit-toria del sovrano contro i Dardani che lo avrebbe portato a cercare lo
4 La traduzione di Giustino come tutte quelle presenti nel testo sono da Santi Amantini (1981) Lrsquounica eccezione a questa affermazione egrave il Filopatore Sulla tradizione storio-grafica avversa al Filopatore vd infra 5 Acheo egrave personaggio noto a Trogo che lo menziona altrove Prol XXX6 La giovinezza in TrogoGiustino egrave percepita come un valore aggiunto mentre per Poli-bio egrave una debolezza Eckstein (1995) p 143 McGing (2013) pp 181-1997 Muccioli (2013) pp 220-223 osserva che lrsquoepiteto fu assunto da Tolemeo IV quando il padre era vivo come strumento per sottolineare la sua predestinazione al trono 8 Polyb V 34 3-5 come anche Plut Cleom 33-34 forniscono notizie denigratorie su Tole-meo IV che sarebbe stato un sovrano inadatto a governare Secondo Huss (1976) pp 9 e 19 e (2001) pp 381-472 alla base vi sarebbe Filarco Se invece si considerano gli studi fatti su Tolemeo di Megalopoli da Schepens (1983) pp 351-368 e Zecchini (1990) pp 213-232 partic 218 egrave possibile che Tolemeo di Megalopoli nello scrivere unrsquoopera sto-riografica su un sovrano lagide non omettesse di menzionare notizie meno celebrative come Teopompo prima di lui aveva fatto nei confronti di Filippo II Sulla tradizione storiografica avversa a Tolemeo IV vd anche Marasco (19791980) pp 159-182 Weber (1997) pp 27ndash72 partic 28 Ager (2003) pp 35-50 McGing (2010) pp 117-119 Cri-scuolo (2011) pp 132-150 partic 148-149
124 MONICA DrsquoAGOSTINI
scontro con gli Etoli Egrave difficile dire se Trogo dedicasse piugrave spazio alla narrazione degli eventi tra il 220 e il 217 Nel Prologo si legge
Undetricensimo volumine continentur haec Res gestae Philippi regis adversus Dardanos et Aetolos repetitaeque inde Creticae origines post cuius insulae societatem Philippus cum Illyriis et Dardanis et rursus Aetolis bello congressus est adiuvantibus Aetolos Romanis quo finito intulit Attalo bellum
Il ventinovesimo libro contiene le imprese del re Filippo contro i Dardani e gli Etoli Sono quindi rievocate le origini di Creta dopo essersi alleato con questrsquoi-sola Filippo si scontrograve in guerra con gli Illiri i Dardani e di nuovo con gli Eto-li mentre i Romani soccorrevano gli Etoli Terminata questa guerra Filippo at-taccograve Attalo
Dal confronto tra Giustino e i Prologi egrave evidente che quella che per i mo-derni egrave la lsquoGuerra degli Alleatirsquo tra Etoli aiutati da Sparta e dallrsquoElide e la Lega Achea alleata di Filippo V sia ridotta sia in Giustino che in Tro-go a una guerra di Filippo contro gli Etoli Colpisce in effetti la comple-ta mancanza nel Prologo XXIX e nellrsquoEpitome del libro di qualsiasi men-zione e riferimento alla Lega Achea e al suo leader Arato protagonisti indiscussi invece nelle Storie polibiane dei primi anni di regno di Filippo V 9 Arato di Sicione importante statista e comandante militare della Le-ga Achea fu uno dei primi personaggi politici a scrivere e pubblicare le proprie memorie (FGrHist 231) di cui Polibio si servigrave ampiamente (I 3 1)10 Lo storico di Megalopoli era un compatriota di Arato e come lui ricoprigrave importanti cariche allrsquointerno della Lega Achea11 Polibio che considerava Arato uno dei fondatori della Lega vedeva in lui una sorta di eroe e leader ideale come emerge dalla descrizione che ne fa di uomo perfetto per lrsquoattivitagrave politica astuto tollerante coraggioso e di succes-so (IV 7 11-8 12) Il rapporto tra Filippo V e Arato egrave determinante per il giudizio di Polibio sul sovrano macedone Filippo egrave infatti descritto co-me un buon sovrano valoroso ma troppo giovane che nei primi anni di regno agigrave bene poicheacute ascoltograve e seguigrave i consigli di Arato (IV 77 1-4)12
Per quanto argumentum e silentio questa assenza di Arato di Sicione e della Lega Achea sia nel Prologo di Trogo che nellrsquoEpitome di Giustino
9 Polibio dedica alla Lega Achea ampia parte dei libri IV e V 10 Riguardo ad Arato di Sicione soprattutto nel rapporto con Polibio vd Meadows (2013) pp 91-116 Vd anche Walbank (1933) Misch (1949) pp 210-212 Urban (1979) Meister (1990) pp 187-189 Habicht (1995) pp 176-179 Beck - Eckstein (2015) sv laquoAratos of Sicyon (231)raquo in BNJ11 Sui legami di Polibio e la sua famiglia con la Lega Achea vd Eckstein (2013) pp 314-33812 Polyb IV 24 1-3 e V 26 6 seguito da Plut Arat 48-49 afferma esplicitamente che il re portava a termine abilmente i suoi piani poicheacute Arato era al suo fianco
IL DISCORSO DEL RE 125
non solo non puograve passare inosservata ma deve indurre i moderni a du-bitare per questi eventi di unrsquoapparente dipendenza diretta giagrave di Tro-go da Polibio
21- 38 Demetrio di Faro e Naupatto
Scomparso Arato nellrsquoEpitome XXIX ha invece un ruolo fondamentale in questi anni come consigliere di Filippo Demetrio di Faro a cui egrave at-tribuito il primo discorso in oratio obliqua dei due libri esaminati13
Demetrio di Faro era un dinasta illirico che si incontra per la prima volta nelle fonti storiografiche in occasione della prima guerra di Ro-ma in Illiria nel 229 Sappiamo infatti da Polibio (II 10 8-11 4) e Appia-no (Illyr 7) che Demetrio giagrave alleato di Teuta sovrana degli Illiri aveva scelto di passare dalla parte romana ed era stato poi ricompensato dal Senato con il controllo di parte dei territori sottratti da Roma a Teuta stessa Nei suoi tentativi di ritagliarsi un ruolo importante nella penisola balcanica Demetrio nel 222 si era alleato con la Lega Ellenica di Doso-ne e Arato a Sellasia contro Cleomene (Polyb II 65 2- 5) ma negli an-ni successivi le sue scorribande nellrsquoAdriatico allarmarono Roma che gli mosse guerra (Polyb III 16 IV 16)14 Sconfitto da Roma e cacciato da Faro Demetrio si rifugiograve alla corte di Filippo intorno al 218 diventan-do consigliere del re
Poicheacute nel Prologo XXVIII si legge laquoIn una digressione egrave narrata la guerra illirica combattuta dai Romani contro Teuta15raquo non egrave da esclu-dere che Trogo giagrave citasse il dinasta di Faro anche se la prima menzio-ne di Demetrio in Giustino egrave a XXIX 2 1 quando il cosiddetto lsquore de-gli Illirirsquo cacciato da Lucio Emilio Paolo dallrsquoAdriatico arrivograve alla corte macedone Nel riassunto degli eventi Giustino segue piugrave da vicino Tro-go riportando il discorso del dinasta a Filippo V per convincere il sovra-no a far guerra a Roma (XXIX 2 2-6) I punti principali di tale discorso sono che i Romani aspirano a realizzare un impero universale a scapito di tutti i re laquocome se fosse cosa illecita che ci fosse un qualche re presso i confini del loro Statoraquo Perciograve Filippo V doveva prepararsi alla guerra con i Romani poicheacute laquoquanto piugrave accessibile e illustre era il suo regno tanto piugrave accaniti nemici gli sarebbero stati i Romani16raquo Demetrio vole-
13 Su questi discorsi di Demetrio vd Coppola (1993) pp 29-5114 Coppola (1993) pp 29-51 vd anche Hammond (1968) pp 1-21 Eckstein (2008) pp 41 58-60 Demetrio di Faro era presentato in Polibio come il rivale di Arato tra i consi-glieri di Filippo Polyb IX 23 9 infatti dichiara che quando il sovrano seguiva i consigli di Arato compiva grandi imprese mentre quando ascoltava Demetrio si macchiava di atti spregevoli15 Trog Prol XXVIII Dictum in excessu bellum Illyricum quod Romani gessere cum Teuta16 Iust XXIX 2 4-5 sibi quoque non aliam ob causam quam quod Italiae finitimus uidebatur
126 MONICA DrsquoAGOSTINI
va infatti cacciare i Romani dalla sponda adriatica dellrsquoIlliria territorio che avrebbe ceduto a Filippo
Il discorso di Demetrio a Filippo egrave presente anche in Polibio (V 101 8-1017) ed egrave inserito cronologicamente durante i giochi Nemei18 nel 217 subito dopo la sconfitta romana del lago Trasimeno ricordata an-che nel passo di Giustino Nel discorso polibiano Demetrio perograve sotto-linea il diritto di Filippo V ad aspirare al dominio universale a partire dallrsquoAdriatico19 mentre nel discorso trogiano Demetrio accusa i Roma-ni di aspirare ad espandersi travolgendo qualsiasi regno sul loro cammi-no Trogo nel discorso di Demetrio presenta il coinvolgimento roma-no in Oriente come una guerra di conquista che contrappone la giova-ne potenza romana allrsquolsquoillustre regnorsquo di Filippo20 prospettiva che ritor-na nel successivo discorso di Filippo V nellrsquoEpitome ma che egrave estranea al-la narrazione di Polibio
Dopo il discorso di Demetrio nellrsquoEpitome come in Polibio (V 104 1) si arriva allrsquoincontro di pace di Naupatto nel 217 che pose fine al-la Guerra degli Alleati tra Etoli Spartani ed Elei contro la lega Achea e
bellum inlatum quasi nefas esset aliquem regem iuxta imperii eorum terminos esse Sed et ipsi cauen-dum esse exemplum cuius quanto promptius nobiliusque sit regnum tanto sit Romanos acriores hostes habiturus17 Polyb V 101 8-10 ὃς καὶ λαβόμενος τῆς ἀφορμῆς ταύτης τὸν μὲν πρὸς τοὺς Αἰτωλοὺς ᾤετο δεῖν τὴν ταχίστην ἀπορρῖψαι πόλεμον ἀντέχεσθαι δὲ τῶν κατὰ τὴν Ἰλλυρίδα πραγμάτων ἠξίου καὶ τῆς εἰς Ἰταλίαν διαβάσεως [9] τὰ μὲν γὰρ κατὰ τὴν Ἑλλάδα πάντα καὶ νῦν ἤδη ποιεῖν αὐτῷ τὸ προσταττόμενον ἔφη καὶ μετὰ ταῦτα ποιήσειν Ἀχαιῶν μὲν ἐθελοντὴν εὐνοούντων Αἰτωλῶν δὲ καταπεπληγμένων ἐκ τῶν συμβεβηκότων αὐτοῖς κατὰ τὸν ἐνεστῶτα πόλεμον [10] τὴν δ᾽ Ἰταλίαν ἔφη καὶ τὴν ἐκεῖ διάβασιν ἀρχὴν εἶναι τῆς ὑπὲρ τῶν ὅλων ἐπιβολῆς ἣν οὐδενὶ καθήκειν μᾶλλον ἢ ᾽κείνῳ τὸν δὲ καιρὸν εἶναι νῦν ἐπταικότων Ῥωμαίων Trad da Mari (2002) laquoCostui allora cogliendo lrsquooccasione gli consigliograve di interrompere al piugrave presto la guerra con gli Etoli e gli chiese di impegnarsi nelle operazioni in Illiria e nellrsquoattraversamento del mare verso lrsquoItalia Disse che infatti giagrave ora tutta la Grecia eseguiva i suoi ordini e lo avrebbe fatto anche in seguito poicheacute gli Achei lo sostenevano di loro iniziativa mentre gli Etoli erano rimasti molto colpiti da quanto era loro avvenuto nella guerra in corso e aggiunse che lrsquoItalia e lrsquoattraversamento del mare in quella direzione erano lrsquoinizio di un disegno di dominio universale che a nessuno spettava piugrave che a lui ora era il momento opportu-no visto che i Romani erano stati battutiraquo18 I giochi Nemei in onore di Zeus erano giochi panellenici celebrati in Argolide negli anni pari delle Olimpiadi 19 Secondo Eckstein (1995) pp 211-212 tale aspirazione egrave connessa allrsquoincapacitagrave di mo-derazione nella vittoria del sovrano Sul concetto di dominio universale in Polibio vd Musti (1978) pp 16-18 Eckstein (2008) pp 217-220 e 372-38120 Adler (2006) pp 383-407 e (2011) pp 37-58 ha notato che i punti principali del discorso di critica allrsquoespansionismo romano di Demetrio ritornano in altri due discorsi dellrsquoEpitome quello degli Etoli (XXVIII 2 1-13) e quello di Mitridate (XXXVIII 4-7) la prioritagrave data a questi argomenti da tale reiterazione retorica indica che lrsquointeresse giagrave di Trogo se non dellae suae fontei non fosse la celebrazione dellrsquoascesa di Roma allrsquoim-pero universale come in Appiano ma piuttosto lrsquoascesa e la discesa dei regni ellenistici
IL DISCORSO DEL RE 127
Filippo V 21 Il testo giustineo omette le circostanze dellrsquoevento non si menzionano infatti esplicitamente neacute il luogo dellrsquoincontro Naupatto neacute le fasi delle trattative neacute i vari rappresentanti dei diversi fronti che vi presero parte I lunghi negoziati di pace si risolvono dunque nel discor-so di Filippo V ai rappresentanti dei fronti
Il sovrano esordisce affermando che la Grecia egrave in grande pericolo percheacute chiunque avesse vinto tra Cartaginesi e Romani sarebbe poi pas-sato in Oriente Filippo utilizza la metafora delle nubi in Occidente che avrebbero macchiato con una pioggia di sangue ogni cosa spinte dai venti di vittoria inoltre il sovrano ritiene che le guerre passate dei Gre-ci siano di poco conto se paragonate alla minaccia di uno scontro con la moltitudine che si radunava in Italia descrivendo la rabbia e il valore di questi nuovi nemici che avrebbero portato rovina ai vicini Il sovrano infine ribadisce che la Grecia era in maggior pericolo della Macedonia ma che sapeva che chi avesse vinto in Italia non avrebbe frenato la sete di vittoria Perciograve anche la Macedonia stessa doveva temere un attacco
Il discorso in Polibio di Agelao di Naupatto rappresentante e leader degli Etoli22 mostra le medesime argomentazioni attribuite in Giustino allrsquointervento di Filippo argomentazioni fondate sul metus hostilis e fina-lizzate a promuovere un nuovo ruolo della Macedonia sia in Grecia che nel Mediterraneo Orientale Agelao proponendo un nuovo program-ma politico panellenico fonda le proprie argomentazioni sul metus hosti-lis per i Cartaginesi e i Romani presentati metaforicamente come nubi che incombono da Occidente Filippo dovrebbe farsi garante della tran-quillitagrave della Grecia che agendo come unrsquounica catena di cittagrave contro i barbari diverrebbe una sicura e fedele collaboratrice della Macedonia Questo permetterebbe ai Greci di conservare il diritto di far pace o guer-ra a loro piacimento senza temere che laquoi giochi da bambini con i quali ci trastulliamo tutti vengano troncati23raquo
Nonostante sia il medesimo discorso nelle due fonti Agelao introdu-ce una forte proposta di alleanza panellenica estranea alle parole di Fi-lippo Inoltre Filippo pur utilizzando la metafora delle nubi da Occi-
21 Interessanti le osservazioni di Scholten (2000) pp 224-228 a proposito della pace che sarebbe stata cercata e sperata da entrambe le parti e non imposta da Filippo come Polibio pare lasciar intendere 22 Vd soprattutto Leacutevy (1994) pp 33-50 Su questo discorso molto dibattuto dai moderni vd anche Schmitt (1989) pp 229-239 Vollmer (1990) pp 96-107 Coppola (1993) pp 149-164 Golan (1995) pp 55-74 Champion (1997) pp 111-128 e (2004) p 55 Wal-bank (2002) pp 127-136 Eckstein (2008) pp 78-83 23 Polyb V 104 10-11 καθόλου τὰς παιδιάς ἃς νῦν παίζομεν πρὸς ἀλλήλους ἐκκοπῆναι συμβῇ πάντων ἡμῶν ἐπὶ τοσοῦτον ὥστε κἂν εὔξασθαι τοῖς θεοῖς ὑπάρχειν ἡμῖν τὴν ἐξουσίαν ταύτην καὶ πολεμεῖν ὅταν βουλώμεθα καὶ διαλύεσθαι πρὸς ἀλλήλους καὶ καθόλου κυρίους εἶναι τῶν ἐν αὑτοῖς ἀμφισβητουμένων
128 MONICA DrsquoAGOSTINI
dente presente anche nelle Storie la arricchisce con la vivida immagine di una tempesta di sangue conferendo una dimensione piugrave concreta e cruenta alla predizione infine il riferimento polibiano alle guerre dei Greci nellrsquoEpitome non riguarda piugrave le guerre tra le cittagrave e le leghe gre-che ma le guerre dei Greci con Macedoni Persiani e Galli Mentre la Grecia scompare sullo sfondo la minaccia Romana egrave meno vaga e piugrave concreta e presente che in Polibio e diventa lrsquounico argomento del di-scorso di Filippo V a Naupatto
Il discorso di Demetrio e quello di Filippo sono al centro del libro XXIX dellrsquoEpitome avendo il duplice scopo di evidenziare sia la poten-ziale aggressivitagrave dei Romani sia la grande tradizione militare della Ma-cedonia e il pieno diritto di Filippo di controllare la Grecia e lrsquoIlliria fi-no allrsquoAdriatico Se il discorso in Polibio si inseriva in un dibattito politi-co dove la Grecia e la Macedonia erano protagoniste alla pari della sce-na ellenica e internazionale nella versione che leggiamo in Trogo i ri-ferimenti alle dispute della realtagrave greca sono reinterpretati a favore di un punto di vista in cui la Macedonia egrave lrsquounico potere dellrsquoOriente gre-co Del dibattito politico di III secolo in Grecia che tanto stava a cuore a Polibio non vi egrave piugrave alcuna traccia in TrogoGiustino rimane soltanto lo scontro tra le due grandi potenze di Oriente e Occidente tra Filippo e Roma Questa prospettiva bipolare dei discorsi trogiani si ritrova nel-la conclusione del capitolo che se da un lato sottolinea ancora una vol-ta il timore di Filippo per Cartaginesi e Romani dallrsquoaltro esplicita che i Romani avevano paura dellrsquoantica gloria dei Macedoni laquovincitori dellrsquoO-rienteraquo e soprattutto di Filippo laquoinfiammato dallo zelo di emulare Ales-sandro che era ben noto come pronto alle guerre e instancabileraquo24
41-11 La Prima Guerra Macedonica
Dei prodromi della Prima Guerra Macedonica Giustino si interessa sol-tanto allrsquoalleanza antiromana tra Annibale e Filippo Questo trattato egrave noto da molte fonti secondo cui Filippo dopo aver appreso che i Roma-ni erano stati sconfitti di nuovo dai Cartaginesi a Canne nel 216 avreb-be mandato unrsquoambasceria ad Annibale per proporre unrsquoalleanza ma lrsquoambasciatore macedone sarebbe stato catturato da Roma sulla via del ritorno25
24 Iust XXIX 3 8 quippe terrebat eos et uetus Macedonum deuicti Orientis gloria et Philippus studio Alexandri aemulationis incensus quem promptum in bella industriumque cognouerant Alla gloria dei Macedoni avevamo giagrave trovato riferimento nei discorsi del libro XXVIII degli Etoli (2 12) e di Antigono Dosone (3 14) 25 Secondo Polyb VII 9 17 Filippo avrebbe aiutato Cartagine nella guerra con Roma in cambio di Corcira Epidamno e Apollonia e della restituzione a Demetrio di Faro del suo regno Inoltre Filippo e Annibale si impegnavano a soccorrersi a vicenda in caso di
IL DISCORSO DEL RE 129
A prescindere dai dettagli del fermo dellrsquoambasciatore macedone da parte romana egrave possibile fare qualche osservazione sul nesso tra questo lsquoincidentersquo diplomatico e lo scoppio della guerra Cassio Dione e Ap-piano riportano che la cattura del legato avrebbe causato una vendetta di Filippo contro i protettorati romani in Adriatico in particolare Cor-cira26 notizia assente in Polibio come in Livio e Plutarco (che da Poli-bio dipendono)27 In questi ultimi autori lrsquoattacco di Filippo in Adriati-co infatti non sarebbe legato allrsquoepisodio dellrsquoambasciatore ma alla de-cisione del sovrano di rompere con il consigliere Arato e di dare ascol-to ai cattivi consigli di Demetrio di Faro presa dopo la spedizione a Mes-sene nel 215214 La tradizione polibiana legge infatti in questi eventi la manifestazione del cambiamento dellrsquoindole di Filippo V da giusta a empia iniziata con lrsquoepisodio della stasis di Messene del 215 e compiu-ta con lrsquoassassinio di Arato del 21328 Nel libro XXIX di Giustino ben-cheacute si conservi traccia dellrsquoindole aggressiva di Filippo e del consiglio di Demetrio di Faro come prodromi dello scontro con Roma non vi sono indizi della metaboleacute del sovrano da giusto a empio e malvagio e neppu-re del ruolo che in tale cambiamento ricoprigrave lrsquoallontanamento tra Ara-to e Filippo
attacco da parte di Roma Mentre Peacutedech (1964) pp 382-383 ritiene sicura la consulta-zione a Roma di tali documenti Zecchini (2003) pp 123-141 come prima di lui Walbank (1957) I p 32 n 4 non ne egrave certo poicheacute Polibio viaggiograve proprio per poter reperire documenti e informazioni sugli eventi dove essi avvennero Altre fonti Liv XXIII 38 7 Plut Arat 51 2 Dio C XV 4 2 e App Mak Fr 1 Sul confronto delle fonti vd DrsquoAgostini (2011) pp 99-121 Sul trattato macedone-cartaginese vd Cassola (1962) pp 65-66 Wal-bank (1967) II pp 42-44 Will (19822) pp 83-84 Barreacute (1983) Longaretti (1989) pp 183-192 Golan (1995) pp 45-46 Eckstein (2008) pp 83-85 Intrieri (2011) pp 53-8226 Dio C XV 4 2 e App Mak Fr1 Filippo per vendicarsi della cattura del proprio amba-sciatore non solo attaccograve Corcira ma saputo dellrsquoarrivo di Levino durante la ritirata da Corcira saccheggiograve anche Apollonia e Orico alleate romane Levino avrebbe poi sconfit-to Filippo e recuperati gli alleati costringendo il re a bruciare le proprie navi e rientrare via terra Si riferisce a questo episodio probabilmente il Mak Fr 9 di Appiano che riporta lrsquoordine di Filippo di uccidere quanti erano sulle navi percheacute non dicessero ai Romani che le forze macedoni erano stremate DrsquoAgostini (2011) pp 99-12127 Polyb V 108-110 Liv XXIV 40 e Plut Arat 51 2 non menzionano Corcira nella narra-zione dellrsquoalleanza macedone-cartaginese e della cattura dellrsquoambasciatore Secondo Liv XXIII 38 7 lrsquoambasciatore sarebbe stato trattenuto a Roma 28 Polyb VII 11 8-11 e Plut Arat 49 1 Coppola (1993) pp 205-210 Dai frammenti di Polyb VII 10-12 e dalla narrazione di Plut Arat 49-51 sappiamo che Filippo era interve-nuto nella stasis di Messene tra oligarchici e democratici ma aveva di nascosto lasciato che i cittadini si massacrassero Una volta giunto Arato la guerra civile fu finalmente sedata ma il sovrano avrebbe voluto su consiglio di Demetrio di Faro approfittare della situazione e imporre una guarnigione nellrsquoacropoli della cittagrave che gli avrebbe conferito un vantaggio strategico per il controllo del Peloponneso Arato dissuase Filippo da per-seguire unrsquoazione militare in Peloponneso ma il re decise su consiglio di Demetrio di rivolgere la sua aggressivitagrave verso lrsquoIlliria prima e i protettorati romani Orico e Apollonia poi
130 MONICA DrsquoAGOSTINI
Dopo aver accennato alla stipula del trattato Giustino affastella ne-gli ultimi paragrafi del capitolo 4 gli eventi tra il 215 e il 205 quando Fi-lippo siglando la pace con Roma pone fine alla Prima Guerra Macedo-nica29 In particolare lrsquoEpitomatore sottolinea da un lato lrsquoingresso in guerra degli Etoli al fianco dei Romani e la successiva alleanza del preto-re Levino con Attalo dallrsquoaltro gli attacchi subiti da parte dei Dardani da Filippo oppresso dalle richieste degli Illiri Il libro dunque si chiude con Filippo in difficoltagrave aggravate dalla comparsa di Filopemene il leader degli Achei30 urtatosi con il re dei Macedoni convince la Lega Achea a staccarsi dallrsquoalleanza con la Macedonia sempre piugrave isolata Tale allon-tanamento egrave considerato da Giustino lrsquoesito di un fallito agguato a Fi-lopemene commissionato da Filippo V e dovuto al sospetto di un tradi-mento del condottiero acheo a favore di Roma Bencheacute anche Plutarco (Fil 12 2) e Pausania (VIII 50 4) menzionino il tentativo di assassinio di Filopemene da parte di Filippo la notizia dellrsquoatteggiamento filoroma-no del generale acheo non parrebbe vicino al ritratto polibiano che ve-de in Filopemene un eroe dellrsquoautonomia e dellrsquoindipendenza achea31
Libro XXX11-39 Cinoscefale
Lrsquoesordio del libro XXX introducendo il grande scontro di Cinoscefale tra Romani e Macedoni riprende la celebrazione della gloria macedo-ne argomento centrale dei discorsi del libro XXIX Con lrsquoeccezione dei primi capitoli sul deplorevole comportamento di Tolemeo IV in Egit-to32 il libro egrave infatti totalmente dedicato allo scontro tra le due potenze
29 Errington (2008) pp 185-190 La guerra egrave nota a noi soprattutto dai frammenti dei libri VIII-XI di Polibio dai passi di Liv XXIV 40 1-17 XXVI 24 1-26 4 XXVII 30 5-33 5 e XXVIII 5 1- 9 1 XXIX 12 1-15 e dalla Vita di Filopemene di Plutarco La sinteticitagrave del riassunto giustineo impedisce un puntuale paragone delle tradizioni Ad esempio la notizia dellrsquoalleanza tra Attalo e Roma sembra tornare in Liv XXVIII 5 1-4 dove perograve non troviamo Levino ma Sulpicio come rappresentante romano personaggio scompar-so in Giustino In maniera simile la pace di Fenice del 205 egrave sintetizzata in Giustino in una riga e non vi egrave traccia delle lunghe trattative che coinvolsero come mediatori anche Egitto Chio Mitilene e Atamania portarono a una prima pace separata tra Filippo e gli Etoli nel 206 e poi alla pace con Roma Le fonti parallele sono molto piugrave dettagliate anche su questi eventi Polyb XI 4 1-6 9 Liv XXVIII 5 13 e XXIX 12 8-16 e App Mak fr III Degno di nota egrave perograve il commento in Giustino secondo cui laquoi Romani erano per il momento soddisfatti di aver rinviato la guerra contro la Macedoniaraquo Lrsquointenzione ro-mana di riprendere la guerra con la Macedonia egrave infatti presente in tutte le fonti Polyb XI 6 7 Liv XXIX 1216 Dio C XVIII 9 (15) e App Mak Fr III e verragrave ripresa al libro XXX dellrsquoEpitome 30 Su Filopemene e Filippo vd Errington (1969) pp 51-69 e 83-84 vd anche Golan (1995) pp 115-132 Eckstein (2008) pp 103 e 360-36131 Pelling (1997) pp 135-13932 Lrsquoesordio del libro XXX egrave dedicato alle scabrose imprese del sovrano egiziano ovvero
IL DISCORSO DEL RE 131
dellrsquoEst e dellrsquoOvest La prima avvisaglia dellrsquoincombente guerra egrave la no-tizia dellrsquoaccordo di Filippo V e Antioco III per la spartizione dellrsquoEgitto governato dal sovrano-bambino Tolemeo V Il sovrano lagide nel 2032 chiese aiuto ai Romani che secondo TrogoGiustino gradirono la ri-chiesta drsquoaiuto percheacute cercavano pretesti per muovere guerra contro Fi-lippo A partire da Polibio numerose altre fonti ci testimoniano questo episodio mettendolo in relazione con lo scoppio della Seconda Guerra Macedonica ed esprimendo una condanna morale per lrsquoempia condotta del re antigonide che cospira contro un bambino33 al contrario nellrsquoE-pitome si esalta la potenza macedone evidenziando la paura dei Romani delle grandi imprese di Filippo (XXX 3 2)
nullius magis arma metuebant reputantibus quantum motum Pyrrhus parua Macedo-num manu in Italia fecisset quantasque res Macedones in Oriente gessissent
di nessun altro temevano maggiormente le armi poicheacute ripensavano a quanto sconvolgimento Pirro aveva provocato in Italia con una piccola schiera di Ma-cedoni e a quanto grandi imprese i Macedoni avevano compiuto in Oriente
La supremazia macedone egrave anche al centro del discorso in oratio obliqua di Filippo allrsquoincontro nel Golfo Maliaco tra i rappresentanti dei fronti coinvolti nella Seconda Guerra Macedonica34 NellrsquoEpitome infatti dopo
la Quarta Guerra Siriaca conclusa con sconfitta a Rafia contro Antioco III nel 217 e la corruzione del sovrano da parte di Agatocle e della sorella una cortigiana che avrebbe sedotto il re Giustino riferisce poi la morte del sovrano nel 204 e lrsquoascesa al trono del piccolo Tolemeo V Epifane sovrano sotto tutela di Tlepolemo dopo la morte di Agatocle e Sosibio 33 Eckstein (2008) pp 121-180 Thornton (2014) pp 65-88 In particolare sulla relazione tra il complotto e la sconfitta antigonide e seleucidica ad opera di Roma la superioritagrave morale romana ai regni ellenistici e la causalitagrave storica in Polibio (XV 20 6) vd Eck-stein (2008) pp 133-138 Ager (2009) pp 15-43 Landucci Gattinoni (2011) pp 89-105 Secondo Polyb III 2 8 XV 20 XVI 1 8-9 seguito da Liv XXXI 14 5 Filippo avrebbe ottenuto le basi tolemaiche in Egeo Samo e la Caria mentre Antioco avrebbe finalmente avuto mano libera in Celesiria e Fenicia oggetto di quasi un secolo di lotte tra Tolemei e Seleucidi La notizia del trattato permette a Polibio di dedicare alcuni paragrafi (XV 20) a condannare aspramente lrsquooperato di Filippo V e Antioco III definendoli empi e senza pudore e dichiarando che la Fortuna punigrave i due sovrani per il loro crudele operato por-tando i Romani contro di loro vd infra App Mak Fr IV trasmette delle clausole secondo cui Antioco avrebbe avuto lrsquoEgitto e Cipro mentre Filippo avrebbe ottenuto Cirene le Cicladi e la Ionia Infine secondo Porfirio FGrHist 260 F 45 lrsquoaccordo prevedeva che i due sovrani annettessero i possedimenti tolemaici confinanti con i rispettivi regni 34 Prima si menziona unrsquoambasceria del Senato a Filippo e Antioco percheacute laquosi astenessero dallrsquoEgittoraquo e la visita di Lepido in Egitto Quindi le lamentele a Roma di Attalo e i Rodii nei confronti di Filippo Egrave probabile che a questo punto Trogo inserisse la campagna di Filippo in Asia contro Attalo menzionata nel Prologo XXX ma tagliata nellrsquoEpitome La cronologia degli scambi diplomatici precedenti la Seconda Guerra Macedonica egrave stra-volta dalla sintesi dellrsquoEpitomatore e rende impossibile qualsiasi confronto con le altre
132 MONICA DrsquoAGOSTINI
il riassunto delle ambascerie nel Mediterraneo preludio allo scontro della prima fase della guerra35 maggior spazio egrave dato al tentativo di pa-ce a Nicea tra Roma Attalo i Rodii gli Achei e gli Etoli e Filippo V nel 198 In questa occasione Filippo rivendica la posizione di dominio dei Macedoni sui Greci ereditata da Filippo II e Alessandro suoi antenati e in virtugrave di tale supremazia macedone rifiuta che i Greci gli dettino le condizioni di pace ma chiede che sia il Senato a decidere Egrave significati-vo che non solo il discorso di Filippo non compaia in nessuna delle fon-ti parallele che descrivono nel particolare le posizioni degli ambasciato-ri di Achei Etoli Rodii e Attalo ma che Polibio (XVIII 8 8)36 affermi che era difficile sapere cosa si fossero detti Filippo e Flaminino durante i colloqui nel Golfo Maliaco Secondo la tradizione polibiana infatti il sovrano accompagnato da due philoi macedoni Apollodoro e Demoste-ne chiese di allontanare dalle trattative tutti tranne i Romani e discus-se la pace solamente con Flaminino Successivamente a causa dellrsquoinca-pacitagrave di trovare un accordo Filippo chiese due mesi di tregua e lrsquointer-vento del Senato Trogo dunque restituisce il discorso che il resto della tradizione riteneva impossibile da conoscere indicando chiaramente la presenza di una fonte diversa rispetto a Polibio su questo avvenimento piugrave informata sul punto di vista di Filippo e interessata a evidenziare la convinzione di Filippo V di avere un diritto di supremazia sulla Grecia in virtugrave delle imprese di Filippo II e Alessandro
La battaglia di Cinoscefale nel 197 momento risolutivo dello scontro tra Roma e Macedonia egrave lrsquoevento principale del libro XXX omina e pre-sagi introducono lrsquoevento campale lrsquoeruzione del vulcano di Santorini
fonti In Polyb XVI 24 3 App Mak Fr IV Liv XXXI 1 10 21 5 5 Paus I 36 5-6 vi sono differenti versioni della sequenza delle ambascerie che denunciarono a Roma lrsquoe-spansionismo macedone ma tutte concordano che le ambascerie precedettero lrsquoinvio dei legati romani in Oriente e che esse furono inviate anche da Atene e dagli Etoli Inoltre secondo la tradizione polibiana (Polyb XVI 27 1-4 34 1-7 Liv XXXI 2 3 6 3-8 4 18 1-9 Diod XXVIII 6) vi furono due diverse ambascerie di cui la seconda sarebbe stato un ultimatum al sovrano recapitato da Lepido In occasione di questa seconda ambasceria avvenuta durante il cruento assedio di Abido Filippo avrebbe detto che i Macedoni in ca-so di guerra si sarebbero difesi con valore In Giustino si puograve notare che ancora una volta dagli eventi sono omesse notizie fondamentali sui Greci nello specifico lrsquoambasceria di Atene la cui disputa con gli Acarnani fu il casus belli della guerra contro Filippo 35 Come i prodromi anche la prima parte della Seconda Guerra Macedonica egrave sintetizza-ta in Giustino e occupa solamente due paragrafi Come spesso accade nei passi sintetiz-zati dallrsquoEpitomatore si trovano le incongruenze maggiori con le fonti parallele tra cui si nota soprattutto la completa omissione di Giustino delle campagne di Publio Sulpicio Galba Massimo di Villio delle vittorie di Tito e Lucio Flaminino e dellrsquoassemblea del 198 che portograve gli Achei ad allearsi con Roma Polyb XXII e Liv XXXI 14 1- 46 16 XXXII 1 1-25 12 App Mak Fr VII Plut Fil 17 4 Flam 5 4 e Paus VII 8 1-236 Le trattattive sono descritte con particolari in Polyb XVIII 1-12 seguito da Liv XXXII 32 6-36 10 e Plut Flam 5 8 e 7 1-3
IL DISCORSO DEL RE 133
nel 197 e lrsquoemergere dellrsquoisola di Hiera e in contemporanea il terremo-to a Rodi Quindi nellrsquoEpitome si annuncia che laquoil nascente impero dei Romani avrebbe divorato quello antico dei Greci e dei Macedoni37raquo Nel passo ricevono spazio soprattutto i due discorsi contrapposti del re ma-cedone Filippo e del comandante romano Flaminino pronunciati pri-ma dello scontro campale e costruiti ciascuno in modo da celebrare le imprese delle due potenze38 Lrsquoenfasi data dalla contrapposizione reto-rica delle parole dei generali egrave tale da rendere suggestiva lrsquoipotesi che lo scontro dovesse essere il momento centrale non solo del libro XXX ma forse di tutta lrsquoopera trogiana
Filippo elenca le grandi vittorie del passato dei Macedoni contro Per-siani Battriani Indiani e le popolazioni drsquoAsia fino allrsquoestremo Orien-te esortando i suoi a combattere con valore percheacute laquola libertagrave egrave piugrave cara del predominio39raquo Il discorso di Flaminino egrave invece piugrave lungo articola-to in un paragone tra Macedoni e Romani alle passate imprese di con-quista macedoni vengono contrapposte le piugrave recenti vittorie romane a Cartagine in Sicilia Italia e Spagna alla grandezza di Alessandro Ma-gno egrave contrapposta quella di Annibale che pure dai Romani era stato sconfitto Lrsquoattenzione poi si concentra su Filippo i Macedoni non laquodo-vevano essere valutati per lrsquoantica forza ma per le forze attuali40raquo poicheacute Filippo non era lrsquoinvitto e invincibile Alessandro Magno ma un ragaz-zo che non riusciva a difendere i propri confini I Macedoni rivendica-vano il valore degli antenati mentre i Romani quello dei propri soldati poicheacute quelli che erano ligrave schierati erano gli stessi che avevano sconfitto Annibale Dopo una cosigrave grandiosa introduzione la battaglia egrave descritta in uno dei paragrafi piugrave significativi di tutta lrsquoopera
His adhortationibus utrimque concitati milites proelio concurrunt alteri Orientis alteri Occidentis imperio gloriantes ferentesque in bellum alii maiorum suorum antiquam et ob-soletam gloriam alii uirentem recentibus experimentis uirtutis florem [16] Sed Macedo-nas Romana Fortuna uicit
I soldati incitati da queste esortazioni dallrsquouna e dallrsquoaltra parte si lanciaro-no nel combattimento vantandosi gli uni del dominio dellrsquoOriente gli altri dellrsquoOccidente e recando in guerra gli uni lrsquoantica e sbiadita gloria dei loro an-
37 Iust XXX 4 4 Quo prodigio territis omnibus uates cecinere oriens Romanorum imperium uetus Graecorum ac Macedonum uoraturum38 Sui discorsi precedenti la battaglia nellrsquoantichitagrave se da considerare reali o costruzioni storiografiche vd Adler (2011) pp 6-839 Iust XXX 4 7 tantoque hoc bellum fortius quam illa sustinendum quanto sit imperio libertas carior40 Iust XXX 4 10 Sed nec Macedonas ueteri fama sed praesentibus uiribus aestimandos
134 MONICA DrsquoAGOSTINI
tenati gli altri il fiore del loro valore fresco e vigoroso per le recenti prove Ma la Fortuna dei Romani vinse i Macedoni
Questo punto di vista probabilmente giagrave trogiano contrappone la virtugrave romana (virtutis flos) celebrata nei discorsi antecedenti la battaglia al-la Fortuna romana (Romana Fortuna) che decise la vittoria interpretabi-le come destino favorevole o buona stella Piugrave che unrsquoaffermazione anti-romana41 come egrave spesso stata intesa si puograve evidenziare il carattere sim-patetico della fonte verso Filippo V destinato a porre fine alla gloria di Filippo II e Alessandro e forse un approccio nostalgico verso i grandi regni macedoni la cui egravera egrave ormai giunta alla fine Tale prospettiva egrave as-sente in Polibio e nella tradizione che da lui dipende poco interessata alle vicende della gloria macedone leggendo infatti i frammenti soprav-vissuti del libro XVIII delle Storie dopo lrsquoaccurata descrizione della bat-taglia (18-33 e 34-40)42 Polibio commenta lo scontro affermando che avrebbe dedicato alcuni capitoli allrsquoesame delle strategie militari delle due armate percheacute (XVIII 28 4-6)
χρήσιμον καὶ καλὸν ἂν εἴη τὸ τὴν διαφορὰν ἐρευνῆσαι καὶ παρὰ τί συμβαίνει Ῥωμαίους ἐπικρατεῖν καὶ τὸ πρωτεῖον ἐκφέρεσθαι τῶν κατὰ πόλεμον ἀγώνων [5] ἵνα μὴ τύχην λέγοντες μόνον μακαρίζωμεν τοὺς κρατοῦντας ἀλόγως καθάπερ οἱ μάταιοι τῶν ἀνθρώπων ἀλλ᾽ εἰδότες τὰς ἀληθεῖς αἰτίας ἐπαινῶμεν καὶ θαυμάζωμεν κατὰ λόγον τοὺς ἡγουμένους
Puograve essere cosa buona e utile esaminare le differenze e per quale motivo i Ro-mani prevalgono e riportano il primo premio nelle competizioni di guerra af-fincheacute non esaltiamo i vincitori senza una ragione parlando solo di fortuna co-me fanno gli sciocchi ma conoscendo le vere cause lodiamo e ammiriamo i co-mandanti seguendo una logica
Polibio dunque sembra rispondere a coloro che parlavano della buo-na stella dei Romani sottolineando che la vittoria nasceva dalla superio-re strategia militare della legione43 Un punto di vista quindi opposto a quello espresso nellrsquoEpitome che proprio di Romana Fortuna parla e riba-dito in chiusura al passo dove Polibio critica nuovamente quei Greci che ritenevano la vittoria romana incredibile (XVIII 32 13)
41 Urban (1982) pp 1424-1443 1435 Richter (1987) p 19 n 4 Alonso-Nuacutentildeez (1992) p 66 e Id (2002) pp 105-110 partic 108-109 Contra Heckel (1997) p 29 che ridimen-siona la categorizzazione di Trogo come storico anti-romano 42 Su Cinoscefale vd Walbank (1957) ad l Hammond (1988) pp 60-82 Sklenaacuter (2004) pp 302-310 Thornton (2014) pp 83-87 43 Sulla Fortuna in Polibio vd McGing (2010) pp 195-201 (con bibliografia) che distin-gue tra quando Polibio intenda caso e quando predeterminazione fato Vd anche Green (1990) pp 400-402 e Eckstein (2008) pp 132-138
IL DISCORSO DEL RE 135
Il punto di vista di Trogo sembra invece presente nei frammenti del-la Makedonikeacute di Appiano su Filippo V44 dove ci si riferisce a Cinoscefale come a una vittoria insperata (Mak 9 1)
ἡγούμενος δ᾽ οὔτε Ῥωμαίοις συμφέρειν οὔτε τοῖς Ἕλλησι Φιλίππου καθαιρεθέντος ἐπιπολάσαι τὴν Αἰτωλῶν βίαν τάχα δ᾽ αὐτὸν καὶ τὸ παράδοξον τῆς νίκης ἀγαπᾶν ἐποίει
Flaminino era consapevole che non sarebbe stato vantaggioso per i Romani o per i Greci che Filippo fosse deposto e che il potere etolico rimanesse incon-trastato forse lo aveva reso moderato nei suoi progetti lrsquoaver ottenuto una vit-toria insperata
Addirittura successivamente si accenna alla sorte avversa a Filippo nel-lo scontro
τὰ μὲν δὴ παρὰ τῶν ἄλλων φιλάνθρωπα ἦν τό τε τῆς τύχης ἄδηλον ἐξ ὧν ἔπαθεν ὁ Φίλιππος ὑφορωμένων καὶ τὸ πταῖσμα τοῦτο οὐ κατ᾽ ἀσθένειαν ἀλλὰ πλέον ἐκ συντυχίας αὐτὸν παθεῖν ἡγουμένων
Gli altri (Greci) erano inclini ad essere moderati vedendo con sospetto lrsquoincer-tezza della fortuna subita da Filippo e ritenendo che egli fosse incorso in questa sconfitta non tanto per la sua inferioritagrave quanto per la sfortuna
Il riferimento in Appiano e Trogo alla fortuna romanasfortuna ma-cedone a proposito di Cinoscefale egrave una traccia dellrsquoopinione politi-ca di quei Greci disprezzati da Polibio come uomini sciocchi καθάπερ οἱ μάταιοι τῶν ἀνθρώπων Tale posizione politica su Cinoscefale sarebbe dunque sopravvissuta nella tradizione storiografica di cui troviamo trac-cia in TrogoGiustino e Appiano
Per comprendere meglio alcune caratteristiche di questa tradizione puograve essere utile tornare ai due discorsi nellrsquoEpitome di Filippo e Flamini-no prima della battaglia Tali passi probabilmente trogiani45 non trova-no infatti riscontro nelle fonti parallele a noi pervenute Polibio (XVIII 18-27) seguito fedelmente da Livio (XXXIII 5-10) pur descrivendo le operazioni di guerra di Cinoscefale con dovizia di particolari non men-ziona un discorso di Filippo ai suoi armati prima della battaglia mentre il discorso di Flaminino per incoraggiare le truppe schierate (XVIII 23 2-6) nelle Storie egrave incentrato sulle vittorie di Sulpicio nella prima parte della guerra Pare dunque originale la versione trogiana che incentra-
44 Tra i frammenti consegnatici dagli Excerpta Constantiniana sono frequenti informazio-ni e osservazioni che rimandano a una prospettiva ellenistica sugli eventi DrsquoAgostini (2011) pp 99-121 45 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362
136 MONICA DrsquoAGOSTINI
ta sulla gloria macedone presenta Cinoscefale come il punto drsquoincon-tro e di scambio tra lrsquoegemonia macedone e lrsquoegemonia romana Non egrave una novitagrave che il leitmotiv delle Storie Filippiche e dunque dellrsquoEpitome sia la translatio imperii giagrave Alonso Nuntildeez definito da Santi Amantini laquouno dei piugrave noti esperti di questioni trogiano-giustineeraquo46 osservava che Tro-go esponeva nel suo perduto lavoro la teoria della successione degli im-peri mondiali secondo lo schema Assiria-Media-Persia-Macedonia-Roma osteggiata dai Parti47 In tale successione il ruolo da protagonista egrave rico-perto dallrsquoegemonia macedone48 che occupa allrsquoincirca 26 dei 44 libri e il cui ultimo vero momento di gloria egrave lo scontro con Roma appunto a Cinoscefale Lrsquoultima impresa macedone ha come esito la transizione del dominio universale da Oriente a Occidente e costituisce il tema cen-trale dellrsquointera vicenda di Filippo lrsquoimportanza della battaglia di Cino-scefale egrave perciograve esaltata nei discorsi sia di Filippo che di Flaminino che a loro volta sono il punto di arrivo delle argomentazioni esposte nelle parole di Demetrio di Faro e di Filippo stesso giagrave nel libro XXIX Le ora-tiones disposte retoricamente nei due libri descrivono due parabole op-poste da un lato quella romana che da lontana potenza desiderosa di espandersi cresce come una pioggia di sangue diventando il giovane e vigoroso potere che sottomesso Annibale egrave pronto a sconfiggere Filip-po Dallrsquoaltro quella macedone che originata con Filippo II personag-gio centrale per Trogo raggiunge il suo apice con la conquista dellrsquoege-monia ad opera di Alessandro Magno contro i Persiani per conoscere la fine con Filippo V il cui antico valore egrave ormai troppo lsquosbiaditorsquo per te-ner testa al vigore romano
La gloria macedone secondo Trogo inizia dunque con Filippo II e si conclude con Filippo V Perseo egrave infatti il malvagio responsabile dellrsquoan-nientamento di ciograve che rimaneva della monarchia macedone49 Trogo pone agli estremi della parabola macedone che occupa dal libro IX al XXX i due re di nome Filippo Filippo II e Filippo V come ribadito in piugrave luoghi dellrsquoEpitome sia in parti riassunte da Giustino che in passi piugrave genuinamente trogiani Dando per scontato che il titolo dellrsquoopera Sto-rie Filippiche si debba al desiderio di Trogo di rifarsi allrsquoopera di Teopom-po sul sovrano macedone egrave possibile che tale titolo sia stato perograve ripen-
46 Santi Amantini (2003) pp 99-11047 laquoPompeius Trogus expounded in his lost work the Historiae Philippicae a theory of the world empire suggestion according to the scheme Assyria-Media-Persia-Macedonia-Rome opposed by the Parthiansraquo Alonso-Nuacutentildeez (2002) pp 105-110 e 133-136 partic 105 Vd anche Richter (1987) pp 19-23 Momigliano (1980) pp 157-162 Alonso-Nuacutentildeez (1992) Heckel (1997) pp 1-41 Gabba (2003) pp 7-9 Santi Amantini (2003) pp 99-110 Mariotta (2014) pp 45-56 48 Franco (1993) pp 71-97 e Landucci (2014) pp 233-26149 Alonso-Nuacutentildeez (2002) pp 105-110 partic 108-109
IL DISCORSO DEL RE 137
sato da Trogo considerando che il periodo compreso tra le imprese dei due Filippo occupa 23 dellrsquoopera50 Si potrebbe allora suggerire che le Storie sono Filippiche poicheacute i due Filippo segnarono lrsquoinizio e la fine di quella che egrave nellrsquoopera di Trogo lrsquoegemonia incontrastata del mondo piugrave gloriosa di tutti i tempi51
La prospettiva ellenistica che vede nei due Filippo i limiti della grande egemonia macedone egrave di nuovo presente anche in Appiano nellrsquooraco-lo riportato nei frammenti della sua Makedonikeacute e noto anche da Pausa-nia (VII 8 9)
αὐχοῦντες βασιλεῦσι Μακηδόνες Ἀργεάδῃσιν ὑμῖν κοιρανέων ἀγαθὸν καὶ πῆμα Φίλιππος ἤτοι ὁ μὲν πρότερος πόλεσιν λαοῖσί τ᾽ ἄνακτας θήσει ὁ δ᾽ ὁπλότερος τιμὴν ἀπὸ πᾶσαν ὀλέσσει δμηθεὶς δ᾽ ἑσπερίοισιν ὑπ᾽ ἀνδράσιν ἐνθάδ᾽ ὀλεῖται
O Macedoni che andate orgogliosi dei re di stirpe argiva I re di nome Filippo saranno arbitri del bene e del male per voi Il primo vi renderagrave signori di cittagrave e popoli il secondo vi priveragrave di ogni onore sconfitto da uomini dellrsquoOcciden-te qui giace morto52
Senza voler entrare nel merito della discussione di tale oracolo di nuo-vo pare di incontrare nei due autori la medesima prospettiva lontana dalla condanna morale del re macedone espressa da Polibio secondo cui la sconfitta egrave il giusto esito della sua crudeltagrave ed empietagrave
Il libro giustineo si conclude menzionando le condizioni della pa-ce di Tempe53 e lrsquoira degli Etoli che videro ignorate le proprie richieste da Flaminino e perciograve cercarono lrsquoalleanza di Antioco contro Roma Se-condo il Prologo XXX il libro perograve proseguiva con le campagne di Antio-co III in Asia Minore contro Molone e Acheo e in Battriana fino ad ar-rivare allrsquoesordio dello scontro con Roma54 Il riassunto giustineo egrave trop-po sommario per permettere un confronto con le fonti parallele Egrave pe-
50 Sul rilievo della storia della Macedonia nellrsquoopera di Trogo e Giustino vd von Gutsch-midt (1894) pp 17-217 Richter (1987) p 28 n 29 Franco (1993) pp 71-97 51 Vd anche Urban (1982) pp 1424-1443 e Alonso-Nuacutentildeez (1992) p 58 52 Mak Fr 2 Vd DrsquoAgostini (2011) pp 99-121 In questa Walbank (2002) pp 127-136 propone di interpretare anche un poema di Alceo di Messene (Anth Pal 9518)53 Egrave probabile che Trogo fornisse piugrave particolari riguardo a questa pace per esempio si puograve ritenere che vi fosse menzione dellrsquoinvio a Roma del figlio Demetrio da parte di Filippo come ostaggio dato che a Iust XXXII 2 3 si richiama appunto tale avvenimento54 Polyb XVIII 34 1-39 7 42 1-45 12 Liv XXXIII 11 3-13 15 24 1-31 11 Plut Flam IX 1-8 App Mak Fr IX riferiscono di due diverse trattative di pace caratterizzate da un vivace dibattito tra chi voleva lrsquoannientamento della Macedonia come in Grecia gli Etoli e a Roma Marco Claudio Marcello e coloro che desideravano la pace con la Macedonia in primis Flaminino
138 MONICA DrsquoAGOSTINI
rograve da notare la mancanza sia nel Prologo che nel testo del libro degli av-venimenti delle celebrazioni Istmie del 196 quando Flaminino procla-mograve la libertagrave dei Greci Piugrave in generale in tutta la narrazione di Giustino delle complesse trattative del 197-196 manca qualsiasi riferimento alla li-bertagrave dei Greci punto nodale nella tradizione di Polibio che con questa sottolineatura esalta sia il ruolo tirannico della Macedonia sia la grande generositagrave dei Romani nei confronti della Grecia Il silenzio di TrogoGiustino su tale questione mostra il prevedibile disinteresse per gli affari dei Greci e nel contempo conferma la presenza di una tradizione che si occupa soprattutto della storia delle monarchie ellenistiche allrsquointer-no della quale la posizione dellrsquoEllade egrave subalterna
Libro XXXII23- 34 Demetrio e Perseo
Gli ultimi anni di regno di Filippo tra il 183 e il 179 sono narrati in un passo breve del libro XXXII Il racconto in Giustino che egrave coerente con il Prologo trogiano segue in maniera sintetica la tradizione polibiana su questi eventi giunta a noi in alcuni passi lacunosi di Polibio (XXIII 1 3-3 10 7 1-7 10 1-11 8) integrati dal racconto particolareggiato di Li-vio (XXXIX 46 7- 48 6 53 1-16 XL 3 3-16 3 201-24 8) e dalla narra-zione di Diodoro (XIX 25) e Plutarco (Aem VIII 11)55
Conclusioni
In questi libri dedicati a Filippo egrave forse possibile vedere in filigrana la rielaborazione voluta di Giustino dei corrispondenti libri trogiani Co-me Giustino stesso afferma nella Prefatio 3 lrsquoopera di Trogo era costruita secondo due criteri quello cronologico e quello per laquoconcatenazione di eventi56raquo ea omnia Pompeius diuisa temporibus et serie rerum digesta conposuit
55 Lrsquoutilizzo della tradizione polibiana in Trogo egrave confermato dallrsquoaderenza a Livio (XL 54 1-56 11) e Diodoro (XXIX 28) del racconto sul pentimento di Filippo per aver ucciso il figlio Demetrio lrsquointenzione di punire Perseo e la correlazione tra questo e la sua mor-te Questo libro egrave dunque differente nellrsquointeresse e nelle fonti dai libri XXIX e XXX poicheacute molto vicino alla tradizione polibiana in Livio Questi avvenimenti in Giustino sono da collegare con lrsquoascesa al trono di Perseo e non con lrsquoepilogo della celebrazione del valore macedone giagrave conclusasi in Giustino con Cinoscefale e la transizione dallrsquoim-perium macedone allrsquoimperium romano Vd Heckel (1997) p 7 Appiano invece riporta ancora una tradizione diversa da quella polibiana in un frammento della Makedonikeacute in particolare Appiano egrave attento al punto di vista macedone e presenta Filippo come una vittima delle circostanze (Mak IX) DrsquoAgostini (2011) pp 99-12156 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362 Alonso-Nuacutentildeez (2002) pp 133-136 He-ckel (1997) pp 1-41 Borgna (2014) pp 52-77
IL DISCORSO DEL RE 139
Serie rerum digesta sembrerebbe unrsquointerpretazione latina della formula κατὰ γένος che Diodoro usa per indicare la struttura della storia di Efo-ro sottolineandone la divisione per argomento57 In tale struttura per argomento dellrsquoEpitome tra i temi principali ci sono dunque il valore e la gloria dei sovrani ellenistici58 riscontrabile nei libri XXVIII-XXXI sui re-gni di Antigono Dosone Filippo V e Antioco III Tale tema presente di sicuro in Trogo egrave conservato nellrsquoazione dellrsquoEpitomatore e anzi come si vede dagli escerpta esaltato dalla selezione dei passi
Per quanto riguarda invece la Quellenforschung 59 egrave evidente che nel testo vi sia presenza di filoni non tradizionali sugli eventi poicheacute la posi-zione di Trogo appare spesso autonoma rispetto alle opinioni condivise dalla storiografia antica Questo aspetto dellrsquoEpitome evidente soprattut-to per ciograve che riguarda gli eventi ellenistici ha suscitato la grande curio-sitagrave degli studiosi che allontanatisi dalla proposta di von Gutschmid che voleva una totale ed esclusiva dipendenza di Trogo da Timagene ora in-dicano con sicurezza tra le fonti piugrave rilevanti per gli eventi ellenistici di III secolo utilizzate da Trogo almeno altri sei nomi oltre a Timagene Ie-ronimo Timeo Filarco Duride Polibio e Posidonio
Per quanto riguarda nello specifico la composizione dei libri XXIX e XXX non vi egrave alcun dubbio che in essi Trogo abbia utilizzato (anche riadattandola) una fonte poco attenta alle questioni di politica interna greca e al legame tra queste e quel ritratto di Filippo come sovrano mal-vagio ed empio che ritorna nella tradizione ufficiale di origine polibia-na passando poi da Polibio in Livio Diodoro e Plutarco60 Trogo pre-serva invece una tradizione ellenistica interessata alla figura di Filippo come ultimo barlume della gloria macedone tradizione che pare quasi una controparte e un completamento dellrsquoAb urbe condita romanocentri-ca di Livio Non si puograve perciograve a mio avviso escludere che per questa se-zione Trogo abbia usato una tradizione di matrice filoellenistica o sem-plicemente ellenisticocentrica unrsquoopera sui regni di diadochi ed epigo-ni che a tutti noi fa venire facilmente alla mente il Basileis o Perigrave Basileon dello storico grecoellenistico augusteo filobarbaro scettico (o critico) verso lrsquoegemonia romana Timagene di Alessandria (FGrHist 88)61
57 Su Eforo vd Vannicelli (1987) pp 165-191 e ora Parmeggiani (2011) 58 Simile legame vi egrave a mio avviso tra i libri XXVI e XXVII che invece affrontavano la crisi delle monarchie ellenistiche causata dalle guerre fraterne59 Vd von Gutschmid (1894) pp 17-217 Richter (1987) pp 17-30 partic 20-23 San-ti Amantini (1972) pp 56-109 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362 Urban (1982) pp 1424-1443 partic 1435 Mecca (2001) pp 199-222 Santi Amantini (2003) pp 99-110 Heckel (2012) pp 3-860 Scuderi (2005) pp 383-40561 Sordi (1982) pp 775-797 Heckel (1997) pp 30-34 Landucci (2014) pp 233-261 e Ead in questo volume
140 MONICA DrsquoAGOSTINI
ABSTRACT
Philip V of Macedon was the first of the Epigonoi to face Rome Several mod-ern reconstructions of the actions and the reign of Philip V have approached it largely from a Roman point of view using as sources Polybius and where Poly-bius is lost Livy The Polybian historiographical tradition tends to portray Phil-ip V as an enemy and a tyrant impious and cruel The Macedonian king was ea-ger to establish a universal and unjust dominion over Greece Italy and beyond and Rome engaged in the first two Macedonian Wars to fight the threat of his growing ambition Nevertheless Polybiusrsquo portrayal of Philip V was affected not only by Polybiusrsquo admiration for Roman political structures military power and overwhelming conquest but also his personal Achaean origins
Looking at in book 29 and 30 of Justinrsquos Epitome of Pompeius Trogus this pa-per focuses on the non Polybian tradition on Philip V this contribution is in-deed the first analysis of the Hellenistic approach to the clash between Rome and Macedonia in the 3rd-2nd Century BC The Epitome shows a considerable di-versity of interpretation from the other sources and reflects very different views of Philip Vrsquos actions that brought him into conflict against Rome In particular these views are more evident related to the accounts of the peace negotiations of Naupactus and the battle of Cynoscephalae in the Epitome the king appears as a courageous and skilled warrior the last of the great Macedonian rulers who fell victim to misfortune This portrayal which has several common features with Appianrsquos fragments of Philip V (Mak 9) counterbalances the Roman and Achaean standpoint present in Polybius providing a more Hellenistic perspec-tive that is likely to have been rooted in a historiographical tradition connect-ed to the losing side in the struggle between Rome and the Hellenistic world
BIBLIOGRAFIA
Adler E (2006) Whorsquos Antiroman Sallust and Pompeius Trogus on Mithridates CJ 101 pp 383-407
Adler E (2011) Valorizing the Barbarians Enemy speeches in Roman Historiography Austin
Ager SL (2003) An Uneasy Balance from the Death of Seleukos to the Battle of Raph-ia in A Erskine (ed) A Companion to the Hellenistic World Oxford pp 35-50
Ager SL (2009) Roman Perspectives on Greek Diplomacy The conceptual clash Greek diplomacy of compromise and Roman Bellum Iustum in C Eilers (ed) Diplomats and Diplomacy in the Roman World Leiden-Boston pp 15-43
Alonso-Nuacutentildeez JM (1992) La Historia Universal de Pompeyo Trogo Madrid
Alonso-Nuacutentildeez JM (2002) The Idea of Universal History in Greece From Herodotus to the Age of Augustus Amsterdam
Ballesteros Pastor L (2013) Pompeyo Trogo Justino y Mitriacutedates Comentario al Epiacutetome de las Historias Filiacutepicas (3716-3881) Hildesheim-Zuumlrich-New York
IL DISCORSO DEL RE 141
Barreacute ML (1983) The God-List in the Treaty between Hannibal and Philip V of Ma-cedon a Study in Light of the Ancient Near Eastern Treaty Tradition Baltimore-Lon-don
Beck H - Eckstein A (2015) sv ldquoAratos of Sicyon (231)rdquo in I Worthington (ed) Brillrsquos New Jacoby Brill Online
Borgna A (2014) Uno sguardo originale intorno a Roma Pompeo Trogo e Giustino laquoLa Biblioteca di ClassicoContemporaneoraquo 1 pp 52-77
Cassola F (1962) I gruppi politici romani nel III secolo aC Trieste
Champion CB (1997) The Nature of Authoritative Evidence in Polybios and Agelausrsquo Speech at Naupactos TAPhA 127 pp 111-128
Champion CB (2004) Cultural Politics in Polybiusrsquo Histories Berkeley
Coppola A (1993) Demetrio di Faro un protagonista dimenticato Roma
Criscuolo L (2011) I due testamenti di Tolemeo VIII Evergete II in A Joumlrdens - J F Quack (hrsg) Aumlgypten zwischen innerem Zwist und aumluszligerem Druck Die Zeit Ptole-maios VI bis VIII Wiesbaden pp 132-150
DrsquoAgostini M (2011) Filippo V e la Storia Romana di Appiano laquoAevumraquo 85 pp 99-121
Eckstein AM (1995) Moral vision in the Histories of Polybius Berkeley
Eckstein AM (2008) Rome enters in the Greek East From Anarchy to Hierarchy in the Hellenistic Mediterranean 230-217 BC Oxford
Eckstein AM (2013) Polybius Phylarchus and Historiographical Criticism CPh 108 4 pp 314-338
Errington RM (1969) Philopoemen Oxford
Errington RM (2008) A History of the Hellenistic World 323-30 BC Malden MA-Oxford
Forni G - Angeli Bertinelli MG (1982) Pompeo Trogo come fonte di storia ANRW II 30 2 pp 1298-1362
Franco C (1993) Trogo Giustino e i successori di Alessandro in L Braccesi - A Coppola - G Cresci Marrone - C Franco (a cura di) LrsquoAlessandro di Giustino dagli antichi ai moderni Roma pp 71-97
Gabba E (2003) Introduzione in D Foraboschi - SM Pizzetti (a cura di) La successione degli imperi e delle egemonie nelle relazioni internazionali Milano pp 7-9
Golan D (1995) The Res Graeciae in Polybius Four Studies Como
Green P (1990) Alexander to Actium The Historical Evolution of the Hellenistic Age Berkeley-Los Angeles
Gutschmid von A (1894) Die beiden ersten Buumlcher des Pompeius Trogus in A von Gutschmid - F Ruumlhl (hrsg) Kleine Schriften Leipzig pp 17-217
142 MONICA DrsquoAGOSTINI
Habicht C (1995) Athen Muumlnchen
Hammond NGL (1968) Illyris Rome and Macedon in 229-205 BC JRS 58 pp 1-21
Hammond NGL (1988) The Campaign and the Battle of Cynoscephalae in 197 BC JHS 108 pp 60-82
Heckel W (1997) Introduction (Part 2) in JC Yardley - W Heckel (eds) Ju-stin Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus Books 11-12 Alexander the Great Introduction Oxford pp 1-41
Heckel W (2012) Introduction in JC Yardley - P Wheatley - W Heckel (eds) Justin Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus II Books 13-15 The Successors to Alexander the Great Oxford pp 1-8
Huss W (1976) Untersuchungen zur Auszligenpolitik Ptolemaiosrsquo IV Muumlnchen
Huss W (2001) Aumlgypten in hellenistischer Zeit 332ndash30 v Chr Muumlnchen
Intrieri M (2011) Fra dialogo e conflitto Annibale e i Greci drsquoOccidente RStudFen 37 pp 53-82
Landucci F (2014) Filippo II e le Storie Filippiche un protagonista storico e storio-grafico in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 233-261
Landucci Gattinoni F (2011) Politica e ideologia in etagrave ellenistica laquoPolitica An-ticaraquo 1 pp 89-105
Leacutevy E (1994) Le discours drsquoAgeacutelaos de Naupacte in L Aigner Foresti - A Bar-zanograve - C Bearzot - L Prandi - G Zecchini (a cura di) Federazioni e federalismo nellrsquoEuropa antica Bergamo 21-25 settembre 1992 Milano (Alle radici della casa co-mune europea 1) pp 33-50
Longaretti L (1989) Lrsquoalleanza tra Annibale e Filippo V di Macedonia RIL 123 pp 183-192
Marasco G (1979-1980) La valutazione di Tolemeo IV Filopatore nella storiografia greca laquoSilenoraquo 5-6 pp 159-182
Mari M [- Musti D - Thornton J] (2002) Polibio Storie Volume III Libri V-VI Milano
Mariotta G (2014) Geografia e Geopolitica nelle Storie Filippiche in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 45-56
McGing B (2010) Polybiusrsquo Histories New York
McGing B (2013) Youthfulness in Polybius the case of Philip V of Macedon in B Gibson - T Harrison (eds) Polybius and his world Oxford pp 181-199
Meadows A (2013) Polybius Aratus and the History of the 140th Olympiad in B
IL DISCORSO DEL RE 143
Gibson - T Harrison (eds) Polybius and his World Essays in Honour of Frank Walbank Oxford pp 91-116
Mecca A (2001) Trogo Timagene e Polieno QS 54 pp 199-222
Meister K (1990) Die Griechische Geschichtsschreibung von den Anfaumlngen bis zum Ende des Hellenismus Stuttgart
Misch G (1949) Geschichte der Autobiographie I Frankfurt am Mein
Momigliano A (1980) Daniele e la teoria greca della successione degli imperi RAL 35 pp 157-162
Muccioli F (2013) Gli epiteti ufficiali dei re ellenistici Stuttgart (Historia Einzel-schriften 224)
Musti D (1978) Polibio e lrsquoimperialismo romano Napoli
Parmeggiani G (2011) Eforo di Cuma studi di storiografia greca Bologna
Peacutedech P (1964) La meacutethode historique de Polybe Paris
Pelling CBR [- Scardigli B - Manfredini M](1997) Plutarco Vite parallele Filopemene Tito Flaminino Milano
Richter H-D (1987) Untersuchungen zur hellenistischen Historiographie die Vorla-gen des Pompeius Trogus fuumlr die Darstellung der nachalexandrischen hellenistischen Ge-schichte (Iust 13-40) Frankfurt
Santi Amantini L (1972) Fonti e valore storico di Pompeo Trogo (Iustin XXXV e XXXVI) Genova
Santi Amantini L (1981) (a cura di) Giustino Storie Filippiche Epitome da Pom-peo Trogo Milano
Santi Amantini L (2003) Il tempo e i tempi nelle Storie Filippiche di Pompeo Tro-go RSA 33 pp 99-110
Schepens G (1983) Les rois ptolegravemaiumlques et lrsquohistoriographie Reacuteflexions sur la trans-formation de lrsquohistoire politique in E vanrsquot Dack - P van Dessel - W Van Gucht (eds) Egypt and the Hellenistic World Proceedings of the International Collo-quium Leuven 24-26 May 1982 Leuven (Studia Hellenistica 27) pp 351-368
Schlicher JJ (1933) Non-Assertive Elements in the Language of the Roman Histo-rians CPh 28 289-300
Schmitt T (1989) Die Bedeutung des zweiten Punischen Krieges fuumlr den Frieden in Naupaktos in H Devijver - E Lipinski (eds) Punic wars Proceedings of the Conference held in Antwerp from the 23th to the 26th of November 1988 in Cooperation with the Departement of History of the laquoUniversitait Antwerpenraquo UFSIA Leuven (Studia Phoenicia 10) pp 229-239
Scholten JB (2000) The Politics of Plunder Aitolians and their koinon in the early Hellenistic Era Berkeley
144 MONICA DrsquoAGOSTINI
Scuderi R (2005) Filippo V e Perseo nei frammenti diodorei in C Bearzot - F Lan-ducci (a cura di) Diodoro e lrsquoaltra Grecia Macedonia Occidente Ellenismo nella Bi-blioteca Storica Atti del convegno Milano 15-16 gennaio 2004 Milano pp 383-405
Sklenaacuter RJ (2004) Sources and Individuality in Two Passages of Livy laquoHistoriaraquo 53 pp 302-310
Sordi M (1982) Timagene di Alessandria Uno storico ellenocentrico e filobarbaro ANRW II 30 1 pp 775-797
Thornton J (2014) Le guerre macedoniche Roma
Urban R (1979) Wachstum und Kriese des achaumlischen Bundes Quellenstudien zur entwicklung des Bundes von 280 bis 222 V Chr Wiesbaden
Urban R (1982) laquoGallisches Bewusstseinraquo und laquoRomkritikraquo bei Pompeius Trogus ANRW II 30 2 pp 1424-1443
Vannicelli P (1987) Lrsquoeconomia delle Storie di Eforo RFIC 115 pp 165-191
Vattuone R (2014) Giustino e lrsquoOccidente greco I VI-V secolo aC in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 261-277
Vollmer D (1990) Symploke das Uumlbergreifen der roumlmischen Expansion auf den grie-chischen Osten Untersuchungen zur roumlmischen Aussenpolitik am Ende des 3 Jh V Chr Stuttgart
Walbank FW (1957) A Historical Commentary on Polibius I Oxford
Walbank FW (1967) A Historical Commentary on Polybius II Oxford
Walbank FW (1933) Aratos of Sicyon Cambridge
Walbank FW (2002) Η ΤΩΝ ΟΛΩΝ ΕΛΠΙΣ and the Antigonids in FW Walbank (ed) Polybius Rome and the Hellenistic World Essays and Reflections West Nyack NY pp 127-136
Weber G (1997) Interaktion Repraumlsentation und Herrschaft Der Koumlnigshof im Hel-lenismus in A Winterling (hrsg) Zwischen lsquoHausrsquo und lsquoStaatrsquo antike Houmlfe im Ver-gleich Munich pp 27-72
Will E (19822) Histoire politique du Monde Helleacutenistique II Nancy
Zecchini G (1990) La storiografia lagide in H Verdin - G Schepens - E De Keyser (eds) Purposes of History Studies in Greek Historiography from the 4th to the 2nd Centuries BC Proceedings of the International Colloquium of Leuven 24-26 May 1988 Leuven (Studia Hellenistica 30) pp 213-232
Zecchini G (2003) Polibio e la tradizione orale in A Casanova - P Desideri (a cura di) Evento racconto scrittura nellrsquoantichitagrave classica Firenze pp 123-141
Finito di stamparenel mese di novembre 2015
da LegoDigit srlLavis (TN)
Comitato scientifico Cinzia Bearzot Franca Landucci Philip A Stadter Giuseppe Zecchini
PP_Bearzot-Landucciindd 2 131115 1550
a cura di
CINZIA BEARZOT FRANCA LANDUCCI
STUDI SULLrsquoEPITOMEDI GIUSTINOII DA ALESSANDRO MAGNO A FILIPPO V DI MACEDONIA
VITA E PENSIERORICERCHESTORIA
PP_Bearzot-Landucciindd 3 131115 1550
La pubblicazione di questo volume ha ricevuto il contribu-to finanziario dellrsquoUniversitagrave Cattolica ed egrave stata realizzata grazie al contributo del Progetto PRIN 2010-2011 del Mini-stero dellrsquoIstruzione dellrsquoUniversitagrave e della Ricerca
wwwvitaepensieroit
Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15 di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dallrsquoart 68 commi 4 e 5 della legge 22 aprile 1941 n 633Le fotocopie effettuate per finalitagrave di carattere professionale economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi Cen-tro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali Corso di Porta Romana 108 20122 Milano e-mail autorizzazioniclearediorg e sito web wwwclearediorg
copy 2015 Vita e Pensiero - Largo A Gemelli 1 - 20123 MilanoISBN 978-88-343-3107-1
PP_Bearzot-Landucciindd 4 131115 1550
INDICE
Presentazione VII
LUISA PRANDIAlessandro il Grande in Giustino 3
FRANCA LANDUCCII Diadochi 17
GIOVANNI BRIZZIGiustino e la storia di Cartagine 39
RICCARDO VATTUONEGiustino e lrsquoOccidente greco II IV-III secolo aC 55
MARIA TERESA SCHETTINOPirro in Giustino 69
FEDERICOMARIA MUCCIOLILrsquoOriente seleucidico da Antioco I ai primi anni di Antioco III in Pompeo TrogoGiustino 99
MONICA DrsquoAGOSTINI Il discorso del Re Filippo V in Giustino 121
01_indiceindd V01_indiceindd V 201115 1537201115 1537
MONICA DrsquoAGOSTINI
Il discorso del Re Filippo V in Giustino
Introduzione
Le vicissitudini del reame antigonide durante il regno di Filippo V sono trattate principalmente nei libri XXIX e XXX delle Epitome delle Storie Fi-lippiche di Pompeo Trogo Alle notizie contenute in questi libri si aggiungo-no la breve menzione dellrsquoascesa al trono del sovrano nel libro XXVIII (3 9 e 4 16) e la descrizione degli eventi relativi alla sua morte nel libro XXXII (2 3- 3 4)
Egrave chiaro dal confronto tra i Prologi e lrsquoEpitome che ampie parti dei due libri trogiani sono state omesse in Giustino in particolare quelle ineren-ti agli avvenimenti orientali poicheacute nec cognoscendi voluptate iucunda nec exemplo erant necessaria (Praefatio 4) le origini di Creta e gli scontri tra Fi-lippo e Attalo nel libro XXIX la spedizione di Filippo in Asia e le cam-pagne di Antioco III nel libro XXX
Degli eventi dei libri XXIX e XXX sono invece menzionati in forma di riassunto da Giustino i piugrave importanti scontri militari tra Roma e Fi-lippo Nella categoria dei passi lsquoepitomatirsquo rientrano la Guerra degli Al-leati la Prima Guerra Macedonica la Seconda Guerra Macedonica Ci-noscefale e le rispettive trattative di pace ovvero Naupatto Fenice Tem-pe Quando ci si trova di fronte a tali riassunti egrave spesso difficile un con-fronto puntuale con le altre tradizioni pur con lrsquoaiuto dei Prologi
Gli eventi che ricevono attenzione nei libri XXIX e XXX sono sele-zionati secondo il criterio giustineo del cosiddetto lsquoflorilegiorsquo1 ovvero per cognitione quaeque dignissima (Praefatio 4)2 Piugrave vicini allrsquooriginale tro-giano e dunque piugrave excerpta che sintesi sono da ritenersi probabilmente i passi del libro XXIX sullrsquoalleanza tra Annibale e Filippo e sulla politica filoromana di Filopemene e quelli del libro XXX sulle questioni amo-
1 Vattuone (2014) pp 261-2772 I criteri per la distinzione dei passi piugrave vicini a Trogo e quelli invece riassunti da Giustino sono stati discussi autorevolmente allrsquointerno di questo progetto da Vattuone (2014) pp 261-277 Sul rapporto tra lrsquoopera di Trogo e lrsquoEpitome vd anche recentemente Heckel (1997) pp 1-41 e Id (2012) pp 1-8 e Borgna (2014) pp 52-77
122 MONICA DrsquoAGOSTINI
rose di Tolemeo III sul patto tra Antioco e Filippo e sullrsquoira degli Eto-li che nel 196 non videro appagata la richiesta di annientare la Macedo-nia Questi passi si prestano maggiormente a un confronto con le fonti parallele bencheacute con prudenza
Centrali nei due libri sono i cinque discorsi in oratio obliqua il primo egrave quello attribuito a Demetrio di Faro seguono tre di Filippo V men-tre lrsquoultimo egrave di Flaminino Poicheacute secondo Giustino (XXXVIII 3 11) Trogo utilizzava solamente lrsquooratio obliqua e avrebbe criticato aspramen-te Sallustio e Livio per lrsquoimpiego di numerosi discorsi in oratio recta i cin-que riportati nei libri XXIX e XXX sono stati considerati trasposizioni dellrsquooriginale trogiano3 In effetti tali discorsi fungono da ossatura del percorso narrativo dei due libri e sono da considerare le sezioni di que-sti libri piugrave vicine allrsquooriginale trogiano Sono perciograve i passi che offrono maggior possibilitagrave di studio per mettere in luce la presenza o lrsquoassen-za di una tradizione alternativa su Filippo V se questa sia giagrave in Trogo e quanto in quale modo e con quale interesse Giustino abbia interpolato tale tradizione Data la complessitagrave dei due libri ritengo opportuno ana-lizzare gli avvenimenti trattati seguendo la divisione in capitoli giustinea
Libro XXIX11-11 Introduzione
Il primo capitolo del libro XXIX si presenta con precisione nei riferi-menti coerenza testuale e attenzione ai dettagli Giustino probabilmen-te ricalcando le riflessioni di Trogo alla considerazione incipitale sul ge-nerale rinnovamento dei vertici degli imperi di lsquotutto il mondorsquo alla fine del III secolo aC fa seguire la lista dei nuovi re con alcuni commenti relativi ai singoli monarchi In particolare si sottolinea la giovane etagrave di tutti i sovrani e i condottieri al momento della loro ascesa al potere os-servazione ribadita nel commento finale al capitolo (XXIX 1 8)
His regibus pueris tametsi nulli senioris aetatis rectores erant tamen in suorum quisque maiorum uestigia intentis magna indoles uirtutis enituit
Questi re fanciulli sebbene non avessero guide di etagrave piugrave anziana tuttavia se-
3 Schlicher (1933) pp 289-300 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362 partic 1309 Adler (2006) pp 383-407 e Id (2011) pp 37-40 Recentemente Ballesteros Pastor (2013) pp 52-54 commentando il discorso di Mitridate (XXXVIII 4-7) ha ritenuto che Giustino abbia dichiarato il falso a proposito dellrsquooratio obliqua a suo avviso in Trogo ci sarebbero stati infatti numerosi discorsi diretti che poi Giustino avrebbe tragravedito come discorsi indiretti nellrsquoEpitome inserendo nel passaggio alcuni errori sintattici e incon-gruenze
IL DISCORSO DEL RE 123
guirono ciascuno con impegno le orme degli antenati e in loro rifulse un gran-de innato valore4
Questa introduzione sembra modellata sul cosiddetto lsquosecondo proe-miorsquo di Polibio (IV 2) la lista dei sovrani e lrsquoordine coincidono infatti con quello del Megalopolitano se non per lrsquoesclusione dellrsquousurpatore seleucide Acheo5 Lrsquointenzione del passo nelle due opere egrave perograve diver-sa mentre il Megalopolitano nel proemio metteva in risalto il sorgere quasi in contemporanea di nuovi conflitti in diverse parti del Mediter-raneo nellrsquoEpitome il filo conduttore di questo elenco di sovrani e con-dottieri egrave la loro gloria e la grandezza degli eventi che essi compirono in giovane etagrave6 Inoltre vi sono in Trogo alcune notizie originali rispetto al Megalopolitano il fatto che lrsquoepiteto Filopatore di Tolemeo IV sia mes-so in relazione con lrsquoassassinio dei genitori del sovrano oppure che lrsquoa-scesa di Annibale al comando dei Cartaginesi sia spiegata con il suo odio per i Romani Entrambe queste notizie non appartengono alla tradizio-ne polibiana in Polibio (II 36 3) Annibale era stato eletto comandante dellrsquoesercito in Spagna per i successi ottenuti mentre il padre Amilcare gli aveva fatto giurare odio eterno ai Romani Per quanto riguarda il Fi-lopatore Polibio ritiene che egli non abbia assassinato la madre Bereni-ce vittima invece del consigliere Sosibio (Polyb V 36 1)7 La versione di Trogo egrave dunque frutto di una propaganda avversa a Tolemeo IV che lo dipinge ancora piugrave negativamente di quanto fatto dalla tradizione poli-biana che certo giagrave non era favorevole al sovrano8
NellrsquoEpitome di Giustino segue una sintesi dei primi anni di regno di Filippo V in particolare vi egrave un brevissimo riferimento allrsquoinaspettata vit-toria del sovrano contro i Dardani che lo avrebbe portato a cercare lo
4 La traduzione di Giustino come tutte quelle presenti nel testo sono da Santi Amantini (1981) Lrsquounica eccezione a questa affermazione egrave il Filopatore Sulla tradizione storio-grafica avversa al Filopatore vd infra 5 Acheo egrave personaggio noto a Trogo che lo menziona altrove Prol XXX6 La giovinezza in TrogoGiustino egrave percepita come un valore aggiunto mentre per Poli-bio egrave una debolezza Eckstein (1995) p 143 McGing (2013) pp 181-1997 Muccioli (2013) pp 220-223 osserva che lrsquoepiteto fu assunto da Tolemeo IV quando il padre era vivo come strumento per sottolineare la sua predestinazione al trono 8 Polyb V 34 3-5 come anche Plut Cleom 33-34 forniscono notizie denigratorie su Tole-meo IV che sarebbe stato un sovrano inadatto a governare Secondo Huss (1976) pp 9 e 19 e (2001) pp 381-472 alla base vi sarebbe Filarco Se invece si considerano gli studi fatti su Tolemeo di Megalopoli da Schepens (1983) pp 351-368 e Zecchini (1990) pp 213-232 partic 218 egrave possibile che Tolemeo di Megalopoli nello scrivere unrsquoopera sto-riografica su un sovrano lagide non omettesse di menzionare notizie meno celebrative come Teopompo prima di lui aveva fatto nei confronti di Filippo II Sulla tradizione storiografica avversa a Tolemeo IV vd anche Marasco (19791980) pp 159-182 Weber (1997) pp 27ndash72 partic 28 Ager (2003) pp 35-50 McGing (2010) pp 117-119 Cri-scuolo (2011) pp 132-150 partic 148-149
124 MONICA DrsquoAGOSTINI
scontro con gli Etoli Egrave difficile dire se Trogo dedicasse piugrave spazio alla narrazione degli eventi tra il 220 e il 217 Nel Prologo si legge
Undetricensimo volumine continentur haec Res gestae Philippi regis adversus Dardanos et Aetolos repetitaeque inde Creticae origines post cuius insulae societatem Philippus cum Illyriis et Dardanis et rursus Aetolis bello congressus est adiuvantibus Aetolos Romanis quo finito intulit Attalo bellum
Il ventinovesimo libro contiene le imprese del re Filippo contro i Dardani e gli Etoli Sono quindi rievocate le origini di Creta dopo essersi alleato con questrsquoi-sola Filippo si scontrograve in guerra con gli Illiri i Dardani e di nuovo con gli Eto-li mentre i Romani soccorrevano gli Etoli Terminata questa guerra Filippo at-taccograve Attalo
Dal confronto tra Giustino e i Prologi egrave evidente che quella che per i mo-derni egrave la lsquoGuerra degli Alleatirsquo tra Etoli aiutati da Sparta e dallrsquoElide e la Lega Achea alleata di Filippo V sia ridotta sia in Giustino che in Tro-go a una guerra di Filippo contro gli Etoli Colpisce in effetti la comple-ta mancanza nel Prologo XXIX e nellrsquoEpitome del libro di qualsiasi men-zione e riferimento alla Lega Achea e al suo leader Arato protagonisti indiscussi invece nelle Storie polibiane dei primi anni di regno di Filippo V 9 Arato di Sicione importante statista e comandante militare della Le-ga Achea fu uno dei primi personaggi politici a scrivere e pubblicare le proprie memorie (FGrHist 231) di cui Polibio si servigrave ampiamente (I 3 1)10 Lo storico di Megalopoli era un compatriota di Arato e come lui ricoprigrave importanti cariche allrsquointerno della Lega Achea11 Polibio che considerava Arato uno dei fondatori della Lega vedeva in lui una sorta di eroe e leader ideale come emerge dalla descrizione che ne fa di uomo perfetto per lrsquoattivitagrave politica astuto tollerante coraggioso e di succes-so (IV 7 11-8 12) Il rapporto tra Filippo V e Arato egrave determinante per il giudizio di Polibio sul sovrano macedone Filippo egrave infatti descritto co-me un buon sovrano valoroso ma troppo giovane che nei primi anni di regno agigrave bene poicheacute ascoltograve e seguigrave i consigli di Arato (IV 77 1-4)12
Per quanto argumentum e silentio questa assenza di Arato di Sicione e della Lega Achea sia nel Prologo di Trogo che nellrsquoEpitome di Giustino
9 Polibio dedica alla Lega Achea ampia parte dei libri IV e V 10 Riguardo ad Arato di Sicione soprattutto nel rapporto con Polibio vd Meadows (2013) pp 91-116 Vd anche Walbank (1933) Misch (1949) pp 210-212 Urban (1979) Meister (1990) pp 187-189 Habicht (1995) pp 176-179 Beck - Eckstein (2015) sv laquoAratos of Sicyon (231)raquo in BNJ11 Sui legami di Polibio e la sua famiglia con la Lega Achea vd Eckstein (2013) pp 314-33812 Polyb IV 24 1-3 e V 26 6 seguito da Plut Arat 48-49 afferma esplicitamente che il re portava a termine abilmente i suoi piani poicheacute Arato era al suo fianco
IL DISCORSO DEL RE 125
non solo non puograve passare inosservata ma deve indurre i moderni a du-bitare per questi eventi di unrsquoapparente dipendenza diretta giagrave di Tro-go da Polibio
21- 38 Demetrio di Faro e Naupatto
Scomparso Arato nellrsquoEpitome XXIX ha invece un ruolo fondamentale in questi anni come consigliere di Filippo Demetrio di Faro a cui egrave at-tribuito il primo discorso in oratio obliqua dei due libri esaminati13
Demetrio di Faro era un dinasta illirico che si incontra per la prima volta nelle fonti storiografiche in occasione della prima guerra di Ro-ma in Illiria nel 229 Sappiamo infatti da Polibio (II 10 8-11 4) e Appia-no (Illyr 7) che Demetrio giagrave alleato di Teuta sovrana degli Illiri aveva scelto di passare dalla parte romana ed era stato poi ricompensato dal Senato con il controllo di parte dei territori sottratti da Roma a Teuta stessa Nei suoi tentativi di ritagliarsi un ruolo importante nella penisola balcanica Demetrio nel 222 si era alleato con la Lega Ellenica di Doso-ne e Arato a Sellasia contro Cleomene (Polyb II 65 2- 5) ma negli an-ni successivi le sue scorribande nellrsquoAdriatico allarmarono Roma che gli mosse guerra (Polyb III 16 IV 16)14 Sconfitto da Roma e cacciato da Faro Demetrio si rifugiograve alla corte di Filippo intorno al 218 diventan-do consigliere del re
Poicheacute nel Prologo XXVIII si legge laquoIn una digressione egrave narrata la guerra illirica combattuta dai Romani contro Teuta15raquo non egrave da esclu-dere che Trogo giagrave citasse il dinasta di Faro anche se la prima menzio-ne di Demetrio in Giustino egrave a XXIX 2 1 quando il cosiddetto lsquore de-gli Illirirsquo cacciato da Lucio Emilio Paolo dallrsquoAdriatico arrivograve alla corte macedone Nel riassunto degli eventi Giustino segue piugrave da vicino Tro-go riportando il discorso del dinasta a Filippo V per convincere il sovra-no a far guerra a Roma (XXIX 2 2-6) I punti principali di tale discorso sono che i Romani aspirano a realizzare un impero universale a scapito di tutti i re laquocome se fosse cosa illecita che ci fosse un qualche re presso i confini del loro Statoraquo Perciograve Filippo V doveva prepararsi alla guerra con i Romani poicheacute laquoquanto piugrave accessibile e illustre era il suo regno tanto piugrave accaniti nemici gli sarebbero stati i Romani16raquo Demetrio vole-
13 Su questi discorsi di Demetrio vd Coppola (1993) pp 29-5114 Coppola (1993) pp 29-51 vd anche Hammond (1968) pp 1-21 Eckstein (2008) pp 41 58-60 Demetrio di Faro era presentato in Polibio come il rivale di Arato tra i consi-glieri di Filippo Polyb IX 23 9 infatti dichiara che quando il sovrano seguiva i consigli di Arato compiva grandi imprese mentre quando ascoltava Demetrio si macchiava di atti spregevoli15 Trog Prol XXVIII Dictum in excessu bellum Illyricum quod Romani gessere cum Teuta16 Iust XXIX 2 4-5 sibi quoque non aliam ob causam quam quod Italiae finitimus uidebatur
126 MONICA DrsquoAGOSTINI
va infatti cacciare i Romani dalla sponda adriatica dellrsquoIlliria territorio che avrebbe ceduto a Filippo
Il discorso di Demetrio a Filippo egrave presente anche in Polibio (V 101 8-1017) ed egrave inserito cronologicamente durante i giochi Nemei18 nel 217 subito dopo la sconfitta romana del lago Trasimeno ricordata an-che nel passo di Giustino Nel discorso polibiano Demetrio perograve sotto-linea il diritto di Filippo V ad aspirare al dominio universale a partire dallrsquoAdriatico19 mentre nel discorso trogiano Demetrio accusa i Roma-ni di aspirare ad espandersi travolgendo qualsiasi regno sul loro cammi-no Trogo nel discorso di Demetrio presenta il coinvolgimento roma-no in Oriente come una guerra di conquista che contrappone la giova-ne potenza romana allrsquolsquoillustre regnorsquo di Filippo20 prospettiva che ritor-na nel successivo discorso di Filippo V nellrsquoEpitome ma che egrave estranea al-la narrazione di Polibio
Dopo il discorso di Demetrio nellrsquoEpitome come in Polibio (V 104 1) si arriva allrsquoincontro di pace di Naupatto nel 217 che pose fine al-la Guerra degli Alleati tra Etoli Spartani ed Elei contro la lega Achea e
bellum inlatum quasi nefas esset aliquem regem iuxta imperii eorum terminos esse Sed et ipsi cauen-dum esse exemplum cuius quanto promptius nobiliusque sit regnum tanto sit Romanos acriores hostes habiturus17 Polyb V 101 8-10 ὃς καὶ λαβόμενος τῆς ἀφορμῆς ταύτης τὸν μὲν πρὸς τοὺς Αἰτωλοὺς ᾤετο δεῖν τὴν ταχίστην ἀπορρῖψαι πόλεμον ἀντέχεσθαι δὲ τῶν κατὰ τὴν Ἰλλυρίδα πραγμάτων ἠξίου καὶ τῆς εἰς Ἰταλίαν διαβάσεως [9] τὰ μὲν γὰρ κατὰ τὴν Ἑλλάδα πάντα καὶ νῦν ἤδη ποιεῖν αὐτῷ τὸ προσταττόμενον ἔφη καὶ μετὰ ταῦτα ποιήσειν Ἀχαιῶν μὲν ἐθελοντὴν εὐνοούντων Αἰτωλῶν δὲ καταπεπληγμένων ἐκ τῶν συμβεβηκότων αὐτοῖς κατὰ τὸν ἐνεστῶτα πόλεμον [10] τὴν δ᾽ Ἰταλίαν ἔφη καὶ τὴν ἐκεῖ διάβασιν ἀρχὴν εἶναι τῆς ὑπὲρ τῶν ὅλων ἐπιβολῆς ἣν οὐδενὶ καθήκειν μᾶλλον ἢ ᾽κείνῳ τὸν δὲ καιρὸν εἶναι νῦν ἐπταικότων Ῥωμαίων Trad da Mari (2002) laquoCostui allora cogliendo lrsquooccasione gli consigliograve di interrompere al piugrave presto la guerra con gli Etoli e gli chiese di impegnarsi nelle operazioni in Illiria e nellrsquoattraversamento del mare verso lrsquoItalia Disse che infatti giagrave ora tutta la Grecia eseguiva i suoi ordini e lo avrebbe fatto anche in seguito poicheacute gli Achei lo sostenevano di loro iniziativa mentre gli Etoli erano rimasti molto colpiti da quanto era loro avvenuto nella guerra in corso e aggiunse che lrsquoItalia e lrsquoattraversamento del mare in quella direzione erano lrsquoinizio di un disegno di dominio universale che a nessuno spettava piugrave che a lui ora era il momento opportu-no visto che i Romani erano stati battutiraquo18 I giochi Nemei in onore di Zeus erano giochi panellenici celebrati in Argolide negli anni pari delle Olimpiadi 19 Secondo Eckstein (1995) pp 211-212 tale aspirazione egrave connessa allrsquoincapacitagrave di mo-derazione nella vittoria del sovrano Sul concetto di dominio universale in Polibio vd Musti (1978) pp 16-18 Eckstein (2008) pp 217-220 e 372-38120 Adler (2006) pp 383-407 e (2011) pp 37-58 ha notato che i punti principali del discorso di critica allrsquoespansionismo romano di Demetrio ritornano in altri due discorsi dellrsquoEpitome quello degli Etoli (XXVIII 2 1-13) e quello di Mitridate (XXXVIII 4-7) la prioritagrave data a questi argomenti da tale reiterazione retorica indica che lrsquointeresse giagrave di Trogo se non dellae suae fontei non fosse la celebrazione dellrsquoascesa di Roma allrsquoim-pero universale come in Appiano ma piuttosto lrsquoascesa e la discesa dei regni ellenistici
IL DISCORSO DEL RE 127
Filippo V 21 Il testo giustineo omette le circostanze dellrsquoevento non si menzionano infatti esplicitamente neacute il luogo dellrsquoincontro Naupatto neacute le fasi delle trattative neacute i vari rappresentanti dei diversi fronti che vi presero parte I lunghi negoziati di pace si risolvono dunque nel discor-so di Filippo V ai rappresentanti dei fronti
Il sovrano esordisce affermando che la Grecia egrave in grande pericolo percheacute chiunque avesse vinto tra Cartaginesi e Romani sarebbe poi pas-sato in Oriente Filippo utilizza la metafora delle nubi in Occidente che avrebbero macchiato con una pioggia di sangue ogni cosa spinte dai venti di vittoria inoltre il sovrano ritiene che le guerre passate dei Gre-ci siano di poco conto se paragonate alla minaccia di uno scontro con la moltitudine che si radunava in Italia descrivendo la rabbia e il valore di questi nuovi nemici che avrebbero portato rovina ai vicini Il sovrano infine ribadisce che la Grecia era in maggior pericolo della Macedonia ma che sapeva che chi avesse vinto in Italia non avrebbe frenato la sete di vittoria Perciograve anche la Macedonia stessa doveva temere un attacco
Il discorso in Polibio di Agelao di Naupatto rappresentante e leader degli Etoli22 mostra le medesime argomentazioni attribuite in Giustino allrsquointervento di Filippo argomentazioni fondate sul metus hostilis e fina-lizzate a promuovere un nuovo ruolo della Macedonia sia in Grecia che nel Mediterraneo Orientale Agelao proponendo un nuovo program-ma politico panellenico fonda le proprie argomentazioni sul metus hosti-lis per i Cartaginesi e i Romani presentati metaforicamente come nubi che incombono da Occidente Filippo dovrebbe farsi garante della tran-quillitagrave della Grecia che agendo come unrsquounica catena di cittagrave contro i barbari diverrebbe una sicura e fedele collaboratrice della Macedonia Questo permetterebbe ai Greci di conservare il diritto di far pace o guer-ra a loro piacimento senza temere che laquoi giochi da bambini con i quali ci trastulliamo tutti vengano troncati23raquo
Nonostante sia il medesimo discorso nelle due fonti Agelao introdu-ce una forte proposta di alleanza panellenica estranea alle parole di Fi-lippo Inoltre Filippo pur utilizzando la metafora delle nubi da Occi-
21 Interessanti le osservazioni di Scholten (2000) pp 224-228 a proposito della pace che sarebbe stata cercata e sperata da entrambe le parti e non imposta da Filippo come Polibio pare lasciar intendere 22 Vd soprattutto Leacutevy (1994) pp 33-50 Su questo discorso molto dibattuto dai moderni vd anche Schmitt (1989) pp 229-239 Vollmer (1990) pp 96-107 Coppola (1993) pp 149-164 Golan (1995) pp 55-74 Champion (1997) pp 111-128 e (2004) p 55 Wal-bank (2002) pp 127-136 Eckstein (2008) pp 78-83 23 Polyb V 104 10-11 καθόλου τὰς παιδιάς ἃς νῦν παίζομεν πρὸς ἀλλήλους ἐκκοπῆναι συμβῇ πάντων ἡμῶν ἐπὶ τοσοῦτον ὥστε κἂν εὔξασθαι τοῖς θεοῖς ὑπάρχειν ἡμῖν τὴν ἐξουσίαν ταύτην καὶ πολεμεῖν ὅταν βουλώμεθα καὶ διαλύεσθαι πρὸς ἀλλήλους καὶ καθόλου κυρίους εἶναι τῶν ἐν αὑτοῖς ἀμφισβητουμένων
128 MONICA DrsquoAGOSTINI
dente presente anche nelle Storie la arricchisce con la vivida immagine di una tempesta di sangue conferendo una dimensione piugrave concreta e cruenta alla predizione infine il riferimento polibiano alle guerre dei Greci nellrsquoEpitome non riguarda piugrave le guerre tra le cittagrave e le leghe gre-che ma le guerre dei Greci con Macedoni Persiani e Galli Mentre la Grecia scompare sullo sfondo la minaccia Romana egrave meno vaga e piugrave concreta e presente che in Polibio e diventa lrsquounico argomento del di-scorso di Filippo V a Naupatto
Il discorso di Demetrio e quello di Filippo sono al centro del libro XXIX dellrsquoEpitome avendo il duplice scopo di evidenziare sia la poten-ziale aggressivitagrave dei Romani sia la grande tradizione militare della Ma-cedonia e il pieno diritto di Filippo di controllare la Grecia e lrsquoIlliria fi-no allrsquoAdriatico Se il discorso in Polibio si inseriva in un dibattito politi-co dove la Grecia e la Macedonia erano protagoniste alla pari della sce-na ellenica e internazionale nella versione che leggiamo in Trogo i ri-ferimenti alle dispute della realtagrave greca sono reinterpretati a favore di un punto di vista in cui la Macedonia egrave lrsquounico potere dellrsquoOriente gre-co Del dibattito politico di III secolo in Grecia che tanto stava a cuore a Polibio non vi egrave piugrave alcuna traccia in TrogoGiustino rimane soltanto lo scontro tra le due grandi potenze di Oriente e Occidente tra Filippo e Roma Questa prospettiva bipolare dei discorsi trogiani si ritrova nel-la conclusione del capitolo che se da un lato sottolinea ancora una vol-ta il timore di Filippo per Cartaginesi e Romani dallrsquoaltro esplicita che i Romani avevano paura dellrsquoantica gloria dei Macedoni laquovincitori dellrsquoO-rienteraquo e soprattutto di Filippo laquoinfiammato dallo zelo di emulare Ales-sandro che era ben noto come pronto alle guerre e instancabileraquo24
41-11 La Prima Guerra Macedonica
Dei prodromi della Prima Guerra Macedonica Giustino si interessa sol-tanto allrsquoalleanza antiromana tra Annibale e Filippo Questo trattato egrave noto da molte fonti secondo cui Filippo dopo aver appreso che i Roma-ni erano stati sconfitti di nuovo dai Cartaginesi a Canne nel 216 avreb-be mandato unrsquoambasceria ad Annibale per proporre unrsquoalleanza ma lrsquoambasciatore macedone sarebbe stato catturato da Roma sulla via del ritorno25
24 Iust XXIX 3 8 quippe terrebat eos et uetus Macedonum deuicti Orientis gloria et Philippus studio Alexandri aemulationis incensus quem promptum in bella industriumque cognouerant Alla gloria dei Macedoni avevamo giagrave trovato riferimento nei discorsi del libro XXVIII degli Etoli (2 12) e di Antigono Dosone (3 14) 25 Secondo Polyb VII 9 17 Filippo avrebbe aiutato Cartagine nella guerra con Roma in cambio di Corcira Epidamno e Apollonia e della restituzione a Demetrio di Faro del suo regno Inoltre Filippo e Annibale si impegnavano a soccorrersi a vicenda in caso di
IL DISCORSO DEL RE 129
A prescindere dai dettagli del fermo dellrsquoambasciatore macedone da parte romana egrave possibile fare qualche osservazione sul nesso tra questo lsquoincidentersquo diplomatico e lo scoppio della guerra Cassio Dione e Ap-piano riportano che la cattura del legato avrebbe causato una vendetta di Filippo contro i protettorati romani in Adriatico in particolare Cor-cira26 notizia assente in Polibio come in Livio e Plutarco (che da Poli-bio dipendono)27 In questi ultimi autori lrsquoattacco di Filippo in Adriati-co infatti non sarebbe legato allrsquoepisodio dellrsquoambasciatore ma alla de-cisione del sovrano di rompere con il consigliere Arato e di dare ascol-to ai cattivi consigli di Demetrio di Faro presa dopo la spedizione a Mes-sene nel 215214 La tradizione polibiana legge infatti in questi eventi la manifestazione del cambiamento dellrsquoindole di Filippo V da giusta a empia iniziata con lrsquoepisodio della stasis di Messene del 215 e compiu-ta con lrsquoassassinio di Arato del 21328 Nel libro XXIX di Giustino ben-cheacute si conservi traccia dellrsquoindole aggressiva di Filippo e del consiglio di Demetrio di Faro come prodromi dello scontro con Roma non vi sono indizi della metaboleacute del sovrano da giusto a empio e malvagio e neppu-re del ruolo che in tale cambiamento ricoprigrave lrsquoallontanamento tra Ara-to e Filippo
attacco da parte di Roma Mentre Peacutedech (1964) pp 382-383 ritiene sicura la consulta-zione a Roma di tali documenti Zecchini (2003) pp 123-141 come prima di lui Walbank (1957) I p 32 n 4 non ne egrave certo poicheacute Polibio viaggiograve proprio per poter reperire documenti e informazioni sugli eventi dove essi avvennero Altre fonti Liv XXIII 38 7 Plut Arat 51 2 Dio C XV 4 2 e App Mak Fr 1 Sul confronto delle fonti vd DrsquoAgostini (2011) pp 99-121 Sul trattato macedone-cartaginese vd Cassola (1962) pp 65-66 Wal-bank (1967) II pp 42-44 Will (19822) pp 83-84 Barreacute (1983) Longaretti (1989) pp 183-192 Golan (1995) pp 45-46 Eckstein (2008) pp 83-85 Intrieri (2011) pp 53-8226 Dio C XV 4 2 e App Mak Fr1 Filippo per vendicarsi della cattura del proprio amba-sciatore non solo attaccograve Corcira ma saputo dellrsquoarrivo di Levino durante la ritirata da Corcira saccheggiograve anche Apollonia e Orico alleate romane Levino avrebbe poi sconfit-to Filippo e recuperati gli alleati costringendo il re a bruciare le proprie navi e rientrare via terra Si riferisce a questo episodio probabilmente il Mak Fr 9 di Appiano che riporta lrsquoordine di Filippo di uccidere quanti erano sulle navi percheacute non dicessero ai Romani che le forze macedoni erano stremate DrsquoAgostini (2011) pp 99-12127 Polyb V 108-110 Liv XXIV 40 e Plut Arat 51 2 non menzionano Corcira nella narra-zione dellrsquoalleanza macedone-cartaginese e della cattura dellrsquoambasciatore Secondo Liv XXIII 38 7 lrsquoambasciatore sarebbe stato trattenuto a Roma 28 Polyb VII 11 8-11 e Plut Arat 49 1 Coppola (1993) pp 205-210 Dai frammenti di Polyb VII 10-12 e dalla narrazione di Plut Arat 49-51 sappiamo che Filippo era interve-nuto nella stasis di Messene tra oligarchici e democratici ma aveva di nascosto lasciato che i cittadini si massacrassero Una volta giunto Arato la guerra civile fu finalmente sedata ma il sovrano avrebbe voluto su consiglio di Demetrio di Faro approfittare della situazione e imporre una guarnigione nellrsquoacropoli della cittagrave che gli avrebbe conferito un vantaggio strategico per il controllo del Peloponneso Arato dissuase Filippo da per-seguire unrsquoazione militare in Peloponneso ma il re decise su consiglio di Demetrio di rivolgere la sua aggressivitagrave verso lrsquoIlliria prima e i protettorati romani Orico e Apollonia poi
130 MONICA DrsquoAGOSTINI
Dopo aver accennato alla stipula del trattato Giustino affastella ne-gli ultimi paragrafi del capitolo 4 gli eventi tra il 215 e il 205 quando Fi-lippo siglando la pace con Roma pone fine alla Prima Guerra Macedo-nica29 In particolare lrsquoEpitomatore sottolinea da un lato lrsquoingresso in guerra degli Etoli al fianco dei Romani e la successiva alleanza del preto-re Levino con Attalo dallrsquoaltro gli attacchi subiti da parte dei Dardani da Filippo oppresso dalle richieste degli Illiri Il libro dunque si chiude con Filippo in difficoltagrave aggravate dalla comparsa di Filopemene il leader degli Achei30 urtatosi con il re dei Macedoni convince la Lega Achea a staccarsi dallrsquoalleanza con la Macedonia sempre piugrave isolata Tale allon-tanamento egrave considerato da Giustino lrsquoesito di un fallito agguato a Fi-lopemene commissionato da Filippo V e dovuto al sospetto di un tradi-mento del condottiero acheo a favore di Roma Bencheacute anche Plutarco (Fil 12 2) e Pausania (VIII 50 4) menzionino il tentativo di assassinio di Filopemene da parte di Filippo la notizia dellrsquoatteggiamento filoroma-no del generale acheo non parrebbe vicino al ritratto polibiano che ve-de in Filopemene un eroe dellrsquoautonomia e dellrsquoindipendenza achea31
Libro XXX11-39 Cinoscefale
Lrsquoesordio del libro XXX introducendo il grande scontro di Cinoscefale tra Romani e Macedoni riprende la celebrazione della gloria macedo-ne argomento centrale dei discorsi del libro XXIX Con lrsquoeccezione dei primi capitoli sul deplorevole comportamento di Tolemeo IV in Egit-to32 il libro egrave infatti totalmente dedicato allo scontro tra le due potenze
29 Errington (2008) pp 185-190 La guerra egrave nota a noi soprattutto dai frammenti dei libri VIII-XI di Polibio dai passi di Liv XXIV 40 1-17 XXVI 24 1-26 4 XXVII 30 5-33 5 e XXVIII 5 1- 9 1 XXIX 12 1-15 e dalla Vita di Filopemene di Plutarco La sinteticitagrave del riassunto giustineo impedisce un puntuale paragone delle tradizioni Ad esempio la notizia dellrsquoalleanza tra Attalo e Roma sembra tornare in Liv XXVIII 5 1-4 dove perograve non troviamo Levino ma Sulpicio come rappresentante romano personaggio scompar-so in Giustino In maniera simile la pace di Fenice del 205 egrave sintetizzata in Giustino in una riga e non vi egrave traccia delle lunghe trattative che coinvolsero come mediatori anche Egitto Chio Mitilene e Atamania portarono a una prima pace separata tra Filippo e gli Etoli nel 206 e poi alla pace con Roma Le fonti parallele sono molto piugrave dettagliate anche su questi eventi Polyb XI 4 1-6 9 Liv XXVIII 5 13 e XXIX 12 8-16 e App Mak fr III Degno di nota egrave perograve il commento in Giustino secondo cui laquoi Romani erano per il momento soddisfatti di aver rinviato la guerra contro la Macedoniaraquo Lrsquointenzione ro-mana di riprendere la guerra con la Macedonia egrave infatti presente in tutte le fonti Polyb XI 6 7 Liv XXIX 1216 Dio C XVIII 9 (15) e App Mak Fr III e verragrave ripresa al libro XXX dellrsquoEpitome 30 Su Filopemene e Filippo vd Errington (1969) pp 51-69 e 83-84 vd anche Golan (1995) pp 115-132 Eckstein (2008) pp 103 e 360-36131 Pelling (1997) pp 135-13932 Lrsquoesordio del libro XXX egrave dedicato alle scabrose imprese del sovrano egiziano ovvero
IL DISCORSO DEL RE 131
dellrsquoEst e dellrsquoOvest La prima avvisaglia dellrsquoincombente guerra egrave la no-tizia dellrsquoaccordo di Filippo V e Antioco III per la spartizione dellrsquoEgitto governato dal sovrano-bambino Tolemeo V Il sovrano lagide nel 2032 chiese aiuto ai Romani che secondo TrogoGiustino gradirono la ri-chiesta drsquoaiuto percheacute cercavano pretesti per muovere guerra contro Fi-lippo A partire da Polibio numerose altre fonti ci testimoniano questo episodio mettendolo in relazione con lo scoppio della Seconda Guerra Macedonica ed esprimendo una condanna morale per lrsquoempia condotta del re antigonide che cospira contro un bambino33 al contrario nellrsquoE-pitome si esalta la potenza macedone evidenziando la paura dei Romani delle grandi imprese di Filippo (XXX 3 2)
nullius magis arma metuebant reputantibus quantum motum Pyrrhus parua Macedo-num manu in Italia fecisset quantasque res Macedones in Oriente gessissent
di nessun altro temevano maggiormente le armi poicheacute ripensavano a quanto sconvolgimento Pirro aveva provocato in Italia con una piccola schiera di Ma-cedoni e a quanto grandi imprese i Macedoni avevano compiuto in Oriente
La supremazia macedone egrave anche al centro del discorso in oratio obliqua di Filippo allrsquoincontro nel Golfo Maliaco tra i rappresentanti dei fronti coinvolti nella Seconda Guerra Macedonica34 NellrsquoEpitome infatti dopo
la Quarta Guerra Siriaca conclusa con sconfitta a Rafia contro Antioco III nel 217 e la corruzione del sovrano da parte di Agatocle e della sorella una cortigiana che avrebbe sedotto il re Giustino riferisce poi la morte del sovrano nel 204 e lrsquoascesa al trono del piccolo Tolemeo V Epifane sovrano sotto tutela di Tlepolemo dopo la morte di Agatocle e Sosibio 33 Eckstein (2008) pp 121-180 Thornton (2014) pp 65-88 In particolare sulla relazione tra il complotto e la sconfitta antigonide e seleucidica ad opera di Roma la superioritagrave morale romana ai regni ellenistici e la causalitagrave storica in Polibio (XV 20 6) vd Eck-stein (2008) pp 133-138 Ager (2009) pp 15-43 Landucci Gattinoni (2011) pp 89-105 Secondo Polyb III 2 8 XV 20 XVI 1 8-9 seguito da Liv XXXI 14 5 Filippo avrebbe ottenuto le basi tolemaiche in Egeo Samo e la Caria mentre Antioco avrebbe finalmente avuto mano libera in Celesiria e Fenicia oggetto di quasi un secolo di lotte tra Tolemei e Seleucidi La notizia del trattato permette a Polibio di dedicare alcuni paragrafi (XV 20) a condannare aspramente lrsquooperato di Filippo V e Antioco III definendoli empi e senza pudore e dichiarando che la Fortuna punigrave i due sovrani per il loro crudele operato por-tando i Romani contro di loro vd infra App Mak Fr IV trasmette delle clausole secondo cui Antioco avrebbe avuto lrsquoEgitto e Cipro mentre Filippo avrebbe ottenuto Cirene le Cicladi e la Ionia Infine secondo Porfirio FGrHist 260 F 45 lrsquoaccordo prevedeva che i due sovrani annettessero i possedimenti tolemaici confinanti con i rispettivi regni 34 Prima si menziona unrsquoambasceria del Senato a Filippo e Antioco percheacute laquosi astenessero dallrsquoEgittoraquo e la visita di Lepido in Egitto Quindi le lamentele a Roma di Attalo e i Rodii nei confronti di Filippo Egrave probabile che a questo punto Trogo inserisse la campagna di Filippo in Asia contro Attalo menzionata nel Prologo XXX ma tagliata nellrsquoEpitome La cronologia degli scambi diplomatici precedenti la Seconda Guerra Macedonica egrave stra-volta dalla sintesi dellrsquoEpitomatore e rende impossibile qualsiasi confronto con le altre
132 MONICA DrsquoAGOSTINI
il riassunto delle ambascerie nel Mediterraneo preludio allo scontro della prima fase della guerra35 maggior spazio egrave dato al tentativo di pa-ce a Nicea tra Roma Attalo i Rodii gli Achei e gli Etoli e Filippo V nel 198 In questa occasione Filippo rivendica la posizione di dominio dei Macedoni sui Greci ereditata da Filippo II e Alessandro suoi antenati e in virtugrave di tale supremazia macedone rifiuta che i Greci gli dettino le condizioni di pace ma chiede che sia il Senato a decidere Egrave significati-vo che non solo il discorso di Filippo non compaia in nessuna delle fon-ti parallele che descrivono nel particolare le posizioni degli ambasciato-ri di Achei Etoli Rodii e Attalo ma che Polibio (XVIII 8 8)36 affermi che era difficile sapere cosa si fossero detti Filippo e Flaminino durante i colloqui nel Golfo Maliaco Secondo la tradizione polibiana infatti il sovrano accompagnato da due philoi macedoni Apollodoro e Demoste-ne chiese di allontanare dalle trattative tutti tranne i Romani e discus-se la pace solamente con Flaminino Successivamente a causa dellrsquoinca-pacitagrave di trovare un accordo Filippo chiese due mesi di tregua e lrsquointer-vento del Senato Trogo dunque restituisce il discorso che il resto della tradizione riteneva impossibile da conoscere indicando chiaramente la presenza di una fonte diversa rispetto a Polibio su questo avvenimento piugrave informata sul punto di vista di Filippo e interessata a evidenziare la convinzione di Filippo V di avere un diritto di supremazia sulla Grecia in virtugrave delle imprese di Filippo II e Alessandro
La battaglia di Cinoscefale nel 197 momento risolutivo dello scontro tra Roma e Macedonia egrave lrsquoevento principale del libro XXX omina e pre-sagi introducono lrsquoevento campale lrsquoeruzione del vulcano di Santorini
fonti In Polyb XVI 24 3 App Mak Fr IV Liv XXXI 1 10 21 5 5 Paus I 36 5-6 vi sono differenti versioni della sequenza delle ambascerie che denunciarono a Roma lrsquoe-spansionismo macedone ma tutte concordano che le ambascerie precedettero lrsquoinvio dei legati romani in Oriente e che esse furono inviate anche da Atene e dagli Etoli Inoltre secondo la tradizione polibiana (Polyb XVI 27 1-4 34 1-7 Liv XXXI 2 3 6 3-8 4 18 1-9 Diod XXVIII 6) vi furono due diverse ambascerie di cui la seconda sarebbe stato un ultimatum al sovrano recapitato da Lepido In occasione di questa seconda ambasceria avvenuta durante il cruento assedio di Abido Filippo avrebbe detto che i Macedoni in ca-so di guerra si sarebbero difesi con valore In Giustino si puograve notare che ancora una volta dagli eventi sono omesse notizie fondamentali sui Greci nello specifico lrsquoambasceria di Atene la cui disputa con gli Acarnani fu il casus belli della guerra contro Filippo 35 Come i prodromi anche la prima parte della Seconda Guerra Macedonica egrave sintetizza-ta in Giustino e occupa solamente due paragrafi Come spesso accade nei passi sintetiz-zati dallrsquoEpitomatore si trovano le incongruenze maggiori con le fonti parallele tra cui si nota soprattutto la completa omissione di Giustino delle campagne di Publio Sulpicio Galba Massimo di Villio delle vittorie di Tito e Lucio Flaminino e dellrsquoassemblea del 198 che portograve gli Achei ad allearsi con Roma Polyb XXII e Liv XXXI 14 1- 46 16 XXXII 1 1-25 12 App Mak Fr VII Plut Fil 17 4 Flam 5 4 e Paus VII 8 1-236 Le trattattive sono descritte con particolari in Polyb XVIII 1-12 seguito da Liv XXXII 32 6-36 10 e Plut Flam 5 8 e 7 1-3
IL DISCORSO DEL RE 133
nel 197 e lrsquoemergere dellrsquoisola di Hiera e in contemporanea il terremo-to a Rodi Quindi nellrsquoEpitome si annuncia che laquoil nascente impero dei Romani avrebbe divorato quello antico dei Greci e dei Macedoni37raquo Nel passo ricevono spazio soprattutto i due discorsi contrapposti del re ma-cedone Filippo e del comandante romano Flaminino pronunciati pri-ma dello scontro campale e costruiti ciascuno in modo da celebrare le imprese delle due potenze38 Lrsquoenfasi data dalla contrapposizione reto-rica delle parole dei generali egrave tale da rendere suggestiva lrsquoipotesi che lo scontro dovesse essere il momento centrale non solo del libro XXX ma forse di tutta lrsquoopera trogiana
Filippo elenca le grandi vittorie del passato dei Macedoni contro Per-siani Battriani Indiani e le popolazioni drsquoAsia fino allrsquoestremo Orien-te esortando i suoi a combattere con valore percheacute laquola libertagrave egrave piugrave cara del predominio39raquo Il discorso di Flaminino egrave invece piugrave lungo articola-to in un paragone tra Macedoni e Romani alle passate imprese di con-quista macedoni vengono contrapposte le piugrave recenti vittorie romane a Cartagine in Sicilia Italia e Spagna alla grandezza di Alessandro Ma-gno egrave contrapposta quella di Annibale che pure dai Romani era stato sconfitto Lrsquoattenzione poi si concentra su Filippo i Macedoni non laquodo-vevano essere valutati per lrsquoantica forza ma per le forze attuali40raquo poicheacute Filippo non era lrsquoinvitto e invincibile Alessandro Magno ma un ragaz-zo che non riusciva a difendere i propri confini I Macedoni rivendica-vano il valore degli antenati mentre i Romani quello dei propri soldati poicheacute quelli che erano ligrave schierati erano gli stessi che avevano sconfitto Annibale Dopo una cosigrave grandiosa introduzione la battaglia egrave descritta in uno dei paragrafi piugrave significativi di tutta lrsquoopera
His adhortationibus utrimque concitati milites proelio concurrunt alteri Orientis alteri Occidentis imperio gloriantes ferentesque in bellum alii maiorum suorum antiquam et ob-soletam gloriam alii uirentem recentibus experimentis uirtutis florem [16] Sed Macedo-nas Romana Fortuna uicit
I soldati incitati da queste esortazioni dallrsquouna e dallrsquoaltra parte si lanciaro-no nel combattimento vantandosi gli uni del dominio dellrsquoOriente gli altri dellrsquoOccidente e recando in guerra gli uni lrsquoantica e sbiadita gloria dei loro an-
37 Iust XXX 4 4 Quo prodigio territis omnibus uates cecinere oriens Romanorum imperium uetus Graecorum ac Macedonum uoraturum38 Sui discorsi precedenti la battaglia nellrsquoantichitagrave se da considerare reali o costruzioni storiografiche vd Adler (2011) pp 6-839 Iust XXX 4 7 tantoque hoc bellum fortius quam illa sustinendum quanto sit imperio libertas carior40 Iust XXX 4 10 Sed nec Macedonas ueteri fama sed praesentibus uiribus aestimandos
134 MONICA DrsquoAGOSTINI
tenati gli altri il fiore del loro valore fresco e vigoroso per le recenti prove Ma la Fortuna dei Romani vinse i Macedoni
Questo punto di vista probabilmente giagrave trogiano contrappone la virtugrave romana (virtutis flos) celebrata nei discorsi antecedenti la battaglia al-la Fortuna romana (Romana Fortuna) che decise la vittoria interpretabi-le come destino favorevole o buona stella Piugrave che unrsquoaffermazione anti-romana41 come egrave spesso stata intesa si puograve evidenziare il carattere sim-patetico della fonte verso Filippo V destinato a porre fine alla gloria di Filippo II e Alessandro e forse un approccio nostalgico verso i grandi regni macedoni la cui egravera egrave ormai giunta alla fine Tale prospettiva egrave as-sente in Polibio e nella tradizione che da lui dipende poco interessata alle vicende della gloria macedone leggendo infatti i frammenti soprav-vissuti del libro XVIII delle Storie dopo lrsquoaccurata descrizione della bat-taglia (18-33 e 34-40)42 Polibio commenta lo scontro affermando che avrebbe dedicato alcuni capitoli allrsquoesame delle strategie militari delle due armate percheacute (XVIII 28 4-6)
χρήσιμον καὶ καλὸν ἂν εἴη τὸ τὴν διαφορὰν ἐρευνῆσαι καὶ παρὰ τί συμβαίνει Ῥωμαίους ἐπικρατεῖν καὶ τὸ πρωτεῖον ἐκφέρεσθαι τῶν κατὰ πόλεμον ἀγώνων [5] ἵνα μὴ τύχην λέγοντες μόνον μακαρίζωμεν τοὺς κρατοῦντας ἀλόγως καθάπερ οἱ μάταιοι τῶν ἀνθρώπων ἀλλ᾽ εἰδότες τὰς ἀληθεῖς αἰτίας ἐπαινῶμεν καὶ θαυμάζωμεν κατὰ λόγον τοὺς ἡγουμένους
Puograve essere cosa buona e utile esaminare le differenze e per quale motivo i Ro-mani prevalgono e riportano il primo premio nelle competizioni di guerra af-fincheacute non esaltiamo i vincitori senza una ragione parlando solo di fortuna co-me fanno gli sciocchi ma conoscendo le vere cause lodiamo e ammiriamo i co-mandanti seguendo una logica
Polibio dunque sembra rispondere a coloro che parlavano della buo-na stella dei Romani sottolineando che la vittoria nasceva dalla superio-re strategia militare della legione43 Un punto di vista quindi opposto a quello espresso nellrsquoEpitome che proprio di Romana Fortuna parla e riba-dito in chiusura al passo dove Polibio critica nuovamente quei Greci che ritenevano la vittoria romana incredibile (XVIII 32 13)
41 Urban (1982) pp 1424-1443 1435 Richter (1987) p 19 n 4 Alonso-Nuacutentildeez (1992) p 66 e Id (2002) pp 105-110 partic 108-109 Contra Heckel (1997) p 29 che ridimen-siona la categorizzazione di Trogo come storico anti-romano 42 Su Cinoscefale vd Walbank (1957) ad l Hammond (1988) pp 60-82 Sklenaacuter (2004) pp 302-310 Thornton (2014) pp 83-87 43 Sulla Fortuna in Polibio vd McGing (2010) pp 195-201 (con bibliografia) che distin-gue tra quando Polibio intenda caso e quando predeterminazione fato Vd anche Green (1990) pp 400-402 e Eckstein (2008) pp 132-138
IL DISCORSO DEL RE 135
Il punto di vista di Trogo sembra invece presente nei frammenti del-la Makedonikeacute di Appiano su Filippo V44 dove ci si riferisce a Cinoscefale come a una vittoria insperata (Mak 9 1)
ἡγούμενος δ᾽ οὔτε Ῥωμαίοις συμφέρειν οὔτε τοῖς Ἕλλησι Φιλίππου καθαιρεθέντος ἐπιπολάσαι τὴν Αἰτωλῶν βίαν τάχα δ᾽ αὐτὸν καὶ τὸ παράδοξον τῆς νίκης ἀγαπᾶν ἐποίει
Flaminino era consapevole che non sarebbe stato vantaggioso per i Romani o per i Greci che Filippo fosse deposto e che il potere etolico rimanesse incon-trastato forse lo aveva reso moderato nei suoi progetti lrsquoaver ottenuto una vit-toria insperata
Addirittura successivamente si accenna alla sorte avversa a Filippo nel-lo scontro
τὰ μὲν δὴ παρὰ τῶν ἄλλων φιλάνθρωπα ἦν τό τε τῆς τύχης ἄδηλον ἐξ ὧν ἔπαθεν ὁ Φίλιππος ὑφορωμένων καὶ τὸ πταῖσμα τοῦτο οὐ κατ᾽ ἀσθένειαν ἀλλὰ πλέον ἐκ συντυχίας αὐτὸν παθεῖν ἡγουμένων
Gli altri (Greci) erano inclini ad essere moderati vedendo con sospetto lrsquoincer-tezza della fortuna subita da Filippo e ritenendo che egli fosse incorso in questa sconfitta non tanto per la sua inferioritagrave quanto per la sfortuna
Il riferimento in Appiano e Trogo alla fortuna romanasfortuna ma-cedone a proposito di Cinoscefale egrave una traccia dellrsquoopinione politi-ca di quei Greci disprezzati da Polibio come uomini sciocchi καθάπερ οἱ μάταιοι τῶν ἀνθρώπων Tale posizione politica su Cinoscefale sarebbe dunque sopravvissuta nella tradizione storiografica di cui troviamo trac-cia in TrogoGiustino e Appiano
Per comprendere meglio alcune caratteristiche di questa tradizione puograve essere utile tornare ai due discorsi nellrsquoEpitome di Filippo e Flamini-no prima della battaglia Tali passi probabilmente trogiani45 non trova-no infatti riscontro nelle fonti parallele a noi pervenute Polibio (XVIII 18-27) seguito fedelmente da Livio (XXXIII 5-10) pur descrivendo le operazioni di guerra di Cinoscefale con dovizia di particolari non men-ziona un discorso di Filippo ai suoi armati prima della battaglia mentre il discorso di Flaminino per incoraggiare le truppe schierate (XVIII 23 2-6) nelle Storie egrave incentrato sulle vittorie di Sulpicio nella prima parte della guerra Pare dunque originale la versione trogiana che incentra-
44 Tra i frammenti consegnatici dagli Excerpta Constantiniana sono frequenti informazio-ni e osservazioni che rimandano a una prospettiva ellenistica sugli eventi DrsquoAgostini (2011) pp 99-121 45 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362
136 MONICA DrsquoAGOSTINI
ta sulla gloria macedone presenta Cinoscefale come il punto drsquoincon-tro e di scambio tra lrsquoegemonia macedone e lrsquoegemonia romana Non egrave una novitagrave che il leitmotiv delle Storie Filippiche e dunque dellrsquoEpitome sia la translatio imperii giagrave Alonso Nuntildeez definito da Santi Amantini laquouno dei piugrave noti esperti di questioni trogiano-giustineeraquo46 osservava che Tro-go esponeva nel suo perduto lavoro la teoria della successione degli im-peri mondiali secondo lo schema Assiria-Media-Persia-Macedonia-Roma osteggiata dai Parti47 In tale successione il ruolo da protagonista egrave rico-perto dallrsquoegemonia macedone48 che occupa allrsquoincirca 26 dei 44 libri e il cui ultimo vero momento di gloria egrave lo scontro con Roma appunto a Cinoscefale Lrsquoultima impresa macedone ha come esito la transizione del dominio universale da Oriente a Occidente e costituisce il tema cen-trale dellrsquointera vicenda di Filippo lrsquoimportanza della battaglia di Cino-scefale egrave perciograve esaltata nei discorsi sia di Filippo che di Flaminino che a loro volta sono il punto di arrivo delle argomentazioni esposte nelle parole di Demetrio di Faro e di Filippo stesso giagrave nel libro XXIX Le ora-tiones disposte retoricamente nei due libri descrivono due parabole op-poste da un lato quella romana che da lontana potenza desiderosa di espandersi cresce come una pioggia di sangue diventando il giovane e vigoroso potere che sottomesso Annibale egrave pronto a sconfiggere Filip-po Dallrsquoaltro quella macedone che originata con Filippo II personag-gio centrale per Trogo raggiunge il suo apice con la conquista dellrsquoege-monia ad opera di Alessandro Magno contro i Persiani per conoscere la fine con Filippo V il cui antico valore egrave ormai troppo lsquosbiaditorsquo per te-ner testa al vigore romano
La gloria macedone secondo Trogo inizia dunque con Filippo II e si conclude con Filippo V Perseo egrave infatti il malvagio responsabile dellrsquoan-nientamento di ciograve che rimaneva della monarchia macedone49 Trogo pone agli estremi della parabola macedone che occupa dal libro IX al XXX i due re di nome Filippo Filippo II e Filippo V come ribadito in piugrave luoghi dellrsquoEpitome sia in parti riassunte da Giustino che in passi piugrave genuinamente trogiani Dando per scontato che il titolo dellrsquoopera Sto-rie Filippiche si debba al desiderio di Trogo di rifarsi allrsquoopera di Teopom-po sul sovrano macedone egrave possibile che tale titolo sia stato perograve ripen-
46 Santi Amantini (2003) pp 99-11047 laquoPompeius Trogus expounded in his lost work the Historiae Philippicae a theory of the world empire suggestion according to the scheme Assyria-Media-Persia-Macedonia-Rome opposed by the Parthiansraquo Alonso-Nuacutentildeez (2002) pp 105-110 e 133-136 partic 105 Vd anche Richter (1987) pp 19-23 Momigliano (1980) pp 157-162 Alonso-Nuacutentildeez (1992) Heckel (1997) pp 1-41 Gabba (2003) pp 7-9 Santi Amantini (2003) pp 99-110 Mariotta (2014) pp 45-56 48 Franco (1993) pp 71-97 e Landucci (2014) pp 233-26149 Alonso-Nuacutentildeez (2002) pp 105-110 partic 108-109
IL DISCORSO DEL RE 137
sato da Trogo considerando che il periodo compreso tra le imprese dei due Filippo occupa 23 dellrsquoopera50 Si potrebbe allora suggerire che le Storie sono Filippiche poicheacute i due Filippo segnarono lrsquoinizio e la fine di quella che egrave nellrsquoopera di Trogo lrsquoegemonia incontrastata del mondo piugrave gloriosa di tutti i tempi51
La prospettiva ellenistica che vede nei due Filippo i limiti della grande egemonia macedone egrave di nuovo presente anche in Appiano nellrsquooraco-lo riportato nei frammenti della sua Makedonikeacute e noto anche da Pausa-nia (VII 8 9)
αὐχοῦντες βασιλεῦσι Μακηδόνες Ἀργεάδῃσιν ὑμῖν κοιρανέων ἀγαθὸν καὶ πῆμα Φίλιππος ἤτοι ὁ μὲν πρότερος πόλεσιν λαοῖσί τ᾽ ἄνακτας θήσει ὁ δ᾽ ὁπλότερος τιμὴν ἀπὸ πᾶσαν ὀλέσσει δμηθεὶς δ᾽ ἑσπερίοισιν ὑπ᾽ ἀνδράσιν ἐνθάδ᾽ ὀλεῖται
O Macedoni che andate orgogliosi dei re di stirpe argiva I re di nome Filippo saranno arbitri del bene e del male per voi Il primo vi renderagrave signori di cittagrave e popoli il secondo vi priveragrave di ogni onore sconfitto da uomini dellrsquoOcciden-te qui giace morto52
Senza voler entrare nel merito della discussione di tale oracolo di nuo-vo pare di incontrare nei due autori la medesima prospettiva lontana dalla condanna morale del re macedone espressa da Polibio secondo cui la sconfitta egrave il giusto esito della sua crudeltagrave ed empietagrave
Il libro giustineo si conclude menzionando le condizioni della pa-ce di Tempe53 e lrsquoira degli Etoli che videro ignorate le proprie richieste da Flaminino e perciograve cercarono lrsquoalleanza di Antioco contro Roma Se-condo il Prologo XXX il libro perograve proseguiva con le campagne di Antio-co III in Asia Minore contro Molone e Acheo e in Battriana fino ad ar-rivare allrsquoesordio dello scontro con Roma54 Il riassunto giustineo egrave trop-po sommario per permettere un confronto con le fonti parallele Egrave pe-
50 Sul rilievo della storia della Macedonia nellrsquoopera di Trogo e Giustino vd von Gutsch-midt (1894) pp 17-217 Richter (1987) p 28 n 29 Franco (1993) pp 71-97 51 Vd anche Urban (1982) pp 1424-1443 e Alonso-Nuacutentildeez (1992) p 58 52 Mak Fr 2 Vd DrsquoAgostini (2011) pp 99-121 In questa Walbank (2002) pp 127-136 propone di interpretare anche un poema di Alceo di Messene (Anth Pal 9518)53 Egrave probabile che Trogo fornisse piugrave particolari riguardo a questa pace per esempio si puograve ritenere che vi fosse menzione dellrsquoinvio a Roma del figlio Demetrio da parte di Filippo come ostaggio dato che a Iust XXXII 2 3 si richiama appunto tale avvenimento54 Polyb XVIII 34 1-39 7 42 1-45 12 Liv XXXIII 11 3-13 15 24 1-31 11 Plut Flam IX 1-8 App Mak Fr IX riferiscono di due diverse trattative di pace caratterizzate da un vivace dibattito tra chi voleva lrsquoannientamento della Macedonia come in Grecia gli Etoli e a Roma Marco Claudio Marcello e coloro che desideravano la pace con la Macedonia in primis Flaminino
138 MONICA DrsquoAGOSTINI
rograve da notare la mancanza sia nel Prologo che nel testo del libro degli av-venimenti delle celebrazioni Istmie del 196 quando Flaminino procla-mograve la libertagrave dei Greci Piugrave in generale in tutta la narrazione di Giustino delle complesse trattative del 197-196 manca qualsiasi riferimento alla li-bertagrave dei Greci punto nodale nella tradizione di Polibio che con questa sottolineatura esalta sia il ruolo tirannico della Macedonia sia la grande generositagrave dei Romani nei confronti della Grecia Il silenzio di TrogoGiustino su tale questione mostra il prevedibile disinteresse per gli affari dei Greci e nel contempo conferma la presenza di una tradizione che si occupa soprattutto della storia delle monarchie ellenistiche allrsquointer-no della quale la posizione dellrsquoEllade egrave subalterna
Libro XXXII23- 34 Demetrio e Perseo
Gli ultimi anni di regno di Filippo tra il 183 e il 179 sono narrati in un passo breve del libro XXXII Il racconto in Giustino che egrave coerente con il Prologo trogiano segue in maniera sintetica la tradizione polibiana su questi eventi giunta a noi in alcuni passi lacunosi di Polibio (XXIII 1 3-3 10 7 1-7 10 1-11 8) integrati dal racconto particolareggiato di Li-vio (XXXIX 46 7- 48 6 53 1-16 XL 3 3-16 3 201-24 8) e dalla narra-zione di Diodoro (XIX 25) e Plutarco (Aem VIII 11)55
Conclusioni
In questi libri dedicati a Filippo egrave forse possibile vedere in filigrana la rielaborazione voluta di Giustino dei corrispondenti libri trogiani Co-me Giustino stesso afferma nella Prefatio 3 lrsquoopera di Trogo era costruita secondo due criteri quello cronologico e quello per laquoconcatenazione di eventi56raquo ea omnia Pompeius diuisa temporibus et serie rerum digesta conposuit
55 Lrsquoutilizzo della tradizione polibiana in Trogo egrave confermato dallrsquoaderenza a Livio (XL 54 1-56 11) e Diodoro (XXIX 28) del racconto sul pentimento di Filippo per aver ucciso il figlio Demetrio lrsquointenzione di punire Perseo e la correlazione tra questo e la sua mor-te Questo libro egrave dunque differente nellrsquointeresse e nelle fonti dai libri XXIX e XXX poicheacute molto vicino alla tradizione polibiana in Livio Questi avvenimenti in Giustino sono da collegare con lrsquoascesa al trono di Perseo e non con lrsquoepilogo della celebrazione del valore macedone giagrave conclusasi in Giustino con Cinoscefale e la transizione dallrsquoim-perium macedone allrsquoimperium romano Vd Heckel (1997) p 7 Appiano invece riporta ancora una tradizione diversa da quella polibiana in un frammento della Makedonikeacute in particolare Appiano egrave attento al punto di vista macedone e presenta Filippo come una vittima delle circostanze (Mak IX) DrsquoAgostini (2011) pp 99-12156 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362 Alonso-Nuacutentildeez (2002) pp 133-136 He-ckel (1997) pp 1-41 Borgna (2014) pp 52-77
IL DISCORSO DEL RE 139
Serie rerum digesta sembrerebbe unrsquointerpretazione latina della formula κατὰ γένος che Diodoro usa per indicare la struttura della storia di Efo-ro sottolineandone la divisione per argomento57 In tale struttura per argomento dellrsquoEpitome tra i temi principali ci sono dunque il valore e la gloria dei sovrani ellenistici58 riscontrabile nei libri XXVIII-XXXI sui re-gni di Antigono Dosone Filippo V e Antioco III Tale tema presente di sicuro in Trogo egrave conservato nellrsquoazione dellrsquoEpitomatore e anzi come si vede dagli escerpta esaltato dalla selezione dei passi
Per quanto riguarda invece la Quellenforschung 59 egrave evidente che nel testo vi sia presenza di filoni non tradizionali sugli eventi poicheacute la posi-zione di Trogo appare spesso autonoma rispetto alle opinioni condivise dalla storiografia antica Questo aspetto dellrsquoEpitome evidente soprattut-to per ciograve che riguarda gli eventi ellenistici ha suscitato la grande curio-sitagrave degli studiosi che allontanatisi dalla proposta di von Gutschmid che voleva una totale ed esclusiva dipendenza di Trogo da Timagene ora in-dicano con sicurezza tra le fonti piugrave rilevanti per gli eventi ellenistici di III secolo utilizzate da Trogo almeno altri sei nomi oltre a Timagene Ie-ronimo Timeo Filarco Duride Polibio e Posidonio
Per quanto riguarda nello specifico la composizione dei libri XXIX e XXX non vi egrave alcun dubbio che in essi Trogo abbia utilizzato (anche riadattandola) una fonte poco attenta alle questioni di politica interna greca e al legame tra queste e quel ritratto di Filippo come sovrano mal-vagio ed empio che ritorna nella tradizione ufficiale di origine polibia-na passando poi da Polibio in Livio Diodoro e Plutarco60 Trogo pre-serva invece una tradizione ellenistica interessata alla figura di Filippo come ultimo barlume della gloria macedone tradizione che pare quasi una controparte e un completamento dellrsquoAb urbe condita romanocentri-ca di Livio Non si puograve perciograve a mio avviso escludere che per questa se-zione Trogo abbia usato una tradizione di matrice filoellenistica o sem-plicemente ellenisticocentrica unrsquoopera sui regni di diadochi ed epigo-ni che a tutti noi fa venire facilmente alla mente il Basileis o Perigrave Basileon dello storico grecoellenistico augusteo filobarbaro scettico (o critico) verso lrsquoegemonia romana Timagene di Alessandria (FGrHist 88)61
57 Su Eforo vd Vannicelli (1987) pp 165-191 e ora Parmeggiani (2011) 58 Simile legame vi egrave a mio avviso tra i libri XXVI e XXVII che invece affrontavano la crisi delle monarchie ellenistiche causata dalle guerre fraterne59 Vd von Gutschmid (1894) pp 17-217 Richter (1987) pp 17-30 partic 20-23 San-ti Amantini (1972) pp 56-109 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362 Urban (1982) pp 1424-1443 partic 1435 Mecca (2001) pp 199-222 Santi Amantini (2003) pp 99-110 Heckel (2012) pp 3-860 Scuderi (2005) pp 383-40561 Sordi (1982) pp 775-797 Heckel (1997) pp 30-34 Landucci (2014) pp 233-261 e Ead in questo volume
140 MONICA DrsquoAGOSTINI
ABSTRACT
Philip V of Macedon was the first of the Epigonoi to face Rome Several mod-ern reconstructions of the actions and the reign of Philip V have approached it largely from a Roman point of view using as sources Polybius and where Poly-bius is lost Livy The Polybian historiographical tradition tends to portray Phil-ip V as an enemy and a tyrant impious and cruel The Macedonian king was ea-ger to establish a universal and unjust dominion over Greece Italy and beyond and Rome engaged in the first two Macedonian Wars to fight the threat of his growing ambition Nevertheless Polybiusrsquo portrayal of Philip V was affected not only by Polybiusrsquo admiration for Roman political structures military power and overwhelming conquest but also his personal Achaean origins
Looking at in book 29 and 30 of Justinrsquos Epitome of Pompeius Trogus this pa-per focuses on the non Polybian tradition on Philip V this contribution is in-deed the first analysis of the Hellenistic approach to the clash between Rome and Macedonia in the 3rd-2nd Century BC The Epitome shows a considerable di-versity of interpretation from the other sources and reflects very different views of Philip Vrsquos actions that brought him into conflict against Rome In particular these views are more evident related to the accounts of the peace negotiations of Naupactus and the battle of Cynoscephalae in the Epitome the king appears as a courageous and skilled warrior the last of the great Macedonian rulers who fell victim to misfortune This portrayal which has several common features with Appianrsquos fragments of Philip V (Mak 9) counterbalances the Roman and Achaean standpoint present in Polybius providing a more Hellenistic perspec-tive that is likely to have been rooted in a historiographical tradition connect-ed to the losing side in the struggle between Rome and the Hellenistic world
BIBLIOGRAFIA
Adler E (2006) Whorsquos Antiroman Sallust and Pompeius Trogus on Mithridates CJ 101 pp 383-407
Adler E (2011) Valorizing the Barbarians Enemy speeches in Roman Historiography Austin
Ager SL (2003) An Uneasy Balance from the Death of Seleukos to the Battle of Raph-ia in A Erskine (ed) A Companion to the Hellenistic World Oxford pp 35-50
Ager SL (2009) Roman Perspectives on Greek Diplomacy The conceptual clash Greek diplomacy of compromise and Roman Bellum Iustum in C Eilers (ed) Diplomats and Diplomacy in the Roman World Leiden-Boston pp 15-43
Alonso-Nuacutentildeez JM (1992) La Historia Universal de Pompeyo Trogo Madrid
Alonso-Nuacutentildeez JM (2002) The Idea of Universal History in Greece From Herodotus to the Age of Augustus Amsterdam
Ballesteros Pastor L (2013) Pompeyo Trogo Justino y Mitriacutedates Comentario al Epiacutetome de las Historias Filiacutepicas (3716-3881) Hildesheim-Zuumlrich-New York
IL DISCORSO DEL RE 141
Barreacute ML (1983) The God-List in the Treaty between Hannibal and Philip V of Ma-cedon a Study in Light of the Ancient Near Eastern Treaty Tradition Baltimore-Lon-don
Beck H - Eckstein A (2015) sv ldquoAratos of Sicyon (231)rdquo in I Worthington (ed) Brillrsquos New Jacoby Brill Online
Borgna A (2014) Uno sguardo originale intorno a Roma Pompeo Trogo e Giustino laquoLa Biblioteca di ClassicoContemporaneoraquo 1 pp 52-77
Cassola F (1962) I gruppi politici romani nel III secolo aC Trieste
Champion CB (1997) The Nature of Authoritative Evidence in Polybios and Agelausrsquo Speech at Naupactos TAPhA 127 pp 111-128
Champion CB (2004) Cultural Politics in Polybiusrsquo Histories Berkeley
Coppola A (1993) Demetrio di Faro un protagonista dimenticato Roma
Criscuolo L (2011) I due testamenti di Tolemeo VIII Evergete II in A Joumlrdens - J F Quack (hrsg) Aumlgypten zwischen innerem Zwist und aumluszligerem Druck Die Zeit Ptole-maios VI bis VIII Wiesbaden pp 132-150
DrsquoAgostini M (2011) Filippo V e la Storia Romana di Appiano laquoAevumraquo 85 pp 99-121
Eckstein AM (1995) Moral vision in the Histories of Polybius Berkeley
Eckstein AM (2008) Rome enters in the Greek East From Anarchy to Hierarchy in the Hellenistic Mediterranean 230-217 BC Oxford
Eckstein AM (2013) Polybius Phylarchus and Historiographical Criticism CPh 108 4 pp 314-338
Errington RM (1969) Philopoemen Oxford
Errington RM (2008) A History of the Hellenistic World 323-30 BC Malden MA-Oxford
Forni G - Angeli Bertinelli MG (1982) Pompeo Trogo come fonte di storia ANRW II 30 2 pp 1298-1362
Franco C (1993) Trogo Giustino e i successori di Alessandro in L Braccesi - A Coppola - G Cresci Marrone - C Franco (a cura di) LrsquoAlessandro di Giustino dagli antichi ai moderni Roma pp 71-97
Gabba E (2003) Introduzione in D Foraboschi - SM Pizzetti (a cura di) La successione degli imperi e delle egemonie nelle relazioni internazionali Milano pp 7-9
Golan D (1995) The Res Graeciae in Polybius Four Studies Como
Green P (1990) Alexander to Actium The Historical Evolution of the Hellenistic Age Berkeley-Los Angeles
Gutschmid von A (1894) Die beiden ersten Buumlcher des Pompeius Trogus in A von Gutschmid - F Ruumlhl (hrsg) Kleine Schriften Leipzig pp 17-217
142 MONICA DrsquoAGOSTINI
Habicht C (1995) Athen Muumlnchen
Hammond NGL (1968) Illyris Rome and Macedon in 229-205 BC JRS 58 pp 1-21
Hammond NGL (1988) The Campaign and the Battle of Cynoscephalae in 197 BC JHS 108 pp 60-82
Heckel W (1997) Introduction (Part 2) in JC Yardley - W Heckel (eds) Ju-stin Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus Books 11-12 Alexander the Great Introduction Oxford pp 1-41
Heckel W (2012) Introduction in JC Yardley - P Wheatley - W Heckel (eds) Justin Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus II Books 13-15 The Successors to Alexander the Great Oxford pp 1-8
Huss W (1976) Untersuchungen zur Auszligenpolitik Ptolemaiosrsquo IV Muumlnchen
Huss W (2001) Aumlgypten in hellenistischer Zeit 332ndash30 v Chr Muumlnchen
Intrieri M (2011) Fra dialogo e conflitto Annibale e i Greci drsquoOccidente RStudFen 37 pp 53-82
Landucci F (2014) Filippo II e le Storie Filippiche un protagonista storico e storio-grafico in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 233-261
Landucci Gattinoni F (2011) Politica e ideologia in etagrave ellenistica laquoPolitica An-ticaraquo 1 pp 89-105
Leacutevy E (1994) Le discours drsquoAgeacutelaos de Naupacte in L Aigner Foresti - A Bar-zanograve - C Bearzot - L Prandi - G Zecchini (a cura di) Federazioni e federalismo nellrsquoEuropa antica Bergamo 21-25 settembre 1992 Milano (Alle radici della casa co-mune europea 1) pp 33-50
Longaretti L (1989) Lrsquoalleanza tra Annibale e Filippo V di Macedonia RIL 123 pp 183-192
Marasco G (1979-1980) La valutazione di Tolemeo IV Filopatore nella storiografia greca laquoSilenoraquo 5-6 pp 159-182
Mari M [- Musti D - Thornton J] (2002) Polibio Storie Volume III Libri V-VI Milano
Mariotta G (2014) Geografia e Geopolitica nelle Storie Filippiche in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 45-56
McGing B (2010) Polybiusrsquo Histories New York
McGing B (2013) Youthfulness in Polybius the case of Philip V of Macedon in B Gibson - T Harrison (eds) Polybius and his world Oxford pp 181-199
Meadows A (2013) Polybius Aratus and the History of the 140th Olympiad in B
IL DISCORSO DEL RE 143
Gibson - T Harrison (eds) Polybius and his World Essays in Honour of Frank Walbank Oxford pp 91-116
Mecca A (2001) Trogo Timagene e Polieno QS 54 pp 199-222
Meister K (1990) Die Griechische Geschichtsschreibung von den Anfaumlngen bis zum Ende des Hellenismus Stuttgart
Misch G (1949) Geschichte der Autobiographie I Frankfurt am Mein
Momigliano A (1980) Daniele e la teoria greca della successione degli imperi RAL 35 pp 157-162
Muccioli F (2013) Gli epiteti ufficiali dei re ellenistici Stuttgart (Historia Einzel-schriften 224)
Musti D (1978) Polibio e lrsquoimperialismo romano Napoli
Parmeggiani G (2011) Eforo di Cuma studi di storiografia greca Bologna
Peacutedech P (1964) La meacutethode historique de Polybe Paris
Pelling CBR [- Scardigli B - Manfredini M](1997) Plutarco Vite parallele Filopemene Tito Flaminino Milano
Richter H-D (1987) Untersuchungen zur hellenistischen Historiographie die Vorla-gen des Pompeius Trogus fuumlr die Darstellung der nachalexandrischen hellenistischen Ge-schichte (Iust 13-40) Frankfurt
Santi Amantini L (1972) Fonti e valore storico di Pompeo Trogo (Iustin XXXV e XXXVI) Genova
Santi Amantini L (1981) (a cura di) Giustino Storie Filippiche Epitome da Pom-peo Trogo Milano
Santi Amantini L (2003) Il tempo e i tempi nelle Storie Filippiche di Pompeo Tro-go RSA 33 pp 99-110
Schepens G (1983) Les rois ptolegravemaiumlques et lrsquohistoriographie Reacuteflexions sur la trans-formation de lrsquohistoire politique in E vanrsquot Dack - P van Dessel - W Van Gucht (eds) Egypt and the Hellenistic World Proceedings of the International Collo-quium Leuven 24-26 May 1982 Leuven (Studia Hellenistica 27) pp 351-368
Schlicher JJ (1933) Non-Assertive Elements in the Language of the Roman Histo-rians CPh 28 289-300
Schmitt T (1989) Die Bedeutung des zweiten Punischen Krieges fuumlr den Frieden in Naupaktos in H Devijver - E Lipinski (eds) Punic wars Proceedings of the Conference held in Antwerp from the 23th to the 26th of November 1988 in Cooperation with the Departement of History of the laquoUniversitait Antwerpenraquo UFSIA Leuven (Studia Phoenicia 10) pp 229-239
Scholten JB (2000) The Politics of Plunder Aitolians and their koinon in the early Hellenistic Era Berkeley
144 MONICA DrsquoAGOSTINI
Scuderi R (2005) Filippo V e Perseo nei frammenti diodorei in C Bearzot - F Lan-ducci (a cura di) Diodoro e lrsquoaltra Grecia Macedonia Occidente Ellenismo nella Bi-blioteca Storica Atti del convegno Milano 15-16 gennaio 2004 Milano pp 383-405
Sklenaacuter RJ (2004) Sources and Individuality in Two Passages of Livy laquoHistoriaraquo 53 pp 302-310
Sordi M (1982) Timagene di Alessandria Uno storico ellenocentrico e filobarbaro ANRW II 30 1 pp 775-797
Thornton J (2014) Le guerre macedoniche Roma
Urban R (1979) Wachstum und Kriese des achaumlischen Bundes Quellenstudien zur entwicklung des Bundes von 280 bis 222 V Chr Wiesbaden
Urban R (1982) laquoGallisches Bewusstseinraquo und laquoRomkritikraquo bei Pompeius Trogus ANRW II 30 2 pp 1424-1443
Vannicelli P (1987) Lrsquoeconomia delle Storie di Eforo RFIC 115 pp 165-191
Vattuone R (2014) Giustino e lrsquoOccidente greco I VI-V secolo aC in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 261-277
Vollmer D (1990) Symploke das Uumlbergreifen der roumlmischen Expansion auf den grie-chischen Osten Untersuchungen zur roumlmischen Aussenpolitik am Ende des 3 Jh V Chr Stuttgart
Walbank FW (1957) A Historical Commentary on Polibius I Oxford
Walbank FW (1967) A Historical Commentary on Polybius II Oxford
Walbank FW (1933) Aratos of Sicyon Cambridge
Walbank FW (2002) Η ΤΩΝ ΟΛΩΝ ΕΛΠΙΣ and the Antigonids in FW Walbank (ed) Polybius Rome and the Hellenistic World Essays and Reflections West Nyack NY pp 127-136
Weber G (1997) Interaktion Repraumlsentation und Herrschaft Der Koumlnigshof im Hel-lenismus in A Winterling (hrsg) Zwischen lsquoHausrsquo und lsquoStaatrsquo antike Houmlfe im Ver-gleich Munich pp 27-72
Will E (19822) Histoire politique du Monde Helleacutenistique II Nancy
Zecchini G (1990) La storiografia lagide in H Verdin - G Schepens - E De Keyser (eds) Purposes of History Studies in Greek Historiography from the 4th to the 2nd Centuries BC Proceedings of the International Colloquium of Leuven 24-26 May 1988 Leuven (Studia Hellenistica 30) pp 213-232
Zecchini G (2003) Polibio e la tradizione orale in A Casanova - P Desideri (a cura di) Evento racconto scrittura nellrsquoantichitagrave classica Firenze pp 123-141
Finito di stamparenel mese di novembre 2015
da LegoDigit srlLavis (TN)
a cura di
CINZIA BEARZOT FRANCA LANDUCCI
STUDI SULLrsquoEPITOMEDI GIUSTINOII DA ALESSANDRO MAGNO A FILIPPO V DI MACEDONIA
VITA E PENSIERORICERCHESTORIA
PP_Bearzot-Landucciindd 3 131115 1550
La pubblicazione di questo volume ha ricevuto il contribu-to finanziario dellrsquoUniversitagrave Cattolica ed egrave stata realizzata grazie al contributo del Progetto PRIN 2010-2011 del Mini-stero dellrsquoIstruzione dellrsquoUniversitagrave e della Ricerca
wwwvitaepensieroit
Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15 di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dallrsquoart 68 commi 4 e 5 della legge 22 aprile 1941 n 633Le fotocopie effettuate per finalitagrave di carattere professionale economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi Cen-tro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali Corso di Porta Romana 108 20122 Milano e-mail autorizzazioniclearediorg e sito web wwwclearediorg
copy 2015 Vita e Pensiero - Largo A Gemelli 1 - 20123 MilanoISBN 978-88-343-3107-1
PP_Bearzot-Landucciindd 4 131115 1550
INDICE
Presentazione VII
LUISA PRANDIAlessandro il Grande in Giustino 3
FRANCA LANDUCCII Diadochi 17
GIOVANNI BRIZZIGiustino e la storia di Cartagine 39
RICCARDO VATTUONEGiustino e lrsquoOccidente greco II IV-III secolo aC 55
MARIA TERESA SCHETTINOPirro in Giustino 69
FEDERICOMARIA MUCCIOLILrsquoOriente seleucidico da Antioco I ai primi anni di Antioco III in Pompeo TrogoGiustino 99
MONICA DrsquoAGOSTINI Il discorso del Re Filippo V in Giustino 121
01_indiceindd V01_indiceindd V 201115 1537201115 1537
MONICA DrsquoAGOSTINI
Il discorso del Re Filippo V in Giustino
Introduzione
Le vicissitudini del reame antigonide durante il regno di Filippo V sono trattate principalmente nei libri XXIX e XXX delle Epitome delle Storie Fi-lippiche di Pompeo Trogo Alle notizie contenute in questi libri si aggiungo-no la breve menzione dellrsquoascesa al trono del sovrano nel libro XXVIII (3 9 e 4 16) e la descrizione degli eventi relativi alla sua morte nel libro XXXII (2 3- 3 4)
Egrave chiaro dal confronto tra i Prologi e lrsquoEpitome che ampie parti dei due libri trogiani sono state omesse in Giustino in particolare quelle ineren-ti agli avvenimenti orientali poicheacute nec cognoscendi voluptate iucunda nec exemplo erant necessaria (Praefatio 4) le origini di Creta e gli scontri tra Fi-lippo e Attalo nel libro XXIX la spedizione di Filippo in Asia e le cam-pagne di Antioco III nel libro XXX
Degli eventi dei libri XXIX e XXX sono invece menzionati in forma di riassunto da Giustino i piugrave importanti scontri militari tra Roma e Fi-lippo Nella categoria dei passi lsquoepitomatirsquo rientrano la Guerra degli Al-leati la Prima Guerra Macedonica la Seconda Guerra Macedonica Ci-noscefale e le rispettive trattative di pace ovvero Naupatto Fenice Tem-pe Quando ci si trova di fronte a tali riassunti egrave spesso difficile un con-fronto puntuale con le altre tradizioni pur con lrsquoaiuto dei Prologi
Gli eventi che ricevono attenzione nei libri XXIX e XXX sono sele-zionati secondo il criterio giustineo del cosiddetto lsquoflorilegiorsquo1 ovvero per cognitione quaeque dignissima (Praefatio 4)2 Piugrave vicini allrsquooriginale tro-giano e dunque piugrave excerpta che sintesi sono da ritenersi probabilmente i passi del libro XXIX sullrsquoalleanza tra Annibale e Filippo e sulla politica filoromana di Filopemene e quelli del libro XXX sulle questioni amo-
1 Vattuone (2014) pp 261-2772 I criteri per la distinzione dei passi piugrave vicini a Trogo e quelli invece riassunti da Giustino sono stati discussi autorevolmente allrsquointerno di questo progetto da Vattuone (2014) pp 261-277 Sul rapporto tra lrsquoopera di Trogo e lrsquoEpitome vd anche recentemente Heckel (1997) pp 1-41 e Id (2012) pp 1-8 e Borgna (2014) pp 52-77
122 MONICA DrsquoAGOSTINI
rose di Tolemeo III sul patto tra Antioco e Filippo e sullrsquoira degli Eto-li che nel 196 non videro appagata la richiesta di annientare la Macedo-nia Questi passi si prestano maggiormente a un confronto con le fonti parallele bencheacute con prudenza
Centrali nei due libri sono i cinque discorsi in oratio obliqua il primo egrave quello attribuito a Demetrio di Faro seguono tre di Filippo V men-tre lrsquoultimo egrave di Flaminino Poicheacute secondo Giustino (XXXVIII 3 11) Trogo utilizzava solamente lrsquooratio obliqua e avrebbe criticato aspramen-te Sallustio e Livio per lrsquoimpiego di numerosi discorsi in oratio recta i cin-que riportati nei libri XXIX e XXX sono stati considerati trasposizioni dellrsquooriginale trogiano3 In effetti tali discorsi fungono da ossatura del percorso narrativo dei due libri e sono da considerare le sezioni di que-sti libri piugrave vicine allrsquooriginale trogiano Sono perciograve i passi che offrono maggior possibilitagrave di studio per mettere in luce la presenza o lrsquoassen-za di una tradizione alternativa su Filippo V se questa sia giagrave in Trogo e quanto in quale modo e con quale interesse Giustino abbia interpolato tale tradizione Data la complessitagrave dei due libri ritengo opportuno ana-lizzare gli avvenimenti trattati seguendo la divisione in capitoli giustinea
Libro XXIX11-11 Introduzione
Il primo capitolo del libro XXIX si presenta con precisione nei riferi-menti coerenza testuale e attenzione ai dettagli Giustino probabilmen-te ricalcando le riflessioni di Trogo alla considerazione incipitale sul ge-nerale rinnovamento dei vertici degli imperi di lsquotutto il mondorsquo alla fine del III secolo aC fa seguire la lista dei nuovi re con alcuni commenti relativi ai singoli monarchi In particolare si sottolinea la giovane etagrave di tutti i sovrani e i condottieri al momento della loro ascesa al potere os-servazione ribadita nel commento finale al capitolo (XXIX 1 8)
His regibus pueris tametsi nulli senioris aetatis rectores erant tamen in suorum quisque maiorum uestigia intentis magna indoles uirtutis enituit
Questi re fanciulli sebbene non avessero guide di etagrave piugrave anziana tuttavia se-
3 Schlicher (1933) pp 289-300 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362 partic 1309 Adler (2006) pp 383-407 e Id (2011) pp 37-40 Recentemente Ballesteros Pastor (2013) pp 52-54 commentando il discorso di Mitridate (XXXVIII 4-7) ha ritenuto che Giustino abbia dichiarato il falso a proposito dellrsquooratio obliqua a suo avviso in Trogo ci sarebbero stati infatti numerosi discorsi diretti che poi Giustino avrebbe tragravedito come discorsi indiretti nellrsquoEpitome inserendo nel passaggio alcuni errori sintattici e incon-gruenze
IL DISCORSO DEL RE 123
guirono ciascuno con impegno le orme degli antenati e in loro rifulse un gran-de innato valore4
Questa introduzione sembra modellata sul cosiddetto lsquosecondo proe-miorsquo di Polibio (IV 2) la lista dei sovrani e lrsquoordine coincidono infatti con quello del Megalopolitano se non per lrsquoesclusione dellrsquousurpatore seleucide Acheo5 Lrsquointenzione del passo nelle due opere egrave perograve diver-sa mentre il Megalopolitano nel proemio metteva in risalto il sorgere quasi in contemporanea di nuovi conflitti in diverse parti del Mediter-raneo nellrsquoEpitome il filo conduttore di questo elenco di sovrani e con-dottieri egrave la loro gloria e la grandezza degli eventi che essi compirono in giovane etagrave6 Inoltre vi sono in Trogo alcune notizie originali rispetto al Megalopolitano il fatto che lrsquoepiteto Filopatore di Tolemeo IV sia mes-so in relazione con lrsquoassassinio dei genitori del sovrano oppure che lrsquoa-scesa di Annibale al comando dei Cartaginesi sia spiegata con il suo odio per i Romani Entrambe queste notizie non appartengono alla tradizio-ne polibiana in Polibio (II 36 3) Annibale era stato eletto comandante dellrsquoesercito in Spagna per i successi ottenuti mentre il padre Amilcare gli aveva fatto giurare odio eterno ai Romani Per quanto riguarda il Fi-lopatore Polibio ritiene che egli non abbia assassinato la madre Bereni-ce vittima invece del consigliere Sosibio (Polyb V 36 1)7 La versione di Trogo egrave dunque frutto di una propaganda avversa a Tolemeo IV che lo dipinge ancora piugrave negativamente di quanto fatto dalla tradizione poli-biana che certo giagrave non era favorevole al sovrano8
NellrsquoEpitome di Giustino segue una sintesi dei primi anni di regno di Filippo V in particolare vi egrave un brevissimo riferimento allrsquoinaspettata vit-toria del sovrano contro i Dardani che lo avrebbe portato a cercare lo
4 La traduzione di Giustino come tutte quelle presenti nel testo sono da Santi Amantini (1981) Lrsquounica eccezione a questa affermazione egrave il Filopatore Sulla tradizione storio-grafica avversa al Filopatore vd infra 5 Acheo egrave personaggio noto a Trogo che lo menziona altrove Prol XXX6 La giovinezza in TrogoGiustino egrave percepita come un valore aggiunto mentre per Poli-bio egrave una debolezza Eckstein (1995) p 143 McGing (2013) pp 181-1997 Muccioli (2013) pp 220-223 osserva che lrsquoepiteto fu assunto da Tolemeo IV quando il padre era vivo come strumento per sottolineare la sua predestinazione al trono 8 Polyb V 34 3-5 come anche Plut Cleom 33-34 forniscono notizie denigratorie su Tole-meo IV che sarebbe stato un sovrano inadatto a governare Secondo Huss (1976) pp 9 e 19 e (2001) pp 381-472 alla base vi sarebbe Filarco Se invece si considerano gli studi fatti su Tolemeo di Megalopoli da Schepens (1983) pp 351-368 e Zecchini (1990) pp 213-232 partic 218 egrave possibile che Tolemeo di Megalopoli nello scrivere unrsquoopera sto-riografica su un sovrano lagide non omettesse di menzionare notizie meno celebrative come Teopompo prima di lui aveva fatto nei confronti di Filippo II Sulla tradizione storiografica avversa a Tolemeo IV vd anche Marasco (19791980) pp 159-182 Weber (1997) pp 27ndash72 partic 28 Ager (2003) pp 35-50 McGing (2010) pp 117-119 Cri-scuolo (2011) pp 132-150 partic 148-149
124 MONICA DrsquoAGOSTINI
scontro con gli Etoli Egrave difficile dire se Trogo dedicasse piugrave spazio alla narrazione degli eventi tra il 220 e il 217 Nel Prologo si legge
Undetricensimo volumine continentur haec Res gestae Philippi regis adversus Dardanos et Aetolos repetitaeque inde Creticae origines post cuius insulae societatem Philippus cum Illyriis et Dardanis et rursus Aetolis bello congressus est adiuvantibus Aetolos Romanis quo finito intulit Attalo bellum
Il ventinovesimo libro contiene le imprese del re Filippo contro i Dardani e gli Etoli Sono quindi rievocate le origini di Creta dopo essersi alleato con questrsquoi-sola Filippo si scontrograve in guerra con gli Illiri i Dardani e di nuovo con gli Eto-li mentre i Romani soccorrevano gli Etoli Terminata questa guerra Filippo at-taccograve Attalo
Dal confronto tra Giustino e i Prologi egrave evidente che quella che per i mo-derni egrave la lsquoGuerra degli Alleatirsquo tra Etoli aiutati da Sparta e dallrsquoElide e la Lega Achea alleata di Filippo V sia ridotta sia in Giustino che in Tro-go a una guerra di Filippo contro gli Etoli Colpisce in effetti la comple-ta mancanza nel Prologo XXIX e nellrsquoEpitome del libro di qualsiasi men-zione e riferimento alla Lega Achea e al suo leader Arato protagonisti indiscussi invece nelle Storie polibiane dei primi anni di regno di Filippo V 9 Arato di Sicione importante statista e comandante militare della Le-ga Achea fu uno dei primi personaggi politici a scrivere e pubblicare le proprie memorie (FGrHist 231) di cui Polibio si servigrave ampiamente (I 3 1)10 Lo storico di Megalopoli era un compatriota di Arato e come lui ricoprigrave importanti cariche allrsquointerno della Lega Achea11 Polibio che considerava Arato uno dei fondatori della Lega vedeva in lui una sorta di eroe e leader ideale come emerge dalla descrizione che ne fa di uomo perfetto per lrsquoattivitagrave politica astuto tollerante coraggioso e di succes-so (IV 7 11-8 12) Il rapporto tra Filippo V e Arato egrave determinante per il giudizio di Polibio sul sovrano macedone Filippo egrave infatti descritto co-me un buon sovrano valoroso ma troppo giovane che nei primi anni di regno agigrave bene poicheacute ascoltograve e seguigrave i consigli di Arato (IV 77 1-4)12
Per quanto argumentum e silentio questa assenza di Arato di Sicione e della Lega Achea sia nel Prologo di Trogo che nellrsquoEpitome di Giustino
9 Polibio dedica alla Lega Achea ampia parte dei libri IV e V 10 Riguardo ad Arato di Sicione soprattutto nel rapporto con Polibio vd Meadows (2013) pp 91-116 Vd anche Walbank (1933) Misch (1949) pp 210-212 Urban (1979) Meister (1990) pp 187-189 Habicht (1995) pp 176-179 Beck - Eckstein (2015) sv laquoAratos of Sicyon (231)raquo in BNJ11 Sui legami di Polibio e la sua famiglia con la Lega Achea vd Eckstein (2013) pp 314-33812 Polyb IV 24 1-3 e V 26 6 seguito da Plut Arat 48-49 afferma esplicitamente che il re portava a termine abilmente i suoi piani poicheacute Arato era al suo fianco
IL DISCORSO DEL RE 125
non solo non puograve passare inosservata ma deve indurre i moderni a du-bitare per questi eventi di unrsquoapparente dipendenza diretta giagrave di Tro-go da Polibio
21- 38 Demetrio di Faro e Naupatto
Scomparso Arato nellrsquoEpitome XXIX ha invece un ruolo fondamentale in questi anni come consigliere di Filippo Demetrio di Faro a cui egrave at-tribuito il primo discorso in oratio obliqua dei due libri esaminati13
Demetrio di Faro era un dinasta illirico che si incontra per la prima volta nelle fonti storiografiche in occasione della prima guerra di Ro-ma in Illiria nel 229 Sappiamo infatti da Polibio (II 10 8-11 4) e Appia-no (Illyr 7) che Demetrio giagrave alleato di Teuta sovrana degli Illiri aveva scelto di passare dalla parte romana ed era stato poi ricompensato dal Senato con il controllo di parte dei territori sottratti da Roma a Teuta stessa Nei suoi tentativi di ritagliarsi un ruolo importante nella penisola balcanica Demetrio nel 222 si era alleato con la Lega Ellenica di Doso-ne e Arato a Sellasia contro Cleomene (Polyb II 65 2- 5) ma negli an-ni successivi le sue scorribande nellrsquoAdriatico allarmarono Roma che gli mosse guerra (Polyb III 16 IV 16)14 Sconfitto da Roma e cacciato da Faro Demetrio si rifugiograve alla corte di Filippo intorno al 218 diventan-do consigliere del re
Poicheacute nel Prologo XXVIII si legge laquoIn una digressione egrave narrata la guerra illirica combattuta dai Romani contro Teuta15raquo non egrave da esclu-dere che Trogo giagrave citasse il dinasta di Faro anche se la prima menzio-ne di Demetrio in Giustino egrave a XXIX 2 1 quando il cosiddetto lsquore de-gli Illirirsquo cacciato da Lucio Emilio Paolo dallrsquoAdriatico arrivograve alla corte macedone Nel riassunto degli eventi Giustino segue piugrave da vicino Tro-go riportando il discorso del dinasta a Filippo V per convincere il sovra-no a far guerra a Roma (XXIX 2 2-6) I punti principali di tale discorso sono che i Romani aspirano a realizzare un impero universale a scapito di tutti i re laquocome se fosse cosa illecita che ci fosse un qualche re presso i confini del loro Statoraquo Perciograve Filippo V doveva prepararsi alla guerra con i Romani poicheacute laquoquanto piugrave accessibile e illustre era il suo regno tanto piugrave accaniti nemici gli sarebbero stati i Romani16raquo Demetrio vole-
13 Su questi discorsi di Demetrio vd Coppola (1993) pp 29-5114 Coppola (1993) pp 29-51 vd anche Hammond (1968) pp 1-21 Eckstein (2008) pp 41 58-60 Demetrio di Faro era presentato in Polibio come il rivale di Arato tra i consi-glieri di Filippo Polyb IX 23 9 infatti dichiara che quando il sovrano seguiva i consigli di Arato compiva grandi imprese mentre quando ascoltava Demetrio si macchiava di atti spregevoli15 Trog Prol XXVIII Dictum in excessu bellum Illyricum quod Romani gessere cum Teuta16 Iust XXIX 2 4-5 sibi quoque non aliam ob causam quam quod Italiae finitimus uidebatur
126 MONICA DrsquoAGOSTINI
va infatti cacciare i Romani dalla sponda adriatica dellrsquoIlliria territorio che avrebbe ceduto a Filippo
Il discorso di Demetrio a Filippo egrave presente anche in Polibio (V 101 8-1017) ed egrave inserito cronologicamente durante i giochi Nemei18 nel 217 subito dopo la sconfitta romana del lago Trasimeno ricordata an-che nel passo di Giustino Nel discorso polibiano Demetrio perograve sotto-linea il diritto di Filippo V ad aspirare al dominio universale a partire dallrsquoAdriatico19 mentre nel discorso trogiano Demetrio accusa i Roma-ni di aspirare ad espandersi travolgendo qualsiasi regno sul loro cammi-no Trogo nel discorso di Demetrio presenta il coinvolgimento roma-no in Oriente come una guerra di conquista che contrappone la giova-ne potenza romana allrsquolsquoillustre regnorsquo di Filippo20 prospettiva che ritor-na nel successivo discorso di Filippo V nellrsquoEpitome ma che egrave estranea al-la narrazione di Polibio
Dopo il discorso di Demetrio nellrsquoEpitome come in Polibio (V 104 1) si arriva allrsquoincontro di pace di Naupatto nel 217 che pose fine al-la Guerra degli Alleati tra Etoli Spartani ed Elei contro la lega Achea e
bellum inlatum quasi nefas esset aliquem regem iuxta imperii eorum terminos esse Sed et ipsi cauen-dum esse exemplum cuius quanto promptius nobiliusque sit regnum tanto sit Romanos acriores hostes habiturus17 Polyb V 101 8-10 ὃς καὶ λαβόμενος τῆς ἀφορμῆς ταύτης τὸν μὲν πρὸς τοὺς Αἰτωλοὺς ᾤετο δεῖν τὴν ταχίστην ἀπορρῖψαι πόλεμον ἀντέχεσθαι δὲ τῶν κατὰ τὴν Ἰλλυρίδα πραγμάτων ἠξίου καὶ τῆς εἰς Ἰταλίαν διαβάσεως [9] τὰ μὲν γὰρ κατὰ τὴν Ἑλλάδα πάντα καὶ νῦν ἤδη ποιεῖν αὐτῷ τὸ προσταττόμενον ἔφη καὶ μετὰ ταῦτα ποιήσειν Ἀχαιῶν μὲν ἐθελοντὴν εὐνοούντων Αἰτωλῶν δὲ καταπεπληγμένων ἐκ τῶν συμβεβηκότων αὐτοῖς κατὰ τὸν ἐνεστῶτα πόλεμον [10] τὴν δ᾽ Ἰταλίαν ἔφη καὶ τὴν ἐκεῖ διάβασιν ἀρχὴν εἶναι τῆς ὑπὲρ τῶν ὅλων ἐπιβολῆς ἣν οὐδενὶ καθήκειν μᾶλλον ἢ ᾽κείνῳ τὸν δὲ καιρὸν εἶναι νῦν ἐπταικότων Ῥωμαίων Trad da Mari (2002) laquoCostui allora cogliendo lrsquooccasione gli consigliograve di interrompere al piugrave presto la guerra con gli Etoli e gli chiese di impegnarsi nelle operazioni in Illiria e nellrsquoattraversamento del mare verso lrsquoItalia Disse che infatti giagrave ora tutta la Grecia eseguiva i suoi ordini e lo avrebbe fatto anche in seguito poicheacute gli Achei lo sostenevano di loro iniziativa mentre gli Etoli erano rimasti molto colpiti da quanto era loro avvenuto nella guerra in corso e aggiunse che lrsquoItalia e lrsquoattraversamento del mare in quella direzione erano lrsquoinizio di un disegno di dominio universale che a nessuno spettava piugrave che a lui ora era il momento opportu-no visto che i Romani erano stati battutiraquo18 I giochi Nemei in onore di Zeus erano giochi panellenici celebrati in Argolide negli anni pari delle Olimpiadi 19 Secondo Eckstein (1995) pp 211-212 tale aspirazione egrave connessa allrsquoincapacitagrave di mo-derazione nella vittoria del sovrano Sul concetto di dominio universale in Polibio vd Musti (1978) pp 16-18 Eckstein (2008) pp 217-220 e 372-38120 Adler (2006) pp 383-407 e (2011) pp 37-58 ha notato che i punti principali del discorso di critica allrsquoespansionismo romano di Demetrio ritornano in altri due discorsi dellrsquoEpitome quello degli Etoli (XXVIII 2 1-13) e quello di Mitridate (XXXVIII 4-7) la prioritagrave data a questi argomenti da tale reiterazione retorica indica che lrsquointeresse giagrave di Trogo se non dellae suae fontei non fosse la celebrazione dellrsquoascesa di Roma allrsquoim-pero universale come in Appiano ma piuttosto lrsquoascesa e la discesa dei regni ellenistici
IL DISCORSO DEL RE 127
Filippo V 21 Il testo giustineo omette le circostanze dellrsquoevento non si menzionano infatti esplicitamente neacute il luogo dellrsquoincontro Naupatto neacute le fasi delle trattative neacute i vari rappresentanti dei diversi fronti che vi presero parte I lunghi negoziati di pace si risolvono dunque nel discor-so di Filippo V ai rappresentanti dei fronti
Il sovrano esordisce affermando che la Grecia egrave in grande pericolo percheacute chiunque avesse vinto tra Cartaginesi e Romani sarebbe poi pas-sato in Oriente Filippo utilizza la metafora delle nubi in Occidente che avrebbero macchiato con una pioggia di sangue ogni cosa spinte dai venti di vittoria inoltre il sovrano ritiene che le guerre passate dei Gre-ci siano di poco conto se paragonate alla minaccia di uno scontro con la moltitudine che si radunava in Italia descrivendo la rabbia e il valore di questi nuovi nemici che avrebbero portato rovina ai vicini Il sovrano infine ribadisce che la Grecia era in maggior pericolo della Macedonia ma che sapeva che chi avesse vinto in Italia non avrebbe frenato la sete di vittoria Perciograve anche la Macedonia stessa doveva temere un attacco
Il discorso in Polibio di Agelao di Naupatto rappresentante e leader degli Etoli22 mostra le medesime argomentazioni attribuite in Giustino allrsquointervento di Filippo argomentazioni fondate sul metus hostilis e fina-lizzate a promuovere un nuovo ruolo della Macedonia sia in Grecia che nel Mediterraneo Orientale Agelao proponendo un nuovo program-ma politico panellenico fonda le proprie argomentazioni sul metus hosti-lis per i Cartaginesi e i Romani presentati metaforicamente come nubi che incombono da Occidente Filippo dovrebbe farsi garante della tran-quillitagrave della Grecia che agendo come unrsquounica catena di cittagrave contro i barbari diverrebbe una sicura e fedele collaboratrice della Macedonia Questo permetterebbe ai Greci di conservare il diritto di far pace o guer-ra a loro piacimento senza temere che laquoi giochi da bambini con i quali ci trastulliamo tutti vengano troncati23raquo
Nonostante sia il medesimo discorso nelle due fonti Agelao introdu-ce una forte proposta di alleanza panellenica estranea alle parole di Fi-lippo Inoltre Filippo pur utilizzando la metafora delle nubi da Occi-
21 Interessanti le osservazioni di Scholten (2000) pp 224-228 a proposito della pace che sarebbe stata cercata e sperata da entrambe le parti e non imposta da Filippo come Polibio pare lasciar intendere 22 Vd soprattutto Leacutevy (1994) pp 33-50 Su questo discorso molto dibattuto dai moderni vd anche Schmitt (1989) pp 229-239 Vollmer (1990) pp 96-107 Coppola (1993) pp 149-164 Golan (1995) pp 55-74 Champion (1997) pp 111-128 e (2004) p 55 Wal-bank (2002) pp 127-136 Eckstein (2008) pp 78-83 23 Polyb V 104 10-11 καθόλου τὰς παιδιάς ἃς νῦν παίζομεν πρὸς ἀλλήλους ἐκκοπῆναι συμβῇ πάντων ἡμῶν ἐπὶ τοσοῦτον ὥστε κἂν εὔξασθαι τοῖς θεοῖς ὑπάρχειν ἡμῖν τὴν ἐξουσίαν ταύτην καὶ πολεμεῖν ὅταν βουλώμεθα καὶ διαλύεσθαι πρὸς ἀλλήλους καὶ καθόλου κυρίους εἶναι τῶν ἐν αὑτοῖς ἀμφισβητουμένων
128 MONICA DrsquoAGOSTINI
dente presente anche nelle Storie la arricchisce con la vivida immagine di una tempesta di sangue conferendo una dimensione piugrave concreta e cruenta alla predizione infine il riferimento polibiano alle guerre dei Greci nellrsquoEpitome non riguarda piugrave le guerre tra le cittagrave e le leghe gre-che ma le guerre dei Greci con Macedoni Persiani e Galli Mentre la Grecia scompare sullo sfondo la minaccia Romana egrave meno vaga e piugrave concreta e presente che in Polibio e diventa lrsquounico argomento del di-scorso di Filippo V a Naupatto
Il discorso di Demetrio e quello di Filippo sono al centro del libro XXIX dellrsquoEpitome avendo il duplice scopo di evidenziare sia la poten-ziale aggressivitagrave dei Romani sia la grande tradizione militare della Ma-cedonia e il pieno diritto di Filippo di controllare la Grecia e lrsquoIlliria fi-no allrsquoAdriatico Se il discorso in Polibio si inseriva in un dibattito politi-co dove la Grecia e la Macedonia erano protagoniste alla pari della sce-na ellenica e internazionale nella versione che leggiamo in Trogo i ri-ferimenti alle dispute della realtagrave greca sono reinterpretati a favore di un punto di vista in cui la Macedonia egrave lrsquounico potere dellrsquoOriente gre-co Del dibattito politico di III secolo in Grecia che tanto stava a cuore a Polibio non vi egrave piugrave alcuna traccia in TrogoGiustino rimane soltanto lo scontro tra le due grandi potenze di Oriente e Occidente tra Filippo e Roma Questa prospettiva bipolare dei discorsi trogiani si ritrova nel-la conclusione del capitolo che se da un lato sottolinea ancora una vol-ta il timore di Filippo per Cartaginesi e Romani dallrsquoaltro esplicita che i Romani avevano paura dellrsquoantica gloria dei Macedoni laquovincitori dellrsquoO-rienteraquo e soprattutto di Filippo laquoinfiammato dallo zelo di emulare Ales-sandro che era ben noto come pronto alle guerre e instancabileraquo24
41-11 La Prima Guerra Macedonica
Dei prodromi della Prima Guerra Macedonica Giustino si interessa sol-tanto allrsquoalleanza antiromana tra Annibale e Filippo Questo trattato egrave noto da molte fonti secondo cui Filippo dopo aver appreso che i Roma-ni erano stati sconfitti di nuovo dai Cartaginesi a Canne nel 216 avreb-be mandato unrsquoambasceria ad Annibale per proporre unrsquoalleanza ma lrsquoambasciatore macedone sarebbe stato catturato da Roma sulla via del ritorno25
24 Iust XXIX 3 8 quippe terrebat eos et uetus Macedonum deuicti Orientis gloria et Philippus studio Alexandri aemulationis incensus quem promptum in bella industriumque cognouerant Alla gloria dei Macedoni avevamo giagrave trovato riferimento nei discorsi del libro XXVIII degli Etoli (2 12) e di Antigono Dosone (3 14) 25 Secondo Polyb VII 9 17 Filippo avrebbe aiutato Cartagine nella guerra con Roma in cambio di Corcira Epidamno e Apollonia e della restituzione a Demetrio di Faro del suo regno Inoltre Filippo e Annibale si impegnavano a soccorrersi a vicenda in caso di
IL DISCORSO DEL RE 129
A prescindere dai dettagli del fermo dellrsquoambasciatore macedone da parte romana egrave possibile fare qualche osservazione sul nesso tra questo lsquoincidentersquo diplomatico e lo scoppio della guerra Cassio Dione e Ap-piano riportano che la cattura del legato avrebbe causato una vendetta di Filippo contro i protettorati romani in Adriatico in particolare Cor-cira26 notizia assente in Polibio come in Livio e Plutarco (che da Poli-bio dipendono)27 In questi ultimi autori lrsquoattacco di Filippo in Adriati-co infatti non sarebbe legato allrsquoepisodio dellrsquoambasciatore ma alla de-cisione del sovrano di rompere con il consigliere Arato e di dare ascol-to ai cattivi consigli di Demetrio di Faro presa dopo la spedizione a Mes-sene nel 215214 La tradizione polibiana legge infatti in questi eventi la manifestazione del cambiamento dellrsquoindole di Filippo V da giusta a empia iniziata con lrsquoepisodio della stasis di Messene del 215 e compiu-ta con lrsquoassassinio di Arato del 21328 Nel libro XXIX di Giustino ben-cheacute si conservi traccia dellrsquoindole aggressiva di Filippo e del consiglio di Demetrio di Faro come prodromi dello scontro con Roma non vi sono indizi della metaboleacute del sovrano da giusto a empio e malvagio e neppu-re del ruolo che in tale cambiamento ricoprigrave lrsquoallontanamento tra Ara-to e Filippo
attacco da parte di Roma Mentre Peacutedech (1964) pp 382-383 ritiene sicura la consulta-zione a Roma di tali documenti Zecchini (2003) pp 123-141 come prima di lui Walbank (1957) I p 32 n 4 non ne egrave certo poicheacute Polibio viaggiograve proprio per poter reperire documenti e informazioni sugli eventi dove essi avvennero Altre fonti Liv XXIII 38 7 Plut Arat 51 2 Dio C XV 4 2 e App Mak Fr 1 Sul confronto delle fonti vd DrsquoAgostini (2011) pp 99-121 Sul trattato macedone-cartaginese vd Cassola (1962) pp 65-66 Wal-bank (1967) II pp 42-44 Will (19822) pp 83-84 Barreacute (1983) Longaretti (1989) pp 183-192 Golan (1995) pp 45-46 Eckstein (2008) pp 83-85 Intrieri (2011) pp 53-8226 Dio C XV 4 2 e App Mak Fr1 Filippo per vendicarsi della cattura del proprio amba-sciatore non solo attaccograve Corcira ma saputo dellrsquoarrivo di Levino durante la ritirata da Corcira saccheggiograve anche Apollonia e Orico alleate romane Levino avrebbe poi sconfit-to Filippo e recuperati gli alleati costringendo il re a bruciare le proprie navi e rientrare via terra Si riferisce a questo episodio probabilmente il Mak Fr 9 di Appiano che riporta lrsquoordine di Filippo di uccidere quanti erano sulle navi percheacute non dicessero ai Romani che le forze macedoni erano stremate DrsquoAgostini (2011) pp 99-12127 Polyb V 108-110 Liv XXIV 40 e Plut Arat 51 2 non menzionano Corcira nella narra-zione dellrsquoalleanza macedone-cartaginese e della cattura dellrsquoambasciatore Secondo Liv XXIII 38 7 lrsquoambasciatore sarebbe stato trattenuto a Roma 28 Polyb VII 11 8-11 e Plut Arat 49 1 Coppola (1993) pp 205-210 Dai frammenti di Polyb VII 10-12 e dalla narrazione di Plut Arat 49-51 sappiamo che Filippo era interve-nuto nella stasis di Messene tra oligarchici e democratici ma aveva di nascosto lasciato che i cittadini si massacrassero Una volta giunto Arato la guerra civile fu finalmente sedata ma il sovrano avrebbe voluto su consiglio di Demetrio di Faro approfittare della situazione e imporre una guarnigione nellrsquoacropoli della cittagrave che gli avrebbe conferito un vantaggio strategico per il controllo del Peloponneso Arato dissuase Filippo da per-seguire unrsquoazione militare in Peloponneso ma il re decise su consiglio di Demetrio di rivolgere la sua aggressivitagrave verso lrsquoIlliria prima e i protettorati romani Orico e Apollonia poi
130 MONICA DrsquoAGOSTINI
Dopo aver accennato alla stipula del trattato Giustino affastella ne-gli ultimi paragrafi del capitolo 4 gli eventi tra il 215 e il 205 quando Fi-lippo siglando la pace con Roma pone fine alla Prima Guerra Macedo-nica29 In particolare lrsquoEpitomatore sottolinea da un lato lrsquoingresso in guerra degli Etoli al fianco dei Romani e la successiva alleanza del preto-re Levino con Attalo dallrsquoaltro gli attacchi subiti da parte dei Dardani da Filippo oppresso dalle richieste degli Illiri Il libro dunque si chiude con Filippo in difficoltagrave aggravate dalla comparsa di Filopemene il leader degli Achei30 urtatosi con il re dei Macedoni convince la Lega Achea a staccarsi dallrsquoalleanza con la Macedonia sempre piugrave isolata Tale allon-tanamento egrave considerato da Giustino lrsquoesito di un fallito agguato a Fi-lopemene commissionato da Filippo V e dovuto al sospetto di un tradi-mento del condottiero acheo a favore di Roma Bencheacute anche Plutarco (Fil 12 2) e Pausania (VIII 50 4) menzionino il tentativo di assassinio di Filopemene da parte di Filippo la notizia dellrsquoatteggiamento filoroma-no del generale acheo non parrebbe vicino al ritratto polibiano che ve-de in Filopemene un eroe dellrsquoautonomia e dellrsquoindipendenza achea31
Libro XXX11-39 Cinoscefale
Lrsquoesordio del libro XXX introducendo il grande scontro di Cinoscefale tra Romani e Macedoni riprende la celebrazione della gloria macedo-ne argomento centrale dei discorsi del libro XXIX Con lrsquoeccezione dei primi capitoli sul deplorevole comportamento di Tolemeo IV in Egit-to32 il libro egrave infatti totalmente dedicato allo scontro tra le due potenze
29 Errington (2008) pp 185-190 La guerra egrave nota a noi soprattutto dai frammenti dei libri VIII-XI di Polibio dai passi di Liv XXIV 40 1-17 XXVI 24 1-26 4 XXVII 30 5-33 5 e XXVIII 5 1- 9 1 XXIX 12 1-15 e dalla Vita di Filopemene di Plutarco La sinteticitagrave del riassunto giustineo impedisce un puntuale paragone delle tradizioni Ad esempio la notizia dellrsquoalleanza tra Attalo e Roma sembra tornare in Liv XXVIII 5 1-4 dove perograve non troviamo Levino ma Sulpicio come rappresentante romano personaggio scompar-so in Giustino In maniera simile la pace di Fenice del 205 egrave sintetizzata in Giustino in una riga e non vi egrave traccia delle lunghe trattative che coinvolsero come mediatori anche Egitto Chio Mitilene e Atamania portarono a una prima pace separata tra Filippo e gli Etoli nel 206 e poi alla pace con Roma Le fonti parallele sono molto piugrave dettagliate anche su questi eventi Polyb XI 4 1-6 9 Liv XXVIII 5 13 e XXIX 12 8-16 e App Mak fr III Degno di nota egrave perograve il commento in Giustino secondo cui laquoi Romani erano per il momento soddisfatti di aver rinviato la guerra contro la Macedoniaraquo Lrsquointenzione ro-mana di riprendere la guerra con la Macedonia egrave infatti presente in tutte le fonti Polyb XI 6 7 Liv XXIX 1216 Dio C XVIII 9 (15) e App Mak Fr III e verragrave ripresa al libro XXX dellrsquoEpitome 30 Su Filopemene e Filippo vd Errington (1969) pp 51-69 e 83-84 vd anche Golan (1995) pp 115-132 Eckstein (2008) pp 103 e 360-36131 Pelling (1997) pp 135-13932 Lrsquoesordio del libro XXX egrave dedicato alle scabrose imprese del sovrano egiziano ovvero
IL DISCORSO DEL RE 131
dellrsquoEst e dellrsquoOvest La prima avvisaglia dellrsquoincombente guerra egrave la no-tizia dellrsquoaccordo di Filippo V e Antioco III per la spartizione dellrsquoEgitto governato dal sovrano-bambino Tolemeo V Il sovrano lagide nel 2032 chiese aiuto ai Romani che secondo TrogoGiustino gradirono la ri-chiesta drsquoaiuto percheacute cercavano pretesti per muovere guerra contro Fi-lippo A partire da Polibio numerose altre fonti ci testimoniano questo episodio mettendolo in relazione con lo scoppio della Seconda Guerra Macedonica ed esprimendo una condanna morale per lrsquoempia condotta del re antigonide che cospira contro un bambino33 al contrario nellrsquoE-pitome si esalta la potenza macedone evidenziando la paura dei Romani delle grandi imprese di Filippo (XXX 3 2)
nullius magis arma metuebant reputantibus quantum motum Pyrrhus parua Macedo-num manu in Italia fecisset quantasque res Macedones in Oriente gessissent
di nessun altro temevano maggiormente le armi poicheacute ripensavano a quanto sconvolgimento Pirro aveva provocato in Italia con una piccola schiera di Ma-cedoni e a quanto grandi imprese i Macedoni avevano compiuto in Oriente
La supremazia macedone egrave anche al centro del discorso in oratio obliqua di Filippo allrsquoincontro nel Golfo Maliaco tra i rappresentanti dei fronti coinvolti nella Seconda Guerra Macedonica34 NellrsquoEpitome infatti dopo
la Quarta Guerra Siriaca conclusa con sconfitta a Rafia contro Antioco III nel 217 e la corruzione del sovrano da parte di Agatocle e della sorella una cortigiana che avrebbe sedotto il re Giustino riferisce poi la morte del sovrano nel 204 e lrsquoascesa al trono del piccolo Tolemeo V Epifane sovrano sotto tutela di Tlepolemo dopo la morte di Agatocle e Sosibio 33 Eckstein (2008) pp 121-180 Thornton (2014) pp 65-88 In particolare sulla relazione tra il complotto e la sconfitta antigonide e seleucidica ad opera di Roma la superioritagrave morale romana ai regni ellenistici e la causalitagrave storica in Polibio (XV 20 6) vd Eck-stein (2008) pp 133-138 Ager (2009) pp 15-43 Landucci Gattinoni (2011) pp 89-105 Secondo Polyb III 2 8 XV 20 XVI 1 8-9 seguito da Liv XXXI 14 5 Filippo avrebbe ottenuto le basi tolemaiche in Egeo Samo e la Caria mentre Antioco avrebbe finalmente avuto mano libera in Celesiria e Fenicia oggetto di quasi un secolo di lotte tra Tolemei e Seleucidi La notizia del trattato permette a Polibio di dedicare alcuni paragrafi (XV 20) a condannare aspramente lrsquooperato di Filippo V e Antioco III definendoli empi e senza pudore e dichiarando che la Fortuna punigrave i due sovrani per il loro crudele operato por-tando i Romani contro di loro vd infra App Mak Fr IV trasmette delle clausole secondo cui Antioco avrebbe avuto lrsquoEgitto e Cipro mentre Filippo avrebbe ottenuto Cirene le Cicladi e la Ionia Infine secondo Porfirio FGrHist 260 F 45 lrsquoaccordo prevedeva che i due sovrani annettessero i possedimenti tolemaici confinanti con i rispettivi regni 34 Prima si menziona unrsquoambasceria del Senato a Filippo e Antioco percheacute laquosi astenessero dallrsquoEgittoraquo e la visita di Lepido in Egitto Quindi le lamentele a Roma di Attalo e i Rodii nei confronti di Filippo Egrave probabile che a questo punto Trogo inserisse la campagna di Filippo in Asia contro Attalo menzionata nel Prologo XXX ma tagliata nellrsquoEpitome La cronologia degli scambi diplomatici precedenti la Seconda Guerra Macedonica egrave stra-volta dalla sintesi dellrsquoEpitomatore e rende impossibile qualsiasi confronto con le altre
132 MONICA DrsquoAGOSTINI
il riassunto delle ambascerie nel Mediterraneo preludio allo scontro della prima fase della guerra35 maggior spazio egrave dato al tentativo di pa-ce a Nicea tra Roma Attalo i Rodii gli Achei e gli Etoli e Filippo V nel 198 In questa occasione Filippo rivendica la posizione di dominio dei Macedoni sui Greci ereditata da Filippo II e Alessandro suoi antenati e in virtugrave di tale supremazia macedone rifiuta che i Greci gli dettino le condizioni di pace ma chiede che sia il Senato a decidere Egrave significati-vo che non solo il discorso di Filippo non compaia in nessuna delle fon-ti parallele che descrivono nel particolare le posizioni degli ambasciato-ri di Achei Etoli Rodii e Attalo ma che Polibio (XVIII 8 8)36 affermi che era difficile sapere cosa si fossero detti Filippo e Flaminino durante i colloqui nel Golfo Maliaco Secondo la tradizione polibiana infatti il sovrano accompagnato da due philoi macedoni Apollodoro e Demoste-ne chiese di allontanare dalle trattative tutti tranne i Romani e discus-se la pace solamente con Flaminino Successivamente a causa dellrsquoinca-pacitagrave di trovare un accordo Filippo chiese due mesi di tregua e lrsquointer-vento del Senato Trogo dunque restituisce il discorso che il resto della tradizione riteneva impossibile da conoscere indicando chiaramente la presenza di una fonte diversa rispetto a Polibio su questo avvenimento piugrave informata sul punto di vista di Filippo e interessata a evidenziare la convinzione di Filippo V di avere un diritto di supremazia sulla Grecia in virtugrave delle imprese di Filippo II e Alessandro
La battaglia di Cinoscefale nel 197 momento risolutivo dello scontro tra Roma e Macedonia egrave lrsquoevento principale del libro XXX omina e pre-sagi introducono lrsquoevento campale lrsquoeruzione del vulcano di Santorini
fonti In Polyb XVI 24 3 App Mak Fr IV Liv XXXI 1 10 21 5 5 Paus I 36 5-6 vi sono differenti versioni della sequenza delle ambascerie che denunciarono a Roma lrsquoe-spansionismo macedone ma tutte concordano che le ambascerie precedettero lrsquoinvio dei legati romani in Oriente e che esse furono inviate anche da Atene e dagli Etoli Inoltre secondo la tradizione polibiana (Polyb XVI 27 1-4 34 1-7 Liv XXXI 2 3 6 3-8 4 18 1-9 Diod XXVIII 6) vi furono due diverse ambascerie di cui la seconda sarebbe stato un ultimatum al sovrano recapitato da Lepido In occasione di questa seconda ambasceria avvenuta durante il cruento assedio di Abido Filippo avrebbe detto che i Macedoni in ca-so di guerra si sarebbero difesi con valore In Giustino si puograve notare che ancora una volta dagli eventi sono omesse notizie fondamentali sui Greci nello specifico lrsquoambasceria di Atene la cui disputa con gli Acarnani fu il casus belli della guerra contro Filippo 35 Come i prodromi anche la prima parte della Seconda Guerra Macedonica egrave sintetizza-ta in Giustino e occupa solamente due paragrafi Come spesso accade nei passi sintetiz-zati dallrsquoEpitomatore si trovano le incongruenze maggiori con le fonti parallele tra cui si nota soprattutto la completa omissione di Giustino delle campagne di Publio Sulpicio Galba Massimo di Villio delle vittorie di Tito e Lucio Flaminino e dellrsquoassemblea del 198 che portograve gli Achei ad allearsi con Roma Polyb XXII e Liv XXXI 14 1- 46 16 XXXII 1 1-25 12 App Mak Fr VII Plut Fil 17 4 Flam 5 4 e Paus VII 8 1-236 Le trattattive sono descritte con particolari in Polyb XVIII 1-12 seguito da Liv XXXII 32 6-36 10 e Plut Flam 5 8 e 7 1-3
IL DISCORSO DEL RE 133
nel 197 e lrsquoemergere dellrsquoisola di Hiera e in contemporanea il terremo-to a Rodi Quindi nellrsquoEpitome si annuncia che laquoil nascente impero dei Romani avrebbe divorato quello antico dei Greci e dei Macedoni37raquo Nel passo ricevono spazio soprattutto i due discorsi contrapposti del re ma-cedone Filippo e del comandante romano Flaminino pronunciati pri-ma dello scontro campale e costruiti ciascuno in modo da celebrare le imprese delle due potenze38 Lrsquoenfasi data dalla contrapposizione reto-rica delle parole dei generali egrave tale da rendere suggestiva lrsquoipotesi che lo scontro dovesse essere il momento centrale non solo del libro XXX ma forse di tutta lrsquoopera trogiana
Filippo elenca le grandi vittorie del passato dei Macedoni contro Per-siani Battriani Indiani e le popolazioni drsquoAsia fino allrsquoestremo Orien-te esortando i suoi a combattere con valore percheacute laquola libertagrave egrave piugrave cara del predominio39raquo Il discorso di Flaminino egrave invece piugrave lungo articola-to in un paragone tra Macedoni e Romani alle passate imprese di con-quista macedoni vengono contrapposte le piugrave recenti vittorie romane a Cartagine in Sicilia Italia e Spagna alla grandezza di Alessandro Ma-gno egrave contrapposta quella di Annibale che pure dai Romani era stato sconfitto Lrsquoattenzione poi si concentra su Filippo i Macedoni non laquodo-vevano essere valutati per lrsquoantica forza ma per le forze attuali40raquo poicheacute Filippo non era lrsquoinvitto e invincibile Alessandro Magno ma un ragaz-zo che non riusciva a difendere i propri confini I Macedoni rivendica-vano il valore degli antenati mentre i Romani quello dei propri soldati poicheacute quelli che erano ligrave schierati erano gli stessi che avevano sconfitto Annibale Dopo una cosigrave grandiosa introduzione la battaglia egrave descritta in uno dei paragrafi piugrave significativi di tutta lrsquoopera
His adhortationibus utrimque concitati milites proelio concurrunt alteri Orientis alteri Occidentis imperio gloriantes ferentesque in bellum alii maiorum suorum antiquam et ob-soletam gloriam alii uirentem recentibus experimentis uirtutis florem [16] Sed Macedo-nas Romana Fortuna uicit
I soldati incitati da queste esortazioni dallrsquouna e dallrsquoaltra parte si lanciaro-no nel combattimento vantandosi gli uni del dominio dellrsquoOriente gli altri dellrsquoOccidente e recando in guerra gli uni lrsquoantica e sbiadita gloria dei loro an-
37 Iust XXX 4 4 Quo prodigio territis omnibus uates cecinere oriens Romanorum imperium uetus Graecorum ac Macedonum uoraturum38 Sui discorsi precedenti la battaglia nellrsquoantichitagrave se da considerare reali o costruzioni storiografiche vd Adler (2011) pp 6-839 Iust XXX 4 7 tantoque hoc bellum fortius quam illa sustinendum quanto sit imperio libertas carior40 Iust XXX 4 10 Sed nec Macedonas ueteri fama sed praesentibus uiribus aestimandos
134 MONICA DrsquoAGOSTINI
tenati gli altri il fiore del loro valore fresco e vigoroso per le recenti prove Ma la Fortuna dei Romani vinse i Macedoni
Questo punto di vista probabilmente giagrave trogiano contrappone la virtugrave romana (virtutis flos) celebrata nei discorsi antecedenti la battaglia al-la Fortuna romana (Romana Fortuna) che decise la vittoria interpretabi-le come destino favorevole o buona stella Piugrave che unrsquoaffermazione anti-romana41 come egrave spesso stata intesa si puograve evidenziare il carattere sim-patetico della fonte verso Filippo V destinato a porre fine alla gloria di Filippo II e Alessandro e forse un approccio nostalgico verso i grandi regni macedoni la cui egravera egrave ormai giunta alla fine Tale prospettiva egrave as-sente in Polibio e nella tradizione che da lui dipende poco interessata alle vicende della gloria macedone leggendo infatti i frammenti soprav-vissuti del libro XVIII delle Storie dopo lrsquoaccurata descrizione della bat-taglia (18-33 e 34-40)42 Polibio commenta lo scontro affermando che avrebbe dedicato alcuni capitoli allrsquoesame delle strategie militari delle due armate percheacute (XVIII 28 4-6)
χρήσιμον καὶ καλὸν ἂν εἴη τὸ τὴν διαφορὰν ἐρευνῆσαι καὶ παρὰ τί συμβαίνει Ῥωμαίους ἐπικρατεῖν καὶ τὸ πρωτεῖον ἐκφέρεσθαι τῶν κατὰ πόλεμον ἀγώνων [5] ἵνα μὴ τύχην λέγοντες μόνον μακαρίζωμεν τοὺς κρατοῦντας ἀλόγως καθάπερ οἱ μάταιοι τῶν ἀνθρώπων ἀλλ᾽ εἰδότες τὰς ἀληθεῖς αἰτίας ἐπαινῶμεν καὶ θαυμάζωμεν κατὰ λόγον τοὺς ἡγουμένους
Puograve essere cosa buona e utile esaminare le differenze e per quale motivo i Ro-mani prevalgono e riportano il primo premio nelle competizioni di guerra af-fincheacute non esaltiamo i vincitori senza una ragione parlando solo di fortuna co-me fanno gli sciocchi ma conoscendo le vere cause lodiamo e ammiriamo i co-mandanti seguendo una logica
Polibio dunque sembra rispondere a coloro che parlavano della buo-na stella dei Romani sottolineando che la vittoria nasceva dalla superio-re strategia militare della legione43 Un punto di vista quindi opposto a quello espresso nellrsquoEpitome che proprio di Romana Fortuna parla e riba-dito in chiusura al passo dove Polibio critica nuovamente quei Greci che ritenevano la vittoria romana incredibile (XVIII 32 13)
41 Urban (1982) pp 1424-1443 1435 Richter (1987) p 19 n 4 Alonso-Nuacutentildeez (1992) p 66 e Id (2002) pp 105-110 partic 108-109 Contra Heckel (1997) p 29 che ridimen-siona la categorizzazione di Trogo come storico anti-romano 42 Su Cinoscefale vd Walbank (1957) ad l Hammond (1988) pp 60-82 Sklenaacuter (2004) pp 302-310 Thornton (2014) pp 83-87 43 Sulla Fortuna in Polibio vd McGing (2010) pp 195-201 (con bibliografia) che distin-gue tra quando Polibio intenda caso e quando predeterminazione fato Vd anche Green (1990) pp 400-402 e Eckstein (2008) pp 132-138
IL DISCORSO DEL RE 135
Il punto di vista di Trogo sembra invece presente nei frammenti del-la Makedonikeacute di Appiano su Filippo V44 dove ci si riferisce a Cinoscefale come a una vittoria insperata (Mak 9 1)
ἡγούμενος δ᾽ οὔτε Ῥωμαίοις συμφέρειν οὔτε τοῖς Ἕλλησι Φιλίππου καθαιρεθέντος ἐπιπολάσαι τὴν Αἰτωλῶν βίαν τάχα δ᾽ αὐτὸν καὶ τὸ παράδοξον τῆς νίκης ἀγαπᾶν ἐποίει
Flaminino era consapevole che non sarebbe stato vantaggioso per i Romani o per i Greci che Filippo fosse deposto e che il potere etolico rimanesse incon-trastato forse lo aveva reso moderato nei suoi progetti lrsquoaver ottenuto una vit-toria insperata
Addirittura successivamente si accenna alla sorte avversa a Filippo nel-lo scontro
τὰ μὲν δὴ παρὰ τῶν ἄλλων φιλάνθρωπα ἦν τό τε τῆς τύχης ἄδηλον ἐξ ὧν ἔπαθεν ὁ Φίλιππος ὑφορωμένων καὶ τὸ πταῖσμα τοῦτο οὐ κατ᾽ ἀσθένειαν ἀλλὰ πλέον ἐκ συντυχίας αὐτὸν παθεῖν ἡγουμένων
Gli altri (Greci) erano inclini ad essere moderati vedendo con sospetto lrsquoincer-tezza della fortuna subita da Filippo e ritenendo che egli fosse incorso in questa sconfitta non tanto per la sua inferioritagrave quanto per la sfortuna
Il riferimento in Appiano e Trogo alla fortuna romanasfortuna ma-cedone a proposito di Cinoscefale egrave una traccia dellrsquoopinione politi-ca di quei Greci disprezzati da Polibio come uomini sciocchi καθάπερ οἱ μάταιοι τῶν ἀνθρώπων Tale posizione politica su Cinoscefale sarebbe dunque sopravvissuta nella tradizione storiografica di cui troviamo trac-cia in TrogoGiustino e Appiano
Per comprendere meglio alcune caratteristiche di questa tradizione puograve essere utile tornare ai due discorsi nellrsquoEpitome di Filippo e Flamini-no prima della battaglia Tali passi probabilmente trogiani45 non trova-no infatti riscontro nelle fonti parallele a noi pervenute Polibio (XVIII 18-27) seguito fedelmente da Livio (XXXIII 5-10) pur descrivendo le operazioni di guerra di Cinoscefale con dovizia di particolari non men-ziona un discorso di Filippo ai suoi armati prima della battaglia mentre il discorso di Flaminino per incoraggiare le truppe schierate (XVIII 23 2-6) nelle Storie egrave incentrato sulle vittorie di Sulpicio nella prima parte della guerra Pare dunque originale la versione trogiana che incentra-
44 Tra i frammenti consegnatici dagli Excerpta Constantiniana sono frequenti informazio-ni e osservazioni che rimandano a una prospettiva ellenistica sugli eventi DrsquoAgostini (2011) pp 99-121 45 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362
136 MONICA DrsquoAGOSTINI
ta sulla gloria macedone presenta Cinoscefale come il punto drsquoincon-tro e di scambio tra lrsquoegemonia macedone e lrsquoegemonia romana Non egrave una novitagrave che il leitmotiv delle Storie Filippiche e dunque dellrsquoEpitome sia la translatio imperii giagrave Alonso Nuntildeez definito da Santi Amantini laquouno dei piugrave noti esperti di questioni trogiano-giustineeraquo46 osservava che Tro-go esponeva nel suo perduto lavoro la teoria della successione degli im-peri mondiali secondo lo schema Assiria-Media-Persia-Macedonia-Roma osteggiata dai Parti47 In tale successione il ruolo da protagonista egrave rico-perto dallrsquoegemonia macedone48 che occupa allrsquoincirca 26 dei 44 libri e il cui ultimo vero momento di gloria egrave lo scontro con Roma appunto a Cinoscefale Lrsquoultima impresa macedone ha come esito la transizione del dominio universale da Oriente a Occidente e costituisce il tema cen-trale dellrsquointera vicenda di Filippo lrsquoimportanza della battaglia di Cino-scefale egrave perciograve esaltata nei discorsi sia di Filippo che di Flaminino che a loro volta sono il punto di arrivo delle argomentazioni esposte nelle parole di Demetrio di Faro e di Filippo stesso giagrave nel libro XXIX Le ora-tiones disposte retoricamente nei due libri descrivono due parabole op-poste da un lato quella romana che da lontana potenza desiderosa di espandersi cresce come una pioggia di sangue diventando il giovane e vigoroso potere che sottomesso Annibale egrave pronto a sconfiggere Filip-po Dallrsquoaltro quella macedone che originata con Filippo II personag-gio centrale per Trogo raggiunge il suo apice con la conquista dellrsquoege-monia ad opera di Alessandro Magno contro i Persiani per conoscere la fine con Filippo V il cui antico valore egrave ormai troppo lsquosbiaditorsquo per te-ner testa al vigore romano
La gloria macedone secondo Trogo inizia dunque con Filippo II e si conclude con Filippo V Perseo egrave infatti il malvagio responsabile dellrsquoan-nientamento di ciograve che rimaneva della monarchia macedone49 Trogo pone agli estremi della parabola macedone che occupa dal libro IX al XXX i due re di nome Filippo Filippo II e Filippo V come ribadito in piugrave luoghi dellrsquoEpitome sia in parti riassunte da Giustino che in passi piugrave genuinamente trogiani Dando per scontato che il titolo dellrsquoopera Sto-rie Filippiche si debba al desiderio di Trogo di rifarsi allrsquoopera di Teopom-po sul sovrano macedone egrave possibile che tale titolo sia stato perograve ripen-
46 Santi Amantini (2003) pp 99-11047 laquoPompeius Trogus expounded in his lost work the Historiae Philippicae a theory of the world empire suggestion according to the scheme Assyria-Media-Persia-Macedonia-Rome opposed by the Parthiansraquo Alonso-Nuacutentildeez (2002) pp 105-110 e 133-136 partic 105 Vd anche Richter (1987) pp 19-23 Momigliano (1980) pp 157-162 Alonso-Nuacutentildeez (1992) Heckel (1997) pp 1-41 Gabba (2003) pp 7-9 Santi Amantini (2003) pp 99-110 Mariotta (2014) pp 45-56 48 Franco (1993) pp 71-97 e Landucci (2014) pp 233-26149 Alonso-Nuacutentildeez (2002) pp 105-110 partic 108-109
IL DISCORSO DEL RE 137
sato da Trogo considerando che il periodo compreso tra le imprese dei due Filippo occupa 23 dellrsquoopera50 Si potrebbe allora suggerire che le Storie sono Filippiche poicheacute i due Filippo segnarono lrsquoinizio e la fine di quella che egrave nellrsquoopera di Trogo lrsquoegemonia incontrastata del mondo piugrave gloriosa di tutti i tempi51
La prospettiva ellenistica che vede nei due Filippo i limiti della grande egemonia macedone egrave di nuovo presente anche in Appiano nellrsquooraco-lo riportato nei frammenti della sua Makedonikeacute e noto anche da Pausa-nia (VII 8 9)
αὐχοῦντες βασιλεῦσι Μακηδόνες Ἀργεάδῃσιν ὑμῖν κοιρανέων ἀγαθὸν καὶ πῆμα Φίλιππος ἤτοι ὁ μὲν πρότερος πόλεσιν λαοῖσί τ᾽ ἄνακτας θήσει ὁ δ᾽ ὁπλότερος τιμὴν ἀπὸ πᾶσαν ὀλέσσει δμηθεὶς δ᾽ ἑσπερίοισιν ὑπ᾽ ἀνδράσιν ἐνθάδ᾽ ὀλεῖται
O Macedoni che andate orgogliosi dei re di stirpe argiva I re di nome Filippo saranno arbitri del bene e del male per voi Il primo vi renderagrave signori di cittagrave e popoli il secondo vi priveragrave di ogni onore sconfitto da uomini dellrsquoOcciden-te qui giace morto52
Senza voler entrare nel merito della discussione di tale oracolo di nuo-vo pare di incontrare nei due autori la medesima prospettiva lontana dalla condanna morale del re macedone espressa da Polibio secondo cui la sconfitta egrave il giusto esito della sua crudeltagrave ed empietagrave
Il libro giustineo si conclude menzionando le condizioni della pa-ce di Tempe53 e lrsquoira degli Etoli che videro ignorate le proprie richieste da Flaminino e perciograve cercarono lrsquoalleanza di Antioco contro Roma Se-condo il Prologo XXX il libro perograve proseguiva con le campagne di Antio-co III in Asia Minore contro Molone e Acheo e in Battriana fino ad ar-rivare allrsquoesordio dello scontro con Roma54 Il riassunto giustineo egrave trop-po sommario per permettere un confronto con le fonti parallele Egrave pe-
50 Sul rilievo della storia della Macedonia nellrsquoopera di Trogo e Giustino vd von Gutsch-midt (1894) pp 17-217 Richter (1987) p 28 n 29 Franco (1993) pp 71-97 51 Vd anche Urban (1982) pp 1424-1443 e Alonso-Nuacutentildeez (1992) p 58 52 Mak Fr 2 Vd DrsquoAgostini (2011) pp 99-121 In questa Walbank (2002) pp 127-136 propone di interpretare anche un poema di Alceo di Messene (Anth Pal 9518)53 Egrave probabile che Trogo fornisse piugrave particolari riguardo a questa pace per esempio si puograve ritenere che vi fosse menzione dellrsquoinvio a Roma del figlio Demetrio da parte di Filippo come ostaggio dato che a Iust XXXII 2 3 si richiama appunto tale avvenimento54 Polyb XVIII 34 1-39 7 42 1-45 12 Liv XXXIII 11 3-13 15 24 1-31 11 Plut Flam IX 1-8 App Mak Fr IX riferiscono di due diverse trattative di pace caratterizzate da un vivace dibattito tra chi voleva lrsquoannientamento della Macedonia come in Grecia gli Etoli e a Roma Marco Claudio Marcello e coloro che desideravano la pace con la Macedonia in primis Flaminino
138 MONICA DrsquoAGOSTINI
rograve da notare la mancanza sia nel Prologo che nel testo del libro degli av-venimenti delle celebrazioni Istmie del 196 quando Flaminino procla-mograve la libertagrave dei Greci Piugrave in generale in tutta la narrazione di Giustino delle complesse trattative del 197-196 manca qualsiasi riferimento alla li-bertagrave dei Greci punto nodale nella tradizione di Polibio che con questa sottolineatura esalta sia il ruolo tirannico della Macedonia sia la grande generositagrave dei Romani nei confronti della Grecia Il silenzio di TrogoGiustino su tale questione mostra il prevedibile disinteresse per gli affari dei Greci e nel contempo conferma la presenza di una tradizione che si occupa soprattutto della storia delle monarchie ellenistiche allrsquointer-no della quale la posizione dellrsquoEllade egrave subalterna
Libro XXXII23- 34 Demetrio e Perseo
Gli ultimi anni di regno di Filippo tra il 183 e il 179 sono narrati in un passo breve del libro XXXII Il racconto in Giustino che egrave coerente con il Prologo trogiano segue in maniera sintetica la tradizione polibiana su questi eventi giunta a noi in alcuni passi lacunosi di Polibio (XXIII 1 3-3 10 7 1-7 10 1-11 8) integrati dal racconto particolareggiato di Li-vio (XXXIX 46 7- 48 6 53 1-16 XL 3 3-16 3 201-24 8) e dalla narra-zione di Diodoro (XIX 25) e Plutarco (Aem VIII 11)55
Conclusioni
In questi libri dedicati a Filippo egrave forse possibile vedere in filigrana la rielaborazione voluta di Giustino dei corrispondenti libri trogiani Co-me Giustino stesso afferma nella Prefatio 3 lrsquoopera di Trogo era costruita secondo due criteri quello cronologico e quello per laquoconcatenazione di eventi56raquo ea omnia Pompeius diuisa temporibus et serie rerum digesta conposuit
55 Lrsquoutilizzo della tradizione polibiana in Trogo egrave confermato dallrsquoaderenza a Livio (XL 54 1-56 11) e Diodoro (XXIX 28) del racconto sul pentimento di Filippo per aver ucciso il figlio Demetrio lrsquointenzione di punire Perseo e la correlazione tra questo e la sua mor-te Questo libro egrave dunque differente nellrsquointeresse e nelle fonti dai libri XXIX e XXX poicheacute molto vicino alla tradizione polibiana in Livio Questi avvenimenti in Giustino sono da collegare con lrsquoascesa al trono di Perseo e non con lrsquoepilogo della celebrazione del valore macedone giagrave conclusasi in Giustino con Cinoscefale e la transizione dallrsquoim-perium macedone allrsquoimperium romano Vd Heckel (1997) p 7 Appiano invece riporta ancora una tradizione diversa da quella polibiana in un frammento della Makedonikeacute in particolare Appiano egrave attento al punto di vista macedone e presenta Filippo come una vittima delle circostanze (Mak IX) DrsquoAgostini (2011) pp 99-12156 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362 Alonso-Nuacutentildeez (2002) pp 133-136 He-ckel (1997) pp 1-41 Borgna (2014) pp 52-77
IL DISCORSO DEL RE 139
Serie rerum digesta sembrerebbe unrsquointerpretazione latina della formula κατὰ γένος che Diodoro usa per indicare la struttura della storia di Efo-ro sottolineandone la divisione per argomento57 In tale struttura per argomento dellrsquoEpitome tra i temi principali ci sono dunque il valore e la gloria dei sovrani ellenistici58 riscontrabile nei libri XXVIII-XXXI sui re-gni di Antigono Dosone Filippo V e Antioco III Tale tema presente di sicuro in Trogo egrave conservato nellrsquoazione dellrsquoEpitomatore e anzi come si vede dagli escerpta esaltato dalla selezione dei passi
Per quanto riguarda invece la Quellenforschung 59 egrave evidente che nel testo vi sia presenza di filoni non tradizionali sugli eventi poicheacute la posi-zione di Trogo appare spesso autonoma rispetto alle opinioni condivise dalla storiografia antica Questo aspetto dellrsquoEpitome evidente soprattut-to per ciograve che riguarda gli eventi ellenistici ha suscitato la grande curio-sitagrave degli studiosi che allontanatisi dalla proposta di von Gutschmid che voleva una totale ed esclusiva dipendenza di Trogo da Timagene ora in-dicano con sicurezza tra le fonti piugrave rilevanti per gli eventi ellenistici di III secolo utilizzate da Trogo almeno altri sei nomi oltre a Timagene Ie-ronimo Timeo Filarco Duride Polibio e Posidonio
Per quanto riguarda nello specifico la composizione dei libri XXIX e XXX non vi egrave alcun dubbio che in essi Trogo abbia utilizzato (anche riadattandola) una fonte poco attenta alle questioni di politica interna greca e al legame tra queste e quel ritratto di Filippo come sovrano mal-vagio ed empio che ritorna nella tradizione ufficiale di origine polibia-na passando poi da Polibio in Livio Diodoro e Plutarco60 Trogo pre-serva invece una tradizione ellenistica interessata alla figura di Filippo come ultimo barlume della gloria macedone tradizione che pare quasi una controparte e un completamento dellrsquoAb urbe condita romanocentri-ca di Livio Non si puograve perciograve a mio avviso escludere che per questa se-zione Trogo abbia usato una tradizione di matrice filoellenistica o sem-plicemente ellenisticocentrica unrsquoopera sui regni di diadochi ed epigo-ni che a tutti noi fa venire facilmente alla mente il Basileis o Perigrave Basileon dello storico grecoellenistico augusteo filobarbaro scettico (o critico) verso lrsquoegemonia romana Timagene di Alessandria (FGrHist 88)61
57 Su Eforo vd Vannicelli (1987) pp 165-191 e ora Parmeggiani (2011) 58 Simile legame vi egrave a mio avviso tra i libri XXVI e XXVII che invece affrontavano la crisi delle monarchie ellenistiche causata dalle guerre fraterne59 Vd von Gutschmid (1894) pp 17-217 Richter (1987) pp 17-30 partic 20-23 San-ti Amantini (1972) pp 56-109 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362 Urban (1982) pp 1424-1443 partic 1435 Mecca (2001) pp 199-222 Santi Amantini (2003) pp 99-110 Heckel (2012) pp 3-860 Scuderi (2005) pp 383-40561 Sordi (1982) pp 775-797 Heckel (1997) pp 30-34 Landucci (2014) pp 233-261 e Ead in questo volume
140 MONICA DrsquoAGOSTINI
ABSTRACT
Philip V of Macedon was the first of the Epigonoi to face Rome Several mod-ern reconstructions of the actions and the reign of Philip V have approached it largely from a Roman point of view using as sources Polybius and where Poly-bius is lost Livy The Polybian historiographical tradition tends to portray Phil-ip V as an enemy and a tyrant impious and cruel The Macedonian king was ea-ger to establish a universal and unjust dominion over Greece Italy and beyond and Rome engaged in the first two Macedonian Wars to fight the threat of his growing ambition Nevertheless Polybiusrsquo portrayal of Philip V was affected not only by Polybiusrsquo admiration for Roman political structures military power and overwhelming conquest but also his personal Achaean origins
Looking at in book 29 and 30 of Justinrsquos Epitome of Pompeius Trogus this pa-per focuses on the non Polybian tradition on Philip V this contribution is in-deed the first analysis of the Hellenistic approach to the clash between Rome and Macedonia in the 3rd-2nd Century BC The Epitome shows a considerable di-versity of interpretation from the other sources and reflects very different views of Philip Vrsquos actions that brought him into conflict against Rome In particular these views are more evident related to the accounts of the peace negotiations of Naupactus and the battle of Cynoscephalae in the Epitome the king appears as a courageous and skilled warrior the last of the great Macedonian rulers who fell victim to misfortune This portrayal which has several common features with Appianrsquos fragments of Philip V (Mak 9) counterbalances the Roman and Achaean standpoint present in Polybius providing a more Hellenistic perspec-tive that is likely to have been rooted in a historiographical tradition connect-ed to the losing side in the struggle between Rome and the Hellenistic world
BIBLIOGRAFIA
Adler E (2006) Whorsquos Antiroman Sallust and Pompeius Trogus on Mithridates CJ 101 pp 383-407
Adler E (2011) Valorizing the Barbarians Enemy speeches in Roman Historiography Austin
Ager SL (2003) An Uneasy Balance from the Death of Seleukos to the Battle of Raph-ia in A Erskine (ed) A Companion to the Hellenistic World Oxford pp 35-50
Ager SL (2009) Roman Perspectives on Greek Diplomacy The conceptual clash Greek diplomacy of compromise and Roman Bellum Iustum in C Eilers (ed) Diplomats and Diplomacy in the Roman World Leiden-Boston pp 15-43
Alonso-Nuacutentildeez JM (1992) La Historia Universal de Pompeyo Trogo Madrid
Alonso-Nuacutentildeez JM (2002) The Idea of Universal History in Greece From Herodotus to the Age of Augustus Amsterdam
Ballesteros Pastor L (2013) Pompeyo Trogo Justino y Mitriacutedates Comentario al Epiacutetome de las Historias Filiacutepicas (3716-3881) Hildesheim-Zuumlrich-New York
IL DISCORSO DEL RE 141
Barreacute ML (1983) The God-List in the Treaty between Hannibal and Philip V of Ma-cedon a Study in Light of the Ancient Near Eastern Treaty Tradition Baltimore-Lon-don
Beck H - Eckstein A (2015) sv ldquoAratos of Sicyon (231)rdquo in I Worthington (ed) Brillrsquos New Jacoby Brill Online
Borgna A (2014) Uno sguardo originale intorno a Roma Pompeo Trogo e Giustino laquoLa Biblioteca di ClassicoContemporaneoraquo 1 pp 52-77
Cassola F (1962) I gruppi politici romani nel III secolo aC Trieste
Champion CB (1997) The Nature of Authoritative Evidence in Polybios and Agelausrsquo Speech at Naupactos TAPhA 127 pp 111-128
Champion CB (2004) Cultural Politics in Polybiusrsquo Histories Berkeley
Coppola A (1993) Demetrio di Faro un protagonista dimenticato Roma
Criscuolo L (2011) I due testamenti di Tolemeo VIII Evergete II in A Joumlrdens - J F Quack (hrsg) Aumlgypten zwischen innerem Zwist und aumluszligerem Druck Die Zeit Ptole-maios VI bis VIII Wiesbaden pp 132-150
DrsquoAgostini M (2011) Filippo V e la Storia Romana di Appiano laquoAevumraquo 85 pp 99-121
Eckstein AM (1995) Moral vision in the Histories of Polybius Berkeley
Eckstein AM (2008) Rome enters in the Greek East From Anarchy to Hierarchy in the Hellenistic Mediterranean 230-217 BC Oxford
Eckstein AM (2013) Polybius Phylarchus and Historiographical Criticism CPh 108 4 pp 314-338
Errington RM (1969) Philopoemen Oxford
Errington RM (2008) A History of the Hellenistic World 323-30 BC Malden MA-Oxford
Forni G - Angeli Bertinelli MG (1982) Pompeo Trogo come fonte di storia ANRW II 30 2 pp 1298-1362
Franco C (1993) Trogo Giustino e i successori di Alessandro in L Braccesi - A Coppola - G Cresci Marrone - C Franco (a cura di) LrsquoAlessandro di Giustino dagli antichi ai moderni Roma pp 71-97
Gabba E (2003) Introduzione in D Foraboschi - SM Pizzetti (a cura di) La successione degli imperi e delle egemonie nelle relazioni internazionali Milano pp 7-9
Golan D (1995) The Res Graeciae in Polybius Four Studies Como
Green P (1990) Alexander to Actium The Historical Evolution of the Hellenistic Age Berkeley-Los Angeles
Gutschmid von A (1894) Die beiden ersten Buumlcher des Pompeius Trogus in A von Gutschmid - F Ruumlhl (hrsg) Kleine Schriften Leipzig pp 17-217
142 MONICA DrsquoAGOSTINI
Habicht C (1995) Athen Muumlnchen
Hammond NGL (1968) Illyris Rome and Macedon in 229-205 BC JRS 58 pp 1-21
Hammond NGL (1988) The Campaign and the Battle of Cynoscephalae in 197 BC JHS 108 pp 60-82
Heckel W (1997) Introduction (Part 2) in JC Yardley - W Heckel (eds) Ju-stin Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus Books 11-12 Alexander the Great Introduction Oxford pp 1-41
Heckel W (2012) Introduction in JC Yardley - P Wheatley - W Heckel (eds) Justin Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus II Books 13-15 The Successors to Alexander the Great Oxford pp 1-8
Huss W (1976) Untersuchungen zur Auszligenpolitik Ptolemaiosrsquo IV Muumlnchen
Huss W (2001) Aumlgypten in hellenistischer Zeit 332ndash30 v Chr Muumlnchen
Intrieri M (2011) Fra dialogo e conflitto Annibale e i Greci drsquoOccidente RStudFen 37 pp 53-82
Landucci F (2014) Filippo II e le Storie Filippiche un protagonista storico e storio-grafico in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 233-261
Landucci Gattinoni F (2011) Politica e ideologia in etagrave ellenistica laquoPolitica An-ticaraquo 1 pp 89-105
Leacutevy E (1994) Le discours drsquoAgeacutelaos de Naupacte in L Aigner Foresti - A Bar-zanograve - C Bearzot - L Prandi - G Zecchini (a cura di) Federazioni e federalismo nellrsquoEuropa antica Bergamo 21-25 settembre 1992 Milano (Alle radici della casa co-mune europea 1) pp 33-50
Longaretti L (1989) Lrsquoalleanza tra Annibale e Filippo V di Macedonia RIL 123 pp 183-192
Marasco G (1979-1980) La valutazione di Tolemeo IV Filopatore nella storiografia greca laquoSilenoraquo 5-6 pp 159-182
Mari M [- Musti D - Thornton J] (2002) Polibio Storie Volume III Libri V-VI Milano
Mariotta G (2014) Geografia e Geopolitica nelle Storie Filippiche in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 45-56
McGing B (2010) Polybiusrsquo Histories New York
McGing B (2013) Youthfulness in Polybius the case of Philip V of Macedon in B Gibson - T Harrison (eds) Polybius and his world Oxford pp 181-199
Meadows A (2013) Polybius Aratus and the History of the 140th Olympiad in B
IL DISCORSO DEL RE 143
Gibson - T Harrison (eds) Polybius and his World Essays in Honour of Frank Walbank Oxford pp 91-116
Mecca A (2001) Trogo Timagene e Polieno QS 54 pp 199-222
Meister K (1990) Die Griechische Geschichtsschreibung von den Anfaumlngen bis zum Ende des Hellenismus Stuttgart
Misch G (1949) Geschichte der Autobiographie I Frankfurt am Mein
Momigliano A (1980) Daniele e la teoria greca della successione degli imperi RAL 35 pp 157-162
Muccioli F (2013) Gli epiteti ufficiali dei re ellenistici Stuttgart (Historia Einzel-schriften 224)
Musti D (1978) Polibio e lrsquoimperialismo romano Napoli
Parmeggiani G (2011) Eforo di Cuma studi di storiografia greca Bologna
Peacutedech P (1964) La meacutethode historique de Polybe Paris
Pelling CBR [- Scardigli B - Manfredini M](1997) Plutarco Vite parallele Filopemene Tito Flaminino Milano
Richter H-D (1987) Untersuchungen zur hellenistischen Historiographie die Vorla-gen des Pompeius Trogus fuumlr die Darstellung der nachalexandrischen hellenistischen Ge-schichte (Iust 13-40) Frankfurt
Santi Amantini L (1972) Fonti e valore storico di Pompeo Trogo (Iustin XXXV e XXXVI) Genova
Santi Amantini L (1981) (a cura di) Giustino Storie Filippiche Epitome da Pom-peo Trogo Milano
Santi Amantini L (2003) Il tempo e i tempi nelle Storie Filippiche di Pompeo Tro-go RSA 33 pp 99-110
Schepens G (1983) Les rois ptolegravemaiumlques et lrsquohistoriographie Reacuteflexions sur la trans-formation de lrsquohistoire politique in E vanrsquot Dack - P van Dessel - W Van Gucht (eds) Egypt and the Hellenistic World Proceedings of the International Collo-quium Leuven 24-26 May 1982 Leuven (Studia Hellenistica 27) pp 351-368
Schlicher JJ (1933) Non-Assertive Elements in the Language of the Roman Histo-rians CPh 28 289-300
Schmitt T (1989) Die Bedeutung des zweiten Punischen Krieges fuumlr den Frieden in Naupaktos in H Devijver - E Lipinski (eds) Punic wars Proceedings of the Conference held in Antwerp from the 23th to the 26th of November 1988 in Cooperation with the Departement of History of the laquoUniversitait Antwerpenraquo UFSIA Leuven (Studia Phoenicia 10) pp 229-239
Scholten JB (2000) The Politics of Plunder Aitolians and their koinon in the early Hellenistic Era Berkeley
144 MONICA DrsquoAGOSTINI
Scuderi R (2005) Filippo V e Perseo nei frammenti diodorei in C Bearzot - F Lan-ducci (a cura di) Diodoro e lrsquoaltra Grecia Macedonia Occidente Ellenismo nella Bi-blioteca Storica Atti del convegno Milano 15-16 gennaio 2004 Milano pp 383-405
Sklenaacuter RJ (2004) Sources and Individuality in Two Passages of Livy laquoHistoriaraquo 53 pp 302-310
Sordi M (1982) Timagene di Alessandria Uno storico ellenocentrico e filobarbaro ANRW II 30 1 pp 775-797
Thornton J (2014) Le guerre macedoniche Roma
Urban R (1979) Wachstum und Kriese des achaumlischen Bundes Quellenstudien zur entwicklung des Bundes von 280 bis 222 V Chr Wiesbaden
Urban R (1982) laquoGallisches Bewusstseinraquo und laquoRomkritikraquo bei Pompeius Trogus ANRW II 30 2 pp 1424-1443
Vannicelli P (1987) Lrsquoeconomia delle Storie di Eforo RFIC 115 pp 165-191
Vattuone R (2014) Giustino e lrsquoOccidente greco I VI-V secolo aC in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 261-277
Vollmer D (1990) Symploke das Uumlbergreifen der roumlmischen Expansion auf den grie-chischen Osten Untersuchungen zur roumlmischen Aussenpolitik am Ende des 3 Jh V Chr Stuttgart
Walbank FW (1957) A Historical Commentary on Polibius I Oxford
Walbank FW (1967) A Historical Commentary on Polybius II Oxford
Walbank FW (1933) Aratos of Sicyon Cambridge
Walbank FW (2002) Η ΤΩΝ ΟΛΩΝ ΕΛΠΙΣ and the Antigonids in FW Walbank (ed) Polybius Rome and the Hellenistic World Essays and Reflections West Nyack NY pp 127-136
Weber G (1997) Interaktion Repraumlsentation und Herrschaft Der Koumlnigshof im Hel-lenismus in A Winterling (hrsg) Zwischen lsquoHausrsquo und lsquoStaatrsquo antike Houmlfe im Ver-gleich Munich pp 27-72
Will E (19822) Histoire politique du Monde Helleacutenistique II Nancy
Zecchini G (1990) La storiografia lagide in H Verdin - G Schepens - E De Keyser (eds) Purposes of History Studies in Greek Historiography from the 4th to the 2nd Centuries BC Proceedings of the International Colloquium of Leuven 24-26 May 1988 Leuven (Studia Hellenistica 30) pp 213-232
Zecchini G (2003) Polibio e la tradizione orale in A Casanova - P Desideri (a cura di) Evento racconto scrittura nellrsquoantichitagrave classica Firenze pp 123-141
Finito di stamparenel mese di novembre 2015
da LegoDigit srlLavis (TN)
La pubblicazione di questo volume ha ricevuto il contribu-to finanziario dellrsquoUniversitagrave Cattolica ed egrave stata realizzata grazie al contributo del Progetto PRIN 2010-2011 del Mini-stero dellrsquoIstruzione dellrsquoUniversitagrave e della Ricerca
wwwvitaepensieroit
Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15 di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dallrsquoart 68 commi 4 e 5 della legge 22 aprile 1941 n 633Le fotocopie effettuate per finalitagrave di carattere professionale economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi Cen-tro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali Corso di Porta Romana 108 20122 Milano e-mail autorizzazioniclearediorg e sito web wwwclearediorg
copy 2015 Vita e Pensiero - Largo A Gemelli 1 - 20123 MilanoISBN 978-88-343-3107-1
PP_Bearzot-Landucciindd 4 131115 1550
INDICE
Presentazione VII
LUISA PRANDIAlessandro il Grande in Giustino 3
FRANCA LANDUCCII Diadochi 17
GIOVANNI BRIZZIGiustino e la storia di Cartagine 39
RICCARDO VATTUONEGiustino e lrsquoOccidente greco II IV-III secolo aC 55
MARIA TERESA SCHETTINOPirro in Giustino 69
FEDERICOMARIA MUCCIOLILrsquoOriente seleucidico da Antioco I ai primi anni di Antioco III in Pompeo TrogoGiustino 99
MONICA DrsquoAGOSTINI Il discorso del Re Filippo V in Giustino 121
01_indiceindd V01_indiceindd V 201115 1537201115 1537
MONICA DrsquoAGOSTINI
Il discorso del Re Filippo V in Giustino
Introduzione
Le vicissitudini del reame antigonide durante il regno di Filippo V sono trattate principalmente nei libri XXIX e XXX delle Epitome delle Storie Fi-lippiche di Pompeo Trogo Alle notizie contenute in questi libri si aggiungo-no la breve menzione dellrsquoascesa al trono del sovrano nel libro XXVIII (3 9 e 4 16) e la descrizione degli eventi relativi alla sua morte nel libro XXXII (2 3- 3 4)
Egrave chiaro dal confronto tra i Prologi e lrsquoEpitome che ampie parti dei due libri trogiani sono state omesse in Giustino in particolare quelle ineren-ti agli avvenimenti orientali poicheacute nec cognoscendi voluptate iucunda nec exemplo erant necessaria (Praefatio 4) le origini di Creta e gli scontri tra Fi-lippo e Attalo nel libro XXIX la spedizione di Filippo in Asia e le cam-pagne di Antioco III nel libro XXX
Degli eventi dei libri XXIX e XXX sono invece menzionati in forma di riassunto da Giustino i piugrave importanti scontri militari tra Roma e Fi-lippo Nella categoria dei passi lsquoepitomatirsquo rientrano la Guerra degli Al-leati la Prima Guerra Macedonica la Seconda Guerra Macedonica Ci-noscefale e le rispettive trattative di pace ovvero Naupatto Fenice Tem-pe Quando ci si trova di fronte a tali riassunti egrave spesso difficile un con-fronto puntuale con le altre tradizioni pur con lrsquoaiuto dei Prologi
Gli eventi che ricevono attenzione nei libri XXIX e XXX sono sele-zionati secondo il criterio giustineo del cosiddetto lsquoflorilegiorsquo1 ovvero per cognitione quaeque dignissima (Praefatio 4)2 Piugrave vicini allrsquooriginale tro-giano e dunque piugrave excerpta che sintesi sono da ritenersi probabilmente i passi del libro XXIX sullrsquoalleanza tra Annibale e Filippo e sulla politica filoromana di Filopemene e quelli del libro XXX sulle questioni amo-
1 Vattuone (2014) pp 261-2772 I criteri per la distinzione dei passi piugrave vicini a Trogo e quelli invece riassunti da Giustino sono stati discussi autorevolmente allrsquointerno di questo progetto da Vattuone (2014) pp 261-277 Sul rapporto tra lrsquoopera di Trogo e lrsquoEpitome vd anche recentemente Heckel (1997) pp 1-41 e Id (2012) pp 1-8 e Borgna (2014) pp 52-77
122 MONICA DrsquoAGOSTINI
rose di Tolemeo III sul patto tra Antioco e Filippo e sullrsquoira degli Eto-li che nel 196 non videro appagata la richiesta di annientare la Macedo-nia Questi passi si prestano maggiormente a un confronto con le fonti parallele bencheacute con prudenza
Centrali nei due libri sono i cinque discorsi in oratio obliqua il primo egrave quello attribuito a Demetrio di Faro seguono tre di Filippo V men-tre lrsquoultimo egrave di Flaminino Poicheacute secondo Giustino (XXXVIII 3 11) Trogo utilizzava solamente lrsquooratio obliqua e avrebbe criticato aspramen-te Sallustio e Livio per lrsquoimpiego di numerosi discorsi in oratio recta i cin-que riportati nei libri XXIX e XXX sono stati considerati trasposizioni dellrsquooriginale trogiano3 In effetti tali discorsi fungono da ossatura del percorso narrativo dei due libri e sono da considerare le sezioni di que-sti libri piugrave vicine allrsquooriginale trogiano Sono perciograve i passi che offrono maggior possibilitagrave di studio per mettere in luce la presenza o lrsquoassen-za di una tradizione alternativa su Filippo V se questa sia giagrave in Trogo e quanto in quale modo e con quale interesse Giustino abbia interpolato tale tradizione Data la complessitagrave dei due libri ritengo opportuno ana-lizzare gli avvenimenti trattati seguendo la divisione in capitoli giustinea
Libro XXIX11-11 Introduzione
Il primo capitolo del libro XXIX si presenta con precisione nei riferi-menti coerenza testuale e attenzione ai dettagli Giustino probabilmen-te ricalcando le riflessioni di Trogo alla considerazione incipitale sul ge-nerale rinnovamento dei vertici degli imperi di lsquotutto il mondorsquo alla fine del III secolo aC fa seguire la lista dei nuovi re con alcuni commenti relativi ai singoli monarchi In particolare si sottolinea la giovane etagrave di tutti i sovrani e i condottieri al momento della loro ascesa al potere os-servazione ribadita nel commento finale al capitolo (XXIX 1 8)
His regibus pueris tametsi nulli senioris aetatis rectores erant tamen in suorum quisque maiorum uestigia intentis magna indoles uirtutis enituit
Questi re fanciulli sebbene non avessero guide di etagrave piugrave anziana tuttavia se-
3 Schlicher (1933) pp 289-300 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362 partic 1309 Adler (2006) pp 383-407 e Id (2011) pp 37-40 Recentemente Ballesteros Pastor (2013) pp 52-54 commentando il discorso di Mitridate (XXXVIII 4-7) ha ritenuto che Giustino abbia dichiarato il falso a proposito dellrsquooratio obliqua a suo avviso in Trogo ci sarebbero stati infatti numerosi discorsi diretti che poi Giustino avrebbe tragravedito come discorsi indiretti nellrsquoEpitome inserendo nel passaggio alcuni errori sintattici e incon-gruenze
IL DISCORSO DEL RE 123
guirono ciascuno con impegno le orme degli antenati e in loro rifulse un gran-de innato valore4
Questa introduzione sembra modellata sul cosiddetto lsquosecondo proe-miorsquo di Polibio (IV 2) la lista dei sovrani e lrsquoordine coincidono infatti con quello del Megalopolitano se non per lrsquoesclusione dellrsquousurpatore seleucide Acheo5 Lrsquointenzione del passo nelle due opere egrave perograve diver-sa mentre il Megalopolitano nel proemio metteva in risalto il sorgere quasi in contemporanea di nuovi conflitti in diverse parti del Mediter-raneo nellrsquoEpitome il filo conduttore di questo elenco di sovrani e con-dottieri egrave la loro gloria e la grandezza degli eventi che essi compirono in giovane etagrave6 Inoltre vi sono in Trogo alcune notizie originali rispetto al Megalopolitano il fatto che lrsquoepiteto Filopatore di Tolemeo IV sia mes-so in relazione con lrsquoassassinio dei genitori del sovrano oppure che lrsquoa-scesa di Annibale al comando dei Cartaginesi sia spiegata con il suo odio per i Romani Entrambe queste notizie non appartengono alla tradizio-ne polibiana in Polibio (II 36 3) Annibale era stato eletto comandante dellrsquoesercito in Spagna per i successi ottenuti mentre il padre Amilcare gli aveva fatto giurare odio eterno ai Romani Per quanto riguarda il Fi-lopatore Polibio ritiene che egli non abbia assassinato la madre Bereni-ce vittima invece del consigliere Sosibio (Polyb V 36 1)7 La versione di Trogo egrave dunque frutto di una propaganda avversa a Tolemeo IV che lo dipinge ancora piugrave negativamente di quanto fatto dalla tradizione poli-biana che certo giagrave non era favorevole al sovrano8
NellrsquoEpitome di Giustino segue una sintesi dei primi anni di regno di Filippo V in particolare vi egrave un brevissimo riferimento allrsquoinaspettata vit-toria del sovrano contro i Dardani che lo avrebbe portato a cercare lo
4 La traduzione di Giustino come tutte quelle presenti nel testo sono da Santi Amantini (1981) Lrsquounica eccezione a questa affermazione egrave il Filopatore Sulla tradizione storio-grafica avversa al Filopatore vd infra 5 Acheo egrave personaggio noto a Trogo che lo menziona altrove Prol XXX6 La giovinezza in TrogoGiustino egrave percepita come un valore aggiunto mentre per Poli-bio egrave una debolezza Eckstein (1995) p 143 McGing (2013) pp 181-1997 Muccioli (2013) pp 220-223 osserva che lrsquoepiteto fu assunto da Tolemeo IV quando il padre era vivo come strumento per sottolineare la sua predestinazione al trono 8 Polyb V 34 3-5 come anche Plut Cleom 33-34 forniscono notizie denigratorie su Tole-meo IV che sarebbe stato un sovrano inadatto a governare Secondo Huss (1976) pp 9 e 19 e (2001) pp 381-472 alla base vi sarebbe Filarco Se invece si considerano gli studi fatti su Tolemeo di Megalopoli da Schepens (1983) pp 351-368 e Zecchini (1990) pp 213-232 partic 218 egrave possibile che Tolemeo di Megalopoli nello scrivere unrsquoopera sto-riografica su un sovrano lagide non omettesse di menzionare notizie meno celebrative come Teopompo prima di lui aveva fatto nei confronti di Filippo II Sulla tradizione storiografica avversa a Tolemeo IV vd anche Marasco (19791980) pp 159-182 Weber (1997) pp 27ndash72 partic 28 Ager (2003) pp 35-50 McGing (2010) pp 117-119 Cri-scuolo (2011) pp 132-150 partic 148-149
124 MONICA DrsquoAGOSTINI
scontro con gli Etoli Egrave difficile dire se Trogo dedicasse piugrave spazio alla narrazione degli eventi tra il 220 e il 217 Nel Prologo si legge
Undetricensimo volumine continentur haec Res gestae Philippi regis adversus Dardanos et Aetolos repetitaeque inde Creticae origines post cuius insulae societatem Philippus cum Illyriis et Dardanis et rursus Aetolis bello congressus est adiuvantibus Aetolos Romanis quo finito intulit Attalo bellum
Il ventinovesimo libro contiene le imprese del re Filippo contro i Dardani e gli Etoli Sono quindi rievocate le origini di Creta dopo essersi alleato con questrsquoi-sola Filippo si scontrograve in guerra con gli Illiri i Dardani e di nuovo con gli Eto-li mentre i Romani soccorrevano gli Etoli Terminata questa guerra Filippo at-taccograve Attalo
Dal confronto tra Giustino e i Prologi egrave evidente che quella che per i mo-derni egrave la lsquoGuerra degli Alleatirsquo tra Etoli aiutati da Sparta e dallrsquoElide e la Lega Achea alleata di Filippo V sia ridotta sia in Giustino che in Tro-go a una guerra di Filippo contro gli Etoli Colpisce in effetti la comple-ta mancanza nel Prologo XXIX e nellrsquoEpitome del libro di qualsiasi men-zione e riferimento alla Lega Achea e al suo leader Arato protagonisti indiscussi invece nelle Storie polibiane dei primi anni di regno di Filippo V 9 Arato di Sicione importante statista e comandante militare della Le-ga Achea fu uno dei primi personaggi politici a scrivere e pubblicare le proprie memorie (FGrHist 231) di cui Polibio si servigrave ampiamente (I 3 1)10 Lo storico di Megalopoli era un compatriota di Arato e come lui ricoprigrave importanti cariche allrsquointerno della Lega Achea11 Polibio che considerava Arato uno dei fondatori della Lega vedeva in lui una sorta di eroe e leader ideale come emerge dalla descrizione che ne fa di uomo perfetto per lrsquoattivitagrave politica astuto tollerante coraggioso e di succes-so (IV 7 11-8 12) Il rapporto tra Filippo V e Arato egrave determinante per il giudizio di Polibio sul sovrano macedone Filippo egrave infatti descritto co-me un buon sovrano valoroso ma troppo giovane che nei primi anni di regno agigrave bene poicheacute ascoltograve e seguigrave i consigli di Arato (IV 77 1-4)12
Per quanto argumentum e silentio questa assenza di Arato di Sicione e della Lega Achea sia nel Prologo di Trogo che nellrsquoEpitome di Giustino
9 Polibio dedica alla Lega Achea ampia parte dei libri IV e V 10 Riguardo ad Arato di Sicione soprattutto nel rapporto con Polibio vd Meadows (2013) pp 91-116 Vd anche Walbank (1933) Misch (1949) pp 210-212 Urban (1979) Meister (1990) pp 187-189 Habicht (1995) pp 176-179 Beck - Eckstein (2015) sv laquoAratos of Sicyon (231)raquo in BNJ11 Sui legami di Polibio e la sua famiglia con la Lega Achea vd Eckstein (2013) pp 314-33812 Polyb IV 24 1-3 e V 26 6 seguito da Plut Arat 48-49 afferma esplicitamente che il re portava a termine abilmente i suoi piani poicheacute Arato era al suo fianco
IL DISCORSO DEL RE 125
non solo non puograve passare inosservata ma deve indurre i moderni a du-bitare per questi eventi di unrsquoapparente dipendenza diretta giagrave di Tro-go da Polibio
21- 38 Demetrio di Faro e Naupatto
Scomparso Arato nellrsquoEpitome XXIX ha invece un ruolo fondamentale in questi anni come consigliere di Filippo Demetrio di Faro a cui egrave at-tribuito il primo discorso in oratio obliqua dei due libri esaminati13
Demetrio di Faro era un dinasta illirico che si incontra per la prima volta nelle fonti storiografiche in occasione della prima guerra di Ro-ma in Illiria nel 229 Sappiamo infatti da Polibio (II 10 8-11 4) e Appia-no (Illyr 7) che Demetrio giagrave alleato di Teuta sovrana degli Illiri aveva scelto di passare dalla parte romana ed era stato poi ricompensato dal Senato con il controllo di parte dei territori sottratti da Roma a Teuta stessa Nei suoi tentativi di ritagliarsi un ruolo importante nella penisola balcanica Demetrio nel 222 si era alleato con la Lega Ellenica di Doso-ne e Arato a Sellasia contro Cleomene (Polyb II 65 2- 5) ma negli an-ni successivi le sue scorribande nellrsquoAdriatico allarmarono Roma che gli mosse guerra (Polyb III 16 IV 16)14 Sconfitto da Roma e cacciato da Faro Demetrio si rifugiograve alla corte di Filippo intorno al 218 diventan-do consigliere del re
Poicheacute nel Prologo XXVIII si legge laquoIn una digressione egrave narrata la guerra illirica combattuta dai Romani contro Teuta15raquo non egrave da esclu-dere che Trogo giagrave citasse il dinasta di Faro anche se la prima menzio-ne di Demetrio in Giustino egrave a XXIX 2 1 quando il cosiddetto lsquore de-gli Illirirsquo cacciato da Lucio Emilio Paolo dallrsquoAdriatico arrivograve alla corte macedone Nel riassunto degli eventi Giustino segue piugrave da vicino Tro-go riportando il discorso del dinasta a Filippo V per convincere il sovra-no a far guerra a Roma (XXIX 2 2-6) I punti principali di tale discorso sono che i Romani aspirano a realizzare un impero universale a scapito di tutti i re laquocome se fosse cosa illecita che ci fosse un qualche re presso i confini del loro Statoraquo Perciograve Filippo V doveva prepararsi alla guerra con i Romani poicheacute laquoquanto piugrave accessibile e illustre era il suo regno tanto piugrave accaniti nemici gli sarebbero stati i Romani16raquo Demetrio vole-
13 Su questi discorsi di Demetrio vd Coppola (1993) pp 29-5114 Coppola (1993) pp 29-51 vd anche Hammond (1968) pp 1-21 Eckstein (2008) pp 41 58-60 Demetrio di Faro era presentato in Polibio come il rivale di Arato tra i consi-glieri di Filippo Polyb IX 23 9 infatti dichiara che quando il sovrano seguiva i consigli di Arato compiva grandi imprese mentre quando ascoltava Demetrio si macchiava di atti spregevoli15 Trog Prol XXVIII Dictum in excessu bellum Illyricum quod Romani gessere cum Teuta16 Iust XXIX 2 4-5 sibi quoque non aliam ob causam quam quod Italiae finitimus uidebatur
126 MONICA DrsquoAGOSTINI
va infatti cacciare i Romani dalla sponda adriatica dellrsquoIlliria territorio che avrebbe ceduto a Filippo
Il discorso di Demetrio a Filippo egrave presente anche in Polibio (V 101 8-1017) ed egrave inserito cronologicamente durante i giochi Nemei18 nel 217 subito dopo la sconfitta romana del lago Trasimeno ricordata an-che nel passo di Giustino Nel discorso polibiano Demetrio perograve sotto-linea il diritto di Filippo V ad aspirare al dominio universale a partire dallrsquoAdriatico19 mentre nel discorso trogiano Demetrio accusa i Roma-ni di aspirare ad espandersi travolgendo qualsiasi regno sul loro cammi-no Trogo nel discorso di Demetrio presenta il coinvolgimento roma-no in Oriente come una guerra di conquista che contrappone la giova-ne potenza romana allrsquolsquoillustre regnorsquo di Filippo20 prospettiva che ritor-na nel successivo discorso di Filippo V nellrsquoEpitome ma che egrave estranea al-la narrazione di Polibio
Dopo il discorso di Demetrio nellrsquoEpitome come in Polibio (V 104 1) si arriva allrsquoincontro di pace di Naupatto nel 217 che pose fine al-la Guerra degli Alleati tra Etoli Spartani ed Elei contro la lega Achea e
bellum inlatum quasi nefas esset aliquem regem iuxta imperii eorum terminos esse Sed et ipsi cauen-dum esse exemplum cuius quanto promptius nobiliusque sit regnum tanto sit Romanos acriores hostes habiturus17 Polyb V 101 8-10 ὃς καὶ λαβόμενος τῆς ἀφορμῆς ταύτης τὸν μὲν πρὸς τοὺς Αἰτωλοὺς ᾤετο δεῖν τὴν ταχίστην ἀπορρῖψαι πόλεμον ἀντέχεσθαι δὲ τῶν κατὰ τὴν Ἰλλυρίδα πραγμάτων ἠξίου καὶ τῆς εἰς Ἰταλίαν διαβάσεως [9] τὰ μὲν γὰρ κατὰ τὴν Ἑλλάδα πάντα καὶ νῦν ἤδη ποιεῖν αὐτῷ τὸ προσταττόμενον ἔφη καὶ μετὰ ταῦτα ποιήσειν Ἀχαιῶν μὲν ἐθελοντὴν εὐνοούντων Αἰτωλῶν δὲ καταπεπληγμένων ἐκ τῶν συμβεβηκότων αὐτοῖς κατὰ τὸν ἐνεστῶτα πόλεμον [10] τὴν δ᾽ Ἰταλίαν ἔφη καὶ τὴν ἐκεῖ διάβασιν ἀρχὴν εἶναι τῆς ὑπὲρ τῶν ὅλων ἐπιβολῆς ἣν οὐδενὶ καθήκειν μᾶλλον ἢ ᾽κείνῳ τὸν δὲ καιρὸν εἶναι νῦν ἐπταικότων Ῥωμαίων Trad da Mari (2002) laquoCostui allora cogliendo lrsquooccasione gli consigliograve di interrompere al piugrave presto la guerra con gli Etoli e gli chiese di impegnarsi nelle operazioni in Illiria e nellrsquoattraversamento del mare verso lrsquoItalia Disse che infatti giagrave ora tutta la Grecia eseguiva i suoi ordini e lo avrebbe fatto anche in seguito poicheacute gli Achei lo sostenevano di loro iniziativa mentre gli Etoli erano rimasti molto colpiti da quanto era loro avvenuto nella guerra in corso e aggiunse che lrsquoItalia e lrsquoattraversamento del mare in quella direzione erano lrsquoinizio di un disegno di dominio universale che a nessuno spettava piugrave che a lui ora era il momento opportu-no visto che i Romani erano stati battutiraquo18 I giochi Nemei in onore di Zeus erano giochi panellenici celebrati in Argolide negli anni pari delle Olimpiadi 19 Secondo Eckstein (1995) pp 211-212 tale aspirazione egrave connessa allrsquoincapacitagrave di mo-derazione nella vittoria del sovrano Sul concetto di dominio universale in Polibio vd Musti (1978) pp 16-18 Eckstein (2008) pp 217-220 e 372-38120 Adler (2006) pp 383-407 e (2011) pp 37-58 ha notato che i punti principali del discorso di critica allrsquoespansionismo romano di Demetrio ritornano in altri due discorsi dellrsquoEpitome quello degli Etoli (XXVIII 2 1-13) e quello di Mitridate (XXXVIII 4-7) la prioritagrave data a questi argomenti da tale reiterazione retorica indica che lrsquointeresse giagrave di Trogo se non dellae suae fontei non fosse la celebrazione dellrsquoascesa di Roma allrsquoim-pero universale come in Appiano ma piuttosto lrsquoascesa e la discesa dei regni ellenistici
IL DISCORSO DEL RE 127
Filippo V 21 Il testo giustineo omette le circostanze dellrsquoevento non si menzionano infatti esplicitamente neacute il luogo dellrsquoincontro Naupatto neacute le fasi delle trattative neacute i vari rappresentanti dei diversi fronti che vi presero parte I lunghi negoziati di pace si risolvono dunque nel discor-so di Filippo V ai rappresentanti dei fronti
Il sovrano esordisce affermando che la Grecia egrave in grande pericolo percheacute chiunque avesse vinto tra Cartaginesi e Romani sarebbe poi pas-sato in Oriente Filippo utilizza la metafora delle nubi in Occidente che avrebbero macchiato con una pioggia di sangue ogni cosa spinte dai venti di vittoria inoltre il sovrano ritiene che le guerre passate dei Gre-ci siano di poco conto se paragonate alla minaccia di uno scontro con la moltitudine che si radunava in Italia descrivendo la rabbia e il valore di questi nuovi nemici che avrebbero portato rovina ai vicini Il sovrano infine ribadisce che la Grecia era in maggior pericolo della Macedonia ma che sapeva che chi avesse vinto in Italia non avrebbe frenato la sete di vittoria Perciograve anche la Macedonia stessa doveva temere un attacco
Il discorso in Polibio di Agelao di Naupatto rappresentante e leader degli Etoli22 mostra le medesime argomentazioni attribuite in Giustino allrsquointervento di Filippo argomentazioni fondate sul metus hostilis e fina-lizzate a promuovere un nuovo ruolo della Macedonia sia in Grecia che nel Mediterraneo Orientale Agelao proponendo un nuovo program-ma politico panellenico fonda le proprie argomentazioni sul metus hosti-lis per i Cartaginesi e i Romani presentati metaforicamente come nubi che incombono da Occidente Filippo dovrebbe farsi garante della tran-quillitagrave della Grecia che agendo come unrsquounica catena di cittagrave contro i barbari diverrebbe una sicura e fedele collaboratrice della Macedonia Questo permetterebbe ai Greci di conservare il diritto di far pace o guer-ra a loro piacimento senza temere che laquoi giochi da bambini con i quali ci trastulliamo tutti vengano troncati23raquo
Nonostante sia il medesimo discorso nelle due fonti Agelao introdu-ce una forte proposta di alleanza panellenica estranea alle parole di Fi-lippo Inoltre Filippo pur utilizzando la metafora delle nubi da Occi-
21 Interessanti le osservazioni di Scholten (2000) pp 224-228 a proposito della pace che sarebbe stata cercata e sperata da entrambe le parti e non imposta da Filippo come Polibio pare lasciar intendere 22 Vd soprattutto Leacutevy (1994) pp 33-50 Su questo discorso molto dibattuto dai moderni vd anche Schmitt (1989) pp 229-239 Vollmer (1990) pp 96-107 Coppola (1993) pp 149-164 Golan (1995) pp 55-74 Champion (1997) pp 111-128 e (2004) p 55 Wal-bank (2002) pp 127-136 Eckstein (2008) pp 78-83 23 Polyb V 104 10-11 καθόλου τὰς παιδιάς ἃς νῦν παίζομεν πρὸς ἀλλήλους ἐκκοπῆναι συμβῇ πάντων ἡμῶν ἐπὶ τοσοῦτον ὥστε κἂν εὔξασθαι τοῖς θεοῖς ὑπάρχειν ἡμῖν τὴν ἐξουσίαν ταύτην καὶ πολεμεῖν ὅταν βουλώμεθα καὶ διαλύεσθαι πρὸς ἀλλήλους καὶ καθόλου κυρίους εἶναι τῶν ἐν αὑτοῖς ἀμφισβητουμένων
128 MONICA DrsquoAGOSTINI
dente presente anche nelle Storie la arricchisce con la vivida immagine di una tempesta di sangue conferendo una dimensione piugrave concreta e cruenta alla predizione infine il riferimento polibiano alle guerre dei Greci nellrsquoEpitome non riguarda piugrave le guerre tra le cittagrave e le leghe gre-che ma le guerre dei Greci con Macedoni Persiani e Galli Mentre la Grecia scompare sullo sfondo la minaccia Romana egrave meno vaga e piugrave concreta e presente che in Polibio e diventa lrsquounico argomento del di-scorso di Filippo V a Naupatto
Il discorso di Demetrio e quello di Filippo sono al centro del libro XXIX dellrsquoEpitome avendo il duplice scopo di evidenziare sia la poten-ziale aggressivitagrave dei Romani sia la grande tradizione militare della Ma-cedonia e il pieno diritto di Filippo di controllare la Grecia e lrsquoIlliria fi-no allrsquoAdriatico Se il discorso in Polibio si inseriva in un dibattito politi-co dove la Grecia e la Macedonia erano protagoniste alla pari della sce-na ellenica e internazionale nella versione che leggiamo in Trogo i ri-ferimenti alle dispute della realtagrave greca sono reinterpretati a favore di un punto di vista in cui la Macedonia egrave lrsquounico potere dellrsquoOriente gre-co Del dibattito politico di III secolo in Grecia che tanto stava a cuore a Polibio non vi egrave piugrave alcuna traccia in TrogoGiustino rimane soltanto lo scontro tra le due grandi potenze di Oriente e Occidente tra Filippo e Roma Questa prospettiva bipolare dei discorsi trogiani si ritrova nel-la conclusione del capitolo che se da un lato sottolinea ancora una vol-ta il timore di Filippo per Cartaginesi e Romani dallrsquoaltro esplicita che i Romani avevano paura dellrsquoantica gloria dei Macedoni laquovincitori dellrsquoO-rienteraquo e soprattutto di Filippo laquoinfiammato dallo zelo di emulare Ales-sandro che era ben noto come pronto alle guerre e instancabileraquo24
41-11 La Prima Guerra Macedonica
Dei prodromi della Prima Guerra Macedonica Giustino si interessa sol-tanto allrsquoalleanza antiromana tra Annibale e Filippo Questo trattato egrave noto da molte fonti secondo cui Filippo dopo aver appreso che i Roma-ni erano stati sconfitti di nuovo dai Cartaginesi a Canne nel 216 avreb-be mandato unrsquoambasceria ad Annibale per proporre unrsquoalleanza ma lrsquoambasciatore macedone sarebbe stato catturato da Roma sulla via del ritorno25
24 Iust XXIX 3 8 quippe terrebat eos et uetus Macedonum deuicti Orientis gloria et Philippus studio Alexandri aemulationis incensus quem promptum in bella industriumque cognouerant Alla gloria dei Macedoni avevamo giagrave trovato riferimento nei discorsi del libro XXVIII degli Etoli (2 12) e di Antigono Dosone (3 14) 25 Secondo Polyb VII 9 17 Filippo avrebbe aiutato Cartagine nella guerra con Roma in cambio di Corcira Epidamno e Apollonia e della restituzione a Demetrio di Faro del suo regno Inoltre Filippo e Annibale si impegnavano a soccorrersi a vicenda in caso di
IL DISCORSO DEL RE 129
A prescindere dai dettagli del fermo dellrsquoambasciatore macedone da parte romana egrave possibile fare qualche osservazione sul nesso tra questo lsquoincidentersquo diplomatico e lo scoppio della guerra Cassio Dione e Ap-piano riportano che la cattura del legato avrebbe causato una vendetta di Filippo contro i protettorati romani in Adriatico in particolare Cor-cira26 notizia assente in Polibio come in Livio e Plutarco (che da Poli-bio dipendono)27 In questi ultimi autori lrsquoattacco di Filippo in Adriati-co infatti non sarebbe legato allrsquoepisodio dellrsquoambasciatore ma alla de-cisione del sovrano di rompere con il consigliere Arato e di dare ascol-to ai cattivi consigli di Demetrio di Faro presa dopo la spedizione a Mes-sene nel 215214 La tradizione polibiana legge infatti in questi eventi la manifestazione del cambiamento dellrsquoindole di Filippo V da giusta a empia iniziata con lrsquoepisodio della stasis di Messene del 215 e compiu-ta con lrsquoassassinio di Arato del 21328 Nel libro XXIX di Giustino ben-cheacute si conservi traccia dellrsquoindole aggressiva di Filippo e del consiglio di Demetrio di Faro come prodromi dello scontro con Roma non vi sono indizi della metaboleacute del sovrano da giusto a empio e malvagio e neppu-re del ruolo che in tale cambiamento ricoprigrave lrsquoallontanamento tra Ara-to e Filippo
attacco da parte di Roma Mentre Peacutedech (1964) pp 382-383 ritiene sicura la consulta-zione a Roma di tali documenti Zecchini (2003) pp 123-141 come prima di lui Walbank (1957) I p 32 n 4 non ne egrave certo poicheacute Polibio viaggiograve proprio per poter reperire documenti e informazioni sugli eventi dove essi avvennero Altre fonti Liv XXIII 38 7 Plut Arat 51 2 Dio C XV 4 2 e App Mak Fr 1 Sul confronto delle fonti vd DrsquoAgostini (2011) pp 99-121 Sul trattato macedone-cartaginese vd Cassola (1962) pp 65-66 Wal-bank (1967) II pp 42-44 Will (19822) pp 83-84 Barreacute (1983) Longaretti (1989) pp 183-192 Golan (1995) pp 45-46 Eckstein (2008) pp 83-85 Intrieri (2011) pp 53-8226 Dio C XV 4 2 e App Mak Fr1 Filippo per vendicarsi della cattura del proprio amba-sciatore non solo attaccograve Corcira ma saputo dellrsquoarrivo di Levino durante la ritirata da Corcira saccheggiograve anche Apollonia e Orico alleate romane Levino avrebbe poi sconfit-to Filippo e recuperati gli alleati costringendo il re a bruciare le proprie navi e rientrare via terra Si riferisce a questo episodio probabilmente il Mak Fr 9 di Appiano che riporta lrsquoordine di Filippo di uccidere quanti erano sulle navi percheacute non dicessero ai Romani che le forze macedoni erano stremate DrsquoAgostini (2011) pp 99-12127 Polyb V 108-110 Liv XXIV 40 e Plut Arat 51 2 non menzionano Corcira nella narra-zione dellrsquoalleanza macedone-cartaginese e della cattura dellrsquoambasciatore Secondo Liv XXIII 38 7 lrsquoambasciatore sarebbe stato trattenuto a Roma 28 Polyb VII 11 8-11 e Plut Arat 49 1 Coppola (1993) pp 205-210 Dai frammenti di Polyb VII 10-12 e dalla narrazione di Plut Arat 49-51 sappiamo che Filippo era interve-nuto nella stasis di Messene tra oligarchici e democratici ma aveva di nascosto lasciato che i cittadini si massacrassero Una volta giunto Arato la guerra civile fu finalmente sedata ma il sovrano avrebbe voluto su consiglio di Demetrio di Faro approfittare della situazione e imporre una guarnigione nellrsquoacropoli della cittagrave che gli avrebbe conferito un vantaggio strategico per il controllo del Peloponneso Arato dissuase Filippo da per-seguire unrsquoazione militare in Peloponneso ma il re decise su consiglio di Demetrio di rivolgere la sua aggressivitagrave verso lrsquoIlliria prima e i protettorati romani Orico e Apollonia poi
130 MONICA DrsquoAGOSTINI
Dopo aver accennato alla stipula del trattato Giustino affastella ne-gli ultimi paragrafi del capitolo 4 gli eventi tra il 215 e il 205 quando Fi-lippo siglando la pace con Roma pone fine alla Prima Guerra Macedo-nica29 In particolare lrsquoEpitomatore sottolinea da un lato lrsquoingresso in guerra degli Etoli al fianco dei Romani e la successiva alleanza del preto-re Levino con Attalo dallrsquoaltro gli attacchi subiti da parte dei Dardani da Filippo oppresso dalle richieste degli Illiri Il libro dunque si chiude con Filippo in difficoltagrave aggravate dalla comparsa di Filopemene il leader degli Achei30 urtatosi con il re dei Macedoni convince la Lega Achea a staccarsi dallrsquoalleanza con la Macedonia sempre piugrave isolata Tale allon-tanamento egrave considerato da Giustino lrsquoesito di un fallito agguato a Fi-lopemene commissionato da Filippo V e dovuto al sospetto di un tradi-mento del condottiero acheo a favore di Roma Bencheacute anche Plutarco (Fil 12 2) e Pausania (VIII 50 4) menzionino il tentativo di assassinio di Filopemene da parte di Filippo la notizia dellrsquoatteggiamento filoroma-no del generale acheo non parrebbe vicino al ritratto polibiano che ve-de in Filopemene un eroe dellrsquoautonomia e dellrsquoindipendenza achea31
Libro XXX11-39 Cinoscefale
Lrsquoesordio del libro XXX introducendo il grande scontro di Cinoscefale tra Romani e Macedoni riprende la celebrazione della gloria macedo-ne argomento centrale dei discorsi del libro XXIX Con lrsquoeccezione dei primi capitoli sul deplorevole comportamento di Tolemeo IV in Egit-to32 il libro egrave infatti totalmente dedicato allo scontro tra le due potenze
29 Errington (2008) pp 185-190 La guerra egrave nota a noi soprattutto dai frammenti dei libri VIII-XI di Polibio dai passi di Liv XXIV 40 1-17 XXVI 24 1-26 4 XXVII 30 5-33 5 e XXVIII 5 1- 9 1 XXIX 12 1-15 e dalla Vita di Filopemene di Plutarco La sinteticitagrave del riassunto giustineo impedisce un puntuale paragone delle tradizioni Ad esempio la notizia dellrsquoalleanza tra Attalo e Roma sembra tornare in Liv XXVIII 5 1-4 dove perograve non troviamo Levino ma Sulpicio come rappresentante romano personaggio scompar-so in Giustino In maniera simile la pace di Fenice del 205 egrave sintetizzata in Giustino in una riga e non vi egrave traccia delle lunghe trattative che coinvolsero come mediatori anche Egitto Chio Mitilene e Atamania portarono a una prima pace separata tra Filippo e gli Etoli nel 206 e poi alla pace con Roma Le fonti parallele sono molto piugrave dettagliate anche su questi eventi Polyb XI 4 1-6 9 Liv XXVIII 5 13 e XXIX 12 8-16 e App Mak fr III Degno di nota egrave perograve il commento in Giustino secondo cui laquoi Romani erano per il momento soddisfatti di aver rinviato la guerra contro la Macedoniaraquo Lrsquointenzione ro-mana di riprendere la guerra con la Macedonia egrave infatti presente in tutte le fonti Polyb XI 6 7 Liv XXIX 1216 Dio C XVIII 9 (15) e App Mak Fr III e verragrave ripresa al libro XXX dellrsquoEpitome 30 Su Filopemene e Filippo vd Errington (1969) pp 51-69 e 83-84 vd anche Golan (1995) pp 115-132 Eckstein (2008) pp 103 e 360-36131 Pelling (1997) pp 135-13932 Lrsquoesordio del libro XXX egrave dedicato alle scabrose imprese del sovrano egiziano ovvero
IL DISCORSO DEL RE 131
dellrsquoEst e dellrsquoOvest La prima avvisaglia dellrsquoincombente guerra egrave la no-tizia dellrsquoaccordo di Filippo V e Antioco III per la spartizione dellrsquoEgitto governato dal sovrano-bambino Tolemeo V Il sovrano lagide nel 2032 chiese aiuto ai Romani che secondo TrogoGiustino gradirono la ri-chiesta drsquoaiuto percheacute cercavano pretesti per muovere guerra contro Fi-lippo A partire da Polibio numerose altre fonti ci testimoniano questo episodio mettendolo in relazione con lo scoppio della Seconda Guerra Macedonica ed esprimendo una condanna morale per lrsquoempia condotta del re antigonide che cospira contro un bambino33 al contrario nellrsquoE-pitome si esalta la potenza macedone evidenziando la paura dei Romani delle grandi imprese di Filippo (XXX 3 2)
nullius magis arma metuebant reputantibus quantum motum Pyrrhus parua Macedo-num manu in Italia fecisset quantasque res Macedones in Oriente gessissent
di nessun altro temevano maggiormente le armi poicheacute ripensavano a quanto sconvolgimento Pirro aveva provocato in Italia con una piccola schiera di Ma-cedoni e a quanto grandi imprese i Macedoni avevano compiuto in Oriente
La supremazia macedone egrave anche al centro del discorso in oratio obliqua di Filippo allrsquoincontro nel Golfo Maliaco tra i rappresentanti dei fronti coinvolti nella Seconda Guerra Macedonica34 NellrsquoEpitome infatti dopo
la Quarta Guerra Siriaca conclusa con sconfitta a Rafia contro Antioco III nel 217 e la corruzione del sovrano da parte di Agatocle e della sorella una cortigiana che avrebbe sedotto il re Giustino riferisce poi la morte del sovrano nel 204 e lrsquoascesa al trono del piccolo Tolemeo V Epifane sovrano sotto tutela di Tlepolemo dopo la morte di Agatocle e Sosibio 33 Eckstein (2008) pp 121-180 Thornton (2014) pp 65-88 In particolare sulla relazione tra il complotto e la sconfitta antigonide e seleucidica ad opera di Roma la superioritagrave morale romana ai regni ellenistici e la causalitagrave storica in Polibio (XV 20 6) vd Eck-stein (2008) pp 133-138 Ager (2009) pp 15-43 Landucci Gattinoni (2011) pp 89-105 Secondo Polyb III 2 8 XV 20 XVI 1 8-9 seguito da Liv XXXI 14 5 Filippo avrebbe ottenuto le basi tolemaiche in Egeo Samo e la Caria mentre Antioco avrebbe finalmente avuto mano libera in Celesiria e Fenicia oggetto di quasi un secolo di lotte tra Tolemei e Seleucidi La notizia del trattato permette a Polibio di dedicare alcuni paragrafi (XV 20) a condannare aspramente lrsquooperato di Filippo V e Antioco III definendoli empi e senza pudore e dichiarando che la Fortuna punigrave i due sovrani per il loro crudele operato por-tando i Romani contro di loro vd infra App Mak Fr IV trasmette delle clausole secondo cui Antioco avrebbe avuto lrsquoEgitto e Cipro mentre Filippo avrebbe ottenuto Cirene le Cicladi e la Ionia Infine secondo Porfirio FGrHist 260 F 45 lrsquoaccordo prevedeva che i due sovrani annettessero i possedimenti tolemaici confinanti con i rispettivi regni 34 Prima si menziona unrsquoambasceria del Senato a Filippo e Antioco percheacute laquosi astenessero dallrsquoEgittoraquo e la visita di Lepido in Egitto Quindi le lamentele a Roma di Attalo e i Rodii nei confronti di Filippo Egrave probabile che a questo punto Trogo inserisse la campagna di Filippo in Asia contro Attalo menzionata nel Prologo XXX ma tagliata nellrsquoEpitome La cronologia degli scambi diplomatici precedenti la Seconda Guerra Macedonica egrave stra-volta dalla sintesi dellrsquoEpitomatore e rende impossibile qualsiasi confronto con le altre
132 MONICA DrsquoAGOSTINI
il riassunto delle ambascerie nel Mediterraneo preludio allo scontro della prima fase della guerra35 maggior spazio egrave dato al tentativo di pa-ce a Nicea tra Roma Attalo i Rodii gli Achei e gli Etoli e Filippo V nel 198 In questa occasione Filippo rivendica la posizione di dominio dei Macedoni sui Greci ereditata da Filippo II e Alessandro suoi antenati e in virtugrave di tale supremazia macedone rifiuta che i Greci gli dettino le condizioni di pace ma chiede che sia il Senato a decidere Egrave significati-vo che non solo il discorso di Filippo non compaia in nessuna delle fon-ti parallele che descrivono nel particolare le posizioni degli ambasciato-ri di Achei Etoli Rodii e Attalo ma che Polibio (XVIII 8 8)36 affermi che era difficile sapere cosa si fossero detti Filippo e Flaminino durante i colloqui nel Golfo Maliaco Secondo la tradizione polibiana infatti il sovrano accompagnato da due philoi macedoni Apollodoro e Demoste-ne chiese di allontanare dalle trattative tutti tranne i Romani e discus-se la pace solamente con Flaminino Successivamente a causa dellrsquoinca-pacitagrave di trovare un accordo Filippo chiese due mesi di tregua e lrsquointer-vento del Senato Trogo dunque restituisce il discorso che il resto della tradizione riteneva impossibile da conoscere indicando chiaramente la presenza di una fonte diversa rispetto a Polibio su questo avvenimento piugrave informata sul punto di vista di Filippo e interessata a evidenziare la convinzione di Filippo V di avere un diritto di supremazia sulla Grecia in virtugrave delle imprese di Filippo II e Alessandro
La battaglia di Cinoscefale nel 197 momento risolutivo dello scontro tra Roma e Macedonia egrave lrsquoevento principale del libro XXX omina e pre-sagi introducono lrsquoevento campale lrsquoeruzione del vulcano di Santorini
fonti In Polyb XVI 24 3 App Mak Fr IV Liv XXXI 1 10 21 5 5 Paus I 36 5-6 vi sono differenti versioni della sequenza delle ambascerie che denunciarono a Roma lrsquoe-spansionismo macedone ma tutte concordano che le ambascerie precedettero lrsquoinvio dei legati romani in Oriente e che esse furono inviate anche da Atene e dagli Etoli Inoltre secondo la tradizione polibiana (Polyb XVI 27 1-4 34 1-7 Liv XXXI 2 3 6 3-8 4 18 1-9 Diod XXVIII 6) vi furono due diverse ambascerie di cui la seconda sarebbe stato un ultimatum al sovrano recapitato da Lepido In occasione di questa seconda ambasceria avvenuta durante il cruento assedio di Abido Filippo avrebbe detto che i Macedoni in ca-so di guerra si sarebbero difesi con valore In Giustino si puograve notare che ancora una volta dagli eventi sono omesse notizie fondamentali sui Greci nello specifico lrsquoambasceria di Atene la cui disputa con gli Acarnani fu il casus belli della guerra contro Filippo 35 Come i prodromi anche la prima parte della Seconda Guerra Macedonica egrave sintetizza-ta in Giustino e occupa solamente due paragrafi Come spesso accade nei passi sintetiz-zati dallrsquoEpitomatore si trovano le incongruenze maggiori con le fonti parallele tra cui si nota soprattutto la completa omissione di Giustino delle campagne di Publio Sulpicio Galba Massimo di Villio delle vittorie di Tito e Lucio Flaminino e dellrsquoassemblea del 198 che portograve gli Achei ad allearsi con Roma Polyb XXII e Liv XXXI 14 1- 46 16 XXXII 1 1-25 12 App Mak Fr VII Plut Fil 17 4 Flam 5 4 e Paus VII 8 1-236 Le trattattive sono descritte con particolari in Polyb XVIII 1-12 seguito da Liv XXXII 32 6-36 10 e Plut Flam 5 8 e 7 1-3
IL DISCORSO DEL RE 133
nel 197 e lrsquoemergere dellrsquoisola di Hiera e in contemporanea il terremo-to a Rodi Quindi nellrsquoEpitome si annuncia che laquoil nascente impero dei Romani avrebbe divorato quello antico dei Greci e dei Macedoni37raquo Nel passo ricevono spazio soprattutto i due discorsi contrapposti del re ma-cedone Filippo e del comandante romano Flaminino pronunciati pri-ma dello scontro campale e costruiti ciascuno in modo da celebrare le imprese delle due potenze38 Lrsquoenfasi data dalla contrapposizione reto-rica delle parole dei generali egrave tale da rendere suggestiva lrsquoipotesi che lo scontro dovesse essere il momento centrale non solo del libro XXX ma forse di tutta lrsquoopera trogiana
Filippo elenca le grandi vittorie del passato dei Macedoni contro Per-siani Battriani Indiani e le popolazioni drsquoAsia fino allrsquoestremo Orien-te esortando i suoi a combattere con valore percheacute laquola libertagrave egrave piugrave cara del predominio39raquo Il discorso di Flaminino egrave invece piugrave lungo articola-to in un paragone tra Macedoni e Romani alle passate imprese di con-quista macedoni vengono contrapposte le piugrave recenti vittorie romane a Cartagine in Sicilia Italia e Spagna alla grandezza di Alessandro Ma-gno egrave contrapposta quella di Annibale che pure dai Romani era stato sconfitto Lrsquoattenzione poi si concentra su Filippo i Macedoni non laquodo-vevano essere valutati per lrsquoantica forza ma per le forze attuali40raquo poicheacute Filippo non era lrsquoinvitto e invincibile Alessandro Magno ma un ragaz-zo che non riusciva a difendere i propri confini I Macedoni rivendica-vano il valore degli antenati mentre i Romani quello dei propri soldati poicheacute quelli che erano ligrave schierati erano gli stessi che avevano sconfitto Annibale Dopo una cosigrave grandiosa introduzione la battaglia egrave descritta in uno dei paragrafi piugrave significativi di tutta lrsquoopera
His adhortationibus utrimque concitati milites proelio concurrunt alteri Orientis alteri Occidentis imperio gloriantes ferentesque in bellum alii maiorum suorum antiquam et ob-soletam gloriam alii uirentem recentibus experimentis uirtutis florem [16] Sed Macedo-nas Romana Fortuna uicit
I soldati incitati da queste esortazioni dallrsquouna e dallrsquoaltra parte si lanciaro-no nel combattimento vantandosi gli uni del dominio dellrsquoOriente gli altri dellrsquoOccidente e recando in guerra gli uni lrsquoantica e sbiadita gloria dei loro an-
37 Iust XXX 4 4 Quo prodigio territis omnibus uates cecinere oriens Romanorum imperium uetus Graecorum ac Macedonum uoraturum38 Sui discorsi precedenti la battaglia nellrsquoantichitagrave se da considerare reali o costruzioni storiografiche vd Adler (2011) pp 6-839 Iust XXX 4 7 tantoque hoc bellum fortius quam illa sustinendum quanto sit imperio libertas carior40 Iust XXX 4 10 Sed nec Macedonas ueteri fama sed praesentibus uiribus aestimandos
134 MONICA DrsquoAGOSTINI
tenati gli altri il fiore del loro valore fresco e vigoroso per le recenti prove Ma la Fortuna dei Romani vinse i Macedoni
Questo punto di vista probabilmente giagrave trogiano contrappone la virtugrave romana (virtutis flos) celebrata nei discorsi antecedenti la battaglia al-la Fortuna romana (Romana Fortuna) che decise la vittoria interpretabi-le come destino favorevole o buona stella Piugrave che unrsquoaffermazione anti-romana41 come egrave spesso stata intesa si puograve evidenziare il carattere sim-patetico della fonte verso Filippo V destinato a porre fine alla gloria di Filippo II e Alessandro e forse un approccio nostalgico verso i grandi regni macedoni la cui egravera egrave ormai giunta alla fine Tale prospettiva egrave as-sente in Polibio e nella tradizione che da lui dipende poco interessata alle vicende della gloria macedone leggendo infatti i frammenti soprav-vissuti del libro XVIII delle Storie dopo lrsquoaccurata descrizione della bat-taglia (18-33 e 34-40)42 Polibio commenta lo scontro affermando che avrebbe dedicato alcuni capitoli allrsquoesame delle strategie militari delle due armate percheacute (XVIII 28 4-6)
χρήσιμον καὶ καλὸν ἂν εἴη τὸ τὴν διαφορὰν ἐρευνῆσαι καὶ παρὰ τί συμβαίνει Ῥωμαίους ἐπικρατεῖν καὶ τὸ πρωτεῖον ἐκφέρεσθαι τῶν κατὰ πόλεμον ἀγώνων [5] ἵνα μὴ τύχην λέγοντες μόνον μακαρίζωμεν τοὺς κρατοῦντας ἀλόγως καθάπερ οἱ μάταιοι τῶν ἀνθρώπων ἀλλ᾽ εἰδότες τὰς ἀληθεῖς αἰτίας ἐπαινῶμεν καὶ θαυμάζωμεν κατὰ λόγον τοὺς ἡγουμένους
Puograve essere cosa buona e utile esaminare le differenze e per quale motivo i Ro-mani prevalgono e riportano il primo premio nelle competizioni di guerra af-fincheacute non esaltiamo i vincitori senza una ragione parlando solo di fortuna co-me fanno gli sciocchi ma conoscendo le vere cause lodiamo e ammiriamo i co-mandanti seguendo una logica
Polibio dunque sembra rispondere a coloro che parlavano della buo-na stella dei Romani sottolineando che la vittoria nasceva dalla superio-re strategia militare della legione43 Un punto di vista quindi opposto a quello espresso nellrsquoEpitome che proprio di Romana Fortuna parla e riba-dito in chiusura al passo dove Polibio critica nuovamente quei Greci che ritenevano la vittoria romana incredibile (XVIII 32 13)
41 Urban (1982) pp 1424-1443 1435 Richter (1987) p 19 n 4 Alonso-Nuacutentildeez (1992) p 66 e Id (2002) pp 105-110 partic 108-109 Contra Heckel (1997) p 29 che ridimen-siona la categorizzazione di Trogo come storico anti-romano 42 Su Cinoscefale vd Walbank (1957) ad l Hammond (1988) pp 60-82 Sklenaacuter (2004) pp 302-310 Thornton (2014) pp 83-87 43 Sulla Fortuna in Polibio vd McGing (2010) pp 195-201 (con bibliografia) che distin-gue tra quando Polibio intenda caso e quando predeterminazione fato Vd anche Green (1990) pp 400-402 e Eckstein (2008) pp 132-138
IL DISCORSO DEL RE 135
Il punto di vista di Trogo sembra invece presente nei frammenti del-la Makedonikeacute di Appiano su Filippo V44 dove ci si riferisce a Cinoscefale come a una vittoria insperata (Mak 9 1)
ἡγούμενος δ᾽ οὔτε Ῥωμαίοις συμφέρειν οὔτε τοῖς Ἕλλησι Φιλίππου καθαιρεθέντος ἐπιπολάσαι τὴν Αἰτωλῶν βίαν τάχα δ᾽ αὐτὸν καὶ τὸ παράδοξον τῆς νίκης ἀγαπᾶν ἐποίει
Flaminino era consapevole che non sarebbe stato vantaggioso per i Romani o per i Greci che Filippo fosse deposto e che il potere etolico rimanesse incon-trastato forse lo aveva reso moderato nei suoi progetti lrsquoaver ottenuto una vit-toria insperata
Addirittura successivamente si accenna alla sorte avversa a Filippo nel-lo scontro
τὰ μὲν δὴ παρὰ τῶν ἄλλων φιλάνθρωπα ἦν τό τε τῆς τύχης ἄδηλον ἐξ ὧν ἔπαθεν ὁ Φίλιππος ὑφορωμένων καὶ τὸ πταῖσμα τοῦτο οὐ κατ᾽ ἀσθένειαν ἀλλὰ πλέον ἐκ συντυχίας αὐτὸν παθεῖν ἡγουμένων
Gli altri (Greci) erano inclini ad essere moderati vedendo con sospetto lrsquoincer-tezza della fortuna subita da Filippo e ritenendo che egli fosse incorso in questa sconfitta non tanto per la sua inferioritagrave quanto per la sfortuna
Il riferimento in Appiano e Trogo alla fortuna romanasfortuna ma-cedone a proposito di Cinoscefale egrave una traccia dellrsquoopinione politi-ca di quei Greci disprezzati da Polibio come uomini sciocchi καθάπερ οἱ μάταιοι τῶν ἀνθρώπων Tale posizione politica su Cinoscefale sarebbe dunque sopravvissuta nella tradizione storiografica di cui troviamo trac-cia in TrogoGiustino e Appiano
Per comprendere meglio alcune caratteristiche di questa tradizione puograve essere utile tornare ai due discorsi nellrsquoEpitome di Filippo e Flamini-no prima della battaglia Tali passi probabilmente trogiani45 non trova-no infatti riscontro nelle fonti parallele a noi pervenute Polibio (XVIII 18-27) seguito fedelmente da Livio (XXXIII 5-10) pur descrivendo le operazioni di guerra di Cinoscefale con dovizia di particolari non men-ziona un discorso di Filippo ai suoi armati prima della battaglia mentre il discorso di Flaminino per incoraggiare le truppe schierate (XVIII 23 2-6) nelle Storie egrave incentrato sulle vittorie di Sulpicio nella prima parte della guerra Pare dunque originale la versione trogiana che incentra-
44 Tra i frammenti consegnatici dagli Excerpta Constantiniana sono frequenti informazio-ni e osservazioni che rimandano a una prospettiva ellenistica sugli eventi DrsquoAgostini (2011) pp 99-121 45 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362
136 MONICA DrsquoAGOSTINI
ta sulla gloria macedone presenta Cinoscefale come il punto drsquoincon-tro e di scambio tra lrsquoegemonia macedone e lrsquoegemonia romana Non egrave una novitagrave che il leitmotiv delle Storie Filippiche e dunque dellrsquoEpitome sia la translatio imperii giagrave Alonso Nuntildeez definito da Santi Amantini laquouno dei piugrave noti esperti di questioni trogiano-giustineeraquo46 osservava che Tro-go esponeva nel suo perduto lavoro la teoria della successione degli im-peri mondiali secondo lo schema Assiria-Media-Persia-Macedonia-Roma osteggiata dai Parti47 In tale successione il ruolo da protagonista egrave rico-perto dallrsquoegemonia macedone48 che occupa allrsquoincirca 26 dei 44 libri e il cui ultimo vero momento di gloria egrave lo scontro con Roma appunto a Cinoscefale Lrsquoultima impresa macedone ha come esito la transizione del dominio universale da Oriente a Occidente e costituisce il tema cen-trale dellrsquointera vicenda di Filippo lrsquoimportanza della battaglia di Cino-scefale egrave perciograve esaltata nei discorsi sia di Filippo che di Flaminino che a loro volta sono il punto di arrivo delle argomentazioni esposte nelle parole di Demetrio di Faro e di Filippo stesso giagrave nel libro XXIX Le ora-tiones disposte retoricamente nei due libri descrivono due parabole op-poste da un lato quella romana che da lontana potenza desiderosa di espandersi cresce come una pioggia di sangue diventando il giovane e vigoroso potere che sottomesso Annibale egrave pronto a sconfiggere Filip-po Dallrsquoaltro quella macedone che originata con Filippo II personag-gio centrale per Trogo raggiunge il suo apice con la conquista dellrsquoege-monia ad opera di Alessandro Magno contro i Persiani per conoscere la fine con Filippo V il cui antico valore egrave ormai troppo lsquosbiaditorsquo per te-ner testa al vigore romano
La gloria macedone secondo Trogo inizia dunque con Filippo II e si conclude con Filippo V Perseo egrave infatti il malvagio responsabile dellrsquoan-nientamento di ciograve che rimaneva della monarchia macedone49 Trogo pone agli estremi della parabola macedone che occupa dal libro IX al XXX i due re di nome Filippo Filippo II e Filippo V come ribadito in piugrave luoghi dellrsquoEpitome sia in parti riassunte da Giustino che in passi piugrave genuinamente trogiani Dando per scontato che il titolo dellrsquoopera Sto-rie Filippiche si debba al desiderio di Trogo di rifarsi allrsquoopera di Teopom-po sul sovrano macedone egrave possibile che tale titolo sia stato perograve ripen-
46 Santi Amantini (2003) pp 99-11047 laquoPompeius Trogus expounded in his lost work the Historiae Philippicae a theory of the world empire suggestion according to the scheme Assyria-Media-Persia-Macedonia-Rome opposed by the Parthiansraquo Alonso-Nuacutentildeez (2002) pp 105-110 e 133-136 partic 105 Vd anche Richter (1987) pp 19-23 Momigliano (1980) pp 157-162 Alonso-Nuacutentildeez (1992) Heckel (1997) pp 1-41 Gabba (2003) pp 7-9 Santi Amantini (2003) pp 99-110 Mariotta (2014) pp 45-56 48 Franco (1993) pp 71-97 e Landucci (2014) pp 233-26149 Alonso-Nuacutentildeez (2002) pp 105-110 partic 108-109
IL DISCORSO DEL RE 137
sato da Trogo considerando che il periodo compreso tra le imprese dei due Filippo occupa 23 dellrsquoopera50 Si potrebbe allora suggerire che le Storie sono Filippiche poicheacute i due Filippo segnarono lrsquoinizio e la fine di quella che egrave nellrsquoopera di Trogo lrsquoegemonia incontrastata del mondo piugrave gloriosa di tutti i tempi51
La prospettiva ellenistica che vede nei due Filippo i limiti della grande egemonia macedone egrave di nuovo presente anche in Appiano nellrsquooraco-lo riportato nei frammenti della sua Makedonikeacute e noto anche da Pausa-nia (VII 8 9)
αὐχοῦντες βασιλεῦσι Μακηδόνες Ἀργεάδῃσιν ὑμῖν κοιρανέων ἀγαθὸν καὶ πῆμα Φίλιππος ἤτοι ὁ μὲν πρότερος πόλεσιν λαοῖσί τ᾽ ἄνακτας θήσει ὁ δ᾽ ὁπλότερος τιμὴν ἀπὸ πᾶσαν ὀλέσσει δμηθεὶς δ᾽ ἑσπερίοισιν ὑπ᾽ ἀνδράσιν ἐνθάδ᾽ ὀλεῖται
O Macedoni che andate orgogliosi dei re di stirpe argiva I re di nome Filippo saranno arbitri del bene e del male per voi Il primo vi renderagrave signori di cittagrave e popoli il secondo vi priveragrave di ogni onore sconfitto da uomini dellrsquoOcciden-te qui giace morto52
Senza voler entrare nel merito della discussione di tale oracolo di nuo-vo pare di incontrare nei due autori la medesima prospettiva lontana dalla condanna morale del re macedone espressa da Polibio secondo cui la sconfitta egrave il giusto esito della sua crudeltagrave ed empietagrave
Il libro giustineo si conclude menzionando le condizioni della pa-ce di Tempe53 e lrsquoira degli Etoli che videro ignorate le proprie richieste da Flaminino e perciograve cercarono lrsquoalleanza di Antioco contro Roma Se-condo il Prologo XXX il libro perograve proseguiva con le campagne di Antio-co III in Asia Minore contro Molone e Acheo e in Battriana fino ad ar-rivare allrsquoesordio dello scontro con Roma54 Il riassunto giustineo egrave trop-po sommario per permettere un confronto con le fonti parallele Egrave pe-
50 Sul rilievo della storia della Macedonia nellrsquoopera di Trogo e Giustino vd von Gutsch-midt (1894) pp 17-217 Richter (1987) p 28 n 29 Franco (1993) pp 71-97 51 Vd anche Urban (1982) pp 1424-1443 e Alonso-Nuacutentildeez (1992) p 58 52 Mak Fr 2 Vd DrsquoAgostini (2011) pp 99-121 In questa Walbank (2002) pp 127-136 propone di interpretare anche un poema di Alceo di Messene (Anth Pal 9518)53 Egrave probabile che Trogo fornisse piugrave particolari riguardo a questa pace per esempio si puograve ritenere che vi fosse menzione dellrsquoinvio a Roma del figlio Demetrio da parte di Filippo come ostaggio dato che a Iust XXXII 2 3 si richiama appunto tale avvenimento54 Polyb XVIII 34 1-39 7 42 1-45 12 Liv XXXIII 11 3-13 15 24 1-31 11 Plut Flam IX 1-8 App Mak Fr IX riferiscono di due diverse trattative di pace caratterizzate da un vivace dibattito tra chi voleva lrsquoannientamento della Macedonia come in Grecia gli Etoli e a Roma Marco Claudio Marcello e coloro che desideravano la pace con la Macedonia in primis Flaminino
138 MONICA DrsquoAGOSTINI
rograve da notare la mancanza sia nel Prologo che nel testo del libro degli av-venimenti delle celebrazioni Istmie del 196 quando Flaminino procla-mograve la libertagrave dei Greci Piugrave in generale in tutta la narrazione di Giustino delle complesse trattative del 197-196 manca qualsiasi riferimento alla li-bertagrave dei Greci punto nodale nella tradizione di Polibio che con questa sottolineatura esalta sia il ruolo tirannico della Macedonia sia la grande generositagrave dei Romani nei confronti della Grecia Il silenzio di TrogoGiustino su tale questione mostra il prevedibile disinteresse per gli affari dei Greci e nel contempo conferma la presenza di una tradizione che si occupa soprattutto della storia delle monarchie ellenistiche allrsquointer-no della quale la posizione dellrsquoEllade egrave subalterna
Libro XXXII23- 34 Demetrio e Perseo
Gli ultimi anni di regno di Filippo tra il 183 e il 179 sono narrati in un passo breve del libro XXXII Il racconto in Giustino che egrave coerente con il Prologo trogiano segue in maniera sintetica la tradizione polibiana su questi eventi giunta a noi in alcuni passi lacunosi di Polibio (XXIII 1 3-3 10 7 1-7 10 1-11 8) integrati dal racconto particolareggiato di Li-vio (XXXIX 46 7- 48 6 53 1-16 XL 3 3-16 3 201-24 8) e dalla narra-zione di Diodoro (XIX 25) e Plutarco (Aem VIII 11)55
Conclusioni
In questi libri dedicati a Filippo egrave forse possibile vedere in filigrana la rielaborazione voluta di Giustino dei corrispondenti libri trogiani Co-me Giustino stesso afferma nella Prefatio 3 lrsquoopera di Trogo era costruita secondo due criteri quello cronologico e quello per laquoconcatenazione di eventi56raquo ea omnia Pompeius diuisa temporibus et serie rerum digesta conposuit
55 Lrsquoutilizzo della tradizione polibiana in Trogo egrave confermato dallrsquoaderenza a Livio (XL 54 1-56 11) e Diodoro (XXIX 28) del racconto sul pentimento di Filippo per aver ucciso il figlio Demetrio lrsquointenzione di punire Perseo e la correlazione tra questo e la sua mor-te Questo libro egrave dunque differente nellrsquointeresse e nelle fonti dai libri XXIX e XXX poicheacute molto vicino alla tradizione polibiana in Livio Questi avvenimenti in Giustino sono da collegare con lrsquoascesa al trono di Perseo e non con lrsquoepilogo della celebrazione del valore macedone giagrave conclusasi in Giustino con Cinoscefale e la transizione dallrsquoim-perium macedone allrsquoimperium romano Vd Heckel (1997) p 7 Appiano invece riporta ancora una tradizione diversa da quella polibiana in un frammento della Makedonikeacute in particolare Appiano egrave attento al punto di vista macedone e presenta Filippo come una vittima delle circostanze (Mak IX) DrsquoAgostini (2011) pp 99-12156 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362 Alonso-Nuacutentildeez (2002) pp 133-136 He-ckel (1997) pp 1-41 Borgna (2014) pp 52-77
IL DISCORSO DEL RE 139
Serie rerum digesta sembrerebbe unrsquointerpretazione latina della formula κατὰ γένος che Diodoro usa per indicare la struttura della storia di Efo-ro sottolineandone la divisione per argomento57 In tale struttura per argomento dellrsquoEpitome tra i temi principali ci sono dunque il valore e la gloria dei sovrani ellenistici58 riscontrabile nei libri XXVIII-XXXI sui re-gni di Antigono Dosone Filippo V e Antioco III Tale tema presente di sicuro in Trogo egrave conservato nellrsquoazione dellrsquoEpitomatore e anzi come si vede dagli escerpta esaltato dalla selezione dei passi
Per quanto riguarda invece la Quellenforschung 59 egrave evidente che nel testo vi sia presenza di filoni non tradizionali sugli eventi poicheacute la posi-zione di Trogo appare spesso autonoma rispetto alle opinioni condivise dalla storiografia antica Questo aspetto dellrsquoEpitome evidente soprattut-to per ciograve che riguarda gli eventi ellenistici ha suscitato la grande curio-sitagrave degli studiosi che allontanatisi dalla proposta di von Gutschmid che voleva una totale ed esclusiva dipendenza di Trogo da Timagene ora in-dicano con sicurezza tra le fonti piugrave rilevanti per gli eventi ellenistici di III secolo utilizzate da Trogo almeno altri sei nomi oltre a Timagene Ie-ronimo Timeo Filarco Duride Polibio e Posidonio
Per quanto riguarda nello specifico la composizione dei libri XXIX e XXX non vi egrave alcun dubbio che in essi Trogo abbia utilizzato (anche riadattandola) una fonte poco attenta alle questioni di politica interna greca e al legame tra queste e quel ritratto di Filippo come sovrano mal-vagio ed empio che ritorna nella tradizione ufficiale di origine polibia-na passando poi da Polibio in Livio Diodoro e Plutarco60 Trogo pre-serva invece una tradizione ellenistica interessata alla figura di Filippo come ultimo barlume della gloria macedone tradizione che pare quasi una controparte e un completamento dellrsquoAb urbe condita romanocentri-ca di Livio Non si puograve perciograve a mio avviso escludere che per questa se-zione Trogo abbia usato una tradizione di matrice filoellenistica o sem-plicemente ellenisticocentrica unrsquoopera sui regni di diadochi ed epigo-ni che a tutti noi fa venire facilmente alla mente il Basileis o Perigrave Basileon dello storico grecoellenistico augusteo filobarbaro scettico (o critico) verso lrsquoegemonia romana Timagene di Alessandria (FGrHist 88)61
57 Su Eforo vd Vannicelli (1987) pp 165-191 e ora Parmeggiani (2011) 58 Simile legame vi egrave a mio avviso tra i libri XXVI e XXVII che invece affrontavano la crisi delle monarchie ellenistiche causata dalle guerre fraterne59 Vd von Gutschmid (1894) pp 17-217 Richter (1987) pp 17-30 partic 20-23 San-ti Amantini (1972) pp 56-109 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362 Urban (1982) pp 1424-1443 partic 1435 Mecca (2001) pp 199-222 Santi Amantini (2003) pp 99-110 Heckel (2012) pp 3-860 Scuderi (2005) pp 383-40561 Sordi (1982) pp 775-797 Heckel (1997) pp 30-34 Landucci (2014) pp 233-261 e Ead in questo volume
140 MONICA DrsquoAGOSTINI
ABSTRACT
Philip V of Macedon was the first of the Epigonoi to face Rome Several mod-ern reconstructions of the actions and the reign of Philip V have approached it largely from a Roman point of view using as sources Polybius and where Poly-bius is lost Livy The Polybian historiographical tradition tends to portray Phil-ip V as an enemy and a tyrant impious and cruel The Macedonian king was ea-ger to establish a universal and unjust dominion over Greece Italy and beyond and Rome engaged in the first two Macedonian Wars to fight the threat of his growing ambition Nevertheless Polybiusrsquo portrayal of Philip V was affected not only by Polybiusrsquo admiration for Roman political structures military power and overwhelming conquest but also his personal Achaean origins
Looking at in book 29 and 30 of Justinrsquos Epitome of Pompeius Trogus this pa-per focuses on the non Polybian tradition on Philip V this contribution is in-deed the first analysis of the Hellenistic approach to the clash between Rome and Macedonia in the 3rd-2nd Century BC The Epitome shows a considerable di-versity of interpretation from the other sources and reflects very different views of Philip Vrsquos actions that brought him into conflict against Rome In particular these views are more evident related to the accounts of the peace negotiations of Naupactus and the battle of Cynoscephalae in the Epitome the king appears as a courageous and skilled warrior the last of the great Macedonian rulers who fell victim to misfortune This portrayal which has several common features with Appianrsquos fragments of Philip V (Mak 9) counterbalances the Roman and Achaean standpoint present in Polybius providing a more Hellenistic perspec-tive that is likely to have been rooted in a historiographical tradition connect-ed to the losing side in the struggle between Rome and the Hellenistic world
BIBLIOGRAFIA
Adler E (2006) Whorsquos Antiroman Sallust and Pompeius Trogus on Mithridates CJ 101 pp 383-407
Adler E (2011) Valorizing the Barbarians Enemy speeches in Roman Historiography Austin
Ager SL (2003) An Uneasy Balance from the Death of Seleukos to the Battle of Raph-ia in A Erskine (ed) A Companion to the Hellenistic World Oxford pp 35-50
Ager SL (2009) Roman Perspectives on Greek Diplomacy The conceptual clash Greek diplomacy of compromise and Roman Bellum Iustum in C Eilers (ed) Diplomats and Diplomacy in the Roman World Leiden-Boston pp 15-43
Alonso-Nuacutentildeez JM (1992) La Historia Universal de Pompeyo Trogo Madrid
Alonso-Nuacutentildeez JM (2002) The Idea of Universal History in Greece From Herodotus to the Age of Augustus Amsterdam
Ballesteros Pastor L (2013) Pompeyo Trogo Justino y Mitriacutedates Comentario al Epiacutetome de las Historias Filiacutepicas (3716-3881) Hildesheim-Zuumlrich-New York
IL DISCORSO DEL RE 141
Barreacute ML (1983) The God-List in the Treaty between Hannibal and Philip V of Ma-cedon a Study in Light of the Ancient Near Eastern Treaty Tradition Baltimore-Lon-don
Beck H - Eckstein A (2015) sv ldquoAratos of Sicyon (231)rdquo in I Worthington (ed) Brillrsquos New Jacoby Brill Online
Borgna A (2014) Uno sguardo originale intorno a Roma Pompeo Trogo e Giustino laquoLa Biblioteca di ClassicoContemporaneoraquo 1 pp 52-77
Cassola F (1962) I gruppi politici romani nel III secolo aC Trieste
Champion CB (1997) The Nature of Authoritative Evidence in Polybios and Agelausrsquo Speech at Naupactos TAPhA 127 pp 111-128
Champion CB (2004) Cultural Politics in Polybiusrsquo Histories Berkeley
Coppola A (1993) Demetrio di Faro un protagonista dimenticato Roma
Criscuolo L (2011) I due testamenti di Tolemeo VIII Evergete II in A Joumlrdens - J F Quack (hrsg) Aumlgypten zwischen innerem Zwist und aumluszligerem Druck Die Zeit Ptole-maios VI bis VIII Wiesbaden pp 132-150
DrsquoAgostini M (2011) Filippo V e la Storia Romana di Appiano laquoAevumraquo 85 pp 99-121
Eckstein AM (1995) Moral vision in the Histories of Polybius Berkeley
Eckstein AM (2008) Rome enters in the Greek East From Anarchy to Hierarchy in the Hellenistic Mediterranean 230-217 BC Oxford
Eckstein AM (2013) Polybius Phylarchus and Historiographical Criticism CPh 108 4 pp 314-338
Errington RM (1969) Philopoemen Oxford
Errington RM (2008) A History of the Hellenistic World 323-30 BC Malden MA-Oxford
Forni G - Angeli Bertinelli MG (1982) Pompeo Trogo come fonte di storia ANRW II 30 2 pp 1298-1362
Franco C (1993) Trogo Giustino e i successori di Alessandro in L Braccesi - A Coppola - G Cresci Marrone - C Franco (a cura di) LrsquoAlessandro di Giustino dagli antichi ai moderni Roma pp 71-97
Gabba E (2003) Introduzione in D Foraboschi - SM Pizzetti (a cura di) La successione degli imperi e delle egemonie nelle relazioni internazionali Milano pp 7-9
Golan D (1995) The Res Graeciae in Polybius Four Studies Como
Green P (1990) Alexander to Actium The Historical Evolution of the Hellenistic Age Berkeley-Los Angeles
Gutschmid von A (1894) Die beiden ersten Buumlcher des Pompeius Trogus in A von Gutschmid - F Ruumlhl (hrsg) Kleine Schriften Leipzig pp 17-217
142 MONICA DrsquoAGOSTINI
Habicht C (1995) Athen Muumlnchen
Hammond NGL (1968) Illyris Rome and Macedon in 229-205 BC JRS 58 pp 1-21
Hammond NGL (1988) The Campaign and the Battle of Cynoscephalae in 197 BC JHS 108 pp 60-82
Heckel W (1997) Introduction (Part 2) in JC Yardley - W Heckel (eds) Ju-stin Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus Books 11-12 Alexander the Great Introduction Oxford pp 1-41
Heckel W (2012) Introduction in JC Yardley - P Wheatley - W Heckel (eds) Justin Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus II Books 13-15 The Successors to Alexander the Great Oxford pp 1-8
Huss W (1976) Untersuchungen zur Auszligenpolitik Ptolemaiosrsquo IV Muumlnchen
Huss W (2001) Aumlgypten in hellenistischer Zeit 332ndash30 v Chr Muumlnchen
Intrieri M (2011) Fra dialogo e conflitto Annibale e i Greci drsquoOccidente RStudFen 37 pp 53-82
Landucci F (2014) Filippo II e le Storie Filippiche un protagonista storico e storio-grafico in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 233-261
Landucci Gattinoni F (2011) Politica e ideologia in etagrave ellenistica laquoPolitica An-ticaraquo 1 pp 89-105
Leacutevy E (1994) Le discours drsquoAgeacutelaos de Naupacte in L Aigner Foresti - A Bar-zanograve - C Bearzot - L Prandi - G Zecchini (a cura di) Federazioni e federalismo nellrsquoEuropa antica Bergamo 21-25 settembre 1992 Milano (Alle radici della casa co-mune europea 1) pp 33-50
Longaretti L (1989) Lrsquoalleanza tra Annibale e Filippo V di Macedonia RIL 123 pp 183-192
Marasco G (1979-1980) La valutazione di Tolemeo IV Filopatore nella storiografia greca laquoSilenoraquo 5-6 pp 159-182
Mari M [- Musti D - Thornton J] (2002) Polibio Storie Volume III Libri V-VI Milano
Mariotta G (2014) Geografia e Geopolitica nelle Storie Filippiche in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 45-56
McGing B (2010) Polybiusrsquo Histories New York
McGing B (2013) Youthfulness in Polybius the case of Philip V of Macedon in B Gibson - T Harrison (eds) Polybius and his world Oxford pp 181-199
Meadows A (2013) Polybius Aratus and the History of the 140th Olympiad in B
IL DISCORSO DEL RE 143
Gibson - T Harrison (eds) Polybius and his World Essays in Honour of Frank Walbank Oxford pp 91-116
Mecca A (2001) Trogo Timagene e Polieno QS 54 pp 199-222
Meister K (1990) Die Griechische Geschichtsschreibung von den Anfaumlngen bis zum Ende des Hellenismus Stuttgart
Misch G (1949) Geschichte der Autobiographie I Frankfurt am Mein
Momigliano A (1980) Daniele e la teoria greca della successione degli imperi RAL 35 pp 157-162
Muccioli F (2013) Gli epiteti ufficiali dei re ellenistici Stuttgart (Historia Einzel-schriften 224)
Musti D (1978) Polibio e lrsquoimperialismo romano Napoli
Parmeggiani G (2011) Eforo di Cuma studi di storiografia greca Bologna
Peacutedech P (1964) La meacutethode historique de Polybe Paris
Pelling CBR [- Scardigli B - Manfredini M](1997) Plutarco Vite parallele Filopemene Tito Flaminino Milano
Richter H-D (1987) Untersuchungen zur hellenistischen Historiographie die Vorla-gen des Pompeius Trogus fuumlr die Darstellung der nachalexandrischen hellenistischen Ge-schichte (Iust 13-40) Frankfurt
Santi Amantini L (1972) Fonti e valore storico di Pompeo Trogo (Iustin XXXV e XXXVI) Genova
Santi Amantini L (1981) (a cura di) Giustino Storie Filippiche Epitome da Pom-peo Trogo Milano
Santi Amantini L (2003) Il tempo e i tempi nelle Storie Filippiche di Pompeo Tro-go RSA 33 pp 99-110
Schepens G (1983) Les rois ptolegravemaiumlques et lrsquohistoriographie Reacuteflexions sur la trans-formation de lrsquohistoire politique in E vanrsquot Dack - P van Dessel - W Van Gucht (eds) Egypt and the Hellenistic World Proceedings of the International Collo-quium Leuven 24-26 May 1982 Leuven (Studia Hellenistica 27) pp 351-368
Schlicher JJ (1933) Non-Assertive Elements in the Language of the Roman Histo-rians CPh 28 289-300
Schmitt T (1989) Die Bedeutung des zweiten Punischen Krieges fuumlr den Frieden in Naupaktos in H Devijver - E Lipinski (eds) Punic wars Proceedings of the Conference held in Antwerp from the 23th to the 26th of November 1988 in Cooperation with the Departement of History of the laquoUniversitait Antwerpenraquo UFSIA Leuven (Studia Phoenicia 10) pp 229-239
Scholten JB (2000) The Politics of Plunder Aitolians and their koinon in the early Hellenistic Era Berkeley
144 MONICA DrsquoAGOSTINI
Scuderi R (2005) Filippo V e Perseo nei frammenti diodorei in C Bearzot - F Lan-ducci (a cura di) Diodoro e lrsquoaltra Grecia Macedonia Occidente Ellenismo nella Bi-blioteca Storica Atti del convegno Milano 15-16 gennaio 2004 Milano pp 383-405
Sklenaacuter RJ (2004) Sources and Individuality in Two Passages of Livy laquoHistoriaraquo 53 pp 302-310
Sordi M (1982) Timagene di Alessandria Uno storico ellenocentrico e filobarbaro ANRW II 30 1 pp 775-797
Thornton J (2014) Le guerre macedoniche Roma
Urban R (1979) Wachstum und Kriese des achaumlischen Bundes Quellenstudien zur entwicklung des Bundes von 280 bis 222 V Chr Wiesbaden
Urban R (1982) laquoGallisches Bewusstseinraquo und laquoRomkritikraquo bei Pompeius Trogus ANRW II 30 2 pp 1424-1443
Vannicelli P (1987) Lrsquoeconomia delle Storie di Eforo RFIC 115 pp 165-191
Vattuone R (2014) Giustino e lrsquoOccidente greco I VI-V secolo aC in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 261-277
Vollmer D (1990) Symploke das Uumlbergreifen der roumlmischen Expansion auf den grie-chischen Osten Untersuchungen zur roumlmischen Aussenpolitik am Ende des 3 Jh V Chr Stuttgart
Walbank FW (1957) A Historical Commentary on Polibius I Oxford
Walbank FW (1967) A Historical Commentary on Polybius II Oxford
Walbank FW (1933) Aratos of Sicyon Cambridge
Walbank FW (2002) Η ΤΩΝ ΟΛΩΝ ΕΛΠΙΣ and the Antigonids in FW Walbank (ed) Polybius Rome and the Hellenistic World Essays and Reflections West Nyack NY pp 127-136
Weber G (1997) Interaktion Repraumlsentation und Herrschaft Der Koumlnigshof im Hel-lenismus in A Winterling (hrsg) Zwischen lsquoHausrsquo und lsquoStaatrsquo antike Houmlfe im Ver-gleich Munich pp 27-72
Will E (19822) Histoire politique du Monde Helleacutenistique II Nancy
Zecchini G (1990) La storiografia lagide in H Verdin - G Schepens - E De Keyser (eds) Purposes of History Studies in Greek Historiography from the 4th to the 2nd Centuries BC Proceedings of the International Colloquium of Leuven 24-26 May 1988 Leuven (Studia Hellenistica 30) pp 213-232
Zecchini G (2003) Polibio e la tradizione orale in A Casanova - P Desideri (a cura di) Evento racconto scrittura nellrsquoantichitagrave classica Firenze pp 123-141
Finito di stamparenel mese di novembre 2015
da LegoDigit srlLavis (TN)
INDICE
Presentazione VII
LUISA PRANDIAlessandro il Grande in Giustino 3
FRANCA LANDUCCII Diadochi 17
GIOVANNI BRIZZIGiustino e la storia di Cartagine 39
RICCARDO VATTUONEGiustino e lrsquoOccidente greco II IV-III secolo aC 55
MARIA TERESA SCHETTINOPirro in Giustino 69
FEDERICOMARIA MUCCIOLILrsquoOriente seleucidico da Antioco I ai primi anni di Antioco III in Pompeo TrogoGiustino 99
MONICA DrsquoAGOSTINI Il discorso del Re Filippo V in Giustino 121
01_indiceindd V01_indiceindd V 201115 1537201115 1537
MONICA DrsquoAGOSTINI
Il discorso del Re Filippo V in Giustino
Introduzione
Le vicissitudini del reame antigonide durante il regno di Filippo V sono trattate principalmente nei libri XXIX e XXX delle Epitome delle Storie Fi-lippiche di Pompeo Trogo Alle notizie contenute in questi libri si aggiungo-no la breve menzione dellrsquoascesa al trono del sovrano nel libro XXVIII (3 9 e 4 16) e la descrizione degli eventi relativi alla sua morte nel libro XXXII (2 3- 3 4)
Egrave chiaro dal confronto tra i Prologi e lrsquoEpitome che ampie parti dei due libri trogiani sono state omesse in Giustino in particolare quelle ineren-ti agli avvenimenti orientali poicheacute nec cognoscendi voluptate iucunda nec exemplo erant necessaria (Praefatio 4) le origini di Creta e gli scontri tra Fi-lippo e Attalo nel libro XXIX la spedizione di Filippo in Asia e le cam-pagne di Antioco III nel libro XXX
Degli eventi dei libri XXIX e XXX sono invece menzionati in forma di riassunto da Giustino i piugrave importanti scontri militari tra Roma e Fi-lippo Nella categoria dei passi lsquoepitomatirsquo rientrano la Guerra degli Al-leati la Prima Guerra Macedonica la Seconda Guerra Macedonica Ci-noscefale e le rispettive trattative di pace ovvero Naupatto Fenice Tem-pe Quando ci si trova di fronte a tali riassunti egrave spesso difficile un con-fronto puntuale con le altre tradizioni pur con lrsquoaiuto dei Prologi
Gli eventi che ricevono attenzione nei libri XXIX e XXX sono sele-zionati secondo il criterio giustineo del cosiddetto lsquoflorilegiorsquo1 ovvero per cognitione quaeque dignissima (Praefatio 4)2 Piugrave vicini allrsquooriginale tro-giano e dunque piugrave excerpta che sintesi sono da ritenersi probabilmente i passi del libro XXIX sullrsquoalleanza tra Annibale e Filippo e sulla politica filoromana di Filopemene e quelli del libro XXX sulle questioni amo-
1 Vattuone (2014) pp 261-2772 I criteri per la distinzione dei passi piugrave vicini a Trogo e quelli invece riassunti da Giustino sono stati discussi autorevolmente allrsquointerno di questo progetto da Vattuone (2014) pp 261-277 Sul rapporto tra lrsquoopera di Trogo e lrsquoEpitome vd anche recentemente Heckel (1997) pp 1-41 e Id (2012) pp 1-8 e Borgna (2014) pp 52-77
122 MONICA DrsquoAGOSTINI
rose di Tolemeo III sul patto tra Antioco e Filippo e sullrsquoira degli Eto-li che nel 196 non videro appagata la richiesta di annientare la Macedo-nia Questi passi si prestano maggiormente a un confronto con le fonti parallele bencheacute con prudenza
Centrali nei due libri sono i cinque discorsi in oratio obliqua il primo egrave quello attribuito a Demetrio di Faro seguono tre di Filippo V men-tre lrsquoultimo egrave di Flaminino Poicheacute secondo Giustino (XXXVIII 3 11) Trogo utilizzava solamente lrsquooratio obliqua e avrebbe criticato aspramen-te Sallustio e Livio per lrsquoimpiego di numerosi discorsi in oratio recta i cin-que riportati nei libri XXIX e XXX sono stati considerati trasposizioni dellrsquooriginale trogiano3 In effetti tali discorsi fungono da ossatura del percorso narrativo dei due libri e sono da considerare le sezioni di que-sti libri piugrave vicine allrsquooriginale trogiano Sono perciograve i passi che offrono maggior possibilitagrave di studio per mettere in luce la presenza o lrsquoassen-za di una tradizione alternativa su Filippo V se questa sia giagrave in Trogo e quanto in quale modo e con quale interesse Giustino abbia interpolato tale tradizione Data la complessitagrave dei due libri ritengo opportuno ana-lizzare gli avvenimenti trattati seguendo la divisione in capitoli giustinea
Libro XXIX11-11 Introduzione
Il primo capitolo del libro XXIX si presenta con precisione nei riferi-menti coerenza testuale e attenzione ai dettagli Giustino probabilmen-te ricalcando le riflessioni di Trogo alla considerazione incipitale sul ge-nerale rinnovamento dei vertici degli imperi di lsquotutto il mondorsquo alla fine del III secolo aC fa seguire la lista dei nuovi re con alcuni commenti relativi ai singoli monarchi In particolare si sottolinea la giovane etagrave di tutti i sovrani e i condottieri al momento della loro ascesa al potere os-servazione ribadita nel commento finale al capitolo (XXIX 1 8)
His regibus pueris tametsi nulli senioris aetatis rectores erant tamen in suorum quisque maiorum uestigia intentis magna indoles uirtutis enituit
Questi re fanciulli sebbene non avessero guide di etagrave piugrave anziana tuttavia se-
3 Schlicher (1933) pp 289-300 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362 partic 1309 Adler (2006) pp 383-407 e Id (2011) pp 37-40 Recentemente Ballesteros Pastor (2013) pp 52-54 commentando il discorso di Mitridate (XXXVIII 4-7) ha ritenuto che Giustino abbia dichiarato il falso a proposito dellrsquooratio obliqua a suo avviso in Trogo ci sarebbero stati infatti numerosi discorsi diretti che poi Giustino avrebbe tragravedito come discorsi indiretti nellrsquoEpitome inserendo nel passaggio alcuni errori sintattici e incon-gruenze
IL DISCORSO DEL RE 123
guirono ciascuno con impegno le orme degli antenati e in loro rifulse un gran-de innato valore4
Questa introduzione sembra modellata sul cosiddetto lsquosecondo proe-miorsquo di Polibio (IV 2) la lista dei sovrani e lrsquoordine coincidono infatti con quello del Megalopolitano se non per lrsquoesclusione dellrsquousurpatore seleucide Acheo5 Lrsquointenzione del passo nelle due opere egrave perograve diver-sa mentre il Megalopolitano nel proemio metteva in risalto il sorgere quasi in contemporanea di nuovi conflitti in diverse parti del Mediter-raneo nellrsquoEpitome il filo conduttore di questo elenco di sovrani e con-dottieri egrave la loro gloria e la grandezza degli eventi che essi compirono in giovane etagrave6 Inoltre vi sono in Trogo alcune notizie originali rispetto al Megalopolitano il fatto che lrsquoepiteto Filopatore di Tolemeo IV sia mes-so in relazione con lrsquoassassinio dei genitori del sovrano oppure che lrsquoa-scesa di Annibale al comando dei Cartaginesi sia spiegata con il suo odio per i Romani Entrambe queste notizie non appartengono alla tradizio-ne polibiana in Polibio (II 36 3) Annibale era stato eletto comandante dellrsquoesercito in Spagna per i successi ottenuti mentre il padre Amilcare gli aveva fatto giurare odio eterno ai Romani Per quanto riguarda il Fi-lopatore Polibio ritiene che egli non abbia assassinato la madre Bereni-ce vittima invece del consigliere Sosibio (Polyb V 36 1)7 La versione di Trogo egrave dunque frutto di una propaganda avversa a Tolemeo IV che lo dipinge ancora piugrave negativamente di quanto fatto dalla tradizione poli-biana che certo giagrave non era favorevole al sovrano8
NellrsquoEpitome di Giustino segue una sintesi dei primi anni di regno di Filippo V in particolare vi egrave un brevissimo riferimento allrsquoinaspettata vit-toria del sovrano contro i Dardani che lo avrebbe portato a cercare lo
4 La traduzione di Giustino come tutte quelle presenti nel testo sono da Santi Amantini (1981) Lrsquounica eccezione a questa affermazione egrave il Filopatore Sulla tradizione storio-grafica avversa al Filopatore vd infra 5 Acheo egrave personaggio noto a Trogo che lo menziona altrove Prol XXX6 La giovinezza in TrogoGiustino egrave percepita come un valore aggiunto mentre per Poli-bio egrave una debolezza Eckstein (1995) p 143 McGing (2013) pp 181-1997 Muccioli (2013) pp 220-223 osserva che lrsquoepiteto fu assunto da Tolemeo IV quando il padre era vivo come strumento per sottolineare la sua predestinazione al trono 8 Polyb V 34 3-5 come anche Plut Cleom 33-34 forniscono notizie denigratorie su Tole-meo IV che sarebbe stato un sovrano inadatto a governare Secondo Huss (1976) pp 9 e 19 e (2001) pp 381-472 alla base vi sarebbe Filarco Se invece si considerano gli studi fatti su Tolemeo di Megalopoli da Schepens (1983) pp 351-368 e Zecchini (1990) pp 213-232 partic 218 egrave possibile che Tolemeo di Megalopoli nello scrivere unrsquoopera sto-riografica su un sovrano lagide non omettesse di menzionare notizie meno celebrative come Teopompo prima di lui aveva fatto nei confronti di Filippo II Sulla tradizione storiografica avversa a Tolemeo IV vd anche Marasco (19791980) pp 159-182 Weber (1997) pp 27ndash72 partic 28 Ager (2003) pp 35-50 McGing (2010) pp 117-119 Cri-scuolo (2011) pp 132-150 partic 148-149
124 MONICA DrsquoAGOSTINI
scontro con gli Etoli Egrave difficile dire se Trogo dedicasse piugrave spazio alla narrazione degli eventi tra il 220 e il 217 Nel Prologo si legge
Undetricensimo volumine continentur haec Res gestae Philippi regis adversus Dardanos et Aetolos repetitaeque inde Creticae origines post cuius insulae societatem Philippus cum Illyriis et Dardanis et rursus Aetolis bello congressus est adiuvantibus Aetolos Romanis quo finito intulit Attalo bellum
Il ventinovesimo libro contiene le imprese del re Filippo contro i Dardani e gli Etoli Sono quindi rievocate le origini di Creta dopo essersi alleato con questrsquoi-sola Filippo si scontrograve in guerra con gli Illiri i Dardani e di nuovo con gli Eto-li mentre i Romani soccorrevano gli Etoli Terminata questa guerra Filippo at-taccograve Attalo
Dal confronto tra Giustino e i Prologi egrave evidente che quella che per i mo-derni egrave la lsquoGuerra degli Alleatirsquo tra Etoli aiutati da Sparta e dallrsquoElide e la Lega Achea alleata di Filippo V sia ridotta sia in Giustino che in Tro-go a una guerra di Filippo contro gli Etoli Colpisce in effetti la comple-ta mancanza nel Prologo XXIX e nellrsquoEpitome del libro di qualsiasi men-zione e riferimento alla Lega Achea e al suo leader Arato protagonisti indiscussi invece nelle Storie polibiane dei primi anni di regno di Filippo V 9 Arato di Sicione importante statista e comandante militare della Le-ga Achea fu uno dei primi personaggi politici a scrivere e pubblicare le proprie memorie (FGrHist 231) di cui Polibio si servigrave ampiamente (I 3 1)10 Lo storico di Megalopoli era un compatriota di Arato e come lui ricoprigrave importanti cariche allrsquointerno della Lega Achea11 Polibio che considerava Arato uno dei fondatori della Lega vedeva in lui una sorta di eroe e leader ideale come emerge dalla descrizione che ne fa di uomo perfetto per lrsquoattivitagrave politica astuto tollerante coraggioso e di succes-so (IV 7 11-8 12) Il rapporto tra Filippo V e Arato egrave determinante per il giudizio di Polibio sul sovrano macedone Filippo egrave infatti descritto co-me un buon sovrano valoroso ma troppo giovane che nei primi anni di regno agigrave bene poicheacute ascoltograve e seguigrave i consigli di Arato (IV 77 1-4)12
Per quanto argumentum e silentio questa assenza di Arato di Sicione e della Lega Achea sia nel Prologo di Trogo che nellrsquoEpitome di Giustino
9 Polibio dedica alla Lega Achea ampia parte dei libri IV e V 10 Riguardo ad Arato di Sicione soprattutto nel rapporto con Polibio vd Meadows (2013) pp 91-116 Vd anche Walbank (1933) Misch (1949) pp 210-212 Urban (1979) Meister (1990) pp 187-189 Habicht (1995) pp 176-179 Beck - Eckstein (2015) sv laquoAratos of Sicyon (231)raquo in BNJ11 Sui legami di Polibio e la sua famiglia con la Lega Achea vd Eckstein (2013) pp 314-33812 Polyb IV 24 1-3 e V 26 6 seguito da Plut Arat 48-49 afferma esplicitamente che il re portava a termine abilmente i suoi piani poicheacute Arato era al suo fianco
IL DISCORSO DEL RE 125
non solo non puograve passare inosservata ma deve indurre i moderni a du-bitare per questi eventi di unrsquoapparente dipendenza diretta giagrave di Tro-go da Polibio
21- 38 Demetrio di Faro e Naupatto
Scomparso Arato nellrsquoEpitome XXIX ha invece un ruolo fondamentale in questi anni come consigliere di Filippo Demetrio di Faro a cui egrave at-tribuito il primo discorso in oratio obliqua dei due libri esaminati13
Demetrio di Faro era un dinasta illirico che si incontra per la prima volta nelle fonti storiografiche in occasione della prima guerra di Ro-ma in Illiria nel 229 Sappiamo infatti da Polibio (II 10 8-11 4) e Appia-no (Illyr 7) che Demetrio giagrave alleato di Teuta sovrana degli Illiri aveva scelto di passare dalla parte romana ed era stato poi ricompensato dal Senato con il controllo di parte dei territori sottratti da Roma a Teuta stessa Nei suoi tentativi di ritagliarsi un ruolo importante nella penisola balcanica Demetrio nel 222 si era alleato con la Lega Ellenica di Doso-ne e Arato a Sellasia contro Cleomene (Polyb II 65 2- 5) ma negli an-ni successivi le sue scorribande nellrsquoAdriatico allarmarono Roma che gli mosse guerra (Polyb III 16 IV 16)14 Sconfitto da Roma e cacciato da Faro Demetrio si rifugiograve alla corte di Filippo intorno al 218 diventan-do consigliere del re
Poicheacute nel Prologo XXVIII si legge laquoIn una digressione egrave narrata la guerra illirica combattuta dai Romani contro Teuta15raquo non egrave da esclu-dere che Trogo giagrave citasse il dinasta di Faro anche se la prima menzio-ne di Demetrio in Giustino egrave a XXIX 2 1 quando il cosiddetto lsquore de-gli Illirirsquo cacciato da Lucio Emilio Paolo dallrsquoAdriatico arrivograve alla corte macedone Nel riassunto degli eventi Giustino segue piugrave da vicino Tro-go riportando il discorso del dinasta a Filippo V per convincere il sovra-no a far guerra a Roma (XXIX 2 2-6) I punti principali di tale discorso sono che i Romani aspirano a realizzare un impero universale a scapito di tutti i re laquocome se fosse cosa illecita che ci fosse un qualche re presso i confini del loro Statoraquo Perciograve Filippo V doveva prepararsi alla guerra con i Romani poicheacute laquoquanto piugrave accessibile e illustre era il suo regno tanto piugrave accaniti nemici gli sarebbero stati i Romani16raquo Demetrio vole-
13 Su questi discorsi di Demetrio vd Coppola (1993) pp 29-5114 Coppola (1993) pp 29-51 vd anche Hammond (1968) pp 1-21 Eckstein (2008) pp 41 58-60 Demetrio di Faro era presentato in Polibio come il rivale di Arato tra i consi-glieri di Filippo Polyb IX 23 9 infatti dichiara che quando il sovrano seguiva i consigli di Arato compiva grandi imprese mentre quando ascoltava Demetrio si macchiava di atti spregevoli15 Trog Prol XXVIII Dictum in excessu bellum Illyricum quod Romani gessere cum Teuta16 Iust XXIX 2 4-5 sibi quoque non aliam ob causam quam quod Italiae finitimus uidebatur
126 MONICA DrsquoAGOSTINI
va infatti cacciare i Romani dalla sponda adriatica dellrsquoIlliria territorio che avrebbe ceduto a Filippo
Il discorso di Demetrio a Filippo egrave presente anche in Polibio (V 101 8-1017) ed egrave inserito cronologicamente durante i giochi Nemei18 nel 217 subito dopo la sconfitta romana del lago Trasimeno ricordata an-che nel passo di Giustino Nel discorso polibiano Demetrio perograve sotto-linea il diritto di Filippo V ad aspirare al dominio universale a partire dallrsquoAdriatico19 mentre nel discorso trogiano Demetrio accusa i Roma-ni di aspirare ad espandersi travolgendo qualsiasi regno sul loro cammi-no Trogo nel discorso di Demetrio presenta il coinvolgimento roma-no in Oriente come una guerra di conquista che contrappone la giova-ne potenza romana allrsquolsquoillustre regnorsquo di Filippo20 prospettiva che ritor-na nel successivo discorso di Filippo V nellrsquoEpitome ma che egrave estranea al-la narrazione di Polibio
Dopo il discorso di Demetrio nellrsquoEpitome come in Polibio (V 104 1) si arriva allrsquoincontro di pace di Naupatto nel 217 che pose fine al-la Guerra degli Alleati tra Etoli Spartani ed Elei contro la lega Achea e
bellum inlatum quasi nefas esset aliquem regem iuxta imperii eorum terminos esse Sed et ipsi cauen-dum esse exemplum cuius quanto promptius nobiliusque sit regnum tanto sit Romanos acriores hostes habiturus17 Polyb V 101 8-10 ὃς καὶ λαβόμενος τῆς ἀφορμῆς ταύτης τὸν μὲν πρὸς τοὺς Αἰτωλοὺς ᾤετο δεῖν τὴν ταχίστην ἀπορρῖψαι πόλεμον ἀντέχεσθαι δὲ τῶν κατὰ τὴν Ἰλλυρίδα πραγμάτων ἠξίου καὶ τῆς εἰς Ἰταλίαν διαβάσεως [9] τὰ μὲν γὰρ κατὰ τὴν Ἑλλάδα πάντα καὶ νῦν ἤδη ποιεῖν αὐτῷ τὸ προσταττόμενον ἔφη καὶ μετὰ ταῦτα ποιήσειν Ἀχαιῶν μὲν ἐθελοντὴν εὐνοούντων Αἰτωλῶν δὲ καταπεπληγμένων ἐκ τῶν συμβεβηκότων αὐτοῖς κατὰ τὸν ἐνεστῶτα πόλεμον [10] τὴν δ᾽ Ἰταλίαν ἔφη καὶ τὴν ἐκεῖ διάβασιν ἀρχὴν εἶναι τῆς ὑπὲρ τῶν ὅλων ἐπιβολῆς ἣν οὐδενὶ καθήκειν μᾶλλον ἢ ᾽κείνῳ τὸν δὲ καιρὸν εἶναι νῦν ἐπταικότων Ῥωμαίων Trad da Mari (2002) laquoCostui allora cogliendo lrsquooccasione gli consigliograve di interrompere al piugrave presto la guerra con gli Etoli e gli chiese di impegnarsi nelle operazioni in Illiria e nellrsquoattraversamento del mare verso lrsquoItalia Disse che infatti giagrave ora tutta la Grecia eseguiva i suoi ordini e lo avrebbe fatto anche in seguito poicheacute gli Achei lo sostenevano di loro iniziativa mentre gli Etoli erano rimasti molto colpiti da quanto era loro avvenuto nella guerra in corso e aggiunse che lrsquoItalia e lrsquoattraversamento del mare in quella direzione erano lrsquoinizio di un disegno di dominio universale che a nessuno spettava piugrave che a lui ora era il momento opportu-no visto che i Romani erano stati battutiraquo18 I giochi Nemei in onore di Zeus erano giochi panellenici celebrati in Argolide negli anni pari delle Olimpiadi 19 Secondo Eckstein (1995) pp 211-212 tale aspirazione egrave connessa allrsquoincapacitagrave di mo-derazione nella vittoria del sovrano Sul concetto di dominio universale in Polibio vd Musti (1978) pp 16-18 Eckstein (2008) pp 217-220 e 372-38120 Adler (2006) pp 383-407 e (2011) pp 37-58 ha notato che i punti principali del discorso di critica allrsquoespansionismo romano di Demetrio ritornano in altri due discorsi dellrsquoEpitome quello degli Etoli (XXVIII 2 1-13) e quello di Mitridate (XXXVIII 4-7) la prioritagrave data a questi argomenti da tale reiterazione retorica indica che lrsquointeresse giagrave di Trogo se non dellae suae fontei non fosse la celebrazione dellrsquoascesa di Roma allrsquoim-pero universale come in Appiano ma piuttosto lrsquoascesa e la discesa dei regni ellenistici
IL DISCORSO DEL RE 127
Filippo V 21 Il testo giustineo omette le circostanze dellrsquoevento non si menzionano infatti esplicitamente neacute il luogo dellrsquoincontro Naupatto neacute le fasi delle trattative neacute i vari rappresentanti dei diversi fronti che vi presero parte I lunghi negoziati di pace si risolvono dunque nel discor-so di Filippo V ai rappresentanti dei fronti
Il sovrano esordisce affermando che la Grecia egrave in grande pericolo percheacute chiunque avesse vinto tra Cartaginesi e Romani sarebbe poi pas-sato in Oriente Filippo utilizza la metafora delle nubi in Occidente che avrebbero macchiato con una pioggia di sangue ogni cosa spinte dai venti di vittoria inoltre il sovrano ritiene che le guerre passate dei Gre-ci siano di poco conto se paragonate alla minaccia di uno scontro con la moltitudine che si radunava in Italia descrivendo la rabbia e il valore di questi nuovi nemici che avrebbero portato rovina ai vicini Il sovrano infine ribadisce che la Grecia era in maggior pericolo della Macedonia ma che sapeva che chi avesse vinto in Italia non avrebbe frenato la sete di vittoria Perciograve anche la Macedonia stessa doveva temere un attacco
Il discorso in Polibio di Agelao di Naupatto rappresentante e leader degli Etoli22 mostra le medesime argomentazioni attribuite in Giustino allrsquointervento di Filippo argomentazioni fondate sul metus hostilis e fina-lizzate a promuovere un nuovo ruolo della Macedonia sia in Grecia che nel Mediterraneo Orientale Agelao proponendo un nuovo program-ma politico panellenico fonda le proprie argomentazioni sul metus hosti-lis per i Cartaginesi e i Romani presentati metaforicamente come nubi che incombono da Occidente Filippo dovrebbe farsi garante della tran-quillitagrave della Grecia che agendo come unrsquounica catena di cittagrave contro i barbari diverrebbe una sicura e fedele collaboratrice della Macedonia Questo permetterebbe ai Greci di conservare il diritto di far pace o guer-ra a loro piacimento senza temere che laquoi giochi da bambini con i quali ci trastulliamo tutti vengano troncati23raquo
Nonostante sia il medesimo discorso nelle due fonti Agelao introdu-ce una forte proposta di alleanza panellenica estranea alle parole di Fi-lippo Inoltre Filippo pur utilizzando la metafora delle nubi da Occi-
21 Interessanti le osservazioni di Scholten (2000) pp 224-228 a proposito della pace che sarebbe stata cercata e sperata da entrambe le parti e non imposta da Filippo come Polibio pare lasciar intendere 22 Vd soprattutto Leacutevy (1994) pp 33-50 Su questo discorso molto dibattuto dai moderni vd anche Schmitt (1989) pp 229-239 Vollmer (1990) pp 96-107 Coppola (1993) pp 149-164 Golan (1995) pp 55-74 Champion (1997) pp 111-128 e (2004) p 55 Wal-bank (2002) pp 127-136 Eckstein (2008) pp 78-83 23 Polyb V 104 10-11 καθόλου τὰς παιδιάς ἃς νῦν παίζομεν πρὸς ἀλλήλους ἐκκοπῆναι συμβῇ πάντων ἡμῶν ἐπὶ τοσοῦτον ὥστε κἂν εὔξασθαι τοῖς θεοῖς ὑπάρχειν ἡμῖν τὴν ἐξουσίαν ταύτην καὶ πολεμεῖν ὅταν βουλώμεθα καὶ διαλύεσθαι πρὸς ἀλλήλους καὶ καθόλου κυρίους εἶναι τῶν ἐν αὑτοῖς ἀμφισβητουμένων
128 MONICA DrsquoAGOSTINI
dente presente anche nelle Storie la arricchisce con la vivida immagine di una tempesta di sangue conferendo una dimensione piugrave concreta e cruenta alla predizione infine il riferimento polibiano alle guerre dei Greci nellrsquoEpitome non riguarda piugrave le guerre tra le cittagrave e le leghe gre-che ma le guerre dei Greci con Macedoni Persiani e Galli Mentre la Grecia scompare sullo sfondo la minaccia Romana egrave meno vaga e piugrave concreta e presente che in Polibio e diventa lrsquounico argomento del di-scorso di Filippo V a Naupatto
Il discorso di Demetrio e quello di Filippo sono al centro del libro XXIX dellrsquoEpitome avendo il duplice scopo di evidenziare sia la poten-ziale aggressivitagrave dei Romani sia la grande tradizione militare della Ma-cedonia e il pieno diritto di Filippo di controllare la Grecia e lrsquoIlliria fi-no allrsquoAdriatico Se il discorso in Polibio si inseriva in un dibattito politi-co dove la Grecia e la Macedonia erano protagoniste alla pari della sce-na ellenica e internazionale nella versione che leggiamo in Trogo i ri-ferimenti alle dispute della realtagrave greca sono reinterpretati a favore di un punto di vista in cui la Macedonia egrave lrsquounico potere dellrsquoOriente gre-co Del dibattito politico di III secolo in Grecia che tanto stava a cuore a Polibio non vi egrave piugrave alcuna traccia in TrogoGiustino rimane soltanto lo scontro tra le due grandi potenze di Oriente e Occidente tra Filippo e Roma Questa prospettiva bipolare dei discorsi trogiani si ritrova nel-la conclusione del capitolo che se da un lato sottolinea ancora una vol-ta il timore di Filippo per Cartaginesi e Romani dallrsquoaltro esplicita che i Romani avevano paura dellrsquoantica gloria dei Macedoni laquovincitori dellrsquoO-rienteraquo e soprattutto di Filippo laquoinfiammato dallo zelo di emulare Ales-sandro che era ben noto come pronto alle guerre e instancabileraquo24
41-11 La Prima Guerra Macedonica
Dei prodromi della Prima Guerra Macedonica Giustino si interessa sol-tanto allrsquoalleanza antiromana tra Annibale e Filippo Questo trattato egrave noto da molte fonti secondo cui Filippo dopo aver appreso che i Roma-ni erano stati sconfitti di nuovo dai Cartaginesi a Canne nel 216 avreb-be mandato unrsquoambasceria ad Annibale per proporre unrsquoalleanza ma lrsquoambasciatore macedone sarebbe stato catturato da Roma sulla via del ritorno25
24 Iust XXIX 3 8 quippe terrebat eos et uetus Macedonum deuicti Orientis gloria et Philippus studio Alexandri aemulationis incensus quem promptum in bella industriumque cognouerant Alla gloria dei Macedoni avevamo giagrave trovato riferimento nei discorsi del libro XXVIII degli Etoli (2 12) e di Antigono Dosone (3 14) 25 Secondo Polyb VII 9 17 Filippo avrebbe aiutato Cartagine nella guerra con Roma in cambio di Corcira Epidamno e Apollonia e della restituzione a Demetrio di Faro del suo regno Inoltre Filippo e Annibale si impegnavano a soccorrersi a vicenda in caso di
IL DISCORSO DEL RE 129
A prescindere dai dettagli del fermo dellrsquoambasciatore macedone da parte romana egrave possibile fare qualche osservazione sul nesso tra questo lsquoincidentersquo diplomatico e lo scoppio della guerra Cassio Dione e Ap-piano riportano che la cattura del legato avrebbe causato una vendetta di Filippo contro i protettorati romani in Adriatico in particolare Cor-cira26 notizia assente in Polibio come in Livio e Plutarco (che da Poli-bio dipendono)27 In questi ultimi autori lrsquoattacco di Filippo in Adriati-co infatti non sarebbe legato allrsquoepisodio dellrsquoambasciatore ma alla de-cisione del sovrano di rompere con il consigliere Arato e di dare ascol-to ai cattivi consigli di Demetrio di Faro presa dopo la spedizione a Mes-sene nel 215214 La tradizione polibiana legge infatti in questi eventi la manifestazione del cambiamento dellrsquoindole di Filippo V da giusta a empia iniziata con lrsquoepisodio della stasis di Messene del 215 e compiu-ta con lrsquoassassinio di Arato del 21328 Nel libro XXIX di Giustino ben-cheacute si conservi traccia dellrsquoindole aggressiva di Filippo e del consiglio di Demetrio di Faro come prodromi dello scontro con Roma non vi sono indizi della metaboleacute del sovrano da giusto a empio e malvagio e neppu-re del ruolo che in tale cambiamento ricoprigrave lrsquoallontanamento tra Ara-to e Filippo
attacco da parte di Roma Mentre Peacutedech (1964) pp 382-383 ritiene sicura la consulta-zione a Roma di tali documenti Zecchini (2003) pp 123-141 come prima di lui Walbank (1957) I p 32 n 4 non ne egrave certo poicheacute Polibio viaggiograve proprio per poter reperire documenti e informazioni sugli eventi dove essi avvennero Altre fonti Liv XXIII 38 7 Plut Arat 51 2 Dio C XV 4 2 e App Mak Fr 1 Sul confronto delle fonti vd DrsquoAgostini (2011) pp 99-121 Sul trattato macedone-cartaginese vd Cassola (1962) pp 65-66 Wal-bank (1967) II pp 42-44 Will (19822) pp 83-84 Barreacute (1983) Longaretti (1989) pp 183-192 Golan (1995) pp 45-46 Eckstein (2008) pp 83-85 Intrieri (2011) pp 53-8226 Dio C XV 4 2 e App Mak Fr1 Filippo per vendicarsi della cattura del proprio amba-sciatore non solo attaccograve Corcira ma saputo dellrsquoarrivo di Levino durante la ritirata da Corcira saccheggiograve anche Apollonia e Orico alleate romane Levino avrebbe poi sconfit-to Filippo e recuperati gli alleati costringendo il re a bruciare le proprie navi e rientrare via terra Si riferisce a questo episodio probabilmente il Mak Fr 9 di Appiano che riporta lrsquoordine di Filippo di uccidere quanti erano sulle navi percheacute non dicessero ai Romani che le forze macedoni erano stremate DrsquoAgostini (2011) pp 99-12127 Polyb V 108-110 Liv XXIV 40 e Plut Arat 51 2 non menzionano Corcira nella narra-zione dellrsquoalleanza macedone-cartaginese e della cattura dellrsquoambasciatore Secondo Liv XXIII 38 7 lrsquoambasciatore sarebbe stato trattenuto a Roma 28 Polyb VII 11 8-11 e Plut Arat 49 1 Coppola (1993) pp 205-210 Dai frammenti di Polyb VII 10-12 e dalla narrazione di Plut Arat 49-51 sappiamo che Filippo era interve-nuto nella stasis di Messene tra oligarchici e democratici ma aveva di nascosto lasciato che i cittadini si massacrassero Una volta giunto Arato la guerra civile fu finalmente sedata ma il sovrano avrebbe voluto su consiglio di Demetrio di Faro approfittare della situazione e imporre una guarnigione nellrsquoacropoli della cittagrave che gli avrebbe conferito un vantaggio strategico per il controllo del Peloponneso Arato dissuase Filippo da per-seguire unrsquoazione militare in Peloponneso ma il re decise su consiglio di Demetrio di rivolgere la sua aggressivitagrave verso lrsquoIlliria prima e i protettorati romani Orico e Apollonia poi
130 MONICA DrsquoAGOSTINI
Dopo aver accennato alla stipula del trattato Giustino affastella ne-gli ultimi paragrafi del capitolo 4 gli eventi tra il 215 e il 205 quando Fi-lippo siglando la pace con Roma pone fine alla Prima Guerra Macedo-nica29 In particolare lrsquoEpitomatore sottolinea da un lato lrsquoingresso in guerra degli Etoli al fianco dei Romani e la successiva alleanza del preto-re Levino con Attalo dallrsquoaltro gli attacchi subiti da parte dei Dardani da Filippo oppresso dalle richieste degli Illiri Il libro dunque si chiude con Filippo in difficoltagrave aggravate dalla comparsa di Filopemene il leader degli Achei30 urtatosi con il re dei Macedoni convince la Lega Achea a staccarsi dallrsquoalleanza con la Macedonia sempre piugrave isolata Tale allon-tanamento egrave considerato da Giustino lrsquoesito di un fallito agguato a Fi-lopemene commissionato da Filippo V e dovuto al sospetto di un tradi-mento del condottiero acheo a favore di Roma Bencheacute anche Plutarco (Fil 12 2) e Pausania (VIII 50 4) menzionino il tentativo di assassinio di Filopemene da parte di Filippo la notizia dellrsquoatteggiamento filoroma-no del generale acheo non parrebbe vicino al ritratto polibiano che ve-de in Filopemene un eroe dellrsquoautonomia e dellrsquoindipendenza achea31
Libro XXX11-39 Cinoscefale
Lrsquoesordio del libro XXX introducendo il grande scontro di Cinoscefale tra Romani e Macedoni riprende la celebrazione della gloria macedo-ne argomento centrale dei discorsi del libro XXIX Con lrsquoeccezione dei primi capitoli sul deplorevole comportamento di Tolemeo IV in Egit-to32 il libro egrave infatti totalmente dedicato allo scontro tra le due potenze
29 Errington (2008) pp 185-190 La guerra egrave nota a noi soprattutto dai frammenti dei libri VIII-XI di Polibio dai passi di Liv XXIV 40 1-17 XXVI 24 1-26 4 XXVII 30 5-33 5 e XXVIII 5 1- 9 1 XXIX 12 1-15 e dalla Vita di Filopemene di Plutarco La sinteticitagrave del riassunto giustineo impedisce un puntuale paragone delle tradizioni Ad esempio la notizia dellrsquoalleanza tra Attalo e Roma sembra tornare in Liv XXVIII 5 1-4 dove perograve non troviamo Levino ma Sulpicio come rappresentante romano personaggio scompar-so in Giustino In maniera simile la pace di Fenice del 205 egrave sintetizzata in Giustino in una riga e non vi egrave traccia delle lunghe trattative che coinvolsero come mediatori anche Egitto Chio Mitilene e Atamania portarono a una prima pace separata tra Filippo e gli Etoli nel 206 e poi alla pace con Roma Le fonti parallele sono molto piugrave dettagliate anche su questi eventi Polyb XI 4 1-6 9 Liv XXVIII 5 13 e XXIX 12 8-16 e App Mak fr III Degno di nota egrave perograve il commento in Giustino secondo cui laquoi Romani erano per il momento soddisfatti di aver rinviato la guerra contro la Macedoniaraquo Lrsquointenzione ro-mana di riprendere la guerra con la Macedonia egrave infatti presente in tutte le fonti Polyb XI 6 7 Liv XXIX 1216 Dio C XVIII 9 (15) e App Mak Fr III e verragrave ripresa al libro XXX dellrsquoEpitome 30 Su Filopemene e Filippo vd Errington (1969) pp 51-69 e 83-84 vd anche Golan (1995) pp 115-132 Eckstein (2008) pp 103 e 360-36131 Pelling (1997) pp 135-13932 Lrsquoesordio del libro XXX egrave dedicato alle scabrose imprese del sovrano egiziano ovvero
IL DISCORSO DEL RE 131
dellrsquoEst e dellrsquoOvest La prima avvisaglia dellrsquoincombente guerra egrave la no-tizia dellrsquoaccordo di Filippo V e Antioco III per la spartizione dellrsquoEgitto governato dal sovrano-bambino Tolemeo V Il sovrano lagide nel 2032 chiese aiuto ai Romani che secondo TrogoGiustino gradirono la ri-chiesta drsquoaiuto percheacute cercavano pretesti per muovere guerra contro Fi-lippo A partire da Polibio numerose altre fonti ci testimoniano questo episodio mettendolo in relazione con lo scoppio della Seconda Guerra Macedonica ed esprimendo una condanna morale per lrsquoempia condotta del re antigonide che cospira contro un bambino33 al contrario nellrsquoE-pitome si esalta la potenza macedone evidenziando la paura dei Romani delle grandi imprese di Filippo (XXX 3 2)
nullius magis arma metuebant reputantibus quantum motum Pyrrhus parua Macedo-num manu in Italia fecisset quantasque res Macedones in Oriente gessissent
di nessun altro temevano maggiormente le armi poicheacute ripensavano a quanto sconvolgimento Pirro aveva provocato in Italia con una piccola schiera di Ma-cedoni e a quanto grandi imprese i Macedoni avevano compiuto in Oriente
La supremazia macedone egrave anche al centro del discorso in oratio obliqua di Filippo allrsquoincontro nel Golfo Maliaco tra i rappresentanti dei fronti coinvolti nella Seconda Guerra Macedonica34 NellrsquoEpitome infatti dopo
la Quarta Guerra Siriaca conclusa con sconfitta a Rafia contro Antioco III nel 217 e la corruzione del sovrano da parte di Agatocle e della sorella una cortigiana che avrebbe sedotto il re Giustino riferisce poi la morte del sovrano nel 204 e lrsquoascesa al trono del piccolo Tolemeo V Epifane sovrano sotto tutela di Tlepolemo dopo la morte di Agatocle e Sosibio 33 Eckstein (2008) pp 121-180 Thornton (2014) pp 65-88 In particolare sulla relazione tra il complotto e la sconfitta antigonide e seleucidica ad opera di Roma la superioritagrave morale romana ai regni ellenistici e la causalitagrave storica in Polibio (XV 20 6) vd Eck-stein (2008) pp 133-138 Ager (2009) pp 15-43 Landucci Gattinoni (2011) pp 89-105 Secondo Polyb III 2 8 XV 20 XVI 1 8-9 seguito da Liv XXXI 14 5 Filippo avrebbe ottenuto le basi tolemaiche in Egeo Samo e la Caria mentre Antioco avrebbe finalmente avuto mano libera in Celesiria e Fenicia oggetto di quasi un secolo di lotte tra Tolemei e Seleucidi La notizia del trattato permette a Polibio di dedicare alcuni paragrafi (XV 20) a condannare aspramente lrsquooperato di Filippo V e Antioco III definendoli empi e senza pudore e dichiarando che la Fortuna punigrave i due sovrani per il loro crudele operato por-tando i Romani contro di loro vd infra App Mak Fr IV trasmette delle clausole secondo cui Antioco avrebbe avuto lrsquoEgitto e Cipro mentre Filippo avrebbe ottenuto Cirene le Cicladi e la Ionia Infine secondo Porfirio FGrHist 260 F 45 lrsquoaccordo prevedeva che i due sovrani annettessero i possedimenti tolemaici confinanti con i rispettivi regni 34 Prima si menziona unrsquoambasceria del Senato a Filippo e Antioco percheacute laquosi astenessero dallrsquoEgittoraquo e la visita di Lepido in Egitto Quindi le lamentele a Roma di Attalo e i Rodii nei confronti di Filippo Egrave probabile che a questo punto Trogo inserisse la campagna di Filippo in Asia contro Attalo menzionata nel Prologo XXX ma tagliata nellrsquoEpitome La cronologia degli scambi diplomatici precedenti la Seconda Guerra Macedonica egrave stra-volta dalla sintesi dellrsquoEpitomatore e rende impossibile qualsiasi confronto con le altre
132 MONICA DrsquoAGOSTINI
il riassunto delle ambascerie nel Mediterraneo preludio allo scontro della prima fase della guerra35 maggior spazio egrave dato al tentativo di pa-ce a Nicea tra Roma Attalo i Rodii gli Achei e gli Etoli e Filippo V nel 198 In questa occasione Filippo rivendica la posizione di dominio dei Macedoni sui Greci ereditata da Filippo II e Alessandro suoi antenati e in virtugrave di tale supremazia macedone rifiuta che i Greci gli dettino le condizioni di pace ma chiede che sia il Senato a decidere Egrave significati-vo che non solo il discorso di Filippo non compaia in nessuna delle fon-ti parallele che descrivono nel particolare le posizioni degli ambasciato-ri di Achei Etoli Rodii e Attalo ma che Polibio (XVIII 8 8)36 affermi che era difficile sapere cosa si fossero detti Filippo e Flaminino durante i colloqui nel Golfo Maliaco Secondo la tradizione polibiana infatti il sovrano accompagnato da due philoi macedoni Apollodoro e Demoste-ne chiese di allontanare dalle trattative tutti tranne i Romani e discus-se la pace solamente con Flaminino Successivamente a causa dellrsquoinca-pacitagrave di trovare un accordo Filippo chiese due mesi di tregua e lrsquointer-vento del Senato Trogo dunque restituisce il discorso che il resto della tradizione riteneva impossibile da conoscere indicando chiaramente la presenza di una fonte diversa rispetto a Polibio su questo avvenimento piugrave informata sul punto di vista di Filippo e interessata a evidenziare la convinzione di Filippo V di avere un diritto di supremazia sulla Grecia in virtugrave delle imprese di Filippo II e Alessandro
La battaglia di Cinoscefale nel 197 momento risolutivo dello scontro tra Roma e Macedonia egrave lrsquoevento principale del libro XXX omina e pre-sagi introducono lrsquoevento campale lrsquoeruzione del vulcano di Santorini
fonti In Polyb XVI 24 3 App Mak Fr IV Liv XXXI 1 10 21 5 5 Paus I 36 5-6 vi sono differenti versioni della sequenza delle ambascerie che denunciarono a Roma lrsquoe-spansionismo macedone ma tutte concordano che le ambascerie precedettero lrsquoinvio dei legati romani in Oriente e che esse furono inviate anche da Atene e dagli Etoli Inoltre secondo la tradizione polibiana (Polyb XVI 27 1-4 34 1-7 Liv XXXI 2 3 6 3-8 4 18 1-9 Diod XXVIII 6) vi furono due diverse ambascerie di cui la seconda sarebbe stato un ultimatum al sovrano recapitato da Lepido In occasione di questa seconda ambasceria avvenuta durante il cruento assedio di Abido Filippo avrebbe detto che i Macedoni in ca-so di guerra si sarebbero difesi con valore In Giustino si puograve notare che ancora una volta dagli eventi sono omesse notizie fondamentali sui Greci nello specifico lrsquoambasceria di Atene la cui disputa con gli Acarnani fu il casus belli della guerra contro Filippo 35 Come i prodromi anche la prima parte della Seconda Guerra Macedonica egrave sintetizza-ta in Giustino e occupa solamente due paragrafi Come spesso accade nei passi sintetiz-zati dallrsquoEpitomatore si trovano le incongruenze maggiori con le fonti parallele tra cui si nota soprattutto la completa omissione di Giustino delle campagne di Publio Sulpicio Galba Massimo di Villio delle vittorie di Tito e Lucio Flaminino e dellrsquoassemblea del 198 che portograve gli Achei ad allearsi con Roma Polyb XXII e Liv XXXI 14 1- 46 16 XXXII 1 1-25 12 App Mak Fr VII Plut Fil 17 4 Flam 5 4 e Paus VII 8 1-236 Le trattattive sono descritte con particolari in Polyb XVIII 1-12 seguito da Liv XXXII 32 6-36 10 e Plut Flam 5 8 e 7 1-3
IL DISCORSO DEL RE 133
nel 197 e lrsquoemergere dellrsquoisola di Hiera e in contemporanea il terremo-to a Rodi Quindi nellrsquoEpitome si annuncia che laquoil nascente impero dei Romani avrebbe divorato quello antico dei Greci e dei Macedoni37raquo Nel passo ricevono spazio soprattutto i due discorsi contrapposti del re ma-cedone Filippo e del comandante romano Flaminino pronunciati pri-ma dello scontro campale e costruiti ciascuno in modo da celebrare le imprese delle due potenze38 Lrsquoenfasi data dalla contrapposizione reto-rica delle parole dei generali egrave tale da rendere suggestiva lrsquoipotesi che lo scontro dovesse essere il momento centrale non solo del libro XXX ma forse di tutta lrsquoopera trogiana
Filippo elenca le grandi vittorie del passato dei Macedoni contro Per-siani Battriani Indiani e le popolazioni drsquoAsia fino allrsquoestremo Orien-te esortando i suoi a combattere con valore percheacute laquola libertagrave egrave piugrave cara del predominio39raquo Il discorso di Flaminino egrave invece piugrave lungo articola-to in un paragone tra Macedoni e Romani alle passate imprese di con-quista macedoni vengono contrapposte le piugrave recenti vittorie romane a Cartagine in Sicilia Italia e Spagna alla grandezza di Alessandro Ma-gno egrave contrapposta quella di Annibale che pure dai Romani era stato sconfitto Lrsquoattenzione poi si concentra su Filippo i Macedoni non laquodo-vevano essere valutati per lrsquoantica forza ma per le forze attuali40raquo poicheacute Filippo non era lrsquoinvitto e invincibile Alessandro Magno ma un ragaz-zo che non riusciva a difendere i propri confini I Macedoni rivendica-vano il valore degli antenati mentre i Romani quello dei propri soldati poicheacute quelli che erano ligrave schierati erano gli stessi che avevano sconfitto Annibale Dopo una cosigrave grandiosa introduzione la battaglia egrave descritta in uno dei paragrafi piugrave significativi di tutta lrsquoopera
His adhortationibus utrimque concitati milites proelio concurrunt alteri Orientis alteri Occidentis imperio gloriantes ferentesque in bellum alii maiorum suorum antiquam et ob-soletam gloriam alii uirentem recentibus experimentis uirtutis florem [16] Sed Macedo-nas Romana Fortuna uicit
I soldati incitati da queste esortazioni dallrsquouna e dallrsquoaltra parte si lanciaro-no nel combattimento vantandosi gli uni del dominio dellrsquoOriente gli altri dellrsquoOccidente e recando in guerra gli uni lrsquoantica e sbiadita gloria dei loro an-
37 Iust XXX 4 4 Quo prodigio territis omnibus uates cecinere oriens Romanorum imperium uetus Graecorum ac Macedonum uoraturum38 Sui discorsi precedenti la battaglia nellrsquoantichitagrave se da considerare reali o costruzioni storiografiche vd Adler (2011) pp 6-839 Iust XXX 4 7 tantoque hoc bellum fortius quam illa sustinendum quanto sit imperio libertas carior40 Iust XXX 4 10 Sed nec Macedonas ueteri fama sed praesentibus uiribus aestimandos
134 MONICA DrsquoAGOSTINI
tenati gli altri il fiore del loro valore fresco e vigoroso per le recenti prove Ma la Fortuna dei Romani vinse i Macedoni
Questo punto di vista probabilmente giagrave trogiano contrappone la virtugrave romana (virtutis flos) celebrata nei discorsi antecedenti la battaglia al-la Fortuna romana (Romana Fortuna) che decise la vittoria interpretabi-le come destino favorevole o buona stella Piugrave che unrsquoaffermazione anti-romana41 come egrave spesso stata intesa si puograve evidenziare il carattere sim-patetico della fonte verso Filippo V destinato a porre fine alla gloria di Filippo II e Alessandro e forse un approccio nostalgico verso i grandi regni macedoni la cui egravera egrave ormai giunta alla fine Tale prospettiva egrave as-sente in Polibio e nella tradizione che da lui dipende poco interessata alle vicende della gloria macedone leggendo infatti i frammenti soprav-vissuti del libro XVIII delle Storie dopo lrsquoaccurata descrizione della bat-taglia (18-33 e 34-40)42 Polibio commenta lo scontro affermando che avrebbe dedicato alcuni capitoli allrsquoesame delle strategie militari delle due armate percheacute (XVIII 28 4-6)
χρήσιμον καὶ καλὸν ἂν εἴη τὸ τὴν διαφορὰν ἐρευνῆσαι καὶ παρὰ τί συμβαίνει Ῥωμαίους ἐπικρατεῖν καὶ τὸ πρωτεῖον ἐκφέρεσθαι τῶν κατὰ πόλεμον ἀγώνων [5] ἵνα μὴ τύχην λέγοντες μόνον μακαρίζωμεν τοὺς κρατοῦντας ἀλόγως καθάπερ οἱ μάταιοι τῶν ἀνθρώπων ἀλλ᾽ εἰδότες τὰς ἀληθεῖς αἰτίας ἐπαινῶμεν καὶ θαυμάζωμεν κατὰ λόγον τοὺς ἡγουμένους
Puograve essere cosa buona e utile esaminare le differenze e per quale motivo i Ro-mani prevalgono e riportano il primo premio nelle competizioni di guerra af-fincheacute non esaltiamo i vincitori senza una ragione parlando solo di fortuna co-me fanno gli sciocchi ma conoscendo le vere cause lodiamo e ammiriamo i co-mandanti seguendo una logica
Polibio dunque sembra rispondere a coloro che parlavano della buo-na stella dei Romani sottolineando che la vittoria nasceva dalla superio-re strategia militare della legione43 Un punto di vista quindi opposto a quello espresso nellrsquoEpitome che proprio di Romana Fortuna parla e riba-dito in chiusura al passo dove Polibio critica nuovamente quei Greci che ritenevano la vittoria romana incredibile (XVIII 32 13)
41 Urban (1982) pp 1424-1443 1435 Richter (1987) p 19 n 4 Alonso-Nuacutentildeez (1992) p 66 e Id (2002) pp 105-110 partic 108-109 Contra Heckel (1997) p 29 che ridimen-siona la categorizzazione di Trogo come storico anti-romano 42 Su Cinoscefale vd Walbank (1957) ad l Hammond (1988) pp 60-82 Sklenaacuter (2004) pp 302-310 Thornton (2014) pp 83-87 43 Sulla Fortuna in Polibio vd McGing (2010) pp 195-201 (con bibliografia) che distin-gue tra quando Polibio intenda caso e quando predeterminazione fato Vd anche Green (1990) pp 400-402 e Eckstein (2008) pp 132-138
IL DISCORSO DEL RE 135
Il punto di vista di Trogo sembra invece presente nei frammenti del-la Makedonikeacute di Appiano su Filippo V44 dove ci si riferisce a Cinoscefale come a una vittoria insperata (Mak 9 1)
ἡγούμενος δ᾽ οὔτε Ῥωμαίοις συμφέρειν οὔτε τοῖς Ἕλλησι Φιλίππου καθαιρεθέντος ἐπιπολάσαι τὴν Αἰτωλῶν βίαν τάχα δ᾽ αὐτὸν καὶ τὸ παράδοξον τῆς νίκης ἀγαπᾶν ἐποίει
Flaminino era consapevole che non sarebbe stato vantaggioso per i Romani o per i Greci che Filippo fosse deposto e che il potere etolico rimanesse incon-trastato forse lo aveva reso moderato nei suoi progetti lrsquoaver ottenuto una vit-toria insperata
Addirittura successivamente si accenna alla sorte avversa a Filippo nel-lo scontro
τὰ μὲν δὴ παρὰ τῶν ἄλλων φιλάνθρωπα ἦν τό τε τῆς τύχης ἄδηλον ἐξ ὧν ἔπαθεν ὁ Φίλιππος ὑφορωμένων καὶ τὸ πταῖσμα τοῦτο οὐ κατ᾽ ἀσθένειαν ἀλλὰ πλέον ἐκ συντυχίας αὐτὸν παθεῖν ἡγουμένων
Gli altri (Greci) erano inclini ad essere moderati vedendo con sospetto lrsquoincer-tezza della fortuna subita da Filippo e ritenendo che egli fosse incorso in questa sconfitta non tanto per la sua inferioritagrave quanto per la sfortuna
Il riferimento in Appiano e Trogo alla fortuna romanasfortuna ma-cedone a proposito di Cinoscefale egrave una traccia dellrsquoopinione politi-ca di quei Greci disprezzati da Polibio come uomini sciocchi καθάπερ οἱ μάταιοι τῶν ἀνθρώπων Tale posizione politica su Cinoscefale sarebbe dunque sopravvissuta nella tradizione storiografica di cui troviamo trac-cia in TrogoGiustino e Appiano
Per comprendere meglio alcune caratteristiche di questa tradizione puograve essere utile tornare ai due discorsi nellrsquoEpitome di Filippo e Flamini-no prima della battaglia Tali passi probabilmente trogiani45 non trova-no infatti riscontro nelle fonti parallele a noi pervenute Polibio (XVIII 18-27) seguito fedelmente da Livio (XXXIII 5-10) pur descrivendo le operazioni di guerra di Cinoscefale con dovizia di particolari non men-ziona un discorso di Filippo ai suoi armati prima della battaglia mentre il discorso di Flaminino per incoraggiare le truppe schierate (XVIII 23 2-6) nelle Storie egrave incentrato sulle vittorie di Sulpicio nella prima parte della guerra Pare dunque originale la versione trogiana che incentra-
44 Tra i frammenti consegnatici dagli Excerpta Constantiniana sono frequenti informazio-ni e osservazioni che rimandano a una prospettiva ellenistica sugli eventi DrsquoAgostini (2011) pp 99-121 45 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362
136 MONICA DrsquoAGOSTINI
ta sulla gloria macedone presenta Cinoscefale come il punto drsquoincon-tro e di scambio tra lrsquoegemonia macedone e lrsquoegemonia romana Non egrave una novitagrave che il leitmotiv delle Storie Filippiche e dunque dellrsquoEpitome sia la translatio imperii giagrave Alonso Nuntildeez definito da Santi Amantini laquouno dei piugrave noti esperti di questioni trogiano-giustineeraquo46 osservava che Tro-go esponeva nel suo perduto lavoro la teoria della successione degli im-peri mondiali secondo lo schema Assiria-Media-Persia-Macedonia-Roma osteggiata dai Parti47 In tale successione il ruolo da protagonista egrave rico-perto dallrsquoegemonia macedone48 che occupa allrsquoincirca 26 dei 44 libri e il cui ultimo vero momento di gloria egrave lo scontro con Roma appunto a Cinoscefale Lrsquoultima impresa macedone ha come esito la transizione del dominio universale da Oriente a Occidente e costituisce il tema cen-trale dellrsquointera vicenda di Filippo lrsquoimportanza della battaglia di Cino-scefale egrave perciograve esaltata nei discorsi sia di Filippo che di Flaminino che a loro volta sono il punto di arrivo delle argomentazioni esposte nelle parole di Demetrio di Faro e di Filippo stesso giagrave nel libro XXIX Le ora-tiones disposte retoricamente nei due libri descrivono due parabole op-poste da un lato quella romana che da lontana potenza desiderosa di espandersi cresce come una pioggia di sangue diventando il giovane e vigoroso potere che sottomesso Annibale egrave pronto a sconfiggere Filip-po Dallrsquoaltro quella macedone che originata con Filippo II personag-gio centrale per Trogo raggiunge il suo apice con la conquista dellrsquoege-monia ad opera di Alessandro Magno contro i Persiani per conoscere la fine con Filippo V il cui antico valore egrave ormai troppo lsquosbiaditorsquo per te-ner testa al vigore romano
La gloria macedone secondo Trogo inizia dunque con Filippo II e si conclude con Filippo V Perseo egrave infatti il malvagio responsabile dellrsquoan-nientamento di ciograve che rimaneva della monarchia macedone49 Trogo pone agli estremi della parabola macedone che occupa dal libro IX al XXX i due re di nome Filippo Filippo II e Filippo V come ribadito in piugrave luoghi dellrsquoEpitome sia in parti riassunte da Giustino che in passi piugrave genuinamente trogiani Dando per scontato che il titolo dellrsquoopera Sto-rie Filippiche si debba al desiderio di Trogo di rifarsi allrsquoopera di Teopom-po sul sovrano macedone egrave possibile che tale titolo sia stato perograve ripen-
46 Santi Amantini (2003) pp 99-11047 laquoPompeius Trogus expounded in his lost work the Historiae Philippicae a theory of the world empire suggestion according to the scheme Assyria-Media-Persia-Macedonia-Rome opposed by the Parthiansraquo Alonso-Nuacutentildeez (2002) pp 105-110 e 133-136 partic 105 Vd anche Richter (1987) pp 19-23 Momigliano (1980) pp 157-162 Alonso-Nuacutentildeez (1992) Heckel (1997) pp 1-41 Gabba (2003) pp 7-9 Santi Amantini (2003) pp 99-110 Mariotta (2014) pp 45-56 48 Franco (1993) pp 71-97 e Landucci (2014) pp 233-26149 Alonso-Nuacutentildeez (2002) pp 105-110 partic 108-109
IL DISCORSO DEL RE 137
sato da Trogo considerando che il periodo compreso tra le imprese dei due Filippo occupa 23 dellrsquoopera50 Si potrebbe allora suggerire che le Storie sono Filippiche poicheacute i due Filippo segnarono lrsquoinizio e la fine di quella che egrave nellrsquoopera di Trogo lrsquoegemonia incontrastata del mondo piugrave gloriosa di tutti i tempi51
La prospettiva ellenistica che vede nei due Filippo i limiti della grande egemonia macedone egrave di nuovo presente anche in Appiano nellrsquooraco-lo riportato nei frammenti della sua Makedonikeacute e noto anche da Pausa-nia (VII 8 9)
αὐχοῦντες βασιλεῦσι Μακηδόνες Ἀργεάδῃσιν ὑμῖν κοιρανέων ἀγαθὸν καὶ πῆμα Φίλιππος ἤτοι ὁ μὲν πρότερος πόλεσιν λαοῖσί τ᾽ ἄνακτας θήσει ὁ δ᾽ ὁπλότερος τιμὴν ἀπὸ πᾶσαν ὀλέσσει δμηθεὶς δ᾽ ἑσπερίοισιν ὑπ᾽ ἀνδράσιν ἐνθάδ᾽ ὀλεῖται
O Macedoni che andate orgogliosi dei re di stirpe argiva I re di nome Filippo saranno arbitri del bene e del male per voi Il primo vi renderagrave signori di cittagrave e popoli il secondo vi priveragrave di ogni onore sconfitto da uomini dellrsquoOcciden-te qui giace morto52
Senza voler entrare nel merito della discussione di tale oracolo di nuo-vo pare di incontrare nei due autori la medesima prospettiva lontana dalla condanna morale del re macedone espressa da Polibio secondo cui la sconfitta egrave il giusto esito della sua crudeltagrave ed empietagrave
Il libro giustineo si conclude menzionando le condizioni della pa-ce di Tempe53 e lrsquoira degli Etoli che videro ignorate le proprie richieste da Flaminino e perciograve cercarono lrsquoalleanza di Antioco contro Roma Se-condo il Prologo XXX il libro perograve proseguiva con le campagne di Antio-co III in Asia Minore contro Molone e Acheo e in Battriana fino ad ar-rivare allrsquoesordio dello scontro con Roma54 Il riassunto giustineo egrave trop-po sommario per permettere un confronto con le fonti parallele Egrave pe-
50 Sul rilievo della storia della Macedonia nellrsquoopera di Trogo e Giustino vd von Gutsch-midt (1894) pp 17-217 Richter (1987) p 28 n 29 Franco (1993) pp 71-97 51 Vd anche Urban (1982) pp 1424-1443 e Alonso-Nuacutentildeez (1992) p 58 52 Mak Fr 2 Vd DrsquoAgostini (2011) pp 99-121 In questa Walbank (2002) pp 127-136 propone di interpretare anche un poema di Alceo di Messene (Anth Pal 9518)53 Egrave probabile che Trogo fornisse piugrave particolari riguardo a questa pace per esempio si puograve ritenere che vi fosse menzione dellrsquoinvio a Roma del figlio Demetrio da parte di Filippo come ostaggio dato che a Iust XXXII 2 3 si richiama appunto tale avvenimento54 Polyb XVIII 34 1-39 7 42 1-45 12 Liv XXXIII 11 3-13 15 24 1-31 11 Plut Flam IX 1-8 App Mak Fr IX riferiscono di due diverse trattative di pace caratterizzate da un vivace dibattito tra chi voleva lrsquoannientamento della Macedonia come in Grecia gli Etoli e a Roma Marco Claudio Marcello e coloro che desideravano la pace con la Macedonia in primis Flaminino
138 MONICA DrsquoAGOSTINI
rograve da notare la mancanza sia nel Prologo che nel testo del libro degli av-venimenti delle celebrazioni Istmie del 196 quando Flaminino procla-mograve la libertagrave dei Greci Piugrave in generale in tutta la narrazione di Giustino delle complesse trattative del 197-196 manca qualsiasi riferimento alla li-bertagrave dei Greci punto nodale nella tradizione di Polibio che con questa sottolineatura esalta sia il ruolo tirannico della Macedonia sia la grande generositagrave dei Romani nei confronti della Grecia Il silenzio di TrogoGiustino su tale questione mostra il prevedibile disinteresse per gli affari dei Greci e nel contempo conferma la presenza di una tradizione che si occupa soprattutto della storia delle monarchie ellenistiche allrsquointer-no della quale la posizione dellrsquoEllade egrave subalterna
Libro XXXII23- 34 Demetrio e Perseo
Gli ultimi anni di regno di Filippo tra il 183 e il 179 sono narrati in un passo breve del libro XXXII Il racconto in Giustino che egrave coerente con il Prologo trogiano segue in maniera sintetica la tradizione polibiana su questi eventi giunta a noi in alcuni passi lacunosi di Polibio (XXIII 1 3-3 10 7 1-7 10 1-11 8) integrati dal racconto particolareggiato di Li-vio (XXXIX 46 7- 48 6 53 1-16 XL 3 3-16 3 201-24 8) e dalla narra-zione di Diodoro (XIX 25) e Plutarco (Aem VIII 11)55
Conclusioni
In questi libri dedicati a Filippo egrave forse possibile vedere in filigrana la rielaborazione voluta di Giustino dei corrispondenti libri trogiani Co-me Giustino stesso afferma nella Prefatio 3 lrsquoopera di Trogo era costruita secondo due criteri quello cronologico e quello per laquoconcatenazione di eventi56raquo ea omnia Pompeius diuisa temporibus et serie rerum digesta conposuit
55 Lrsquoutilizzo della tradizione polibiana in Trogo egrave confermato dallrsquoaderenza a Livio (XL 54 1-56 11) e Diodoro (XXIX 28) del racconto sul pentimento di Filippo per aver ucciso il figlio Demetrio lrsquointenzione di punire Perseo e la correlazione tra questo e la sua mor-te Questo libro egrave dunque differente nellrsquointeresse e nelle fonti dai libri XXIX e XXX poicheacute molto vicino alla tradizione polibiana in Livio Questi avvenimenti in Giustino sono da collegare con lrsquoascesa al trono di Perseo e non con lrsquoepilogo della celebrazione del valore macedone giagrave conclusasi in Giustino con Cinoscefale e la transizione dallrsquoim-perium macedone allrsquoimperium romano Vd Heckel (1997) p 7 Appiano invece riporta ancora una tradizione diversa da quella polibiana in un frammento della Makedonikeacute in particolare Appiano egrave attento al punto di vista macedone e presenta Filippo come una vittima delle circostanze (Mak IX) DrsquoAgostini (2011) pp 99-12156 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362 Alonso-Nuacutentildeez (2002) pp 133-136 He-ckel (1997) pp 1-41 Borgna (2014) pp 52-77
IL DISCORSO DEL RE 139
Serie rerum digesta sembrerebbe unrsquointerpretazione latina della formula κατὰ γένος che Diodoro usa per indicare la struttura della storia di Efo-ro sottolineandone la divisione per argomento57 In tale struttura per argomento dellrsquoEpitome tra i temi principali ci sono dunque il valore e la gloria dei sovrani ellenistici58 riscontrabile nei libri XXVIII-XXXI sui re-gni di Antigono Dosone Filippo V e Antioco III Tale tema presente di sicuro in Trogo egrave conservato nellrsquoazione dellrsquoEpitomatore e anzi come si vede dagli escerpta esaltato dalla selezione dei passi
Per quanto riguarda invece la Quellenforschung 59 egrave evidente che nel testo vi sia presenza di filoni non tradizionali sugli eventi poicheacute la posi-zione di Trogo appare spesso autonoma rispetto alle opinioni condivise dalla storiografia antica Questo aspetto dellrsquoEpitome evidente soprattut-to per ciograve che riguarda gli eventi ellenistici ha suscitato la grande curio-sitagrave degli studiosi che allontanatisi dalla proposta di von Gutschmid che voleva una totale ed esclusiva dipendenza di Trogo da Timagene ora in-dicano con sicurezza tra le fonti piugrave rilevanti per gli eventi ellenistici di III secolo utilizzate da Trogo almeno altri sei nomi oltre a Timagene Ie-ronimo Timeo Filarco Duride Polibio e Posidonio
Per quanto riguarda nello specifico la composizione dei libri XXIX e XXX non vi egrave alcun dubbio che in essi Trogo abbia utilizzato (anche riadattandola) una fonte poco attenta alle questioni di politica interna greca e al legame tra queste e quel ritratto di Filippo come sovrano mal-vagio ed empio che ritorna nella tradizione ufficiale di origine polibia-na passando poi da Polibio in Livio Diodoro e Plutarco60 Trogo pre-serva invece una tradizione ellenistica interessata alla figura di Filippo come ultimo barlume della gloria macedone tradizione che pare quasi una controparte e un completamento dellrsquoAb urbe condita romanocentri-ca di Livio Non si puograve perciograve a mio avviso escludere che per questa se-zione Trogo abbia usato una tradizione di matrice filoellenistica o sem-plicemente ellenisticocentrica unrsquoopera sui regni di diadochi ed epigo-ni che a tutti noi fa venire facilmente alla mente il Basileis o Perigrave Basileon dello storico grecoellenistico augusteo filobarbaro scettico (o critico) verso lrsquoegemonia romana Timagene di Alessandria (FGrHist 88)61
57 Su Eforo vd Vannicelli (1987) pp 165-191 e ora Parmeggiani (2011) 58 Simile legame vi egrave a mio avviso tra i libri XXVI e XXVII che invece affrontavano la crisi delle monarchie ellenistiche causata dalle guerre fraterne59 Vd von Gutschmid (1894) pp 17-217 Richter (1987) pp 17-30 partic 20-23 San-ti Amantini (1972) pp 56-109 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362 Urban (1982) pp 1424-1443 partic 1435 Mecca (2001) pp 199-222 Santi Amantini (2003) pp 99-110 Heckel (2012) pp 3-860 Scuderi (2005) pp 383-40561 Sordi (1982) pp 775-797 Heckel (1997) pp 30-34 Landucci (2014) pp 233-261 e Ead in questo volume
140 MONICA DrsquoAGOSTINI
ABSTRACT
Philip V of Macedon was the first of the Epigonoi to face Rome Several mod-ern reconstructions of the actions and the reign of Philip V have approached it largely from a Roman point of view using as sources Polybius and where Poly-bius is lost Livy The Polybian historiographical tradition tends to portray Phil-ip V as an enemy and a tyrant impious and cruel The Macedonian king was ea-ger to establish a universal and unjust dominion over Greece Italy and beyond and Rome engaged in the first two Macedonian Wars to fight the threat of his growing ambition Nevertheless Polybiusrsquo portrayal of Philip V was affected not only by Polybiusrsquo admiration for Roman political structures military power and overwhelming conquest but also his personal Achaean origins
Looking at in book 29 and 30 of Justinrsquos Epitome of Pompeius Trogus this pa-per focuses on the non Polybian tradition on Philip V this contribution is in-deed the first analysis of the Hellenistic approach to the clash between Rome and Macedonia in the 3rd-2nd Century BC The Epitome shows a considerable di-versity of interpretation from the other sources and reflects very different views of Philip Vrsquos actions that brought him into conflict against Rome In particular these views are more evident related to the accounts of the peace negotiations of Naupactus and the battle of Cynoscephalae in the Epitome the king appears as a courageous and skilled warrior the last of the great Macedonian rulers who fell victim to misfortune This portrayal which has several common features with Appianrsquos fragments of Philip V (Mak 9) counterbalances the Roman and Achaean standpoint present in Polybius providing a more Hellenistic perspec-tive that is likely to have been rooted in a historiographical tradition connect-ed to the losing side in the struggle between Rome and the Hellenistic world
BIBLIOGRAFIA
Adler E (2006) Whorsquos Antiroman Sallust and Pompeius Trogus on Mithridates CJ 101 pp 383-407
Adler E (2011) Valorizing the Barbarians Enemy speeches in Roman Historiography Austin
Ager SL (2003) An Uneasy Balance from the Death of Seleukos to the Battle of Raph-ia in A Erskine (ed) A Companion to the Hellenistic World Oxford pp 35-50
Ager SL (2009) Roman Perspectives on Greek Diplomacy The conceptual clash Greek diplomacy of compromise and Roman Bellum Iustum in C Eilers (ed) Diplomats and Diplomacy in the Roman World Leiden-Boston pp 15-43
Alonso-Nuacutentildeez JM (1992) La Historia Universal de Pompeyo Trogo Madrid
Alonso-Nuacutentildeez JM (2002) The Idea of Universal History in Greece From Herodotus to the Age of Augustus Amsterdam
Ballesteros Pastor L (2013) Pompeyo Trogo Justino y Mitriacutedates Comentario al Epiacutetome de las Historias Filiacutepicas (3716-3881) Hildesheim-Zuumlrich-New York
IL DISCORSO DEL RE 141
Barreacute ML (1983) The God-List in the Treaty between Hannibal and Philip V of Ma-cedon a Study in Light of the Ancient Near Eastern Treaty Tradition Baltimore-Lon-don
Beck H - Eckstein A (2015) sv ldquoAratos of Sicyon (231)rdquo in I Worthington (ed) Brillrsquos New Jacoby Brill Online
Borgna A (2014) Uno sguardo originale intorno a Roma Pompeo Trogo e Giustino laquoLa Biblioteca di ClassicoContemporaneoraquo 1 pp 52-77
Cassola F (1962) I gruppi politici romani nel III secolo aC Trieste
Champion CB (1997) The Nature of Authoritative Evidence in Polybios and Agelausrsquo Speech at Naupactos TAPhA 127 pp 111-128
Champion CB (2004) Cultural Politics in Polybiusrsquo Histories Berkeley
Coppola A (1993) Demetrio di Faro un protagonista dimenticato Roma
Criscuolo L (2011) I due testamenti di Tolemeo VIII Evergete II in A Joumlrdens - J F Quack (hrsg) Aumlgypten zwischen innerem Zwist und aumluszligerem Druck Die Zeit Ptole-maios VI bis VIII Wiesbaden pp 132-150
DrsquoAgostini M (2011) Filippo V e la Storia Romana di Appiano laquoAevumraquo 85 pp 99-121
Eckstein AM (1995) Moral vision in the Histories of Polybius Berkeley
Eckstein AM (2008) Rome enters in the Greek East From Anarchy to Hierarchy in the Hellenistic Mediterranean 230-217 BC Oxford
Eckstein AM (2013) Polybius Phylarchus and Historiographical Criticism CPh 108 4 pp 314-338
Errington RM (1969) Philopoemen Oxford
Errington RM (2008) A History of the Hellenistic World 323-30 BC Malden MA-Oxford
Forni G - Angeli Bertinelli MG (1982) Pompeo Trogo come fonte di storia ANRW II 30 2 pp 1298-1362
Franco C (1993) Trogo Giustino e i successori di Alessandro in L Braccesi - A Coppola - G Cresci Marrone - C Franco (a cura di) LrsquoAlessandro di Giustino dagli antichi ai moderni Roma pp 71-97
Gabba E (2003) Introduzione in D Foraboschi - SM Pizzetti (a cura di) La successione degli imperi e delle egemonie nelle relazioni internazionali Milano pp 7-9
Golan D (1995) The Res Graeciae in Polybius Four Studies Como
Green P (1990) Alexander to Actium The Historical Evolution of the Hellenistic Age Berkeley-Los Angeles
Gutschmid von A (1894) Die beiden ersten Buumlcher des Pompeius Trogus in A von Gutschmid - F Ruumlhl (hrsg) Kleine Schriften Leipzig pp 17-217
142 MONICA DrsquoAGOSTINI
Habicht C (1995) Athen Muumlnchen
Hammond NGL (1968) Illyris Rome and Macedon in 229-205 BC JRS 58 pp 1-21
Hammond NGL (1988) The Campaign and the Battle of Cynoscephalae in 197 BC JHS 108 pp 60-82
Heckel W (1997) Introduction (Part 2) in JC Yardley - W Heckel (eds) Ju-stin Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus Books 11-12 Alexander the Great Introduction Oxford pp 1-41
Heckel W (2012) Introduction in JC Yardley - P Wheatley - W Heckel (eds) Justin Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus II Books 13-15 The Successors to Alexander the Great Oxford pp 1-8
Huss W (1976) Untersuchungen zur Auszligenpolitik Ptolemaiosrsquo IV Muumlnchen
Huss W (2001) Aumlgypten in hellenistischer Zeit 332ndash30 v Chr Muumlnchen
Intrieri M (2011) Fra dialogo e conflitto Annibale e i Greci drsquoOccidente RStudFen 37 pp 53-82
Landucci F (2014) Filippo II e le Storie Filippiche un protagonista storico e storio-grafico in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 233-261
Landucci Gattinoni F (2011) Politica e ideologia in etagrave ellenistica laquoPolitica An-ticaraquo 1 pp 89-105
Leacutevy E (1994) Le discours drsquoAgeacutelaos de Naupacte in L Aigner Foresti - A Bar-zanograve - C Bearzot - L Prandi - G Zecchini (a cura di) Federazioni e federalismo nellrsquoEuropa antica Bergamo 21-25 settembre 1992 Milano (Alle radici della casa co-mune europea 1) pp 33-50
Longaretti L (1989) Lrsquoalleanza tra Annibale e Filippo V di Macedonia RIL 123 pp 183-192
Marasco G (1979-1980) La valutazione di Tolemeo IV Filopatore nella storiografia greca laquoSilenoraquo 5-6 pp 159-182
Mari M [- Musti D - Thornton J] (2002) Polibio Storie Volume III Libri V-VI Milano
Mariotta G (2014) Geografia e Geopolitica nelle Storie Filippiche in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 45-56
McGing B (2010) Polybiusrsquo Histories New York
McGing B (2013) Youthfulness in Polybius the case of Philip V of Macedon in B Gibson - T Harrison (eds) Polybius and his world Oxford pp 181-199
Meadows A (2013) Polybius Aratus and the History of the 140th Olympiad in B
IL DISCORSO DEL RE 143
Gibson - T Harrison (eds) Polybius and his World Essays in Honour of Frank Walbank Oxford pp 91-116
Mecca A (2001) Trogo Timagene e Polieno QS 54 pp 199-222
Meister K (1990) Die Griechische Geschichtsschreibung von den Anfaumlngen bis zum Ende des Hellenismus Stuttgart
Misch G (1949) Geschichte der Autobiographie I Frankfurt am Mein
Momigliano A (1980) Daniele e la teoria greca della successione degli imperi RAL 35 pp 157-162
Muccioli F (2013) Gli epiteti ufficiali dei re ellenistici Stuttgart (Historia Einzel-schriften 224)
Musti D (1978) Polibio e lrsquoimperialismo romano Napoli
Parmeggiani G (2011) Eforo di Cuma studi di storiografia greca Bologna
Peacutedech P (1964) La meacutethode historique de Polybe Paris
Pelling CBR [- Scardigli B - Manfredini M](1997) Plutarco Vite parallele Filopemene Tito Flaminino Milano
Richter H-D (1987) Untersuchungen zur hellenistischen Historiographie die Vorla-gen des Pompeius Trogus fuumlr die Darstellung der nachalexandrischen hellenistischen Ge-schichte (Iust 13-40) Frankfurt
Santi Amantini L (1972) Fonti e valore storico di Pompeo Trogo (Iustin XXXV e XXXVI) Genova
Santi Amantini L (1981) (a cura di) Giustino Storie Filippiche Epitome da Pom-peo Trogo Milano
Santi Amantini L (2003) Il tempo e i tempi nelle Storie Filippiche di Pompeo Tro-go RSA 33 pp 99-110
Schepens G (1983) Les rois ptolegravemaiumlques et lrsquohistoriographie Reacuteflexions sur la trans-formation de lrsquohistoire politique in E vanrsquot Dack - P van Dessel - W Van Gucht (eds) Egypt and the Hellenistic World Proceedings of the International Collo-quium Leuven 24-26 May 1982 Leuven (Studia Hellenistica 27) pp 351-368
Schlicher JJ (1933) Non-Assertive Elements in the Language of the Roman Histo-rians CPh 28 289-300
Schmitt T (1989) Die Bedeutung des zweiten Punischen Krieges fuumlr den Frieden in Naupaktos in H Devijver - E Lipinski (eds) Punic wars Proceedings of the Conference held in Antwerp from the 23th to the 26th of November 1988 in Cooperation with the Departement of History of the laquoUniversitait Antwerpenraquo UFSIA Leuven (Studia Phoenicia 10) pp 229-239
Scholten JB (2000) The Politics of Plunder Aitolians and their koinon in the early Hellenistic Era Berkeley
144 MONICA DrsquoAGOSTINI
Scuderi R (2005) Filippo V e Perseo nei frammenti diodorei in C Bearzot - F Lan-ducci (a cura di) Diodoro e lrsquoaltra Grecia Macedonia Occidente Ellenismo nella Bi-blioteca Storica Atti del convegno Milano 15-16 gennaio 2004 Milano pp 383-405
Sklenaacuter RJ (2004) Sources and Individuality in Two Passages of Livy laquoHistoriaraquo 53 pp 302-310
Sordi M (1982) Timagene di Alessandria Uno storico ellenocentrico e filobarbaro ANRW II 30 1 pp 775-797
Thornton J (2014) Le guerre macedoniche Roma
Urban R (1979) Wachstum und Kriese des achaumlischen Bundes Quellenstudien zur entwicklung des Bundes von 280 bis 222 V Chr Wiesbaden
Urban R (1982) laquoGallisches Bewusstseinraquo und laquoRomkritikraquo bei Pompeius Trogus ANRW II 30 2 pp 1424-1443
Vannicelli P (1987) Lrsquoeconomia delle Storie di Eforo RFIC 115 pp 165-191
Vattuone R (2014) Giustino e lrsquoOccidente greco I VI-V secolo aC in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 261-277
Vollmer D (1990) Symploke das Uumlbergreifen der roumlmischen Expansion auf den grie-chischen Osten Untersuchungen zur roumlmischen Aussenpolitik am Ende des 3 Jh V Chr Stuttgart
Walbank FW (1957) A Historical Commentary on Polibius I Oxford
Walbank FW (1967) A Historical Commentary on Polybius II Oxford
Walbank FW (1933) Aratos of Sicyon Cambridge
Walbank FW (2002) Η ΤΩΝ ΟΛΩΝ ΕΛΠΙΣ and the Antigonids in FW Walbank (ed) Polybius Rome and the Hellenistic World Essays and Reflections West Nyack NY pp 127-136
Weber G (1997) Interaktion Repraumlsentation und Herrschaft Der Koumlnigshof im Hel-lenismus in A Winterling (hrsg) Zwischen lsquoHausrsquo und lsquoStaatrsquo antike Houmlfe im Ver-gleich Munich pp 27-72
Will E (19822) Histoire politique du Monde Helleacutenistique II Nancy
Zecchini G (1990) La storiografia lagide in H Verdin - G Schepens - E De Keyser (eds) Purposes of History Studies in Greek Historiography from the 4th to the 2nd Centuries BC Proceedings of the International Colloquium of Leuven 24-26 May 1988 Leuven (Studia Hellenistica 30) pp 213-232
Zecchini G (2003) Polibio e la tradizione orale in A Casanova - P Desideri (a cura di) Evento racconto scrittura nellrsquoantichitagrave classica Firenze pp 123-141
Finito di stamparenel mese di novembre 2015
da LegoDigit srlLavis (TN)
MONICA DrsquoAGOSTINI
Il discorso del Re Filippo V in Giustino
Introduzione
Le vicissitudini del reame antigonide durante il regno di Filippo V sono trattate principalmente nei libri XXIX e XXX delle Epitome delle Storie Fi-lippiche di Pompeo Trogo Alle notizie contenute in questi libri si aggiungo-no la breve menzione dellrsquoascesa al trono del sovrano nel libro XXVIII (3 9 e 4 16) e la descrizione degli eventi relativi alla sua morte nel libro XXXII (2 3- 3 4)
Egrave chiaro dal confronto tra i Prologi e lrsquoEpitome che ampie parti dei due libri trogiani sono state omesse in Giustino in particolare quelle ineren-ti agli avvenimenti orientali poicheacute nec cognoscendi voluptate iucunda nec exemplo erant necessaria (Praefatio 4) le origini di Creta e gli scontri tra Fi-lippo e Attalo nel libro XXIX la spedizione di Filippo in Asia e le cam-pagne di Antioco III nel libro XXX
Degli eventi dei libri XXIX e XXX sono invece menzionati in forma di riassunto da Giustino i piugrave importanti scontri militari tra Roma e Fi-lippo Nella categoria dei passi lsquoepitomatirsquo rientrano la Guerra degli Al-leati la Prima Guerra Macedonica la Seconda Guerra Macedonica Ci-noscefale e le rispettive trattative di pace ovvero Naupatto Fenice Tem-pe Quando ci si trova di fronte a tali riassunti egrave spesso difficile un con-fronto puntuale con le altre tradizioni pur con lrsquoaiuto dei Prologi
Gli eventi che ricevono attenzione nei libri XXIX e XXX sono sele-zionati secondo il criterio giustineo del cosiddetto lsquoflorilegiorsquo1 ovvero per cognitione quaeque dignissima (Praefatio 4)2 Piugrave vicini allrsquooriginale tro-giano e dunque piugrave excerpta che sintesi sono da ritenersi probabilmente i passi del libro XXIX sullrsquoalleanza tra Annibale e Filippo e sulla politica filoromana di Filopemene e quelli del libro XXX sulle questioni amo-
1 Vattuone (2014) pp 261-2772 I criteri per la distinzione dei passi piugrave vicini a Trogo e quelli invece riassunti da Giustino sono stati discussi autorevolmente allrsquointerno di questo progetto da Vattuone (2014) pp 261-277 Sul rapporto tra lrsquoopera di Trogo e lrsquoEpitome vd anche recentemente Heckel (1997) pp 1-41 e Id (2012) pp 1-8 e Borgna (2014) pp 52-77
122 MONICA DrsquoAGOSTINI
rose di Tolemeo III sul patto tra Antioco e Filippo e sullrsquoira degli Eto-li che nel 196 non videro appagata la richiesta di annientare la Macedo-nia Questi passi si prestano maggiormente a un confronto con le fonti parallele bencheacute con prudenza
Centrali nei due libri sono i cinque discorsi in oratio obliqua il primo egrave quello attribuito a Demetrio di Faro seguono tre di Filippo V men-tre lrsquoultimo egrave di Flaminino Poicheacute secondo Giustino (XXXVIII 3 11) Trogo utilizzava solamente lrsquooratio obliqua e avrebbe criticato aspramen-te Sallustio e Livio per lrsquoimpiego di numerosi discorsi in oratio recta i cin-que riportati nei libri XXIX e XXX sono stati considerati trasposizioni dellrsquooriginale trogiano3 In effetti tali discorsi fungono da ossatura del percorso narrativo dei due libri e sono da considerare le sezioni di que-sti libri piugrave vicine allrsquooriginale trogiano Sono perciograve i passi che offrono maggior possibilitagrave di studio per mettere in luce la presenza o lrsquoassen-za di una tradizione alternativa su Filippo V se questa sia giagrave in Trogo e quanto in quale modo e con quale interesse Giustino abbia interpolato tale tradizione Data la complessitagrave dei due libri ritengo opportuno ana-lizzare gli avvenimenti trattati seguendo la divisione in capitoli giustinea
Libro XXIX11-11 Introduzione
Il primo capitolo del libro XXIX si presenta con precisione nei riferi-menti coerenza testuale e attenzione ai dettagli Giustino probabilmen-te ricalcando le riflessioni di Trogo alla considerazione incipitale sul ge-nerale rinnovamento dei vertici degli imperi di lsquotutto il mondorsquo alla fine del III secolo aC fa seguire la lista dei nuovi re con alcuni commenti relativi ai singoli monarchi In particolare si sottolinea la giovane etagrave di tutti i sovrani e i condottieri al momento della loro ascesa al potere os-servazione ribadita nel commento finale al capitolo (XXIX 1 8)
His regibus pueris tametsi nulli senioris aetatis rectores erant tamen in suorum quisque maiorum uestigia intentis magna indoles uirtutis enituit
Questi re fanciulli sebbene non avessero guide di etagrave piugrave anziana tuttavia se-
3 Schlicher (1933) pp 289-300 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362 partic 1309 Adler (2006) pp 383-407 e Id (2011) pp 37-40 Recentemente Ballesteros Pastor (2013) pp 52-54 commentando il discorso di Mitridate (XXXVIII 4-7) ha ritenuto che Giustino abbia dichiarato il falso a proposito dellrsquooratio obliqua a suo avviso in Trogo ci sarebbero stati infatti numerosi discorsi diretti che poi Giustino avrebbe tragravedito come discorsi indiretti nellrsquoEpitome inserendo nel passaggio alcuni errori sintattici e incon-gruenze
IL DISCORSO DEL RE 123
guirono ciascuno con impegno le orme degli antenati e in loro rifulse un gran-de innato valore4
Questa introduzione sembra modellata sul cosiddetto lsquosecondo proe-miorsquo di Polibio (IV 2) la lista dei sovrani e lrsquoordine coincidono infatti con quello del Megalopolitano se non per lrsquoesclusione dellrsquousurpatore seleucide Acheo5 Lrsquointenzione del passo nelle due opere egrave perograve diver-sa mentre il Megalopolitano nel proemio metteva in risalto il sorgere quasi in contemporanea di nuovi conflitti in diverse parti del Mediter-raneo nellrsquoEpitome il filo conduttore di questo elenco di sovrani e con-dottieri egrave la loro gloria e la grandezza degli eventi che essi compirono in giovane etagrave6 Inoltre vi sono in Trogo alcune notizie originali rispetto al Megalopolitano il fatto che lrsquoepiteto Filopatore di Tolemeo IV sia mes-so in relazione con lrsquoassassinio dei genitori del sovrano oppure che lrsquoa-scesa di Annibale al comando dei Cartaginesi sia spiegata con il suo odio per i Romani Entrambe queste notizie non appartengono alla tradizio-ne polibiana in Polibio (II 36 3) Annibale era stato eletto comandante dellrsquoesercito in Spagna per i successi ottenuti mentre il padre Amilcare gli aveva fatto giurare odio eterno ai Romani Per quanto riguarda il Fi-lopatore Polibio ritiene che egli non abbia assassinato la madre Bereni-ce vittima invece del consigliere Sosibio (Polyb V 36 1)7 La versione di Trogo egrave dunque frutto di una propaganda avversa a Tolemeo IV che lo dipinge ancora piugrave negativamente di quanto fatto dalla tradizione poli-biana che certo giagrave non era favorevole al sovrano8
NellrsquoEpitome di Giustino segue una sintesi dei primi anni di regno di Filippo V in particolare vi egrave un brevissimo riferimento allrsquoinaspettata vit-toria del sovrano contro i Dardani che lo avrebbe portato a cercare lo
4 La traduzione di Giustino come tutte quelle presenti nel testo sono da Santi Amantini (1981) Lrsquounica eccezione a questa affermazione egrave il Filopatore Sulla tradizione storio-grafica avversa al Filopatore vd infra 5 Acheo egrave personaggio noto a Trogo che lo menziona altrove Prol XXX6 La giovinezza in TrogoGiustino egrave percepita come un valore aggiunto mentre per Poli-bio egrave una debolezza Eckstein (1995) p 143 McGing (2013) pp 181-1997 Muccioli (2013) pp 220-223 osserva che lrsquoepiteto fu assunto da Tolemeo IV quando il padre era vivo come strumento per sottolineare la sua predestinazione al trono 8 Polyb V 34 3-5 come anche Plut Cleom 33-34 forniscono notizie denigratorie su Tole-meo IV che sarebbe stato un sovrano inadatto a governare Secondo Huss (1976) pp 9 e 19 e (2001) pp 381-472 alla base vi sarebbe Filarco Se invece si considerano gli studi fatti su Tolemeo di Megalopoli da Schepens (1983) pp 351-368 e Zecchini (1990) pp 213-232 partic 218 egrave possibile che Tolemeo di Megalopoli nello scrivere unrsquoopera sto-riografica su un sovrano lagide non omettesse di menzionare notizie meno celebrative come Teopompo prima di lui aveva fatto nei confronti di Filippo II Sulla tradizione storiografica avversa a Tolemeo IV vd anche Marasco (19791980) pp 159-182 Weber (1997) pp 27ndash72 partic 28 Ager (2003) pp 35-50 McGing (2010) pp 117-119 Cri-scuolo (2011) pp 132-150 partic 148-149
124 MONICA DrsquoAGOSTINI
scontro con gli Etoli Egrave difficile dire se Trogo dedicasse piugrave spazio alla narrazione degli eventi tra il 220 e il 217 Nel Prologo si legge
Undetricensimo volumine continentur haec Res gestae Philippi regis adversus Dardanos et Aetolos repetitaeque inde Creticae origines post cuius insulae societatem Philippus cum Illyriis et Dardanis et rursus Aetolis bello congressus est adiuvantibus Aetolos Romanis quo finito intulit Attalo bellum
Il ventinovesimo libro contiene le imprese del re Filippo contro i Dardani e gli Etoli Sono quindi rievocate le origini di Creta dopo essersi alleato con questrsquoi-sola Filippo si scontrograve in guerra con gli Illiri i Dardani e di nuovo con gli Eto-li mentre i Romani soccorrevano gli Etoli Terminata questa guerra Filippo at-taccograve Attalo
Dal confronto tra Giustino e i Prologi egrave evidente che quella che per i mo-derni egrave la lsquoGuerra degli Alleatirsquo tra Etoli aiutati da Sparta e dallrsquoElide e la Lega Achea alleata di Filippo V sia ridotta sia in Giustino che in Tro-go a una guerra di Filippo contro gli Etoli Colpisce in effetti la comple-ta mancanza nel Prologo XXIX e nellrsquoEpitome del libro di qualsiasi men-zione e riferimento alla Lega Achea e al suo leader Arato protagonisti indiscussi invece nelle Storie polibiane dei primi anni di regno di Filippo V 9 Arato di Sicione importante statista e comandante militare della Le-ga Achea fu uno dei primi personaggi politici a scrivere e pubblicare le proprie memorie (FGrHist 231) di cui Polibio si servigrave ampiamente (I 3 1)10 Lo storico di Megalopoli era un compatriota di Arato e come lui ricoprigrave importanti cariche allrsquointerno della Lega Achea11 Polibio che considerava Arato uno dei fondatori della Lega vedeva in lui una sorta di eroe e leader ideale come emerge dalla descrizione che ne fa di uomo perfetto per lrsquoattivitagrave politica astuto tollerante coraggioso e di succes-so (IV 7 11-8 12) Il rapporto tra Filippo V e Arato egrave determinante per il giudizio di Polibio sul sovrano macedone Filippo egrave infatti descritto co-me un buon sovrano valoroso ma troppo giovane che nei primi anni di regno agigrave bene poicheacute ascoltograve e seguigrave i consigli di Arato (IV 77 1-4)12
Per quanto argumentum e silentio questa assenza di Arato di Sicione e della Lega Achea sia nel Prologo di Trogo che nellrsquoEpitome di Giustino
9 Polibio dedica alla Lega Achea ampia parte dei libri IV e V 10 Riguardo ad Arato di Sicione soprattutto nel rapporto con Polibio vd Meadows (2013) pp 91-116 Vd anche Walbank (1933) Misch (1949) pp 210-212 Urban (1979) Meister (1990) pp 187-189 Habicht (1995) pp 176-179 Beck - Eckstein (2015) sv laquoAratos of Sicyon (231)raquo in BNJ11 Sui legami di Polibio e la sua famiglia con la Lega Achea vd Eckstein (2013) pp 314-33812 Polyb IV 24 1-3 e V 26 6 seguito da Plut Arat 48-49 afferma esplicitamente che il re portava a termine abilmente i suoi piani poicheacute Arato era al suo fianco
IL DISCORSO DEL RE 125
non solo non puograve passare inosservata ma deve indurre i moderni a du-bitare per questi eventi di unrsquoapparente dipendenza diretta giagrave di Tro-go da Polibio
21- 38 Demetrio di Faro e Naupatto
Scomparso Arato nellrsquoEpitome XXIX ha invece un ruolo fondamentale in questi anni come consigliere di Filippo Demetrio di Faro a cui egrave at-tribuito il primo discorso in oratio obliqua dei due libri esaminati13
Demetrio di Faro era un dinasta illirico che si incontra per la prima volta nelle fonti storiografiche in occasione della prima guerra di Ro-ma in Illiria nel 229 Sappiamo infatti da Polibio (II 10 8-11 4) e Appia-no (Illyr 7) che Demetrio giagrave alleato di Teuta sovrana degli Illiri aveva scelto di passare dalla parte romana ed era stato poi ricompensato dal Senato con il controllo di parte dei territori sottratti da Roma a Teuta stessa Nei suoi tentativi di ritagliarsi un ruolo importante nella penisola balcanica Demetrio nel 222 si era alleato con la Lega Ellenica di Doso-ne e Arato a Sellasia contro Cleomene (Polyb II 65 2- 5) ma negli an-ni successivi le sue scorribande nellrsquoAdriatico allarmarono Roma che gli mosse guerra (Polyb III 16 IV 16)14 Sconfitto da Roma e cacciato da Faro Demetrio si rifugiograve alla corte di Filippo intorno al 218 diventan-do consigliere del re
Poicheacute nel Prologo XXVIII si legge laquoIn una digressione egrave narrata la guerra illirica combattuta dai Romani contro Teuta15raquo non egrave da esclu-dere che Trogo giagrave citasse il dinasta di Faro anche se la prima menzio-ne di Demetrio in Giustino egrave a XXIX 2 1 quando il cosiddetto lsquore de-gli Illirirsquo cacciato da Lucio Emilio Paolo dallrsquoAdriatico arrivograve alla corte macedone Nel riassunto degli eventi Giustino segue piugrave da vicino Tro-go riportando il discorso del dinasta a Filippo V per convincere il sovra-no a far guerra a Roma (XXIX 2 2-6) I punti principali di tale discorso sono che i Romani aspirano a realizzare un impero universale a scapito di tutti i re laquocome se fosse cosa illecita che ci fosse un qualche re presso i confini del loro Statoraquo Perciograve Filippo V doveva prepararsi alla guerra con i Romani poicheacute laquoquanto piugrave accessibile e illustre era il suo regno tanto piugrave accaniti nemici gli sarebbero stati i Romani16raquo Demetrio vole-
13 Su questi discorsi di Demetrio vd Coppola (1993) pp 29-5114 Coppola (1993) pp 29-51 vd anche Hammond (1968) pp 1-21 Eckstein (2008) pp 41 58-60 Demetrio di Faro era presentato in Polibio come il rivale di Arato tra i consi-glieri di Filippo Polyb IX 23 9 infatti dichiara che quando il sovrano seguiva i consigli di Arato compiva grandi imprese mentre quando ascoltava Demetrio si macchiava di atti spregevoli15 Trog Prol XXVIII Dictum in excessu bellum Illyricum quod Romani gessere cum Teuta16 Iust XXIX 2 4-5 sibi quoque non aliam ob causam quam quod Italiae finitimus uidebatur
126 MONICA DrsquoAGOSTINI
va infatti cacciare i Romani dalla sponda adriatica dellrsquoIlliria territorio che avrebbe ceduto a Filippo
Il discorso di Demetrio a Filippo egrave presente anche in Polibio (V 101 8-1017) ed egrave inserito cronologicamente durante i giochi Nemei18 nel 217 subito dopo la sconfitta romana del lago Trasimeno ricordata an-che nel passo di Giustino Nel discorso polibiano Demetrio perograve sotto-linea il diritto di Filippo V ad aspirare al dominio universale a partire dallrsquoAdriatico19 mentre nel discorso trogiano Demetrio accusa i Roma-ni di aspirare ad espandersi travolgendo qualsiasi regno sul loro cammi-no Trogo nel discorso di Demetrio presenta il coinvolgimento roma-no in Oriente come una guerra di conquista che contrappone la giova-ne potenza romana allrsquolsquoillustre regnorsquo di Filippo20 prospettiva che ritor-na nel successivo discorso di Filippo V nellrsquoEpitome ma che egrave estranea al-la narrazione di Polibio
Dopo il discorso di Demetrio nellrsquoEpitome come in Polibio (V 104 1) si arriva allrsquoincontro di pace di Naupatto nel 217 che pose fine al-la Guerra degli Alleati tra Etoli Spartani ed Elei contro la lega Achea e
bellum inlatum quasi nefas esset aliquem regem iuxta imperii eorum terminos esse Sed et ipsi cauen-dum esse exemplum cuius quanto promptius nobiliusque sit regnum tanto sit Romanos acriores hostes habiturus17 Polyb V 101 8-10 ὃς καὶ λαβόμενος τῆς ἀφορμῆς ταύτης τὸν μὲν πρὸς τοὺς Αἰτωλοὺς ᾤετο δεῖν τὴν ταχίστην ἀπορρῖψαι πόλεμον ἀντέχεσθαι δὲ τῶν κατὰ τὴν Ἰλλυρίδα πραγμάτων ἠξίου καὶ τῆς εἰς Ἰταλίαν διαβάσεως [9] τὰ μὲν γὰρ κατὰ τὴν Ἑλλάδα πάντα καὶ νῦν ἤδη ποιεῖν αὐτῷ τὸ προσταττόμενον ἔφη καὶ μετὰ ταῦτα ποιήσειν Ἀχαιῶν μὲν ἐθελοντὴν εὐνοούντων Αἰτωλῶν δὲ καταπεπληγμένων ἐκ τῶν συμβεβηκότων αὐτοῖς κατὰ τὸν ἐνεστῶτα πόλεμον [10] τὴν δ᾽ Ἰταλίαν ἔφη καὶ τὴν ἐκεῖ διάβασιν ἀρχὴν εἶναι τῆς ὑπὲρ τῶν ὅλων ἐπιβολῆς ἣν οὐδενὶ καθήκειν μᾶλλον ἢ ᾽κείνῳ τὸν δὲ καιρὸν εἶναι νῦν ἐπταικότων Ῥωμαίων Trad da Mari (2002) laquoCostui allora cogliendo lrsquooccasione gli consigliograve di interrompere al piugrave presto la guerra con gli Etoli e gli chiese di impegnarsi nelle operazioni in Illiria e nellrsquoattraversamento del mare verso lrsquoItalia Disse che infatti giagrave ora tutta la Grecia eseguiva i suoi ordini e lo avrebbe fatto anche in seguito poicheacute gli Achei lo sostenevano di loro iniziativa mentre gli Etoli erano rimasti molto colpiti da quanto era loro avvenuto nella guerra in corso e aggiunse che lrsquoItalia e lrsquoattraversamento del mare in quella direzione erano lrsquoinizio di un disegno di dominio universale che a nessuno spettava piugrave che a lui ora era il momento opportu-no visto che i Romani erano stati battutiraquo18 I giochi Nemei in onore di Zeus erano giochi panellenici celebrati in Argolide negli anni pari delle Olimpiadi 19 Secondo Eckstein (1995) pp 211-212 tale aspirazione egrave connessa allrsquoincapacitagrave di mo-derazione nella vittoria del sovrano Sul concetto di dominio universale in Polibio vd Musti (1978) pp 16-18 Eckstein (2008) pp 217-220 e 372-38120 Adler (2006) pp 383-407 e (2011) pp 37-58 ha notato che i punti principali del discorso di critica allrsquoespansionismo romano di Demetrio ritornano in altri due discorsi dellrsquoEpitome quello degli Etoli (XXVIII 2 1-13) e quello di Mitridate (XXXVIII 4-7) la prioritagrave data a questi argomenti da tale reiterazione retorica indica che lrsquointeresse giagrave di Trogo se non dellae suae fontei non fosse la celebrazione dellrsquoascesa di Roma allrsquoim-pero universale come in Appiano ma piuttosto lrsquoascesa e la discesa dei regni ellenistici
IL DISCORSO DEL RE 127
Filippo V 21 Il testo giustineo omette le circostanze dellrsquoevento non si menzionano infatti esplicitamente neacute il luogo dellrsquoincontro Naupatto neacute le fasi delle trattative neacute i vari rappresentanti dei diversi fronti che vi presero parte I lunghi negoziati di pace si risolvono dunque nel discor-so di Filippo V ai rappresentanti dei fronti
Il sovrano esordisce affermando che la Grecia egrave in grande pericolo percheacute chiunque avesse vinto tra Cartaginesi e Romani sarebbe poi pas-sato in Oriente Filippo utilizza la metafora delle nubi in Occidente che avrebbero macchiato con una pioggia di sangue ogni cosa spinte dai venti di vittoria inoltre il sovrano ritiene che le guerre passate dei Gre-ci siano di poco conto se paragonate alla minaccia di uno scontro con la moltitudine che si radunava in Italia descrivendo la rabbia e il valore di questi nuovi nemici che avrebbero portato rovina ai vicini Il sovrano infine ribadisce che la Grecia era in maggior pericolo della Macedonia ma che sapeva che chi avesse vinto in Italia non avrebbe frenato la sete di vittoria Perciograve anche la Macedonia stessa doveva temere un attacco
Il discorso in Polibio di Agelao di Naupatto rappresentante e leader degli Etoli22 mostra le medesime argomentazioni attribuite in Giustino allrsquointervento di Filippo argomentazioni fondate sul metus hostilis e fina-lizzate a promuovere un nuovo ruolo della Macedonia sia in Grecia che nel Mediterraneo Orientale Agelao proponendo un nuovo program-ma politico panellenico fonda le proprie argomentazioni sul metus hosti-lis per i Cartaginesi e i Romani presentati metaforicamente come nubi che incombono da Occidente Filippo dovrebbe farsi garante della tran-quillitagrave della Grecia che agendo come unrsquounica catena di cittagrave contro i barbari diverrebbe una sicura e fedele collaboratrice della Macedonia Questo permetterebbe ai Greci di conservare il diritto di far pace o guer-ra a loro piacimento senza temere che laquoi giochi da bambini con i quali ci trastulliamo tutti vengano troncati23raquo
Nonostante sia il medesimo discorso nelle due fonti Agelao introdu-ce una forte proposta di alleanza panellenica estranea alle parole di Fi-lippo Inoltre Filippo pur utilizzando la metafora delle nubi da Occi-
21 Interessanti le osservazioni di Scholten (2000) pp 224-228 a proposito della pace che sarebbe stata cercata e sperata da entrambe le parti e non imposta da Filippo come Polibio pare lasciar intendere 22 Vd soprattutto Leacutevy (1994) pp 33-50 Su questo discorso molto dibattuto dai moderni vd anche Schmitt (1989) pp 229-239 Vollmer (1990) pp 96-107 Coppola (1993) pp 149-164 Golan (1995) pp 55-74 Champion (1997) pp 111-128 e (2004) p 55 Wal-bank (2002) pp 127-136 Eckstein (2008) pp 78-83 23 Polyb V 104 10-11 καθόλου τὰς παιδιάς ἃς νῦν παίζομεν πρὸς ἀλλήλους ἐκκοπῆναι συμβῇ πάντων ἡμῶν ἐπὶ τοσοῦτον ὥστε κἂν εὔξασθαι τοῖς θεοῖς ὑπάρχειν ἡμῖν τὴν ἐξουσίαν ταύτην καὶ πολεμεῖν ὅταν βουλώμεθα καὶ διαλύεσθαι πρὸς ἀλλήλους καὶ καθόλου κυρίους εἶναι τῶν ἐν αὑτοῖς ἀμφισβητουμένων
128 MONICA DrsquoAGOSTINI
dente presente anche nelle Storie la arricchisce con la vivida immagine di una tempesta di sangue conferendo una dimensione piugrave concreta e cruenta alla predizione infine il riferimento polibiano alle guerre dei Greci nellrsquoEpitome non riguarda piugrave le guerre tra le cittagrave e le leghe gre-che ma le guerre dei Greci con Macedoni Persiani e Galli Mentre la Grecia scompare sullo sfondo la minaccia Romana egrave meno vaga e piugrave concreta e presente che in Polibio e diventa lrsquounico argomento del di-scorso di Filippo V a Naupatto
Il discorso di Demetrio e quello di Filippo sono al centro del libro XXIX dellrsquoEpitome avendo il duplice scopo di evidenziare sia la poten-ziale aggressivitagrave dei Romani sia la grande tradizione militare della Ma-cedonia e il pieno diritto di Filippo di controllare la Grecia e lrsquoIlliria fi-no allrsquoAdriatico Se il discorso in Polibio si inseriva in un dibattito politi-co dove la Grecia e la Macedonia erano protagoniste alla pari della sce-na ellenica e internazionale nella versione che leggiamo in Trogo i ri-ferimenti alle dispute della realtagrave greca sono reinterpretati a favore di un punto di vista in cui la Macedonia egrave lrsquounico potere dellrsquoOriente gre-co Del dibattito politico di III secolo in Grecia che tanto stava a cuore a Polibio non vi egrave piugrave alcuna traccia in TrogoGiustino rimane soltanto lo scontro tra le due grandi potenze di Oriente e Occidente tra Filippo e Roma Questa prospettiva bipolare dei discorsi trogiani si ritrova nel-la conclusione del capitolo che se da un lato sottolinea ancora una vol-ta il timore di Filippo per Cartaginesi e Romani dallrsquoaltro esplicita che i Romani avevano paura dellrsquoantica gloria dei Macedoni laquovincitori dellrsquoO-rienteraquo e soprattutto di Filippo laquoinfiammato dallo zelo di emulare Ales-sandro che era ben noto come pronto alle guerre e instancabileraquo24
41-11 La Prima Guerra Macedonica
Dei prodromi della Prima Guerra Macedonica Giustino si interessa sol-tanto allrsquoalleanza antiromana tra Annibale e Filippo Questo trattato egrave noto da molte fonti secondo cui Filippo dopo aver appreso che i Roma-ni erano stati sconfitti di nuovo dai Cartaginesi a Canne nel 216 avreb-be mandato unrsquoambasceria ad Annibale per proporre unrsquoalleanza ma lrsquoambasciatore macedone sarebbe stato catturato da Roma sulla via del ritorno25
24 Iust XXIX 3 8 quippe terrebat eos et uetus Macedonum deuicti Orientis gloria et Philippus studio Alexandri aemulationis incensus quem promptum in bella industriumque cognouerant Alla gloria dei Macedoni avevamo giagrave trovato riferimento nei discorsi del libro XXVIII degli Etoli (2 12) e di Antigono Dosone (3 14) 25 Secondo Polyb VII 9 17 Filippo avrebbe aiutato Cartagine nella guerra con Roma in cambio di Corcira Epidamno e Apollonia e della restituzione a Demetrio di Faro del suo regno Inoltre Filippo e Annibale si impegnavano a soccorrersi a vicenda in caso di
IL DISCORSO DEL RE 129
A prescindere dai dettagli del fermo dellrsquoambasciatore macedone da parte romana egrave possibile fare qualche osservazione sul nesso tra questo lsquoincidentersquo diplomatico e lo scoppio della guerra Cassio Dione e Ap-piano riportano che la cattura del legato avrebbe causato una vendetta di Filippo contro i protettorati romani in Adriatico in particolare Cor-cira26 notizia assente in Polibio come in Livio e Plutarco (che da Poli-bio dipendono)27 In questi ultimi autori lrsquoattacco di Filippo in Adriati-co infatti non sarebbe legato allrsquoepisodio dellrsquoambasciatore ma alla de-cisione del sovrano di rompere con il consigliere Arato e di dare ascol-to ai cattivi consigli di Demetrio di Faro presa dopo la spedizione a Mes-sene nel 215214 La tradizione polibiana legge infatti in questi eventi la manifestazione del cambiamento dellrsquoindole di Filippo V da giusta a empia iniziata con lrsquoepisodio della stasis di Messene del 215 e compiu-ta con lrsquoassassinio di Arato del 21328 Nel libro XXIX di Giustino ben-cheacute si conservi traccia dellrsquoindole aggressiva di Filippo e del consiglio di Demetrio di Faro come prodromi dello scontro con Roma non vi sono indizi della metaboleacute del sovrano da giusto a empio e malvagio e neppu-re del ruolo che in tale cambiamento ricoprigrave lrsquoallontanamento tra Ara-to e Filippo
attacco da parte di Roma Mentre Peacutedech (1964) pp 382-383 ritiene sicura la consulta-zione a Roma di tali documenti Zecchini (2003) pp 123-141 come prima di lui Walbank (1957) I p 32 n 4 non ne egrave certo poicheacute Polibio viaggiograve proprio per poter reperire documenti e informazioni sugli eventi dove essi avvennero Altre fonti Liv XXIII 38 7 Plut Arat 51 2 Dio C XV 4 2 e App Mak Fr 1 Sul confronto delle fonti vd DrsquoAgostini (2011) pp 99-121 Sul trattato macedone-cartaginese vd Cassola (1962) pp 65-66 Wal-bank (1967) II pp 42-44 Will (19822) pp 83-84 Barreacute (1983) Longaretti (1989) pp 183-192 Golan (1995) pp 45-46 Eckstein (2008) pp 83-85 Intrieri (2011) pp 53-8226 Dio C XV 4 2 e App Mak Fr1 Filippo per vendicarsi della cattura del proprio amba-sciatore non solo attaccograve Corcira ma saputo dellrsquoarrivo di Levino durante la ritirata da Corcira saccheggiograve anche Apollonia e Orico alleate romane Levino avrebbe poi sconfit-to Filippo e recuperati gli alleati costringendo il re a bruciare le proprie navi e rientrare via terra Si riferisce a questo episodio probabilmente il Mak Fr 9 di Appiano che riporta lrsquoordine di Filippo di uccidere quanti erano sulle navi percheacute non dicessero ai Romani che le forze macedoni erano stremate DrsquoAgostini (2011) pp 99-12127 Polyb V 108-110 Liv XXIV 40 e Plut Arat 51 2 non menzionano Corcira nella narra-zione dellrsquoalleanza macedone-cartaginese e della cattura dellrsquoambasciatore Secondo Liv XXIII 38 7 lrsquoambasciatore sarebbe stato trattenuto a Roma 28 Polyb VII 11 8-11 e Plut Arat 49 1 Coppola (1993) pp 205-210 Dai frammenti di Polyb VII 10-12 e dalla narrazione di Plut Arat 49-51 sappiamo che Filippo era interve-nuto nella stasis di Messene tra oligarchici e democratici ma aveva di nascosto lasciato che i cittadini si massacrassero Una volta giunto Arato la guerra civile fu finalmente sedata ma il sovrano avrebbe voluto su consiglio di Demetrio di Faro approfittare della situazione e imporre una guarnigione nellrsquoacropoli della cittagrave che gli avrebbe conferito un vantaggio strategico per il controllo del Peloponneso Arato dissuase Filippo da per-seguire unrsquoazione militare in Peloponneso ma il re decise su consiglio di Demetrio di rivolgere la sua aggressivitagrave verso lrsquoIlliria prima e i protettorati romani Orico e Apollonia poi
130 MONICA DrsquoAGOSTINI
Dopo aver accennato alla stipula del trattato Giustino affastella ne-gli ultimi paragrafi del capitolo 4 gli eventi tra il 215 e il 205 quando Fi-lippo siglando la pace con Roma pone fine alla Prima Guerra Macedo-nica29 In particolare lrsquoEpitomatore sottolinea da un lato lrsquoingresso in guerra degli Etoli al fianco dei Romani e la successiva alleanza del preto-re Levino con Attalo dallrsquoaltro gli attacchi subiti da parte dei Dardani da Filippo oppresso dalle richieste degli Illiri Il libro dunque si chiude con Filippo in difficoltagrave aggravate dalla comparsa di Filopemene il leader degli Achei30 urtatosi con il re dei Macedoni convince la Lega Achea a staccarsi dallrsquoalleanza con la Macedonia sempre piugrave isolata Tale allon-tanamento egrave considerato da Giustino lrsquoesito di un fallito agguato a Fi-lopemene commissionato da Filippo V e dovuto al sospetto di un tradi-mento del condottiero acheo a favore di Roma Bencheacute anche Plutarco (Fil 12 2) e Pausania (VIII 50 4) menzionino il tentativo di assassinio di Filopemene da parte di Filippo la notizia dellrsquoatteggiamento filoroma-no del generale acheo non parrebbe vicino al ritratto polibiano che ve-de in Filopemene un eroe dellrsquoautonomia e dellrsquoindipendenza achea31
Libro XXX11-39 Cinoscefale
Lrsquoesordio del libro XXX introducendo il grande scontro di Cinoscefale tra Romani e Macedoni riprende la celebrazione della gloria macedo-ne argomento centrale dei discorsi del libro XXIX Con lrsquoeccezione dei primi capitoli sul deplorevole comportamento di Tolemeo IV in Egit-to32 il libro egrave infatti totalmente dedicato allo scontro tra le due potenze
29 Errington (2008) pp 185-190 La guerra egrave nota a noi soprattutto dai frammenti dei libri VIII-XI di Polibio dai passi di Liv XXIV 40 1-17 XXVI 24 1-26 4 XXVII 30 5-33 5 e XXVIII 5 1- 9 1 XXIX 12 1-15 e dalla Vita di Filopemene di Plutarco La sinteticitagrave del riassunto giustineo impedisce un puntuale paragone delle tradizioni Ad esempio la notizia dellrsquoalleanza tra Attalo e Roma sembra tornare in Liv XXVIII 5 1-4 dove perograve non troviamo Levino ma Sulpicio come rappresentante romano personaggio scompar-so in Giustino In maniera simile la pace di Fenice del 205 egrave sintetizzata in Giustino in una riga e non vi egrave traccia delle lunghe trattative che coinvolsero come mediatori anche Egitto Chio Mitilene e Atamania portarono a una prima pace separata tra Filippo e gli Etoli nel 206 e poi alla pace con Roma Le fonti parallele sono molto piugrave dettagliate anche su questi eventi Polyb XI 4 1-6 9 Liv XXVIII 5 13 e XXIX 12 8-16 e App Mak fr III Degno di nota egrave perograve il commento in Giustino secondo cui laquoi Romani erano per il momento soddisfatti di aver rinviato la guerra contro la Macedoniaraquo Lrsquointenzione ro-mana di riprendere la guerra con la Macedonia egrave infatti presente in tutte le fonti Polyb XI 6 7 Liv XXIX 1216 Dio C XVIII 9 (15) e App Mak Fr III e verragrave ripresa al libro XXX dellrsquoEpitome 30 Su Filopemene e Filippo vd Errington (1969) pp 51-69 e 83-84 vd anche Golan (1995) pp 115-132 Eckstein (2008) pp 103 e 360-36131 Pelling (1997) pp 135-13932 Lrsquoesordio del libro XXX egrave dedicato alle scabrose imprese del sovrano egiziano ovvero
IL DISCORSO DEL RE 131
dellrsquoEst e dellrsquoOvest La prima avvisaglia dellrsquoincombente guerra egrave la no-tizia dellrsquoaccordo di Filippo V e Antioco III per la spartizione dellrsquoEgitto governato dal sovrano-bambino Tolemeo V Il sovrano lagide nel 2032 chiese aiuto ai Romani che secondo TrogoGiustino gradirono la ri-chiesta drsquoaiuto percheacute cercavano pretesti per muovere guerra contro Fi-lippo A partire da Polibio numerose altre fonti ci testimoniano questo episodio mettendolo in relazione con lo scoppio della Seconda Guerra Macedonica ed esprimendo una condanna morale per lrsquoempia condotta del re antigonide che cospira contro un bambino33 al contrario nellrsquoE-pitome si esalta la potenza macedone evidenziando la paura dei Romani delle grandi imprese di Filippo (XXX 3 2)
nullius magis arma metuebant reputantibus quantum motum Pyrrhus parua Macedo-num manu in Italia fecisset quantasque res Macedones in Oriente gessissent
di nessun altro temevano maggiormente le armi poicheacute ripensavano a quanto sconvolgimento Pirro aveva provocato in Italia con una piccola schiera di Ma-cedoni e a quanto grandi imprese i Macedoni avevano compiuto in Oriente
La supremazia macedone egrave anche al centro del discorso in oratio obliqua di Filippo allrsquoincontro nel Golfo Maliaco tra i rappresentanti dei fronti coinvolti nella Seconda Guerra Macedonica34 NellrsquoEpitome infatti dopo
la Quarta Guerra Siriaca conclusa con sconfitta a Rafia contro Antioco III nel 217 e la corruzione del sovrano da parte di Agatocle e della sorella una cortigiana che avrebbe sedotto il re Giustino riferisce poi la morte del sovrano nel 204 e lrsquoascesa al trono del piccolo Tolemeo V Epifane sovrano sotto tutela di Tlepolemo dopo la morte di Agatocle e Sosibio 33 Eckstein (2008) pp 121-180 Thornton (2014) pp 65-88 In particolare sulla relazione tra il complotto e la sconfitta antigonide e seleucidica ad opera di Roma la superioritagrave morale romana ai regni ellenistici e la causalitagrave storica in Polibio (XV 20 6) vd Eck-stein (2008) pp 133-138 Ager (2009) pp 15-43 Landucci Gattinoni (2011) pp 89-105 Secondo Polyb III 2 8 XV 20 XVI 1 8-9 seguito da Liv XXXI 14 5 Filippo avrebbe ottenuto le basi tolemaiche in Egeo Samo e la Caria mentre Antioco avrebbe finalmente avuto mano libera in Celesiria e Fenicia oggetto di quasi un secolo di lotte tra Tolemei e Seleucidi La notizia del trattato permette a Polibio di dedicare alcuni paragrafi (XV 20) a condannare aspramente lrsquooperato di Filippo V e Antioco III definendoli empi e senza pudore e dichiarando che la Fortuna punigrave i due sovrani per il loro crudele operato por-tando i Romani contro di loro vd infra App Mak Fr IV trasmette delle clausole secondo cui Antioco avrebbe avuto lrsquoEgitto e Cipro mentre Filippo avrebbe ottenuto Cirene le Cicladi e la Ionia Infine secondo Porfirio FGrHist 260 F 45 lrsquoaccordo prevedeva che i due sovrani annettessero i possedimenti tolemaici confinanti con i rispettivi regni 34 Prima si menziona unrsquoambasceria del Senato a Filippo e Antioco percheacute laquosi astenessero dallrsquoEgittoraquo e la visita di Lepido in Egitto Quindi le lamentele a Roma di Attalo e i Rodii nei confronti di Filippo Egrave probabile che a questo punto Trogo inserisse la campagna di Filippo in Asia contro Attalo menzionata nel Prologo XXX ma tagliata nellrsquoEpitome La cronologia degli scambi diplomatici precedenti la Seconda Guerra Macedonica egrave stra-volta dalla sintesi dellrsquoEpitomatore e rende impossibile qualsiasi confronto con le altre
132 MONICA DrsquoAGOSTINI
il riassunto delle ambascerie nel Mediterraneo preludio allo scontro della prima fase della guerra35 maggior spazio egrave dato al tentativo di pa-ce a Nicea tra Roma Attalo i Rodii gli Achei e gli Etoli e Filippo V nel 198 In questa occasione Filippo rivendica la posizione di dominio dei Macedoni sui Greci ereditata da Filippo II e Alessandro suoi antenati e in virtugrave di tale supremazia macedone rifiuta che i Greci gli dettino le condizioni di pace ma chiede che sia il Senato a decidere Egrave significati-vo che non solo il discorso di Filippo non compaia in nessuna delle fon-ti parallele che descrivono nel particolare le posizioni degli ambasciato-ri di Achei Etoli Rodii e Attalo ma che Polibio (XVIII 8 8)36 affermi che era difficile sapere cosa si fossero detti Filippo e Flaminino durante i colloqui nel Golfo Maliaco Secondo la tradizione polibiana infatti il sovrano accompagnato da due philoi macedoni Apollodoro e Demoste-ne chiese di allontanare dalle trattative tutti tranne i Romani e discus-se la pace solamente con Flaminino Successivamente a causa dellrsquoinca-pacitagrave di trovare un accordo Filippo chiese due mesi di tregua e lrsquointer-vento del Senato Trogo dunque restituisce il discorso che il resto della tradizione riteneva impossibile da conoscere indicando chiaramente la presenza di una fonte diversa rispetto a Polibio su questo avvenimento piugrave informata sul punto di vista di Filippo e interessata a evidenziare la convinzione di Filippo V di avere un diritto di supremazia sulla Grecia in virtugrave delle imprese di Filippo II e Alessandro
La battaglia di Cinoscefale nel 197 momento risolutivo dello scontro tra Roma e Macedonia egrave lrsquoevento principale del libro XXX omina e pre-sagi introducono lrsquoevento campale lrsquoeruzione del vulcano di Santorini
fonti In Polyb XVI 24 3 App Mak Fr IV Liv XXXI 1 10 21 5 5 Paus I 36 5-6 vi sono differenti versioni della sequenza delle ambascerie che denunciarono a Roma lrsquoe-spansionismo macedone ma tutte concordano che le ambascerie precedettero lrsquoinvio dei legati romani in Oriente e che esse furono inviate anche da Atene e dagli Etoli Inoltre secondo la tradizione polibiana (Polyb XVI 27 1-4 34 1-7 Liv XXXI 2 3 6 3-8 4 18 1-9 Diod XXVIII 6) vi furono due diverse ambascerie di cui la seconda sarebbe stato un ultimatum al sovrano recapitato da Lepido In occasione di questa seconda ambasceria avvenuta durante il cruento assedio di Abido Filippo avrebbe detto che i Macedoni in ca-so di guerra si sarebbero difesi con valore In Giustino si puograve notare che ancora una volta dagli eventi sono omesse notizie fondamentali sui Greci nello specifico lrsquoambasceria di Atene la cui disputa con gli Acarnani fu il casus belli della guerra contro Filippo 35 Come i prodromi anche la prima parte della Seconda Guerra Macedonica egrave sintetizza-ta in Giustino e occupa solamente due paragrafi Come spesso accade nei passi sintetiz-zati dallrsquoEpitomatore si trovano le incongruenze maggiori con le fonti parallele tra cui si nota soprattutto la completa omissione di Giustino delle campagne di Publio Sulpicio Galba Massimo di Villio delle vittorie di Tito e Lucio Flaminino e dellrsquoassemblea del 198 che portograve gli Achei ad allearsi con Roma Polyb XXII e Liv XXXI 14 1- 46 16 XXXII 1 1-25 12 App Mak Fr VII Plut Fil 17 4 Flam 5 4 e Paus VII 8 1-236 Le trattattive sono descritte con particolari in Polyb XVIII 1-12 seguito da Liv XXXII 32 6-36 10 e Plut Flam 5 8 e 7 1-3
IL DISCORSO DEL RE 133
nel 197 e lrsquoemergere dellrsquoisola di Hiera e in contemporanea il terremo-to a Rodi Quindi nellrsquoEpitome si annuncia che laquoil nascente impero dei Romani avrebbe divorato quello antico dei Greci e dei Macedoni37raquo Nel passo ricevono spazio soprattutto i due discorsi contrapposti del re ma-cedone Filippo e del comandante romano Flaminino pronunciati pri-ma dello scontro campale e costruiti ciascuno in modo da celebrare le imprese delle due potenze38 Lrsquoenfasi data dalla contrapposizione reto-rica delle parole dei generali egrave tale da rendere suggestiva lrsquoipotesi che lo scontro dovesse essere il momento centrale non solo del libro XXX ma forse di tutta lrsquoopera trogiana
Filippo elenca le grandi vittorie del passato dei Macedoni contro Per-siani Battriani Indiani e le popolazioni drsquoAsia fino allrsquoestremo Orien-te esortando i suoi a combattere con valore percheacute laquola libertagrave egrave piugrave cara del predominio39raquo Il discorso di Flaminino egrave invece piugrave lungo articola-to in un paragone tra Macedoni e Romani alle passate imprese di con-quista macedoni vengono contrapposte le piugrave recenti vittorie romane a Cartagine in Sicilia Italia e Spagna alla grandezza di Alessandro Ma-gno egrave contrapposta quella di Annibale che pure dai Romani era stato sconfitto Lrsquoattenzione poi si concentra su Filippo i Macedoni non laquodo-vevano essere valutati per lrsquoantica forza ma per le forze attuali40raquo poicheacute Filippo non era lrsquoinvitto e invincibile Alessandro Magno ma un ragaz-zo che non riusciva a difendere i propri confini I Macedoni rivendica-vano il valore degli antenati mentre i Romani quello dei propri soldati poicheacute quelli che erano ligrave schierati erano gli stessi che avevano sconfitto Annibale Dopo una cosigrave grandiosa introduzione la battaglia egrave descritta in uno dei paragrafi piugrave significativi di tutta lrsquoopera
His adhortationibus utrimque concitati milites proelio concurrunt alteri Orientis alteri Occidentis imperio gloriantes ferentesque in bellum alii maiorum suorum antiquam et ob-soletam gloriam alii uirentem recentibus experimentis uirtutis florem [16] Sed Macedo-nas Romana Fortuna uicit
I soldati incitati da queste esortazioni dallrsquouna e dallrsquoaltra parte si lanciaro-no nel combattimento vantandosi gli uni del dominio dellrsquoOriente gli altri dellrsquoOccidente e recando in guerra gli uni lrsquoantica e sbiadita gloria dei loro an-
37 Iust XXX 4 4 Quo prodigio territis omnibus uates cecinere oriens Romanorum imperium uetus Graecorum ac Macedonum uoraturum38 Sui discorsi precedenti la battaglia nellrsquoantichitagrave se da considerare reali o costruzioni storiografiche vd Adler (2011) pp 6-839 Iust XXX 4 7 tantoque hoc bellum fortius quam illa sustinendum quanto sit imperio libertas carior40 Iust XXX 4 10 Sed nec Macedonas ueteri fama sed praesentibus uiribus aestimandos
134 MONICA DrsquoAGOSTINI
tenati gli altri il fiore del loro valore fresco e vigoroso per le recenti prove Ma la Fortuna dei Romani vinse i Macedoni
Questo punto di vista probabilmente giagrave trogiano contrappone la virtugrave romana (virtutis flos) celebrata nei discorsi antecedenti la battaglia al-la Fortuna romana (Romana Fortuna) che decise la vittoria interpretabi-le come destino favorevole o buona stella Piugrave che unrsquoaffermazione anti-romana41 come egrave spesso stata intesa si puograve evidenziare il carattere sim-patetico della fonte verso Filippo V destinato a porre fine alla gloria di Filippo II e Alessandro e forse un approccio nostalgico verso i grandi regni macedoni la cui egravera egrave ormai giunta alla fine Tale prospettiva egrave as-sente in Polibio e nella tradizione che da lui dipende poco interessata alle vicende della gloria macedone leggendo infatti i frammenti soprav-vissuti del libro XVIII delle Storie dopo lrsquoaccurata descrizione della bat-taglia (18-33 e 34-40)42 Polibio commenta lo scontro affermando che avrebbe dedicato alcuni capitoli allrsquoesame delle strategie militari delle due armate percheacute (XVIII 28 4-6)
χρήσιμον καὶ καλὸν ἂν εἴη τὸ τὴν διαφορὰν ἐρευνῆσαι καὶ παρὰ τί συμβαίνει Ῥωμαίους ἐπικρατεῖν καὶ τὸ πρωτεῖον ἐκφέρεσθαι τῶν κατὰ πόλεμον ἀγώνων [5] ἵνα μὴ τύχην λέγοντες μόνον μακαρίζωμεν τοὺς κρατοῦντας ἀλόγως καθάπερ οἱ μάταιοι τῶν ἀνθρώπων ἀλλ᾽ εἰδότες τὰς ἀληθεῖς αἰτίας ἐπαινῶμεν καὶ θαυμάζωμεν κατὰ λόγον τοὺς ἡγουμένους
Puograve essere cosa buona e utile esaminare le differenze e per quale motivo i Ro-mani prevalgono e riportano il primo premio nelle competizioni di guerra af-fincheacute non esaltiamo i vincitori senza una ragione parlando solo di fortuna co-me fanno gli sciocchi ma conoscendo le vere cause lodiamo e ammiriamo i co-mandanti seguendo una logica
Polibio dunque sembra rispondere a coloro che parlavano della buo-na stella dei Romani sottolineando che la vittoria nasceva dalla superio-re strategia militare della legione43 Un punto di vista quindi opposto a quello espresso nellrsquoEpitome che proprio di Romana Fortuna parla e riba-dito in chiusura al passo dove Polibio critica nuovamente quei Greci che ritenevano la vittoria romana incredibile (XVIII 32 13)
41 Urban (1982) pp 1424-1443 1435 Richter (1987) p 19 n 4 Alonso-Nuacutentildeez (1992) p 66 e Id (2002) pp 105-110 partic 108-109 Contra Heckel (1997) p 29 che ridimen-siona la categorizzazione di Trogo come storico anti-romano 42 Su Cinoscefale vd Walbank (1957) ad l Hammond (1988) pp 60-82 Sklenaacuter (2004) pp 302-310 Thornton (2014) pp 83-87 43 Sulla Fortuna in Polibio vd McGing (2010) pp 195-201 (con bibliografia) che distin-gue tra quando Polibio intenda caso e quando predeterminazione fato Vd anche Green (1990) pp 400-402 e Eckstein (2008) pp 132-138
IL DISCORSO DEL RE 135
Il punto di vista di Trogo sembra invece presente nei frammenti del-la Makedonikeacute di Appiano su Filippo V44 dove ci si riferisce a Cinoscefale come a una vittoria insperata (Mak 9 1)
ἡγούμενος δ᾽ οὔτε Ῥωμαίοις συμφέρειν οὔτε τοῖς Ἕλλησι Φιλίππου καθαιρεθέντος ἐπιπολάσαι τὴν Αἰτωλῶν βίαν τάχα δ᾽ αὐτὸν καὶ τὸ παράδοξον τῆς νίκης ἀγαπᾶν ἐποίει
Flaminino era consapevole che non sarebbe stato vantaggioso per i Romani o per i Greci che Filippo fosse deposto e che il potere etolico rimanesse incon-trastato forse lo aveva reso moderato nei suoi progetti lrsquoaver ottenuto una vit-toria insperata
Addirittura successivamente si accenna alla sorte avversa a Filippo nel-lo scontro
τὰ μὲν δὴ παρὰ τῶν ἄλλων φιλάνθρωπα ἦν τό τε τῆς τύχης ἄδηλον ἐξ ὧν ἔπαθεν ὁ Φίλιππος ὑφορωμένων καὶ τὸ πταῖσμα τοῦτο οὐ κατ᾽ ἀσθένειαν ἀλλὰ πλέον ἐκ συντυχίας αὐτὸν παθεῖν ἡγουμένων
Gli altri (Greci) erano inclini ad essere moderati vedendo con sospetto lrsquoincer-tezza della fortuna subita da Filippo e ritenendo che egli fosse incorso in questa sconfitta non tanto per la sua inferioritagrave quanto per la sfortuna
Il riferimento in Appiano e Trogo alla fortuna romanasfortuna ma-cedone a proposito di Cinoscefale egrave una traccia dellrsquoopinione politi-ca di quei Greci disprezzati da Polibio come uomini sciocchi καθάπερ οἱ μάταιοι τῶν ἀνθρώπων Tale posizione politica su Cinoscefale sarebbe dunque sopravvissuta nella tradizione storiografica di cui troviamo trac-cia in TrogoGiustino e Appiano
Per comprendere meglio alcune caratteristiche di questa tradizione puograve essere utile tornare ai due discorsi nellrsquoEpitome di Filippo e Flamini-no prima della battaglia Tali passi probabilmente trogiani45 non trova-no infatti riscontro nelle fonti parallele a noi pervenute Polibio (XVIII 18-27) seguito fedelmente da Livio (XXXIII 5-10) pur descrivendo le operazioni di guerra di Cinoscefale con dovizia di particolari non men-ziona un discorso di Filippo ai suoi armati prima della battaglia mentre il discorso di Flaminino per incoraggiare le truppe schierate (XVIII 23 2-6) nelle Storie egrave incentrato sulle vittorie di Sulpicio nella prima parte della guerra Pare dunque originale la versione trogiana che incentra-
44 Tra i frammenti consegnatici dagli Excerpta Constantiniana sono frequenti informazio-ni e osservazioni che rimandano a una prospettiva ellenistica sugli eventi DrsquoAgostini (2011) pp 99-121 45 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362
136 MONICA DrsquoAGOSTINI
ta sulla gloria macedone presenta Cinoscefale come il punto drsquoincon-tro e di scambio tra lrsquoegemonia macedone e lrsquoegemonia romana Non egrave una novitagrave che il leitmotiv delle Storie Filippiche e dunque dellrsquoEpitome sia la translatio imperii giagrave Alonso Nuntildeez definito da Santi Amantini laquouno dei piugrave noti esperti di questioni trogiano-giustineeraquo46 osservava che Tro-go esponeva nel suo perduto lavoro la teoria della successione degli im-peri mondiali secondo lo schema Assiria-Media-Persia-Macedonia-Roma osteggiata dai Parti47 In tale successione il ruolo da protagonista egrave rico-perto dallrsquoegemonia macedone48 che occupa allrsquoincirca 26 dei 44 libri e il cui ultimo vero momento di gloria egrave lo scontro con Roma appunto a Cinoscefale Lrsquoultima impresa macedone ha come esito la transizione del dominio universale da Oriente a Occidente e costituisce il tema cen-trale dellrsquointera vicenda di Filippo lrsquoimportanza della battaglia di Cino-scefale egrave perciograve esaltata nei discorsi sia di Filippo che di Flaminino che a loro volta sono il punto di arrivo delle argomentazioni esposte nelle parole di Demetrio di Faro e di Filippo stesso giagrave nel libro XXIX Le ora-tiones disposte retoricamente nei due libri descrivono due parabole op-poste da un lato quella romana che da lontana potenza desiderosa di espandersi cresce come una pioggia di sangue diventando il giovane e vigoroso potere che sottomesso Annibale egrave pronto a sconfiggere Filip-po Dallrsquoaltro quella macedone che originata con Filippo II personag-gio centrale per Trogo raggiunge il suo apice con la conquista dellrsquoege-monia ad opera di Alessandro Magno contro i Persiani per conoscere la fine con Filippo V il cui antico valore egrave ormai troppo lsquosbiaditorsquo per te-ner testa al vigore romano
La gloria macedone secondo Trogo inizia dunque con Filippo II e si conclude con Filippo V Perseo egrave infatti il malvagio responsabile dellrsquoan-nientamento di ciograve che rimaneva della monarchia macedone49 Trogo pone agli estremi della parabola macedone che occupa dal libro IX al XXX i due re di nome Filippo Filippo II e Filippo V come ribadito in piugrave luoghi dellrsquoEpitome sia in parti riassunte da Giustino che in passi piugrave genuinamente trogiani Dando per scontato che il titolo dellrsquoopera Sto-rie Filippiche si debba al desiderio di Trogo di rifarsi allrsquoopera di Teopom-po sul sovrano macedone egrave possibile che tale titolo sia stato perograve ripen-
46 Santi Amantini (2003) pp 99-11047 laquoPompeius Trogus expounded in his lost work the Historiae Philippicae a theory of the world empire suggestion according to the scheme Assyria-Media-Persia-Macedonia-Rome opposed by the Parthiansraquo Alonso-Nuacutentildeez (2002) pp 105-110 e 133-136 partic 105 Vd anche Richter (1987) pp 19-23 Momigliano (1980) pp 157-162 Alonso-Nuacutentildeez (1992) Heckel (1997) pp 1-41 Gabba (2003) pp 7-9 Santi Amantini (2003) pp 99-110 Mariotta (2014) pp 45-56 48 Franco (1993) pp 71-97 e Landucci (2014) pp 233-26149 Alonso-Nuacutentildeez (2002) pp 105-110 partic 108-109
IL DISCORSO DEL RE 137
sato da Trogo considerando che il periodo compreso tra le imprese dei due Filippo occupa 23 dellrsquoopera50 Si potrebbe allora suggerire che le Storie sono Filippiche poicheacute i due Filippo segnarono lrsquoinizio e la fine di quella che egrave nellrsquoopera di Trogo lrsquoegemonia incontrastata del mondo piugrave gloriosa di tutti i tempi51
La prospettiva ellenistica che vede nei due Filippo i limiti della grande egemonia macedone egrave di nuovo presente anche in Appiano nellrsquooraco-lo riportato nei frammenti della sua Makedonikeacute e noto anche da Pausa-nia (VII 8 9)
αὐχοῦντες βασιλεῦσι Μακηδόνες Ἀργεάδῃσιν ὑμῖν κοιρανέων ἀγαθὸν καὶ πῆμα Φίλιππος ἤτοι ὁ μὲν πρότερος πόλεσιν λαοῖσί τ᾽ ἄνακτας θήσει ὁ δ᾽ ὁπλότερος τιμὴν ἀπὸ πᾶσαν ὀλέσσει δμηθεὶς δ᾽ ἑσπερίοισιν ὑπ᾽ ἀνδράσιν ἐνθάδ᾽ ὀλεῖται
O Macedoni che andate orgogliosi dei re di stirpe argiva I re di nome Filippo saranno arbitri del bene e del male per voi Il primo vi renderagrave signori di cittagrave e popoli il secondo vi priveragrave di ogni onore sconfitto da uomini dellrsquoOcciden-te qui giace morto52
Senza voler entrare nel merito della discussione di tale oracolo di nuo-vo pare di incontrare nei due autori la medesima prospettiva lontana dalla condanna morale del re macedone espressa da Polibio secondo cui la sconfitta egrave il giusto esito della sua crudeltagrave ed empietagrave
Il libro giustineo si conclude menzionando le condizioni della pa-ce di Tempe53 e lrsquoira degli Etoli che videro ignorate le proprie richieste da Flaminino e perciograve cercarono lrsquoalleanza di Antioco contro Roma Se-condo il Prologo XXX il libro perograve proseguiva con le campagne di Antio-co III in Asia Minore contro Molone e Acheo e in Battriana fino ad ar-rivare allrsquoesordio dello scontro con Roma54 Il riassunto giustineo egrave trop-po sommario per permettere un confronto con le fonti parallele Egrave pe-
50 Sul rilievo della storia della Macedonia nellrsquoopera di Trogo e Giustino vd von Gutsch-midt (1894) pp 17-217 Richter (1987) p 28 n 29 Franco (1993) pp 71-97 51 Vd anche Urban (1982) pp 1424-1443 e Alonso-Nuacutentildeez (1992) p 58 52 Mak Fr 2 Vd DrsquoAgostini (2011) pp 99-121 In questa Walbank (2002) pp 127-136 propone di interpretare anche un poema di Alceo di Messene (Anth Pal 9518)53 Egrave probabile che Trogo fornisse piugrave particolari riguardo a questa pace per esempio si puograve ritenere che vi fosse menzione dellrsquoinvio a Roma del figlio Demetrio da parte di Filippo come ostaggio dato che a Iust XXXII 2 3 si richiama appunto tale avvenimento54 Polyb XVIII 34 1-39 7 42 1-45 12 Liv XXXIII 11 3-13 15 24 1-31 11 Plut Flam IX 1-8 App Mak Fr IX riferiscono di due diverse trattative di pace caratterizzate da un vivace dibattito tra chi voleva lrsquoannientamento della Macedonia come in Grecia gli Etoli e a Roma Marco Claudio Marcello e coloro che desideravano la pace con la Macedonia in primis Flaminino
138 MONICA DrsquoAGOSTINI
rograve da notare la mancanza sia nel Prologo che nel testo del libro degli av-venimenti delle celebrazioni Istmie del 196 quando Flaminino procla-mograve la libertagrave dei Greci Piugrave in generale in tutta la narrazione di Giustino delle complesse trattative del 197-196 manca qualsiasi riferimento alla li-bertagrave dei Greci punto nodale nella tradizione di Polibio che con questa sottolineatura esalta sia il ruolo tirannico della Macedonia sia la grande generositagrave dei Romani nei confronti della Grecia Il silenzio di TrogoGiustino su tale questione mostra il prevedibile disinteresse per gli affari dei Greci e nel contempo conferma la presenza di una tradizione che si occupa soprattutto della storia delle monarchie ellenistiche allrsquointer-no della quale la posizione dellrsquoEllade egrave subalterna
Libro XXXII23- 34 Demetrio e Perseo
Gli ultimi anni di regno di Filippo tra il 183 e il 179 sono narrati in un passo breve del libro XXXII Il racconto in Giustino che egrave coerente con il Prologo trogiano segue in maniera sintetica la tradizione polibiana su questi eventi giunta a noi in alcuni passi lacunosi di Polibio (XXIII 1 3-3 10 7 1-7 10 1-11 8) integrati dal racconto particolareggiato di Li-vio (XXXIX 46 7- 48 6 53 1-16 XL 3 3-16 3 201-24 8) e dalla narra-zione di Diodoro (XIX 25) e Plutarco (Aem VIII 11)55
Conclusioni
In questi libri dedicati a Filippo egrave forse possibile vedere in filigrana la rielaborazione voluta di Giustino dei corrispondenti libri trogiani Co-me Giustino stesso afferma nella Prefatio 3 lrsquoopera di Trogo era costruita secondo due criteri quello cronologico e quello per laquoconcatenazione di eventi56raquo ea omnia Pompeius diuisa temporibus et serie rerum digesta conposuit
55 Lrsquoutilizzo della tradizione polibiana in Trogo egrave confermato dallrsquoaderenza a Livio (XL 54 1-56 11) e Diodoro (XXIX 28) del racconto sul pentimento di Filippo per aver ucciso il figlio Demetrio lrsquointenzione di punire Perseo e la correlazione tra questo e la sua mor-te Questo libro egrave dunque differente nellrsquointeresse e nelle fonti dai libri XXIX e XXX poicheacute molto vicino alla tradizione polibiana in Livio Questi avvenimenti in Giustino sono da collegare con lrsquoascesa al trono di Perseo e non con lrsquoepilogo della celebrazione del valore macedone giagrave conclusasi in Giustino con Cinoscefale e la transizione dallrsquoim-perium macedone allrsquoimperium romano Vd Heckel (1997) p 7 Appiano invece riporta ancora una tradizione diversa da quella polibiana in un frammento della Makedonikeacute in particolare Appiano egrave attento al punto di vista macedone e presenta Filippo come una vittima delle circostanze (Mak IX) DrsquoAgostini (2011) pp 99-12156 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362 Alonso-Nuacutentildeez (2002) pp 133-136 He-ckel (1997) pp 1-41 Borgna (2014) pp 52-77
IL DISCORSO DEL RE 139
Serie rerum digesta sembrerebbe unrsquointerpretazione latina della formula κατὰ γένος che Diodoro usa per indicare la struttura della storia di Efo-ro sottolineandone la divisione per argomento57 In tale struttura per argomento dellrsquoEpitome tra i temi principali ci sono dunque il valore e la gloria dei sovrani ellenistici58 riscontrabile nei libri XXVIII-XXXI sui re-gni di Antigono Dosone Filippo V e Antioco III Tale tema presente di sicuro in Trogo egrave conservato nellrsquoazione dellrsquoEpitomatore e anzi come si vede dagli escerpta esaltato dalla selezione dei passi
Per quanto riguarda invece la Quellenforschung 59 egrave evidente che nel testo vi sia presenza di filoni non tradizionali sugli eventi poicheacute la posi-zione di Trogo appare spesso autonoma rispetto alle opinioni condivise dalla storiografia antica Questo aspetto dellrsquoEpitome evidente soprattut-to per ciograve che riguarda gli eventi ellenistici ha suscitato la grande curio-sitagrave degli studiosi che allontanatisi dalla proposta di von Gutschmid che voleva una totale ed esclusiva dipendenza di Trogo da Timagene ora in-dicano con sicurezza tra le fonti piugrave rilevanti per gli eventi ellenistici di III secolo utilizzate da Trogo almeno altri sei nomi oltre a Timagene Ie-ronimo Timeo Filarco Duride Polibio e Posidonio
Per quanto riguarda nello specifico la composizione dei libri XXIX e XXX non vi egrave alcun dubbio che in essi Trogo abbia utilizzato (anche riadattandola) una fonte poco attenta alle questioni di politica interna greca e al legame tra queste e quel ritratto di Filippo come sovrano mal-vagio ed empio che ritorna nella tradizione ufficiale di origine polibia-na passando poi da Polibio in Livio Diodoro e Plutarco60 Trogo pre-serva invece una tradizione ellenistica interessata alla figura di Filippo come ultimo barlume della gloria macedone tradizione che pare quasi una controparte e un completamento dellrsquoAb urbe condita romanocentri-ca di Livio Non si puograve perciograve a mio avviso escludere che per questa se-zione Trogo abbia usato una tradizione di matrice filoellenistica o sem-plicemente ellenisticocentrica unrsquoopera sui regni di diadochi ed epigo-ni che a tutti noi fa venire facilmente alla mente il Basileis o Perigrave Basileon dello storico grecoellenistico augusteo filobarbaro scettico (o critico) verso lrsquoegemonia romana Timagene di Alessandria (FGrHist 88)61
57 Su Eforo vd Vannicelli (1987) pp 165-191 e ora Parmeggiani (2011) 58 Simile legame vi egrave a mio avviso tra i libri XXVI e XXVII che invece affrontavano la crisi delle monarchie ellenistiche causata dalle guerre fraterne59 Vd von Gutschmid (1894) pp 17-217 Richter (1987) pp 17-30 partic 20-23 San-ti Amantini (1972) pp 56-109 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362 Urban (1982) pp 1424-1443 partic 1435 Mecca (2001) pp 199-222 Santi Amantini (2003) pp 99-110 Heckel (2012) pp 3-860 Scuderi (2005) pp 383-40561 Sordi (1982) pp 775-797 Heckel (1997) pp 30-34 Landucci (2014) pp 233-261 e Ead in questo volume
140 MONICA DrsquoAGOSTINI
ABSTRACT
Philip V of Macedon was the first of the Epigonoi to face Rome Several mod-ern reconstructions of the actions and the reign of Philip V have approached it largely from a Roman point of view using as sources Polybius and where Poly-bius is lost Livy The Polybian historiographical tradition tends to portray Phil-ip V as an enemy and a tyrant impious and cruel The Macedonian king was ea-ger to establish a universal and unjust dominion over Greece Italy and beyond and Rome engaged in the first two Macedonian Wars to fight the threat of his growing ambition Nevertheless Polybiusrsquo portrayal of Philip V was affected not only by Polybiusrsquo admiration for Roman political structures military power and overwhelming conquest but also his personal Achaean origins
Looking at in book 29 and 30 of Justinrsquos Epitome of Pompeius Trogus this pa-per focuses on the non Polybian tradition on Philip V this contribution is in-deed the first analysis of the Hellenistic approach to the clash between Rome and Macedonia in the 3rd-2nd Century BC The Epitome shows a considerable di-versity of interpretation from the other sources and reflects very different views of Philip Vrsquos actions that brought him into conflict against Rome In particular these views are more evident related to the accounts of the peace negotiations of Naupactus and the battle of Cynoscephalae in the Epitome the king appears as a courageous and skilled warrior the last of the great Macedonian rulers who fell victim to misfortune This portrayal which has several common features with Appianrsquos fragments of Philip V (Mak 9) counterbalances the Roman and Achaean standpoint present in Polybius providing a more Hellenistic perspec-tive that is likely to have been rooted in a historiographical tradition connect-ed to the losing side in the struggle between Rome and the Hellenistic world
BIBLIOGRAFIA
Adler E (2006) Whorsquos Antiroman Sallust and Pompeius Trogus on Mithridates CJ 101 pp 383-407
Adler E (2011) Valorizing the Barbarians Enemy speeches in Roman Historiography Austin
Ager SL (2003) An Uneasy Balance from the Death of Seleukos to the Battle of Raph-ia in A Erskine (ed) A Companion to the Hellenistic World Oxford pp 35-50
Ager SL (2009) Roman Perspectives on Greek Diplomacy The conceptual clash Greek diplomacy of compromise and Roman Bellum Iustum in C Eilers (ed) Diplomats and Diplomacy in the Roman World Leiden-Boston pp 15-43
Alonso-Nuacutentildeez JM (1992) La Historia Universal de Pompeyo Trogo Madrid
Alonso-Nuacutentildeez JM (2002) The Idea of Universal History in Greece From Herodotus to the Age of Augustus Amsterdam
Ballesteros Pastor L (2013) Pompeyo Trogo Justino y Mitriacutedates Comentario al Epiacutetome de las Historias Filiacutepicas (3716-3881) Hildesheim-Zuumlrich-New York
IL DISCORSO DEL RE 141
Barreacute ML (1983) The God-List in the Treaty between Hannibal and Philip V of Ma-cedon a Study in Light of the Ancient Near Eastern Treaty Tradition Baltimore-Lon-don
Beck H - Eckstein A (2015) sv ldquoAratos of Sicyon (231)rdquo in I Worthington (ed) Brillrsquos New Jacoby Brill Online
Borgna A (2014) Uno sguardo originale intorno a Roma Pompeo Trogo e Giustino laquoLa Biblioteca di ClassicoContemporaneoraquo 1 pp 52-77
Cassola F (1962) I gruppi politici romani nel III secolo aC Trieste
Champion CB (1997) The Nature of Authoritative Evidence in Polybios and Agelausrsquo Speech at Naupactos TAPhA 127 pp 111-128
Champion CB (2004) Cultural Politics in Polybiusrsquo Histories Berkeley
Coppola A (1993) Demetrio di Faro un protagonista dimenticato Roma
Criscuolo L (2011) I due testamenti di Tolemeo VIII Evergete II in A Joumlrdens - J F Quack (hrsg) Aumlgypten zwischen innerem Zwist und aumluszligerem Druck Die Zeit Ptole-maios VI bis VIII Wiesbaden pp 132-150
DrsquoAgostini M (2011) Filippo V e la Storia Romana di Appiano laquoAevumraquo 85 pp 99-121
Eckstein AM (1995) Moral vision in the Histories of Polybius Berkeley
Eckstein AM (2008) Rome enters in the Greek East From Anarchy to Hierarchy in the Hellenistic Mediterranean 230-217 BC Oxford
Eckstein AM (2013) Polybius Phylarchus and Historiographical Criticism CPh 108 4 pp 314-338
Errington RM (1969) Philopoemen Oxford
Errington RM (2008) A History of the Hellenistic World 323-30 BC Malden MA-Oxford
Forni G - Angeli Bertinelli MG (1982) Pompeo Trogo come fonte di storia ANRW II 30 2 pp 1298-1362
Franco C (1993) Trogo Giustino e i successori di Alessandro in L Braccesi - A Coppola - G Cresci Marrone - C Franco (a cura di) LrsquoAlessandro di Giustino dagli antichi ai moderni Roma pp 71-97
Gabba E (2003) Introduzione in D Foraboschi - SM Pizzetti (a cura di) La successione degli imperi e delle egemonie nelle relazioni internazionali Milano pp 7-9
Golan D (1995) The Res Graeciae in Polybius Four Studies Como
Green P (1990) Alexander to Actium The Historical Evolution of the Hellenistic Age Berkeley-Los Angeles
Gutschmid von A (1894) Die beiden ersten Buumlcher des Pompeius Trogus in A von Gutschmid - F Ruumlhl (hrsg) Kleine Schriften Leipzig pp 17-217
142 MONICA DrsquoAGOSTINI
Habicht C (1995) Athen Muumlnchen
Hammond NGL (1968) Illyris Rome and Macedon in 229-205 BC JRS 58 pp 1-21
Hammond NGL (1988) The Campaign and the Battle of Cynoscephalae in 197 BC JHS 108 pp 60-82
Heckel W (1997) Introduction (Part 2) in JC Yardley - W Heckel (eds) Ju-stin Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus Books 11-12 Alexander the Great Introduction Oxford pp 1-41
Heckel W (2012) Introduction in JC Yardley - P Wheatley - W Heckel (eds) Justin Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus II Books 13-15 The Successors to Alexander the Great Oxford pp 1-8
Huss W (1976) Untersuchungen zur Auszligenpolitik Ptolemaiosrsquo IV Muumlnchen
Huss W (2001) Aumlgypten in hellenistischer Zeit 332ndash30 v Chr Muumlnchen
Intrieri M (2011) Fra dialogo e conflitto Annibale e i Greci drsquoOccidente RStudFen 37 pp 53-82
Landucci F (2014) Filippo II e le Storie Filippiche un protagonista storico e storio-grafico in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 233-261
Landucci Gattinoni F (2011) Politica e ideologia in etagrave ellenistica laquoPolitica An-ticaraquo 1 pp 89-105
Leacutevy E (1994) Le discours drsquoAgeacutelaos de Naupacte in L Aigner Foresti - A Bar-zanograve - C Bearzot - L Prandi - G Zecchini (a cura di) Federazioni e federalismo nellrsquoEuropa antica Bergamo 21-25 settembre 1992 Milano (Alle radici della casa co-mune europea 1) pp 33-50
Longaretti L (1989) Lrsquoalleanza tra Annibale e Filippo V di Macedonia RIL 123 pp 183-192
Marasco G (1979-1980) La valutazione di Tolemeo IV Filopatore nella storiografia greca laquoSilenoraquo 5-6 pp 159-182
Mari M [- Musti D - Thornton J] (2002) Polibio Storie Volume III Libri V-VI Milano
Mariotta G (2014) Geografia e Geopolitica nelle Storie Filippiche in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 45-56
McGing B (2010) Polybiusrsquo Histories New York
McGing B (2013) Youthfulness in Polybius the case of Philip V of Macedon in B Gibson - T Harrison (eds) Polybius and his world Oxford pp 181-199
Meadows A (2013) Polybius Aratus and the History of the 140th Olympiad in B
IL DISCORSO DEL RE 143
Gibson - T Harrison (eds) Polybius and his World Essays in Honour of Frank Walbank Oxford pp 91-116
Mecca A (2001) Trogo Timagene e Polieno QS 54 pp 199-222
Meister K (1990) Die Griechische Geschichtsschreibung von den Anfaumlngen bis zum Ende des Hellenismus Stuttgart
Misch G (1949) Geschichte der Autobiographie I Frankfurt am Mein
Momigliano A (1980) Daniele e la teoria greca della successione degli imperi RAL 35 pp 157-162
Muccioli F (2013) Gli epiteti ufficiali dei re ellenistici Stuttgart (Historia Einzel-schriften 224)
Musti D (1978) Polibio e lrsquoimperialismo romano Napoli
Parmeggiani G (2011) Eforo di Cuma studi di storiografia greca Bologna
Peacutedech P (1964) La meacutethode historique de Polybe Paris
Pelling CBR [- Scardigli B - Manfredini M](1997) Plutarco Vite parallele Filopemene Tito Flaminino Milano
Richter H-D (1987) Untersuchungen zur hellenistischen Historiographie die Vorla-gen des Pompeius Trogus fuumlr die Darstellung der nachalexandrischen hellenistischen Ge-schichte (Iust 13-40) Frankfurt
Santi Amantini L (1972) Fonti e valore storico di Pompeo Trogo (Iustin XXXV e XXXVI) Genova
Santi Amantini L (1981) (a cura di) Giustino Storie Filippiche Epitome da Pom-peo Trogo Milano
Santi Amantini L (2003) Il tempo e i tempi nelle Storie Filippiche di Pompeo Tro-go RSA 33 pp 99-110
Schepens G (1983) Les rois ptolegravemaiumlques et lrsquohistoriographie Reacuteflexions sur la trans-formation de lrsquohistoire politique in E vanrsquot Dack - P van Dessel - W Van Gucht (eds) Egypt and the Hellenistic World Proceedings of the International Collo-quium Leuven 24-26 May 1982 Leuven (Studia Hellenistica 27) pp 351-368
Schlicher JJ (1933) Non-Assertive Elements in the Language of the Roman Histo-rians CPh 28 289-300
Schmitt T (1989) Die Bedeutung des zweiten Punischen Krieges fuumlr den Frieden in Naupaktos in H Devijver - E Lipinski (eds) Punic wars Proceedings of the Conference held in Antwerp from the 23th to the 26th of November 1988 in Cooperation with the Departement of History of the laquoUniversitait Antwerpenraquo UFSIA Leuven (Studia Phoenicia 10) pp 229-239
Scholten JB (2000) The Politics of Plunder Aitolians and their koinon in the early Hellenistic Era Berkeley
144 MONICA DrsquoAGOSTINI
Scuderi R (2005) Filippo V e Perseo nei frammenti diodorei in C Bearzot - F Lan-ducci (a cura di) Diodoro e lrsquoaltra Grecia Macedonia Occidente Ellenismo nella Bi-blioteca Storica Atti del convegno Milano 15-16 gennaio 2004 Milano pp 383-405
Sklenaacuter RJ (2004) Sources and Individuality in Two Passages of Livy laquoHistoriaraquo 53 pp 302-310
Sordi M (1982) Timagene di Alessandria Uno storico ellenocentrico e filobarbaro ANRW II 30 1 pp 775-797
Thornton J (2014) Le guerre macedoniche Roma
Urban R (1979) Wachstum und Kriese des achaumlischen Bundes Quellenstudien zur entwicklung des Bundes von 280 bis 222 V Chr Wiesbaden
Urban R (1982) laquoGallisches Bewusstseinraquo und laquoRomkritikraquo bei Pompeius Trogus ANRW II 30 2 pp 1424-1443
Vannicelli P (1987) Lrsquoeconomia delle Storie di Eforo RFIC 115 pp 165-191
Vattuone R (2014) Giustino e lrsquoOccidente greco I VI-V secolo aC in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 261-277
Vollmer D (1990) Symploke das Uumlbergreifen der roumlmischen Expansion auf den grie-chischen Osten Untersuchungen zur roumlmischen Aussenpolitik am Ende des 3 Jh V Chr Stuttgart
Walbank FW (1957) A Historical Commentary on Polibius I Oxford
Walbank FW (1967) A Historical Commentary on Polybius II Oxford
Walbank FW (1933) Aratos of Sicyon Cambridge
Walbank FW (2002) Η ΤΩΝ ΟΛΩΝ ΕΛΠΙΣ and the Antigonids in FW Walbank (ed) Polybius Rome and the Hellenistic World Essays and Reflections West Nyack NY pp 127-136
Weber G (1997) Interaktion Repraumlsentation und Herrschaft Der Koumlnigshof im Hel-lenismus in A Winterling (hrsg) Zwischen lsquoHausrsquo und lsquoStaatrsquo antike Houmlfe im Ver-gleich Munich pp 27-72
Will E (19822) Histoire politique du Monde Helleacutenistique II Nancy
Zecchini G (1990) La storiografia lagide in H Verdin - G Schepens - E De Keyser (eds) Purposes of History Studies in Greek Historiography from the 4th to the 2nd Centuries BC Proceedings of the International Colloquium of Leuven 24-26 May 1988 Leuven (Studia Hellenistica 30) pp 213-232
Zecchini G (2003) Polibio e la tradizione orale in A Casanova - P Desideri (a cura di) Evento racconto scrittura nellrsquoantichitagrave classica Firenze pp 123-141
Finito di stamparenel mese di novembre 2015
da LegoDigit srlLavis (TN)
122 MONICA DrsquoAGOSTINI
rose di Tolemeo III sul patto tra Antioco e Filippo e sullrsquoira degli Eto-li che nel 196 non videro appagata la richiesta di annientare la Macedo-nia Questi passi si prestano maggiormente a un confronto con le fonti parallele bencheacute con prudenza
Centrali nei due libri sono i cinque discorsi in oratio obliqua il primo egrave quello attribuito a Demetrio di Faro seguono tre di Filippo V men-tre lrsquoultimo egrave di Flaminino Poicheacute secondo Giustino (XXXVIII 3 11) Trogo utilizzava solamente lrsquooratio obliqua e avrebbe criticato aspramen-te Sallustio e Livio per lrsquoimpiego di numerosi discorsi in oratio recta i cin-que riportati nei libri XXIX e XXX sono stati considerati trasposizioni dellrsquooriginale trogiano3 In effetti tali discorsi fungono da ossatura del percorso narrativo dei due libri e sono da considerare le sezioni di que-sti libri piugrave vicine allrsquooriginale trogiano Sono perciograve i passi che offrono maggior possibilitagrave di studio per mettere in luce la presenza o lrsquoassen-za di una tradizione alternativa su Filippo V se questa sia giagrave in Trogo e quanto in quale modo e con quale interesse Giustino abbia interpolato tale tradizione Data la complessitagrave dei due libri ritengo opportuno ana-lizzare gli avvenimenti trattati seguendo la divisione in capitoli giustinea
Libro XXIX11-11 Introduzione
Il primo capitolo del libro XXIX si presenta con precisione nei riferi-menti coerenza testuale e attenzione ai dettagli Giustino probabilmen-te ricalcando le riflessioni di Trogo alla considerazione incipitale sul ge-nerale rinnovamento dei vertici degli imperi di lsquotutto il mondorsquo alla fine del III secolo aC fa seguire la lista dei nuovi re con alcuni commenti relativi ai singoli monarchi In particolare si sottolinea la giovane etagrave di tutti i sovrani e i condottieri al momento della loro ascesa al potere os-servazione ribadita nel commento finale al capitolo (XXIX 1 8)
His regibus pueris tametsi nulli senioris aetatis rectores erant tamen in suorum quisque maiorum uestigia intentis magna indoles uirtutis enituit
Questi re fanciulli sebbene non avessero guide di etagrave piugrave anziana tuttavia se-
3 Schlicher (1933) pp 289-300 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362 partic 1309 Adler (2006) pp 383-407 e Id (2011) pp 37-40 Recentemente Ballesteros Pastor (2013) pp 52-54 commentando il discorso di Mitridate (XXXVIII 4-7) ha ritenuto che Giustino abbia dichiarato il falso a proposito dellrsquooratio obliqua a suo avviso in Trogo ci sarebbero stati infatti numerosi discorsi diretti che poi Giustino avrebbe tragravedito come discorsi indiretti nellrsquoEpitome inserendo nel passaggio alcuni errori sintattici e incon-gruenze
IL DISCORSO DEL RE 123
guirono ciascuno con impegno le orme degli antenati e in loro rifulse un gran-de innato valore4
Questa introduzione sembra modellata sul cosiddetto lsquosecondo proe-miorsquo di Polibio (IV 2) la lista dei sovrani e lrsquoordine coincidono infatti con quello del Megalopolitano se non per lrsquoesclusione dellrsquousurpatore seleucide Acheo5 Lrsquointenzione del passo nelle due opere egrave perograve diver-sa mentre il Megalopolitano nel proemio metteva in risalto il sorgere quasi in contemporanea di nuovi conflitti in diverse parti del Mediter-raneo nellrsquoEpitome il filo conduttore di questo elenco di sovrani e con-dottieri egrave la loro gloria e la grandezza degli eventi che essi compirono in giovane etagrave6 Inoltre vi sono in Trogo alcune notizie originali rispetto al Megalopolitano il fatto che lrsquoepiteto Filopatore di Tolemeo IV sia mes-so in relazione con lrsquoassassinio dei genitori del sovrano oppure che lrsquoa-scesa di Annibale al comando dei Cartaginesi sia spiegata con il suo odio per i Romani Entrambe queste notizie non appartengono alla tradizio-ne polibiana in Polibio (II 36 3) Annibale era stato eletto comandante dellrsquoesercito in Spagna per i successi ottenuti mentre il padre Amilcare gli aveva fatto giurare odio eterno ai Romani Per quanto riguarda il Fi-lopatore Polibio ritiene che egli non abbia assassinato la madre Bereni-ce vittima invece del consigliere Sosibio (Polyb V 36 1)7 La versione di Trogo egrave dunque frutto di una propaganda avversa a Tolemeo IV che lo dipinge ancora piugrave negativamente di quanto fatto dalla tradizione poli-biana che certo giagrave non era favorevole al sovrano8
NellrsquoEpitome di Giustino segue una sintesi dei primi anni di regno di Filippo V in particolare vi egrave un brevissimo riferimento allrsquoinaspettata vit-toria del sovrano contro i Dardani che lo avrebbe portato a cercare lo
4 La traduzione di Giustino come tutte quelle presenti nel testo sono da Santi Amantini (1981) Lrsquounica eccezione a questa affermazione egrave il Filopatore Sulla tradizione storio-grafica avversa al Filopatore vd infra 5 Acheo egrave personaggio noto a Trogo che lo menziona altrove Prol XXX6 La giovinezza in TrogoGiustino egrave percepita come un valore aggiunto mentre per Poli-bio egrave una debolezza Eckstein (1995) p 143 McGing (2013) pp 181-1997 Muccioli (2013) pp 220-223 osserva che lrsquoepiteto fu assunto da Tolemeo IV quando il padre era vivo come strumento per sottolineare la sua predestinazione al trono 8 Polyb V 34 3-5 come anche Plut Cleom 33-34 forniscono notizie denigratorie su Tole-meo IV che sarebbe stato un sovrano inadatto a governare Secondo Huss (1976) pp 9 e 19 e (2001) pp 381-472 alla base vi sarebbe Filarco Se invece si considerano gli studi fatti su Tolemeo di Megalopoli da Schepens (1983) pp 351-368 e Zecchini (1990) pp 213-232 partic 218 egrave possibile che Tolemeo di Megalopoli nello scrivere unrsquoopera sto-riografica su un sovrano lagide non omettesse di menzionare notizie meno celebrative come Teopompo prima di lui aveva fatto nei confronti di Filippo II Sulla tradizione storiografica avversa a Tolemeo IV vd anche Marasco (19791980) pp 159-182 Weber (1997) pp 27ndash72 partic 28 Ager (2003) pp 35-50 McGing (2010) pp 117-119 Cri-scuolo (2011) pp 132-150 partic 148-149
124 MONICA DrsquoAGOSTINI
scontro con gli Etoli Egrave difficile dire se Trogo dedicasse piugrave spazio alla narrazione degli eventi tra il 220 e il 217 Nel Prologo si legge
Undetricensimo volumine continentur haec Res gestae Philippi regis adversus Dardanos et Aetolos repetitaeque inde Creticae origines post cuius insulae societatem Philippus cum Illyriis et Dardanis et rursus Aetolis bello congressus est adiuvantibus Aetolos Romanis quo finito intulit Attalo bellum
Il ventinovesimo libro contiene le imprese del re Filippo contro i Dardani e gli Etoli Sono quindi rievocate le origini di Creta dopo essersi alleato con questrsquoi-sola Filippo si scontrograve in guerra con gli Illiri i Dardani e di nuovo con gli Eto-li mentre i Romani soccorrevano gli Etoli Terminata questa guerra Filippo at-taccograve Attalo
Dal confronto tra Giustino e i Prologi egrave evidente che quella che per i mo-derni egrave la lsquoGuerra degli Alleatirsquo tra Etoli aiutati da Sparta e dallrsquoElide e la Lega Achea alleata di Filippo V sia ridotta sia in Giustino che in Tro-go a una guerra di Filippo contro gli Etoli Colpisce in effetti la comple-ta mancanza nel Prologo XXIX e nellrsquoEpitome del libro di qualsiasi men-zione e riferimento alla Lega Achea e al suo leader Arato protagonisti indiscussi invece nelle Storie polibiane dei primi anni di regno di Filippo V 9 Arato di Sicione importante statista e comandante militare della Le-ga Achea fu uno dei primi personaggi politici a scrivere e pubblicare le proprie memorie (FGrHist 231) di cui Polibio si servigrave ampiamente (I 3 1)10 Lo storico di Megalopoli era un compatriota di Arato e come lui ricoprigrave importanti cariche allrsquointerno della Lega Achea11 Polibio che considerava Arato uno dei fondatori della Lega vedeva in lui una sorta di eroe e leader ideale come emerge dalla descrizione che ne fa di uomo perfetto per lrsquoattivitagrave politica astuto tollerante coraggioso e di succes-so (IV 7 11-8 12) Il rapporto tra Filippo V e Arato egrave determinante per il giudizio di Polibio sul sovrano macedone Filippo egrave infatti descritto co-me un buon sovrano valoroso ma troppo giovane che nei primi anni di regno agigrave bene poicheacute ascoltograve e seguigrave i consigli di Arato (IV 77 1-4)12
Per quanto argumentum e silentio questa assenza di Arato di Sicione e della Lega Achea sia nel Prologo di Trogo che nellrsquoEpitome di Giustino
9 Polibio dedica alla Lega Achea ampia parte dei libri IV e V 10 Riguardo ad Arato di Sicione soprattutto nel rapporto con Polibio vd Meadows (2013) pp 91-116 Vd anche Walbank (1933) Misch (1949) pp 210-212 Urban (1979) Meister (1990) pp 187-189 Habicht (1995) pp 176-179 Beck - Eckstein (2015) sv laquoAratos of Sicyon (231)raquo in BNJ11 Sui legami di Polibio e la sua famiglia con la Lega Achea vd Eckstein (2013) pp 314-33812 Polyb IV 24 1-3 e V 26 6 seguito da Plut Arat 48-49 afferma esplicitamente che il re portava a termine abilmente i suoi piani poicheacute Arato era al suo fianco
IL DISCORSO DEL RE 125
non solo non puograve passare inosservata ma deve indurre i moderni a du-bitare per questi eventi di unrsquoapparente dipendenza diretta giagrave di Tro-go da Polibio
21- 38 Demetrio di Faro e Naupatto
Scomparso Arato nellrsquoEpitome XXIX ha invece un ruolo fondamentale in questi anni come consigliere di Filippo Demetrio di Faro a cui egrave at-tribuito il primo discorso in oratio obliqua dei due libri esaminati13
Demetrio di Faro era un dinasta illirico che si incontra per la prima volta nelle fonti storiografiche in occasione della prima guerra di Ro-ma in Illiria nel 229 Sappiamo infatti da Polibio (II 10 8-11 4) e Appia-no (Illyr 7) che Demetrio giagrave alleato di Teuta sovrana degli Illiri aveva scelto di passare dalla parte romana ed era stato poi ricompensato dal Senato con il controllo di parte dei territori sottratti da Roma a Teuta stessa Nei suoi tentativi di ritagliarsi un ruolo importante nella penisola balcanica Demetrio nel 222 si era alleato con la Lega Ellenica di Doso-ne e Arato a Sellasia contro Cleomene (Polyb II 65 2- 5) ma negli an-ni successivi le sue scorribande nellrsquoAdriatico allarmarono Roma che gli mosse guerra (Polyb III 16 IV 16)14 Sconfitto da Roma e cacciato da Faro Demetrio si rifugiograve alla corte di Filippo intorno al 218 diventan-do consigliere del re
Poicheacute nel Prologo XXVIII si legge laquoIn una digressione egrave narrata la guerra illirica combattuta dai Romani contro Teuta15raquo non egrave da esclu-dere che Trogo giagrave citasse il dinasta di Faro anche se la prima menzio-ne di Demetrio in Giustino egrave a XXIX 2 1 quando il cosiddetto lsquore de-gli Illirirsquo cacciato da Lucio Emilio Paolo dallrsquoAdriatico arrivograve alla corte macedone Nel riassunto degli eventi Giustino segue piugrave da vicino Tro-go riportando il discorso del dinasta a Filippo V per convincere il sovra-no a far guerra a Roma (XXIX 2 2-6) I punti principali di tale discorso sono che i Romani aspirano a realizzare un impero universale a scapito di tutti i re laquocome se fosse cosa illecita che ci fosse un qualche re presso i confini del loro Statoraquo Perciograve Filippo V doveva prepararsi alla guerra con i Romani poicheacute laquoquanto piugrave accessibile e illustre era il suo regno tanto piugrave accaniti nemici gli sarebbero stati i Romani16raquo Demetrio vole-
13 Su questi discorsi di Demetrio vd Coppola (1993) pp 29-5114 Coppola (1993) pp 29-51 vd anche Hammond (1968) pp 1-21 Eckstein (2008) pp 41 58-60 Demetrio di Faro era presentato in Polibio come il rivale di Arato tra i consi-glieri di Filippo Polyb IX 23 9 infatti dichiara che quando il sovrano seguiva i consigli di Arato compiva grandi imprese mentre quando ascoltava Demetrio si macchiava di atti spregevoli15 Trog Prol XXVIII Dictum in excessu bellum Illyricum quod Romani gessere cum Teuta16 Iust XXIX 2 4-5 sibi quoque non aliam ob causam quam quod Italiae finitimus uidebatur
126 MONICA DrsquoAGOSTINI
va infatti cacciare i Romani dalla sponda adriatica dellrsquoIlliria territorio che avrebbe ceduto a Filippo
Il discorso di Demetrio a Filippo egrave presente anche in Polibio (V 101 8-1017) ed egrave inserito cronologicamente durante i giochi Nemei18 nel 217 subito dopo la sconfitta romana del lago Trasimeno ricordata an-che nel passo di Giustino Nel discorso polibiano Demetrio perograve sotto-linea il diritto di Filippo V ad aspirare al dominio universale a partire dallrsquoAdriatico19 mentre nel discorso trogiano Demetrio accusa i Roma-ni di aspirare ad espandersi travolgendo qualsiasi regno sul loro cammi-no Trogo nel discorso di Demetrio presenta il coinvolgimento roma-no in Oriente come una guerra di conquista che contrappone la giova-ne potenza romana allrsquolsquoillustre regnorsquo di Filippo20 prospettiva che ritor-na nel successivo discorso di Filippo V nellrsquoEpitome ma che egrave estranea al-la narrazione di Polibio
Dopo il discorso di Demetrio nellrsquoEpitome come in Polibio (V 104 1) si arriva allrsquoincontro di pace di Naupatto nel 217 che pose fine al-la Guerra degli Alleati tra Etoli Spartani ed Elei contro la lega Achea e
bellum inlatum quasi nefas esset aliquem regem iuxta imperii eorum terminos esse Sed et ipsi cauen-dum esse exemplum cuius quanto promptius nobiliusque sit regnum tanto sit Romanos acriores hostes habiturus17 Polyb V 101 8-10 ὃς καὶ λαβόμενος τῆς ἀφορμῆς ταύτης τὸν μὲν πρὸς τοὺς Αἰτωλοὺς ᾤετο δεῖν τὴν ταχίστην ἀπορρῖψαι πόλεμον ἀντέχεσθαι δὲ τῶν κατὰ τὴν Ἰλλυρίδα πραγμάτων ἠξίου καὶ τῆς εἰς Ἰταλίαν διαβάσεως [9] τὰ μὲν γὰρ κατὰ τὴν Ἑλλάδα πάντα καὶ νῦν ἤδη ποιεῖν αὐτῷ τὸ προσταττόμενον ἔφη καὶ μετὰ ταῦτα ποιήσειν Ἀχαιῶν μὲν ἐθελοντὴν εὐνοούντων Αἰτωλῶν δὲ καταπεπληγμένων ἐκ τῶν συμβεβηκότων αὐτοῖς κατὰ τὸν ἐνεστῶτα πόλεμον [10] τὴν δ᾽ Ἰταλίαν ἔφη καὶ τὴν ἐκεῖ διάβασιν ἀρχὴν εἶναι τῆς ὑπὲρ τῶν ὅλων ἐπιβολῆς ἣν οὐδενὶ καθήκειν μᾶλλον ἢ ᾽κείνῳ τὸν δὲ καιρὸν εἶναι νῦν ἐπταικότων Ῥωμαίων Trad da Mari (2002) laquoCostui allora cogliendo lrsquooccasione gli consigliograve di interrompere al piugrave presto la guerra con gli Etoli e gli chiese di impegnarsi nelle operazioni in Illiria e nellrsquoattraversamento del mare verso lrsquoItalia Disse che infatti giagrave ora tutta la Grecia eseguiva i suoi ordini e lo avrebbe fatto anche in seguito poicheacute gli Achei lo sostenevano di loro iniziativa mentre gli Etoli erano rimasti molto colpiti da quanto era loro avvenuto nella guerra in corso e aggiunse che lrsquoItalia e lrsquoattraversamento del mare in quella direzione erano lrsquoinizio di un disegno di dominio universale che a nessuno spettava piugrave che a lui ora era il momento opportu-no visto che i Romani erano stati battutiraquo18 I giochi Nemei in onore di Zeus erano giochi panellenici celebrati in Argolide negli anni pari delle Olimpiadi 19 Secondo Eckstein (1995) pp 211-212 tale aspirazione egrave connessa allrsquoincapacitagrave di mo-derazione nella vittoria del sovrano Sul concetto di dominio universale in Polibio vd Musti (1978) pp 16-18 Eckstein (2008) pp 217-220 e 372-38120 Adler (2006) pp 383-407 e (2011) pp 37-58 ha notato che i punti principali del discorso di critica allrsquoespansionismo romano di Demetrio ritornano in altri due discorsi dellrsquoEpitome quello degli Etoli (XXVIII 2 1-13) e quello di Mitridate (XXXVIII 4-7) la prioritagrave data a questi argomenti da tale reiterazione retorica indica che lrsquointeresse giagrave di Trogo se non dellae suae fontei non fosse la celebrazione dellrsquoascesa di Roma allrsquoim-pero universale come in Appiano ma piuttosto lrsquoascesa e la discesa dei regni ellenistici
IL DISCORSO DEL RE 127
Filippo V 21 Il testo giustineo omette le circostanze dellrsquoevento non si menzionano infatti esplicitamente neacute il luogo dellrsquoincontro Naupatto neacute le fasi delle trattative neacute i vari rappresentanti dei diversi fronti che vi presero parte I lunghi negoziati di pace si risolvono dunque nel discor-so di Filippo V ai rappresentanti dei fronti
Il sovrano esordisce affermando che la Grecia egrave in grande pericolo percheacute chiunque avesse vinto tra Cartaginesi e Romani sarebbe poi pas-sato in Oriente Filippo utilizza la metafora delle nubi in Occidente che avrebbero macchiato con una pioggia di sangue ogni cosa spinte dai venti di vittoria inoltre il sovrano ritiene che le guerre passate dei Gre-ci siano di poco conto se paragonate alla minaccia di uno scontro con la moltitudine che si radunava in Italia descrivendo la rabbia e il valore di questi nuovi nemici che avrebbero portato rovina ai vicini Il sovrano infine ribadisce che la Grecia era in maggior pericolo della Macedonia ma che sapeva che chi avesse vinto in Italia non avrebbe frenato la sete di vittoria Perciograve anche la Macedonia stessa doveva temere un attacco
Il discorso in Polibio di Agelao di Naupatto rappresentante e leader degli Etoli22 mostra le medesime argomentazioni attribuite in Giustino allrsquointervento di Filippo argomentazioni fondate sul metus hostilis e fina-lizzate a promuovere un nuovo ruolo della Macedonia sia in Grecia che nel Mediterraneo Orientale Agelao proponendo un nuovo program-ma politico panellenico fonda le proprie argomentazioni sul metus hosti-lis per i Cartaginesi e i Romani presentati metaforicamente come nubi che incombono da Occidente Filippo dovrebbe farsi garante della tran-quillitagrave della Grecia che agendo come unrsquounica catena di cittagrave contro i barbari diverrebbe una sicura e fedele collaboratrice della Macedonia Questo permetterebbe ai Greci di conservare il diritto di far pace o guer-ra a loro piacimento senza temere che laquoi giochi da bambini con i quali ci trastulliamo tutti vengano troncati23raquo
Nonostante sia il medesimo discorso nelle due fonti Agelao introdu-ce una forte proposta di alleanza panellenica estranea alle parole di Fi-lippo Inoltre Filippo pur utilizzando la metafora delle nubi da Occi-
21 Interessanti le osservazioni di Scholten (2000) pp 224-228 a proposito della pace che sarebbe stata cercata e sperata da entrambe le parti e non imposta da Filippo come Polibio pare lasciar intendere 22 Vd soprattutto Leacutevy (1994) pp 33-50 Su questo discorso molto dibattuto dai moderni vd anche Schmitt (1989) pp 229-239 Vollmer (1990) pp 96-107 Coppola (1993) pp 149-164 Golan (1995) pp 55-74 Champion (1997) pp 111-128 e (2004) p 55 Wal-bank (2002) pp 127-136 Eckstein (2008) pp 78-83 23 Polyb V 104 10-11 καθόλου τὰς παιδιάς ἃς νῦν παίζομεν πρὸς ἀλλήλους ἐκκοπῆναι συμβῇ πάντων ἡμῶν ἐπὶ τοσοῦτον ὥστε κἂν εὔξασθαι τοῖς θεοῖς ὑπάρχειν ἡμῖν τὴν ἐξουσίαν ταύτην καὶ πολεμεῖν ὅταν βουλώμεθα καὶ διαλύεσθαι πρὸς ἀλλήλους καὶ καθόλου κυρίους εἶναι τῶν ἐν αὑτοῖς ἀμφισβητουμένων
128 MONICA DrsquoAGOSTINI
dente presente anche nelle Storie la arricchisce con la vivida immagine di una tempesta di sangue conferendo una dimensione piugrave concreta e cruenta alla predizione infine il riferimento polibiano alle guerre dei Greci nellrsquoEpitome non riguarda piugrave le guerre tra le cittagrave e le leghe gre-che ma le guerre dei Greci con Macedoni Persiani e Galli Mentre la Grecia scompare sullo sfondo la minaccia Romana egrave meno vaga e piugrave concreta e presente che in Polibio e diventa lrsquounico argomento del di-scorso di Filippo V a Naupatto
Il discorso di Demetrio e quello di Filippo sono al centro del libro XXIX dellrsquoEpitome avendo il duplice scopo di evidenziare sia la poten-ziale aggressivitagrave dei Romani sia la grande tradizione militare della Ma-cedonia e il pieno diritto di Filippo di controllare la Grecia e lrsquoIlliria fi-no allrsquoAdriatico Se il discorso in Polibio si inseriva in un dibattito politi-co dove la Grecia e la Macedonia erano protagoniste alla pari della sce-na ellenica e internazionale nella versione che leggiamo in Trogo i ri-ferimenti alle dispute della realtagrave greca sono reinterpretati a favore di un punto di vista in cui la Macedonia egrave lrsquounico potere dellrsquoOriente gre-co Del dibattito politico di III secolo in Grecia che tanto stava a cuore a Polibio non vi egrave piugrave alcuna traccia in TrogoGiustino rimane soltanto lo scontro tra le due grandi potenze di Oriente e Occidente tra Filippo e Roma Questa prospettiva bipolare dei discorsi trogiani si ritrova nel-la conclusione del capitolo che se da un lato sottolinea ancora una vol-ta il timore di Filippo per Cartaginesi e Romani dallrsquoaltro esplicita che i Romani avevano paura dellrsquoantica gloria dei Macedoni laquovincitori dellrsquoO-rienteraquo e soprattutto di Filippo laquoinfiammato dallo zelo di emulare Ales-sandro che era ben noto come pronto alle guerre e instancabileraquo24
41-11 La Prima Guerra Macedonica
Dei prodromi della Prima Guerra Macedonica Giustino si interessa sol-tanto allrsquoalleanza antiromana tra Annibale e Filippo Questo trattato egrave noto da molte fonti secondo cui Filippo dopo aver appreso che i Roma-ni erano stati sconfitti di nuovo dai Cartaginesi a Canne nel 216 avreb-be mandato unrsquoambasceria ad Annibale per proporre unrsquoalleanza ma lrsquoambasciatore macedone sarebbe stato catturato da Roma sulla via del ritorno25
24 Iust XXIX 3 8 quippe terrebat eos et uetus Macedonum deuicti Orientis gloria et Philippus studio Alexandri aemulationis incensus quem promptum in bella industriumque cognouerant Alla gloria dei Macedoni avevamo giagrave trovato riferimento nei discorsi del libro XXVIII degli Etoli (2 12) e di Antigono Dosone (3 14) 25 Secondo Polyb VII 9 17 Filippo avrebbe aiutato Cartagine nella guerra con Roma in cambio di Corcira Epidamno e Apollonia e della restituzione a Demetrio di Faro del suo regno Inoltre Filippo e Annibale si impegnavano a soccorrersi a vicenda in caso di
IL DISCORSO DEL RE 129
A prescindere dai dettagli del fermo dellrsquoambasciatore macedone da parte romana egrave possibile fare qualche osservazione sul nesso tra questo lsquoincidentersquo diplomatico e lo scoppio della guerra Cassio Dione e Ap-piano riportano che la cattura del legato avrebbe causato una vendetta di Filippo contro i protettorati romani in Adriatico in particolare Cor-cira26 notizia assente in Polibio come in Livio e Plutarco (che da Poli-bio dipendono)27 In questi ultimi autori lrsquoattacco di Filippo in Adriati-co infatti non sarebbe legato allrsquoepisodio dellrsquoambasciatore ma alla de-cisione del sovrano di rompere con il consigliere Arato e di dare ascol-to ai cattivi consigli di Demetrio di Faro presa dopo la spedizione a Mes-sene nel 215214 La tradizione polibiana legge infatti in questi eventi la manifestazione del cambiamento dellrsquoindole di Filippo V da giusta a empia iniziata con lrsquoepisodio della stasis di Messene del 215 e compiu-ta con lrsquoassassinio di Arato del 21328 Nel libro XXIX di Giustino ben-cheacute si conservi traccia dellrsquoindole aggressiva di Filippo e del consiglio di Demetrio di Faro come prodromi dello scontro con Roma non vi sono indizi della metaboleacute del sovrano da giusto a empio e malvagio e neppu-re del ruolo che in tale cambiamento ricoprigrave lrsquoallontanamento tra Ara-to e Filippo
attacco da parte di Roma Mentre Peacutedech (1964) pp 382-383 ritiene sicura la consulta-zione a Roma di tali documenti Zecchini (2003) pp 123-141 come prima di lui Walbank (1957) I p 32 n 4 non ne egrave certo poicheacute Polibio viaggiograve proprio per poter reperire documenti e informazioni sugli eventi dove essi avvennero Altre fonti Liv XXIII 38 7 Plut Arat 51 2 Dio C XV 4 2 e App Mak Fr 1 Sul confronto delle fonti vd DrsquoAgostini (2011) pp 99-121 Sul trattato macedone-cartaginese vd Cassola (1962) pp 65-66 Wal-bank (1967) II pp 42-44 Will (19822) pp 83-84 Barreacute (1983) Longaretti (1989) pp 183-192 Golan (1995) pp 45-46 Eckstein (2008) pp 83-85 Intrieri (2011) pp 53-8226 Dio C XV 4 2 e App Mak Fr1 Filippo per vendicarsi della cattura del proprio amba-sciatore non solo attaccograve Corcira ma saputo dellrsquoarrivo di Levino durante la ritirata da Corcira saccheggiograve anche Apollonia e Orico alleate romane Levino avrebbe poi sconfit-to Filippo e recuperati gli alleati costringendo il re a bruciare le proprie navi e rientrare via terra Si riferisce a questo episodio probabilmente il Mak Fr 9 di Appiano che riporta lrsquoordine di Filippo di uccidere quanti erano sulle navi percheacute non dicessero ai Romani che le forze macedoni erano stremate DrsquoAgostini (2011) pp 99-12127 Polyb V 108-110 Liv XXIV 40 e Plut Arat 51 2 non menzionano Corcira nella narra-zione dellrsquoalleanza macedone-cartaginese e della cattura dellrsquoambasciatore Secondo Liv XXIII 38 7 lrsquoambasciatore sarebbe stato trattenuto a Roma 28 Polyb VII 11 8-11 e Plut Arat 49 1 Coppola (1993) pp 205-210 Dai frammenti di Polyb VII 10-12 e dalla narrazione di Plut Arat 49-51 sappiamo che Filippo era interve-nuto nella stasis di Messene tra oligarchici e democratici ma aveva di nascosto lasciato che i cittadini si massacrassero Una volta giunto Arato la guerra civile fu finalmente sedata ma il sovrano avrebbe voluto su consiglio di Demetrio di Faro approfittare della situazione e imporre una guarnigione nellrsquoacropoli della cittagrave che gli avrebbe conferito un vantaggio strategico per il controllo del Peloponneso Arato dissuase Filippo da per-seguire unrsquoazione militare in Peloponneso ma il re decise su consiglio di Demetrio di rivolgere la sua aggressivitagrave verso lrsquoIlliria prima e i protettorati romani Orico e Apollonia poi
130 MONICA DrsquoAGOSTINI
Dopo aver accennato alla stipula del trattato Giustino affastella ne-gli ultimi paragrafi del capitolo 4 gli eventi tra il 215 e il 205 quando Fi-lippo siglando la pace con Roma pone fine alla Prima Guerra Macedo-nica29 In particolare lrsquoEpitomatore sottolinea da un lato lrsquoingresso in guerra degli Etoli al fianco dei Romani e la successiva alleanza del preto-re Levino con Attalo dallrsquoaltro gli attacchi subiti da parte dei Dardani da Filippo oppresso dalle richieste degli Illiri Il libro dunque si chiude con Filippo in difficoltagrave aggravate dalla comparsa di Filopemene il leader degli Achei30 urtatosi con il re dei Macedoni convince la Lega Achea a staccarsi dallrsquoalleanza con la Macedonia sempre piugrave isolata Tale allon-tanamento egrave considerato da Giustino lrsquoesito di un fallito agguato a Fi-lopemene commissionato da Filippo V e dovuto al sospetto di un tradi-mento del condottiero acheo a favore di Roma Bencheacute anche Plutarco (Fil 12 2) e Pausania (VIII 50 4) menzionino il tentativo di assassinio di Filopemene da parte di Filippo la notizia dellrsquoatteggiamento filoroma-no del generale acheo non parrebbe vicino al ritratto polibiano che ve-de in Filopemene un eroe dellrsquoautonomia e dellrsquoindipendenza achea31
Libro XXX11-39 Cinoscefale
Lrsquoesordio del libro XXX introducendo il grande scontro di Cinoscefale tra Romani e Macedoni riprende la celebrazione della gloria macedo-ne argomento centrale dei discorsi del libro XXIX Con lrsquoeccezione dei primi capitoli sul deplorevole comportamento di Tolemeo IV in Egit-to32 il libro egrave infatti totalmente dedicato allo scontro tra le due potenze
29 Errington (2008) pp 185-190 La guerra egrave nota a noi soprattutto dai frammenti dei libri VIII-XI di Polibio dai passi di Liv XXIV 40 1-17 XXVI 24 1-26 4 XXVII 30 5-33 5 e XXVIII 5 1- 9 1 XXIX 12 1-15 e dalla Vita di Filopemene di Plutarco La sinteticitagrave del riassunto giustineo impedisce un puntuale paragone delle tradizioni Ad esempio la notizia dellrsquoalleanza tra Attalo e Roma sembra tornare in Liv XXVIII 5 1-4 dove perograve non troviamo Levino ma Sulpicio come rappresentante romano personaggio scompar-so in Giustino In maniera simile la pace di Fenice del 205 egrave sintetizzata in Giustino in una riga e non vi egrave traccia delle lunghe trattative che coinvolsero come mediatori anche Egitto Chio Mitilene e Atamania portarono a una prima pace separata tra Filippo e gli Etoli nel 206 e poi alla pace con Roma Le fonti parallele sono molto piugrave dettagliate anche su questi eventi Polyb XI 4 1-6 9 Liv XXVIII 5 13 e XXIX 12 8-16 e App Mak fr III Degno di nota egrave perograve il commento in Giustino secondo cui laquoi Romani erano per il momento soddisfatti di aver rinviato la guerra contro la Macedoniaraquo Lrsquointenzione ro-mana di riprendere la guerra con la Macedonia egrave infatti presente in tutte le fonti Polyb XI 6 7 Liv XXIX 1216 Dio C XVIII 9 (15) e App Mak Fr III e verragrave ripresa al libro XXX dellrsquoEpitome 30 Su Filopemene e Filippo vd Errington (1969) pp 51-69 e 83-84 vd anche Golan (1995) pp 115-132 Eckstein (2008) pp 103 e 360-36131 Pelling (1997) pp 135-13932 Lrsquoesordio del libro XXX egrave dedicato alle scabrose imprese del sovrano egiziano ovvero
IL DISCORSO DEL RE 131
dellrsquoEst e dellrsquoOvest La prima avvisaglia dellrsquoincombente guerra egrave la no-tizia dellrsquoaccordo di Filippo V e Antioco III per la spartizione dellrsquoEgitto governato dal sovrano-bambino Tolemeo V Il sovrano lagide nel 2032 chiese aiuto ai Romani che secondo TrogoGiustino gradirono la ri-chiesta drsquoaiuto percheacute cercavano pretesti per muovere guerra contro Fi-lippo A partire da Polibio numerose altre fonti ci testimoniano questo episodio mettendolo in relazione con lo scoppio della Seconda Guerra Macedonica ed esprimendo una condanna morale per lrsquoempia condotta del re antigonide che cospira contro un bambino33 al contrario nellrsquoE-pitome si esalta la potenza macedone evidenziando la paura dei Romani delle grandi imprese di Filippo (XXX 3 2)
nullius magis arma metuebant reputantibus quantum motum Pyrrhus parua Macedo-num manu in Italia fecisset quantasque res Macedones in Oriente gessissent
di nessun altro temevano maggiormente le armi poicheacute ripensavano a quanto sconvolgimento Pirro aveva provocato in Italia con una piccola schiera di Ma-cedoni e a quanto grandi imprese i Macedoni avevano compiuto in Oriente
La supremazia macedone egrave anche al centro del discorso in oratio obliqua di Filippo allrsquoincontro nel Golfo Maliaco tra i rappresentanti dei fronti coinvolti nella Seconda Guerra Macedonica34 NellrsquoEpitome infatti dopo
la Quarta Guerra Siriaca conclusa con sconfitta a Rafia contro Antioco III nel 217 e la corruzione del sovrano da parte di Agatocle e della sorella una cortigiana che avrebbe sedotto il re Giustino riferisce poi la morte del sovrano nel 204 e lrsquoascesa al trono del piccolo Tolemeo V Epifane sovrano sotto tutela di Tlepolemo dopo la morte di Agatocle e Sosibio 33 Eckstein (2008) pp 121-180 Thornton (2014) pp 65-88 In particolare sulla relazione tra il complotto e la sconfitta antigonide e seleucidica ad opera di Roma la superioritagrave morale romana ai regni ellenistici e la causalitagrave storica in Polibio (XV 20 6) vd Eck-stein (2008) pp 133-138 Ager (2009) pp 15-43 Landucci Gattinoni (2011) pp 89-105 Secondo Polyb III 2 8 XV 20 XVI 1 8-9 seguito da Liv XXXI 14 5 Filippo avrebbe ottenuto le basi tolemaiche in Egeo Samo e la Caria mentre Antioco avrebbe finalmente avuto mano libera in Celesiria e Fenicia oggetto di quasi un secolo di lotte tra Tolemei e Seleucidi La notizia del trattato permette a Polibio di dedicare alcuni paragrafi (XV 20) a condannare aspramente lrsquooperato di Filippo V e Antioco III definendoli empi e senza pudore e dichiarando che la Fortuna punigrave i due sovrani per il loro crudele operato por-tando i Romani contro di loro vd infra App Mak Fr IV trasmette delle clausole secondo cui Antioco avrebbe avuto lrsquoEgitto e Cipro mentre Filippo avrebbe ottenuto Cirene le Cicladi e la Ionia Infine secondo Porfirio FGrHist 260 F 45 lrsquoaccordo prevedeva che i due sovrani annettessero i possedimenti tolemaici confinanti con i rispettivi regni 34 Prima si menziona unrsquoambasceria del Senato a Filippo e Antioco percheacute laquosi astenessero dallrsquoEgittoraquo e la visita di Lepido in Egitto Quindi le lamentele a Roma di Attalo e i Rodii nei confronti di Filippo Egrave probabile che a questo punto Trogo inserisse la campagna di Filippo in Asia contro Attalo menzionata nel Prologo XXX ma tagliata nellrsquoEpitome La cronologia degli scambi diplomatici precedenti la Seconda Guerra Macedonica egrave stra-volta dalla sintesi dellrsquoEpitomatore e rende impossibile qualsiasi confronto con le altre
132 MONICA DrsquoAGOSTINI
il riassunto delle ambascerie nel Mediterraneo preludio allo scontro della prima fase della guerra35 maggior spazio egrave dato al tentativo di pa-ce a Nicea tra Roma Attalo i Rodii gli Achei e gli Etoli e Filippo V nel 198 In questa occasione Filippo rivendica la posizione di dominio dei Macedoni sui Greci ereditata da Filippo II e Alessandro suoi antenati e in virtugrave di tale supremazia macedone rifiuta che i Greci gli dettino le condizioni di pace ma chiede che sia il Senato a decidere Egrave significati-vo che non solo il discorso di Filippo non compaia in nessuna delle fon-ti parallele che descrivono nel particolare le posizioni degli ambasciato-ri di Achei Etoli Rodii e Attalo ma che Polibio (XVIII 8 8)36 affermi che era difficile sapere cosa si fossero detti Filippo e Flaminino durante i colloqui nel Golfo Maliaco Secondo la tradizione polibiana infatti il sovrano accompagnato da due philoi macedoni Apollodoro e Demoste-ne chiese di allontanare dalle trattative tutti tranne i Romani e discus-se la pace solamente con Flaminino Successivamente a causa dellrsquoinca-pacitagrave di trovare un accordo Filippo chiese due mesi di tregua e lrsquointer-vento del Senato Trogo dunque restituisce il discorso che il resto della tradizione riteneva impossibile da conoscere indicando chiaramente la presenza di una fonte diversa rispetto a Polibio su questo avvenimento piugrave informata sul punto di vista di Filippo e interessata a evidenziare la convinzione di Filippo V di avere un diritto di supremazia sulla Grecia in virtugrave delle imprese di Filippo II e Alessandro
La battaglia di Cinoscefale nel 197 momento risolutivo dello scontro tra Roma e Macedonia egrave lrsquoevento principale del libro XXX omina e pre-sagi introducono lrsquoevento campale lrsquoeruzione del vulcano di Santorini
fonti In Polyb XVI 24 3 App Mak Fr IV Liv XXXI 1 10 21 5 5 Paus I 36 5-6 vi sono differenti versioni della sequenza delle ambascerie che denunciarono a Roma lrsquoe-spansionismo macedone ma tutte concordano che le ambascerie precedettero lrsquoinvio dei legati romani in Oriente e che esse furono inviate anche da Atene e dagli Etoli Inoltre secondo la tradizione polibiana (Polyb XVI 27 1-4 34 1-7 Liv XXXI 2 3 6 3-8 4 18 1-9 Diod XXVIII 6) vi furono due diverse ambascerie di cui la seconda sarebbe stato un ultimatum al sovrano recapitato da Lepido In occasione di questa seconda ambasceria avvenuta durante il cruento assedio di Abido Filippo avrebbe detto che i Macedoni in ca-so di guerra si sarebbero difesi con valore In Giustino si puograve notare che ancora una volta dagli eventi sono omesse notizie fondamentali sui Greci nello specifico lrsquoambasceria di Atene la cui disputa con gli Acarnani fu il casus belli della guerra contro Filippo 35 Come i prodromi anche la prima parte della Seconda Guerra Macedonica egrave sintetizza-ta in Giustino e occupa solamente due paragrafi Come spesso accade nei passi sintetiz-zati dallrsquoEpitomatore si trovano le incongruenze maggiori con le fonti parallele tra cui si nota soprattutto la completa omissione di Giustino delle campagne di Publio Sulpicio Galba Massimo di Villio delle vittorie di Tito e Lucio Flaminino e dellrsquoassemblea del 198 che portograve gli Achei ad allearsi con Roma Polyb XXII e Liv XXXI 14 1- 46 16 XXXII 1 1-25 12 App Mak Fr VII Plut Fil 17 4 Flam 5 4 e Paus VII 8 1-236 Le trattattive sono descritte con particolari in Polyb XVIII 1-12 seguito da Liv XXXII 32 6-36 10 e Plut Flam 5 8 e 7 1-3
IL DISCORSO DEL RE 133
nel 197 e lrsquoemergere dellrsquoisola di Hiera e in contemporanea il terremo-to a Rodi Quindi nellrsquoEpitome si annuncia che laquoil nascente impero dei Romani avrebbe divorato quello antico dei Greci e dei Macedoni37raquo Nel passo ricevono spazio soprattutto i due discorsi contrapposti del re ma-cedone Filippo e del comandante romano Flaminino pronunciati pri-ma dello scontro campale e costruiti ciascuno in modo da celebrare le imprese delle due potenze38 Lrsquoenfasi data dalla contrapposizione reto-rica delle parole dei generali egrave tale da rendere suggestiva lrsquoipotesi che lo scontro dovesse essere il momento centrale non solo del libro XXX ma forse di tutta lrsquoopera trogiana
Filippo elenca le grandi vittorie del passato dei Macedoni contro Per-siani Battriani Indiani e le popolazioni drsquoAsia fino allrsquoestremo Orien-te esortando i suoi a combattere con valore percheacute laquola libertagrave egrave piugrave cara del predominio39raquo Il discorso di Flaminino egrave invece piugrave lungo articola-to in un paragone tra Macedoni e Romani alle passate imprese di con-quista macedoni vengono contrapposte le piugrave recenti vittorie romane a Cartagine in Sicilia Italia e Spagna alla grandezza di Alessandro Ma-gno egrave contrapposta quella di Annibale che pure dai Romani era stato sconfitto Lrsquoattenzione poi si concentra su Filippo i Macedoni non laquodo-vevano essere valutati per lrsquoantica forza ma per le forze attuali40raquo poicheacute Filippo non era lrsquoinvitto e invincibile Alessandro Magno ma un ragaz-zo che non riusciva a difendere i propri confini I Macedoni rivendica-vano il valore degli antenati mentre i Romani quello dei propri soldati poicheacute quelli che erano ligrave schierati erano gli stessi che avevano sconfitto Annibale Dopo una cosigrave grandiosa introduzione la battaglia egrave descritta in uno dei paragrafi piugrave significativi di tutta lrsquoopera
His adhortationibus utrimque concitati milites proelio concurrunt alteri Orientis alteri Occidentis imperio gloriantes ferentesque in bellum alii maiorum suorum antiquam et ob-soletam gloriam alii uirentem recentibus experimentis uirtutis florem [16] Sed Macedo-nas Romana Fortuna uicit
I soldati incitati da queste esortazioni dallrsquouna e dallrsquoaltra parte si lanciaro-no nel combattimento vantandosi gli uni del dominio dellrsquoOriente gli altri dellrsquoOccidente e recando in guerra gli uni lrsquoantica e sbiadita gloria dei loro an-
37 Iust XXX 4 4 Quo prodigio territis omnibus uates cecinere oriens Romanorum imperium uetus Graecorum ac Macedonum uoraturum38 Sui discorsi precedenti la battaglia nellrsquoantichitagrave se da considerare reali o costruzioni storiografiche vd Adler (2011) pp 6-839 Iust XXX 4 7 tantoque hoc bellum fortius quam illa sustinendum quanto sit imperio libertas carior40 Iust XXX 4 10 Sed nec Macedonas ueteri fama sed praesentibus uiribus aestimandos
134 MONICA DrsquoAGOSTINI
tenati gli altri il fiore del loro valore fresco e vigoroso per le recenti prove Ma la Fortuna dei Romani vinse i Macedoni
Questo punto di vista probabilmente giagrave trogiano contrappone la virtugrave romana (virtutis flos) celebrata nei discorsi antecedenti la battaglia al-la Fortuna romana (Romana Fortuna) che decise la vittoria interpretabi-le come destino favorevole o buona stella Piugrave che unrsquoaffermazione anti-romana41 come egrave spesso stata intesa si puograve evidenziare il carattere sim-patetico della fonte verso Filippo V destinato a porre fine alla gloria di Filippo II e Alessandro e forse un approccio nostalgico verso i grandi regni macedoni la cui egravera egrave ormai giunta alla fine Tale prospettiva egrave as-sente in Polibio e nella tradizione che da lui dipende poco interessata alle vicende della gloria macedone leggendo infatti i frammenti soprav-vissuti del libro XVIII delle Storie dopo lrsquoaccurata descrizione della bat-taglia (18-33 e 34-40)42 Polibio commenta lo scontro affermando che avrebbe dedicato alcuni capitoli allrsquoesame delle strategie militari delle due armate percheacute (XVIII 28 4-6)
χρήσιμον καὶ καλὸν ἂν εἴη τὸ τὴν διαφορὰν ἐρευνῆσαι καὶ παρὰ τί συμβαίνει Ῥωμαίους ἐπικρατεῖν καὶ τὸ πρωτεῖον ἐκφέρεσθαι τῶν κατὰ πόλεμον ἀγώνων [5] ἵνα μὴ τύχην λέγοντες μόνον μακαρίζωμεν τοὺς κρατοῦντας ἀλόγως καθάπερ οἱ μάταιοι τῶν ἀνθρώπων ἀλλ᾽ εἰδότες τὰς ἀληθεῖς αἰτίας ἐπαινῶμεν καὶ θαυμάζωμεν κατὰ λόγον τοὺς ἡγουμένους
Puograve essere cosa buona e utile esaminare le differenze e per quale motivo i Ro-mani prevalgono e riportano il primo premio nelle competizioni di guerra af-fincheacute non esaltiamo i vincitori senza una ragione parlando solo di fortuna co-me fanno gli sciocchi ma conoscendo le vere cause lodiamo e ammiriamo i co-mandanti seguendo una logica
Polibio dunque sembra rispondere a coloro che parlavano della buo-na stella dei Romani sottolineando che la vittoria nasceva dalla superio-re strategia militare della legione43 Un punto di vista quindi opposto a quello espresso nellrsquoEpitome che proprio di Romana Fortuna parla e riba-dito in chiusura al passo dove Polibio critica nuovamente quei Greci che ritenevano la vittoria romana incredibile (XVIII 32 13)
41 Urban (1982) pp 1424-1443 1435 Richter (1987) p 19 n 4 Alonso-Nuacutentildeez (1992) p 66 e Id (2002) pp 105-110 partic 108-109 Contra Heckel (1997) p 29 che ridimen-siona la categorizzazione di Trogo come storico anti-romano 42 Su Cinoscefale vd Walbank (1957) ad l Hammond (1988) pp 60-82 Sklenaacuter (2004) pp 302-310 Thornton (2014) pp 83-87 43 Sulla Fortuna in Polibio vd McGing (2010) pp 195-201 (con bibliografia) che distin-gue tra quando Polibio intenda caso e quando predeterminazione fato Vd anche Green (1990) pp 400-402 e Eckstein (2008) pp 132-138
IL DISCORSO DEL RE 135
Il punto di vista di Trogo sembra invece presente nei frammenti del-la Makedonikeacute di Appiano su Filippo V44 dove ci si riferisce a Cinoscefale come a una vittoria insperata (Mak 9 1)
ἡγούμενος δ᾽ οὔτε Ῥωμαίοις συμφέρειν οὔτε τοῖς Ἕλλησι Φιλίππου καθαιρεθέντος ἐπιπολάσαι τὴν Αἰτωλῶν βίαν τάχα δ᾽ αὐτὸν καὶ τὸ παράδοξον τῆς νίκης ἀγαπᾶν ἐποίει
Flaminino era consapevole che non sarebbe stato vantaggioso per i Romani o per i Greci che Filippo fosse deposto e che il potere etolico rimanesse incon-trastato forse lo aveva reso moderato nei suoi progetti lrsquoaver ottenuto una vit-toria insperata
Addirittura successivamente si accenna alla sorte avversa a Filippo nel-lo scontro
τὰ μὲν δὴ παρὰ τῶν ἄλλων φιλάνθρωπα ἦν τό τε τῆς τύχης ἄδηλον ἐξ ὧν ἔπαθεν ὁ Φίλιππος ὑφορωμένων καὶ τὸ πταῖσμα τοῦτο οὐ κατ᾽ ἀσθένειαν ἀλλὰ πλέον ἐκ συντυχίας αὐτὸν παθεῖν ἡγουμένων
Gli altri (Greci) erano inclini ad essere moderati vedendo con sospetto lrsquoincer-tezza della fortuna subita da Filippo e ritenendo che egli fosse incorso in questa sconfitta non tanto per la sua inferioritagrave quanto per la sfortuna
Il riferimento in Appiano e Trogo alla fortuna romanasfortuna ma-cedone a proposito di Cinoscefale egrave una traccia dellrsquoopinione politi-ca di quei Greci disprezzati da Polibio come uomini sciocchi καθάπερ οἱ μάταιοι τῶν ἀνθρώπων Tale posizione politica su Cinoscefale sarebbe dunque sopravvissuta nella tradizione storiografica di cui troviamo trac-cia in TrogoGiustino e Appiano
Per comprendere meglio alcune caratteristiche di questa tradizione puograve essere utile tornare ai due discorsi nellrsquoEpitome di Filippo e Flamini-no prima della battaglia Tali passi probabilmente trogiani45 non trova-no infatti riscontro nelle fonti parallele a noi pervenute Polibio (XVIII 18-27) seguito fedelmente da Livio (XXXIII 5-10) pur descrivendo le operazioni di guerra di Cinoscefale con dovizia di particolari non men-ziona un discorso di Filippo ai suoi armati prima della battaglia mentre il discorso di Flaminino per incoraggiare le truppe schierate (XVIII 23 2-6) nelle Storie egrave incentrato sulle vittorie di Sulpicio nella prima parte della guerra Pare dunque originale la versione trogiana che incentra-
44 Tra i frammenti consegnatici dagli Excerpta Constantiniana sono frequenti informazio-ni e osservazioni che rimandano a una prospettiva ellenistica sugli eventi DrsquoAgostini (2011) pp 99-121 45 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362
136 MONICA DrsquoAGOSTINI
ta sulla gloria macedone presenta Cinoscefale come il punto drsquoincon-tro e di scambio tra lrsquoegemonia macedone e lrsquoegemonia romana Non egrave una novitagrave che il leitmotiv delle Storie Filippiche e dunque dellrsquoEpitome sia la translatio imperii giagrave Alonso Nuntildeez definito da Santi Amantini laquouno dei piugrave noti esperti di questioni trogiano-giustineeraquo46 osservava che Tro-go esponeva nel suo perduto lavoro la teoria della successione degli im-peri mondiali secondo lo schema Assiria-Media-Persia-Macedonia-Roma osteggiata dai Parti47 In tale successione il ruolo da protagonista egrave rico-perto dallrsquoegemonia macedone48 che occupa allrsquoincirca 26 dei 44 libri e il cui ultimo vero momento di gloria egrave lo scontro con Roma appunto a Cinoscefale Lrsquoultima impresa macedone ha come esito la transizione del dominio universale da Oriente a Occidente e costituisce il tema cen-trale dellrsquointera vicenda di Filippo lrsquoimportanza della battaglia di Cino-scefale egrave perciograve esaltata nei discorsi sia di Filippo che di Flaminino che a loro volta sono il punto di arrivo delle argomentazioni esposte nelle parole di Demetrio di Faro e di Filippo stesso giagrave nel libro XXIX Le ora-tiones disposte retoricamente nei due libri descrivono due parabole op-poste da un lato quella romana che da lontana potenza desiderosa di espandersi cresce come una pioggia di sangue diventando il giovane e vigoroso potere che sottomesso Annibale egrave pronto a sconfiggere Filip-po Dallrsquoaltro quella macedone che originata con Filippo II personag-gio centrale per Trogo raggiunge il suo apice con la conquista dellrsquoege-monia ad opera di Alessandro Magno contro i Persiani per conoscere la fine con Filippo V il cui antico valore egrave ormai troppo lsquosbiaditorsquo per te-ner testa al vigore romano
La gloria macedone secondo Trogo inizia dunque con Filippo II e si conclude con Filippo V Perseo egrave infatti il malvagio responsabile dellrsquoan-nientamento di ciograve che rimaneva della monarchia macedone49 Trogo pone agli estremi della parabola macedone che occupa dal libro IX al XXX i due re di nome Filippo Filippo II e Filippo V come ribadito in piugrave luoghi dellrsquoEpitome sia in parti riassunte da Giustino che in passi piugrave genuinamente trogiani Dando per scontato che il titolo dellrsquoopera Sto-rie Filippiche si debba al desiderio di Trogo di rifarsi allrsquoopera di Teopom-po sul sovrano macedone egrave possibile che tale titolo sia stato perograve ripen-
46 Santi Amantini (2003) pp 99-11047 laquoPompeius Trogus expounded in his lost work the Historiae Philippicae a theory of the world empire suggestion according to the scheme Assyria-Media-Persia-Macedonia-Rome opposed by the Parthiansraquo Alonso-Nuacutentildeez (2002) pp 105-110 e 133-136 partic 105 Vd anche Richter (1987) pp 19-23 Momigliano (1980) pp 157-162 Alonso-Nuacutentildeez (1992) Heckel (1997) pp 1-41 Gabba (2003) pp 7-9 Santi Amantini (2003) pp 99-110 Mariotta (2014) pp 45-56 48 Franco (1993) pp 71-97 e Landucci (2014) pp 233-26149 Alonso-Nuacutentildeez (2002) pp 105-110 partic 108-109
IL DISCORSO DEL RE 137
sato da Trogo considerando che il periodo compreso tra le imprese dei due Filippo occupa 23 dellrsquoopera50 Si potrebbe allora suggerire che le Storie sono Filippiche poicheacute i due Filippo segnarono lrsquoinizio e la fine di quella che egrave nellrsquoopera di Trogo lrsquoegemonia incontrastata del mondo piugrave gloriosa di tutti i tempi51
La prospettiva ellenistica che vede nei due Filippo i limiti della grande egemonia macedone egrave di nuovo presente anche in Appiano nellrsquooraco-lo riportato nei frammenti della sua Makedonikeacute e noto anche da Pausa-nia (VII 8 9)
αὐχοῦντες βασιλεῦσι Μακηδόνες Ἀργεάδῃσιν ὑμῖν κοιρανέων ἀγαθὸν καὶ πῆμα Φίλιππος ἤτοι ὁ μὲν πρότερος πόλεσιν λαοῖσί τ᾽ ἄνακτας θήσει ὁ δ᾽ ὁπλότερος τιμὴν ἀπὸ πᾶσαν ὀλέσσει δμηθεὶς δ᾽ ἑσπερίοισιν ὑπ᾽ ἀνδράσιν ἐνθάδ᾽ ὀλεῖται
O Macedoni che andate orgogliosi dei re di stirpe argiva I re di nome Filippo saranno arbitri del bene e del male per voi Il primo vi renderagrave signori di cittagrave e popoli il secondo vi priveragrave di ogni onore sconfitto da uomini dellrsquoOcciden-te qui giace morto52
Senza voler entrare nel merito della discussione di tale oracolo di nuo-vo pare di incontrare nei due autori la medesima prospettiva lontana dalla condanna morale del re macedone espressa da Polibio secondo cui la sconfitta egrave il giusto esito della sua crudeltagrave ed empietagrave
Il libro giustineo si conclude menzionando le condizioni della pa-ce di Tempe53 e lrsquoira degli Etoli che videro ignorate le proprie richieste da Flaminino e perciograve cercarono lrsquoalleanza di Antioco contro Roma Se-condo il Prologo XXX il libro perograve proseguiva con le campagne di Antio-co III in Asia Minore contro Molone e Acheo e in Battriana fino ad ar-rivare allrsquoesordio dello scontro con Roma54 Il riassunto giustineo egrave trop-po sommario per permettere un confronto con le fonti parallele Egrave pe-
50 Sul rilievo della storia della Macedonia nellrsquoopera di Trogo e Giustino vd von Gutsch-midt (1894) pp 17-217 Richter (1987) p 28 n 29 Franco (1993) pp 71-97 51 Vd anche Urban (1982) pp 1424-1443 e Alonso-Nuacutentildeez (1992) p 58 52 Mak Fr 2 Vd DrsquoAgostini (2011) pp 99-121 In questa Walbank (2002) pp 127-136 propone di interpretare anche un poema di Alceo di Messene (Anth Pal 9518)53 Egrave probabile che Trogo fornisse piugrave particolari riguardo a questa pace per esempio si puograve ritenere che vi fosse menzione dellrsquoinvio a Roma del figlio Demetrio da parte di Filippo come ostaggio dato che a Iust XXXII 2 3 si richiama appunto tale avvenimento54 Polyb XVIII 34 1-39 7 42 1-45 12 Liv XXXIII 11 3-13 15 24 1-31 11 Plut Flam IX 1-8 App Mak Fr IX riferiscono di due diverse trattative di pace caratterizzate da un vivace dibattito tra chi voleva lrsquoannientamento della Macedonia come in Grecia gli Etoli e a Roma Marco Claudio Marcello e coloro che desideravano la pace con la Macedonia in primis Flaminino
138 MONICA DrsquoAGOSTINI
rograve da notare la mancanza sia nel Prologo che nel testo del libro degli av-venimenti delle celebrazioni Istmie del 196 quando Flaminino procla-mograve la libertagrave dei Greci Piugrave in generale in tutta la narrazione di Giustino delle complesse trattative del 197-196 manca qualsiasi riferimento alla li-bertagrave dei Greci punto nodale nella tradizione di Polibio che con questa sottolineatura esalta sia il ruolo tirannico della Macedonia sia la grande generositagrave dei Romani nei confronti della Grecia Il silenzio di TrogoGiustino su tale questione mostra il prevedibile disinteresse per gli affari dei Greci e nel contempo conferma la presenza di una tradizione che si occupa soprattutto della storia delle monarchie ellenistiche allrsquointer-no della quale la posizione dellrsquoEllade egrave subalterna
Libro XXXII23- 34 Demetrio e Perseo
Gli ultimi anni di regno di Filippo tra il 183 e il 179 sono narrati in un passo breve del libro XXXII Il racconto in Giustino che egrave coerente con il Prologo trogiano segue in maniera sintetica la tradizione polibiana su questi eventi giunta a noi in alcuni passi lacunosi di Polibio (XXIII 1 3-3 10 7 1-7 10 1-11 8) integrati dal racconto particolareggiato di Li-vio (XXXIX 46 7- 48 6 53 1-16 XL 3 3-16 3 201-24 8) e dalla narra-zione di Diodoro (XIX 25) e Plutarco (Aem VIII 11)55
Conclusioni
In questi libri dedicati a Filippo egrave forse possibile vedere in filigrana la rielaborazione voluta di Giustino dei corrispondenti libri trogiani Co-me Giustino stesso afferma nella Prefatio 3 lrsquoopera di Trogo era costruita secondo due criteri quello cronologico e quello per laquoconcatenazione di eventi56raquo ea omnia Pompeius diuisa temporibus et serie rerum digesta conposuit
55 Lrsquoutilizzo della tradizione polibiana in Trogo egrave confermato dallrsquoaderenza a Livio (XL 54 1-56 11) e Diodoro (XXIX 28) del racconto sul pentimento di Filippo per aver ucciso il figlio Demetrio lrsquointenzione di punire Perseo e la correlazione tra questo e la sua mor-te Questo libro egrave dunque differente nellrsquointeresse e nelle fonti dai libri XXIX e XXX poicheacute molto vicino alla tradizione polibiana in Livio Questi avvenimenti in Giustino sono da collegare con lrsquoascesa al trono di Perseo e non con lrsquoepilogo della celebrazione del valore macedone giagrave conclusasi in Giustino con Cinoscefale e la transizione dallrsquoim-perium macedone allrsquoimperium romano Vd Heckel (1997) p 7 Appiano invece riporta ancora una tradizione diversa da quella polibiana in un frammento della Makedonikeacute in particolare Appiano egrave attento al punto di vista macedone e presenta Filippo come una vittima delle circostanze (Mak IX) DrsquoAgostini (2011) pp 99-12156 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362 Alonso-Nuacutentildeez (2002) pp 133-136 He-ckel (1997) pp 1-41 Borgna (2014) pp 52-77
IL DISCORSO DEL RE 139
Serie rerum digesta sembrerebbe unrsquointerpretazione latina della formula κατὰ γένος che Diodoro usa per indicare la struttura della storia di Efo-ro sottolineandone la divisione per argomento57 In tale struttura per argomento dellrsquoEpitome tra i temi principali ci sono dunque il valore e la gloria dei sovrani ellenistici58 riscontrabile nei libri XXVIII-XXXI sui re-gni di Antigono Dosone Filippo V e Antioco III Tale tema presente di sicuro in Trogo egrave conservato nellrsquoazione dellrsquoEpitomatore e anzi come si vede dagli escerpta esaltato dalla selezione dei passi
Per quanto riguarda invece la Quellenforschung 59 egrave evidente che nel testo vi sia presenza di filoni non tradizionali sugli eventi poicheacute la posi-zione di Trogo appare spesso autonoma rispetto alle opinioni condivise dalla storiografia antica Questo aspetto dellrsquoEpitome evidente soprattut-to per ciograve che riguarda gli eventi ellenistici ha suscitato la grande curio-sitagrave degli studiosi che allontanatisi dalla proposta di von Gutschmid che voleva una totale ed esclusiva dipendenza di Trogo da Timagene ora in-dicano con sicurezza tra le fonti piugrave rilevanti per gli eventi ellenistici di III secolo utilizzate da Trogo almeno altri sei nomi oltre a Timagene Ie-ronimo Timeo Filarco Duride Polibio e Posidonio
Per quanto riguarda nello specifico la composizione dei libri XXIX e XXX non vi egrave alcun dubbio che in essi Trogo abbia utilizzato (anche riadattandola) una fonte poco attenta alle questioni di politica interna greca e al legame tra queste e quel ritratto di Filippo come sovrano mal-vagio ed empio che ritorna nella tradizione ufficiale di origine polibia-na passando poi da Polibio in Livio Diodoro e Plutarco60 Trogo pre-serva invece una tradizione ellenistica interessata alla figura di Filippo come ultimo barlume della gloria macedone tradizione che pare quasi una controparte e un completamento dellrsquoAb urbe condita romanocentri-ca di Livio Non si puograve perciograve a mio avviso escludere che per questa se-zione Trogo abbia usato una tradizione di matrice filoellenistica o sem-plicemente ellenisticocentrica unrsquoopera sui regni di diadochi ed epigo-ni che a tutti noi fa venire facilmente alla mente il Basileis o Perigrave Basileon dello storico grecoellenistico augusteo filobarbaro scettico (o critico) verso lrsquoegemonia romana Timagene di Alessandria (FGrHist 88)61
57 Su Eforo vd Vannicelli (1987) pp 165-191 e ora Parmeggiani (2011) 58 Simile legame vi egrave a mio avviso tra i libri XXVI e XXVII che invece affrontavano la crisi delle monarchie ellenistiche causata dalle guerre fraterne59 Vd von Gutschmid (1894) pp 17-217 Richter (1987) pp 17-30 partic 20-23 San-ti Amantini (1972) pp 56-109 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362 Urban (1982) pp 1424-1443 partic 1435 Mecca (2001) pp 199-222 Santi Amantini (2003) pp 99-110 Heckel (2012) pp 3-860 Scuderi (2005) pp 383-40561 Sordi (1982) pp 775-797 Heckel (1997) pp 30-34 Landucci (2014) pp 233-261 e Ead in questo volume
140 MONICA DrsquoAGOSTINI
ABSTRACT
Philip V of Macedon was the first of the Epigonoi to face Rome Several mod-ern reconstructions of the actions and the reign of Philip V have approached it largely from a Roman point of view using as sources Polybius and where Poly-bius is lost Livy The Polybian historiographical tradition tends to portray Phil-ip V as an enemy and a tyrant impious and cruel The Macedonian king was ea-ger to establish a universal and unjust dominion over Greece Italy and beyond and Rome engaged in the first two Macedonian Wars to fight the threat of his growing ambition Nevertheless Polybiusrsquo portrayal of Philip V was affected not only by Polybiusrsquo admiration for Roman political structures military power and overwhelming conquest but also his personal Achaean origins
Looking at in book 29 and 30 of Justinrsquos Epitome of Pompeius Trogus this pa-per focuses on the non Polybian tradition on Philip V this contribution is in-deed the first analysis of the Hellenistic approach to the clash between Rome and Macedonia in the 3rd-2nd Century BC The Epitome shows a considerable di-versity of interpretation from the other sources and reflects very different views of Philip Vrsquos actions that brought him into conflict against Rome In particular these views are more evident related to the accounts of the peace negotiations of Naupactus and the battle of Cynoscephalae in the Epitome the king appears as a courageous and skilled warrior the last of the great Macedonian rulers who fell victim to misfortune This portrayal which has several common features with Appianrsquos fragments of Philip V (Mak 9) counterbalances the Roman and Achaean standpoint present in Polybius providing a more Hellenistic perspec-tive that is likely to have been rooted in a historiographical tradition connect-ed to the losing side in the struggle between Rome and the Hellenistic world
BIBLIOGRAFIA
Adler E (2006) Whorsquos Antiroman Sallust and Pompeius Trogus on Mithridates CJ 101 pp 383-407
Adler E (2011) Valorizing the Barbarians Enemy speeches in Roman Historiography Austin
Ager SL (2003) An Uneasy Balance from the Death of Seleukos to the Battle of Raph-ia in A Erskine (ed) A Companion to the Hellenistic World Oxford pp 35-50
Ager SL (2009) Roman Perspectives on Greek Diplomacy The conceptual clash Greek diplomacy of compromise and Roman Bellum Iustum in C Eilers (ed) Diplomats and Diplomacy in the Roman World Leiden-Boston pp 15-43
Alonso-Nuacutentildeez JM (1992) La Historia Universal de Pompeyo Trogo Madrid
Alonso-Nuacutentildeez JM (2002) The Idea of Universal History in Greece From Herodotus to the Age of Augustus Amsterdam
Ballesteros Pastor L (2013) Pompeyo Trogo Justino y Mitriacutedates Comentario al Epiacutetome de las Historias Filiacutepicas (3716-3881) Hildesheim-Zuumlrich-New York
IL DISCORSO DEL RE 141
Barreacute ML (1983) The God-List in the Treaty between Hannibal and Philip V of Ma-cedon a Study in Light of the Ancient Near Eastern Treaty Tradition Baltimore-Lon-don
Beck H - Eckstein A (2015) sv ldquoAratos of Sicyon (231)rdquo in I Worthington (ed) Brillrsquos New Jacoby Brill Online
Borgna A (2014) Uno sguardo originale intorno a Roma Pompeo Trogo e Giustino laquoLa Biblioteca di ClassicoContemporaneoraquo 1 pp 52-77
Cassola F (1962) I gruppi politici romani nel III secolo aC Trieste
Champion CB (1997) The Nature of Authoritative Evidence in Polybios and Agelausrsquo Speech at Naupactos TAPhA 127 pp 111-128
Champion CB (2004) Cultural Politics in Polybiusrsquo Histories Berkeley
Coppola A (1993) Demetrio di Faro un protagonista dimenticato Roma
Criscuolo L (2011) I due testamenti di Tolemeo VIII Evergete II in A Joumlrdens - J F Quack (hrsg) Aumlgypten zwischen innerem Zwist und aumluszligerem Druck Die Zeit Ptole-maios VI bis VIII Wiesbaden pp 132-150
DrsquoAgostini M (2011) Filippo V e la Storia Romana di Appiano laquoAevumraquo 85 pp 99-121
Eckstein AM (1995) Moral vision in the Histories of Polybius Berkeley
Eckstein AM (2008) Rome enters in the Greek East From Anarchy to Hierarchy in the Hellenistic Mediterranean 230-217 BC Oxford
Eckstein AM (2013) Polybius Phylarchus and Historiographical Criticism CPh 108 4 pp 314-338
Errington RM (1969) Philopoemen Oxford
Errington RM (2008) A History of the Hellenistic World 323-30 BC Malden MA-Oxford
Forni G - Angeli Bertinelli MG (1982) Pompeo Trogo come fonte di storia ANRW II 30 2 pp 1298-1362
Franco C (1993) Trogo Giustino e i successori di Alessandro in L Braccesi - A Coppola - G Cresci Marrone - C Franco (a cura di) LrsquoAlessandro di Giustino dagli antichi ai moderni Roma pp 71-97
Gabba E (2003) Introduzione in D Foraboschi - SM Pizzetti (a cura di) La successione degli imperi e delle egemonie nelle relazioni internazionali Milano pp 7-9
Golan D (1995) The Res Graeciae in Polybius Four Studies Como
Green P (1990) Alexander to Actium The Historical Evolution of the Hellenistic Age Berkeley-Los Angeles
Gutschmid von A (1894) Die beiden ersten Buumlcher des Pompeius Trogus in A von Gutschmid - F Ruumlhl (hrsg) Kleine Schriften Leipzig pp 17-217
142 MONICA DrsquoAGOSTINI
Habicht C (1995) Athen Muumlnchen
Hammond NGL (1968) Illyris Rome and Macedon in 229-205 BC JRS 58 pp 1-21
Hammond NGL (1988) The Campaign and the Battle of Cynoscephalae in 197 BC JHS 108 pp 60-82
Heckel W (1997) Introduction (Part 2) in JC Yardley - W Heckel (eds) Ju-stin Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus Books 11-12 Alexander the Great Introduction Oxford pp 1-41
Heckel W (2012) Introduction in JC Yardley - P Wheatley - W Heckel (eds) Justin Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus II Books 13-15 The Successors to Alexander the Great Oxford pp 1-8
Huss W (1976) Untersuchungen zur Auszligenpolitik Ptolemaiosrsquo IV Muumlnchen
Huss W (2001) Aumlgypten in hellenistischer Zeit 332ndash30 v Chr Muumlnchen
Intrieri M (2011) Fra dialogo e conflitto Annibale e i Greci drsquoOccidente RStudFen 37 pp 53-82
Landucci F (2014) Filippo II e le Storie Filippiche un protagonista storico e storio-grafico in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 233-261
Landucci Gattinoni F (2011) Politica e ideologia in etagrave ellenistica laquoPolitica An-ticaraquo 1 pp 89-105
Leacutevy E (1994) Le discours drsquoAgeacutelaos de Naupacte in L Aigner Foresti - A Bar-zanograve - C Bearzot - L Prandi - G Zecchini (a cura di) Federazioni e federalismo nellrsquoEuropa antica Bergamo 21-25 settembre 1992 Milano (Alle radici della casa co-mune europea 1) pp 33-50
Longaretti L (1989) Lrsquoalleanza tra Annibale e Filippo V di Macedonia RIL 123 pp 183-192
Marasco G (1979-1980) La valutazione di Tolemeo IV Filopatore nella storiografia greca laquoSilenoraquo 5-6 pp 159-182
Mari M [- Musti D - Thornton J] (2002) Polibio Storie Volume III Libri V-VI Milano
Mariotta G (2014) Geografia e Geopolitica nelle Storie Filippiche in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 45-56
McGing B (2010) Polybiusrsquo Histories New York
McGing B (2013) Youthfulness in Polybius the case of Philip V of Macedon in B Gibson - T Harrison (eds) Polybius and his world Oxford pp 181-199
Meadows A (2013) Polybius Aratus and the History of the 140th Olympiad in B
IL DISCORSO DEL RE 143
Gibson - T Harrison (eds) Polybius and his World Essays in Honour of Frank Walbank Oxford pp 91-116
Mecca A (2001) Trogo Timagene e Polieno QS 54 pp 199-222
Meister K (1990) Die Griechische Geschichtsschreibung von den Anfaumlngen bis zum Ende des Hellenismus Stuttgart
Misch G (1949) Geschichte der Autobiographie I Frankfurt am Mein
Momigliano A (1980) Daniele e la teoria greca della successione degli imperi RAL 35 pp 157-162
Muccioli F (2013) Gli epiteti ufficiali dei re ellenistici Stuttgart (Historia Einzel-schriften 224)
Musti D (1978) Polibio e lrsquoimperialismo romano Napoli
Parmeggiani G (2011) Eforo di Cuma studi di storiografia greca Bologna
Peacutedech P (1964) La meacutethode historique de Polybe Paris
Pelling CBR [- Scardigli B - Manfredini M](1997) Plutarco Vite parallele Filopemene Tito Flaminino Milano
Richter H-D (1987) Untersuchungen zur hellenistischen Historiographie die Vorla-gen des Pompeius Trogus fuumlr die Darstellung der nachalexandrischen hellenistischen Ge-schichte (Iust 13-40) Frankfurt
Santi Amantini L (1972) Fonti e valore storico di Pompeo Trogo (Iustin XXXV e XXXVI) Genova
Santi Amantini L (1981) (a cura di) Giustino Storie Filippiche Epitome da Pom-peo Trogo Milano
Santi Amantini L (2003) Il tempo e i tempi nelle Storie Filippiche di Pompeo Tro-go RSA 33 pp 99-110
Schepens G (1983) Les rois ptolegravemaiumlques et lrsquohistoriographie Reacuteflexions sur la trans-formation de lrsquohistoire politique in E vanrsquot Dack - P van Dessel - W Van Gucht (eds) Egypt and the Hellenistic World Proceedings of the International Collo-quium Leuven 24-26 May 1982 Leuven (Studia Hellenistica 27) pp 351-368
Schlicher JJ (1933) Non-Assertive Elements in the Language of the Roman Histo-rians CPh 28 289-300
Schmitt T (1989) Die Bedeutung des zweiten Punischen Krieges fuumlr den Frieden in Naupaktos in H Devijver - E Lipinski (eds) Punic wars Proceedings of the Conference held in Antwerp from the 23th to the 26th of November 1988 in Cooperation with the Departement of History of the laquoUniversitait Antwerpenraquo UFSIA Leuven (Studia Phoenicia 10) pp 229-239
Scholten JB (2000) The Politics of Plunder Aitolians and their koinon in the early Hellenistic Era Berkeley
144 MONICA DrsquoAGOSTINI
Scuderi R (2005) Filippo V e Perseo nei frammenti diodorei in C Bearzot - F Lan-ducci (a cura di) Diodoro e lrsquoaltra Grecia Macedonia Occidente Ellenismo nella Bi-blioteca Storica Atti del convegno Milano 15-16 gennaio 2004 Milano pp 383-405
Sklenaacuter RJ (2004) Sources and Individuality in Two Passages of Livy laquoHistoriaraquo 53 pp 302-310
Sordi M (1982) Timagene di Alessandria Uno storico ellenocentrico e filobarbaro ANRW II 30 1 pp 775-797
Thornton J (2014) Le guerre macedoniche Roma
Urban R (1979) Wachstum und Kriese des achaumlischen Bundes Quellenstudien zur entwicklung des Bundes von 280 bis 222 V Chr Wiesbaden
Urban R (1982) laquoGallisches Bewusstseinraquo und laquoRomkritikraquo bei Pompeius Trogus ANRW II 30 2 pp 1424-1443
Vannicelli P (1987) Lrsquoeconomia delle Storie di Eforo RFIC 115 pp 165-191
Vattuone R (2014) Giustino e lrsquoOccidente greco I VI-V secolo aC in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 261-277
Vollmer D (1990) Symploke das Uumlbergreifen der roumlmischen Expansion auf den grie-chischen Osten Untersuchungen zur roumlmischen Aussenpolitik am Ende des 3 Jh V Chr Stuttgart
Walbank FW (1957) A Historical Commentary on Polibius I Oxford
Walbank FW (1967) A Historical Commentary on Polybius II Oxford
Walbank FW (1933) Aratos of Sicyon Cambridge
Walbank FW (2002) Η ΤΩΝ ΟΛΩΝ ΕΛΠΙΣ and the Antigonids in FW Walbank (ed) Polybius Rome and the Hellenistic World Essays and Reflections West Nyack NY pp 127-136
Weber G (1997) Interaktion Repraumlsentation und Herrschaft Der Koumlnigshof im Hel-lenismus in A Winterling (hrsg) Zwischen lsquoHausrsquo und lsquoStaatrsquo antike Houmlfe im Ver-gleich Munich pp 27-72
Will E (19822) Histoire politique du Monde Helleacutenistique II Nancy
Zecchini G (1990) La storiografia lagide in H Verdin - G Schepens - E De Keyser (eds) Purposes of History Studies in Greek Historiography from the 4th to the 2nd Centuries BC Proceedings of the International Colloquium of Leuven 24-26 May 1988 Leuven (Studia Hellenistica 30) pp 213-232
Zecchini G (2003) Polibio e la tradizione orale in A Casanova - P Desideri (a cura di) Evento racconto scrittura nellrsquoantichitagrave classica Firenze pp 123-141
Finito di stamparenel mese di novembre 2015
da LegoDigit srlLavis (TN)
IL DISCORSO DEL RE 123
guirono ciascuno con impegno le orme degli antenati e in loro rifulse un gran-de innato valore4
Questa introduzione sembra modellata sul cosiddetto lsquosecondo proe-miorsquo di Polibio (IV 2) la lista dei sovrani e lrsquoordine coincidono infatti con quello del Megalopolitano se non per lrsquoesclusione dellrsquousurpatore seleucide Acheo5 Lrsquointenzione del passo nelle due opere egrave perograve diver-sa mentre il Megalopolitano nel proemio metteva in risalto il sorgere quasi in contemporanea di nuovi conflitti in diverse parti del Mediter-raneo nellrsquoEpitome il filo conduttore di questo elenco di sovrani e con-dottieri egrave la loro gloria e la grandezza degli eventi che essi compirono in giovane etagrave6 Inoltre vi sono in Trogo alcune notizie originali rispetto al Megalopolitano il fatto che lrsquoepiteto Filopatore di Tolemeo IV sia mes-so in relazione con lrsquoassassinio dei genitori del sovrano oppure che lrsquoa-scesa di Annibale al comando dei Cartaginesi sia spiegata con il suo odio per i Romani Entrambe queste notizie non appartengono alla tradizio-ne polibiana in Polibio (II 36 3) Annibale era stato eletto comandante dellrsquoesercito in Spagna per i successi ottenuti mentre il padre Amilcare gli aveva fatto giurare odio eterno ai Romani Per quanto riguarda il Fi-lopatore Polibio ritiene che egli non abbia assassinato la madre Bereni-ce vittima invece del consigliere Sosibio (Polyb V 36 1)7 La versione di Trogo egrave dunque frutto di una propaganda avversa a Tolemeo IV che lo dipinge ancora piugrave negativamente di quanto fatto dalla tradizione poli-biana che certo giagrave non era favorevole al sovrano8
NellrsquoEpitome di Giustino segue una sintesi dei primi anni di regno di Filippo V in particolare vi egrave un brevissimo riferimento allrsquoinaspettata vit-toria del sovrano contro i Dardani che lo avrebbe portato a cercare lo
4 La traduzione di Giustino come tutte quelle presenti nel testo sono da Santi Amantini (1981) Lrsquounica eccezione a questa affermazione egrave il Filopatore Sulla tradizione storio-grafica avversa al Filopatore vd infra 5 Acheo egrave personaggio noto a Trogo che lo menziona altrove Prol XXX6 La giovinezza in TrogoGiustino egrave percepita come un valore aggiunto mentre per Poli-bio egrave una debolezza Eckstein (1995) p 143 McGing (2013) pp 181-1997 Muccioli (2013) pp 220-223 osserva che lrsquoepiteto fu assunto da Tolemeo IV quando il padre era vivo come strumento per sottolineare la sua predestinazione al trono 8 Polyb V 34 3-5 come anche Plut Cleom 33-34 forniscono notizie denigratorie su Tole-meo IV che sarebbe stato un sovrano inadatto a governare Secondo Huss (1976) pp 9 e 19 e (2001) pp 381-472 alla base vi sarebbe Filarco Se invece si considerano gli studi fatti su Tolemeo di Megalopoli da Schepens (1983) pp 351-368 e Zecchini (1990) pp 213-232 partic 218 egrave possibile che Tolemeo di Megalopoli nello scrivere unrsquoopera sto-riografica su un sovrano lagide non omettesse di menzionare notizie meno celebrative come Teopompo prima di lui aveva fatto nei confronti di Filippo II Sulla tradizione storiografica avversa a Tolemeo IV vd anche Marasco (19791980) pp 159-182 Weber (1997) pp 27ndash72 partic 28 Ager (2003) pp 35-50 McGing (2010) pp 117-119 Cri-scuolo (2011) pp 132-150 partic 148-149
124 MONICA DrsquoAGOSTINI
scontro con gli Etoli Egrave difficile dire se Trogo dedicasse piugrave spazio alla narrazione degli eventi tra il 220 e il 217 Nel Prologo si legge
Undetricensimo volumine continentur haec Res gestae Philippi regis adversus Dardanos et Aetolos repetitaeque inde Creticae origines post cuius insulae societatem Philippus cum Illyriis et Dardanis et rursus Aetolis bello congressus est adiuvantibus Aetolos Romanis quo finito intulit Attalo bellum
Il ventinovesimo libro contiene le imprese del re Filippo contro i Dardani e gli Etoli Sono quindi rievocate le origini di Creta dopo essersi alleato con questrsquoi-sola Filippo si scontrograve in guerra con gli Illiri i Dardani e di nuovo con gli Eto-li mentre i Romani soccorrevano gli Etoli Terminata questa guerra Filippo at-taccograve Attalo
Dal confronto tra Giustino e i Prologi egrave evidente che quella che per i mo-derni egrave la lsquoGuerra degli Alleatirsquo tra Etoli aiutati da Sparta e dallrsquoElide e la Lega Achea alleata di Filippo V sia ridotta sia in Giustino che in Tro-go a una guerra di Filippo contro gli Etoli Colpisce in effetti la comple-ta mancanza nel Prologo XXIX e nellrsquoEpitome del libro di qualsiasi men-zione e riferimento alla Lega Achea e al suo leader Arato protagonisti indiscussi invece nelle Storie polibiane dei primi anni di regno di Filippo V 9 Arato di Sicione importante statista e comandante militare della Le-ga Achea fu uno dei primi personaggi politici a scrivere e pubblicare le proprie memorie (FGrHist 231) di cui Polibio si servigrave ampiamente (I 3 1)10 Lo storico di Megalopoli era un compatriota di Arato e come lui ricoprigrave importanti cariche allrsquointerno della Lega Achea11 Polibio che considerava Arato uno dei fondatori della Lega vedeva in lui una sorta di eroe e leader ideale come emerge dalla descrizione che ne fa di uomo perfetto per lrsquoattivitagrave politica astuto tollerante coraggioso e di succes-so (IV 7 11-8 12) Il rapporto tra Filippo V e Arato egrave determinante per il giudizio di Polibio sul sovrano macedone Filippo egrave infatti descritto co-me un buon sovrano valoroso ma troppo giovane che nei primi anni di regno agigrave bene poicheacute ascoltograve e seguigrave i consigli di Arato (IV 77 1-4)12
Per quanto argumentum e silentio questa assenza di Arato di Sicione e della Lega Achea sia nel Prologo di Trogo che nellrsquoEpitome di Giustino
9 Polibio dedica alla Lega Achea ampia parte dei libri IV e V 10 Riguardo ad Arato di Sicione soprattutto nel rapporto con Polibio vd Meadows (2013) pp 91-116 Vd anche Walbank (1933) Misch (1949) pp 210-212 Urban (1979) Meister (1990) pp 187-189 Habicht (1995) pp 176-179 Beck - Eckstein (2015) sv laquoAratos of Sicyon (231)raquo in BNJ11 Sui legami di Polibio e la sua famiglia con la Lega Achea vd Eckstein (2013) pp 314-33812 Polyb IV 24 1-3 e V 26 6 seguito da Plut Arat 48-49 afferma esplicitamente che il re portava a termine abilmente i suoi piani poicheacute Arato era al suo fianco
IL DISCORSO DEL RE 125
non solo non puograve passare inosservata ma deve indurre i moderni a du-bitare per questi eventi di unrsquoapparente dipendenza diretta giagrave di Tro-go da Polibio
21- 38 Demetrio di Faro e Naupatto
Scomparso Arato nellrsquoEpitome XXIX ha invece un ruolo fondamentale in questi anni come consigliere di Filippo Demetrio di Faro a cui egrave at-tribuito il primo discorso in oratio obliqua dei due libri esaminati13
Demetrio di Faro era un dinasta illirico che si incontra per la prima volta nelle fonti storiografiche in occasione della prima guerra di Ro-ma in Illiria nel 229 Sappiamo infatti da Polibio (II 10 8-11 4) e Appia-no (Illyr 7) che Demetrio giagrave alleato di Teuta sovrana degli Illiri aveva scelto di passare dalla parte romana ed era stato poi ricompensato dal Senato con il controllo di parte dei territori sottratti da Roma a Teuta stessa Nei suoi tentativi di ritagliarsi un ruolo importante nella penisola balcanica Demetrio nel 222 si era alleato con la Lega Ellenica di Doso-ne e Arato a Sellasia contro Cleomene (Polyb II 65 2- 5) ma negli an-ni successivi le sue scorribande nellrsquoAdriatico allarmarono Roma che gli mosse guerra (Polyb III 16 IV 16)14 Sconfitto da Roma e cacciato da Faro Demetrio si rifugiograve alla corte di Filippo intorno al 218 diventan-do consigliere del re
Poicheacute nel Prologo XXVIII si legge laquoIn una digressione egrave narrata la guerra illirica combattuta dai Romani contro Teuta15raquo non egrave da esclu-dere che Trogo giagrave citasse il dinasta di Faro anche se la prima menzio-ne di Demetrio in Giustino egrave a XXIX 2 1 quando il cosiddetto lsquore de-gli Illirirsquo cacciato da Lucio Emilio Paolo dallrsquoAdriatico arrivograve alla corte macedone Nel riassunto degli eventi Giustino segue piugrave da vicino Tro-go riportando il discorso del dinasta a Filippo V per convincere il sovra-no a far guerra a Roma (XXIX 2 2-6) I punti principali di tale discorso sono che i Romani aspirano a realizzare un impero universale a scapito di tutti i re laquocome se fosse cosa illecita che ci fosse un qualche re presso i confini del loro Statoraquo Perciograve Filippo V doveva prepararsi alla guerra con i Romani poicheacute laquoquanto piugrave accessibile e illustre era il suo regno tanto piugrave accaniti nemici gli sarebbero stati i Romani16raquo Demetrio vole-
13 Su questi discorsi di Demetrio vd Coppola (1993) pp 29-5114 Coppola (1993) pp 29-51 vd anche Hammond (1968) pp 1-21 Eckstein (2008) pp 41 58-60 Demetrio di Faro era presentato in Polibio come il rivale di Arato tra i consi-glieri di Filippo Polyb IX 23 9 infatti dichiara che quando il sovrano seguiva i consigli di Arato compiva grandi imprese mentre quando ascoltava Demetrio si macchiava di atti spregevoli15 Trog Prol XXVIII Dictum in excessu bellum Illyricum quod Romani gessere cum Teuta16 Iust XXIX 2 4-5 sibi quoque non aliam ob causam quam quod Italiae finitimus uidebatur
126 MONICA DrsquoAGOSTINI
va infatti cacciare i Romani dalla sponda adriatica dellrsquoIlliria territorio che avrebbe ceduto a Filippo
Il discorso di Demetrio a Filippo egrave presente anche in Polibio (V 101 8-1017) ed egrave inserito cronologicamente durante i giochi Nemei18 nel 217 subito dopo la sconfitta romana del lago Trasimeno ricordata an-che nel passo di Giustino Nel discorso polibiano Demetrio perograve sotto-linea il diritto di Filippo V ad aspirare al dominio universale a partire dallrsquoAdriatico19 mentre nel discorso trogiano Demetrio accusa i Roma-ni di aspirare ad espandersi travolgendo qualsiasi regno sul loro cammi-no Trogo nel discorso di Demetrio presenta il coinvolgimento roma-no in Oriente come una guerra di conquista che contrappone la giova-ne potenza romana allrsquolsquoillustre regnorsquo di Filippo20 prospettiva che ritor-na nel successivo discorso di Filippo V nellrsquoEpitome ma che egrave estranea al-la narrazione di Polibio
Dopo il discorso di Demetrio nellrsquoEpitome come in Polibio (V 104 1) si arriva allrsquoincontro di pace di Naupatto nel 217 che pose fine al-la Guerra degli Alleati tra Etoli Spartani ed Elei contro la lega Achea e
bellum inlatum quasi nefas esset aliquem regem iuxta imperii eorum terminos esse Sed et ipsi cauen-dum esse exemplum cuius quanto promptius nobiliusque sit regnum tanto sit Romanos acriores hostes habiturus17 Polyb V 101 8-10 ὃς καὶ λαβόμενος τῆς ἀφορμῆς ταύτης τὸν μὲν πρὸς τοὺς Αἰτωλοὺς ᾤετο δεῖν τὴν ταχίστην ἀπορρῖψαι πόλεμον ἀντέχεσθαι δὲ τῶν κατὰ τὴν Ἰλλυρίδα πραγμάτων ἠξίου καὶ τῆς εἰς Ἰταλίαν διαβάσεως [9] τὰ μὲν γὰρ κατὰ τὴν Ἑλλάδα πάντα καὶ νῦν ἤδη ποιεῖν αὐτῷ τὸ προσταττόμενον ἔφη καὶ μετὰ ταῦτα ποιήσειν Ἀχαιῶν μὲν ἐθελοντὴν εὐνοούντων Αἰτωλῶν δὲ καταπεπληγμένων ἐκ τῶν συμβεβηκότων αὐτοῖς κατὰ τὸν ἐνεστῶτα πόλεμον [10] τὴν δ᾽ Ἰταλίαν ἔφη καὶ τὴν ἐκεῖ διάβασιν ἀρχὴν εἶναι τῆς ὑπὲρ τῶν ὅλων ἐπιβολῆς ἣν οὐδενὶ καθήκειν μᾶλλον ἢ ᾽κείνῳ τὸν δὲ καιρὸν εἶναι νῦν ἐπταικότων Ῥωμαίων Trad da Mari (2002) laquoCostui allora cogliendo lrsquooccasione gli consigliograve di interrompere al piugrave presto la guerra con gli Etoli e gli chiese di impegnarsi nelle operazioni in Illiria e nellrsquoattraversamento del mare verso lrsquoItalia Disse che infatti giagrave ora tutta la Grecia eseguiva i suoi ordini e lo avrebbe fatto anche in seguito poicheacute gli Achei lo sostenevano di loro iniziativa mentre gli Etoli erano rimasti molto colpiti da quanto era loro avvenuto nella guerra in corso e aggiunse che lrsquoItalia e lrsquoattraversamento del mare in quella direzione erano lrsquoinizio di un disegno di dominio universale che a nessuno spettava piugrave che a lui ora era il momento opportu-no visto che i Romani erano stati battutiraquo18 I giochi Nemei in onore di Zeus erano giochi panellenici celebrati in Argolide negli anni pari delle Olimpiadi 19 Secondo Eckstein (1995) pp 211-212 tale aspirazione egrave connessa allrsquoincapacitagrave di mo-derazione nella vittoria del sovrano Sul concetto di dominio universale in Polibio vd Musti (1978) pp 16-18 Eckstein (2008) pp 217-220 e 372-38120 Adler (2006) pp 383-407 e (2011) pp 37-58 ha notato che i punti principali del discorso di critica allrsquoespansionismo romano di Demetrio ritornano in altri due discorsi dellrsquoEpitome quello degli Etoli (XXVIII 2 1-13) e quello di Mitridate (XXXVIII 4-7) la prioritagrave data a questi argomenti da tale reiterazione retorica indica che lrsquointeresse giagrave di Trogo se non dellae suae fontei non fosse la celebrazione dellrsquoascesa di Roma allrsquoim-pero universale come in Appiano ma piuttosto lrsquoascesa e la discesa dei regni ellenistici
IL DISCORSO DEL RE 127
Filippo V 21 Il testo giustineo omette le circostanze dellrsquoevento non si menzionano infatti esplicitamente neacute il luogo dellrsquoincontro Naupatto neacute le fasi delle trattative neacute i vari rappresentanti dei diversi fronti che vi presero parte I lunghi negoziati di pace si risolvono dunque nel discor-so di Filippo V ai rappresentanti dei fronti
Il sovrano esordisce affermando che la Grecia egrave in grande pericolo percheacute chiunque avesse vinto tra Cartaginesi e Romani sarebbe poi pas-sato in Oriente Filippo utilizza la metafora delle nubi in Occidente che avrebbero macchiato con una pioggia di sangue ogni cosa spinte dai venti di vittoria inoltre il sovrano ritiene che le guerre passate dei Gre-ci siano di poco conto se paragonate alla minaccia di uno scontro con la moltitudine che si radunava in Italia descrivendo la rabbia e il valore di questi nuovi nemici che avrebbero portato rovina ai vicini Il sovrano infine ribadisce che la Grecia era in maggior pericolo della Macedonia ma che sapeva che chi avesse vinto in Italia non avrebbe frenato la sete di vittoria Perciograve anche la Macedonia stessa doveva temere un attacco
Il discorso in Polibio di Agelao di Naupatto rappresentante e leader degli Etoli22 mostra le medesime argomentazioni attribuite in Giustino allrsquointervento di Filippo argomentazioni fondate sul metus hostilis e fina-lizzate a promuovere un nuovo ruolo della Macedonia sia in Grecia che nel Mediterraneo Orientale Agelao proponendo un nuovo program-ma politico panellenico fonda le proprie argomentazioni sul metus hosti-lis per i Cartaginesi e i Romani presentati metaforicamente come nubi che incombono da Occidente Filippo dovrebbe farsi garante della tran-quillitagrave della Grecia che agendo come unrsquounica catena di cittagrave contro i barbari diverrebbe una sicura e fedele collaboratrice della Macedonia Questo permetterebbe ai Greci di conservare il diritto di far pace o guer-ra a loro piacimento senza temere che laquoi giochi da bambini con i quali ci trastulliamo tutti vengano troncati23raquo
Nonostante sia il medesimo discorso nelle due fonti Agelao introdu-ce una forte proposta di alleanza panellenica estranea alle parole di Fi-lippo Inoltre Filippo pur utilizzando la metafora delle nubi da Occi-
21 Interessanti le osservazioni di Scholten (2000) pp 224-228 a proposito della pace che sarebbe stata cercata e sperata da entrambe le parti e non imposta da Filippo come Polibio pare lasciar intendere 22 Vd soprattutto Leacutevy (1994) pp 33-50 Su questo discorso molto dibattuto dai moderni vd anche Schmitt (1989) pp 229-239 Vollmer (1990) pp 96-107 Coppola (1993) pp 149-164 Golan (1995) pp 55-74 Champion (1997) pp 111-128 e (2004) p 55 Wal-bank (2002) pp 127-136 Eckstein (2008) pp 78-83 23 Polyb V 104 10-11 καθόλου τὰς παιδιάς ἃς νῦν παίζομεν πρὸς ἀλλήλους ἐκκοπῆναι συμβῇ πάντων ἡμῶν ἐπὶ τοσοῦτον ὥστε κἂν εὔξασθαι τοῖς θεοῖς ὑπάρχειν ἡμῖν τὴν ἐξουσίαν ταύτην καὶ πολεμεῖν ὅταν βουλώμεθα καὶ διαλύεσθαι πρὸς ἀλλήλους καὶ καθόλου κυρίους εἶναι τῶν ἐν αὑτοῖς ἀμφισβητουμένων
128 MONICA DrsquoAGOSTINI
dente presente anche nelle Storie la arricchisce con la vivida immagine di una tempesta di sangue conferendo una dimensione piugrave concreta e cruenta alla predizione infine il riferimento polibiano alle guerre dei Greci nellrsquoEpitome non riguarda piugrave le guerre tra le cittagrave e le leghe gre-che ma le guerre dei Greci con Macedoni Persiani e Galli Mentre la Grecia scompare sullo sfondo la minaccia Romana egrave meno vaga e piugrave concreta e presente che in Polibio e diventa lrsquounico argomento del di-scorso di Filippo V a Naupatto
Il discorso di Demetrio e quello di Filippo sono al centro del libro XXIX dellrsquoEpitome avendo il duplice scopo di evidenziare sia la poten-ziale aggressivitagrave dei Romani sia la grande tradizione militare della Ma-cedonia e il pieno diritto di Filippo di controllare la Grecia e lrsquoIlliria fi-no allrsquoAdriatico Se il discorso in Polibio si inseriva in un dibattito politi-co dove la Grecia e la Macedonia erano protagoniste alla pari della sce-na ellenica e internazionale nella versione che leggiamo in Trogo i ri-ferimenti alle dispute della realtagrave greca sono reinterpretati a favore di un punto di vista in cui la Macedonia egrave lrsquounico potere dellrsquoOriente gre-co Del dibattito politico di III secolo in Grecia che tanto stava a cuore a Polibio non vi egrave piugrave alcuna traccia in TrogoGiustino rimane soltanto lo scontro tra le due grandi potenze di Oriente e Occidente tra Filippo e Roma Questa prospettiva bipolare dei discorsi trogiani si ritrova nel-la conclusione del capitolo che se da un lato sottolinea ancora una vol-ta il timore di Filippo per Cartaginesi e Romani dallrsquoaltro esplicita che i Romani avevano paura dellrsquoantica gloria dei Macedoni laquovincitori dellrsquoO-rienteraquo e soprattutto di Filippo laquoinfiammato dallo zelo di emulare Ales-sandro che era ben noto come pronto alle guerre e instancabileraquo24
41-11 La Prima Guerra Macedonica
Dei prodromi della Prima Guerra Macedonica Giustino si interessa sol-tanto allrsquoalleanza antiromana tra Annibale e Filippo Questo trattato egrave noto da molte fonti secondo cui Filippo dopo aver appreso che i Roma-ni erano stati sconfitti di nuovo dai Cartaginesi a Canne nel 216 avreb-be mandato unrsquoambasceria ad Annibale per proporre unrsquoalleanza ma lrsquoambasciatore macedone sarebbe stato catturato da Roma sulla via del ritorno25
24 Iust XXIX 3 8 quippe terrebat eos et uetus Macedonum deuicti Orientis gloria et Philippus studio Alexandri aemulationis incensus quem promptum in bella industriumque cognouerant Alla gloria dei Macedoni avevamo giagrave trovato riferimento nei discorsi del libro XXVIII degli Etoli (2 12) e di Antigono Dosone (3 14) 25 Secondo Polyb VII 9 17 Filippo avrebbe aiutato Cartagine nella guerra con Roma in cambio di Corcira Epidamno e Apollonia e della restituzione a Demetrio di Faro del suo regno Inoltre Filippo e Annibale si impegnavano a soccorrersi a vicenda in caso di
IL DISCORSO DEL RE 129
A prescindere dai dettagli del fermo dellrsquoambasciatore macedone da parte romana egrave possibile fare qualche osservazione sul nesso tra questo lsquoincidentersquo diplomatico e lo scoppio della guerra Cassio Dione e Ap-piano riportano che la cattura del legato avrebbe causato una vendetta di Filippo contro i protettorati romani in Adriatico in particolare Cor-cira26 notizia assente in Polibio come in Livio e Plutarco (che da Poli-bio dipendono)27 In questi ultimi autori lrsquoattacco di Filippo in Adriati-co infatti non sarebbe legato allrsquoepisodio dellrsquoambasciatore ma alla de-cisione del sovrano di rompere con il consigliere Arato e di dare ascol-to ai cattivi consigli di Demetrio di Faro presa dopo la spedizione a Mes-sene nel 215214 La tradizione polibiana legge infatti in questi eventi la manifestazione del cambiamento dellrsquoindole di Filippo V da giusta a empia iniziata con lrsquoepisodio della stasis di Messene del 215 e compiu-ta con lrsquoassassinio di Arato del 21328 Nel libro XXIX di Giustino ben-cheacute si conservi traccia dellrsquoindole aggressiva di Filippo e del consiglio di Demetrio di Faro come prodromi dello scontro con Roma non vi sono indizi della metaboleacute del sovrano da giusto a empio e malvagio e neppu-re del ruolo che in tale cambiamento ricoprigrave lrsquoallontanamento tra Ara-to e Filippo
attacco da parte di Roma Mentre Peacutedech (1964) pp 382-383 ritiene sicura la consulta-zione a Roma di tali documenti Zecchini (2003) pp 123-141 come prima di lui Walbank (1957) I p 32 n 4 non ne egrave certo poicheacute Polibio viaggiograve proprio per poter reperire documenti e informazioni sugli eventi dove essi avvennero Altre fonti Liv XXIII 38 7 Plut Arat 51 2 Dio C XV 4 2 e App Mak Fr 1 Sul confronto delle fonti vd DrsquoAgostini (2011) pp 99-121 Sul trattato macedone-cartaginese vd Cassola (1962) pp 65-66 Wal-bank (1967) II pp 42-44 Will (19822) pp 83-84 Barreacute (1983) Longaretti (1989) pp 183-192 Golan (1995) pp 45-46 Eckstein (2008) pp 83-85 Intrieri (2011) pp 53-8226 Dio C XV 4 2 e App Mak Fr1 Filippo per vendicarsi della cattura del proprio amba-sciatore non solo attaccograve Corcira ma saputo dellrsquoarrivo di Levino durante la ritirata da Corcira saccheggiograve anche Apollonia e Orico alleate romane Levino avrebbe poi sconfit-to Filippo e recuperati gli alleati costringendo il re a bruciare le proprie navi e rientrare via terra Si riferisce a questo episodio probabilmente il Mak Fr 9 di Appiano che riporta lrsquoordine di Filippo di uccidere quanti erano sulle navi percheacute non dicessero ai Romani che le forze macedoni erano stremate DrsquoAgostini (2011) pp 99-12127 Polyb V 108-110 Liv XXIV 40 e Plut Arat 51 2 non menzionano Corcira nella narra-zione dellrsquoalleanza macedone-cartaginese e della cattura dellrsquoambasciatore Secondo Liv XXIII 38 7 lrsquoambasciatore sarebbe stato trattenuto a Roma 28 Polyb VII 11 8-11 e Plut Arat 49 1 Coppola (1993) pp 205-210 Dai frammenti di Polyb VII 10-12 e dalla narrazione di Plut Arat 49-51 sappiamo che Filippo era interve-nuto nella stasis di Messene tra oligarchici e democratici ma aveva di nascosto lasciato che i cittadini si massacrassero Una volta giunto Arato la guerra civile fu finalmente sedata ma il sovrano avrebbe voluto su consiglio di Demetrio di Faro approfittare della situazione e imporre una guarnigione nellrsquoacropoli della cittagrave che gli avrebbe conferito un vantaggio strategico per il controllo del Peloponneso Arato dissuase Filippo da per-seguire unrsquoazione militare in Peloponneso ma il re decise su consiglio di Demetrio di rivolgere la sua aggressivitagrave verso lrsquoIlliria prima e i protettorati romani Orico e Apollonia poi
130 MONICA DrsquoAGOSTINI
Dopo aver accennato alla stipula del trattato Giustino affastella ne-gli ultimi paragrafi del capitolo 4 gli eventi tra il 215 e il 205 quando Fi-lippo siglando la pace con Roma pone fine alla Prima Guerra Macedo-nica29 In particolare lrsquoEpitomatore sottolinea da un lato lrsquoingresso in guerra degli Etoli al fianco dei Romani e la successiva alleanza del preto-re Levino con Attalo dallrsquoaltro gli attacchi subiti da parte dei Dardani da Filippo oppresso dalle richieste degli Illiri Il libro dunque si chiude con Filippo in difficoltagrave aggravate dalla comparsa di Filopemene il leader degli Achei30 urtatosi con il re dei Macedoni convince la Lega Achea a staccarsi dallrsquoalleanza con la Macedonia sempre piugrave isolata Tale allon-tanamento egrave considerato da Giustino lrsquoesito di un fallito agguato a Fi-lopemene commissionato da Filippo V e dovuto al sospetto di un tradi-mento del condottiero acheo a favore di Roma Bencheacute anche Plutarco (Fil 12 2) e Pausania (VIII 50 4) menzionino il tentativo di assassinio di Filopemene da parte di Filippo la notizia dellrsquoatteggiamento filoroma-no del generale acheo non parrebbe vicino al ritratto polibiano che ve-de in Filopemene un eroe dellrsquoautonomia e dellrsquoindipendenza achea31
Libro XXX11-39 Cinoscefale
Lrsquoesordio del libro XXX introducendo il grande scontro di Cinoscefale tra Romani e Macedoni riprende la celebrazione della gloria macedo-ne argomento centrale dei discorsi del libro XXIX Con lrsquoeccezione dei primi capitoli sul deplorevole comportamento di Tolemeo IV in Egit-to32 il libro egrave infatti totalmente dedicato allo scontro tra le due potenze
29 Errington (2008) pp 185-190 La guerra egrave nota a noi soprattutto dai frammenti dei libri VIII-XI di Polibio dai passi di Liv XXIV 40 1-17 XXVI 24 1-26 4 XXVII 30 5-33 5 e XXVIII 5 1- 9 1 XXIX 12 1-15 e dalla Vita di Filopemene di Plutarco La sinteticitagrave del riassunto giustineo impedisce un puntuale paragone delle tradizioni Ad esempio la notizia dellrsquoalleanza tra Attalo e Roma sembra tornare in Liv XXVIII 5 1-4 dove perograve non troviamo Levino ma Sulpicio come rappresentante romano personaggio scompar-so in Giustino In maniera simile la pace di Fenice del 205 egrave sintetizzata in Giustino in una riga e non vi egrave traccia delle lunghe trattative che coinvolsero come mediatori anche Egitto Chio Mitilene e Atamania portarono a una prima pace separata tra Filippo e gli Etoli nel 206 e poi alla pace con Roma Le fonti parallele sono molto piugrave dettagliate anche su questi eventi Polyb XI 4 1-6 9 Liv XXVIII 5 13 e XXIX 12 8-16 e App Mak fr III Degno di nota egrave perograve il commento in Giustino secondo cui laquoi Romani erano per il momento soddisfatti di aver rinviato la guerra contro la Macedoniaraquo Lrsquointenzione ro-mana di riprendere la guerra con la Macedonia egrave infatti presente in tutte le fonti Polyb XI 6 7 Liv XXIX 1216 Dio C XVIII 9 (15) e App Mak Fr III e verragrave ripresa al libro XXX dellrsquoEpitome 30 Su Filopemene e Filippo vd Errington (1969) pp 51-69 e 83-84 vd anche Golan (1995) pp 115-132 Eckstein (2008) pp 103 e 360-36131 Pelling (1997) pp 135-13932 Lrsquoesordio del libro XXX egrave dedicato alle scabrose imprese del sovrano egiziano ovvero
IL DISCORSO DEL RE 131
dellrsquoEst e dellrsquoOvest La prima avvisaglia dellrsquoincombente guerra egrave la no-tizia dellrsquoaccordo di Filippo V e Antioco III per la spartizione dellrsquoEgitto governato dal sovrano-bambino Tolemeo V Il sovrano lagide nel 2032 chiese aiuto ai Romani che secondo TrogoGiustino gradirono la ri-chiesta drsquoaiuto percheacute cercavano pretesti per muovere guerra contro Fi-lippo A partire da Polibio numerose altre fonti ci testimoniano questo episodio mettendolo in relazione con lo scoppio della Seconda Guerra Macedonica ed esprimendo una condanna morale per lrsquoempia condotta del re antigonide che cospira contro un bambino33 al contrario nellrsquoE-pitome si esalta la potenza macedone evidenziando la paura dei Romani delle grandi imprese di Filippo (XXX 3 2)
nullius magis arma metuebant reputantibus quantum motum Pyrrhus parua Macedo-num manu in Italia fecisset quantasque res Macedones in Oriente gessissent
di nessun altro temevano maggiormente le armi poicheacute ripensavano a quanto sconvolgimento Pirro aveva provocato in Italia con una piccola schiera di Ma-cedoni e a quanto grandi imprese i Macedoni avevano compiuto in Oriente
La supremazia macedone egrave anche al centro del discorso in oratio obliqua di Filippo allrsquoincontro nel Golfo Maliaco tra i rappresentanti dei fronti coinvolti nella Seconda Guerra Macedonica34 NellrsquoEpitome infatti dopo
la Quarta Guerra Siriaca conclusa con sconfitta a Rafia contro Antioco III nel 217 e la corruzione del sovrano da parte di Agatocle e della sorella una cortigiana che avrebbe sedotto il re Giustino riferisce poi la morte del sovrano nel 204 e lrsquoascesa al trono del piccolo Tolemeo V Epifane sovrano sotto tutela di Tlepolemo dopo la morte di Agatocle e Sosibio 33 Eckstein (2008) pp 121-180 Thornton (2014) pp 65-88 In particolare sulla relazione tra il complotto e la sconfitta antigonide e seleucidica ad opera di Roma la superioritagrave morale romana ai regni ellenistici e la causalitagrave storica in Polibio (XV 20 6) vd Eck-stein (2008) pp 133-138 Ager (2009) pp 15-43 Landucci Gattinoni (2011) pp 89-105 Secondo Polyb III 2 8 XV 20 XVI 1 8-9 seguito da Liv XXXI 14 5 Filippo avrebbe ottenuto le basi tolemaiche in Egeo Samo e la Caria mentre Antioco avrebbe finalmente avuto mano libera in Celesiria e Fenicia oggetto di quasi un secolo di lotte tra Tolemei e Seleucidi La notizia del trattato permette a Polibio di dedicare alcuni paragrafi (XV 20) a condannare aspramente lrsquooperato di Filippo V e Antioco III definendoli empi e senza pudore e dichiarando che la Fortuna punigrave i due sovrani per il loro crudele operato por-tando i Romani contro di loro vd infra App Mak Fr IV trasmette delle clausole secondo cui Antioco avrebbe avuto lrsquoEgitto e Cipro mentre Filippo avrebbe ottenuto Cirene le Cicladi e la Ionia Infine secondo Porfirio FGrHist 260 F 45 lrsquoaccordo prevedeva che i due sovrani annettessero i possedimenti tolemaici confinanti con i rispettivi regni 34 Prima si menziona unrsquoambasceria del Senato a Filippo e Antioco percheacute laquosi astenessero dallrsquoEgittoraquo e la visita di Lepido in Egitto Quindi le lamentele a Roma di Attalo e i Rodii nei confronti di Filippo Egrave probabile che a questo punto Trogo inserisse la campagna di Filippo in Asia contro Attalo menzionata nel Prologo XXX ma tagliata nellrsquoEpitome La cronologia degli scambi diplomatici precedenti la Seconda Guerra Macedonica egrave stra-volta dalla sintesi dellrsquoEpitomatore e rende impossibile qualsiasi confronto con le altre
132 MONICA DrsquoAGOSTINI
il riassunto delle ambascerie nel Mediterraneo preludio allo scontro della prima fase della guerra35 maggior spazio egrave dato al tentativo di pa-ce a Nicea tra Roma Attalo i Rodii gli Achei e gli Etoli e Filippo V nel 198 In questa occasione Filippo rivendica la posizione di dominio dei Macedoni sui Greci ereditata da Filippo II e Alessandro suoi antenati e in virtugrave di tale supremazia macedone rifiuta che i Greci gli dettino le condizioni di pace ma chiede che sia il Senato a decidere Egrave significati-vo che non solo il discorso di Filippo non compaia in nessuna delle fon-ti parallele che descrivono nel particolare le posizioni degli ambasciato-ri di Achei Etoli Rodii e Attalo ma che Polibio (XVIII 8 8)36 affermi che era difficile sapere cosa si fossero detti Filippo e Flaminino durante i colloqui nel Golfo Maliaco Secondo la tradizione polibiana infatti il sovrano accompagnato da due philoi macedoni Apollodoro e Demoste-ne chiese di allontanare dalle trattative tutti tranne i Romani e discus-se la pace solamente con Flaminino Successivamente a causa dellrsquoinca-pacitagrave di trovare un accordo Filippo chiese due mesi di tregua e lrsquointer-vento del Senato Trogo dunque restituisce il discorso che il resto della tradizione riteneva impossibile da conoscere indicando chiaramente la presenza di una fonte diversa rispetto a Polibio su questo avvenimento piugrave informata sul punto di vista di Filippo e interessata a evidenziare la convinzione di Filippo V di avere un diritto di supremazia sulla Grecia in virtugrave delle imprese di Filippo II e Alessandro
La battaglia di Cinoscefale nel 197 momento risolutivo dello scontro tra Roma e Macedonia egrave lrsquoevento principale del libro XXX omina e pre-sagi introducono lrsquoevento campale lrsquoeruzione del vulcano di Santorini
fonti In Polyb XVI 24 3 App Mak Fr IV Liv XXXI 1 10 21 5 5 Paus I 36 5-6 vi sono differenti versioni della sequenza delle ambascerie che denunciarono a Roma lrsquoe-spansionismo macedone ma tutte concordano che le ambascerie precedettero lrsquoinvio dei legati romani in Oriente e che esse furono inviate anche da Atene e dagli Etoli Inoltre secondo la tradizione polibiana (Polyb XVI 27 1-4 34 1-7 Liv XXXI 2 3 6 3-8 4 18 1-9 Diod XXVIII 6) vi furono due diverse ambascerie di cui la seconda sarebbe stato un ultimatum al sovrano recapitato da Lepido In occasione di questa seconda ambasceria avvenuta durante il cruento assedio di Abido Filippo avrebbe detto che i Macedoni in ca-so di guerra si sarebbero difesi con valore In Giustino si puograve notare che ancora una volta dagli eventi sono omesse notizie fondamentali sui Greci nello specifico lrsquoambasceria di Atene la cui disputa con gli Acarnani fu il casus belli della guerra contro Filippo 35 Come i prodromi anche la prima parte della Seconda Guerra Macedonica egrave sintetizza-ta in Giustino e occupa solamente due paragrafi Come spesso accade nei passi sintetiz-zati dallrsquoEpitomatore si trovano le incongruenze maggiori con le fonti parallele tra cui si nota soprattutto la completa omissione di Giustino delle campagne di Publio Sulpicio Galba Massimo di Villio delle vittorie di Tito e Lucio Flaminino e dellrsquoassemblea del 198 che portograve gli Achei ad allearsi con Roma Polyb XXII e Liv XXXI 14 1- 46 16 XXXII 1 1-25 12 App Mak Fr VII Plut Fil 17 4 Flam 5 4 e Paus VII 8 1-236 Le trattattive sono descritte con particolari in Polyb XVIII 1-12 seguito da Liv XXXII 32 6-36 10 e Plut Flam 5 8 e 7 1-3
IL DISCORSO DEL RE 133
nel 197 e lrsquoemergere dellrsquoisola di Hiera e in contemporanea il terremo-to a Rodi Quindi nellrsquoEpitome si annuncia che laquoil nascente impero dei Romani avrebbe divorato quello antico dei Greci e dei Macedoni37raquo Nel passo ricevono spazio soprattutto i due discorsi contrapposti del re ma-cedone Filippo e del comandante romano Flaminino pronunciati pri-ma dello scontro campale e costruiti ciascuno in modo da celebrare le imprese delle due potenze38 Lrsquoenfasi data dalla contrapposizione reto-rica delle parole dei generali egrave tale da rendere suggestiva lrsquoipotesi che lo scontro dovesse essere il momento centrale non solo del libro XXX ma forse di tutta lrsquoopera trogiana
Filippo elenca le grandi vittorie del passato dei Macedoni contro Per-siani Battriani Indiani e le popolazioni drsquoAsia fino allrsquoestremo Orien-te esortando i suoi a combattere con valore percheacute laquola libertagrave egrave piugrave cara del predominio39raquo Il discorso di Flaminino egrave invece piugrave lungo articola-to in un paragone tra Macedoni e Romani alle passate imprese di con-quista macedoni vengono contrapposte le piugrave recenti vittorie romane a Cartagine in Sicilia Italia e Spagna alla grandezza di Alessandro Ma-gno egrave contrapposta quella di Annibale che pure dai Romani era stato sconfitto Lrsquoattenzione poi si concentra su Filippo i Macedoni non laquodo-vevano essere valutati per lrsquoantica forza ma per le forze attuali40raquo poicheacute Filippo non era lrsquoinvitto e invincibile Alessandro Magno ma un ragaz-zo che non riusciva a difendere i propri confini I Macedoni rivendica-vano il valore degli antenati mentre i Romani quello dei propri soldati poicheacute quelli che erano ligrave schierati erano gli stessi che avevano sconfitto Annibale Dopo una cosigrave grandiosa introduzione la battaglia egrave descritta in uno dei paragrafi piugrave significativi di tutta lrsquoopera
His adhortationibus utrimque concitati milites proelio concurrunt alteri Orientis alteri Occidentis imperio gloriantes ferentesque in bellum alii maiorum suorum antiquam et ob-soletam gloriam alii uirentem recentibus experimentis uirtutis florem [16] Sed Macedo-nas Romana Fortuna uicit
I soldati incitati da queste esortazioni dallrsquouna e dallrsquoaltra parte si lanciaro-no nel combattimento vantandosi gli uni del dominio dellrsquoOriente gli altri dellrsquoOccidente e recando in guerra gli uni lrsquoantica e sbiadita gloria dei loro an-
37 Iust XXX 4 4 Quo prodigio territis omnibus uates cecinere oriens Romanorum imperium uetus Graecorum ac Macedonum uoraturum38 Sui discorsi precedenti la battaglia nellrsquoantichitagrave se da considerare reali o costruzioni storiografiche vd Adler (2011) pp 6-839 Iust XXX 4 7 tantoque hoc bellum fortius quam illa sustinendum quanto sit imperio libertas carior40 Iust XXX 4 10 Sed nec Macedonas ueteri fama sed praesentibus uiribus aestimandos
134 MONICA DrsquoAGOSTINI
tenati gli altri il fiore del loro valore fresco e vigoroso per le recenti prove Ma la Fortuna dei Romani vinse i Macedoni
Questo punto di vista probabilmente giagrave trogiano contrappone la virtugrave romana (virtutis flos) celebrata nei discorsi antecedenti la battaglia al-la Fortuna romana (Romana Fortuna) che decise la vittoria interpretabi-le come destino favorevole o buona stella Piugrave che unrsquoaffermazione anti-romana41 come egrave spesso stata intesa si puograve evidenziare il carattere sim-patetico della fonte verso Filippo V destinato a porre fine alla gloria di Filippo II e Alessandro e forse un approccio nostalgico verso i grandi regni macedoni la cui egravera egrave ormai giunta alla fine Tale prospettiva egrave as-sente in Polibio e nella tradizione che da lui dipende poco interessata alle vicende della gloria macedone leggendo infatti i frammenti soprav-vissuti del libro XVIII delle Storie dopo lrsquoaccurata descrizione della bat-taglia (18-33 e 34-40)42 Polibio commenta lo scontro affermando che avrebbe dedicato alcuni capitoli allrsquoesame delle strategie militari delle due armate percheacute (XVIII 28 4-6)
χρήσιμον καὶ καλὸν ἂν εἴη τὸ τὴν διαφορὰν ἐρευνῆσαι καὶ παρὰ τί συμβαίνει Ῥωμαίους ἐπικρατεῖν καὶ τὸ πρωτεῖον ἐκφέρεσθαι τῶν κατὰ πόλεμον ἀγώνων [5] ἵνα μὴ τύχην λέγοντες μόνον μακαρίζωμεν τοὺς κρατοῦντας ἀλόγως καθάπερ οἱ μάταιοι τῶν ἀνθρώπων ἀλλ᾽ εἰδότες τὰς ἀληθεῖς αἰτίας ἐπαινῶμεν καὶ θαυμάζωμεν κατὰ λόγον τοὺς ἡγουμένους
Puograve essere cosa buona e utile esaminare le differenze e per quale motivo i Ro-mani prevalgono e riportano il primo premio nelle competizioni di guerra af-fincheacute non esaltiamo i vincitori senza una ragione parlando solo di fortuna co-me fanno gli sciocchi ma conoscendo le vere cause lodiamo e ammiriamo i co-mandanti seguendo una logica
Polibio dunque sembra rispondere a coloro che parlavano della buo-na stella dei Romani sottolineando che la vittoria nasceva dalla superio-re strategia militare della legione43 Un punto di vista quindi opposto a quello espresso nellrsquoEpitome che proprio di Romana Fortuna parla e riba-dito in chiusura al passo dove Polibio critica nuovamente quei Greci che ritenevano la vittoria romana incredibile (XVIII 32 13)
41 Urban (1982) pp 1424-1443 1435 Richter (1987) p 19 n 4 Alonso-Nuacutentildeez (1992) p 66 e Id (2002) pp 105-110 partic 108-109 Contra Heckel (1997) p 29 che ridimen-siona la categorizzazione di Trogo come storico anti-romano 42 Su Cinoscefale vd Walbank (1957) ad l Hammond (1988) pp 60-82 Sklenaacuter (2004) pp 302-310 Thornton (2014) pp 83-87 43 Sulla Fortuna in Polibio vd McGing (2010) pp 195-201 (con bibliografia) che distin-gue tra quando Polibio intenda caso e quando predeterminazione fato Vd anche Green (1990) pp 400-402 e Eckstein (2008) pp 132-138
IL DISCORSO DEL RE 135
Il punto di vista di Trogo sembra invece presente nei frammenti del-la Makedonikeacute di Appiano su Filippo V44 dove ci si riferisce a Cinoscefale come a una vittoria insperata (Mak 9 1)
ἡγούμενος δ᾽ οὔτε Ῥωμαίοις συμφέρειν οὔτε τοῖς Ἕλλησι Φιλίππου καθαιρεθέντος ἐπιπολάσαι τὴν Αἰτωλῶν βίαν τάχα δ᾽ αὐτὸν καὶ τὸ παράδοξον τῆς νίκης ἀγαπᾶν ἐποίει
Flaminino era consapevole che non sarebbe stato vantaggioso per i Romani o per i Greci che Filippo fosse deposto e che il potere etolico rimanesse incon-trastato forse lo aveva reso moderato nei suoi progetti lrsquoaver ottenuto una vit-toria insperata
Addirittura successivamente si accenna alla sorte avversa a Filippo nel-lo scontro
τὰ μὲν δὴ παρὰ τῶν ἄλλων φιλάνθρωπα ἦν τό τε τῆς τύχης ἄδηλον ἐξ ὧν ἔπαθεν ὁ Φίλιππος ὑφορωμένων καὶ τὸ πταῖσμα τοῦτο οὐ κατ᾽ ἀσθένειαν ἀλλὰ πλέον ἐκ συντυχίας αὐτὸν παθεῖν ἡγουμένων
Gli altri (Greci) erano inclini ad essere moderati vedendo con sospetto lrsquoincer-tezza della fortuna subita da Filippo e ritenendo che egli fosse incorso in questa sconfitta non tanto per la sua inferioritagrave quanto per la sfortuna
Il riferimento in Appiano e Trogo alla fortuna romanasfortuna ma-cedone a proposito di Cinoscefale egrave una traccia dellrsquoopinione politi-ca di quei Greci disprezzati da Polibio come uomini sciocchi καθάπερ οἱ μάταιοι τῶν ἀνθρώπων Tale posizione politica su Cinoscefale sarebbe dunque sopravvissuta nella tradizione storiografica di cui troviamo trac-cia in TrogoGiustino e Appiano
Per comprendere meglio alcune caratteristiche di questa tradizione puograve essere utile tornare ai due discorsi nellrsquoEpitome di Filippo e Flamini-no prima della battaglia Tali passi probabilmente trogiani45 non trova-no infatti riscontro nelle fonti parallele a noi pervenute Polibio (XVIII 18-27) seguito fedelmente da Livio (XXXIII 5-10) pur descrivendo le operazioni di guerra di Cinoscefale con dovizia di particolari non men-ziona un discorso di Filippo ai suoi armati prima della battaglia mentre il discorso di Flaminino per incoraggiare le truppe schierate (XVIII 23 2-6) nelle Storie egrave incentrato sulle vittorie di Sulpicio nella prima parte della guerra Pare dunque originale la versione trogiana che incentra-
44 Tra i frammenti consegnatici dagli Excerpta Constantiniana sono frequenti informazio-ni e osservazioni che rimandano a una prospettiva ellenistica sugli eventi DrsquoAgostini (2011) pp 99-121 45 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362
136 MONICA DrsquoAGOSTINI
ta sulla gloria macedone presenta Cinoscefale come il punto drsquoincon-tro e di scambio tra lrsquoegemonia macedone e lrsquoegemonia romana Non egrave una novitagrave che il leitmotiv delle Storie Filippiche e dunque dellrsquoEpitome sia la translatio imperii giagrave Alonso Nuntildeez definito da Santi Amantini laquouno dei piugrave noti esperti di questioni trogiano-giustineeraquo46 osservava che Tro-go esponeva nel suo perduto lavoro la teoria della successione degli im-peri mondiali secondo lo schema Assiria-Media-Persia-Macedonia-Roma osteggiata dai Parti47 In tale successione il ruolo da protagonista egrave rico-perto dallrsquoegemonia macedone48 che occupa allrsquoincirca 26 dei 44 libri e il cui ultimo vero momento di gloria egrave lo scontro con Roma appunto a Cinoscefale Lrsquoultima impresa macedone ha come esito la transizione del dominio universale da Oriente a Occidente e costituisce il tema cen-trale dellrsquointera vicenda di Filippo lrsquoimportanza della battaglia di Cino-scefale egrave perciograve esaltata nei discorsi sia di Filippo che di Flaminino che a loro volta sono il punto di arrivo delle argomentazioni esposte nelle parole di Demetrio di Faro e di Filippo stesso giagrave nel libro XXIX Le ora-tiones disposte retoricamente nei due libri descrivono due parabole op-poste da un lato quella romana che da lontana potenza desiderosa di espandersi cresce come una pioggia di sangue diventando il giovane e vigoroso potere che sottomesso Annibale egrave pronto a sconfiggere Filip-po Dallrsquoaltro quella macedone che originata con Filippo II personag-gio centrale per Trogo raggiunge il suo apice con la conquista dellrsquoege-monia ad opera di Alessandro Magno contro i Persiani per conoscere la fine con Filippo V il cui antico valore egrave ormai troppo lsquosbiaditorsquo per te-ner testa al vigore romano
La gloria macedone secondo Trogo inizia dunque con Filippo II e si conclude con Filippo V Perseo egrave infatti il malvagio responsabile dellrsquoan-nientamento di ciograve che rimaneva della monarchia macedone49 Trogo pone agli estremi della parabola macedone che occupa dal libro IX al XXX i due re di nome Filippo Filippo II e Filippo V come ribadito in piugrave luoghi dellrsquoEpitome sia in parti riassunte da Giustino che in passi piugrave genuinamente trogiani Dando per scontato che il titolo dellrsquoopera Sto-rie Filippiche si debba al desiderio di Trogo di rifarsi allrsquoopera di Teopom-po sul sovrano macedone egrave possibile che tale titolo sia stato perograve ripen-
46 Santi Amantini (2003) pp 99-11047 laquoPompeius Trogus expounded in his lost work the Historiae Philippicae a theory of the world empire suggestion according to the scheme Assyria-Media-Persia-Macedonia-Rome opposed by the Parthiansraquo Alonso-Nuacutentildeez (2002) pp 105-110 e 133-136 partic 105 Vd anche Richter (1987) pp 19-23 Momigliano (1980) pp 157-162 Alonso-Nuacutentildeez (1992) Heckel (1997) pp 1-41 Gabba (2003) pp 7-9 Santi Amantini (2003) pp 99-110 Mariotta (2014) pp 45-56 48 Franco (1993) pp 71-97 e Landucci (2014) pp 233-26149 Alonso-Nuacutentildeez (2002) pp 105-110 partic 108-109
IL DISCORSO DEL RE 137
sato da Trogo considerando che il periodo compreso tra le imprese dei due Filippo occupa 23 dellrsquoopera50 Si potrebbe allora suggerire che le Storie sono Filippiche poicheacute i due Filippo segnarono lrsquoinizio e la fine di quella che egrave nellrsquoopera di Trogo lrsquoegemonia incontrastata del mondo piugrave gloriosa di tutti i tempi51
La prospettiva ellenistica che vede nei due Filippo i limiti della grande egemonia macedone egrave di nuovo presente anche in Appiano nellrsquooraco-lo riportato nei frammenti della sua Makedonikeacute e noto anche da Pausa-nia (VII 8 9)
αὐχοῦντες βασιλεῦσι Μακηδόνες Ἀργεάδῃσιν ὑμῖν κοιρανέων ἀγαθὸν καὶ πῆμα Φίλιππος ἤτοι ὁ μὲν πρότερος πόλεσιν λαοῖσί τ᾽ ἄνακτας θήσει ὁ δ᾽ ὁπλότερος τιμὴν ἀπὸ πᾶσαν ὀλέσσει δμηθεὶς δ᾽ ἑσπερίοισιν ὑπ᾽ ἀνδράσιν ἐνθάδ᾽ ὀλεῖται
O Macedoni che andate orgogliosi dei re di stirpe argiva I re di nome Filippo saranno arbitri del bene e del male per voi Il primo vi renderagrave signori di cittagrave e popoli il secondo vi priveragrave di ogni onore sconfitto da uomini dellrsquoOcciden-te qui giace morto52
Senza voler entrare nel merito della discussione di tale oracolo di nuo-vo pare di incontrare nei due autori la medesima prospettiva lontana dalla condanna morale del re macedone espressa da Polibio secondo cui la sconfitta egrave il giusto esito della sua crudeltagrave ed empietagrave
Il libro giustineo si conclude menzionando le condizioni della pa-ce di Tempe53 e lrsquoira degli Etoli che videro ignorate le proprie richieste da Flaminino e perciograve cercarono lrsquoalleanza di Antioco contro Roma Se-condo il Prologo XXX il libro perograve proseguiva con le campagne di Antio-co III in Asia Minore contro Molone e Acheo e in Battriana fino ad ar-rivare allrsquoesordio dello scontro con Roma54 Il riassunto giustineo egrave trop-po sommario per permettere un confronto con le fonti parallele Egrave pe-
50 Sul rilievo della storia della Macedonia nellrsquoopera di Trogo e Giustino vd von Gutsch-midt (1894) pp 17-217 Richter (1987) p 28 n 29 Franco (1993) pp 71-97 51 Vd anche Urban (1982) pp 1424-1443 e Alonso-Nuacutentildeez (1992) p 58 52 Mak Fr 2 Vd DrsquoAgostini (2011) pp 99-121 In questa Walbank (2002) pp 127-136 propone di interpretare anche un poema di Alceo di Messene (Anth Pal 9518)53 Egrave probabile che Trogo fornisse piugrave particolari riguardo a questa pace per esempio si puograve ritenere che vi fosse menzione dellrsquoinvio a Roma del figlio Demetrio da parte di Filippo come ostaggio dato che a Iust XXXII 2 3 si richiama appunto tale avvenimento54 Polyb XVIII 34 1-39 7 42 1-45 12 Liv XXXIII 11 3-13 15 24 1-31 11 Plut Flam IX 1-8 App Mak Fr IX riferiscono di due diverse trattative di pace caratterizzate da un vivace dibattito tra chi voleva lrsquoannientamento della Macedonia come in Grecia gli Etoli e a Roma Marco Claudio Marcello e coloro che desideravano la pace con la Macedonia in primis Flaminino
138 MONICA DrsquoAGOSTINI
rograve da notare la mancanza sia nel Prologo che nel testo del libro degli av-venimenti delle celebrazioni Istmie del 196 quando Flaminino procla-mograve la libertagrave dei Greci Piugrave in generale in tutta la narrazione di Giustino delle complesse trattative del 197-196 manca qualsiasi riferimento alla li-bertagrave dei Greci punto nodale nella tradizione di Polibio che con questa sottolineatura esalta sia il ruolo tirannico della Macedonia sia la grande generositagrave dei Romani nei confronti della Grecia Il silenzio di TrogoGiustino su tale questione mostra il prevedibile disinteresse per gli affari dei Greci e nel contempo conferma la presenza di una tradizione che si occupa soprattutto della storia delle monarchie ellenistiche allrsquointer-no della quale la posizione dellrsquoEllade egrave subalterna
Libro XXXII23- 34 Demetrio e Perseo
Gli ultimi anni di regno di Filippo tra il 183 e il 179 sono narrati in un passo breve del libro XXXII Il racconto in Giustino che egrave coerente con il Prologo trogiano segue in maniera sintetica la tradizione polibiana su questi eventi giunta a noi in alcuni passi lacunosi di Polibio (XXIII 1 3-3 10 7 1-7 10 1-11 8) integrati dal racconto particolareggiato di Li-vio (XXXIX 46 7- 48 6 53 1-16 XL 3 3-16 3 201-24 8) e dalla narra-zione di Diodoro (XIX 25) e Plutarco (Aem VIII 11)55
Conclusioni
In questi libri dedicati a Filippo egrave forse possibile vedere in filigrana la rielaborazione voluta di Giustino dei corrispondenti libri trogiani Co-me Giustino stesso afferma nella Prefatio 3 lrsquoopera di Trogo era costruita secondo due criteri quello cronologico e quello per laquoconcatenazione di eventi56raquo ea omnia Pompeius diuisa temporibus et serie rerum digesta conposuit
55 Lrsquoutilizzo della tradizione polibiana in Trogo egrave confermato dallrsquoaderenza a Livio (XL 54 1-56 11) e Diodoro (XXIX 28) del racconto sul pentimento di Filippo per aver ucciso il figlio Demetrio lrsquointenzione di punire Perseo e la correlazione tra questo e la sua mor-te Questo libro egrave dunque differente nellrsquointeresse e nelle fonti dai libri XXIX e XXX poicheacute molto vicino alla tradizione polibiana in Livio Questi avvenimenti in Giustino sono da collegare con lrsquoascesa al trono di Perseo e non con lrsquoepilogo della celebrazione del valore macedone giagrave conclusasi in Giustino con Cinoscefale e la transizione dallrsquoim-perium macedone allrsquoimperium romano Vd Heckel (1997) p 7 Appiano invece riporta ancora una tradizione diversa da quella polibiana in un frammento della Makedonikeacute in particolare Appiano egrave attento al punto di vista macedone e presenta Filippo come una vittima delle circostanze (Mak IX) DrsquoAgostini (2011) pp 99-12156 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362 Alonso-Nuacutentildeez (2002) pp 133-136 He-ckel (1997) pp 1-41 Borgna (2014) pp 52-77
IL DISCORSO DEL RE 139
Serie rerum digesta sembrerebbe unrsquointerpretazione latina della formula κατὰ γένος che Diodoro usa per indicare la struttura della storia di Efo-ro sottolineandone la divisione per argomento57 In tale struttura per argomento dellrsquoEpitome tra i temi principali ci sono dunque il valore e la gloria dei sovrani ellenistici58 riscontrabile nei libri XXVIII-XXXI sui re-gni di Antigono Dosone Filippo V e Antioco III Tale tema presente di sicuro in Trogo egrave conservato nellrsquoazione dellrsquoEpitomatore e anzi come si vede dagli escerpta esaltato dalla selezione dei passi
Per quanto riguarda invece la Quellenforschung 59 egrave evidente che nel testo vi sia presenza di filoni non tradizionali sugli eventi poicheacute la posi-zione di Trogo appare spesso autonoma rispetto alle opinioni condivise dalla storiografia antica Questo aspetto dellrsquoEpitome evidente soprattut-to per ciograve che riguarda gli eventi ellenistici ha suscitato la grande curio-sitagrave degli studiosi che allontanatisi dalla proposta di von Gutschmid che voleva una totale ed esclusiva dipendenza di Trogo da Timagene ora in-dicano con sicurezza tra le fonti piugrave rilevanti per gli eventi ellenistici di III secolo utilizzate da Trogo almeno altri sei nomi oltre a Timagene Ie-ronimo Timeo Filarco Duride Polibio e Posidonio
Per quanto riguarda nello specifico la composizione dei libri XXIX e XXX non vi egrave alcun dubbio che in essi Trogo abbia utilizzato (anche riadattandola) una fonte poco attenta alle questioni di politica interna greca e al legame tra queste e quel ritratto di Filippo come sovrano mal-vagio ed empio che ritorna nella tradizione ufficiale di origine polibia-na passando poi da Polibio in Livio Diodoro e Plutarco60 Trogo pre-serva invece una tradizione ellenistica interessata alla figura di Filippo come ultimo barlume della gloria macedone tradizione che pare quasi una controparte e un completamento dellrsquoAb urbe condita romanocentri-ca di Livio Non si puograve perciograve a mio avviso escludere che per questa se-zione Trogo abbia usato una tradizione di matrice filoellenistica o sem-plicemente ellenisticocentrica unrsquoopera sui regni di diadochi ed epigo-ni che a tutti noi fa venire facilmente alla mente il Basileis o Perigrave Basileon dello storico grecoellenistico augusteo filobarbaro scettico (o critico) verso lrsquoegemonia romana Timagene di Alessandria (FGrHist 88)61
57 Su Eforo vd Vannicelli (1987) pp 165-191 e ora Parmeggiani (2011) 58 Simile legame vi egrave a mio avviso tra i libri XXVI e XXVII che invece affrontavano la crisi delle monarchie ellenistiche causata dalle guerre fraterne59 Vd von Gutschmid (1894) pp 17-217 Richter (1987) pp 17-30 partic 20-23 San-ti Amantini (1972) pp 56-109 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362 Urban (1982) pp 1424-1443 partic 1435 Mecca (2001) pp 199-222 Santi Amantini (2003) pp 99-110 Heckel (2012) pp 3-860 Scuderi (2005) pp 383-40561 Sordi (1982) pp 775-797 Heckel (1997) pp 30-34 Landucci (2014) pp 233-261 e Ead in questo volume
140 MONICA DrsquoAGOSTINI
ABSTRACT
Philip V of Macedon was the first of the Epigonoi to face Rome Several mod-ern reconstructions of the actions and the reign of Philip V have approached it largely from a Roman point of view using as sources Polybius and where Poly-bius is lost Livy The Polybian historiographical tradition tends to portray Phil-ip V as an enemy and a tyrant impious and cruel The Macedonian king was ea-ger to establish a universal and unjust dominion over Greece Italy and beyond and Rome engaged in the first two Macedonian Wars to fight the threat of his growing ambition Nevertheless Polybiusrsquo portrayal of Philip V was affected not only by Polybiusrsquo admiration for Roman political structures military power and overwhelming conquest but also his personal Achaean origins
Looking at in book 29 and 30 of Justinrsquos Epitome of Pompeius Trogus this pa-per focuses on the non Polybian tradition on Philip V this contribution is in-deed the first analysis of the Hellenistic approach to the clash between Rome and Macedonia in the 3rd-2nd Century BC The Epitome shows a considerable di-versity of interpretation from the other sources and reflects very different views of Philip Vrsquos actions that brought him into conflict against Rome In particular these views are more evident related to the accounts of the peace negotiations of Naupactus and the battle of Cynoscephalae in the Epitome the king appears as a courageous and skilled warrior the last of the great Macedonian rulers who fell victim to misfortune This portrayal which has several common features with Appianrsquos fragments of Philip V (Mak 9) counterbalances the Roman and Achaean standpoint present in Polybius providing a more Hellenistic perspec-tive that is likely to have been rooted in a historiographical tradition connect-ed to the losing side in the struggle between Rome and the Hellenistic world
BIBLIOGRAFIA
Adler E (2006) Whorsquos Antiroman Sallust and Pompeius Trogus on Mithridates CJ 101 pp 383-407
Adler E (2011) Valorizing the Barbarians Enemy speeches in Roman Historiography Austin
Ager SL (2003) An Uneasy Balance from the Death of Seleukos to the Battle of Raph-ia in A Erskine (ed) A Companion to the Hellenistic World Oxford pp 35-50
Ager SL (2009) Roman Perspectives on Greek Diplomacy The conceptual clash Greek diplomacy of compromise and Roman Bellum Iustum in C Eilers (ed) Diplomats and Diplomacy in the Roman World Leiden-Boston pp 15-43
Alonso-Nuacutentildeez JM (1992) La Historia Universal de Pompeyo Trogo Madrid
Alonso-Nuacutentildeez JM (2002) The Idea of Universal History in Greece From Herodotus to the Age of Augustus Amsterdam
Ballesteros Pastor L (2013) Pompeyo Trogo Justino y Mitriacutedates Comentario al Epiacutetome de las Historias Filiacutepicas (3716-3881) Hildesheim-Zuumlrich-New York
IL DISCORSO DEL RE 141
Barreacute ML (1983) The God-List in the Treaty between Hannibal and Philip V of Ma-cedon a Study in Light of the Ancient Near Eastern Treaty Tradition Baltimore-Lon-don
Beck H - Eckstein A (2015) sv ldquoAratos of Sicyon (231)rdquo in I Worthington (ed) Brillrsquos New Jacoby Brill Online
Borgna A (2014) Uno sguardo originale intorno a Roma Pompeo Trogo e Giustino laquoLa Biblioteca di ClassicoContemporaneoraquo 1 pp 52-77
Cassola F (1962) I gruppi politici romani nel III secolo aC Trieste
Champion CB (1997) The Nature of Authoritative Evidence in Polybios and Agelausrsquo Speech at Naupactos TAPhA 127 pp 111-128
Champion CB (2004) Cultural Politics in Polybiusrsquo Histories Berkeley
Coppola A (1993) Demetrio di Faro un protagonista dimenticato Roma
Criscuolo L (2011) I due testamenti di Tolemeo VIII Evergete II in A Joumlrdens - J F Quack (hrsg) Aumlgypten zwischen innerem Zwist und aumluszligerem Druck Die Zeit Ptole-maios VI bis VIII Wiesbaden pp 132-150
DrsquoAgostini M (2011) Filippo V e la Storia Romana di Appiano laquoAevumraquo 85 pp 99-121
Eckstein AM (1995) Moral vision in the Histories of Polybius Berkeley
Eckstein AM (2008) Rome enters in the Greek East From Anarchy to Hierarchy in the Hellenistic Mediterranean 230-217 BC Oxford
Eckstein AM (2013) Polybius Phylarchus and Historiographical Criticism CPh 108 4 pp 314-338
Errington RM (1969) Philopoemen Oxford
Errington RM (2008) A History of the Hellenistic World 323-30 BC Malden MA-Oxford
Forni G - Angeli Bertinelli MG (1982) Pompeo Trogo come fonte di storia ANRW II 30 2 pp 1298-1362
Franco C (1993) Trogo Giustino e i successori di Alessandro in L Braccesi - A Coppola - G Cresci Marrone - C Franco (a cura di) LrsquoAlessandro di Giustino dagli antichi ai moderni Roma pp 71-97
Gabba E (2003) Introduzione in D Foraboschi - SM Pizzetti (a cura di) La successione degli imperi e delle egemonie nelle relazioni internazionali Milano pp 7-9
Golan D (1995) The Res Graeciae in Polybius Four Studies Como
Green P (1990) Alexander to Actium The Historical Evolution of the Hellenistic Age Berkeley-Los Angeles
Gutschmid von A (1894) Die beiden ersten Buumlcher des Pompeius Trogus in A von Gutschmid - F Ruumlhl (hrsg) Kleine Schriften Leipzig pp 17-217
142 MONICA DrsquoAGOSTINI
Habicht C (1995) Athen Muumlnchen
Hammond NGL (1968) Illyris Rome and Macedon in 229-205 BC JRS 58 pp 1-21
Hammond NGL (1988) The Campaign and the Battle of Cynoscephalae in 197 BC JHS 108 pp 60-82
Heckel W (1997) Introduction (Part 2) in JC Yardley - W Heckel (eds) Ju-stin Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus Books 11-12 Alexander the Great Introduction Oxford pp 1-41
Heckel W (2012) Introduction in JC Yardley - P Wheatley - W Heckel (eds) Justin Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus II Books 13-15 The Successors to Alexander the Great Oxford pp 1-8
Huss W (1976) Untersuchungen zur Auszligenpolitik Ptolemaiosrsquo IV Muumlnchen
Huss W (2001) Aumlgypten in hellenistischer Zeit 332ndash30 v Chr Muumlnchen
Intrieri M (2011) Fra dialogo e conflitto Annibale e i Greci drsquoOccidente RStudFen 37 pp 53-82
Landucci F (2014) Filippo II e le Storie Filippiche un protagonista storico e storio-grafico in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 233-261
Landucci Gattinoni F (2011) Politica e ideologia in etagrave ellenistica laquoPolitica An-ticaraquo 1 pp 89-105
Leacutevy E (1994) Le discours drsquoAgeacutelaos de Naupacte in L Aigner Foresti - A Bar-zanograve - C Bearzot - L Prandi - G Zecchini (a cura di) Federazioni e federalismo nellrsquoEuropa antica Bergamo 21-25 settembre 1992 Milano (Alle radici della casa co-mune europea 1) pp 33-50
Longaretti L (1989) Lrsquoalleanza tra Annibale e Filippo V di Macedonia RIL 123 pp 183-192
Marasco G (1979-1980) La valutazione di Tolemeo IV Filopatore nella storiografia greca laquoSilenoraquo 5-6 pp 159-182
Mari M [- Musti D - Thornton J] (2002) Polibio Storie Volume III Libri V-VI Milano
Mariotta G (2014) Geografia e Geopolitica nelle Storie Filippiche in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 45-56
McGing B (2010) Polybiusrsquo Histories New York
McGing B (2013) Youthfulness in Polybius the case of Philip V of Macedon in B Gibson - T Harrison (eds) Polybius and his world Oxford pp 181-199
Meadows A (2013) Polybius Aratus and the History of the 140th Olympiad in B
IL DISCORSO DEL RE 143
Gibson - T Harrison (eds) Polybius and his World Essays in Honour of Frank Walbank Oxford pp 91-116
Mecca A (2001) Trogo Timagene e Polieno QS 54 pp 199-222
Meister K (1990) Die Griechische Geschichtsschreibung von den Anfaumlngen bis zum Ende des Hellenismus Stuttgart
Misch G (1949) Geschichte der Autobiographie I Frankfurt am Mein
Momigliano A (1980) Daniele e la teoria greca della successione degli imperi RAL 35 pp 157-162
Muccioli F (2013) Gli epiteti ufficiali dei re ellenistici Stuttgart (Historia Einzel-schriften 224)
Musti D (1978) Polibio e lrsquoimperialismo romano Napoli
Parmeggiani G (2011) Eforo di Cuma studi di storiografia greca Bologna
Peacutedech P (1964) La meacutethode historique de Polybe Paris
Pelling CBR [- Scardigli B - Manfredini M](1997) Plutarco Vite parallele Filopemene Tito Flaminino Milano
Richter H-D (1987) Untersuchungen zur hellenistischen Historiographie die Vorla-gen des Pompeius Trogus fuumlr die Darstellung der nachalexandrischen hellenistischen Ge-schichte (Iust 13-40) Frankfurt
Santi Amantini L (1972) Fonti e valore storico di Pompeo Trogo (Iustin XXXV e XXXVI) Genova
Santi Amantini L (1981) (a cura di) Giustino Storie Filippiche Epitome da Pom-peo Trogo Milano
Santi Amantini L (2003) Il tempo e i tempi nelle Storie Filippiche di Pompeo Tro-go RSA 33 pp 99-110
Schepens G (1983) Les rois ptolegravemaiumlques et lrsquohistoriographie Reacuteflexions sur la trans-formation de lrsquohistoire politique in E vanrsquot Dack - P van Dessel - W Van Gucht (eds) Egypt and the Hellenistic World Proceedings of the International Collo-quium Leuven 24-26 May 1982 Leuven (Studia Hellenistica 27) pp 351-368
Schlicher JJ (1933) Non-Assertive Elements in the Language of the Roman Histo-rians CPh 28 289-300
Schmitt T (1989) Die Bedeutung des zweiten Punischen Krieges fuumlr den Frieden in Naupaktos in H Devijver - E Lipinski (eds) Punic wars Proceedings of the Conference held in Antwerp from the 23th to the 26th of November 1988 in Cooperation with the Departement of History of the laquoUniversitait Antwerpenraquo UFSIA Leuven (Studia Phoenicia 10) pp 229-239
Scholten JB (2000) The Politics of Plunder Aitolians and their koinon in the early Hellenistic Era Berkeley
144 MONICA DrsquoAGOSTINI
Scuderi R (2005) Filippo V e Perseo nei frammenti diodorei in C Bearzot - F Lan-ducci (a cura di) Diodoro e lrsquoaltra Grecia Macedonia Occidente Ellenismo nella Bi-blioteca Storica Atti del convegno Milano 15-16 gennaio 2004 Milano pp 383-405
Sklenaacuter RJ (2004) Sources and Individuality in Two Passages of Livy laquoHistoriaraquo 53 pp 302-310
Sordi M (1982) Timagene di Alessandria Uno storico ellenocentrico e filobarbaro ANRW II 30 1 pp 775-797
Thornton J (2014) Le guerre macedoniche Roma
Urban R (1979) Wachstum und Kriese des achaumlischen Bundes Quellenstudien zur entwicklung des Bundes von 280 bis 222 V Chr Wiesbaden
Urban R (1982) laquoGallisches Bewusstseinraquo und laquoRomkritikraquo bei Pompeius Trogus ANRW II 30 2 pp 1424-1443
Vannicelli P (1987) Lrsquoeconomia delle Storie di Eforo RFIC 115 pp 165-191
Vattuone R (2014) Giustino e lrsquoOccidente greco I VI-V secolo aC in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 261-277
Vollmer D (1990) Symploke das Uumlbergreifen der roumlmischen Expansion auf den grie-chischen Osten Untersuchungen zur roumlmischen Aussenpolitik am Ende des 3 Jh V Chr Stuttgart
Walbank FW (1957) A Historical Commentary on Polibius I Oxford
Walbank FW (1967) A Historical Commentary on Polybius II Oxford
Walbank FW (1933) Aratos of Sicyon Cambridge
Walbank FW (2002) Η ΤΩΝ ΟΛΩΝ ΕΛΠΙΣ and the Antigonids in FW Walbank (ed) Polybius Rome and the Hellenistic World Essays and Reflections West Nyack NY pp 127-136
Weber G (1997) Interaktion Repraumlsentation und Herrschaft Der Koumlnigshof im Hel-lenismus in A Winterling (hrsg) Zwischen lsquoHausrsquo und lsquoStaatrsquo antike Houmlfe im Ver-gleich Munich pp 27-72
Will E (19822) Histoire politique du Monde Helleacutenistique II Nancy
Zecchini G (1990) La storiografia lagide in H Verdin - G Schepens - E De Keyser (eds) Purposes of History Studies in Greek Historiography from the 4th to the 2nd Centuries BC Proceedings of the International Colloquium of Leuven 24-26 May 1988 Leuven (Studia Hellenistica 30) pp 213-232
Zecchini G (2003) Polibio e la tradizione orale in A Casanova - P Desideri (a cura di) Evento racconto scrittura nellrsquoantichitagrave classica Firenze pp 123-141
Finito di stamparenel mese di novembre 2015
da LegoDigit srlLavis (TN)
124 MONICA DrsquoAGOSTINI
scontro con gli Etoli Egrave difficile dire se Trogo dedicasse piugrave spazio alla narrazione degli eventi tra il 220 e il 217 Nel Prologo si legge
Undetricensimo volumine continentur haec Res gestae Philippi regis adversus Dardanos et Aetolos repetitaeque inde Creticae origines post cuius insulae societatem Philippus cum Illyriis et Dardanis et rursus Aetolis bello congressus est adiuvantibus Aetolos Romanis quo finito intulit Attalo bellum
Il ventinovesimo libro contiene le imprese del re Filippo contro i Dardani e gli Etoli Sono quindi rievocate le origini di Creta dopo essersi alleato con questrsquoi-sola Filippo si scontrograve in guerra con gli Illiri i Dardani e di nuovo con gli Eto-li mentre i Romani soccorrevano gli Etoli Terminata questa guerra Filippo at-taccograve Attalo
Dal confronto tra Giustino e i Prologi egrave evidente che quella che per i mo-derni egrave la lsquoGuerra degli Alleatirsquo tra Etoli aiutati da Sparta e dallrsquoElide e la Lega Achea alleata di Filippo V sia ridotta sia in Giustino che in Tro-go a una guerra di Filippo contro gli Etoli Colpisce in effetti la comple-ta mancanza nel Prologo XXIX e nellrsquoEpitome del libro di qualsiasi men-zione e riferimento alla Lega Achea e al suo leader Arato protagonisti indiscussi invece nelle Storie polibiane dei primi anni di regno di Filippo V 9 Arato di Sicione importante statista e comandante militare della Le-ga Achea fu uno dei primi personaggi politici a scrivere e pubblicare le proprie memorie (FGrHist 231) di cui Polibio si servigrave ampiamente (I 3 1)10 Lo storico di Megalopoli era un compatriota di Arato e come lui ricoprigrave importanti cariche allrsquointerno della Lega Achea11 Polibio che considerava Arato uno dei fondatori della Lega vedeva in lui una sorta di eroe e leader ideale come emerge dalla descrizione che ne fa di uomo perfetto per lrsquoattivitagrave politica astuto tollerante coraggioso e di succes-so (IV 7 11-8 12) Il rapporto tra Filippo V e Arato egrave determinante per il giudizio di Polibio sul sovrano macedone Filippo egrave infatti descritto co-me un buon sovrano valoroso ma troppo giovane che nei primi anni di regno agigrave bene poicheacute ascoltograve e seguigrave i consigli di Arato (IV 77 1-4)12
Per quanto argumentum e silentio questa assenza di Arato di Sicione e della Lega Achea sia nel Prologo di Trogo che nellrsquoEpitome di Giustino
9 Polibio dedica alla Lega Achea ampia parte dei libri IV e V 10 Riguardo ad Arato di Sicione soprattutto nel rapporto con Polibio vd Meadows (2013) pp 91-116 Vd anche Walbank (1933) Misch (1949) pp 210-212 Urban (1979) Meister (1990) pp 187-189 Habicht (1995) pp 176-179 Beck - Eckstein (2015) sv laquoAratos of Sicyon (231)raquo in BNJ11 Sui legami di Polibio e la sua famiglia con la Lega Achea vd Eckstein (2013) pp 314-33812 Polyb IV 24 1-3 e V 26 6 seguito da Plut Arat 48-49 afferma esplicitamente che il re portava a termine abilmente i suoi piani poicheacute Arato era al suo fianco
IL DISCORSO DEL RE 125
non solo non puograve passare inosservata ma deve indurre i moderni a du-bitare per questi eventi di unrsquoapparente dipendenza diretta giagrave di Tro-go da Polibio
21- 38 Demetrio di Faro e Naupatto
Scomparso Arato nellrsquoEpitome XXIX ha invece un ruolo fondamentale in questi anni come consigliere di Filippo Demetrio di Faro a cui egrave at-tribuito il primo discorso in oratio obliqua dei due libri esaminati13
Demetrio di Faro era un dinasta illirico che si incontra per la prima volta nelle fonti storiografiche in occasione della prima guerra di Ro-ma in Illiria nel 229 Sappiamo infatti da Polibio (II 10 8-11 4) e Appia-no (Illyr 7) che Demetrio giagrave alleato di Teuta sovrana degli Illiri aveva scelto di passare dalla parte romana ed era stato poi ricompensato dal Senato con il controllo di parte dei territori sottratti da Roma a Teuta stessa Nei suoi tentativi di ritagliarsi un ruolo importante nella penisola balcanica Demetrio nel 222 si era alleato con la Lega Ellenica di Doso-ne e Arato a Sellasia contro Cleomene (Polyb II 65 2- 5) ma negli an-ni successivi le sue scorribande nellrsquoAdriatico allarmarono Roma che gli mosse guerra (Polyb III 16 IV 16)14 Sconfitto da Roma e cacciato da Faro Demetrio si rifugiograve alla corte di Filippo intorno al 218 diventan-do consigliere del re
Poicheacute nel Prologo XXVIII si legge laquoIn una digressione egrave narrata la guerra illirica combattuta dai Romani contro Teuta15raquo non egrave da esclu-dere che Trogo giagrave citasse il dinasta di Faro anche se la prima menzio-ne di Demetrio in Giustino egrave a XXIX 2 1 quando il cosiddetto lsquore de-gli Illirirsquo cacciato da Lucio Emilio Paolo dallrsquoAdriatico arrivograve alla corte macedone Nel riassunto degli eventi Giustino segue piugrave da vicino Tro-go riportando il discorso del dinasta a Filippo V per convincere il sovra-no a far guerra a Roma (XXIX 2 2-6) I punti principali di tale discorso sono che i Romani aspirano a realizzare un impero universale a scapito di tutti i re laquocome se fosse cosa illecita che ci fosse un qualche re presso i confini del loro Statoraquo Perciograve Filippo V doveva prepararsi alla guerra con i Romani poicheacute laquoquanto piugrave accessibile e illustre era il suo regno tanto piugrave accaniti nemici gli sarebbero stati i Romani16raquo Demetrio vole-
13 Su questi discorsi di Demetrio vd Coppola (1993) pp 29-5114 Coppola (1993) pp 29-51 vd anche Hammond (1968) pp 1-21 Eckstein (2008) pp 41 58-60 Demetrio di Faro era presentato in Polibio come il rivale di Arato tra i consi-glieri di Filippo Polyb IX 23 9 infatti dichiara che quando il sovrano seguiva i consigli di Arato compiva grandi imprese mentre quando ascoltava Demetrio si macchiava di atti spregevoli15 Trog Prol XXVIII Dictum in excessu bellum Illyricum quod Romani gessere cum Teuta16 Iust XXIX 2 4-5 sibi quoque non aliam ob causam quam quod Italiae finitimus uidebatur
126 MONICA DrsquoAGOSTINI
va infatti cacciare i Romani dalla sponda adriatica dellrsquoIlliria territorio che avrebbe ceduto a Filippo
Il discorso di Demetrio a Filippo egrave presente anche in Polibio (V 101 8-1017) ed egrave inserito cronologicamente durante i giochi Nemei18 nel 217 subito dopo la sconfitta romana del lago Trasimeno ricordata an-che nel passo di Giustino Nel discorso polibiano Demetrio perograve sotto-linea il diritto di Filippo V ad aspirare al dominio universale a partire dallrsquoAdriatico19 mentre nel discorso trogiano Demetrio accusa i Roma-ni di aspirare ad espandersi travolgendo qualsiasi regno sul loro cammi-no Trogo nel discorso di Demetrio presenta il coinvolgimento roma-no in Oriente come una guerra di conquista che contrappone la giova-ne potenza romana allrsquolsquoillustre regnorsquo di Filippo20 prospettiva che ritor-na nel successivo discorso di Filippo V nellrsquoEpitome ma che egrave estranea al-la narrazione di Polibio
Dopo il discorso di Demetrio nellrsquoEpitome come in Polibio (V 104 1) si arriva allrsquoincontro di pace di Naupatto nel 217 che pose fine al-la Guerra degli Alleati tra Etoli Spartani ed Elei contro la lega Achea e
bellum inlatum quasi nefas esset aliquem regem iuxta imperii eorum terminos esse Sed et ipsi cauen-dum esse exemplum cuius quanto promptius nobiliusque sit regnum tanto sit Romanos acriores hostes habiturus17 Polyb V 101 8-10 ὃς καὶ λαβόμενος τῆς ἀφορμῆς ταύτης τὸν μὲν πρὸς τοὺς Αἰτωλοὺς ᾤετο δεῖν τὴν ταχίστην ἀπορρῖψαι πόλεμον ἀντέχεσθαι δὲ τῶν κατὰ τὴν Ἰλλυρίδα πραγμάτων ἠξίου καὶ τῆς εἰς Ἰταλίαν διαβάσεως [9] τὰ μὲν γὰρ κατὰ τὴν Ἑλλάδα πάντα καὶ νῦν ἤδη ποιεῖν αὐτῷ τὸ προσταττόμενον ἔφη καὶ μετὰ ταῦτα ποιήσειν Ἀχαιῶν μὲν ἐθελοντὴν εὐνοούντων Αἰτωλῶν δὲ καταπεπληγμένων ἐκ τῶν συμβεβηκότων αὐτοῖς κατὰ τὸν ἐνεστῶτα πόλεμον [10] τὴν δ᾽ Ἰταλίαν ἔφη καὶ τὴν ἐκεῖ διάβασιν ἀρχὴν εἶναι τῆς ὑπὲρ τῶν ὅλων ἐπιβολῆς ἣν οὐδενὶ καθήκειν μᾶλλον ἢ ᾽κείνῳ τὸν δὲ καιρὸν εἶναι νῦν ἐπταικότων Ῥωμαίων Trad da Mari (2002) laquoCostui allora cogliendo lrsquooccasione gli consigliograve di interrompere al piugrave presto la guerra con gli Etoli e gli chiese di impegnarsi nelle operazioni in Illiria e nellrsquoattraversamento del mare verso lrsquoItalia Disse che infatti giagrave ora tutta la Grecia eseguiva i suoi ordini e lo avrebbe fatto anche in seguito poicheacute gli Achei lo sostenevano di loro iniziativa mentre gli Etoli erano rimasti molto colpiti da quanto era loro avvenuto nella guerra in corso e aggiunse che lrsquoItalia e lrsquoattraversamento del mare in quella direzione erano lrsquoinizio di un disegno di dominio universale che a nessuno spettava piugrave che a lui ora era il momento opportu-no visto che i Romani erano stati battutiraquo18 I giochi Nemei in onore di Zeus erano giochi panellenici celebrati in Argolide negli anni pari delle Olimpiadi 19 Secondo Eckstein (1995) pp 211-212 tale aspirazione egrave connessa allrsquoincapacitagrave di mo-derazione nella vittoria del sovrano Sul concetto di dominio universale in Polibio vd Musti (1978) pp 16-18 Eckstein (2008) pp 217-220 e 372-38120 Adler (2006) pp 383-407 e (2011) pp 37-58 ha notato che i punti principali del discorso di critica allrsquoespansionismo romano di Demetrio ritornano in altri due discorsi dellrsquoEpitome quello degli Etoli (XXVIII 2 1-13) e quello di Mitridate (XXXVIII 4-7) la prioritagrave data a questi argomenti da tale reiterazione retorica indica che lrsquointeresse giagrave di Trogo se non dellae suae fontei non fosse la celebrazione dellrsquoascesa di Roma allrsquoim-pero universale come in Appiano ma piuttosto lrsquoascesa e la discesa dei regni ellenistici
IL DISCORSO DEL RE 127
Filippo V 21 Il testo giustineo omette le circostanze dellrsquoevento non si menzionano infatti esplicitamente neacute il luogo dellrsquoincontro Naupatto neacute le fasi delle trattative neacute i vari rappresentanti dei diversi fronti che vi presero parte I lunghi negoziati di pace si risolvono dunque nel discor-so di Filippo V ai rappresentanti dei fronti
Il sovrano esordisce affermando che la Grecia egrave in grande pericolo percheacute chiunque avesse vinto tra Cartaginesi e Romani sarebbe poi pas-sato in Oriente Filippo utilizza la metafora delle nubi in Occidente che avrebbero macchiato con una pioggia di sangue ogni cosa spinte dai venti di vittoria inoltre il sovrano ritiene che le guerre passate dei Gre-ci siano di poco conto se paragonate alla minaccia di uno scontro con la moltitudine che si radunava in Italia descrivendo la rabbia e il valore di questi nuovi nemici che avrebbero portato rovina ai vicini Il sovrano infine ribadisce che la Grecia era in maggior pericolo della Macedonia ma che sapeva che chi avesse vinto in Italia non avrebbe frenato la sete di vittoria Perciograve anche la Macedonia stessa doveva temere un attacco
Il discorso in Polibio di Agelao di Naupatto rappresentante e leader degli Etoli22 mostra le medesime argomentazioni attribuite in Giustino allrsquointervento di Filippo argomentazioni fondate sul metus hostilis e fina-lizzate a promuovere un nuovo ruolo della Macedonia sia in Grecia che nel Mediterraneo Orientale Agelao proponendo un nuovo program-ma politico panellenico fonda le proprie argomentazioni sul metus hosti-lis per i Cartaginesi e i Romani presentati metaforicamente come nubi che incombono da Occidente Filippo dovrebbe farsi garante della tran-quillitagrave della Grecia che agendo come unrsquounica catena di cittagrave contro i barbari diverrebbe una sicura e fedele collaboratrice della Macedonia Questo permetterebbe ai Greci di conservare il diritto di far pace o guer-ra a loro piacimento senza temere che laquoi giochi da bambini con i quali ci trastulliamo tutti vengano troncati23raquo
Nonostante sia il medesimo discorso nelle due fonti Agelao introdu-ce una forte proposta di alleanza panellenica estranea alle parole di Fi-lippo Inoltre Filippo pur utilizzando la metafora delle nubi da Occi-
21 Interessanti le osservazioni di Scholten (2000) pp 224-228 a proposito della pace che sarebbe stata cercata e sperata da entrambe le parti e non imposta da Filippo come Polibio pare lasciar intendere 22 Vd soprattutto Leacutevy (1994) pp 33-50 Su questo discorso molto dibattuto dai moderni vd anche Schmitt (1989) pp 229-239 Vollmer (1990) pp 96-107 Coppola (1993) pp 149-164 Golan (1995) pp 55-74 Champion (1997) pp 111-128 e (2004) p 55 Wal-bank (2002) pp 127-136 Eckstein (2008) pp 78-83 23 Polyb V 104 10-11 καθόλου τὰς παιδιάς ἃς νῦν παίζομεν πρὸς ἀλλήλους ἐκκοπῆναι συμβῇ πάντων ἡμῶν ἐπὶ τοσοῦτον ὥστε κἂν εὔξασθαι τοῖς θεοῖς ὑπάρχειν ἡμῖν τὴν ἐξουσίαν ταύτην καὶ πολεμεῖν ὅταν βουλώμεθα καὶ διαλύεσθαι πρὸς ἀλλήλους καὶ καθόλου κυρίους εἶναι τῶν ἐν αὑτοῖς ἀμφισβητουμένων
128 MONICA DrsquoAGOSTINI
dente presente anche nelle Storie la arricchisce con la vivida immagine di una tempesta di sangue conferendo una dimensione piugrave concreta e cruenta alla predizione infine il riferimento polibiano alle guerre dei Greci nellrsquoEpitome non riguarda piugrave le guerre tra le cittagrave e le leghe gre-che ma le guerre dei Greci con Macedoni Persiani e Galli Mentre la Grecia scompare sullo sfondo la minaccia Romana egrave meno vaga e piugrave concreta e presente che in Polibio e diventa lrsquounico argomento del di-scorso di Filippo V a Naupatto
Il discorso di Demetrio e quello di Filippo sono al centro del libro XXIX dellrsquoEpitome avendo il duplice scopo di evidenziare sia la poten-ziale aggressivitagrave dei Romani sia la grande tradizione militare della Ma-cedonia e il pieno diritto di Filippo di controllare la Grecia e lrsquoIlliria fi-no allrsquoAdriatico Se il discorso in Polibio si inseriva in un dibattito politi-co dove la Grecia e la Macedonia erano protagoniste alla pari della sce-na ellenica e internazionale nella versione che leggiamo in Trogo i ri-ferimenti alle dispute della realtagrave greca sono reinterpretati a favore di un punto di vista in cui la Macedonia egrave lrsquounico potere dellrsquoOriente gre-co Del dibattito politico di III secolo in Grecia che tanto stava a cuore a Polibio non vi egrave piugrave alcuna traccia in TrogoGiustino rimane soltanto lo scontro tra le due grandi potenze di Oriente e Occidente tra Filippo e Roma Questa prospettiva bipolare dei discorsi trogiani si ritrova nel-la conclusione del capitolo che se da un lato sottolinea ancora una vol-ta il timore di Filippo per Cartaginesi e Romani dallrsquoaltro esplicita che i Romani avevano paura dellrsquoantica gloria dei Macedoni laquovincitori dellrsquoO-rienteraquo e soprattutto di Filippo laquoinfiammato dallo zelo di emulare Ales-sandro che era ben noto come pronto alle guerre e instancabileraquo24
41-11 La Prima Guerra Macedonica
Dei prodromi della Prima Guerra Macedonica Giustino si interessa sol-tanto allrsquoalleanza antiromana tra Annibale e Filippo Questo trattato egrave noto da molte fonti secondo cui Filippo dopo aver appreso che i Roma-ni erano stati sconfitti di nuovo dai Cartaginesi a Canne nel 216 avreb-be mandato unrsquoambasceria ad Annibale per proporre unrsquoalleanza ma lrsquoambasciatore macedone sarebbe stato catturato da Roma sulla via del ritorno25
24 Iust XXIX 3 8 quippe terrebat eos et uetus Macedonum deuicti Orientis gloria et Philippus studio Alexandri aemulationis incensus quem promptum in bella industriumque cognouerant Alla gloria dei Macedoni avevamo giagrave trovato riferimento nei discorsi del libro XXVIII degli Etoli (2 12) e di Antigono Dosone (3 14) 25 Secondo Polyb VII 9 17 Filippo avrebbe aiutato Cartagine nella guerra con Roma in cambio di Corcira Epidamno e Apollonia e della restituzione a Demetrio di Faro del suo regno Inoltre Filippo e Annibale si impegnavano a soccorrersi a vicenda in caso di
IL DISCORSO DEL RE 129
A prescindere dai dettagli del fermo dellrsquoambasciatore macedone da parte romana egrave possibile fare qualche osservazione sul nesso tra questo lsquoincidentersquo diplomatico e lo scoppio della guerra Cassio Dione e Ap-piano riportano che la cattura del legato avrebbe causato una vendetta di Filippo contro i protettorati romani in Adriatico in particolare Cor-cira26 notizia assente in Polibio come in Livio e Plutarco (che da Poli-bio dipendono)27 In questi ultimi autori lrsquoattacco di Filippo in Adriati-co infatti non sarebbe legato allrsquoepisodio dellrsquoambasciatore ma alla de-cisione del sovrano di rompere con il consigliere Arato e di dare ascol-to ai cattivi consigli di Demetrio di Faro presa dopo la spedizione a Mes-sene nel 215214 La tradizione polibiana legge infatti in questi eventi la manifestazione del cambiamento dellrsquoindole di Filippo V da giusta a empia iniziata con lrsquoepisodio della stasis di Messene del 215 e compiu-ta con lrsquoassassinio di Arato del 21328 Nel libro XXIX di Giustino ben-cheacute si conservi traccia dellrsquoindole aggressiva di Filippo e del consiglio di Demetrio di Faro come prodromi dello scontro con Roma non vi sono indizi della metaboleacute del sovrano da giusto a empio e malvagio e neppu-re del ruolo che in tale cambiamento ricoprigrave lrsquoallontanamento tra Ara-to e Filippo
attacco da parte di Roma Mentre Peacutedech (1964) pp 382-383 ritiene sicura la consulta-zione a Roma di tali documenti Zecchini (2003) pp 123-141 come prima di lui Walbank (1957) I p 32 n 4 non ne egrave certo poicheacute Polibio viaggiograve proprio per poter reperire documenti e informazioni sugli eventi dove essi avvennero Altre fonti Liv XXIII 38 7 Plut Arat 51 2 Dio C XV 4 2 e App Mak Fr 1 Sul confronto delle fonti vd DrsquoAgostini (2011) pp 99-121 Sul trattato macedone-cartaginese vd Cassola (1962) pp 65-66 Wal-bank (1967) II pp 42-44 Will (19822) pp 83-84 Barreacute (1983) Longaretti (1989) pp 183-192 Golan (1995) pp 45-46 Eckstein (2008) pp 83-85 Intrieri (2011) pp 53-8226 Dio C XV 4 2 e App Mak Fr1 Filippo per vendicarsi della cattura del proprio amba-sciatore non solo attaccograve Corcira ma saputo dellrsquoarrivo di Levino durante la ritirata da Corcira saccheggiograve anche Apollonia e Orico alleate romane Levino avrebbe poi sconfit-to Filippo e recuperati gli alleati costringendo il re a bruciare le proprie navi e rientrare via terra Si riferisce a questo episodio probabilmente il Mak Fr 9 di Appiano che riporta lrsquoordine di Filippo di uccidere quanti erano sulle navi percheacute non dicessero ai Romani che le forze macedoni erano stremate DrsquoAgostini (2011) pp 99-12127 Polyb V 108-110 Liv XXIV 40 e Plut Arat 51 2 non menzionano Corcira nella narra-zione dellrsquoalleanza macedone-cartaginese e della cattura dellrsquoambasciatore Secondo Liv XXIII 38 7 lrsquoambasciatore sarebbe stato trattenuto a Roma 28 Polyb VII 11 8-11 e Plut Arat 49 1 Coppola (1993) pp 205-210 Dai frammenti di Polyb VII 10-12 e dalla narrazione di Plut Arat 49-51 sappiamo che Filippo era interve-nuto nella stasis di Messene tra oligarchici e democratici ma aveva di nascosto lasciato che i cittadini si massacrassero Una volta giunto Arato la guerra civile fu finalmente sedata ma il sovrano avrebbe voluto su consiglio di Demetrio di Faro approfittare della situazione e imporre una guarnigione nellrsquoacropoli della cittagrave che gli avrebbe conferito un vantaggio strategico per il controllo del Peloponneso Arato dissuase Filippo da per-seguire unrsquoazione militare in Peloponneso ma il re decise su consiglio di Demetrio di rivolgere la sua aggressivitagrave verso lrsquoIlliria prima e i protettorati romani Orico e Apollonia poi
130 MONICA DrsquoAGOSTINI
Dopo aver accennato alla stipula del trattato Giustino affastella ne-gli ultimi paragrafi del capitolo 4 gli eventi tra il 215 e il 205 quando Fi-lippo siglando la pace con Roma pone fine alla Prima Guerra Macedo-nica29 In particolare lrsquoEpitomatore sottolinea da un lato lrsquoingresso in guerra degli Etoli al fianco dei Romani e la successiva alleanza del preto-re Levino con Attalo dallrsquoaltro gli attacchi subiti da parte dei Dardani da Filippo oppresso dalle richieste degli Illiri Il libro dunque si chiude con Filippo in difficoltagrave aggravate dalla comparsa di Filopemene il leader degli Achei30 urtatosi con il re dei Macedoni convince la Lega Achea a staccarsi dallrsquoalleanza con la Macedonia sempre piugrave isolata Tale allon-tanamento egrave considerato da Giustino lrsquoesito di un fallito agguato a Fi-lopemene commissionato da Filippo V e dovuto al sospetto di un tradi-mento del condottiero acheo a favore di Roma Bencheacute anche Plutarco (Fil 12 2) e Pausania (VIII 50 4) menzionino il tentativo di assassinio di Filopemene da parte di Filippo la notizia dellrsquoatteggiamento filoroma-no del generale acheo non parrebbe vicino al ritratto polibiano che ve-de in Filopemene un eroe dellrsquoautonomia e dellrsquoindipendenza achea31
Libro XXX11-39 Cinoscefale
Lrsquoesordio del libro XXX introducendo il grande scontro di Cinoscefale tra Romani e Macedoni riprende la celebrazione della gloria macedo-ne argomento centrale dei discorsi del libro XXIX Con lrsquoeccezione dei primi capitoli sul deplorevole comportamento di Tolemeo IV in Egit-to32 il libro egrave infatti totalmente dedicato allo scontro tra le due potenze
29 Errington (2008) pp 185-190 La guerra egrave nota a noi soprattutto dai frammenti dei libri VIII-XI di Polibio dai passi di Liv XXIV 40 1-17 XXVI 24 1-26 4 XXVII 30 5-33 5 e XXVIII 5 1- 9 1 XXIX 12 1-15 e dalla Vita di Filopemene di Plutarco La sinteticitagrave del riassunto giustineo impedisce un puntuale paragone delle tradizioni Ad esempio la notizia dellrsquoalleanza tra Attalo e Roma sembra tornare in Liv XXVIII 5 1-4 dove perograve non troviamo Levino ma Sulpicio come rappresentante romano personaggio scompar-so in Giustino In maniera simile la pace di Fenice del 205 egrave sintetizzata in Giustino in una riga e non vi egrave traccia delle lunghe trattative che coinvolsero come mediatori anche Egitto Chio Mitilene e Atamania portarono a una prima pace separata tra Filippo e gli Etoli nel 206 e poi alla pace con Roma Le fonti parallele sono molto piugrave dettagliate anche su questi eventi Polyb XI 4 1-6 9 Liv XXVIII 5 13 e XXIX 12 8-16 e App Mak fr III Degno di nota egrave perograve il commento in Giustino secondo cui laquoi Romani erano per il momento soddisfatti di aver rinviato la guerra contro la Macedoniaraquo Lrsquointenzione ro-mana di riprendere la guerra con la Macedonia egrave infatti presente in tutte le fonti Polyb XI 6 7 Liv XXIX 1216 Dio C XVIII 9 (15) e App Mak Fr III e verragrave ripresa al libro XXX dellrsquoEpitome 30 Su Filopemene e Filippo vd Errington (1969) pp 51-69 e 83-84 vd anche Golan (1995) pp 115-132 Eckstein (2008) pp 103 e 360-36131 Pelling (1997) pp 135-13932 Lrsquoesordio del libro XXX egrave dedicato alle scabrose imprese del sovrano egiziano ovvero
IL DISCORSO DEL RE 131
dellrsquoEst e dellrsquoOvest La prima avvisaglia dellrsquoincombente guerra egrave la no-tizia dellrsquoaccordo di Filippo V e Antioco III per la spartizione dellrsquoEgitto governato dal sovrano-bambino Tolemeo V Il sovrano lagide nel 2032 chiese aiuto ai Romani che secondo TrogoGiustino gradirono la ri-chiesta drsquoaiuto percheacute cercavano pretesti per muovere guerra contro Fi-lippo A partire da Polibio numerose altre fonti ci testimoniano questo episodio mettendolo in relazione con lo scoppio della Seconda Guerra Macedonica ed esprimendo una condanna morale per lrsquoempia condotta del re antigonide che cospira contro un bambino33 al contrario nellrsquoE-pitome si esalta la potenza macedone evidenziando la paura dei Romani delle grandi imprese di Filippo (XXX 3 2)
nullius magis arma metuebant reputantibus quantum motum Pyrrhus parua Macedo-num manu in Italia fecisset quantasque res Macedones in Oriente gessissent
di nessun altro temevano maggiormente le armi poicheacute ripensavano a quanto sconvolgimento Pirro aveva provocato in Italia con una piccola schiera di Ma-cedoni e a quanto grandi imprese i Macedoni avevano compiuto in Oriente
La supremazia macedone egrave anche al centro del discorso in oratio obliqua di Filippo allrsquoincontro nel Golfo Maliaco tra i rappresentanti dei fronti coinvolti nella Seconda Guerra Macedonica34 NellrsquoEpitome infatti dopo
la Quarta Guerra Siriaca conclusa con sconfitta a Rafia contro Antioco III nel 217 e la corruzione del sovrano da parte di Agatocle e della sorella una cortigiana che avrebbe sedotto il re Giustino riferisce poi la morte del sovrano nel 204 e lrsquoascesa al trono del piccolo Tolemeo V Epifane sovrano sotto tutela di Tlepolemo dopo la morte di Agatocle e Sosibio 33 Eckstein (2008) pp 121-180 Thornton (2014) pp 65-88 In particolare sulla relazione tra il complotto e la sconfitta antigonide e seleucidica ad opera di Roma la superioritagrave morale romana ai regni ellenistici e la causalitagrave storica in Polibio (XV 20 6) vd Eck-stein (2008) pp 133-138 Ager (2009) pp 15-43 Landucci Gattinoni (2011) pp 89-105 Secondo Polyb III 2 8 XV 20 XVI 1 8-9 seguito da Liv XXXI 14 5 Filippo avrebbe ottenuto le basi tolemaiche in Egeo Samo e la Caria mentre Antioco avrebbe finalmente avuto mano libera in Celesiria e Fenicia oggetto di quasi un secolo di lotte tra Tolemei e Seleucidi La notizia del trattato permette a Polibio di dedicare alcuni paragrafi (XV 20) a condannare aspramente lrsquooperato di Filippo V e Antioco III definendoli empi e senza pudore e dichiarando che la Fortuna punigrave i due sovrani per il loro crudele operato por-tando i Romani contro di loro vd infra App Mak Fr IV trasmette delle clausole secondo cui Antioco avrebbe avuto lrsquoEgitto e Cipro mentre Filippo avrebbe ottenuto Cirene le Cicladi e la Ionia Infine secondo Porfirio FGrHist 260 F 45 lrsquoaccordo prevedeva che i due sovrani annettessero i possedimenti tolemaici confinanti con i rispettivi regni 34 Prima si menziona unrsquoambasceria del Senato a Filippo e Antioco percheacute laquosi astenessero dallrsquoEgittoraquo e la visita di Lepido in Egitto Quindi le lamentele a Roma di Attalo e i Rodii nei confronti di Filippo Egrave probabile che a questo punto Trogo inserisse la campagna di Filippo in Asia contro Attalo menzionata nel Prologo XXX ma tagliata nellrsquoEpitome La cronologia degli scambi diplomatici precedenti la Seconda Guerra Macedonica egrave stra-volta dalla sintesi dellrsquoEpitomatore e rende impossibile qualsiasi confronto con le altre
132 MONICA DrsquoAGOSTINI
il riassunto delle ambascerie nel Mediterraneo preludio allo scontro della prima fase della guerra35 maggior spazio egrave dato al tentativo di pa-ce a Nicea tra Roma Attalo i Rodii gli Achei e gli Etoli e Filippo V nel 198 In questa occasione Filippo rivendica la posizione di dominio dei Macedoni sui Greci ereditata da Filippo II e Alessandro suoi antenati e in virtugrave di tale supremazia macedone rifiuta che i Greci gli dettino le condizioni di pace ma chiede che sia il Senato a decidere Egrave significati-vo che non solo il discorso di Filippo non compaia in nessuna delle fon-ti parallele che descrivono nel particolare le posizioni degli ambasciato-ri di Achei Etoli Rodii e Attalo ma che Polibio (XVIII 8 8)36 affermi che era difficile sapere cosa si fossero detti Filippo e Flaminino durante i colloqui nel Golfo Maliaco Secondo la tradizione polibiana infatti il sovrano accompagnato da due philoi macedoni Apollodoro e Demoste-ne chiese di allontanare dalle trattative tutti tranne i Romani e discus-se la pace solamente con Flaminino Successivamente a causa dellrsquoinca-pacitagrave di trovare un accordo Filippo chiese due mesi di tregua e lrsquointer-vento del Senato Trogo dunque restituisce il discorso che il resto della tradizione riteneva impossibile da conoscere indicando chiaramente la presenza di una fonte diversa rispetto a Polibio su questo avvenimento piugrave informata sul punto di vista di Filippo e interessata a evidenziare la convinzione di Filippo V di avere un diritto di supremazia sulla Grecia in virtugrave delle imprese di Filippo II e Alessandro
La battaglia di Cinoscefale nel 197 momento risolutivo dello scontro tra Roma e Macedonia egrave lrsquoevento principale del libro XXX omina e pre-sagi introducono lrsquoevento campale lrsquoeruzione del vulcano di Santorini
fonti In Polyb XVI 24 3 App Mak Fr IV Liv XXXI 1 10 21 5 5 Paus I 36 5-6 vi sono differenti versioni della sequenza delle ambascerie che denunciarono a Roma lrsquoe-spansionismo macedone ma tutte concordano che le ambascerie precedettero lrsquoinvio dei legati romani in Oriente e che esse furono inviate anche da Atene e dagli Etoli Inoltre secondo la tradizione polibiana (Polyb XVI 27 1-4 34 1-7 Liv XXXI 2 3 6 3-8 4 18 1-9 Diod XXVIII 6) vi furono due diverse ambascerie di cui la seconda sarebbe stato un ultimatum al sovrano recapitato da Lepido In occasione di questa seconda ambasceria avvenuta durante il cruento assedio di Abido Filippo avrebbe detto che i Macedoni in ca-so di guerra si sarebbero difesi con valore In Giustino si puograve notare che ancora una volta dagli eventi sono omesse notizie fondamentali sui Greci nello specifico lrsquoambasceria di Atene la cui disputa con gli Acarnani fu il casus belli della guerra contro Filippo 35 Come i prodromi anche la prima parte della Seconda Guerra Macedonica egrave sintetizza-ta in Giustino e occupa solamente due paragrafi Come spesso accade nei passi sintetiz-zati dallrsquoEpitomatore si trovano le incongruenze maggiori con le fonti parallele tra cui si nota soprattutto la completa omissione di Giustino delle campagne di Publio Sulpicio Galba Massimo di Villio delle vittorie di Tito e Lucio Flaminino e dellrsquoassemblea del 198 che portograve gli Achei ad allearsi con Roma Polyb XXII e Liv XXXI 14 1- 46 16 XXXII 1 1-25 12 App Mak Fr VII Plut Fil 17 4 Flam 5 4 e Paus VII 8 1-236 Le trattattive sono descritte con particolari in Polyb XVIII 1-12 seguito da Liv XXXII 32 6-36 10 e Plut Flam 5 8 e 7 1-3
IL DISCORSO DEL RE 133
nel 197 e lrsquoemergere dellrsquoisola di Hiera e in contemporanea il terremo-to a Rodi Quindi nellrsquoEpitome si annuncia che laquoil nascente impero dei Romani avrebbe divorato quello antico dei Greci e dei Macedoni37raquo Nel passo ricevono spazio soprattutto i due discorsi contrapposti del re ma-cedone Filippo e del comandante romano Flaminino pronunciati pri-ma dello scontro campale e costruiti ciascuno in modo da celebrare le imprese delle due potenze38 Lrsquoenfasi data dalla contrapposizione reto-rica delle parole dei generali egrave tale da rendere suggestiva lrsquoipotesi che lo scontro dovesse essere il momento centrale non solo del libro XXX ma forse di tutta lrsquoopera trogiana
Filippo elenca le grandi vittorie del passato dei Macedoni contro Per-siani Battriani Indiani e le popolazioni drsquoAsia fino allrsquoestremo Orien-te esortando i suoi a combattere con valore percheacute laquola libertagrave egrave piugrave cara del predominio39raquo Il discorso di Flaminino egrave invece piugrave lungo articola-to in un paragone tra Macedoni e Romani alle passate imprese di con-quista macedoni vengono contrapposte le piugrave recenti vittorie romane a Cartagine in Sicilia Italia e Spagna alla grandezza di Alessandro Ma-gno egrave contrapposta quella di Annibale che pure dai Romani era stato sconfitto Lrsquoattenzione poi si concentra su Filippo i Macedoni non laquodo-vevano essere valutati per lrsquoantica forza ma per le forze attuali40raquo poicheacute Filippo non era lrsquoinvitto e invincibile Alessandro Magno ma un ragaz-zo che non riusciva a difendere i propri confini I Macedoni rivendica-vano il valore degli antenati mentre i Romani quello dei propri soldati poicheacute quelli che erano ligrave schierati erano gli stessi che avevano sconfitto Annibale Dopo una cosigrave grandiosa introduzione la battaglia egrave descritta in uno dei paragrafi piugrave significativi di tutta lrsquoopera
His adhortationibus utrimque concitati milites proelio concurrunt alteri Orientis alteri Occidentis imperio gloriantes ferentesque in bellum alii maiorum suorum antiquam et ob-soletam gloriam alii uirentem recentibus experimentis uirtutis florem [16] Sed Macedo-nas Romana Fortuna uicit
I soldati incitati da queste esortazioni dallrsquouna e dallrsquoaltra parte si lanciaro-no nel combattimento vantandosi gli uni del dominio dellrsquoOriente gli altri dellrsquoOccidente e recando in guerra gli uni lrsquoantica e sbiadita gloria dei loro an-
37 Iust XXX 4 4 Quo prodigio territis omnibus uates cecinere oriens Romanorum imperium uetus Graecorum ac Macedonum uoraturum38 Sui discorsi precedenti la battaglia nellrsquoantichitagrave se da considerare reali o costruzioni storiografiche vd Adler (2011) pp 6-839 Iust XXX 4 7 tantoque hoc bellum fortius quam illa sustinendum quanto sit imperio libertas carior40 Iust XXX 4 10 Sed nec Macedonas ueteri fama sed praesentibus uiribus aestimandos
134 MONICA DrsquoAGOSTINI
tenati gli altri il fiore del loro valore fresco e vigoroso per le recenti prove Ma la Fortuna dei Romani vinse i Macedoni
Questo punto di vista probabilmente giagrave trogiano contrappone la virtugrave romana (virtutis flos) celebrata nei discorsi antecedenti la battaglia al-la Fortuna romana (Romana Fortuna) che decise la vittoria interpretabi-le come destino favorevole o buona stella Piugrave che unrsquoaffermazione anti-romana41 come egrave spesso stata intesa si puograve evidenziare il carattere sim-patetico della fonte verso Filippo V destinato a porre fine alla gloria di Filippo II e Alessandro e forse un approccio nostalgico verso i grandi regni macedoni la cui egravera egrave ormai giunta alla fine Tale prospettiva egrave as-sente in Polibio e nella tradizione che da lui dipende poco interessata alle vicende della gloria macedone leggendo infatti i frammenti soprav-vissuti del libro XVIII delle Storie dopo lrsquoaccurata descrizione della bat-taglia (18-33 e 34-40)42 Polibio commenta lo scontro affermando che avrebbe dedicato alcuni capitoli allrsquoesame delle strategie militari delle due armate percheacute (XVIII 28 4-6)
χρήσιμον καὶ καλὸν ἂν εἴη τὸ τὴν διαφορὰν ἐρευνῆσαι καὶ παρὰ τί συμβαίνει Ῥωμαίους ἐπικρατεῖν καὶ τὸ πρωτεῖον ἐκφέρεσθαι τῶν κατὰ πόλεμον ἀγώνων [5] ἵνα μὴ τύχην λέγοντες μόνον μακαρίζωμεν τοὺς κρατοῦντας ἀλόγως καθάπερ οἱ μάταιοι τῶν ἀνθρώπων ἀλλ᾽ εἰδότες τὰς ἀληθεῖς αἰτίας ἐπαινῶμεν καὶ θαυμάζωμεν κατὰ λόγον τοὺς ἡγουμένους
Puograve essere cosa buona e utile esaminare le differenze e per quale motivo i Ro-mani prevalgono e riportano il primo premio nelle competizioni di guerra af-fincheacute non esaltiamo i vincitori senza una ragione parlando solo di fortuna co-me fanno gli sciocchi ma conoscendo le vere cause lodiamo e ammiriamo i co-mandanti seguendo una logica
Polibio dunque sembra rispondere a coloro che parlavano della buo-na stella dei Romani sottolineando che la vittoria nasceva dalla superio-re strategia militare della legione43 Un punto di vista quindi opposto a quello espresso nellrsquoEpitome che proprio di Romana Fortuna parla e riba-dito in chiusura al passo dove Polibio critica nuovamente quei Greci che ritenevano la vittoria romana incredibile (XVIII 32 13)
41 Urban (1982) pp 1424-1443 1435 Richter (1987) p 19 n 4 Alonso-Nuacutentildeez (1992) p 66 e Id (2002) pp 105-110 partic 108-109 Contra Heckel (1997) p 29 che ridimen-siona la categorizzazione di Trogo come storico anti-romano 42 Su Cinoscefale vd Walbank (1957) ad l Hammond (1988) pp 60-82 Sklenaacuter (2004) pp 302-310 Thornton (2014) pp 83-87 43 Sulla Fortuna in Polibio vd McGing (2010) pp 195-201 (con bibliografia) che distin-gue tra quando Polibio intenda caso e quando predeterminazione fato Vd anche Green (1990) pp 400-402 e Eckstein (2008) pp 132-138
IL DISCORSO DEL RE 135
Il punto di vista di Trogo sembra invece presente nei frammenti del-la Makedonikeacute di Appiano su Filippo V44 dove ci si riferisce a Cinoscefale come a una vittoria insperata (Mak 9 1)
ἡγούμενος δ᾽ οὔτε Ῥωμαίοις συμφέρειν οὔτε τοῖς Ἕλλησι Φιλίππου καθαιρεθέντος ἐπιπολάσαι τὴν Αἰτωλῶν βίαν τάχα δ᾽ αὐτὸν καὶ τὸ παράδοξον τῆς νίκης ἀγαπᾶν ἐποίει
Flaminino era consapevole che non sarebbe stato vantaggioso per i Romani o per i Greci che Filippo fosse deposto e che il potere etolico rimanesse incon-trastato forse lo aveva reso moderato nei suoi progetti lrsquoaver ottenuto una vit-toria insperata
Addirittura successivamente si accenna alla sorte avversa a Filippo nel-lo scontro
τὰ μὲν δὴ παρὰ τῶν ἄλλων φιλάνθρωπα ἦν τό τε τῆς τύχης ἄδηλον ἐξ ὧν ἔπαθεν ὁ Φίλιππος ὑφορωμένων καὶ τὸ πταῖσμα τοῦτο οὐ κατ᾽ ἀσθένειαν ἀλλὰ πλέον ἐκ συντυχίας αὐτὸν παθεῖν ἡγουμένων
Gli altri (Greci) erano inclini ad essere moderati vedendo con sospetto lrsquoincer-tezza della fortuna subita da Filippo e ritenendo che egli fosse incorso in questa sconfitta non tanto per la sua inferioritagrave quanto per la sfortuna
Il riferimento in Appiano e Trogo alla fortuna romanasfortuna ma-cedone a proposito di Cinoscefale egrave una traccia dellrsquoopinione politi-ca di quei Greci disprezzati da Polibio come uomini sciocchi καθάπερ οἱ μάταιοι τῶν ἀνθρώπων Tale posizione politica su Cinoscefale sarebbe dunque sopravvissuta nella tradizione storiografica di cui troviamo trac-cia in TrogoGiustino e Appiano
Per comprendere meglio alcune caratteristiche di questa tradizione puograve essere utile tornare ai due discorsi nellrsquoEpitome di Filippo e Flamini-no prima della battaglia Tali passi probabilmente trogiani45 non trova-no infatti riscontro nelle fonti parallele a noi pervenute Polibio (XVIII 18-27) seguito fedelmente da Livio (XXXIII 5-10) pur descrivendo le operazioni di guerra di Cinoscefale con dovizia di particolari non men-ziona un discorso di Filippo ai suoi armati prima della battaglia mentre il discorso di Flaminino per incoraggiare le truppe schierate (XVIII 23 2-6) nelle Storie egrave incentrato sulle vittorie di Sulpicio nella prima parte della guerra Pare dunque originale la versione trogiana che incentra-
44 Tra i frammenti consegnatici dagli Excerpta Constantiniana sono frequenti informazio-ni e osservazioni che rimandano a una prospettiva ellenistica sugli eventi DrsquoAgostini (2011) pp 99-121 45 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362
136 MONICA DrsquoAGOSTINI
ta sulla gloria macedone presenta Cinoscefale come il punto drsquoincon-tro e di scambio tra lrsquoegemonia macedone e lrsquoegemonia romana Non egrave una novitagrave che il leitmotiv delle Storie Filippiche e dunque dellrsquoEpitome sia la translatio imperii giagrave Alonso Nuntildeez definito da Santi Amantini laquouno dei piugrave noti esperti di questioni trogiano-giustineeraquo46 osservava che Tro-go esponeva nel suo perduto lavoro la teoria della successione degli im-peri mondiali secondo lo schema Assiria-Media-Persia-Macedonia-Roma osteggiata dai Parti47 In tale successione il ruolo da protagonista egrave rico-perto dallrsquoegemonia macedone48 che occupa allrsquoincirca 26 dei 44 libri e il cui ultimo vero momento di gloria egrave lo scontro con Roma appunto a Cinoscefale Lrsquoultima impresa macedone ha come esito la transizione del dominio universale da Oriente a Occidente e costituisce il tema cen-trale dellrsquointera vicenda di Filippo lrsquoimportanza della battaglia di Cino-scefale egrave perciograve esaltata nei discorsi sia di Filippo che di Flaminino che a loro volta sono il punto di arrivo delle argomentazioni esposte nelle parole di Demetrio di Faro e di Filippo stesso giagrave nel libro XXIX Le ora-tiones disposte retoricamente nei due libri descrivono due parabole op-poste da un lato quella romana che da lontana potenza desiderosa di espandersi cresce come una pioggia di sangue diventando il giovane e vigoroso potere che sottomesso Annibale egrave pronto a sconfiggere Filip-po Dallrsquoaltro quella macedone che originata con Filippo II personag-gio centrale per Trogo raggiunge il suo apice con la conquista dellrsquoege-monia ad opera di Alessandro Magno contro i Persiani per conoscere la fine con Filippo V il cui antico valore egrave ormai troppo lsquosbiaditorsquo per te-ner testa al vigore romano
La gloria macedone secondo Trogo inizia dunque con Filippo II e si conclude con Filippo V Perseo egrave infatti il malvagio responsabile dellrsquoan-nientamento di ciograve che rimaneva della monarchia macedone49 Trogo pone agli estremi della parabola macedone che occupa dal libro IX al XXX i due re di nome Filippo Filippo II e Filippo V come ribadito in piugrave luoghi dellrsquoEpitome sia in parti riassunte da Giustino che in passi piugrave genuinamente trogiani Dando per scontato che il titolo dellrsquoopera Sto-rie Filippiche si debba al desiderio di Trogo di rifarsi allrsquoopera di Teopom-po sul sovrano macedone egrave possibile che tale titolo sia stato perograve ripen-
46 Santi Amantini (2003) pp 99-11047 laquoPompeius Trogus expounded in his lost work the Historiae Philippicae a theory of the world empire suggestion according to the scheme Assyria-Media-Persia-Macedonia-Rome opposed by the Parthiansraquo Alonso-Nuacutentildeez (2002) pp 105-110 e 133-136 partic 105 Vd anche Richter (1987) pp 19-23 Momigliano (1980) pp 157-162 Alonso-Nuacutentildeez (1992) Heckel (1997) pp 1-41 Gabba (2003) pp 7-9 Santi Amantini (2003) pp 99-110 Mariotta (2014) pp 45-56 48 Franco (1993) pp 71-97 e Landucci (2014) pp 233-26149 Alonso-Nuacutentildeez (2002) pp 105-110 partic 108-109
IL DISCORSO DEL RE 137
sato da Trogo considerando che il periodo compreso tra le imprese dei due Filippo occupa 23 dellrsquoopera50 Si potrebbe allora suggerire che le Storie sono Filippiche poicheacute i due Filippo segnarono lrsquoinizio e la fine di quella che egrave nellrsquoopera di Trogo lrsquoegemonia incontrastata del mondo piugrave gloriosa di tutti i tempi51
La prospettiva ellenistica che vede nei due Filippo i limiti della grande egemonia macedone egrave di nuovo presente anche in Appiano nellrsquooraco-lo riportato nei frammenti della sua Makedonikeacute e noto anche da Pausa-nia (VII 8 9)
αὐχοῦντες βασιλεῦσι Μακηδόνες Ἀργεάδῃσιν ὑμῖν κοιρανέων ἀγαθὸν καὶ πῆμα Φίλιππος ἤτοι ὁ μὲν πρότερος πόλεσιν λαοῖσί τ᾽ ἄνακτας θήσει ὁ δ᾽ ὁπλότερος τιμὴν ἀπὸ πᾶσαν ὀλέσσει δμηθεὶς δ᾽ ἑσπερίοισιν ὑπ᾽ ἀνδράσιν ἐνθάδ᾽ ὀλεῖται
O Macedoni che andate orgogliosi dei re di stirpe argiva I re di nome Filippo saranno arbitri del bene e del male per voi Il primo vi renderagrave signori di cittagrave e popoli il secondo vi priveragrave di ogni onore sconfitto da uomini dellrsquoOcciden-te qui giace morto52
Senza voler entrare nel merito della discussione di tale oracolo di nuo-vo pare di incontrare nei due autori la medesima prospettiva lontana dalla condanna morale del re macedone espressa da Polibio secondo cui la sconfitta egrave il giusto esito della sua crudeltagrave ed empietagrave
Il libro giustineo si conclude menzionando le condizioni della pa-ce di Tempe53 e lrsquoira degli Etoli che videro ignorate le proprie richieste da Flaminino e perciograve cercarono lrsquoalleanza di Antioco contro Roma Se-condo il Prologo XXX il libro perograve proseguiva con le campagne di Antio-co III in Asia Minore contro Molone e Acheo e in Battriana fino ad ar-rivare allrsquoesordio dello scontro con Roma54 Il riassunto giustineo egrave trop-po sommario per permettere un confronto con le fonti parallele Egrave pe-
50 Sul rilievo della storia della Macedonia nellrsquoopera di Trogo e Giustino vd von Gutsch-midt (1894) pp 17-217 Richter (1987) p 28 n 29 Franco (1993) pp 71-97 51 Vd anche Urban (1982) pp 1424-1443 e Alonso-Nuacutentildeez (1992) p 58 52 Mak Fr 2 Vd DrsquoAgostini (2011) pp 99-121 In questa Walbank (2002) pp 127-136 propone di interpretare anche un poema di Alceo di Messene (Anth Pal 9518)53 Egrave probabile che Trogo fornisse piugrave particolari riguardo a questa pace per esempio si puograve ritenere che vi fosse menzione dellrsquoinvio a Roma del figlio Demetrio da parte di Filippo come ostaggio dato che a Iust XXXII 2 3 si richiama appunto tale avvenimento54 Polyb XVIII 34 1-39 7 42 1-45 12 Liv XXXIII 11 3-13 15 24 1-31 11 Plut Flam IX 1-8 App Mak Fr IX riferiscono di due diverse trattative di pace caratterizzate da un vivace dibattito tra chi voleva lrsquoannientamento della Macedonia come in Grecia gli Etoli e a Roma Marco Claudio Marcello e coloro che desideravano la pace con la Macedonia in primis Flaminino
138 MONICA DrsquoAGOSTINI
rograve da notare la mancanza sia nel Prologo che nel testo del libro degli av-venimenti delle celebrazioni Istmie del 196 quando Flaminino procla-mograve la libertagrave dei Greci Piugrave in generale in tutta la narrazione di Giustino delle complesse trattative del 197-196 manca qualsiasi riferimento alla li-bertagrave dei Greci punto nodale nella tradizione di Polibio che con questa sottolineatura esalta sia il ruolo tirannico della Macedonia sia la grande generositagrave dei Romani nei confronti della Grecia Il silenzio di TrogoGiustino su tale questione mostra il prevedibile disinteresse per gli affari dei Greci e nel contempo conferma la presenza di una tradizione che si occupa soprattutto della storia delle monarchie ellenistiche allrsquointer-no della quale la posizione dellrsquoEllade egrave subalterna
Libro XXXII23- 34 Demetrio e Perseo
Gli ultimi anni di regno di Filippo tra il 183 e il 179 sono narrati in un passo breve del libro XXXII Il racconto in Giustino che egrave coerente con il Prologo trogiano segue in maniera sintetica la tradizione polibiana su questi eventi giunta a noi in alcuni passi lacunosi di Polibio (XXIII 1 3-3 10 7 1-7 10 1-11 8) integrati dal racconto particolareggiato di Li-vio (XXXIX 46 7- 48 6 53 1-16 XL 3 3-16 3 201-24 8) e dalla narra-zione di Diodoro (XIX 25) e Plutarco (Aem VIII 11)55
Conclusioni
In questi libri dedicati a Filippo egrave forse possibile vedere in filigrana la rielaborazione voluta di Giustino dei corrispondenti libri trogiani Co-me Giustino stesso afferma nella Prefatio 3 lrsquoopera di Trogo era costruita secondo due criteri quello cronologico e quello per laquoconcatenazione di eventi56raquo ea omnia Pompeius diuisa temporibus et serie rerum digesta conposuit
55 Lrsquoutilizzo della tradizione polibiana in Trogo egrave confermato dallrsquoaderenza a Livio (XL 54 1-56 11) e Diodoro (XXIX 28) del racconto sul pentimento di Filippo per aver ucciso il figlio Demetrio lrsquointenzione di punire Perseo e la correlazione tra questo e la sua mor-te Questo libro egrave dunque differente nellrsquointeresse e nelle fonti dai libri XXIX e XXX poicheacute molto vicino alla tradizione polibiana in Livio Questi avvenimenti in Giustino sono da collegare con lrsquoascesa al trono di Perseo e non con lrsquoepilogo della celebrazione del valore macedone giagrave conclusasi in Giustino con Cinoscefale e la transizione dallrsquoim-perium macedone allrsquoimperium romano Vd Heckel (1997) p 7 Appiano invece riporta ancora una tradizione diversa da quella polibiana in un frammento della Makedonikeacute in particolare Appiano egrave attento al punto di vista macedone e presenta Filippo come una vittima delle circostanze (Mak IX) DrsquoAgostini (2011) pp 99-12156 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362 Alonso-Nuacutentildeez (2002) pp 133-136 He-ckel (1997) pp 1-41 Borgna (2014) pp 52-77
IL DISCORSO DEL RE 139
Serie rerum digesta sembrerebbe unrsquointerpretazione latina della formula κατὰ γένος che Diodoro usa per indicare la struttura della storia di Efo-ro sottolineandone la divisione per argomento57 In tale struttura per argomento dellrsquoEpitome tra i temi principali ci sono dunque il valore e la gloria dei sovrani ellenistici58 riscontrabile nei libri XXVIII-XXXI sui re-gni di Antigono Dosone Filippo V e Antioco III Tale tema presente di sicuro in Trogo egrave conservato nellrsquoazione dellrsquoEpitomatore e anzi come si vede dagli escerpta esaltato dalla selezione dei passi
Per quanto riguarda invece la Quellenforschung 59 egrave evidente che nel testo vi sia presenza di filoni non tradizionali sugli eventi poicheacute la posi-zione di Trogo appare spesso autonoma rispetto alle opinioni condivise dalla storiografia antica Questo aspetto dellrsquoEpitome evidente soprattut-to per ciograve che riguarda gli eventi ellenistici ha suscitato la grande curio-sitagrave degli studiosi che allontanatisi dalla proposta di von Gutschmid che voleva una totale ed esclusiva dipendenza di Trogo da Timagene ora in-dicano con sicurezza tra le fonti piugrave rilevanti per gli eventi ellenistici di III secolo utilizzate da Trogo almeno altri sei nomi oltre a Timagene Ie-ronimo Timeo Filarco Duride Polibio e Posidonio
Per quanto riguarda nello specifico la composizione dei libri XXIX e XXX non vi egrave alcun dubbio che in essi Trogo abbia utilizzato (anche riadattandola) una fonte poco attenta alle questioni di politica interna greca e al legame tra queste e quel ritratto di Filippo come sovrano mal-vagio ed empio che ritorna nella tradizione ufficiale di origine polibia-na passando poi da Polibio in Livio Diodoro e Plutarco60 Trogo pre-serva invece una tradizione ellenistica interessata alla figura di Filippo come ultimo barlume della gloria macedone tradizione che pare quasi una controparte e un completamento dellrsquoAb urbe condita romanocentri-ca di Livio Non si puograve perciograve a mio avviso escludere che per questa se-zione Trogo abbia usato una tradizione di matrice filoellenistica o sem-plicemente ellenisticocentrica unrsquoopera sui regni di diadochi ed epigo-ni che a tutti noi fa venire facilmente alla mente il Basileis o Perigrave Basileon dello storico grecoellenistico augusteo filobarbaro scettico (o critico) verso lrsquoegemonia romana Timagene di Alessandria (FGrHist 88)61
57 Su Eforo vd Vannicelli (1987) pp 165-191 e ora Parmeggiani (2011) 58 Simile legame vi egrave a mio avviso tra i libri XXVI e XXVII che invece affrontavano la crisi delle monarchie ellenistiche causata dalle guerre fraterne59 Vd von Gutschmid (1894) pp 17-217 Richter (1987) pp 17-30 partic 20-23 San-ti Amantini (1972) pp 56-109 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362 Urban (1982) pp 1424-1443 partic 1435 Mecca (2001) pp 199-222 Santi Amantini (2003) pp 99-110 Heckel (2012) pp 3-860 Scuderi (2005) pp 383-40561 Sordi (1982) pp 775-797 Heckel (1997) pp 30-34 Landucci (2014) pp 233-261 e Ead in questo volume
140 MONICA DrsquoAGOSTINI
ABSTRACT
Philip V of Macedon was the first of the Epigonoi to face Rome Several mod-ern reconstructions of the actions and the reign of Philip V have approached it largely from a Roman point of view using as sources Polybius and where Poly-bius is lost Livy The Polybian historiographical tradition tends to portray Phil-ip V as an enemy and a tyrant impious and cruel The Macedonian king was ea-ger to establish a universal and unjust dominion over Greece Italy and beyond and Rome engaged in the first two Macedonian Wars to fight the threat of his growing ambition Nevertheless Polybiusrsquo portrayal of Philip V was affected not only by Polybiusrsquo admiration for Roman political structures military power and overwhelming conquest but also his personal Achaean origins
Looking at in book 29 and 30 of Justinrsquos Epitome of Pompeius Trogus this pa-per focuses on the non Polybian tradition on Philip V this contribution is in-deed the first analysis of the Hellenistic approach to the clash between Rome and Macedonia in the 3rd-2nd Century BC The Epitome shows a considerable di-versity of interpretation from the other sources and reflects very different views of Philip Vrsquos actions that brought him into conflict against Rome In particular these views are more evident related to the accounts of the peace negotiations of Naupactus and the battle of Cynoscephalae in the Epitome the king appears as a courageous and skilled warrior the last of the great Macedonian rulers who fell victim to misfortune This portrayal which has several common features with Appianrsquos fragments of Philip V (Mak 9) counterbalances the Roman and Achaean standpoint present in Polybius providing a more Hellenistic perspec-tive that is likely to have been rooted in a historiographical tradition connect-ed to the losing side in the struggle between Rome and the Hellenistic world
BIBLIOGRAFIA
Adler E (2006) Whorsquos Antiroman Sallust and Pompeius Trogus on Mithridates CJ 101 pp 383-407
Adler E (2011) Valorizing the Barbarians Enemy speeches in Roman Historiography Austin
Ager SL (2003) An Uneasy Balance from the Death of Seleukos to the Battle of Raph-ia in A Erskine (ed) A Companion to the Hellenistic World Oxford pp 35-50
Ager SL (2009) Roman Perspectives on Greek Diplomacy The conceptual clash Greek diplomacy of compromise and Roman Bellum Iustum in C Eilers (ed) Diplomats and Diplomacy in the Roman World Leiden-Boston pp 15-43
Alonso-Nuacutentildeez JM (1992) La Historia Universal de Pompeyo Trogo Madrid
Alonso-Nuacutentildeez JM (2002) The Idea of Universal History in Greece From Herodotus to the Age of Augustus Amsterdam
Ballesteros Pastor L (2013) Pompeyo Trogo Justino y Mitriacutedates Comentario al Epiacutetome de las Historias Filiacutepicas (3716-3881) Hildesheim-Zuumlrich-New York
IL DISCORSO DEL RE 141
Barreacute ML (1983) The God-List in the Treaty between Hannibal and Philip V of Ma-cedon a Study in Light of the Ancient Near Eastern Treaty Tradition Baltimore-Lon-don
Beck H - Eckstein A (2015) sv ldquoAratos of Sicyon (231)rdquo in I Worthington (ed) Brillrsquos New Jacoby Brill Online
Borgna A (2014) Uno sguardo originale intorno a Roma Pompeo Trogo e Giustino laquoLa Biblioteca di ClassicoContemporaneoraquo 1 pp 52-77
Cassola F (1962) I gruppi politici romani nel III secolo aC Trieste
Champion CB (1997) The Nature of Authoritative Evidence in Polybios and Agelausrsquo Speech at Naupactos TAPhA 127 pp 111-128
Champion CB (2004) Cultural Politics in Polybiusrsquo Histories Berkeley
Coppola A (1993) Demetrio di Faro un protagonista dimenticato Roma
Criscuolo L (2011) I due testamenti di Tolemeo VIII Evergete II in A Joumlrdens - J F Quack (hrsg) Aumlgypten zwischen innerem Zwist und aumluszligerem Druck Die Zeit Ptole-maios VI bis VIII Wiesbaden pp 132-150
DrsquoAgostini M (2011) Filippo V e la Storia Romana di Appiano laquoAevumraquo 85 pp 99-121
Eckstein AM (1995) Moral vision in the Histories of Polybius Berkeley
Eckstein AM (2008) Rome enters in the Greek East From Anarchy to Hierarchy in the Hellenistic Mediterranean 230-217 BC Oxford
Eckstein AM (2013) Polybius Phylarchus and Historiographical Criticism CPh 108 4 pp 314-338
Errington RM (1969) Philopoemen Oxford
Errington RM (2008) A History of the Hellenistic World 323-30 BC Malden MA-Oxford
Forni G - Angeli Bertinelli MG (1982) Pompeo Trogo come fonte di storia ANRW II 30 2 pp 1298-1362
Franco C (1993) Trogo Giustino e i successori di Alessandro in L Braccesi - A Coppola - G Cresci Marrone - C Franco (a cura di) LrsquoAlessandro di Giustino dagli antichi ai moderni Roma pp 71-97
Gabba E (2003) Introduzione in D Foraboschi - SM Pizzetti (a cura di) La successione degli imperi e delle egemonie nelle relazioni internazionali Milano pp 7-9
Golan D (1995) The Res Graeciae in Polybius Four Studies Como
Green P (1990) Alexander to Actium The Historical Evolution of the Hellenistic Age Berkeley-Los Angeles
Gutschmid von A (1894) Die beiden ersten Buumlcher des Pompeius Trogus in A von Gutschmid - F Ruumlhl (hrsg) Kleine Schriften Leipzig pp 17-217
142 MONICA DrsquoAGOSTINI
Habicht C (1995) Athen Muumlnchen
Hammond NGL (1968) Illyris Rome and Macedon in 229-205 BC JRS 58 pp 1-21
Hammond NGL (1988) The Campaign and the Battle of Cynoscephalae in 197 BC JHS 108 pp 60-82
Heckel W (1997) Introduction (Part 2) in JC Yardley - W Heckel (eds) Ju-stin Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus Books 11-12 Alexander the Great Introduction Oxford pp 1-41
Heckel W (2012) Introduction in JC Yardley - P Wheatley - W Heckel (eds) Justin Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus II Books 13-15 The Successors to Alexander the Great Oxford pp 1-8
Huss W (1976) Untersuchungen zur Auszligenpolitik Ptolemaiosrsquo IV Muumlnchen
Huss W (2001) Aumlgypten in hellenistischer Zeit 332ndash30 v Chr Muumlnchen
Intrieri M (2011) Fra dialogo e conflitto Annibale e i Greci drsquoOccidente RStudFen 37 pp 53-82
Landucci F (2014) Filippo II e le Storie Filippiche un protagonista storico e storio-grafico in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 233-261
Landucci Gattinoni F (2011) Politica e ideologia in etagrave ellenistica laquoPolitica An-ticaraquo 1 pp 89-105
Leacutevy E (1994) Le discours drsquoAgeacutelaos de Naupacte in L Aigner Foresti - A Bar-zanograve - C Bearzot - L Prandi - G Zecchini (a cura di) Federazioni e federalismo nellrsquoEuropa antica Bergamo 21-25 settembre 1992 Milano (Alle radici della casa co-mune europea 1) pp 33-50
Longaretti L (1989) Lrsquoalleanza tra Annibale e Filippo V di Macedonia RIL 123 pp 183-192
Marasco G (1979-1980) La valutazione di Tolemeo IV Filopatore nella storiografia greca laquoSilenoraquo 5-6 pp 159-182
Mari M [- Musti D - Thornton J] (2002) Polibio Storie Volume III Libri V-VI Milano
Mariotta G (2014) Geografia e Geopolitica nelle Storie Filippiche in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 45-56
McGing B (2010) Polybiusrsquo Histories New York
McGing B (2013) Youthfulness in Polybius the case of Philip V of Macedon in B Gibson - T Harrison (eds) Polybius and his world Oxford pp 181-199
Meadows A (2013) Polybius Aratus and the History of the 140th Olympiad in B
IL DISCORSO DEL RE 143
Gibson - T Harrison (eds) Polybius and his World Essays in Honour of Frank Walbank Oxford pp 91-116
Mecca A (2001) Trogo Timagene e Polieno QS 54 pp 199-222
Meister K (1990) Die Griechische Geschichtsschreibung von den Anfaumlngen bis zum Ende des Hellenismus Stuttgart
Misch G (1949) Geschichte der Autobiographie I Frankfurt am Mein
Momigliano A (1980) Daniele e la teoria greca della successione degli imperi RAL 35 pp 157-162
Muccioli F (2013) Gli epiteti ufficiali dei re ellenistici Stuttgart (Historia Einzel-schriften 224)
Musti D (1978) Polibio e lrsquoimperialismo romano Napoli
Parmeggiani G (2011) Eforo di Cuma studi di storiografia greca Bologna
Peacutedech P (1964) La meacutethode historique de Polybe Paris
Pelling CBR [- Scardigli B - Manfredini M](1997) Plutarco Vite parallele Filopemene Tito Flaminino Milano
Richter H-D (1987) Untersuchungen zur hellenistischen Historiographie die Vorla-gen des Pompeius Trogus fuumlr die Darstellung der nachalexandrischen hellenistischen Ge-schichte (Iust 13-40) Frankfurt
Santi Amantini L (1972) Fonti e valore storico di Pompeo Trogo (Iustin XXXV e XXXVI) Genova
Santi Amantini L (1981) (a cura di) Giustino Storie Filippiche Epitome da Pom-peo Trogo Milano
Santi Amantini L (2003) Il tempo e i tempi nelle Storie Filippiche di Pompeo Tro-go RSA 33 pp 99-110
Schepens G (1983) Les rois ptolegravemaiumlques et lrsquohistoriographie Reacuteflexions sur la trans-formation de lrsquohistoire politique in E vanrsquot Dack - P van Dessel - W Van Gucht (eds) Egypt and the Hellenistic World Proceedings of the International Collo-quium Leuven 24-26 May 1982 Leuven (Studia Hellenistica 27) pp 351-368
Schlicher JJ (1933) Non-Assertive Elements in the Language of the Roman Histo-rians CPh 28 289-300
Schmitt T (1989) Die Bedeutung des zweiten Punischen Krieges fuumlr den Frieden in Naupaktos in H Devijver - E Lipinski (eds) Punic wars Proceedings of the Conference held in Antwerp from the 23th to the 26th of November 1988 in Cooperation with the Departement of History of the laquoUniversitait Antwerpenraquo UFSIA Leuven (Studia Phoenicia 10) pp 229-239
Scholten JB (2000) The Politics of Plunder Aitolians and their koinon in the early Hellenistic Era Berkeley
144 MONICA DrsquoAGOSTINI
Scuderi R (2005) Filippo V e Perseo nei frammenti diodorei in C Bearzot - F Lan-ducci (a cura di) Diodoro e lrsquoaltra Grecia Macedonia Occidente Ellenismo nella Bi-blioteca Storica Atti del convegno Milano 15-16 gennaio 2004 Milano pp 383-405
Sklenaacuter RJ (2004) Sources and Individuality in Two Passages of Livy laquoHistoriaraquo 53 pp 302-310
Sordi M (1982) Timagene di Alessandria Uno storico ellenocentrico e filobarbaro ANRW II 30 1 pp 775-797
Thornton J (2014) Le guerre macedoniche Roma
Urban R (1979) Wachstum und Kriese des achaumlischen Bundes Quellenstudien zur entwicklung des Bundes von 280 bis 222 V Chr Wiesbaden
Urban R (1982) laquoGallisches Bewusstseinraquo und laquoRomkritikraquo bei Pompeius Trogus ANRW II 30 2 pp 1424-1443
Vannicelli P (1987) Lrsquoeconomia delle Storie di Eforo RFIC 115 pp 165-191
Vattuone R (2014) Giustino e lrsquoOccidente greco I VI-V secolo aC in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 261-277
Vollmer D (1990) Symploke das Uumlbergreifen der roumlmischen Expansion auf den grie-chischen Osten Untersuchungen zur roumlmischen Aussenpolitik am Ende des 3 Jh V Chr Stuttgart
Walbank FW (1957) A Historical Commentary on Polibius I Oxford
Walbank FW (1967) A Historical Commentary on Polybius II Oxford
Walbank FW (1933) Aratos of Sicyon Cambridge
Walbank FW (2002) Η ΤΩΝ ΟΛΩΝ ΕΛΠΙΣ and the Antigonids in FW Walbank (ed) Polybius Rome and the Hellenistic World Essays and Reflections West Nyack NY pp 127-136
Weber G (1997) Interaktion Repraumlsentation und Herrschaft Der Koumlnigshof im Hel-lenismus in A Winterling (hrsg) Zwischen lsquoHausrsquo und lsquoStaatrsquo antike Houmlfe im Ver-gleich Munich pp 27-72
Will E (19822) Histoire politique du Monde Helleacutenistique II Nancy
Zecchini G (1990) La storiografia lagide in H Verdin - G Schepens - E De Keyser (eds) Purposes of History Studies in Greek Historiography from the 4th to the 2nd Centuries BC Proceedings of the International Colloquium of Leuven 24-26 May 1988 Leuven (Studia Hellenistica 30) pp 213-232
Zecchini G (2003) Polibio e la tradizione orale in A Casanova - P Desideri (a cura di) Evento racconto scrittura nellrsquoantichitagrave classica Firenze pp 123-141
Finito di stamparenel mese di novembre 2015
da LegoDigit srlLavis (TN)
IL DISCORSO DEL RE 125
non solo non puograve passare inosservata ma deve indurre i moderni a du-bitare per questi eventi di unrsquoapparente dipendenza diretta giagrave di Tro-go da Polibio
21- 38 Demetrio di Faro e Naupatto
Scomparso Arato nellrsquoEpitome XXIX ha invece un ruolo fondamentale in questi anni come consigliere di Filippo Demetrio di Faro a cui egrave at-tribuito il primo discorso in oratio obliqua dei due libri esaminati13
Demetrio di Faro era un dinasta illirico che si incontra per la prima volta nelle fonti storiografiche in occasione della prima guerra di Ro-ma in Illiria nel 229 Sappiamo infatti da Polibio (II 10 8-11 4) e Appia-no (Illyr 7) che Demetrio giagrave alleato di Teuta sovrana degli Illiri aveva scelto di passare dalla parte romana ed era stato poi ricompensato dal Senato con il controllo di parte dei territori sottratti da Roma a Teuta stessa Nei suoi tentativi di ritagliarsi un ruolo importante nella penisola balcanica Demetrio nel 222 si era alleato con la Lega Ellenica di Doso-ne e Arato a Sellasia contro Cleomene (Polyb II 65 2- 5) ma negli an-ni successivi le sue scorribande nellrsquoAdriatico allarmarono Roma che gli mosse guerra (Polyb III 16 IV 16)14 Sconfitto da Roma e cacciato da Faro Demetrio si rifugiograve alla corte di Filippo intorno al 218 diventan-do consigliere del re
Poicheacute nel Prologo XXVIII si legge laquoIn una digressione egrave narrata la guerra illirica combattuta dai Romani contro Teuta15raquo non egrave da esclu-dere che Trogo giagrave citasse il dinasta di Faro anche se la prima menzio-ne di Demetrio in Giustino egrave a XXIX 2 1 quando il cosiddetto lsquore de-gli Illirirsquo cacciato da Lucio Emilio Paolo dallrsquoAdriatico arrivograve alla corte macedone Nel riassunto degli eventi Giustino segue piugrave da vicino Tro-go riportando il discorso del dinasta a Filippo V per convincere il sovra-no a far guerra a Roma (XXIX 2 2-6) I punti principali di tale discorso sono che i Romani aspirano a realizzare un impero universale a scapito di tutti i re laquocome se fosse cosa illecita che ci fosse un qualche re presso i confini del loro Statoraquo Perciograve Filippo V doveva prepararsi alla guerra con i Romani poicheacute laquoquanto piugrave accessibile e illustre era il suo regno tanto piugrave accaniti nemici gli sarebbero stati i Romani16raquo Demetrio vole-
13 Su questi discorsi di Demetrio vd Coppola (1993) pp 29-5114 Coppola (1993) pp 29-51 vd anche Hammond (1968) pp 1-21 Eckstein (2008) pp 41 58-60 Demetrio di Faro era presentato in Polibio come il rivale di Arato tra i consi-glieri di Filippo Polyb IX 23 9 infatti dichiara che quando il sovrano seguiva i consigli di Arato compiva grandi imprese mentre quando ascoltava Demetrio si macchiava di atti spregevoli15 Trog Prol XXVIII Dictum in excessu bellum Illyricum quod Romani gessere cum Teuta16 Iust XXIX 2 4-5 sibi quoque non aliam ob causam quam quod Italiae finitimus uidebatur
126 MONICA DrsquoAGOSTINI
va infatti cacciare i Romani dalla sponda adriatica dellrsquoIlliria territorio che avrebbe ceduto a Filippo
Il discorso di Demetrio a Filippo egrave presente anche in Polibio (V 101 8-1017) ed egrave inserito cronologicamente durante i giochi Nemei18 nel 217 subito dopo la sconfitta romana del lago Trasimeno ricordata an-che nel passo di Giustino Nel discorso polibiano Demetrio perograve sotto-linea il diritto di Filippo V ad aspirare al dominio universale a partire dallrsquoAdriatico19 mentre nel discorso trogiano Demetrio accusa i Roma-ni di aspirare ad espandersi travolgendo qualsiasi regno sul loro cammi-no Trogo nel discorso di Demetrio presenta il coinvolgimento roma-no in Oriente come una guerra di conquista che contrappone la giova-ne potenza romana allrsquolsquoillustre regnorsquo di Filippo20 prospettiva che ritor-na nel successivo discorso di Filippo V nellrsquoEpitome ma che egrave estranea al-la narrazione di Polibio
Dopo il discorso di Demetrio nellrsquoEpitome come in Polibio (V 104 1) si arriva allrsquoincontro di pace di Naupatto nel 217 che pose fine al-la Guerra degli Alleati tra Etoli Spartani ed Elei contro la lega Achea e
bellum inlatum quasi nefas esset aliquem regem iuxta imperii eorum terminos esse Sed et ipsi cauen-dum esse exemplum cuius quanto promptius nobiliusque sit regnum tanto sit Romanos acriores hostes habiturus17 Polyb V 101 8-10 ὃς καὶ λαβόμενος τῆς ἀφορμῆς ταύτης τὸν μὲν πρὸς τοὺς Αἰτωλοὺς ᾤετο δεῖν τὴν ταχίστην ἀπορρῖψαι πόλεμον ἀντέχεσθαι δὲ τῶν κατὰ τὴν Ἰλλυρίδα πραγμάτων ἠξίου καὶ τῆς εἰς Ἰταλίαν διαβάσεως [9] τὰ μὲν γὰρ κατὰ τὴν Ἑλλάδα πάντα καὶ νῦν ἤδη ποιεῖν αὐτῷ τὸ προσταττόμενον ἔφη καὶ μετὰ ταῦτα ποιήσειν Ἀχαιῶν μὲν ἐθελοντὴν εὐνοούντων Αἰτωλῶν δὲ καταπεπληγμένων ἐκ τῶν συμβεβηκότων αὐτοῖς κατὰ τὸν ἐνεστῶτα πόλεμον [10] τὴν δ᾽ Ἰταλίαν ἔφη καὶ τὴν ἐκεῖ διάβασιν ἀρχὴν εἶναι τῆς ὑπὲρ τῶν ὅλων ἐπιβολῆς ἣν οὐδενὶ καθήκειν μᾶλλον ἢ ᾽κείνῳ τὸν δὲ καιρὸν εἶναι νῦν ἐπταικότων Ῥωμαίων Trad da Mari (2002) laquoCostui allora cogliendo lrsquooccasione gli consigliograve di interrompere al piugrave presto la guerra con gli Etoli e gli chiese di impegnarsi nelle operazioni in Illiria e nellrsquoattraversamento del mare verso lrsquoItalia Disse che infatti giagrave ora tutta la Grecia eseguiva i suoi ordini e lo avrebbe fatto anche in seguito poicheacute gli Achei lo sostenevano di loro iniziativa mentre gli Etoli erano rimasti molto colpiti da quanto era loro avvenuto nella guerra in corso e aggiunse che lrsquoItalia e lrsquoattraversamento del mare in quella direzione erano lrsquoinizio di un disegno di dominio universale che a nessuno spettava piugrave che a lui ora era il momento opportu-no visto che i Romani erano stati battutiraquo18 I giochi Nemei in onore di Zeus erano giochi panellenici celebrati in Argolide negli anni pari delle Olimpiadi 19 Secondo Eckstein (1995) pp 211-212 tale aspirazione egrave connessa allrsquoincapacitagrave di mo-derazione nella vittoria del sovrano Sul concetto di dominio universale in Polibio vd Musti (1978) pp 16-18 Eckstein (2008) pp 217-220 e 372-38120 Adler (2006) pp 383-407 e (2011) pp 37-58 ha notato che i punti principali del discorso di critica allrsquoespansionismo romano di Demetrio ritornano in altri due discorsi dellrsquoEpitome quello degli Etoli (XXVIII 2 1-13) e quello di Mitridate (XXXVIII 4-7) la prioritagrave data a questi argomenti da tale reiterazione retorica indica che lrsquointeresse giagrave di Trogo se non dellae suae fontei non fosse la celebrazione dellrsquoascesa di Roma allrsquoim-pero universale come in Appiano ma piuttosto lrsquoascesa e la discesa dei regni ellenistici
IL DISCORSO DEL RE 127
Filippo V 21 Il testo giustineo omette le circostanze dellrsquoevento non si menzionano infatti esplicitamente neacute il luogo dellrsquoincontro Naupatto neacute le fasi delle trattative neacute i vari rappresentanti dei diversi fronti che vi presero parte I lunghi negoziati di pace si risolvono dunque nel discor-so di Filippo V ai rappresentanti dei fronti
Il sovrano esordisce affermando che la Grecia egrave in grande pericolo percheacute chiunque avesse vinto tra Cartaginesi e Romani sarebbe poi pas-sato in Oriente Filippo utilizza la metafora delle nubi in Occidente che avrebbero macchiato con una pioggia di sangue ogni cosa spinte dai venti di vittoria inoltre il sovrano ritiene che le guerre passate dei Gre-ci siano di poco conto se paragonate alla minaccia di uno scontro con la moltitudine che si radunava in Italia descrivendo la rabbia e il valore di questi nuovi nemici che avrebbero portato rovina ai vicini Il sovrano infine ribadisce che la Grecia era in maggior pericolo della Macedonia ma che sapeva che chi avesse vinto in Italia non avrebbe frenato la sete di vittoria Perciograve anche la Macedonia stessa doveva temere un attacco
Il discorso in Polibio di Agelao di Naupatto rappresentante e leader degli Etoli22 mostra le medesime argomentazioni attribuite in Giustino allrsquointervento di Filippo argomentazioni fondate sul metus hostilis e fina-lizzate a promuovere un nuovo ruolo della Macedonia sia in Grecia che nel Mediterraneo Orientale Agelao proponendo un nuovo program-ma politico panellenico fonda le proprie argomentazioni sul metus hosti-lis per i Cartaginesi e i Romani presentati metaforicamente come nubi che incombono da Occidente Filippo dovrebbe farsi garante della tran-quillitagrave della Grecia che agendo come unrsquounica catena di cittagrave contro i barbari diverrebbe una sicura e fedele collaboratrice della Macedonia Questo permetterebbe ai Greci di conservare il diritto di far pace o guer-ra a loro piacimento senza temere che laquoi giochi da bambini con i quali ci trastulliamo tutti vengano troncati23raquo
Nonostante sia il medesimo discorso nelle due fonti Agelao introdu-ce una forte proposta di alleanza panellenica estranea alle parole di Fi-lippo Inoltre Filippo pur utilizzando la metafora delle nubi da Occi-
21 Interessanti le osservazioni di Scholten (2000) pp 224-228 a proposito della pace che sarebbe stata cercata e sperata da entrambe le parti e non imposta da Filippo come Polibio pare lasciar intendere 22 Vd soprattutto Leacutevy (1994) pp 33-50 Su questo discorso molto dibattuto dai moderni vd anche Schmitt (1989) pp 229-239 Vollmer (1990) pp 96-107 Coppola (1993) pp 149-164 Golan (1995) pp 55-74 Champion (1997) pp 111-128 e (2004) p 55 Wal-bank (2002) pp 127-136 Eckstein (2008) pp 78-83 23 Polyb V 104 10-11 καθόλου τὰς παιδιάς ἃς νῦν παίζομεν πρὸς ἀλλήλους ἐκκοπῆναι συμβῇ πάντων ἡμῶν ἐπὶ τοσοῦτον ὥστε κἂν εὔξασθαι τοῖς θεοῖς ὑπάρχειν ἡμῖν τὴν ἐξουσίαν ταύτην καὶ πολεμεῖν ὅταν βουλώμεθα καὶ διαλύεσθαι πρὸς ἀλλήλους καὶ καθόλου κυρίους εἶναι τῶν ἐν αὑτοῖς ἀμφισβητουμένων
128 MONICA DrsquoAGOSTINI
dente presente anche nelle Storie la arricchisce con la vivida immagine di una tempesta di sangue conferendo una dimensione piugrave concreta e cruenta alla predizione infine il riferimento polibiano alle guerre dei Greci nellrsquoEpitome non riguarda piugrave le guerre tra le cittagrave e le leghe gre-che ma le guerre dei Greci con Macedoni Persiani e Galli Mentre la Grecia scompare sullo sfondo la minaccia Romana egrave meno vaga e piugrave concreta e presente che in Polibio e diventa lrsquounico argomento del di-scorso di Filippo V a Naupatto
Il discorso di Demetrio e quello di Filippo sono al centro del libro XXIX dellrsquoEpitome avendo il duplice scopo di evidenziare sia la poten-ziale aggressivitagrave dei Romani sia la grande tradizione militare della Ma-cedonia e il pieno diritto di Filippo di controllare la Grecia e lrsquoIlliria fi-no allrsquoAdriatico Se il discorso in Polibio si inseriva in un dibattito politi-co dove la Grecia e la Macedonia erano protagoniste alla pari della sce-na ellenica e internazionale nella versione che leggiamo in Trogo i ri-ferimenti alle dispute della realtagrave greca sono reinterpretati a favore di un punto di vista in cui la Macedonia egrave lrsquounico potere dellrsquoOriente gre-co Del dibattito politico di III secolo in Grecia che tanto stava a cuore a Polibio non vi egrave piugrave alcuna traccia in TrogoGiustino rimane soltanto lo scontro tra le due grandi potenze di Oriente e Occidente tra Filippo e Roma Questa prospettiva bipolare dei discorsi trogiani si ritrova nel-la conclusione del capitolo che se da un lato sottolinea ancora una vol-ta il timore di Filippo per Cartaginesi e Romani dallrsquoaltro esplicita che i Romani avevano paura dellrsquoantica gloria dei Macedoni laquovincitori dellrsquoO-rienteraquo e soprattutto di Filippo laquoinfiammato dallo zelo di emulare Ales-sandro che era ben noto come pronto alle guerre e instancabileraquo24
41-11 La Prima Guerra Macedonica
Dei prodromi della Prima Guerra Macedonica Giustino si interessa sol-tanto allrsquoalleanza antiromana tra Annibale e Filippo Questo trattato egrave noto da molte fonti secondo cui Filippo dopo aver appreso che i Roma-ni erano stati sconfitti di nuovo dai Cartaginesi a Canne nel 216 avreb-be mandato unrsquoambasceria ad Annibale per proporre unrsquoalleanza ma lrsquoambasciatore macedone sarebbe stato catturato da Roma sulla via del ritorno25
24 Iust XXIX 3 8 quippe terrebat eos et uetus Macedonum deuicti Orientis gloria et Philippus studio Alexandri aemulationis incensus quem promptum in bella industriumque cognouerant Alla gloria dei Macedoni avevamo giagrave trovato riferimento nei discorsi del libro XXVIII degli Etoli (2 12) e di Antigono Dosone (3 14) 25 Secondo Polyb VII 9 17 Filippo avrebbe aiutato Cartagine nella guerra con Roma in cambio di Corcira Epidamno e Apollonia e della restituzione a Demetrio di Faro del suo regno Inoltre Filippo e Annibale si impegnavano a soccorrersi a vicenda in caso di
IL DISCORSO DEL RE 129
A prescindere dai dettagli del fermo dellrsquoambasciatore macedone da parte romana egrave possibile fare qualche osservazione sul nesso tra questo lsquoincidentersquo diplomatico e lo scoppio della guerra Cassio Dione e Ap-piano riportano che la cattura del legato avrebbe causato una vendetta di Filippo contro i protettorati romani in Adriatico in particolare Cor-cira26 notizia assente in Polibio come in Livio e Plutarco (che da Poli-bio dipendono)27 In questi ultimi autori lrsquoattacco di Filippo in Adriati-co infatti non sarebbe legato allrsquoepisodio dellrsquoambasciatore ma alla de-cisione del sovrano di rompere con il consigliere Arato e di dare ascol-to ai cattivi consigli di Demetrio di Faro presa dopo la spedizione a Mes-sene nel 215214 La tradizione polibiana legge infatti in questi eventi la manifestazione del cambiamento dellrsquoindole di Filippo V da giusta a empia iniziata con lrsquoepisodio della stasis di Messene del 215 e compiu-ta con lrsquoassassinio di Arato del 21328 Nel libro XXIX di Giustino ben-cheacute si conservi traccia dellrsquoindole aggressiva di Filippo e del consiglio di Demetrio di Faro come prodromi dello scontro con Roma non vi sono indizi della metaboleacute del sovrano da giusto a empio e malvagio e neppu-re del ruolo che in tale cambiamento ricoprigrave lrsquoallontanamento tra Ara-to e Filippo
attacco da parte di Roma Mentre Peacutedech (1964) pp 382-383 ritiene sicura la consulta-zione a Roma di tali documenti Zecchini (2003) pp 123-141 come prima di lui Walbank (1957) I p 32 n 4 non ne egrave certo poicheacute Polibio viaggiograve proprio per poter reperire documenti e informazioni sugli eventi dove essi avvennero Altre fonti Liv XXIII 38 7 Plut Arat 51 2 Dio C XV 4 2 e App Mak Fr 1 Sul confronto delle fonti vd DrsquoAgostini (2011) pp 99-121 Sul trattato macedone-cartaginese vd Cassola (1962) pp 65-66 Wal-bank (1967) II pp 42-44 Will (19822) pp 83-84 Barreacute (1983) Longaretti (1989) pp 183-192 Golan (1995) pp 45-46 Eckstein (2008) pp 83-85 Intrieri (2011) pp 53-8226 Dio C XV 4 2 e App Mak Fr1 Filippo per vendicarsi della cattura del proprio amba-sciatore non solo attaccograve Corcira ma saputo dellrsquoarrivo di Levino durante la ritirata da Corcira saccheggiograve anche Apollonia e Orico alleate romane Levino avrebbe poi sconfit-to Filippo e recuperati gli alleati costringendo il re a bruciare le proprie navi e rientrare via terra Si riferisce a questo episodio probabilmente il Mak Fr 9 di Appiano che riporta lrsquoordine di Filippo di uccidere quanti erano sulle navi percheacute non dicessero ai Romani che le forze macedoni erano stremate DrsquoAgostini (2011) pp 99-12127 Polyb V 108-110 Liv XXIV 40 e Plut Arat 51 2 non menzionano Corcira nella narra-zione dellrsquoalleanza macedone-cartaginese e della cattura dellrsquoambasciatore Secondo Liv XXIII 38 7 lrsquoambasciatore sarebbe stato trattenuto a Roma 28 Polyb VII 11 8-11 e Plut Arat 49 1 Coppola (1993) pp 205-210 Dai frammenti di Polyb VII 10-12 e dalla narrazione di Plut Arat 49-51 sappiamo che Filippo era interve-nuto nella stasis di Messene tra oligarchici e democratici ma aveva di nascosto lasciato che i cittadini si massacrassero Una volta giunto Arato la guerra civile fu finalmente sedata ma il sovrano avrebbe voluto su consiglio di Demetrio di Faro approfittare della situazione e imporre una guarnigione nellrsquoacropoli della cittagrave che gli avrebbe conferito un vantaggio strategico per il controllo del Peloponneso Arato dissuase Filippo da per-seguire unrsquoazione militare in Peloponneso ma il re decise su consiglio di Demetrio di rivolgere la sua aggressivitagrave verso lrsquoIlliria prima e i protettorati romani Orico e Apollonia poi
130 MONICA DrsquoAGOSTINI
Dopo aver accennato alla stipula del trattato Giustino affastella ne-gli ultimi paragrafi del capitolo 4 gli eventi tra il 215 e il 205 quando Fi-lippo siglando la pace con Roma pone fine alla Prima Guerra Macedo-nica29 In particolare lrsquoEpitomatore sottolinea da un lato lrsquoingresso in guerra degli Etoli al fianco dei Romani e la successiva alleanza del preto-re Levino con Attalo dallrsquoaltro gli attacchi subiti da parte dei Dardani da Filippo oppresso dalle richieste degli Illiri Il libro dunque si chiude con Filippo in difficoltagrave aggravate dalla comparsa di Filopemene il leader degli Achei30 urtatosi con il re dei Macedoni convince la Lega Achea a staccarsi dallrsquoalleanza con la Macedonia sempre piugrave isolata Tale allon-tanamento egrave considerato da Giustino lrsquoesito di un fallito agguato a Fi-lopemene commissionato da Filippo V e dovuto al sospetto di un tradi-mento del condottiero acheo a favore di Roma Bencheacute anche Plutarco (Fil 12 2) e Pausania (VIII 50 4) menzionino il tentativo di assassinio di Filopemene da parte di Filippo la notizia dellrsquoatteggiamento filoroma-no del generale acheo non parrebbe vicino al ritratto polibiano che ve-de in Filopemene un eroe dellrsquoautonomia e dellrsquoindipendenza achea31
Libro XXX11-39 Cinoscefale
Lrsquoesordio del libro XXX introducendo il grande scontro di Cinoscefale tra Romani e Macedoni riprende la celebrazione della gloria macedo-ne argomento centrale dei discorsi del libro XXIX Con lrsquoeccezione dei primi capitoli sul deplorevole comportamento di Tolemeo IV in Egit-to32 il libro egrave infatti totalmente dedicato allo scontro tra le due potenze
29 Errington (2008) pp 185-190 La guerra egrave nota a noi soprattutto dai frammenti dei libri VIII-XI di Polibio dai passi di Liv XXIV 40 1-17 XXVI 24 1-26 4 XXVII 30 5-33 5 e XXVIII 5 1- 9 1 XXIX 12 1-15 e dalla Vita di Filopemene di Plutarco La sinteticitagrave del riassunto giustineo impedisce un puntuale paragone delle tradizioni Ad esempio la notizia dellrsquoalleanza tra Attalo e Roma sembra tornare in Liv XXVIII 5 1-4 dove perograve non troviamo Levino ma Sulpicio come rappresentante romano personaggio scompar-so in Giustino In maniera simile la pace di Fenice del 205 egrave sintetizzata in Giustino in una riga e non vi egrave traccia delle lunghe trattative che coinvolsero come mediatori anche Egitto Chio Mitilene e Atamania portarono a una prima pace separata tra Filippo e gli Etoli nel 206 e poi alla pace con Roma Le fonti parallele sono molto piugrave dettagliate anche su questi eventi Polyb XI 4 1-6 9 Liv XXVIII 5 13 e XXIX 12 8-16 e App Mak fr III Degno di nota egrave perograve il commento in Giustino secondo cui laquoi Romani erano per il momento soddisfatti di aver rinviato la guerra contro la Macedoniaraquo Lrsquointenzione ro-mana di riprendere la guerra con la Macedonia egrave infatti presente in tutte le fonti Polyb XI 6 7 Liv XXIX 1216 Dio C XVIII 9 (15) e App Mak Fr III e verragrave ripresa al libro XXX dellrsquoEpitome 30 Su Filopemene e Filippo vd Errington (1969) pp 51-69 e 83-84 vd anche Golan (1995) pp 115-132 Eckstein (2008) pp 103 e 360-36131 Pelling (1997) pp 135-13932 Lrsquoesordio del libro XXX egrave dedicato alle scabrose imprese del sovrano egiziano ovvero
IL DISCORSO DEL RE 131
dellrsquoEst e dellrsquoOvest La prima avvisaglia dellrsquoincombente guerra egrave la no-tizia dellrsquoaccordo di Filippo V e Antioco III per la spartizione dellrsquoEgitto governato dal sovrano-bambino Tolemeo V Il sovrano lagide nel 2032 chiese aiuto ai Romani che secondo TrogoGiustino gradirono la ri-chiesta drsquoaiuto percheacute cercavano pretesti per muovere guerra contro Fi-lippo A partire da Polibio numerose altre fonti ci testimoniano questo episodio mettendolo in relazione con lo scoppio della Seconda Guerra Macedonica ed esprimendo una condanna morale per lrsquoempia condotta del re antigonide che cospira contro un bambino33 al contrario nellrsquoE-pitome si esalta la potenza macedone evidenziando la paura dei Romani delle grandi imprese di Filippo (XXX 3 2)
nullius magis arma metuebant reputantibus quantum motum Pyrrhus parua Macedo-num manu in Italia fecisset quantasque res Macedones in Oriente gessissent
di nessun altro temevano maggiormente le armi poicheacute ripensavano a quanto sconvolgimento Pirro aveva provocato in Italia con una piccola schiera di Ma-cedoni e a quanto grandi imprese i Macedoni avevano compiuto in Oriente
La supremazia macedone egrave anche al centro del discorso in oratio obliqua di Filippo allrsquoincontro nel Golfo Maliaco tra i rappresentanti dei fronti coinvolti nella Seconda Guerra Macedonica34 NellrsquoEpitome infatti dopo
la Quarta Guerra Siriaca conclusa con sconfitta a Rafia contro Antioco III nel 217 e la corruzione del sovrano da parte di Agatocle e della sorella una cortigiana che avrebbe sedotto il re Giustino riferisce poi la morte del sovrano nel 204 e lrsquoascesa al trono del piccolo Tolemeo V Epifane sovrano sotto tutela di Tlepolemo dopo la morte di Agatocle e Sosibio 33 Eckstein (2008) pp 121-180 Thornton (2014) pp 65-88 In particolare sulla relazione tra il complotto e la sconfitta antigonide e seleucidica ad opera di Roma la superioritagrave morale romana ai regni ellenistici e la causalitagrave storica in Polibio (XV 20 6) vd Eck-stein (2008) pp 133-138 Ager (2009) pp 15-43 Landucci Gattinoni (2011) pp 89-105 Secondo Polyb III 2 8 XV 20 XVI 1 8-9 seguito da Liv XXXI 14 5 Filippo avrebbe ottenuto le basi tolemaiche in Egeo Samo e la Caria mentre Antioco avrebbe finalmente avuto mano libera in Celesiria e Fenicia oggetto di quasi un secolo di lotte tra Tolemei e Seleucidi La notizia del trattato permette a Polibio di dedicare alcuni paragrafi (XV 20) a condannare aspramente lrsquooperato di Filippo V e Antioco III definendoli empi e senza pudore e dichiarando che la Fortuna punigrave i due sovrani per il loro crudele operato por-tando i Romani contro di loro vd infra App Mak Fr IV trasmette delle clausole secondo cui Antioco avrebbe avuto lrsquoEgitto e Cipro mentre Filippo avrebbe ottenuto Cirene le Cicladi e la Ionia Infine secondo Porfirio FGrHist 260 F 45 lrsquoaccordo prevedeva che i due sovrani annettessero i possedimenti tolemaici confinanti con i rispettivi regni 34 Prima si menziona unrsquoambasceria del Senato a Filippo e Antioco percheacute laquosi astenessero dallrsquoEgittoraquo e la visita di Lepido in Egitto Quindi le lamentele a Roma di Attalo e i Rodii nei confronti di Filippo Egrave probabile che a questo punto Trogo inserisse la campagna di Filippo in Asia contro Attalo menzionata nel Prologo XXX ma tagliata nellrsquoEpitome La cronologia degli scambi diplomatici precedenti la Seconda Guerra Macedonica egrave stra-volta dalla sintesi dellrsquoEpitomatore e rende impossibile qualsiasi confronto con le altre
132 MONICA DrsquoAGOSTINI
il riassunto delle ambascerie nel Mediterraneo preludio allo scontro della prima fase della guerra35 maggior spazio egrave dato al tentativo di pa-ce a Nicea tra Roma Attalo i Rodii gli Achei e gli Etoli e Filippo V nel 198 In questa occasione Filippo rivendica la posizione di dominio dei Macedoni sui Greci ereditata da Filippo II e Alessandro suoi antenati e in virtugrave di tale supremazia macedone rifiuta che i Greci gli dettino le condizioni di pace ma chiede che sia il Senato a decidere Egrave significati-vo che non solo il discorso di Filippo non compaia in nessuna delle fon-ti parallele che descrivono nel particolare le posizioni degli ambasciato-ri di Achei Etoli Rodii e Attalo ma che Polibio (XVIII 8 8)36 affermi che era difficile sapere cosa si fossero detti Filippo e Flaminino durante i colloqui nel Golfo Maliaco Secondo la tradizione polibiana infatti il sovrano accompagnato da due philoi macedoni Apollodoro e Demoste-ne chiese di allontanare dalle trattative tutti tranne i Romani e discus-se la pace solamente con Flaminino Successivamente a causa dellrsquoinca-pacitagrave di trovare un accordo Filippo chiese due mesi di tregua e lrsquointer-vento del Senato Trogo dunque restituisce il discorso che il resto della tradizione riteneva impossibile da conoscere indicando chiaramente la presenza di una fonte diversa rispetto a Polibio su questo avvenimento piugrave informata sul punto di vista di Filippo e interessata a evidenziare la convinzione di Filippo V di avere un diritto di supremazia sulla Grecia in virtugrave delle imprese di Filippo II e Alessandro
La battaglia di Cinoscefale nel 197 momento risolutivo dello scontro tra Roma e Macedonia egrave lrsquoevento principale del libro XXX omina e pre-sagi introducono lrsquoevento campale lrsquoeruzione del vulcano di Santorini
fonti In Polyb XVI 24 3 App Mak Fr IV Liv XXXI 1 10 21 5 5 Paus I 36 5-6 vi sono differenti versioni della sequenza delle ambascerie che denunciarono a Roma lrsquoe-spansionismo macedone ma tutte concordano che le ambascerie precedettero lrsquoinvio dei legati romani in Oriente e che esse furono inviate anche da Atene e dagli Etoli Inoltre secondo la tradizione polibiana (Polyb XVI 27 1-4 34 1-7 Liv XXXI 2 3 6 3-8 4 18 1-9 Diod XXVIII 6) vi furono due diverse ambascerie di cui la seconda sarebbe stato un ultimatum al sovrano recapitato da Lepido In occasione di questa seconda ambasceria avvenuta durante il cruento assedio di Abido Filippo avrebbe detto che i Macedoni in ca-so di guerra si sarebbero difesi con valore In Giustino si puograve notare che ancora una volta dagli eventi sono omesse notizie fondamentali sui Greci nello specifico lrsquoambasceria di Atene la cui disputa con gli Acarnani fu il casus belli della guerra contro Filippo 35 Come i prodromi anche la prima parte della Seconda Guerra Macedonica egrave sintetizza-ta in Giustino e occupa solamente due paragrafi Come spesso accade nei passi sintetiz-zati dallrsquoEpitomatore si trovano le incongruenze maggiori con le fonti parallele tra cui si nota soprattutto la completa omissione di Giustino delle campagne di Publio Sulpicio Galba Massimo di Villio delle vittorie di Tito e Lucio Flaminino e dellrsquoassemblea del 198 che portograve gli Achei ad allearsi con Roma Polyb XXII e Liv XXXI 14 1- 46 16 XXXII 1 1-25 12 App Mak Fr VII Plut Fil 17 4 Flam 5 4 e Paus VII 8 1-236 Le trattattive sono descritte con particolari in Polyb XVIII 1-12 seguito da Liv XXXII 32 6-36 10 e Plut Flam 5 8 e 7 1-3
IL DISCORSO DEL RE 133
nel 197 e lrsquoemergere dellrsquoisola di Hiera e in contemporanea il terremo-to a Rodi Quindi nellrsquoEpitome si annuncia che laquoil nascente impero dei Romani avrebbe divorato quello antico dei Greci e dei Macedoni37raquo Nel passo ricevono spazio soprattutto i due discorsi contrapposti del re ma-cedone Filippo e del comandante romano Flaminino pronunciati pri-ma dello scontro campale e costruiti ciascuno in modo da celebrare le imprese delle due potenze38 Lrsquoenfasi data dalla contrapposizione reto-rica delle parole dei generali egrave tale da rendere suggestiva lrsquoipotesi che lo scontro dovesse essere il momento centrale non solo del libro XXX ma forse di tutta lrsquoopera trogiana
Filippo elenca le grandi vittorie del passato dei Macedoni contro Per-siani Battriani Indiani e le popolazioni drsquoAsia fino allrsquoestremo Orien-te esortando i suoi a combattere con valore percheacute laquola libertagrave egrave piugrave cara del predominio39raquo Il discorso di Flaminino egrave invece piugrave lungo articola-to in un paragone tra Macedoni e Romani alle passate imprese di con-quista macedoni vengono contrapposte le piugrave recenti vittorie romane a Cartagine in Sicilia Italia e Spagna alla grandezza di Alessandro Ma-gno egrave contrapposta quella di Annibale che pure dai Romani era stato sconfitto Lrsquoattenzione poi si concentra su Filippo i Macedoni non laquodo-vevano essere valutati per lrsquoantica forza ma per le forze attuali40raquo poicheacute Filippo non era lrsquoinvitto e invincibile Alessandro Magno ma un ragaz-zo che non riusciva a difendere i propri confini I Macedoni rivendica-vano il valore degli antenati mentre i Romani quello dei propri soldati poicheacute quelli che erano ligrave schierati erano gli stessi che avevano sconfitto Annibale Dopo una cosigrave grandiosa introduzione la battaglia egrave descritta in uno dei paragrafi piugrave significativi di tutta lrsquoopera
His adhortationibus utrimque concitati milites proelio concurrunt alteri Orientis alteri Occidentis imperio gloriantes ferentesque in bellum alii maiorum suorum antiquam et ob-soletam gloriam alii uirentem recentibus experimentis uirtutis florem [16] Sed Macedo-nas Romana Fortuna uicit
I soldati incitati da queste esortazioni dallrsquouna e dallrsquoaltra parte si lanciaro-no nel combattimento vantandosi gli uni del dominio dellrsquoOriente gli altri dellrsquoOccidente e recando in guerra gli uni lrsquoantica e sbiadita gloria dei loro an-
37 Iust XXX 4 4 Quo prodigio territis omnibus uates cecinere oriens Romanorum imperium uetus Graecorum ac Macedonum uoraturum38 Sui discorsi precedenti la battaglia nellrsquoantichitagrave se da considerare reali o costruzioni storiografiche vd Adler (2011) pp 6-839 Iust XXX 4 7 tantoque hoc bellum fortius quam illa sustinendum quanto sit imperio libertas carior40 Iust XXX 4 10 Sed nec Macedonas ueteri fama sed praesentibus uiribus aestimandos
134 MONICA DrsquoAGOSTINI
tenati gli altri il fiore del loro valore fresco e vigoroso per le recenti prove Ma la Fortuna dei Romani vinse i Macedoni
Questo punto di vista probabilmente giagrave trogiano contrappone la virtugrave romana (virtutis flos) celebrata nei discorsi antecedenti la battaglia al-la Fortuna romana (Romana Fortuna) che decise la vittoria interpretabi-le come destino favorevole o buona stella Piugrave che unrsquoaffermazione anti-romana41 come egrave spesso stata intesa si puograve evidenziare il carattere sim-patetico della fonte verso Filippo V destinato a porre fine alla gloria di Filippo II e Alessandro e forse un approccio nostalgico verso i grandi regni macedoni la cui egravera egrave ormai giunta alla fine Tale prospettiva egrave as-sente in Polibio e nella tradizione che da lui dipende poco interessata alle vicende della gloria macedone leggendo infatti i frammenti soprav-vissuti del libro XVIII delle Storie dopo lrsquoaccurata descrizione della bat-taglia (18-33 e 34-40)42 Polibio commenta lo scontro affermando che avrebbe dedicato alcuni capitoli allrsquoesame delle strategie militari delle due armate percheacute (XVIII 28 4-6)
χρήσιμον καὶ καλὸν ἂν εἴη τὸ τὴν διαφορὰν ἐρευνῆσαι καὶ παρὰ τί συμβαίνει Ῥωμαίους ἐπικρατεῖν καὶ τὸ πρωτεῖον ἐκφέρεσθαι τῶν κατὰ πόλεμον ἀγώνων [5] ἵνα μὴ τύχην λέγοντες μόνον μακαρίζωμεν τοὺς κρατοῦντας ἀλόγως καθάπερ οἱ μάταιοι τῶν ἀνθρώπων ἀλλ᾽ εἰδότες τὰς ἀληθεῖς αἰτίας ἐπαινῶμεν καὶ θαυμάζωμεν κατὰ λόγον τοὺς ἡγουμένους
Puograve essere cosa buona e utile esaminare le differenze e per quale motivo i Ro-mani prevalgono e riportano il primo premio nelle competizioni di guerra af-fincheacute non esaltiamo i vincitori senza una ragione parlando solo di fortuna co-me fanno gli sciocchi ma conoscendo le vere cause lodiamo e ammiriamo i co-mandanti seguendo una logica
Polibio dunque sembra rispondere a coloro che parlavano della buo-na stella dei Romani sottolineando che la vittoria nasceva dalla superio-re strategia militare della legione43 Un punto di vista quindi opposto a quello espresso nellrsquoEpitome che proprio di Romana Fortuna parla e riba-dito in chiusura al passo dove Polibio critica nuovamente quei Greci che ritenevano la vittoria romana incredibile (XVIII 32 13)
41 Urban (1982) pp 1424-1443 1435 Richter (1987) p 19 n 4 Alonso-Nuacutentildeez (1992) p 66 e Id (2002) pp 105-110 partic 108-109 Contra Heckel (1997) p 29 che ridimen-siona la categorizzazione di Trogo come storico anti-romano 42 Su Cinoscefale vd Walbank (1957) ad l Hammond (1988) pp 60-82 Sklenaacuter (2004) pp 302-310 Thornton (2014) pp 83-87 43 Sulla Fortuna in Polibio vd McGing (2010) pp 195-201 (con bibliografia) che distin-gue tra quando Polibio intenda caso e quando predeterminazione fato Vd anche Green (1990) pp 400-402 e Eckstein (2008) pp 132-138
IL DISCORSO DEL RE 135
Il punto di vista di Trogo sembra invece presente nei frammenti del-la Makedonikeacute di Appiano su Filippo V44 dove ci si riferisce a Cinoscefale come a una vittoria insperata (Mak 9 1)
ἡγούμενος δ᾽ οὔτε Ῥωμαίοις συμφέρειν οὔτε τοῖς Ἕλλησι Φιλίππου καθαιρεθέντος ἐπιπολάσαι τὴν Αἰτωλῶν βίαν τάχα δ᾽ αὐτὸν καὶ τὸ παράδοξον τῆς νίκης ἀγαπᾶν ἐποίει
Flaminino era consapevole che non sarebbe stato vantaggioso per i Romani o per i Greci che Filippo fosse deposto e che il potere etolico rimanesse incon-trastato forse lo aveva reso moderato nei suoi progetti lrsquoaver ottenuto una vit-toria insperata
Addirittura successivamente si accenna alla sorte avversa a Filippo nel-lo scontro
τὰ μὲν δὴ παρὰ τῶν ἄλλων φιλάνθρωπα ἦν τό τε τῆς τύχης ἄδηλον ἐξ ὧν ἔπαθεν ὁ Φίλιππος ὑφορωμένων καὶ τὸ πταῖσμα τοῦτο οὐ κατ᾽ ἀσθένειαν ἀλλὰ πλέον ἐκ συντυχίας αὐτὸν παθεῖν ἡγουμένων
Gli altri (Greci) erano inclini ad essere moderati vedendo con sospetto lrsquoincer-tezza della fortuna subita da Filippo e ritenendo che egli fosse incorso in questa sconfitta non tanto per la sua inferioritagrave quanto per la sfortuna
Il riferimento in Appiano e Trogo alla fortuna romanasfortuna ma-cedone a proposito di Cinoscefale egrave una traccia dellrsquoopinione politi-ca di quei Greci disprezzati da Polibio come uomini sciocchi καθάπερ οἱ μάταιοι τῶν ἀνθρώπων Tale posizione politica su Cinoscefale sarebbe dunque sopravvissuta nella tradizione storiografica di cui troviamo trac-cia in TrogoGiustino e Appiano
Per comprendere meglio alcune caratteristiche di questa tradizione puograve essere utile tornare ai due discorsi nellrsquoEpitome di Filippo e Flamini-no prima della battaglia Tali passi probabilmente trogiani45 non trova-no infatti riscontro nelle fonti parallele a noi pervenute Polibio (XVIII 18-27) seguito fedelmente da Livio (XXXIII 5-10) pur descrivendo le operazioni di guerra di Cinoscefale con dovizia di particolari non men-ziona un discorso di Filippo ai suoi armati prima della battaglia mentre il discorso di Flaminino per incoraggiare le truppe schierate (XVIII 23 2-6) nelle Storie egrave incentrato sulle vittorie di Sulpicio nella prima parte della guerra Pare dunque originale la versione trogiana che incentra-
44 Tra i frammenti consegnatici dagli Excerpta Constantiniana sono frequenti informazio-ni e osservazioni che rimandano a una prospettiva ellenistica sugli eventi DrsquoAgostini (2011) pp 99-121 45 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362
136 MONICA DrsquoAGOSTINI
ta sulla gloria macedone presenta Cinoscefale come il punto drsquoincon-tro e di scambio tra lrsquoegemonia macedone e lrsquoegemonia romana Non egrave una novitagrave che il leitmotiv delle Storie Filippiche e dunque dellrsquoEpitome sia la translatio imperii giagrave Alonso Nuntildeez definito da Santi Amantini laquouno dei piugrave noti esperti di questioni trogiano-giustineeraquo46 osservava che Tro-go esponeva nel suo perduto lavoro la teoria della successione degli im-peri mondiali secondo lo schema Assiria-Media-Persia-Macedonia-Roma osteggiata dai Parti47 In tale successione il ruolo da protagonista egrave rico-perto dallrsquoegemonia macedone48 che occupa allrsquoincirca 26 dei 44 libri e il cui ultimo vero momento di gloria egrave lo scontro con Roma appunto a Cinoscefale Lrsquoultima impresa macedone ha come esito la transizione del dominio universale da Oriente a Occidente e costituisce il tema cen-trale dellrsquointera vicenda di Filippo lrsquoimportanza della battaglia di Cino-scefale egrave perciograve esaltata nei discorsi sia di Filippo che di Flaminino che a loro volta sono il punto di arrivo delle argomentazioni esposte nelle parole di Demetrio di Faro e di Filippo stesso giagrave nel libro XXIX Le ora-tiones disposte retoricamente nei due libri descrivono due parabole op-poste da un lato quella romana che da lontana potenza desiderosa di espandersi cresce come una pioggia di sangue diventando il giovane e vigoroso potere che sottomesso Annibale egrave pronto a sconfiggere Filip-po Dallrsquoaltro quella macedone che originata con Filippo II personag-gio centrale per Trogo raggiunge il suo apice con la conquista dellrsquoege-monia ad opera di Alessandro Magno contro i Persiani per conoscere la fine con Filippo V il cui antico valore egrave ormai troppo lsquosbiaditorsquo per te-ner testa al vigore romano
La gloria macedone secondo Trogo inizia dunque con Filippo II e si conclude con Filippo V Perseo egrave infatti il malvagio responsabile dellrsquoan-nientamento di ciograve che rimaneva della monarchia macedone49 Trogo pone agli estremi della parabola macedone che occupa dal libro IX al XXX i due re di nome Filippo Filippo II e Filippo V come ribadito in piugrave luoghi dellrsquoEpitome sia in parti riassunte da Giustino che in passi piugrave genuinamente trogiani Dando per scontato che il titolo dellrsquoopera Sto-rie Filippiche si debba al desiderio di Trogo di rifarsi allrsquoopera di Teopom-po sul sovrano macedone egrave possibile che tale titolo sia stato perograve ripen-
46 Santi Amantini (2003) pp 99-11047 laquoPompeius Trogus expounded in his lost work the Historiae Philippicae a theory of the world empire suggestion according to the scheme Assyria-Media-Persia-Macedonia-Rome opposed by the Parthiansraquo Alonso-Nuacutentildeez (2002) pp 105-110 e 133-136 partic 105 Vd anche Richter (1987) pp 19-23 Momigliano (1980) pp 157-162 Alonso-Nuacutentildeez (1992) Heckel (1997) pp 1-41 Gabba (2003) pp 7-9 Santi Amantini (2003) pp 99-110 Mariotta (2014) pp 45-56 48 Franco (1993) pp 71-97 e Landucci (2014) pp 233-26149 Alonso-Nuacutentildeez (2002) pp 105-110 partic 108-109
IL DISCORSO DEL RE 137
sato da Trogo considerando che il periodo compreso tra le imprese dei due Filippo occupa 23 dellrsquoopera50 Si potrebbe allora suggerire che le Storie sono Filippiche poicheacute i due Filippo segnarono lrsquoinizio e la fine di quella che egrave nellrsquoopera di Trogo lrsquoegemonia incontrastata del mondo piugrave gloriosa di tutti i tempi51
La prospettiva ellenistica che vede nei due Filippo i limiti della grande egemonia macedone egrave di nuovo presente anche in Appiano nellrsquooraco-lo riportato nei frammenti della sua Makedonikeacute e noto anche da Pausa-nia (VII 8 9)
αὐχοῦντες βασιλεῦσι Μακηδόνες Ἀργεάδῃσιν ὑμῖν κοιρανέων ἀγαθὸν καὶ πῆμα Φίλιππος ἤτοι ὁ μὲν πρότερος πόλεσιν λαοῖσί τ᾽ ἄνακτας θήσει ὁ δ᾽ ὁπλότερος τιμὴν ἀπὸ πᾶσαν ὀλέσσει δμηθεὶς δ᾽ ἑσπερίοισιν ὑπ᾽ ἀνδράσιν ἐνθάδ᾽ ὀλεῖται
O Macedoni che andate orgogliosi dei re di stirpe argiva I re di nome Filippo saranno arbitri del bene e del male per voi Il primo vi renderagrave signori di cittagrave e popoli il secondo vi priveragrave di ogni onore sconfitto da uomini dellrsquoOcciden-te qui giace morto52
Senza voler entrare nel merito della discussione di tale oracolo di nuo-vo pare di incontrare nei due autori la medesima prospettiva lontana dalla condanna morale del re macedone espressa da Polibio secondo cui la sconfitta egrave il giusto esito della sua crudeltagrave ed empietagrave
Il libro giustineo si conclude menzionando le condizioni della pa-ce di Tempe53 e lrsquoira degli Etoli che videro ignorate le proprie richieste da Flaminino e perciograve cercarono lrsquoalleanza di Antioco contro Roma Se-condo il Prologo XXX il libro perograve proseguiva con le campagne di Antio-co III in Asia Minore contro Molone e Acheo e in Battriana fino ad ar-rivare allrsquoesordio dello scontro con Roma54 Il riassunto giustineo egrave trop-po sommario per permettere un confronto con le fonti parallele Egrave pe-
50 Sul rilievo della storia della Macedonia nellrsquoopera di Trogo e Giustino vd von Gutsch-midt (1894) pp 17-217 Richter (1987) p 28 n 29 Franco (1993) pp 71-97 51 Vd anche Urban (1982) pp 1424-1443 e Alonso-Nuacutentildeez (1992) p 58 52 Mak Fr 2 Vd DrsquoAgostini (2011) pp 99-121 In questa Walbank (2002) pp 127-136 propone di interpretare anche un poema di Alceo di Messene (Anth Pal 9518)53 Egrave probabile che Trogo fornisse piugrave particolari riguardo a questa pace per esempio si puograve ritenere che vi fosse menzione dellrsquoinvio a Roma del figlio Demetrio da parte di Filippo come ostaggio dato che a Iust XXXII 2 3 si richiama appunto tale avvenimento54 Polyb XVIII 34 1-39 7 42 1-45 12 Liv XXXIII 11 3-13 15 24 1-31 11 Plut Flam IX 1-8 App Mak Fr IX riferiscono di due diverse trattative di pace caratterizzate da un vivace dibattito tra chi voleva lrsquoannientamento della Macedonia come in Grecia gli Etoli e a Roma Marco Claudio Marcello e coloro che desideravano la pace con la Macedonia in primis Flaminino
138 MONICA DrsquoAGOSTINI
rograve da notare la mancanza sia nel Prologo che nel testo del libro degli av-venimenti delle celebrazioni Istmie del 196 quando Flaminino procla-mograve la libertagrave dei Greci Piugrave in generale in tutta la narrazione di Giustino delle complesse trattative del 197-196 manca qualsiasi riferimento alla li-bertagrave dei Greci punto nodale nella tradizione di Polibio che con questa sottolineatura esalta sia il ruolo tirannico della Macedonia sia la grande generositagrave dei Romani nei confronti della Grecia Il silenzio di TrogoGiustino su tale questione mostra il prevedibile disinteresse per gli affari dei Greci e nel contempo conferma la presenza di una tradizione che si occupa soprattutto della storia delle monarchie ellenistiche allrsquointer-no della quale la posizione dellrsquoEllade egrave subalterna
Libro XXXII23- 34 Demetrio e Perseo
Gli ultimi anni di regno di Filippo tra il 183 e il 179 sono narrati in un passo breve del libro XXXII Il racconto in Giustino che egrave coerente con il Prologo trogiano segue in maniera sintetica la tradizione polibiana su questi eventi giunta a noi in alcuni passi lacunosi di Polibio (XXIII 1 3-3 10 7 1-7 10 1-11 8) integrati dal racconto particolareggiato di Li-vio (XXXIX 46 7- 48 6 53 1-16 XL 3 3-16 3 201-24 8) e dalla narra-zione di Diodoro (XIX 25) e Plutarco (Aem VIII 11)55
Conclusioni
In questi libri dedicati a Filippo egrave forse possibile vedere in filigrana la rielaborazione voluta di Giustino dei corrispondenti libri trogiani Co-me Giustino stesso afferma nella Prefatio 3 lrsquoopera di Trogo era costruita secondo due criteri quello cronologico e quello per laquoconcatenazione di eventi56raquo ea omnia Pompeius diuisa temporibus et serie rerum digesta conposuit
55 Lrsquoutilizzo della tradizione polibiana in Trogo egrave confermato dallrsquoaderenza a Livio (XL 54 1-56 11) e Diodoro (XXIX 28) del racconto sul pentimento di Filippo per aver ucciso il figlio Demetrio lrsquointenzione di punire Perseo e la correlazione tra questo e la sua mor-te Questo libro egrave dunque differente nellrsquointeresse e nelle fonti dai libri XXIX e XXX poicheacute molto vicino alla tradizione polibiana in Livio Questi avvenimenti in Giustino sono da collegare con lrsquoascesa al trono di Perseo e non con lrsquoepilogo della celebrazione del valore macedone giagrave conclusasi in Giustino con Cinoscefale e la transizione dallrsquoim-perium macedone allrsquoimperium romano Vd Heckel (1997) p 7 Appiano invece riporta ancora una tradizione diversa da quella polibiana in un frammento della Makedonikeacute in particolare Appiano egrave attento al punto di vista macedone e presenta Filippo come una vittima delle circostanze (Mak IX) DrsquoAgostini (2011) pp 99-12156 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362 Alonso-Nuacutentildeez (2002) pp 133-136 He-ckel (1997) pp 1-41 Borgna (2014) pp 52-77
IL DISCORSO DEL RE 139
Serie rerum digesta sembrerebbe unrsquointerpretazione latina della formula κατὰ γένος che Diodoro usa per indicare la struttura della storia di Efo-ro sottolineandone la divisione per argomento57 In tale struttura per argomento dellrsquoEpitome tra i temi principali ci sono dunque il valore e la gloria dei sovrani ellenistici58 riscontrabile nei libri XXVIII-XXXI sui re-gni di Antigono Dosone Filippo V e Antioco III Tale tema presente di sicuro in Trogo egrave conservato nellrsquoazione dellrsquoEpitomatore e anzi come si vede dagli escerpta esaltato dalla selezione dei passi
Per quanto riguarda invece la Quellenforschung 59 egrave evidente che nel testo vi sia presenza di filoni non tradizionali sugli eventi poicheacute la posi-zione di Trogo appare spesso autonoma rispetto alle opinioni condivise dalla storiografia antica Questo aspetto dellrsquoEpitome evidente soprattut-to per ciograve che riguarda gli eventi ellenistici ha suscitato la grande curio-sitagrave degli studiosi che allontanatisi dalla proposta di von Gutschmid che voleva una totale ed esclusiva dipendenza di Trogo da Timagene ora in-dicano con sicurezza tra le fonti piugrave rilevanti per gli eventi ellenistici di III secolo utilizzate da Trogo almeno altri sei nomi oltre a Timagene Ie-ronimo Timeo Filarco Duride Polibio e Posidonio
Per quanto riguarda nello specifico la composizione dei libri XXIX e XXX non vi egrave alcun dubbio che in essi Trogo abbia utilizzato (anche riadattandola) una fonte poco attenta alle questioni di politica interna greca e al legame tra queste e quel ritratto di Filippo come sovrano mal-vagio ed empio che ritorna nella tradizione ufficiale di origine polibia-na passando poi da Polibio in Livio Diodoro e Plutarco60 Trogo pre-serva invece una tradizione ellenistica interessata alla figura di Filippo come ultimo barlume della gloria macedone tradizione che pare quasi una controparte e un completamento dellrsquoAb urbe condita romanocentri-ca di Livio Non si puograve perciograve a mio avviso escludere che per questa se-zione Trogo abbia usato una tradizione di matrice filoellenistica o sem-plicemente ellenisticocentrica unrsquoopera sui regni di diadochi ed epigo-ni che a tutti noi fa venire facilmente alla mente il Basileis o Perigrave Basileon dello storico grecoellenistico augusteo filobarbaro scettico (o critico) verso lrsquoegemonia romana Timagene di Alessandria (FGrHist 88)61
57 Su Eforo vd Vannicelli (1987) pp 165-191 e ora Parmeggiani (2011) 58 Simile legame vi egrave a mio avviso tra i libri XXVI e XXVII che invece affrontavano la crisi delle monarchie ellenistiche causata dalle guerre fraterne59 Vd von Gutschmid (1894) pp 17-217 Richter (1987) pp 17-30 partic 20-23 San-ti Amantini (1972) pp 56-109 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362 Urban (1982) pp 1424-1443 partic 1435 Mecca (2001) pp 199-222 Santi Amantini (2003) pp 99-110 Heckel (2012) pp 3-860 Scuderi (2005) pp 383-40561 Sordi (1982) pp 775-797 Heckel (1997) pp 30-34 Landucci (2014) pp 233-261 e Ead in questo volume
140 MONICA DrsquoAGOSTINI
ABSTRACT
Philip V of Macedon was the first of the Epigonoi to face Rome Several mod-ern reconstructions of the actions and the reign of Philip V have approached it largely from a Roman point of view using as sources Polybius and where Poly-bius is lost Livy The Polybian historiographical tradition tends to portray Phil-ip V as an enemy and a tyrant impious and cruel The Macedonian king was ea-ger to establish a universal and unjust dominion over Greece Italy and beyond and Rome engaged in the first two Macedonian Wars to fight the threat of his growing ambition Nevertheless Polybiusrsquo portrayal of Philip V was affected not only by Polybiusrsquo admiration for Roman political structures military power and overwhelming conquest but also his personal Achaean origins
Looking at in book 29 and 30 of Justinrsquos Epitome of Pompeius Trogus this pa-per focuses on the non Polybian tradition on Philip V this contribution is in-deed the first analysis of the Hellenistic approach to the clash between Rome and Macedonia in the 3rd-2nd Century BC The Epitome shows a considerable di-versity of interpretation from the other sources and reflects very different views of Philip Vrsquos actions that brought him into conflict against Rome In particular these views are more evident related to the accounts of the peace negotiations of Naupactus and the battle of Cynoscephalae in the Epitome the king appears as a courageous and skilled warrior the last of the great Macedonian rulers who fell victim to misfortune This portrayal which has several common features with Appianrsquos fragments of Philip V (Mak 9) counterbalances the Roman and Achaean standpoint present in Polybius providing a more Hellenistic perspec-tive that is likely to have been rooted in a historiographical tradition connect-ed to the losing side in the struggle between Rome and the Hellenistic world
BIBLIOGRAFIA
Adler E (2006) Whorsquos Antiroman Sallust and Pompeius Trogus on Mithridates CJ 101 pp 383-407
Adler E (2011) Valorizing the Barbarians Enemy speeches in Roman Historiography Austin
Ager SL (2003) An Uneasy Balance from the Death of Seleukos to the Battle of Raph-ia in A Erskine (ed) A Companion to the Hellenistic World Oxford pp 35-50
Ager SL (2009) Roman Perspectives on Greek Diplomacy The conceptual clash Greek diplomacy of compromise and Roman Bellum Iustum in C Eilers (ed) Diplomats and Diplomacy in the Roman World Leiden-Boston pp 15-43
Alonso-Nuacutentildeez JM (1992) La Historia Universal de Pompeyo Trogo Madrid
Alonso-Nuacutentildeez JM (2002) The Idea of Universal History in Greece From Herodotus to the Age of Augustus Amsterdam
Ballesteros Pastor L (2013) Pompeyo Trogo Justino y Mitriacutedates Comentario al Epiacutetome de las Historias Filiacutepicas (3716-3881) Hildesheim-Zuumlrich-New York
IL DISCORSO DEL RE 141
Barreacute ML (1983) The God-List in the Treaty between Hannibal and Philip V of Ma-cedon a Study in Light of the Ancient Near Eastern Treaty Tradition Baltimore-Lon-don
Beck H - Eckstein A (2015) sv ldquoAratos of Sicyon (231)rdquo in I Worthington (ed) Brillrsquos New Jacoby Brill Online
Borgna A (2014) Uno sguardo originale intorno a Roma Pompeo Trogo e Giustino laquoLa Biblioteca di ClassicoContemporaneoraquo 1 pp 52-77
Cassola F (1962) I gruppi politici romani nel III secolo aC Trieste
Champion CB (1997) The Nature of Authoritative Evidence in Polybios and Agelausrsquo Speech at Naupactos TAPhA 127 pp 111-128
Champion CB (2004) Cultural Politics in Polybiusrsquo Histories Berkeley
Coppola A (1993) Demetrio di Faro un protagonista dimenticato Roma
Criscuolo L (2011) I due testamenti di Tolemeo VIII Evergete II in A Joumlrdens - J F Quack (hrsg) Aumlgypten zwischen innerem Zwist und aumluszligerem Druck Die Zeit Ptole-maios VI bis VIII Wiesbaden pp 132-150
DrsquoAgostini M (2011) Filippo V e la Storia Romana di Appiano laquoAevumraquo 85 pp 99-121
Eckstein AM (1995) Moral vision in the Histories of Polybius Berkeley
Eckstein AM (2008) Rome enters in the Greek East From Anarchy to Hierarchy in the Hellenistic Mediterranean 230-217 BC Oxford
Eckstein AM (2013) Polybius Phylarchus and Historiographical Criticism CPh 108 4 pp 314-338
Errington RM (1969) Philopoemen Oxford
Errington RM (2008) A History of the Hellenistic World 323-30 BC Malden MA-Oxford
Forni G - Angeli Bertinelli MG (1982) Pompeo Trogo come fonte di storia ANRW II 30 2 pp 1298-1362
Franco C (1993) Trogo Giustino e i successori di Alessandro in L Braccesi - A Coppola - G Cresci Marrone - C Franco (a cura di) LrsquoAlessandro di Giustino dagli antichi ai moderni Roma pp 71-97
Gabba E (2003) Introduzione in D Foraboschi - SM Pizzetti (a cura di) La successione degli imperi e delle egemonie nelle relazioni internazionali Milano pp 7-9
Golan D (1995) The Res Graeciae in Polybius Four Studies Como
Green P (1990) Alexander to Actium The Historical Evolution of the Hellenistic Age Berkeley-Los Angeles
Gutschmid von A (1894) Die beiden ersten Buumlcher des Pompeius Trogus in A von Gutschmid - F Ruumlhl (hrsg) Kleine Schriften Leipzig pp 17-217
142 MONICA DrsquoAGOSTINI
Habicht C (1995) Athen Muumlnchen
Hammond NGL (1968) Illyris Rome and Macedon in 229-205 BC JRS 58 pp 1-21
Hammond NGL (1988) The Campaign and the Battle of Cynoscephalae in 197 BC JHS 108 pp 60-82
Heckel W (1997) Introduction (Part 2) in JC Yardley - W Heckel (eds) Ju-stin Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus Books 11-12 Alexander the Great Introduction Oxford pp 1-41
Heckel W (2012) Introduction in JC Yardley - P Wheatley - W Heckel (eds) Justin Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus II Books 13-15 The Successors to Alexander the Great Oxford pp 1-8
Huss W (1976) Untersuchungen zur Auszligenpolitik Ptolemaiosrsquo IV Muumlnchen
Huss W (2001) Aumlgypten in hellenistischer Zeit 332ndash30 v Chr Muumlnchen
Intrieri M (2011) Fra dialogo e conflitto Annibale e i Greci drsquoOccidente RStudFen 37 pp 53-82
Landucci F (2014) Filippo II e le Storie Filippiche un protagonista storico e storio-grafico in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 233-261
Landucci Gattinoni F (2011) Politica e ideologia in etagrave ellenistica laquoPolitica An-ticaraquo 1 pp 89-105
Leacutevy E (1994) Le discours drsquoAgeacutelaos de Naupacte in L Aigner Foresti - A Bar-zanograve - C Bearzot - L Prandi - G Zecchini (a cura di) Federazioni e federalismo nellrsquoEuropa antica Bergamo 21-25 settembre 1992 Milano (Alle radici della casa co-mune europea 1) pp 33-50
Longaretti L (1989) Lrsquoalleanza tra Annibale e Filippo V di Macedonia RIL 123 pp 183-192
Marasco G (1979-1980) La valutazione di Tolemeo IV Filopatore nella storiografia greca laquoSilenoraquo 5-6 pp 159-182
Mari M [- Musti D - Thornton J] (2002) Polibio Storie Volume III Libri V-VI Milano
Mariotta G (2014) Geografia e Geopolitica nelle Storie Filippiche in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 45-56
McGing B (2010) Polybiusrsquo Histories New York
McGing B (2013) Youthfulness in Polybius the case of Philip V of Macedon in B Gibson - T Harrison (eds) Polybius and his world Oxford pp 181-199
Meadows A (2013) Polybius Aratus and the History of the 140th Olympiad in B
IL DISCORSO DEL RE 143
Gibson - T Harrison (eds) Polybius and his World Essays in Honour of Frank Walbank Oxford pp 91-116
Mecca A (2001) Trogo Timagene e Polieno QS 54 pp 199-222
Meister K (1990) Die Griechische Geschichtsschreibung von den Anfaumlngen bis zum Ende des Hellenismus Stuttgart
Misch G (1949) Geschichte der Autobiographie I Frankfurt am Mein
Momigliano A (1980) Daniele e la teoria greca della successione degli imperi RAL 35 pp 157-162
Muccioli F (2013) Gli epiteti ufficiali dei re ellenistici Stuttgart (Historia Einzel-schriften 224)
Musti D (1978) Polibio e lrsquoimperialismo romano Napoli
Parmeggiani G (2011) Eforo di Cuma studi di storiografia greca Bologna
Peacutedech P (1964) La meacutethode historique de Polybe Paris
Pelling CBR [- Scardigli B - Manfredini M](1997) Plutarco Vite parallele Filopemene Tito Flaminino Milano
Richter H-D (1987) Untersuchungen zur hellenistischen Historiographie die Vorla-gen des Pompeius Trogus fuumlr die Darstellung der nachalexandrischen hellenistischen Ge-schichte (Iust 13-40) Frankfurt
Santi Amantini L (1972) Fonti e valore storico di Pompeo Trogo (Iustin XXXV e XXXVI) Genova
Santi Amantini L (1981) (a cura di) Giustino Storie Filippiche Epitome da Pom-peo Trogo Milano
Santi Amantini L (2003) Il tempo e i tempi nelle Storie Filippiche di Pompeo Tro-go RSA 33 pp 99-110
Schepens G (1983) Les rois ptolegravemaiumlques et lrsquohistoriographie Reacuteflexions sur la trans-formation de lrsquohistoire politique in E vanrsquot Dack - P van Dessel - W Van Gucht (eds) Egypt and the Hellenistic World Proceedings of the International Collo-quium Leuven 24-26 May 1982 Leuven (Studia Hellenistica 27) pp 351-368
Schlicher JJ (1933) Non-Assertive Elements in the Language of the Roman Histo-rians CPh 28 289-300
Schmitt T (1989) Die Bedeutung des zweiten Punischen Krieges fuumlr den Frieden in Naupaktos in H Devijver - E Lipinski (eds) Punic wars Proceedings of the Conference held in Antwerp from the 23th to the 26th of November 1988 in Cooperation with the Departement of History of the laquoUniversitait Antwerpenraquo UFSIA Leuven (Studia Phoenicia 10) pp 229-239
Scholten JB (2000) The Politics of Plunder Aitolians and their koinon in the early Hellenistic Era Berkeley
144 MONICA DrsquoAGOSTINI
Scuderi R (2005) Filippo V e Perseo nei frammenti diodorei in C Bearzot - F Lan-ducci (a cura di) Diodoro e lrsquoaltra Grecia Macedonia Occidente Ellenismo nella Bi-blioteca Storica Atti del convegno Milano 15-16 gennaio 2004 Milano pp 383-405
Sklenaacuter RJ (2004) Sources and Individuality in Two Passages of Livy laquoHistoriaraquo 53 pp 302-310
Sordi M (1982) Timagene di Alessandria Uno storico ellenocentrico e filobarbaro ANRW II 30 1 pp 775-797
Thornton J (2014) Le guerre macedoniche Roma
Urban R (1979) Wachstum und Kriese des achaumlischen Bundes Quellenstudien zur entwicklung des Bundes von 280 bis 222 V Chr Wiesbaden
Urban R (1982) laquoGallisches Bewusstseinraquo und laquoRomkritikraquo bei Pompeius Trogus ANRW II 30 2 pp 1424-1443
Vannicelli P (1987) Lrsquoeconomia delle Storie di Eforo RFIC 115 pp 165-191
Vattuone R (2014) Giustino e lrsquoOccidente greco I VI-V secolo aC in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 261-277
Vollmer D (1990) Symploke das Uumlbergreifen der roumlmischen Expansion auf den grie-chischen Osten Untersuchungen zur roumlmischen Aussenpolitik am Ende des 3 Jh V Chr Stuttgart
Walbank FW (1957) A Historical Commentary on Polibius I Oxford
Walbank FW (1967) A Historical Commentary on Polybius II Oxford
Walbank FW (1933) Aratos of Sicyon Cambridge
Walbank FW (2002) Η ΤΩΝ ΟΛΩΝ ΕΛΠΙΣ and the Antigonids in FW Walbank (ed) Polybius Rome and the Hellenistic World Essays and Reflections West Nyack NY pp 127-136
Weber G (1997) Interaktion Repraumlsentation und Herrschaft Der Koumlnigshof im Hel-lenismus in A Winterling (hrsg) Zwischen lsquoHausrsquo und lsquoStaatrsquo antike Houmlfe im Ver-gleich Munich pp 27-72
Will E (19822) Histoire politique du Monde Helleacutenistique II Nancy
Zecchini G (1990) La storiografia lagide in H Verdin - G Schepens - E De Keyser (eds) Purposes of History Studies in Greek Historiography from the 4th to the 2nd Centuries BC Proceedings of the International Colloquium of Leuven 24-26 May 1988 Leuven (Studia Hellenistica 30) pp 213-232
Zecchini G (2003) Polibio e la tradizione orale in A Casanova - P Desideri (a cura di) Evento racconto scrittura nellrsquoantichitagrave classica Firenze pp 123-141
Finito di stamparenel mese di novembre 2015
da LegoDigit srlLavis (TN)
126 MONICA DrsquoAGOSTINI
va infatti cacciare i Romani dalla sponda adriatica dellrsquoIlliria territorio che avrebbe ceduto a Filippo
Il discorso di Demetrio a Filippo egrave presente anche in Polibio (V 101 8-1017) ed egrave inserito cronologicamente durante i giochi Nemei18 nel 217 subito dopo la sconfitta romana del lago Trasimeno ricordata an-che nel passo di Giustino Nel discorso polibiano Demetrio perograve sotto-linea il diritto di Filippo V ad aspirare al dominio universale a partire dallrsquoAdriatico19 mentre nel discorso trogiano Demetrio accusa i Roma-ni di aspirare ad espandersi travolgendo qualsiasi regno sul loro cammi-no Trogo nel discorso di Demetrio presenta il coinvolgimento roma-no in Oriente come una guerra di conquista che contrappone la giova-ne potenza romana allrsquolsquoillustre regnorsquo di Filippo20 prospettiva che ritor-na nel successivo discorso di Filippo V nellrsquoEpitome ma che egrave estranea al-la narrazione di Polibio
Dopo il discorso di Demetrio nellrsquoEpitome come in Polibio (V 104 1) si arriva allrsquoincontro di pace di Naupatto nel 217 che pose fine al-la Guerra degli Alleati tra Etoli Spartani ed Elei contro la lega Achea e
bellum inlatum quasi nefas esset aliquem regem iuxta imperii eorum terminos esse Sed et ipsi cauen-dum esse exemplum cuius quanto promptius nobiliusque sit regnum tanto sit Romanos acriores hostes habiturus17 Polyb V 101 8-10 ὃς καὶ λαβόμενος τῆς ἀφορμῆς ταύτης τὸν μὲν πρὸς τοὺς Αἰτωλοὺς ᾤετο δεῖν τὴν ταχίστην ἀπορρῖψαι πόλεμον ἀντέχεσθαι δὲ τῶν κατὰ τὴν Ἰλλυρίδα πραγμάτων ἠξίου καὶ τῆς εἰς Ἰταλίαν διαβάσεως [9] τὰ μὲν γὰρ κατὰ τὴν Ἑλλάδα πάντα καὶ νῦν ἤδη ποιεῖν αὐτῷ τὸ προσταττόμενον ἔφη καὶ μετὰ ταῦτα ποιήσειν Ἀχαιῶν μὲν ἐθελοντὴν εὐνοούντων Αἰτωλῶν δὲ καταπεπληγμένων ἐκ τῶν συμβεβηκότων αὐτοῖς κατὰ τὸν ἐνεστῶτα πόλεμον [10] τὴν δ᾽ Ἰταλίαν ἔφη καὶ τὴν ἐκεῖ διάβασιν ἀρχὴν εἶναι τῆς ὑπὲρ τῶν ὅλων ἐπιβολῆς ἣν οὐδενὶ καθήκειν μᾶλλον ἢ ᾽κείνῳ τὸν δὲ καιρὸν εἶναι νῦν ἐπταικότων Ῥωμαίων Trad da Mari (2002) laquoCostui allora cogliendo lrsquooccasione gli consigliograve di interrompere al piugrave presto la guerra con gli Etoli e gli chiese di impegnarsi nelle operazioni in Illiria e nellrsquoattraversamento del mare verso lrsquoItalia Disse che infatti giagrave ora tutta la Grecia eseguiva i suoi ordini e lo avrebbe fatto anche in seguito poicheacute gli Achei lo sostenevano di loro iniziativa mentre gli Etoli erano rimasti molto colpiti da quanto era loro avvenuto nella guerra in corso e aggiunse che lrsquoItalia e lrsquoattraversamento del mare in quella direzione erano lrsquoinizio di un disegno di dominio universale che a nessuno spettava piugrave che a lui ora era il momento opportu-no visto che i Romani erano stati battutiraquo18 I giochi Nemei in onore di Zeus erano giochi panellenici celebrati in Argolide negli anni pari delle Olimpiadi 19 Secondo Eckstein (1995) pp 211-212 tale aspirazione egrave connessa allrsquoincapacitagrave di mo-derazione nella vittoria del sovrano Sul concetto di dominio universale in Polibio vd Musti (1978) pp 16-18 Eckstein (2008) pp 217-220 e 372-38120 Adler (2006) pp 383-407 e (2011) pp 37-58 ha notato che i punti principali del discorso di critica allrsquoespansionismo romano di Demetrio ritornano in altri due discorsi dellrsquoEpitome quello degli Etoli (XXVIII 2 1-13) e quello di Mitridate (XXXVIII 4-7) la prioritagrave data a questi argomenti da tale reiterazione retorica indica che lrsquointeresse giagrave di Trogo se non dellae suae fontei non fosse la celebrazione dellrsquoascesa di Roma allrsquoim-pero universale come in Appiano ma piuttosto lrsquoascesa e la discesa dei regni ellenistici
IL DISCORSO DEL RE 127
Filippo V 21 Il testo giustineo omette le circostanze dellrsquoevento non si menzionano infatti esplicitamente neacute il luogo dellrsquoincontro Naupatto neacute le fasi delle trattative neacute i vari rappresentanti dei diversi fronti che vi presero parte I lunghi negoziati di pace si risolvono dunque nel discor-so di Filippo V ai rappresentanti dei fronti
Il sovrano esordisce affermando che la Grecia egrave in grande pericolo percheacute chiunque avesse vinto tra Cartaginesi e Romani sarebbe poi pas-sato in Oriente Filippo utilizza la metafora delle nubi in Occidente che avrebbero macchiato con una pioggia di sangue ogni cosa spinte dai venti di vittoria inoltre il sovrano ritiene che le guerre passate dei Gre-ci siano di poco conto se paragonate alla minaccia di uno scontro con la moltitudine che si radunava in Italia descrivendo la rabbia e il valore di questi nuovi nemici che avrebbero portato rovina ai vicini Il sovrano infine ribadisce che la Grecia era in maggior pericolo della Macedonia ma che sapeva che chi avesse vinto in Italia non avrebbe frenato la sete di vittoria Perciograve anche la Macedonia stessa doveva temere un attacco
Il discorso in Polibio di Agelao di Naupatto rappresentante e leader degli Etoli22 mostra le medesime argomentazioni attribuite in Giustino allrsquointervento di Filippo argomentazioni fondate sul metus hostilis e fina-lizzate a promuovere un nuovo ruolo della Macedonia sia in Grecia che nel Mediterraneo Orientale Agelao proponendo un nuovo program-ma politico panellenico fonda le proprie argomentazioni sul metus hosti-lis per i Cartaginesi e i Romani presentati metaforicamente come nubi che incombono da Occidente Filippo dovrebbe farsi garante della tran-quillitagrave della Grecia che agendo come unrsquounica catena di cittagrave contro i barbari diverrebbe una sicura e fedele collaboratrice della Macedonia Questo permetterebbe ai Greci di conservare il diritto di far pace o guer-ra a loro piacimento senza temere che laquoi giochi da bambini con i quali ci trastulliamo tutti vengano troncati23raquo
Nonostante sia il medesimo discorso nelle due fonti Agelao introdu-ce una forte proposta di alleanza panellenica estranea alle parole di Fi-lippo Inoltre Filippo pur utilizzando la metafora delle nubi da Occi-
21 Interessanti le osservazioni di Scholten (2000) pp 224-228 a proposito della pace che sarebbe stata cercata e sperata da entrambe le parti e non imposta da Filippo come Polibio pare lasciar intendere 22 Vd soprattutto Leacutevy (1994) pp 33-50 Su questo discorso molto dibattuto dai moderni vd anche Schmitt (1989) pp 229-239 Vollmer (1990) pp 96-107 Coppola (1993) pp 149-164 Golan (1995) pp 55-74 Champion (1997) pp 111-128 e (2004) p 55 Wal-bank (2002) pp 127-136 Eckstein (2008) pp 78-83 23 Polyb V 104 10-11 καθόλου τὰς παιδιάς ἃς νῦν παίζομεν πρὸς ἀλλήλους ἐκκοπῆναι συμβῇ πάντων ἡμῶν ἐπὶ τοσοῦτον ὥστε κἂν εὔξασθαι τοῖς θεοῖς ὑπάρχειν ἡμῖν τὴν ἐξουσίαν ταύτην καὶ πολεμεῖν ὅταν βουλώμεθα καὶ διαλύεσθαι πρὸς ἀλλήλους καὶ καθόλου κυρίους εἶναι τῶν ἐν αὑτοῖς ἀμφισβητουμένων
128 MONICA DrsquoAGOSTINI
dente presente anche nelle Storie la arricchisce con la vivida immagine di una tempesta di sangue conferendo una dimensione piugrave concreta e cruenta alla predizione infine il riferimento polibiano alle guerre dei Greci nellrsquoEpitome non riguarda piugrave le guerre tra le cittagrave e le leghe gre-che ma le guerre dei Greci con Macedoni Persiani e Galli Mentre la Grecia scompare sullo sfondo la minaccia Romana egrave meno vaga e piugrave concreta e presente che in Polibio e diventa lrsquounico argomento del di-scorso di Filippo V a Naupatto
Il discorso di Demetrio e quello di Filippo sono al centro del libro XXIX dellrsquoEpitome avendo il duplice scopo di evidenziare sia la poten-ziale aggressivitagrave dei Romani sia la grande tradizione militare della Ma-cedonia e il pieno diritto di Filippo di controllare la Grecia e lrsquoIlliria fi-no allrsquoAdriatico Se il discorso in Polibio si inseriva in un dibattito politi-co dove la Grecia e la Macedonia erano protagoniste alla pari della sce-na ellenica e internazionale nella versione che leggiamo in Trogo i ri-ferimenti alle dispute della realtagrave greca sono reinterpretati a favore di un punto di vista in cui la Macedonia egrave lrsquounico potere dellrsquoOriente gre-co Del dibattito politico di III secolo in Grecia che tanto stava a cuore a Polibio non vi egrave piugrave alcuna traccia in TrogoGiustino rimane soltanto lo scontro tra le due grandi potenze di Oriente e Occidente tra Filippo e Roma Questa prospettiva bipolare dei discorsi trogiani si ritrova nel-la conclusione del capitolo che se da un lato sottolinea ancora una vol-ta il timore di Filippo per Cartaginesi e Romani dallrsquoaltro esplicita che i Romani avevano paura dellrsquoantica gloria dei Macedoni laquovincitori dellrsquoO-rienteraquo e soprattutto di Filippo laquoinfiammato dallo zelo di emulare Ales-sandro che era ben noto come pronto alle guerre e instancabileraquo24
41-11 La Prima Guerra Macedonica
Dei prodromi della Prima Guerra Macedonica Giustino si interessa sol-tanto allrsquoalleanza antiromana tra Annibale e Filippo Questo trattato egrave noto da molte fonti secondo cui Filippo dopo aver appreso che i Roma-ni erano stati sconfitti di nuovo dai Cartaginesi a Canne nel 216 avreb-be mandato unrsquoambasceria ad Annibale per proporre unrsquoalleanza ma lrsquoambasciatore macedone sarebbe stato catturato da Roma sulla via del ritorno25
24 Iust XXIX 3 8 quippe terrebat eos et uetus Macedonum deuicti Orientis gloria et Philippus studio Alexandri aemulationis incensus quem promptum in bella industriumque cognouerant Alla gloria dei Macedoni avevamo giagrave trovato riferimento nei discorsi del libro XXVIII degli Etoli (2 12) e di Antigono Dosone (3 14) 25 Secondo Polyb VII 9 17 Filippo avrebbe aiutato Cartagine nella guerra con Roma in cambio di Corcira Epidamno e Apollonia e della restituzione a Demetrio di Faro del suo regno Inoltre Filippo e Annibale si impegnavano a soccorrersi a vicenda in caso di
IL DISCORSO DEL RE 129
A prescindere dai dettagli del fermo dellrsquoambasciatore macedone da parte romana egrave possibile fare qualche osservazione sul nesso tra questo lsquoincidentersquo diplomatico e lo scoppio della guerra Cassio Dione e Ap-piano riportano che la cattura del legato avrebbe causato una vendetta di Filippo contro i protettorati romani in Adriatico in particolare Cor-cira26 notizia assente in Polibio come in Livio e Plutarco (che da Poli-bio dipendono)27 In questi ultimi autori lrsquoattacco di Filippo in Adriati-co infatti non sarebbe legato allrsquoepisodio dellrsquoambasciatore ma alla de-cisione del sovrano di rompere con il consigliere Arato e di dare ascol-to ai cattivi consigli di Demetrio di Faro presa dopo la spedizione a Mes-sene nel 215214 La tradizione polibiana legge infatti in questi eventi la manifestazione del cambiamento dellrsquoindole di Filippo V da giusta a empia iniziata con lrsquoepisodio della stasis di Messene del 215 e compiu-ta con lrsquoassassinio di Arato del 21328 Nel libro XXIX di Giustino ben-cheacute si conservi traccia dellrsquoindole aggressiva di Filippo e del consiglio di Demetrio di Faro come prodromi dello scontro con Roma non vi sono indizi della metaboleacute del sovrano da giusto a empio e malvagio e neppu-re del ruolo che in tale cambiamento ricoprigrave lrsquoallontanamento tra Ara-to e Filippo
attacco da parte di Roma Mentre Peacutedech (1964) pp 382-383 ritiene sicura la consulta-zione a Roma di tali documenti Zecchini (2003) pp 123-141 come prima di lui Walbank (1957) I p 32 n 4 non ne egrave certo poicheacute Polibio viaggiograve proprio per poter reperire documenti e informazioni sugli eventi dove essi avvennero Altre fonti Liv XXIII 38 7 Plut Arat 51 2 Dio C XV 4 2 e App Mak Fr 1 Sul confronto delle fonti vd DrsquoAgostini (2011) pp 99-121 Sul trattato macedone-cartaginese vd Cassola (1962) pp 65-66 Wal-bank (1967) II pp 42-44 Will (19822) pp 83-84 Barreacute (1983) Longaretti (1989) pp 183-192 Golan (1995) pp 45-46 Eckstein (2008) pp 83-85 Intrieri (2011) pp 53-8226 Dio C XV 4 2 e App Mak Fr1 Filippo per vendicarsi della cattura del proprio amba-sciatore non solo attaccograve Corcira ma saputo dellrsquoarrivo di Levino durante la ritirata da Corcira saccheggiograve anche Apollonia e Orico alleate romane Levino avrebbe poi sconfit-to Filippo e recuperati gli alleati costringendo il re a bruciare le proprie navi e rientrare via terra Si riferisce a questo episodio probabilmente il Mak Fr 9 di Appiano che riporta lrsquoordine di Filippo di uccidere quanti erano sulle navi percheacute non dicessero ai Romani che le forze macedoni erano stremate DrsquoAgostini (2011) pp 99-12127 Polyb V 108-110 Liv XXIV 40 e Plut Arat 51 2 non menzionano Corcira nella narra-zione dellrsquoalleanza macedone-cartaginese e della cattura dellrsquoambasciatore Secondo Liv XXIII 38 7 lrsquoambasciatore sarebbe stato trattenuto a Roma 28 Polyb VII 11 8-11 e Plut Arat 49 1 Coppola (1993) pp 205-210 Dai frammenti di Polyb VII 10-12 e dalla narrazione di Plut Arat 49-51 sappiamo che Filippo era interve-nuto nella stasis di Messene tra oligarchici e democratici ma aveva di nascosto lasciato che i cittadini si massacrassero Una volta giunto Arato la guerra civile fu finalmente sedata ma il sovrano avrebbe voluto su consiglio di Demetrio di Faro approfittare della situazione e imporre una guarnigione nellrsquoacropoli della cittagrave che gli avrebbe conferito un vantaggio strategico per il controllo del Peloponneso Arato dissuase Filippo da per-seguire unrsquoazione militare in Peloponneso ma il re decise su consiglio di Demetrio di rivolgere la sua aggressivitagrave verso lrsquoIlliria prima e i protettorati romani Orico e Apollonia poi
130 MONICA DrsquoAGOSTINI
Dopo aver accennato alla stipula del trattato Giustino affastella ne-gli ultimi paragrafi del capitolo 4 gli eventi tra il 215 e il 205 quando Fi-lippo siglando la pace con Roma pone fine alla Prima Guerra Macedo-nica29 In particolare lrsquoEpitomatore sottolinea da un lato lrsquoingresso in guerra degli Etoli al fianco dei Romani e la successiva alleanza del preto-re Levino con Attalo dallrsquoaltro gli attacchi subiti da parte dei Dardani da Filippo oppresso dalle richieste degli Illiri Il libro dunque si chiude con Filippo in difficoltagrave aggravate dalla comparsa di Filopemene il leader degli Achei30 urtatosi con il re dei Macedoni convince la Lega Achea a staccarsi dallrsquoalleanza con la Macedonia sempre piugrave isolata Tale allon-tanamento egrave considerato da Giustino lrsquoesito di un fallito agguato a Fi-lopemene commissionato da Filippo V e dovuto al sospetto di un tradi-mento del condottiero acheo a favore di Roma Bencheacute anche Plutarco (Fil 12 2) e Pausania (VIII 50 4) menzionino il tentativo di assassinio di Filopemene da parte di Filippo la notizia dellrsquoatteggiamento filoroma-no del generale acheo non parrebbe vicino al ritratto polibiano che ve-de in Filopemene un eroe dellrsquoautonomia e dellrsquoindipendenza achea31
Libro XXX11-39 Cinoscefale
Lrsquoesordio del libro XXX introducendo il grande scontro di Cinoscefale tra Romani e Macedoni riprende la celebrazione della gloria macedo-ne argomento centrale dei discorsi del libro XXIX Con lrsquoeccezione dei primi capitoli sul deplorevole comportamento di Tolemeo IV in Egit-to32 il libro egrave infatti totalmente dedicato allo scontro tra le due potenze
29 Errington (2008) pp 185-190 La guerra egrave nota a noi soprattutto dai frammenti dei libri VIII-XI di Polibio dai passi di Liv XXIV 40 1-17 XXVI 24 1-26 4 XXVII 30 5-33 5 e XXVIII 5 1- 9 1 XXIX 12 1-15 e dalla Vita di Filopemene di Plutarco La sinteticitagrave del riassunto giustineo impedisce un puntuale paragone delle tradizioni Ad esempio la notizia dellrsquoalleanza tra Attalo e Roma sembra tornare in Liv XXVIII 5 1-4 dove perograve non troviamo Levino ma Sulpicio come rappresentante romano personaggio scompar-so in Giustino In maniera simile la pace di Fenice del 205 egrave sintetizzata in Giustino in una riga e non vi egrave traccia delle lunghe trattative che coinvolsero come mediatori anche Egitto Chio Mitilene e Atamania portarono a una prima pace separata tra Filippo e gli Etoli nel 206 e poi alla pace con Roma Le fonti parallele sono molto piugrave dettagliate anche su questi eventi Polyb XI 4 1-6 9 Liv XXVIII 5 13 e XXIX 12 8-16 e App Mak fr III Degno di nota egrave perograve il commento in Giustino secondo cui laquoi Romani erano per il momento soddisfatti di aver rinviato la guerra contro la Macedoniaraquo Lrsquointenzione ro-mana di riprendere la guerra con la Macedonia egrave infatti presente in tutte le fonti Polyb XI 6 7 Liv XXIX 1216 Dio C XVIII 9 (15) e App Mak Fr III e verragrave ripresa al libro XXX dellrsquoEpitome 30 Su Filopemene e Filippo vd Errington (1969) pp 51-69 e 83-84 vd anche Golan (1995) pp 115-132 Eckstein (2008) pp 103 e 360-36131 Pelling (1997) pp 135-13932 Lrsquoesordio del libro XXX egrave dedicato alle scabrose imprese del sovrano egiziano ovvero
IL DISCORSO DEL RE 131
dellrsquoEst e dellrsquoOvest La prima avvisaglia dellrsquoincombente guerra egrave la no-tizia dellrsquoaccordo di Filippo V e Antioco III per la spartizione dellrsquoEgitto governato dal sovrano-bambino Tolemeo V Il sovrano lagide nel 2032 chiese aiuto ai Romani che secondo TrogoGiustino gradirono la ri-chiesta drsquoaiuto percheacute cercavano pretesti per muovere guerra contro Fi-lippo A partire da Polibio numerose altre fonti ci testimoniano questo episodio mettendolo in relazione con lo scoppio della Seconda Guerra Macedonica ed esprimendo una condanna morale per lrsquoempia condotta del re antigonide che cospira contro un bambino33 al contrario nellrsquoE-pitome si esalta la potenza macedone evidenziando la paura dei Romani delle grandi imprese di Filippo (XXX 3 2)
nullius magis arma metuebant reputantibus quantum motum Pyrrhus parua Macedo-num manu in Italia fecisset quantasque res Macedones in Oriente gessissent
di nessun altro temevano maggiormente le armi poicheacute ripensavano a quanto sconvolgimento Pirro aveva provocato in Italia con una piccola schiera di Ma-cedoni e a quanto grandi imprese i Macedoni avevano compiuto in Oriente
La supremazia macedone egrave anche al centro del discorso in oratio obliqua di Filippo allrsquoincontro nel Golfo Maliaco tra i rappresentanti dei fronti coinvolti nella Seconda Guerra Macedonica34 NellrsquoEpitome infatti dopo
la Quarta Guerra Siriaca conclusa con sconfitta a Rafia contro Antioco III nel 217 e la corruzione del sovrano da parte di Agatocle e della sorella una cortigiana che avrebbe sedotto il re Giustino riferisce poi la morte del sovrano nel 204 e lrsquoascesa al trono del piccolo Tolemeo V Epifane sovrano sotto tutela di Tlepolemo dopo la morte di Agatocle e Sosibio 33 Eckstein (2008) pp 121-180 Thornton (2014) pp 65-88 In particolare sulla relazione tra il complotto e la sconfitta antigonide e seleucidica ad opera di Roma la superioritagrave morale romana ai regni ellenistici e la causalitagrave storica in Polibio (XV 20 6) vd Eck-stein (2008) pp 133-138 Ager (2009) pp 15-43 Landucci Gattinoni (2011) pp 89-105 Secondo Polyb III 2 8 XV 20 XVI 1 8-9 seguito da Liv XXXI 14 5 Filippo avrebbe ottenuto le basi tolemaiche in Egeo Samo e la Caria mentre Antioco avrebbe finalmente avuto mano libera in Celesiria e Fenicia oggetto di quasi un secolo di lotte tra Tolemei e Seleucidi La notizia del trattato permette a Polibio di dedicare alcuni paragrafi (XV 20) a condannare aspramente lrsquooperato di Filippo V e Antioco III definendoli empi e senza pudore e dichiarando che la Fortuna punigrave i due sovrani per il loro crudele operato por-tando i Romani contro di loro vd infra App Mak Fr IV trasmette delle clausole secondo cui Antioco avrebbe avuto lrsquoEgitto e Cipro mentre Filippo avrebbe ottenuto Cirene le Cicladi e la Ionia Infine secondo Porfirio FGrHist 260 F 45 lrsquoaccordo prevedeva che i due sovrani annettessero i possedimenti tolemaici confinanti con i rispettivi regni 34 Prima si menziona unrsquoambasceria del Senato a Filippo e Antioco percheacute laquosi astenessero dallrsquoEgittoraquo e la visita di Lepido in Egitto Quindi le lamentele a Roma di Attalo e i Rodii nei confronti di Filippo Egrave probabile che a questo punto Trogo inserisse la campagna di Filippo in Asia contro Attalo menzionata nel Prologo XXX ma tagliata nellrsquoEpitome La cronologia degli scambi diplomatici precedenti la Seconda Guerra Macedonica egrave stra-volta dalla sintesi dellrsquoEpitomatore e rende impossibile qualsiasi confronto con le altre
132 MONICA DrsquoAGOSTINI
il riassunto delle ambascerie nel Mediterraneo preludio allo scontro della prima fase della guerra35 maggior spazio egrave dato al tentativo di pa-ce a Nicea tra Roma Attalo i Rodii gli Achei e gli Etoli e Filippo V nel 198 In questa occasione Filippo rivendica la posizione di dominio dei Macedoni sui Greci ereditata da Filippo II e Alessandro suoi antenati e in virtugrave di tale supremazia macedone rifiuta che i Greci gli dettino le condizioni di pace ma chiede che sia il Senato a decidere Egrave significati-vo che non solo il discorso di Filippo non compaia in nessuna delle fon-ti parallele che descrivono nel particolare le posizioni degli ambasciato-ri di Achei Etoli Rodii e Attalo ma che Polibio (XVIII 8 8)36 affermi che era difficile sapere cosa si fossero detti Filippo e Flaminino durante i colloqui nel Golfo Maliaco Secondo la tradizione polibiana infatti il sovrano accompagnato da due philoi macedoni Apollodoro e Demoste-ne chiese di allontanare dalle trattative tutti tranne i Romani e discus-se la pace solamente con Flaminino Successivamente a causa dellrsquoinca-pacitagrave di trovare un accordo Filippo chiese due mesi di tregua e lrsquointer-vento del Senato Trogo dunque restituisce il discorso che il resto della tradizione riteneva impossibile da conoscere indicando chiaramente la presenza di una fonte diversa rispetto a Polibio su questo avvenimento piugrave informata sul punto di vista di Filippo e interessata a evidenziare la convinzione di Filippo V di avere un diritto di supremazia sulla Grecia in virtugrave delle imprese di Filippo II e Alessandro
La battaglia di Cinoscefale nel 197 momento risolutivo dello scontro tra Roma e Macedonia egrave lrsquoevento principale del libro XXX omina e pre-sagi introducono lrsquoevento campale lrsquoeruzione del vulcano di Santorini
fonti In Polyb XVI 24 3 App Mak Fr IV Liv XXXI 1 10 21 5 5 Paus I 36 5-6 vi sono differenti versioni della sequenza delle ambascerie che denunciarono a Roma lrsquoe-spansionismo macedone ma tutte concordano che le ambascerie precedettero lrsquoinvio dei legati romani in Oriente e che esse furono inviate anche da Atene e dagli Etoli Inoltre secondo la tradizione polibiana (Polyb XVI 27 1-4 34 1-7 Liv XXXI 2 3 6 3-8 4 18 1-9 Diod XXVIII 6) vi furono due diverse ambascerie di cui la seconda sarebbe stato un ultimatum al sovrano recapitato da Lepido In occasione di questa seconda ambasceria avvenuta durante il cruento assedio di Abido Filippo avrebbe detto che i Macedoni in ca-so di guerra si sarebbero difesi con valore In Giustino si puograve notare che ancora una volta dagli eventi sono omesse notizie fondamentali sui Greci nello specifico lrsquoambasceria di Atene la cui disputa con gli Acarnani fu il casus belli della guerra contro Filippo 35 Come i prodromi anche la prima parte della Seconda Guerra Macedonica egrave sintetizza-ta in Giustino e occupa solamente due paragrafi Come spesso accade nei passi sintetiz-zati dallrsquoEpitomatore si trovano le incongruenze maggiori con le fonti parallele tra cui si nota soprattutto la completa omissione di Giustino delle campagne di Publio Sulpicio Galba Massimo di Villio delle vittorie di Tito e Lucio Flaminino e dellrsquoassemblea del 198 che portograve gli Achei ad allearsi con Roma Polyb XXII e Liv XXXI 14 1- 46 16 XXXII 1 1-25 12 App Mak Fr VII Plut Fil 17 4 Flam 5 4 e Paus VII 8 1-236 Le trattattive sono descritte con particolari in Polyb XVIII 1-12 seguito da Liv XXXII 32 6-36 10 e Plut Flam 5 8 e 7 1-3
IL DISCORSO DEL RE 133
nel 197 e lrsquoemergere dellrsquoisola di Hiera e in contemporanea il terremo-to a Rodi Quindi nellrsquoEpitome si annuncia che laquoil nascente impero dei Romani avrebbe divorato quello antico dei Greci e dei Macedoni37raquo Nel passo ricevono spazio soprattutto i due discorsi contrapposti del re ma-cedone Filippo e del comandante romano Flaminino pronunciati pri-ma dello scontro campale e costruiti ciascuno in modo da celebrare le imprese delle due potenze38 Lrsquoenfasi data dalla contrapposizione reto-rica delle parole dei generali egrave tale da rendere suggestiva lrsquoipotesi che lo scontro dovesse essere il momento centrale non solo del libro XXX ma forse di tutta lrsquoopera trogiana
Filippo elenca le grandi vittorie del passato dei Macedoni contro Per-siani Battriani Indiani e le popolazioni drsquoAsia fino allrsquoestremo Orien-te esortando i suoi a combattere con valore percheacute laquola libertagrave egrave piugrave cara del predominio39raquo Il discorso di Flaminino egrave invece piugrave lungo articola-to in un paragone tra Macedoni e Romani alle passate imprese di con-quista macedoni vengono contrapposte le piugrave recenti vittorie romane a Cartagine in Sicilia Italia e Spagna alla grandezza di Alessandro Ma-gno egrave contrapposta quella di Annibale che pure dai Romani era stato sconfitto Lrsquoattenzione poi si concentra su Filippo i Macedoni non laquodo-vevano essere valutati per lrsquoantica forza ma per le forze attuali40raquo poicheacute Filippo non era lrsquoinvitto e invincibile Alessandro Magno ma un ragaz-zo che non riusciva a difendere i propri confini I Macedoni rivendica-vano il valore degli antenati mentre i Romani quello dei propri soldati poicheacute quelli che erano ligrave schierati erano gli stessi che avevano sconfitto Annibale Dopo una cosigrave grandiosa introduzione la battaglia egrave descritta in uno dei paragrafi piugrave significativi di tutta lrsquoopera
His adhortationibus utrimque concitati milites proelio concurrunt alteri Orientis alteri Occidentis imperio gloriantes ferentesque in bellum alii maiorum suorum antiquam et ob-soletam gloriam alii uirentem recentibus experimentis uirtutis florem [16] Sed Macedo-nas Romana Fortuna uicit
I soldati incitati da queste esortazioni dallrsquouna e dallrsquoaltra parte si lanciaro-no nel combattimento vantandosi gli uni del dominio dellrsquoOriente gli altri dellrsquoOccidente e recando in guerra gli uni lrsquoantica e sbiadita gloria dei loro an-
37 Iust XXX 4 4 Quo prodigio territis omnibus uates cecinere oriens Romanorum imperium uetus Graecorum ac Macedonum uoraturum38 Sui discorsi precedenti la battaglia nellrsquoantichitagrave se da considerare reali o costruzioni storiografiche vd Adler (2011) pp 6-839 Iust XXX 4 7 tantoque hoc bellum fortius quam illa sustinendum quanto sit imperio libertas carior40 Iust XXX 4 10 Sed nec Macedonas ueteri fama sed praesentibus uiribus aestimandos
134 MONICA DrsquoAGOSTINI
tenati gli altri il fiore del loro valore fresco e vigoroso per le recenti prove Ma la Fortuna dei Romani vinse i Macedoni
Questo punto di vista probabilmente giagrave trogiano contrappone la virtugrave romana (virtutis flos) celebrata nei discorsi antecedenti la battaglia al-la Fortuna romana (Romana Fortuna) che decise la vittoria interpretabi-le come destino favorevole o buona stella Piugrave che unrsquoaffermazione anti-romana41 come egrave spesso stata intesa si puograve evidenziare il carattere sim-patetico della fonte verso Filippo V destinato a porre fine alla gloria di Filippo II e Alessandro e forse un approccio nostalgico verso i grandi regni macedoni la cui egravera egrave ormai giunta alla fine Tale prospettiva egrave as-sente in Polibio e nella tradizione che da lui dipende poco interessata alle vicende della gloria macedone leggendo infatti i frammenti soprav-vissuti del libro XVIII delle Storie dopo lrsquoaccurata descrizione della bat-taglia (18-33 e 34-40)42 Polibio commenta lo scontro affermando che avrebbe dedicato alcuni capitoli allrsquoesame delle strategie militari delle due armate percheacute (XVIII 28 4-6)
χρήσιμον καὶ καλὸν ἂν εἴη τὸ τὴν διαφορὰν ἐρευνῆσαι καὶ παρὰ τί συμβαίνει Ῥωμαίους ἐπικρατεῖν καὶ τὸ πρωτεῖον ἐκφέρεσθαι τῶν κατὰ πόλεμον ἀγώνων [5] ἵνα μὴ τύχην λέγοντες μόνον μακαρίζωμεν τοὺς κρατοῦντας ἀλόγως καθάπερ οἱ μάταιοι τῶν ἀνθρώπων ἀλλ᾽ εἰδότες τὰς ἀληθεῖς αἰτίας ἐπαινῶμεν καὶ θαυμάζωμεν κατὰ λόγον τοὺς ἡγουμένους
Puograve essere cosa buona e utile esaminare le differenze e per quale motivo i Ro-mani prevalgono e riportano il primo premio nelle competizioni di guerra af-fincheacute non esaltiamo i vincitori senza una ragione parlando solo di fortuna co-me fanno gli sciocchi ma conoscendo le vere cause lodiamo e ammiriamo i co-mandanti seguendo una logica
Polibio dunque sembra rispondere a coloro che parlavano della buo-na stella dei Romani sottolineando che la vittoria nasceva dalla superio-re strategia militare della legione43 Un punto di vista quindi opposto a quello espresso nellrsquoEpitome che proprio di Romana Fortuna parla e riba-dito in chiusura al passo dove Polibio critica nuovamente quei Greci che ritenevano la vittoria romana incredibile (XVIII 32 13)
41 Urban (1982) pp 1424-1443 1435 Richter (1987) p 19 n 4 Alonso-Nuacutentildeez (1992) p 66 e Id (2002) pp 105-110 partic 108-109 Contra Heckel (1997) p 29 che ridimen-siona la categorizzazione di Trogo come storico anti-romano 42 Su Cinoscefale vd Walbank (1957) ad l Hammond (1988) pp 60-82 Sklenaacuter (2004) pp 302-310 Thornton (2014) pp 83-87 43 Sulla Fortuna in Polibio vd McGing (2010) pp 195-201 (con bibliografia) che distin-gue tra quando Polibio intenda caso e quando predeterminazione fato Vd anche Green (1990) pp 400-402 e Eckstein (2008) pp 132-138
IL DISCORSO DEL RE 135
Il punto di vista di Trogo sembra invece presente nei frammenti del-la Makedonikeacute di Appiano su Filippo V44 dove ci si riferisce a Cinoscefale come a una vittoria insperata (Mak 9 1)
ἡγούμενος δ᾽ οὔτε Ῥωμαίοις συμφέρειν οὔτε τοῖς Ἕλλησι Φιλίππου καθαιρεθέντος ἐπιπολάσαι τὴν Αἰτωλῶν βίαν τάχα δ᾽ αὐτὸν καὶ τὸ παράδοξον τῆς νίκης ἀγαπᾶν ἐποίει
Flaminino era consapevole che non sarebbe stato vantaggioso per i Romani o per i Greci che Filippo fosse deposto e che il potere etolico rimanesse incon-trastato forse lo aveva reso moderato nei suoi progetti lrsquoaver ottenuto una vit-toria insperata
Addirittura successivamente si accenna alla sorte avversa a Filippo nel-lo scontro
τὰ μὲν δὴ παρὰ τῶν ἄλλων φιλάνθρωπα ἦν τό τε τῆς τύχης ἄδηλον ἐξ ὧν ἔπαθεν ὁ Φίλιππος ὑφορωμένων καὶ τὸ πταῖσμα τοῦτο οὐ κατ᾽ ἀσθένειαν ἀλλὰ πλέον ἐκ συντυχίας αὐτὸν παθεῖν ἡγουμένων
Gli altri (Greci) erano inclini ad essere moderati vedendo con sospetto lrsquoincer-tezza della fortuna subita da Filippo e ritenendo che egli fosse incorso in questa sconfitta non tanto per la sua inferioritagrave quanto per la sfortuna
Il riferimento in Appiano e Trogo alla fortuna romanasfortuna ma-cedone a proposito di Cinoscefale egrave una traccia dellrsquoopinione politi-ca di quei Greci disprezzati da Polibio come uomini sciocchi καθάπερ οἱ μάταιοι τῶν ἀνθρώπων Tale posizione politica su Cinoscefale sarebbe dunque sopravvissuta nella tradizione storiografica di cui troviamo trac-cia in TrogoGiustino e Appiano
Per comprendere meglio alcune caratteristiche di questa tradizione puograve essere utile tornare ai due discorsi nellrsquoEpitome di Filippo e Flamini-no prima della battaglia Tali passi probabilmente trogiani45 non trova-no infatti riscontro nelle fonti parallele a noi pervenute Polibio (XVIII 18-27) seguito fedelmente da Livio (XXXIII 5-10) pur descrivendo le operazioni di guerra di Cinoscefale con dovizia di particolari non men-ziona un discorso di Filippo ai suoi armati prima della battaglia mentre il discorso di Flaminino per incoraggiare le truppe schierate (XVIII 23 2-6) nelle Storie egrave incentrato sulle vittorie di Sulpicio nella prima parte della guerra Pare dunque originale la versione trogiana che incentra-
44 Tra i frammenti consegnatici dagli Excerpta Constantiniana sono frequenti informazio-ni e osservazioni che rimandano a una prospettiva ellenistica sugli eventi DrsquoAgostini (2011) pp 99-121 45 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362
136 MONICA DrsquoAGOSTINI
ta sulla gloria macedone presenta Cinoscefale come il punto drsquoincon-tro e di scambio tra lrsquoegemonia macedone e lrsquoegemonia romana Non egrave una novitagrave che il leitmotiv delle Storie Filippiche e dunque dellrsquoEpitome sia la translatio imperii giagrave Alonso Nuntildeez definito da Santi Amantini laquouno dei piugrave noti esperti di questioni trogiano-giustineeraquo46 osservava che Tro-go esponeva nel suo perduto lavoro la teoria della successione degli im-peri mondiali secondo lo schema Assiria-Media-Persia-Macedonia-Roma osteggiata dai Parti47 In tale successione il ruolo da protagonista egrave rico-perto dallrsquoegemonia macedone48 che occupa allrsquoincirca 26 dei 44 libri e il cui ultimo vero momento di gloria egrave lo scontro con Roma appunto a Cinoscefale Lrsquoultima impresa macedone ha come esito la transizione del dominio universale da Oriente a Occidente e costituisce il tema cen-trale dellrsquointera vicenda di Filippo lrsquoimportanza della battaglia di Cino-scefale egrave perciograve esaltata nei discorsi sia di Filippo che di Flaminino che a loro volta sono il punto di arrivo delle argomentazioni esposte nelle parole di Demetrio di Faro e di Filippo stesso giagrave nel libro XXIX Le ora-tiones disposte retoricamente nei due libri descrivono due parabole op-poste da un lato quella romana che da lontana potenza desiderosa di espandersi cresce come una pioggia di sangue diventando il giovane e vigoroso potere che sottomesso Annibale egrave pronto a sconfiggere Filip-po Dallrsquoaltro quella macedone che originata con Filippo II personag-gio centrale per Trogo raggiunge il suo apice con la conquista dellrsquoege-monia ad opera di Alessandro Magno contro i Persiani per conoscere la fine con Filippo V il cui antico valore egrave ormai troppo lsquosbiaditorsquo per te-ner testa al vigore romano
La gloria macedone secondo Trogo inizia dunque con Filippo II e si conclude con Filippo V Perseo egrave infatti il malvagio responsabile dellrsquoan-nientamento di ciograve che rimaneva della monarchia macedone49 Trogo pone agli estremi della parabola macedone che occupa dal libro IX al XXX i due re di nome Filippo Filippo II e Filippo V come ribadito in piugrave luoghi dellrsquoEpitome sia in parti riassunte da Giustino che in passi piugrave genuinamente trogiani Dando per scontato che il titolo dellrsquoopera Sto-rie Filippiche si debba al desiderio di Trogo di rifarsi allrsquoopera di Teopom-po sul sovrano macedone egrave possibile che tale titolo sia stato perograve ripen-
46 Santi Amantini (2003) pp 99-11047 laquoPompeius Trogus expounded in his lost work the Historiae Philippicae a theory of the world empire suggestion according to the scheme Assyria-Media-Persia-Macedonia-Rome opposed by the Parthiansraquo Alonso-Nuacutentildeez (2002) pp 105-110 e 133-136 partic 105 Vd anche Richter (1987) pp 19-23 Momigliano (1980) pp 157-162 Alonso-Nuacutentildeez (1992) Heckel (1997) pp 1-41 Gabba (2003) pp 7-9 Santi Amantini (2003) pp 99-110 Mariotta (2014) pp 45-56 48 Franco (1993) pp 71-97 e Landucci (2014) pp 233-26149 Alonso-Nuacutentildeez (2002) pp 105-110 partic 108-109
IL DISCORSO DEL RE 137
sato da Trogo considerando che il periodo compreso tra le imprese dei due Filippo occupa 23 dellrsquoopera50 Si potrebbe allora suggerire che le Storie sono Filippiche poicheacute i due Filippo segnarono lrsquoinizio e la fine di quella che egrave nellrsquoopera di Trogo lrsquoegemonia incontrastata del mondo piugrave gloriosa di tutti i tempi51
La prospettiva ellenistica che vede nei due Filippo i limiti della grande egemonia macedone egrave di nuovo presente anche in Appiano nellrsquooraco-lo riportato nei frammenti della sua Makedonikeacute e noto anche da Pausa-nia (VII 8 9)
αὐχοῦντες βασιλεῦσι Μακηδόνες Ἀργεάδῃσιν ὑμῖν κοιρανέων ἀγαθὸν καὶ πῆμα Φίλιππος ἤτοι ὁ μὲν πρότερος πόλεσιν λαοῖσί τ᾽ ἄνακτας θήσει ὁ δ᾽ ὁπλότερος τιμὴν ἀπὸ πᾶσαν ὀλέσσει δμηθεὶς δ᾽ ἑσπερίοισιν ὑπ᾽ ἀνδράσιν ἐνθάδ᾽ ὀλεῖται
O Macedoni che andate orgogliosi dei re di stirpe argiva I re di nome Filippo saranno arbitri del bene e del male per voi Il primo vi renderagrave signori di cittagrave e popoli il secondo vi priveragrave di ogni onore sconfitto da uomini dellrsquoOcciden-te qui giace morto52
Senza voler entrare nel merito della discussione di tale oracolo di nuo-vo pare di incontrare nei due autori la medesima prospettiva lontana dalla condanna morale del re macedone espressa da Polibio secondo cui la sconfitta egrave il giusto esito della sua crudeltagrave ed empietagrave
Il libro giustineo si conclude menzionando le condizioni della pa-ce di Tempe53 e lrsquoira degli Etoli che videro ignorate le proprie richieste da Flaminino e perciograve cercarono lrsquoalleanza di Antioco contro Roma Se-condo il Prologo XXX il libro perograve proseguiva con le campagne di Antio-co III in Asia Minore contro Molone e Acheo e in Battriana fino ad ar-rivare allrsquoesordio dello scontro con Roma54 Il riassunto giustineo egrave trop-po sommario per permettere un confronto con le fonti parallele Egrave pe-
50 Sul rilievo della storia della Macedonia nellrsquoopera di Trogo e Giustino vd von Gutsch-midt (1894) pp 17-217 Richter (1987) p 28 n 29 Franco (1993) pp 71-97 51 Vd anche Urban (1982) pp 1424-1443 e Alonso-Nuacutentildeez (1992) p 58 52 Mak Fr 2 Vd DrsquoAgostini (2011) pp 99-121 In questa Walbank (2002) pp 127-136 propone di interpretare anche un poema di Alceo di Messene (Anth Pal 9518)53 Egrave probabile che Trogo fornisse piugrave particolari riguardo a questa pace per esempio si puograve ritenere che vi fosse menzione dellrsquoinvio a Roma del figlio Demetrio da parte di Filippo come ostaggio dato che a Iust XXXII 2 3 si richiama appunto tale avvenimento54 Polyb XVIII 34 1-39 7 42 1-45 12 Liv XXXIII 11 3-13 15 24 1-31 11 Plut Flam IX 1-8 App Mak Fr IX riferiscono di due diverse trattative di pace caratterizzate da un vivace dibattito tra chi voleva lrsquoannientamento della Macedonia come in Grecia gli Etoli e a Roma Marco Claudio Marcello e coloro che desideravano la pace con la Macedonia in primis Flaminino
138 MONICA DrsquoAGOSTINI
rograve da notare la mancanza sia nel Prologo che nel testo del libro degli av-venimenti delle celebrazioni Istmie del 196 quando Flaminino procla-mograve la libertagrave dei Greci Piugrave in generale in tutta la narrazione di Giustino delle complesse trattative del 197-196 manca qualsiasi riferimento alla li-bertagrave dei Greci punto nodale nella tradizione di Polibio che con questa sottolineatura esalta sia il ruolo tirannico della Macedonia sia la grande generositagrave dei Romani nei confronti della Grecia Il silenzio di TrogoGiustino su tale questione mostra il prevedibile disinteresse per gli affari dei Greci e nel contempo conferma la presenza di una tradizione che si occupa soprattutto della storia delle monarchie ellenistiche allrsquointer-no della quale la posizione dellrsquoEllade egrave subalterna
Libro XXXII23- 34 Demetrio e Perseo
Gli ultimi anni di regno di Filippo tra il 183 e il 179 sono narrati in un passo breve del libro XXXII Il racconto in Giustino che egrave coerente con il Prologo trogiano segue in maniera sintetica la tradizione polibiana su questi eventi giunta a noi in alcuni passi lacunosi di Polibio (XXIII 1 3-3 10 7 1-7 10 1-11 8) integrati dal racconto particolareggiato di Li-vio (XXXIX 46 7- 48 6 53 1-16 XL 3 3-16 3 201-24 8) e dalla narra-zione di Diodoro (XIX 25) e Plutarco (Aem VIII 11)55
Conclusioni
In questi libri dedicati a Filippo egrave forse possibile vedere in filigrana la rielaborazione voluta di Giustino dei corrispondenti libri trogiani Co-me Giustino stesso afferma nella Prefatio 3 lrsquoopera di Trogo era costruita secondo due criteri quello cronologico e quello per laquoconcatenazione di eventi56raquo ea omnia Pompeius diuisa temporibus et serie rerum digesta conposuit
55 Lrsquoutilizzo della tradizione polibiana in Trogo egrave confermato dallrsquoaderenza a Livio (XL 54 1-56 11) e Diodoro (XXIX 28) del racconto sul pentimento di Filippo per aver ucciso il figlio Demetrio lrsquointenzione di punire Perseo e la correlazione tra questo e la sua mor-te Questo libro egrave dunque differente nellrsquointeresse e nelle fonti dai libri XXIX e XXX poicheacute molto vicino alla tradizione polibiana in Livio Questi avvenimenti in Giustino sono da collegare con lrsquoascesa al trono di Perseo e non con lrsquoepilogo della celebrazione del valore macedone giagrave conclusasi in Giustino con Cinoscefale e la transizione dallrsquoim-perium macedone allrsquoimperium romano Vd Heckel (1997) p 7 Appiano invece riporta ancora una tradizione diversa da quella polibiana in un frammento della Makedonikeacute in particolare Appiano egrave attento al punto di vista macedone e presenta Filippo come una vittima delle circostanze (Mak IX) DrsquoAgostini (2011) pp 99-12156 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362 Alonso-Nuacutentildeez (2002) pp 133-136 He-ckel (1997) pp 1-41 Borgna (2014) pp 52-77
IL DISCORSO DEL RE 139
Serie rerum digesta sembrerebbe unrsquointerpretazione latina della formula κατὰ γένος che Diodoro usa per indicare la struttura della storia di Efo-ro sottolineandone la divisione per argomento57 In tale struttura per argomento dellrsquoEpitome tra i temi principali ci sono dunque il valore e la gloria dei sovrani ellenistici58 riscontrabile nei libri XXVIII-XXXI sui re-gni di Antigono Dosone Filippo V e Antioco III Tale tema presente di sicuro in Trogo egrave conservato nellrsquoazione dellrsquoEpitomatore e anzi come si vede dagli escerpta esaltato dalla selezione dei passi
Per quanto riguarda invece la Quellenforschung 59 egrave evidente che nel testo vi sia presenza di filoni non tradizionali sugli eventi poicheacute la posi-zione di Trogo appare spesso autonoma rispetto alle opinioni condivise dalla storiografia antica Questo aspetto dellrsquoEpitome evidente soprattut-to per ciograve che riguarda gli eventi ellenistici ha suscitato la grande curio-sitagrave degli studiosi che allontanatisi dalla proposta di von Gutschmid che voleva una totale ed esclusiva dipendenza di Trogo da Timagene ora in-dicano con sicurezza tra le fonti piugrave rilevanti per gli eventi ellenistici di III secolo utilizzate da Trogo almeno altri sei nomi oltre a Timagene Ie-ronimo Timeo Filarco Duride Polibio e Posidonio
Per quanto riguarda nello specifico la composizione dei libri XXIX e XXX non vi egrave alcun dubbio che in essi Trogo abbia utilizzato (anche riadattandola) una fonte poco attenta alle questioni di politica interna greca e al legame tra queste e quel ritratto di Filippo come sovrano mal-vagio ed empio che ritorna nella tradizione ufficiale di origine polibia-na passando poi da Polibio in Livio Diodoro e Plutarco60 Trogo pre-serva invece una tradizione ellenistica interessata alla figura di Filippo come ultimo barlume della gloria macedone tradizione che pare quasi una controparte e un completamento dellrsquoAb urbe condita romanocentri-ca di Livio Non si puograve perciograve a mio avviso escludere che per questa se-zione Trogo abbia usato una tradizione di matrice filoellenistica o sem-plicemente ellenisticocentrica unrsquoopera sui regni di diadochi ed epigo-ni che a tutti noi fa venire facilmente alla mente il Basileis o Perigrave Basileon dello storico grecoellenistico augusteo filobarbaro scettico (o critico) verso lrsquoegemonia romana Timagene di Alessandria (FGrHist 88)61
57 Su Eforo vd Vannicelli (1987) pp 165-191 e ora Parmeggiani (2011) 58 Simile legame vi egrave a mio avviso tra i libri XXVI e XXVII che invece affrontavano la crisi delle monarchie ellenistiche causata dalle guerre fraterne59 Vd von Gutschmid (1894) pp 17-217 Richter (1987) pp 17-30 partic 20-23 San-ti Amantini (1972) pp 56-109 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362 Urban (1982) pp 1424-1443 partic 1435 Mecca (2001) pp 199-222 Santi Amantini (2003) pp 99-110 Heckel (2012) pp 3-860 Scuderi (2005) pp 383-40561 Sordi (1982) pp 775-797 Heckel (1997) pp 30-34 Landucci (2014) pp 233-261 e Ead in questo volume
140 MONICA DrsquoAGOSTINI
ABSTRACT
Philip V of Macedon was the first of the Epigonoi to face Rome Several mod-ern reconstructions of the actions and the reign of Philip V have approached it largely from a Roman point of view using as sources Polybius and where Poly-bius is lost Livy The Polybian historiographical tradition tends to portray Phil-ip V as an enemy and a tyrant impious and cruel The Macedonian king was ea-ger to establish a universal and unjust dominion over Greece Italy and beyond and Rome engaged in the first two Macedonian Wars to fight the threat of his growing ambition Nevertheless Polybiusrsquo portrayal of Philip V was affected not only by Polybiusrsquo admiration for Roman political structures military power and overwhelming conquest but also his personal Achaean origins
Looking at in book 29 and 30 of Justinrsquos Epitome of Pompeius Trogus this pa-per focuses on the non Polybian tradition on Philip V this contribution is in-deed the first analysis of the Hellenistic approach to the clash between Rome and Macedonia in the 3rd-2nd Century BC The Epitome shows a considerable di-versity of interpretation from the other sources and reflects very different views of Philip Vrsquos actions that brought him into conflict against Rome In particular these views are more evident related to the accounts of the peace negotiations of Naupactus and the battle of Cynoscephalae in the Epitome the king appears as a courageous and skilled warrior the last of the great Macedonian rulers who fell victim to misfortune This portrayal which has several common features with Appianrsquos fragments of Philip V (Mak 9) counterbalances the Roman and Achaean standpoint present in Polybius providing a more Hellenistic perspec-tive that is likely to have been rooted in a historiographical tradition connect-ed to the losing side in the struggle between Rome and the Hellenistic world
BIBLIOGRAFIA
Adler E (2006) Whorsquos Antiroman Sallust and Pompeius Trogus on Mithridates CJ 101 pp 383-407
Adler E (2011) Valorizing the Barbarians Enemy speeches in Roman Historiography Austin
Ager SL (2003) An Uneasy Balance from the Death of Seleukos to the Battle of Raph-ia in A Erskine (ed) A Companion to the Hellenistic World Oxford pp 35-50
Ager SL (2009) Roman Perspectives on Greek Diplomacy The conceptual clash Greek diplomacy of compromise and Roman Bellum Iustum in C Eilers (ed) Diplomats and Diplomacy in the Roman World Leiden-Boston pp 15-43
Alonso-Nuacutentildeez JM (1992) La Historia Universal de Pompeyo Trogo Madrid
Alonso-Nuacutentildeez JM (2002) The Idea of Universal History in Greece From Herodotus to the Age of Augustus Amsterdam
Ballesteros Pastor L (2013) Pompeyo Trogo Justino y Mitriacutedates Comentario al Epiacutetome de las Historias Filiacutepicas (3716-3881) Hildesheim-Zuumlrich-New York
IL DISCORSO DEL RE 141
Barreacute ML (1983) The God-List in the Treaty between Hannibal and Philip V of Ma-cedon a Study in Light of the Ancient Near Eastern Treaty Tradition Baltimore-Lon-don
Beck H - Eckstein A (2015) sv ldquoAratos of Sicyon (231)rdquo in I Worthington (ed) Brillrsquos New Jacoby Brill Online
Borgna A (2014) Uno sguardo originale intorno a Roma Pompeo Trogo e Giustino laquoLa Biblioteca di ClassicoContemporaneoraquo 1 pp 52-77
Cassola F (1962) I gruppi politici romani nel III secolo aC Trieste
Champion CB (1997) The Nature of Authoritative Evidence in Polybios and Agelausrsquo Speech at Naupactos TAPhA 127 pp 111-128
Champion CB (2004) Cultural Politics in Polybiusrsquo Histories Berkeley
Coppola A (1993) Demetrio di Faro un protagonista dimenticato Roma
Criscuolo L (2011) I due testamenti di Tolemeo VIII Evergete II in A Joumlrdens - J F Quack (hrsg) Aumlgypten zwischen innerem Zwist und aumluszligerem Druck Die Zeit Ptole-maios VI bis VIII Wiesbaden pp 132-150
DrsquoAgostini M (2011) Filippo V e la Storia Romana di Appiano laquoAevumraquo 85 pp 99-121
Eckstein AM (1995) Moral vision in the Histories of Polybius Berkeley
Eckstein AM (2008) Rome enters in the Greek East From Anarchy to Hierarchy in the Hellenistic Mediterranean 230-217 BC Oxford
Eckstein AM (2013) Polybius Phylarchus and Historiographical Criticism CPh 108 4 pp 314-338
Errington RM (1969) Philopoemen Oxford
Errington RM (2008) A History of the Hellenistic World 323-30 BC Malden MA-Oxford
Forni G - Angeli Bertinelli MG (1982) Pompeo Trogo come fonte di storia ANRW II 30 2 pp 1298-1362
Franco C (1993) Trogo Giustino e i successori di Alessandro in L Braccesi - A Coppola - G Cresci Marrone - C Franco (a cura di) LrsquoAlessandro di Giustino dagli antichi ai moderni Roma pp 71-97
Gabba E (2003) Introduzione in D Foraboschi - SM Pizzetti (a cura di) La successione degli imperi e delle egemonie nelle relazioni internazionali Milano pp 7-9
Golan D (1995) The Res Graeciae in Polybius Four Studies Como
Green P (1990) Alexander to Actium The Historical Evolution of the Hellenistic Age Berkeley-Los Angeles
Gutschmid von A (1894) Die beiden ersten Buumlcher des Pompeius Trogus in A von Gutschmid - F Ruumlhl (hrsg) Kleine Schriften Leipzig pp 17-217
142 MONICA DrsquoAGOSTINI
Habicht C (1995) Athen Muumlnchen
Hammond NGL (1968) Illyris Rome and Macedon in 229-205 BC JRS 58 pp 1-21
Hammond NGL (1988) The Campaign and the Battle of Cynoscephalae in 197 BC JHS 108 pp 60-82
Heckel W (1997) Introduction (Part 2) in JC Yardley - W Heckel (eds) Ju-stin Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus Books 11-12 Alexander the Great Introduction Oxford pp 1-41
Heckel W (2012) Introduction in JC Yardley - P Wheatley - W Heckel (eds) Justin Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus II Books 13-15 The Successors to Alexander the Great Oxford pp 1-8
Huss W (1976) Untersuchungen zur Auszligenpolitik Ptolemaiosrsquo IV Muumlnchen
Huss W (2001) Aumlgypten in hellenistischer Zeit 332ndash30 v Chr Muumlnchen
Intrieri M (2011) Fra dialogo e conflitto Annibale e i Greci drsquoOccidente RStudFen 37 pp 53-82
Landucci F (2014) Filippo II e le Storie Filippiche un protagonista storico e storio-grafico in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 233-261
Landucci Gattinoni F (2011) Politica e ideologia in etagrave ellenistica laquoPolitica An-ticaraquo 1 pp 89-105
Leacutevy E (1994) Le discours drsquoAgeacutelaos de Naupacte in L Aigner Foresti - A Bar-zanograve - C Bearzot - L Prandi - G Zecchini (a cura di) Federazioni e federalismo nellrsquoEuropa antica Bergamo 21-25 settembre 1992 Milano (Alle radici della casa co-mune europea 1) pp 33-50
Longaretti L (1989) Lrsquoalleanza tra Annibale e Filippo V di Macedonia RIL 123 pp 183-192
Marasco G (1979-1980) La valutazione di Tolemeo IV Filopatore nella storiografia greca laquoSilenoraquo 5-6 pp 159-182
Mari M [- Musti D - Thornton J] (2002) Polibio Storie Volume III Libri V-VI Milano
Mariotta G (2014) Geografia e Geopolitica nelle Storie Filippiche in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 45-56
McGing B (2010) Polybiusrsquo Histories New York
McGing B (2013) Youthfulness in Polybius the case of Philip V of Macedon in B Gibson - T Harrison (eds) Polybius and his world Oxford pp 181-199
Meadows A (2013) Polybius Aratus and the History of the 140th Olympiad in B
IL DISCORSO DEL RE 143
Gibson - T Harrison (eds) Polybius and his World Essays in Honour of Frank Walbank Oxford pp 91-116
Mecca A (2001) Trogo Timagene e Polieno QS 54 pp 199-222
Meister K (1990) Die Griechische Geschichtsschreibung von den Anfaumlngen bis zum Ende des Hellenismus Stuttgart
Misch G (1949) Geschichte der Autobiographie I Frankfurt am Mein
Momigliano A (1980) Daniele e la teoria greca della successione degli imperi RAL 35 pp 157-162
Muccioli F (2013) Gli epiteti ufficiali dei re ellenistici Stuttgart (Historia Einzel-schriften 224)
Musti D (1978) Polibio e lrsquoimperialismo romano Napoli
Parmeggiani G (2011) Eforo di Cuma studi di storiografia greca Bologna
Peacutedech P (1964) La meacutethode historique de Polybe Paris
Pelling CBR [- Scardigli B - Manfredini M](1997) Plutarco Vite parallele Filopemene Tito Flaminino Milano
Richter H-D (1987) Untersuchungen zur hellenistischen Historiographie die Vorla-gen des Pompeius Trogus fuumlr die Darstellung der nachalexandrischen hellenistischen Ge-schichte (Iust 13-40) Frankfurt
Santi Amantini L (1972) Fonti e valore storico di Pompeo Trogo (Iustin XXXV e XXXVI) Genova
Santi Amantini L (1981) (a cura di) Giustino Storie Filippiche Epitome da Pom-peo Trogo Milano
Santi Amantini L (2003) Il tempo e i tempi nelle Storie Filippiche di Pompeo Tro-go RSA 33 pp 99-110
Schepens G (1983) Les rois ptolegravemaiumlques et lrsquohistoriographie Reacuteflexions sur la trans-formation de lrsquohistoire politique in E vanrsquot Dack - P van Dessel - W Van Gucht (eds) Egypt and the Hellenistic World Proceedings of the International Collo-quium Leuven 24-26 May 1982 Leuven (Studia Hellenistica 27) pp 351-368
Schlicher JJ (1933) Non-Assertive Elements in the Language of the Roman Histo-rians CPh 28 289-300
Schmitt T (1989) Die Bedeutung des zweiten Punischen Krieges fuumlr den Frieden in Naupaktos in H Devijver - E Lipinski (eds) Punic wars Proceedings of the Conference held in Antwerp from the 23th to the 26th of November 1988 in Cooperation with the Departement of History of the laquoUniversitait Antwerpenraquo UFSIA Leuven (Studia Phoenicia 10) pp 229-239
Scholten JB (2000) The Politics of Plunder Aitolians and their koinon in the early Hellenistic Era Berkeley
144 MONICA DrsquoAGOSTINI
Scuderi R (2005) Filippo V e Perseo nei frammenti diodorei in C Bearzot - F Lan-ducci (a cura di) Diodoro e lrsquoaltra Grecia Macedonia Occidente Ellenismo nella Bi-blioteca Storica Atti del convegno Milano 15-16 gennaio 2004 Milano pp 383-405
Sklenaacuter RJ (2004) Sources and Individuality in Two Passages of Livy laquoHistoriaraquo 53 pp 302-310
Sordi M (1982) Timagene di Alessandria Uno storico ellenocentrico e filobarbaro ANRW II 30 1 pp 775-797
Thornton J (2014) Le guerre macedoniche Roma
Urban R (1979) Wachstum und Kriese des achaumlischen Bundes Quellenstudien zur entwicklung des Bundes von 280 bis 222 V Chr Wiesbaden
Urban R (1982) laquoGallisches Bewusstseinraquo und laquoRomkritikraquo bei Pompeius Trogus ANRW II 30 2 pp 1424-1443
Vannicelli P (1987) Lrsquoeconomia delle Storie di Eforo RFIC 115 pp 165-191
Vattuone R (2014) Giustino e lrsquoOccidente greco I VI-V secolo aC in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 261-277
Vollmer D (1990) Symploke das Uumlbergreifen der roumlmischen Expansion auf den grie-chischen Osten Untersuchungen zur roumlmischen Aussenpolitik am Ende des 3 Jh V Chr Stuttgart
Walbank FW (1957) A Historical Commentary on Polibius I Oxford
Walbank FW (1967) A Historical Commentary on Polybius II Oxford
Walbank FW (1933) Aratos of Sicyon Cambridge
Walbank FW (2002) Η ΤΩΝ ΟΛΩΝ ΕΛΠΙΣ and the Antigonids in FW Walbank (ed) Polybius Rome and the Hellenistic World Essays and Reflections West Nyack NY pp 127-136
Weber G (1997) Interaktion Repraumlsentation und Herrschaft Der Koumlnigshof im Hel-lenismus in A Winterling (hrsg) Zwischen lsquoHausrsquo und lsquoStaatrsquo antike Houmlfe im Ver-gleich Munich pp 27-72
Will E (19822) Histoire politique du Monde Helleacutenistique II Nancy
Zecchini G (1990) La storiografia lagide in H Verdin - G Schepens - E De Keyser (eds) Purposes of History Studies in Greek Historiography from the 4th to the 2nd Centuries BC Proceedings of the International Colloquium of Leuven 24-26 May 1988 Leuven (Studia Hellenistica 30) pp 213-232
Zecchini G (2003) Polibio e la tradizione orale in A Casanova - P Desideri (a cura di) Evento racconto scrittura nellrsquoantichitagrave classica Firenze pp 123-141
Finito di stamparenel mese di novembre 2015
da LegoDigit srlLavis (TN)
IL DISCORSO DEL RE 127
Filippo V 21 Il testo giustineo omette le circostanze dellrsquoevento non si menzionano infatti esplicitamente neacute il luogo dellrsquoincontro Naupatto neacute le fasi delle trattative neacute i vari rappresentanti dei diversi fronti che vi presero parte I lunghi negoziati di pace si risolvono dunque nel discor-so di Filippo V ai rappresentanti dei fronti
Il sovrano esordisce affermando che la Grecia egrave in grande pericolo percheacute chiunque avesse vinto tra Cartaginesi e Romani sarebbe poi pas-sato in Oriente Filippo utilizza la metafora delle nubi in Occidente che avrebbero macchiato con una pioggia di sangue ogni cosa spinte dai venti di vittoria inoltre il sovrano ritiene che le guerre passate dei Gre-ci siano di poco conto se paragonate alla minaccia di uno scontro con la moltitudine che si radunava in Italia descrivendo la rabbia e il valore di questi nuovi nemici che avrebbero portato rovina ai vicini Il sovrano infine ribadisce che la Grecia era in maggior pericolo della Macedonia ma che sapeva che chi avesse vinto in Italia non avrebbe frenato la sete di vittoria Perciograve anche la Macedonia stessa doveva temere un attacco
Il discorso in Polibio di Agelao di Naupatto rappresentante e leader degli Etoli22 mostra le medesime argomentazioni attribuite in Giustino allrsquointervento di Filippo argomentazioni fondate sul metus hostilis e fina-lizzate a promuovere un nuovo ruolo della Macedonia sia in Grecia che nel Mediterraneo Orientale Agelao proponendo un nuovo program-ma politico panellenico fonda le proprie argomentazioni sul metus hosti-lis per i Cartaginesi e i Romani presentati metaforicamente come nubi che incombono da Occidente Filippo dovrebbe farsi garante della tran-quillitagrave della Grecia che agendo come unrsquounica catena di cittagrave contro i barbari diverrebbe una sicura e fedele collaboratrice della Macedonia Questo permetterebbe ai Greci di conservare il diritto di far pace o guer-ra a loro piacimento senza temere che laquoi giochi da bambini con i quali ci trastulliamo tutti vengano troncati23raquo
Nonostante sia il medesimo discorso nelle due fonti Agelao introdu-ce una forte proposta di alleanza panellenica estranea alle parole di Fi-lippo Inoltre Filippo pur utilizzando la metafora delle nubi da Occi-
21 Interessanti le osservazioni di Scholten (2000) pp 224-228 a proposito della pace che sarebbe stata cercata e sperata da entrambe le parti e non imposta da Filippo come Polibio pare lasciar intendere 22 Vd soprattutto Leacutevy (1994) pp 33-50 Su questo discorso molto dibattuto dai moderni vd anche Schmitt (1989) pp 229-239 Vollmer (1990) pp 96-107 Coppola (1993) pp 149-164 Golan (1995) pp 55-74 Champion (1997) pp 111-128 e (2004) p 55 Wal-bank (2002) pp 127-136 Eckstein (2008) pp 78-83 23 Polyb V 104 10-11 καθόλου τὰς παιδιάς ἃς νῦν παίζομεν πρὸς ἀλλήλους ἐκκοπῆναι συμβῇ πάντων ἡμῶν ἐπὶ τοσοῦτον ὥστε κἂν εὔξασθαι τοῖς θεοῖς ὑπάρχειν ἡμῖν τὴν ἐξουσίαν ταύτην καὶ πολεμεῖν ὅταν βουλώμεθα καὶ διαλύεσθαι πρὸς ἀλλήλους καὶ καθόλου κυρίους εἶναι τῶν ἐν αὑτοῖς ἀμφισβητουμένων
128 MONICA DrsquoAGOSTINI
dente presente anche nelle Storie la arricchisce con la vivida immagine di una tempesta di sangue conferendo una dimensione piugrave concreta e cruenta alla predizione infine il riferimento polibiano alle guerre dei Greci nellrsquoEpitome non riguarda piugrave le guerre tra le cittagrave e le leghe gre-che ma le guerre dei Greci con Macedoni Persiani e Galli Mentre la Grecia scompare sullo sfondo la minaccia Romana egrave meno vaga e piugrave concreta e presente che in Polibio e diventa lrsquounico argomento del di-scorso di Filippo V a Naupatto
Il discorso di Demetrio e quello di Filippo sono al centro del libro XXIX dellrsquoEpitome avendo il duplice scopo di evidenziare sia la poten-ziale aggressivitagrave dei Romani sia la grande tradizione militare della Ma-cedonia e il pieno diritto di Filippo di controllare la Grecia e lrsquoIlliria fi-no allrsquoAdriatico Se il discorso in Polibio si inseriva in un dibattito politi-co dove la Grecia e la Macedonia erano protagoniste alla pari della sce-na ellenica e internazionale nella versione che leggiamo in Trogo i ri-ferimenti alle dispute della realtagrave greca sono reinterpretati a favore di un punto di vista in cui la Macedonia egrave lrsquounico potere dellrsquoOriente gre-co Del dibattito politico di III secolo in Grecia che tanto stava a cuore a Polibio non vi egrave piugrave alcuna traccia in TrogoGiustino rimane soltanto lo scontro tra le due grandi potenze di Oriente e Occidente tra Filippo e Roma Questa prospettiva bipolare dei discorsi trogiani si ritrova nel-la conclusione del capitolo che se da un lato sottolinea ancora una vol-ta il timore di Filippo per Cartaginesi e Romani dallrsquoaltro esplicita che i Romani avevano paura dellrsquoantica gloria dei Macedoni laquovincitori dellrsquoO-rienteraquo e soprattutto di Filippo laquoinfiammato dallo zelo di emulare Ales-sandro che era ben noto come pronto alle guerre e instancabileraquo24
41-11 La Prima Guerra Macedonica
Dei prodromi della Prima Guerra Macedonica Giustino si interessa sol-tanto allrsquoalleanza antiromana tra Annibale e Filippo Questo trattato egrave noto da molte fonti secondo cui Filippo dopo aver appreso che i Roma-ni erano stati sconfitti di nuovo dai Cartaginesi a Canne nel 216 avreb-be mandato unrsquoambasceria ad Annibale per proporre unrsquoalleanza ma lrsquoambasciatore macedone sarebbe stato catturato da Roma sulla via del ritorno25
24 Iust XXIX 3 8 quippe terrebat eos et uetus Macedonum deuicti Orientis gloria et Philippus studio Alexandri aemulationis incensus quem promptum in bella industriumque cognouerant Alla gloria dei Macedoni avevamo giagrave trovato riferimento nei discorsi del libro XXVIII degli Etoli (2 12) e di Antigono Dosone (3 14) 25 Secondo Polyb VII 9 17 Filippo avrebbe aiutato Cartagine nella guerra con Roma in cambio di Corcira Epidamno e Apollonia e della restituzione a Demetrio di Faro del suo regno Inoltre Filippo e Annibale si impegnavano a soccorrersi a vicenda in caso di
IL DISCORSO DEL RE 129
A prescindere dai dettagli del fermo dellrsquoambasciatore macedone da parte romana egrave possibile fare qualche osservazione sul nesso tra questo lsquoincidentersquo diplomatico e lo scoppio della guerra Cassio Dione e Ap-piano riportano che la cattura del legato avrebbe causato una vendetta di Filippo contro i protettorati romani in Adriatico in particolare Cor-cira26 notizia assente in Polibio come in Livio e Plutarco (che da Poli-bio dipendono)27 In questi ultimi autori lrsquoattacco di Filippo in Adriati-co infatti non sarebbe legato allrsquoepisodio dellrsquoambasciatore ma alla de-cisione del sovrano di rompere con il consigliere Arato e di dare ascol-to ai cattivi consigli di Demetrio di Faro presa dopo la spedizione a Mes-sene nel 215214 La tradizione polibiana legge infatti in questi eventi la manifestazione del cambiamento dellrsquoindole di Filippo V da giusta a empia iniziata con lrsquoepisodio della stasis di Messene del 215 e compiu-ta con lrsquoassassinio di Arato del 21328 Nel libro XXIX di Giustino ben-cheacute si conservi traccia dellrsquoindole aggressiva di Filippo e del consiglio di Demetrio di Faro come prodromi dello scontro con Roma non vi sono indizi della metaboleacute del sovrano da giusto a empio e malvagio e neppu-re del ruolo che in tale cambiamento ricoprigrave lrsquoallontanamento tra Ara-to e Filippo
attacco da parte di Roma Mentre Peacutedech (1964) pp 382-383 ritiene sicura la consulta-zione a Roma di tali documenti Zecchini (2003) pp 123-141 come prima di lui Walbank (1957) I p 32 n 4 non ne egrave certo poicheacute Polibio viaggiograve proprio per poter reperire documenti e informazioni sugli eventi dove essi avvennero Altre fonti Liv XXIII 38 7 Plut Arat 51 2 Dio C XV 4 2 e App Mak Fr 1 Sul confronto delle fonti vd DrsquoAgostini (2011) pp 99-121 Sul trattato macedone-cartaginese vd Cassola (1962) pp 65-66 Wal-bank (1967) II pp 42-44 Will (19822) pp 83-84 Barreacute (1983) Longaretti (1989) pp 183-192 Golan (1995) pp 45-46 Eckstein (2008) pp 83-85 Intrieri (2011) pp 53-8226 Dio C XV 4 2 e App Mak Fr1 Filippo per vendicarsi della cattura del proprio amba-sciatore non solo attaccograve Corcira ma saputo dellrsquoarrivo di Levino durante la ritirata da Corcira saccheggiograve anche Apollonia e Orico alleate romane Levino avrebbe poi sconfit-to Filippo e recuperati gli alleati costringendo il re a bruciare le proprie navi e rientrare via terra Si riferisce a questo episodio probabilmente il Mak Fr 9 di Appiano che riporta lrsquoordine di Filippo di uccidere quanti erano sulle navi percheacute non dicessero ai Romani che le forze macedoni erano stremate DrsquoAgostini (2011) pp 99-12127 Polyb V 108-110 Liv XXIV 40 e Plut Arat 51 2 non menzionano Corcira nella narra-zione dellrsquoalleanza macedone-cartaginese e della cattura dellrsquoambasciatore Secondo Liv XXIII 38 7 lrsquoambasciatore sarebbe stato trattenuto a Roma 28 Polyb VII 11 8-11 e Plut Arat 49 1 Coppola (1993) pp 205-210 Dai frammenti di Polyb VII 10-12 e dalla narrazione di Plut Arat 49-51 sappiamo che Filippo era interve-nuto nella stasis di Messene tra oligarchici e democratici ma aveva di nascosto lasciato che i cittadini si massacrassero Una volta giunto Arato la guerra civile fu finalmente sedata ma il sovrano avrebbe voluto su consiglio di Demetrio di Faro approfittare della situazione e imporre una guarnigione nellrsquoacropoli della cittagrave che gli avrebbe conferito un vantaggio strategico per il controllo del Peloponneso Arato dissuase Filippo da per-seguire unrsquoazione militare in Peloponneso ma il re decise su consiglio di Demetrio di rivolgere la sua aggressivitagrave verso lrsquoIlliria prima e i protettorati romani Orico e Apollonia poi
130 MONICA DrsquoAGOSTINI
Dopo aver accennato alla stipula del trattato Giustino affastella ne-gli ultimi paragrafi del capitolo 4 gli eventi tra il 215 e il 205 quando Fi-lippo siglando la pace con Roma pone fine alla Prima Guerra Macedo-nica29 In particolare lrsquoEpitomatore sottolinea da un lato lrsquoingresso in guerra degli Etoli al fianco dei Romani e la successiva alleanza del preto-re Levino con Attalo dallrsquoaltro gli attacchi subiti da parte dei Dardani da Filippo oppresso dalle richieste degli Illiri Il libro dunque si chiude con Filippo in difficoltagrave aggravate dalla comparsa di Filopemene il leader degli Achei30 urtatosi con il re dei Macedoni convince la Lega Achea a staccarsi dallrsquoalleanza con la Macedonia sempre piugrave isolata Tale allon-tanamento egrave considerato da Giustino lrsquoesito di un fallito agguato a Fi-lopemene commissionato da Filippo V e dovuto al sospetto di un tradi-mento del condottiero acheo a favore di Roma Bencheacute anche Plutarco (Fil 12 2) e Pausania (VIII 50 4) menzionino il tentativo di assassinio di Filopemene da parte di Filippo la notizia dellrsquoatteggiamento filoroma-no del generale acheo non parrebbe vicino al ritratto polibiano che ve-de in Filopemene un eroe dellrsquoautonomia e dellrsquoindipendenza achea31
Libro XXX11-39 Cinoscefale
Lrsquoesordio del libro XXX introducendo il grande scontro di Cinoscefale tra Romani e Macedoni riprende la celebrazione della gloria macedo-ne argomento centrale dei discorsi del libro XXIX Con lrsquoeccezione dei primi capitoli sul deplorevole comportamento di Tolemeo IV in Egit-to32 il libro egrave infatti totalmente dedicato allo scontro tra le due potenze
29 Errington (2008) pp 185-190 La guerra egrave nota a noi soprattutto dai frammenti dei libri VIII-XI di Polibio dai passi di Liv XXIV 40 1-17 XXVI 24 1-26 4 XXVII 30 5-33 5 e XXVIII 5 1- 9 1 XXIX 12 1-15 e dalla Vita di Filopemene di Plutarco La sinteticitagrave del riassunto giustineo impedisce un puntuale paragone delle tradizioni Ad esempio la notizia dellrsquoalleanza tra Attalo e Roma sembra tornare in Liv XXVIII 5 1-4 dove perograve non troviamo Levino ma Sulpicio come rappresentante romano personaggio scompar-so in Giustino In maniera simile la pace di Fenice del 205 egrave sintetizzata in Giustino in una riga e non vi egrave traccia delle lunghe trattative che coinvolsero come mediatori anche Egitto Chio Mitilene e Atamania portarono a una prima pace separata tra Filippo e gli Etoli nel 206 e poi alla pace con Roma Le fonti parallele sono molto piugrave dettagliate anche su questi eventi Polyb XI 4 1-6 9 Liv XXVIII 5 13 e XXIX 12 8-16 e App Mak fr III Degno di nota egrave perograve il commento in Giustino secondo cui laquoi Romani erano per il momento soddisfatti di aver rinviato la guerra contro la Macedoniaraquo Lrsquointenzione ro-mana di riprendere la guerra con la Macedonia egrave infatti presente in tutte le fonti Polyb XI 6 7 Liv XXIX 1216 Dio C XVIII 9 (15) e App Mak Fr III e verragrave ripresa al libro XXX dellrsquoEpitome 30 Su Filopemene e Filippo vd Errington (1969) pp 51-69 e 83-84 vd anche Golan (1995) pp 115-132 Eckstein (2008) pp 103 e 360-36131 Pelling (1997) pp 135-13932 Lrsquoesordio del libro XXX egrave dedicato alle scabrose imprese del sovrano egiziano ovvero
IL DISCORSO DEL RE 131
dellrsquoEst e dellrsquoOvest La prima avvisaglia dellrsquoincombente guerra egrave la no-tizia dellrsquoaccordo di Filippo V e Antioco III per la spartizione dellrsquoEgitto governato dal sovrano-bambino Tolemeo V Il sovrano lagide nel 2032 chiese aiuto ai Romani che secondo TrogoGiustino gradirono la ri-chiesta drsquoaiuto percheacute cercavano pretesti per muovere guerra contro Fi-lippo A partire da Polibio numerose altre fonti ci testimoniano questo episodio mettendolo in relazione con lo scoppio della Seconda Guerra Macedonica ed esprimendo una condanna morale per lrsquoempia condotta del re antigonide che cospira contro un bambino33 al contrario nellrsquoE-pitome si esalta la potenza macedone evidenziando la paura dei Romani delle grandi imprese di Filippo (XXX 3 2)
nullius magis arma metuebant reputantibus quantum motum Pyrrhus parua Macedo-num manu in Italia fecisset quantasque res Macedones in Oriente gessissent
di nessun altro temevano maggiormente le armi poicheacute ripensavano a quanto sconvolgimento Pirro aveva provocato in Italia con una piccola schiera di Ma-cedoni e a quanto grandi imprese i Macedoni avevano compiuto in Oriente
La supremazia macedone egrave anche al centro del discorso in oratio obliqua di Filippo allrsquoincontro nel Golfo Maliaco tra i rappresentanti dei fronti coinvolti nella Seconda Guerra Macedonica34 NellrsquoEpitome infatti dopo
la Quarta Guerra Siriaca conclusa con sconfitta a Rafia contro Antioco III nel 217 e la corruzione del sovrano da parte di Agatocle e della sorella una cortigiana che avrebbe sedotto il re Giustino riferisce poi la morte del sovrano nel 204 e lrsquoascesa al trono del piccolo Tolemeo V Epifane sovrano sotto tutela di Tlepolemo dopo la morte di Agatocle e Sosibio 33 Eckstein (2008) pp 121-180 Thornton (2014) pp 65-88 In particolare sulla relazione tra il complotto e la sconfitta antigonide e seleucidica ad opera di Roma la superioritagrave morale romana ai regni ellenistici e la causalitagrave storica in Polibio (XV 20 6) vd Eck-stein (2008) pp 133-138 Ager (2009) pp 15-43 Landucci Gattinoni (2011) pp 89-105 Secondo Polyb III 2 8 XV 20 XVI 1 8-9 seguito da Liv XXXI 14 5 Filippo avrebbe ottenuto le basi tolemaiche in Egeo Samo e la Caria mentre Antioco avrebbe finalmente avuto mano libera in Celesiria e Fenicia oggetto di quasi un secolo di lotte tra Tolemei e Seleucidi La notizia del trattato permette a Polibio di dedicare alcuni paragrafi (XV 20) a condannare aspramente lrsquooperato di Filippo V e Antioco III definendoli empi e senza pudore e dichiarando che la Fortuna punigrave i due sovrani per il loro crudele operato por-tando i Romani contro di loro vd infra App Mak Fr IV trasmette delle clausole secondo cui Antioco avrebbe avuto lrsquoEgitto e Cipro mentre Filippo avrebbe ottenuto Cirene le Cicladi e la Ionia Infine secondo Porfirio FGrHist 260 F 45 lrsquoaccordo prevedeva che i due sovrani annettessero i possedimenti tolemaici confinanti con i rispettivi regni 34 Prima si menziona unrsquoambasceria del Senato a Filippo e Antioco percheacute laquosi astenessero dallrsquoEgittoraquo e la visita di Lepido in Egitto Quindi le lamentele a Roma di Attalo e i Rodii nei confronti di Filippo Egrave probabile che a questo punto Trogo inserisse la campagna di Filippo in Asia contro Attalo menzionata nel Prologo XXX ma tagliata nellrsquoEpitome La cronologia degli scambi diplomatici precedenti la Seconda Guerra Macedonica egrave stra-volta dalla sintesi dellrsquoEpitomatore e rende impossibile qualsiasi confronto con le altre
132 MONICA DrsquoAGOSTINI
il riassunto delle ambascerie nel Mediterraneo preludio allo scontro della prima fase della guerra35 maggior spazio egrave dato al tentativo di pa-ce a Nicea tra Roma Attalo i Rodii gli Achei e gli Etoli e Filippo V nel 198 In questa occasione Filippo rivendica la posizione di dominio dei Macedoni sui Greci ereditata da Filippo II e Alessandro suoi antenati e in virtugrave di tale supremazia macedone rifiuta che i Greci gli dettino le condizioni di pace ma chiede che sia il Senato a decidere Egrave significati-vo che non solo il discorso di Filippo non compaia in nessuna delle fon-ti parallele che descrivono nel particolare le posizioni degli ambasciato-ri di Achei Etoli Rodii e Attalo ma che Polibio (XVIII 8 8)36 affermi che era difficile sapere cosa si fossero detti Filippo e Flaminino durante i colloqui nel Golfo Maliaco Secondo la tradizione polibiana infatti il sovrano accompagnato da due philoi macedoni Apollodoro e Demoste-ne chiese di allontanare dalle trattative tutti tranne i Romani e discus-se la pace solamente con Flaminino Successivamente a causa dellrsquoinca-pacitagrave di trovare un accordo Filippo chiese due mesi di tregua e lrsquointer-vento del Senato Trogo dunque restituisce il discorso che il resto della tradizione riteneva impossibile da conoscere indicando chiaramente la presenza di una fonte diversa rispetto a Polibio su questo avvenimento piugrave informata sul punto di vista di Filippo e interessata a evidenziare la convinzione di Filippo V di avere un diritto di supremazia sulla Grecia in virtugrave delle imprese di Filippo II e Alessandro
La battaglia di Cinoscefale nel 197 momento risolutivo dello scontro tra Roma e Macedonia egrave lrsquoevento principale del libro XXX omina e pre-sagi introducono lrsquoevento campale lrsquoeruzione del vulcano di Santorini
fonti In Polyb XVI 24 3 App Mak Fr IV Liv XXXI 1 10 21 5 5 Paus I 36 5-6 vi sono differenti versioni della sequenza delle ambascerie che denunciarono a Roma lrsquoe-spansionismo macedone ma tutte concordano che le ambascerie precedettero lrsquoinvio dei legati romani in Oriente e che esse furono inviate anche da Atene e dagli Etoli Inoltre secondo la tradizione polibiana (Polyb XVI 27 1-4 34 1-7 Liv XXXI 2 3 6 3-8 4 18 1-9 Diod XXVIII 6) vi furono due diverse ambascerie di cui la seconda sarebbe stato un ultimatum al sovrano recapitato da Lepido In occasione di questa seconda ambasceria avvenuta durante il cruento assedio di Abido Filippo avrebbe detto che i Macedoni in ca-so di guerra si sarebbero difesi con valore In Giustino si puograve notare che ancora una volta dagli eventi sono omesse notizie fondamentali sui Greci nello specifico lrsquoambasceria di Atene la cui disputa con gli Acarnani fu il casus belli della guerra contro Filippo 35 Come i prodromi anche la prima parte della Seconda Guerra Macedonica egrave sintetizza-ta in Giustino e occupa solamente due paragrafi Come spesso accade nei passi sintetiz-zati dallrsquoEpitomatore si trovano le incongruenze maggiori con le fonti parallele tra cui si nota soprattutto la completa omissione di Giustino delle campagne di Publio Sulpicio Galba Massimo di Villio delle vittorie di Tito e Lucio Flaminino e dellrsquoassemblea del 198 che portograve gli Achei ad allearsi con Roma Polyb XXII e Liv XXXI 14 1- 46 16 XXXII 1 1-25 12 App Mak Fr VII Plut Fil 17 4 Flam 5 4 e Paus VII 8 1-236 Le trattattive sono descritte con particolari in Polyb XVIII 1-12 seguito da Liv XXXII 32 6-36 10 e Plut Flam 5 8 e 7 1-3
IL DISCORSO DEL RE 133
nel 197 e lrsquoemergere dellrsquoisola di Hiera e in contemporanea il terremo-to a Rodi Quindi nellrsquoEpitome si annuncia che laquoil nascente impero dei Romani avrebbe divorato quello antico dei Greci e dei Macedoni37raquo Nel passo ricevono spazio soprattutto i due discorsi contrapposti del re ma-cedone Filippo e del comandante romano Flaminino pronunciati pri-ma dello scontro campale e costruiti ciascuno in modo da celebrare le imprese delle due potenze38 Lrsquoenfasi data dalla contrapposizione reto-rica delle parole dei generali egrave tale da rendere suggestiva lrsquoipotesi che lo scontro dovesse essere il momento centrale non solo del libro XXX ma forse di tutta lrsquoopera trogiana
Filippo elenca le grandi vittorie del passato dei Macedoni contro Per-siani Battriani Indiani e le popolazioni drsquoAsia fino allrsquoestremo Orien-te esortando i suoi a combattere con valore percheacute laquola libertagrave egrave piugrave cara del predominio39raquo Il discorso di Flaminino egrave invece piugrave lungo articola-to in un paragone tra Macedoni e Romani alle passate imprese di con-quista macedoni vengono contrapposte le piugrave recenti vittorie romane a Cartagine in Sicilia Italia e Spagna alla grandezza di Alessandro Ma-gno egrave contrapposta quella di Annibale che pure dai Romani era stato sconfitto Lrsquoattenzione poi si concentra su Filippo i Macedoni non laquodo-vevano essere valutati per lrsquoantica forza ma per le forze attuali40raquo poicheacute Filippo non era lrsquoinvitto e invincibile Alessandro Magno ma un ragaz-zo che non riusciva a difendere i propri confini I Macedoni rivendica-vano il valore degli antenati mentre i Romani quello dei propri soldati poicheacute quelli che erano ligrave schierati erano gli stessi che avevano sconfitto Annibale Dopo una cosigrave grandiosa introduzione la battaglia egrave descritta in uno dei paragrafi piugrave significativi di tutta lrsquoopera
His adhortationibus utrimque concitati milites proelio concurrunt alteri Orientis alteri Occidentis imperio gloriantes ferentesque in bellum alii maiorum suorum antiquam et ob-soletam gloriam alii uirentem recentibus experimentis uirtutis florem [16] Sed Macedo-nas Romana Fortuna uicit
I soldati incitati da queste esortazioni dallrsquouna e dallrsquoaltra parte si lanciaro-no nel combattimento vantandosi gli uni del dominio dellrsquoOriente gli altri dellrsquoOccidente e recando in guerra gli uni lrsquoantica e sbiadita gloria dei loro an-
37 Iust XXX 4 4 Quo prodigio territis omnibus uates cecinere oriens Romanorum imperium uetus Graecorum ac Macedonum uoraturum38 Sui discorsi precedenti la battaglia nellrsquoantichitagrave se da considerare reali o costruzioni storiografiche vd Adler (2011) pp 6-839 Iust XXX 4 7 tantoque hoc bellum fortius quam illa sustinendum quanto sit imperio libertas carior40 Iust XXX 4 10 Sed nec Macedonas ueteri fama sed praesentibus uiribus aestimandos
134 MONICA DrsquoAGOSTINI
tenati gli altri il fiore del loro valore fresco e vigoroso per le recenti prove Ma la Fortuna dei Romani vinse i Macedoni
Questo punto di vista probabilmente giagrave trogiano contrappone la virtugrave romana (virtutis flos) celebrata nei discorsi antecedenti la battaglia al-la Fortuna romana (Romana Fortuna) che decise la vittoria interpretabi-le come destino favorevole o buona stella Piugrave che unrsquoaffermazione anti-romana41 come egrave spesso stata intesa si puograve evidenziare il carattere sim-patetico della fonte verso Filippo V destinato a porre fine alla gloria di Filippo II e Alessandro e forse un approccio nostalgico verso i grandi regni macedoni la cui egravera egrave ormai giunta alla fine Tale prospettiva egrave as-sente in Polibio e nella tradizione che da lui dipende poco interessata alle vicende della gloria macedone leggendo infatti i frammenti soprav-vissuti del libro XVIII delle Storie dopo lrsquoaccurata descrizione della bat-taglia (18-33 e 34-40)42 Polibio commenta lo scontro affermando che avrebbe dedicato alcuni capitoli allrsquoesame delle strategie militari delle due armate percheacute (XVIII 28 4-6)
χρήσιμον καὶ καλὸν ἂν εἴη τὸ τὴν διαφορὰν ἐρευνῆσαι καὶ παρὰ τί συμβαίνει Ῥωμαίους ἐπικρατεῖν καὶ τὸ πρωτεῖον ἐκφέρεσθαι τῶν κατὰ πόλεμον ἀγώνων [5] ἵνα μὴ τύχην λέγοντες μόνον μακαρίζωμεν τοὺς κρατοῦντας ἀλόγως καθάπερ οἱ μάταιοι τῶν ἀνθρώπων ἀλλ᾽ εἰδότες τὰς ἀληθεῖς αἰτίας ἐπαινῶμεν καὶ θαυμάζωμεν κατὰ λόγον τοὺς ἡγουμένους
Puograve essere cosa buona e utile esaminare le differenze e per quale motivo i Ro-mani prevalgono e riportano il primo premio nelle competizioni di guerra af-fincheacute non esaltiamo i vincitori senza una ragione parlando solo di fortuna co-me fanno gli sciocchi ma conoscendo le vere cause lodiamo e ammiriamo i co-mandanti seguendo una logica
Polibio dunque sembra rispondere a coloro che parlavano della buo-na stella dei Romani sottolineando che la vittoria nasceva dalla superio-re strategia militare della legione43 Un punto di vista quindi opposto a quello espresso nellrsquoEpitome che proprio di Romana Fortuna parla e riba-dito in chiusura al passo dove Polibio critica nuovamente quei Greci che ritenevano la vittoria romana incredibile (XVIII 32 13)
41 Urban (1982) pp 1424-1443 1435 Richter (1987) p 19 n 4 Alonso-Nuacutentildeez (1992) p 66 e Id (2002) pp 105-110 partic 108-109 Contra Heckel (1997) p 29 che ridimen-siona la categorizzazione di Trogo come storico anti-romano 42 Su Cinoscefale vd Walbank (1957) ad l Hammond (1988) pp 60-82 Sklenaacuter (2004) pp 302-310 Thornton (2014) pp 83-87 43 Sulla Fortuna in Polibio vd McGing (2010) pp 195-201 (con bibliografia) che distin-gue tra quando Polibio intenda caso e quando predeterminazione fato Vd anche Green (1990) pp 400-402 e Eckstein (2008) pp 132-138
IL DISCORSO DEL RE 135
Il punto di vista di Trogo sembra invece presente nei frammenti del-la Makedonikeacute di Appiano su Filippo V44 dove ci si riferisce a Cinoscefale come a una vittoria insperata (Mak 9 1)
ἡγούμενος δ᾽ οὔτε Ῥωμαίοις συμφέρειν οὔτε τοῖς Ἕλλησι Φιλίππου καθαιρεθέντος ἐπιπολάσαι τὴν Αἰτωλῶν βίαν τάχα δ᾽ αὐτὸν καὶ τὸ παράδοξον τῆς νίκης ἀγαπᾶν ἐποίει
Flaminino era consapevole che non sarebbe stato vantaggioso per i Romani o per i Greci che Filippo fosse deposto e che il potere etolico rimanesse incon-trastato forse lo aveva reso moderato nei suoi progetti lrsquoaver ottenuto una vit-toria insperata
Addirittura successivamente si accenna alla sorte avversa a Filippo nel-lo scontro
τὰ μὲν δὴ παρὰ τῶν ἄλλων φιλάνθρωπα ἦν τό τε τῆς τύχης ἄδηλον ἐξ ὧν ἔπαθεν ὁ Φίλιππος ὑφορωμένων καὶ τὸ πταῖσμα τοῦτο οὐ κατ᾽ ἀσθένειαν ἀλλὰ πλέον ἐκ συντυχίας αὐτὸν παθεῖν ἡγουμένων
Gli altri (Greci) erano inclini ad essere moderati vedendo con sospetto lrsquoincer-tezza della fortuna subita da Filippo e ritenendo che egli fosse incorso in questa sconfitta non tanto per la sua inferioritagrave quanto per la sfortuna
Il riferimento in Appiano e Trogo alla fortuna romanasfortuna ma-cedone a proposito di Cinoscefale egrave una traccia dellrsquoopinione politi-ca di quei Greci disprezzati da Polibio come uomini sciocchi καθάπερ οἱ μάταιοι τῶν ἀνθρώπων Tale posizione politica su Cinoscefale sarebbe dunque sopravvissuta nella tradizione storiografica di cui troviamo trac-cia in TrogoGiustino e Appiano
Per comprendere meglio alcune caratteristiche di questa tradizione puograve essere utile tornare ai due discorsi nellrsquoEpitome di Filippo e Flamini-no prima della battaglia Tali passi probabilmente trogiani45 non trova-no infatti riscontro nelle fonti parallele a noi pervenute Polibio (XVIII 18-27) seguito fedelmente da Livio (XXXIII 5-10) pur descrivendo le operazioni di guerra di Cinoscefale con dovizia di particolari non men-ziona un discorso di Filippo ai suoi armati prima della battaglia mentre il discorso di Flaminino per incoraggiare le truppe schierate (XVIII 23 2-6) nelle Storie egrave incentrato sulle vittorie di Sulpicio nella prima parte della guerra Pare dunque originale la versione trogiana che incentra-
44 Tra i frammenti consegnatici dagli Excerpta Constantiniana sono frequenti informazio-ni e osservazioni che rimandano a una prospettiva ellenistica sugli eventi DrsquoAgostini (2011) pp 99-121 45 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362
136 MONICA DrsquoAGOSTINI
ta sulla gloria macedone presenta Cinoscefale come il punto drsquoincon-tro e di scambio tra lrsquoegemonia macedone e lrsquoegemonia romana Non egrave una novitagrave che il leitmotiv delle Storie Filippiche e dunque dellrsquoEpitome sia la translatio imperii giagrave Alonso Nuntildeez definito da Santi Amantini laquouno dei piugrave noti esperti di questioni trogiano-giustineeraquo46 osservava che Tro-go esponeva nel suo perduto lavoro la teoria della successione degli im-peri mondiali secondo lo schema Assiria-Media-Persia-Macedonia-Roma osteggiata dai Parti47 In tale successione il ruolo da protagonista egrave rico-perto dallrsquoegemonia macedone48 che occupa allrsquoincirca 26 dei 44 libri e il cui ultimo vero momento di gloria egrave lo scontro con Roma appunto a Cinoscefale Lrsquoultima impresa macedone ha come esito la transizione del dominio universale da Oriente a Occidente e costituisce il tema cen-trale dellrsquointera vicenda di Filippo lrsquoimportanza della battaglia di Cino-scefale egrave perciograve esaltata nei discorsi sia di Filippo che di Flaminino che a loro volta sono il punto di arrivo delle argomentazioni esposte nelle parole di Demetrio di Faro e di Filippo stesso giagrave nel libro XXIX Le ora-tiones disposte retoricamente nei due libri descrivono due parabole op-poste da un lato quella romana che da lontana potenza desiderosa di espandersi cresce come una pioggia di sangue diventando il giovane e vigoroso potere che sottomesso Annibale egrave pronto a sconfiggere Filip-po Dallrsquoaltro quella macedone che originata con Filippo II personag-gio centrale per Trogo raggiunge il suo apice con la conquista dellrsquoege-monia ad opera di Alessandro Magno contro i Persiani per conoscere la fine con Filippo V il cui antico valore egrave ormai troppo lsquosbiaditorsquo per te-ner testa al vigore romano
La gloria macedone secondo Trogo inizia dunque con Filippo II e si conclude con Filippo V Perseo egrave infatti il malvagio responsabile dellrsquoan-nientamento di ciograve che rimaneva della monarchia macedone49 Trogo pone agli estremi della parabola macedone che occupa dal libro IX al XXX i due re di nome Filippo Filippo II e Filippo V come ribadito in piugrave luoghi dellrsquoEpitome sia in parti riassunte da Giustino che in passi piugrave genuinamente trogiani Dando per scontato che il titolo dellrsquoopera Sto-rie Filippiche si debba al desiderio di Trogo di rifarsi allrsquoopera di Teopom-po sul sovrano macedone egrave possibile che tale titolo sia stato perograve ripen-
46 Santi Amantini (2003) pp 99-11047 laquoPompeius Trogus expounded in his lost work the Historiae Philippicae a theory of the world empire suggestion according to the scheme Assyria-Media-Persia-Macedonia-Rome opposed by the Parthiansraquo Alonso-Nuacutentildeez (2002) pp 105-110 e 133-136 partic 105 Vd anche Richter (1987) pp 19-23 Momigliano (1980) pp 157-162 Alonso-Nuacutentildeez (1992) Heckel (1997) pp 1-41 Gabba (2003) pp 7-9 Santi Amantini (2003) pp 99-110 Mariotta (2014) pp 45-56 48 Franco (1993) pp 71-97 e Landucci (2014) pp 233-26149 Alonso-Nuacutentildeez (2002) pp 105-110 partic 108-109
IL DISCORSO DEL RE 137
sato da Trogo considerando che il periodo compreso tra le imprese dei due Filippo occupa 23 dellrsquoopera50 Si potrebbe allora suggerire che le Storie sono Filippiche poicheacute i due Filippo segnarono lrsquoinizio e la fine di quella che egrave nellrsquoopera di Trogo lrsquoegemonia incontrastata del mondo piugrave gloriosa di tutti i tempi51
La prospettiva ellenistica che vede nei due Filippo i limiti della grande egemonia macedone egrave di nuovo presente anche in Appiano nellrsquooraco-lo riportato nei frammenti della sua Makedonikeacute e noto anche da Pausa-nia (VII 8 9)
αὐχοῦντες βασιλεῦσι Μακηδόνες Ἀργεάδῃσιν ὑμῖν κοιρανέων ἀγαθὸν καὶ πῆμα Φίλιππος ἤτοι ὁ μὲν πρότερος πόλεσιν λαοῖσί τ᾽ ἄνακτας θήσει ὁ δ᾽ ὁπλότερος τιμὴν ἀπὸ πᾶσαν ὀλέσσει δμηθεὶς δ᾽ ἑσπερίοισιν ὑπ᾽ ἀνδράσιν ἐνθάδ᾽ ὀλεῖται
O Macedoni che andate orgogliosi dei re di stirpe argiva I re di nome Filippo saranno arbitri del bene e del male per voi Il primo vi renderagrave signori di cittagrave e popoli il secondo vi priveragrave di ogni onore sconfitto da uomini dellrsquoOcciden-te qui giace morto52
Senza voler entrare nel merito della discussione di tale oracolo di nuo-vo pare di incontrare nei due autori la medesima prospettiva lontana dalla condanna morale del re macedone espressa da Polibio secondo cui la sconfitta egrave il giusto esito della sua crudeltagrave ed empietagrave
Il libro giustineo si conclude menzionando le condizioni della pa-ce di Tempe53 e lrsquoira degli Etoli che videro ignorate le proprie richieste da Flaminino e perciograve cercarono lrsquoalleanza di Antioco contro Roma Se-condo il Prologo XXX il libro perograve proseguiva con le campagne di Antio-co III in Asia Minore contro Molone e Acheo e in Battriana fino ad ar-rivare allrsquoesordio dello scontro con Roma54 Il riassunto giustineo egrave trop-po sommario per permettere un confronto con le fonti parallele Egrave pe-
50 Sul rilievo della storia della Macedonia nellrsquoopera di Trogo e Giustino vd von Gutsch-midt (1894) pp 17-217 Richter (1987) p 28 n 29 Franco (1993) pp 71-97 51 Vd anche Urban (1982) pp 1424-1443 e Alonso-Nuacutentildeez (1992) p 58 52 Mak Fr 2 Vd DrsquoAgostini (2011) pp 99-121 In questa Walbank (2002) pp 127-136 propone di interpretare anche un poema di Alceo di Messene (Anth Pal 9518)53 Egrave probabile che Trogo fornisse piugrave particolari riguardo a questa pace per esempio si puograve ritenere che vi fosse menzione dellrsquoinvio a Roma del figlio Demetrio da parte di Filippo come ostaggio dato che a Iust XXXII 2 3 si richiama appunto tale avvenimento54 Polyb XVIII 34 1-39 7 42 1-45 12 Liv XXXIII 11 3-13 15 24 1-31 11 Plut Flam IX 1-8 App Mak Fr IX riferiscono di due diverse trattative di pace caratterizzate da un vivace dibattito tra chi voleva lrsquoannientamento della Macedonia come in Grecia gli Etoli e a Roma Marco Claudio Marcello e coloro che desideravano la pace con la Macedonia in primis Flaminino
138 MONICA DrsquoAGOSTINI
rograve da notare la mancanza sia nel Prologo che nel testo del libro degli av-venimenti delle celebrazioni Istmie del 196 quando Flaminino procla-mograve la libertagrave dei Greci Piugrave in generale in tutta la narrazione di Giustino delle complesse trattative del 197-196 manca qualsiasi riferimento alla li-bertagrave dei Greci punto nodale nella tradizione di Polibio che con questa sottolineatura esalta sia il ruolo tirannico della Macedonia sia la grande generositagrave dei Romani nei confronti della Grecia Il silenzio di TrogoGiustino su tale questione mostra il prevedibile disinteresse per gli affari dei Greci e nel contempo conferma la presenza di una tradizione che si occupa soprattutto della storia delle monarchie ellenistiche allrsquointer-no della quale la posizione dellrsquoEllade egrave subalterna
Libro XXXII23- 34 Demetrio e Perseo
Gli ultimi anni di regno di Filippo tra il 183 e il 179 sono narrati in un passo breve del libro XXXII Il racconto in Giustino che egrave coerente con il Prologo trogiano segue in maniera sintetica la tradizione polibiana su questi eventi giunta a noi in alcuni passi lacunosi di Polibio (XXIII 1 3-3 10 7 1-7 10 1-11 8) integrati dal racconto particolareggiato di Li-vio (XXXIX 46 7- 48 6 53 1-16 XL 3 3-16 3 201-24 8) e dalla narra-zione di Diodoro (XIX 25) e Plutarco (Aem VIII 11)55
Conclusioni
In questi libri dedicati a Filippo egrave forse possibile vedere in filigrana la rielaborazione voluta di Giustino dei corrispondenti libri trogiani Co-me Giustino stesso afferma nella Prefatio 3 lrsquoopera di Trogo era costruita secondo due criteri quello cronologico e quello per laquoconcatenazione di eventi56raquo ea omnia Pompeius diuisa temporibus et serie rerum digesta conposuit
55 Lrsquoutilizzo della tradizione polibiana in Trogo egrave confermato dallrsquoaderenza a Livio (XL 54 1-56 11) e Diodoro (XXIX 28) del racconto sul pentimento di Filippo per aver ucciso il figlio Demetrio lrsquointenzione di punire Perseo e la correlazione tra questo e la sua mor-te Questo libro egrave dunque differente nellrsquointeresse e nelle fonti dai libri XXIX e XXX poicheacute molto vicino alla tradizione polibiana in Livio Questi avvenimenti in Giustino sono da collegare con lrsquoascesa al trono di Perseo e non con lrsquoepilogo della celebrazione del valore macedone giagrave conclusasi in Giustino con Cinoscefale e la transizione dallrsquoim-perium macedone allrsquoimperium romano Vd Heckel (1997) p 7 Appiano invece riporta ancora una tradizione diversa da quella polibiana in un frammento della Makedonikeacute in particolare Appiano egrave attento al punto di vista macedone e presenta Filippo come una vittima delle circostanze (Mak IX) DrsquoAgostini (2011) pp 99-12156 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362 Alonso-Nuacutentildeez (2002) pp 133-136 He-ckel (1997) pp 1-41 Borgna (2014) pp 52-77
IL DISCORSO DEL RE 139
Serie rerum digesta sembrerebbe unrsquointerpretazione latina della formula κατὰ γένος che Diodoro usa per indicare la struttura della storia di Efo-ro sottolineandone la divisione per argomento57 In tale struttura per argomento dellrsquoEpitome tra i temi principali ci sono dunque il valore e la gloria dei sovrani ellenistici58 riscontrabile nei libri XXVIII-XXXI sui re-gni di Antigono Dosone Filippo V e Antioco III Tale tema presente di sicuro in Trogo egrave conservato nellrsquoazione dellrsquoEpitomatore e anzi come si vede dagli escerpta esaltato dalla selezione dei passi
Per quanto riguarda invece la Quellenforschung 59 egrave evidente che nel testo vi sia presenza di filoni non tradizionali sugli eventi poicheacute la posi-zione di Trogo appare spesso autonoma rispetto alle opinioni condivise dalla storiografia antica Questo aspetto dellrsquoEpitome evidente soprattut-to per ciograve che riguarda gli eventi ellenistici ha suscitato la grande curio-sitagrave degli studiosi che allontanatisi dalla proposta di von Gutschmid che voleva una totale ed esclusiva dipendenza di Trogo da Timagene ora in-dicano con sicurezza tra le fonti piugrave rilevanti per gli eventi ellenistici di III secolo utilizzate da Trogo almeno altri sei nomi oltre a Timagene Ie-ronimo Timeo Filarco Duride Polibio e Posidonio
Per quanto riguarda nello specifico la composizione dei libri XXIX e XXX non vi egrave alcun dubbio che in essi Trogo abbia utilizzato (anche riadattandola) una fonte poco attenta alle questioni di politica interna greca e al legame tra queste e quel ritratto di Filippo come sovrano mal-vagio ed empio che ritorna nella tradizione ufficiale di origine polibia-na passando poi da Polibio in Livio Diodoro e Plutarco60 Trogo pre-serva invece una tradizione ellenistica interessata alla figura di Filippo come ultimo barlume della gloria macedone tradizione che pare quasi una controparte e un completamento dellrsquoAb urbe condita romanocentri-ca di Livio Non si puograve perciograve a mio avviso escludere che per questa se-zione Trogo abbia usato una tradizione di matrice filoellenistica o sem-plicemente ellenisticocentrica unrsquoopera sui regni di diadochi ed epigo-ni che a tutti noi fa venire facilmente alla mente il Basileis o Perigrave Basileon dello storico grecoellenistico augusteo filobarbaro scettico (o critico) verso lrsquoegemonia romana Timagene di Alessandria (FGrHist 88)61
57 Su Eforo vd Vannicelli (1987) pp 165-191 e ora Parmeggiani (2011) 58 Simile legame vi egrave a mio avviso tra i libri XXVI e XXVII che invece affrontavano la crisi delle monarchie ellenistiche causata dalle guerre fraterne59 Vd von Gutschmid (1894) pp 17-217 Richter (1987) pp 17-30 partic 20-23 San-ti Amantini (1972) pp 56-109 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362 Urban (1982) pp 1424-1443 partic 1435 Mecca (2001) pp 199-222 Santi Amantini (2003) pp 99-110 Heckel (2012) pp 3-860 Scuderi (2005) pp 383-40561 Sordi (1982) pp 775-797 Heckel (1997) pp 30-34 Landucci (2014) pp 233-261 e Ead in questo volume
140 MONICA DrsquoAGOSTINI
ABSTRACT
Philip V of Macedon was the first of the Epigonoi to face Rome Several mod-ern reconstructions of the actions and the reign of Philip V have approached it largely from a Roman point of view using as sources Polybius and where Poly-bius is lost Livy The Polybian historiographical tradition tends to portray Phil-ip V as an enemy and a tyrant impious and cruel The Macedonian king was ea-ger to establish a universal and unjust dominion over Greece Italy and beyond and Rome engaged in the first two Macedonian Wars to fight the threat of his growing ambition Nevertheless Polybiusrsquo portrayal of Philip V was affected not only by Polybiusrsquo admiration for Roman political structures military power and overwhelming conquest but also his personal Achaean origins
Looking at in book 29 and 30 of Justinrsquos Epitome of Pompeius Trogus this pa-per focuses on the non Polybian tradition on Philip V this contribution is in-deed the first analysis of the Hellenistic approach to the clash between Rome and Macedonia in the 3rd-2nd Century BC The Epitome shows a considerable di-versity of interpretation from the other sources and reflects very different views of Philip Vrsquos actions that brought him into conflict against Rome In particular these views are more evident related to the accounts of the peace negotiations of Naupactus and the battle of Cynoscephalae in the Epitome the king appears as a courageous and skilled warrior the last of the great Macedonian rulers who fell victim to misfortune This portrayal which has several common features with Appianrsquos fragments of Philip V (Mak 9) counterbalances the Roman and Achaean standpoint present in Polybius providing a more Hellenistic perspec-tive that is likely to have been rooted in a historiographical tradition connect-ed to the losing side in the struggle between Rome and the Hellenistic world
BIBLIOGRAFIA
Adler E (2006) Whorsquos Antiroman Sallust and Pompeius Trogus on Mithridates CJ 101 pp 383-407
Adler E (2011) Valorizing the Barbarians Enemy speeches in Roman Historiography Austin
Ager SL (2003) An Uneasy Balance from the Death of Seleukos to the Battle of Raph-ia in A Erskine (ed) A Companion to the Hellenistic World Oxford pp 35-50
Ager SL (2009) Roman Perspectives on Greek Diplomacy The conceptual clash Greek diplomacy of compromise and Roman Bellum Iustum in C Eilers (ed) Diplomats and Diplomacy in the Roman World Leiden-Boston pp 15-43
Alonso-Nuacutentildeez JM (1992) La Historia Universal de Pompeyo Trogo Madrid
Alonso-Nuacutentildeez JM (2002) The Idea of Universal History in Greece From Herodotus to the Age of Augustus Amsterdam
Ballesteros Pastor L (2013) Pompeyo Trogo Justino y Mitriacutedates Comentario al Epiacutetome de las Historias Filiacutepicas (3716-3881) Hildesheim-Zuumlrich-New York
IL DISCORSO DEL RE 141
Barreacute ML (1983) The God-List in the Treaty between Hannibal and Philip V of Ma-cedon a Study in Light of the Ancient Near Eastern Treaty Tradition Baltimore-Lon-don
Beck H - Eckstein A (2015) sv ldquoAratos of Sicyon (231)rdquo in I Worthington (ed) Brillrsquos New Jacoby Brill Online
Borgna A (2014) Uno sguardo originale intorno a Roma Pompeo Trogo e Giustino laquoLa Biblioteca di ClassicoContemporaneoraquo 1 pp 52-77
Cassola F (1962) I gruppi politici romani nel III secolo aC Trieste
Champion CB (1997) The Nature of Authoritative Evidence in Polybios and Agelausrsquo Speech at Naupactos TAPhA 127 pp 111-128
Champion CB (2004) Cultural Politics in Polybiusrsquo Histories Berkeley
Coppola A (1993) Demetrio di Faro un protagonista dimenticato Roma
Criscuolo L (2011) I due testamenti di Tolemeo VIII Evergete II in A Joumlrdens - J F Quack (hrsg) Aumlgypten zwischen innerem Zwist und aumluszligerem Druck Die Zeit Ptole-maios VI bis VIII Wiesbaden pp 132-150
DrsquoAgostini M (2011) Filippo V e la Storia Romana di Appiano laquoAevumraquo 85 pp 99-121
Eckstein AM (1995) Moral vision in the Histories of Polybius Berkeley
Eckstein AM (2008) Rome enters in the Greek East From Anarchy to Hierarchy in the Hellenistic Mediterranean 230-217 BC Oxford
Eckstein AM (2013) Polybius Phylarchus and Historiographical Criticism CPh 108 4 pp 314-338
Errington RM (1969) Philopoemen Oxford
Errington RM (2008) A History of the Hellenistic World 323-30 BC Malden MA-Oxford
Forni G - Angeli Bertinelli MG (1982) Pompeo Trogo come fonte di storia ANRW II 30 2 pp 1298-1362
Franco C (1993) Trogo Giustino e i successori di Alessandro in L Braccesi - A Coppola - G Cresci Marrone - C Franco (a cura di) LrsquoAlessandro di Giustino dagli antichi ai moderni Roma pp 71-97
Gabba E (2003) Introduzione in D Foraboschi - SM Pizzetti (a cura di) La successione degli imperi e delle egemonie nelle relazioni internazionali Milano pp 7-9
Golan D (1995) The Res Graeciae in Polybius Four Studies Como
Green P (1990) Alexander to Actium The Historical Evolution of the Hellenistic Age Berkeley-Los Angeles
Gutschmid von A (1894) Die beiden ersten Buumlcher des Pompeius Trogus in A von Gutschmid - F Ruumlhl (hrsg) Kleine Schriften Leipzig pp 17-217
142 MONICA DrsquoAGOSTINI
Habicht C (1995) Athen Muumlnchen
Hammond NGL (1968) Illyris Rome and Macedon in 229-205 BC JRS 58 pp 1-21
Hammond NGL (1988) The Campaign and the Battle of Cynoscephalae in 197 BC JHS 108 pp 60-82
Heckel W (1997) Introduction (Part 2) in JC Yardley - W Heckel (eds) Ju-stin Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus Books 11-12 Alexander the Great Introduction Oxford pp 1-41
Heckel W (2012) Introduction in JC Yardley - P Wheatley - W Heckel (eds) Justin Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus II Books 13-15 The Successors to Alexander the Great Oxford pp 1-8
Huss W (1976) Untersuchungen zur Auszligenpolitik Ptolemaiosrsquo IV Muumlnchen
Huss W (2001) Aumlgypten in hellenistischer Zeit 332ndash30 v Chr Muumlnchen
Intrieri M (2011) Fra dialogo e conflitto Annibale e i Greci drsquoOccidente RStudFen 37 pp 53-82
Landucci F (2014) Filippo II e le Storie Filippiche un protagonista storico e storio-grafico in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 233-261
Landucci Gattinoni F (2011) Politica e ideologia in etagrave ellenistica laquoPolitica An-ticaraquo 1 pp 89-105
Leacutevy E (1994) Le discours drsquoAgeacutelaos de Naupacte in L Aigner Foresti - A Bar-zanograve - C Bearzot - L Prandi - G Zecchini (a cura di) Federazioni e federalismo nellrsquoEuropa antica Bergamo 21-25 settembre 1992 Milano (Alle radici della casa co-mune europea 1) pp 33-50
Longaretti L (1989) Lrsquoalleanza tra Annibale e Filippo V di Macedonia RIL 123 pp 183-192
Marasco G (1979-1980) La valutazione di Tolemeo IV Filopatore nella storiografia greca laquoSilenoraquo 5-6 pp 159-182
Mari M [- Musti D - Thornton J] (2002) Polibio Storie Volume III Libri V-VI Milano
Mariotta G (2014) Geografia e Geopolitica nelle Storie Filippiche in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 45-56
McGing B (2010) Polybiusrsquo Histories New York
McGing B (2013) Youthfulness in Polybius the case of Philip V of Macedon in B Gibson - T Harrison (eds) Polybius and his world Oxford pp 181-199
Meadows A (2013) Polybius Aratus and the History of the 140th Olympiad in B
IL DISCORSO DEL RE 143
Gibson - T Harrison (eds) Polybius and his World Essays in Honour of Frank Walbank Oxford pp 91-116
Mecca A (2001) Trogo Timagene e Polieno QS 54 pp 199-222
Meister K (1990) Die Griechische Geschichtsschreibung von den Anfaumlngen bis zum Ende des Hellenismus Stuttgart
Misch G (1949) Geschichte der Autobiographie I Frankfurt am Mein
Momigliano A (1980) Daniele e la teoria greca della successione degli imperi RAL 35 pp 157-162
Muccioli F (2013) Gli epiteti ufficiali dei re ellenistici Stuttgart (Historia Einzel-schriften 224)
Musti D (1978) Polibio e lrsquoimperialismo romano Napoli
Parmeggiani G (2011) Eforo di Cuma studi di storiografia greca Bologna
Peacutedech P (1964) La meacutethode historique de Polybe Paris
Pelling CBR [- Scardigli B - Manfredini M](1997) Plutarco Vite parallele Filopemene Tito Flaminino Milano
Richter H-D (1987) Untersuchungen zur hellenistischen Historiographie die Vorla-gen des Pompeius Trogus fuumlr die Darstellung der nachalexandrischen hellenistischen Ge-schichte (Iust 13-40) Frankfurt
Santi Amantini L (1972) Fonti e valore storico di Pompeo Trogo (Iustin XXXV e XXXVI) Genova
Santi Amantini L (1981) (a cura di) Giustino Storie Filippiche Epitome da Pom-peo Trogo Milano
Santi Amantini L (2003) Il tempo e i tempi nelle Storie Filippiche di Pompeo Tro-go RSA 33 pp 99-110
Schepens G (1983) Les rois ptolegravemaiumlques et lrsquohistoriographie Reacuteflexions sur la trans-formation de lrsquohistoire politique in E vanrsquot Dack - P van Dessel - W Van Gucht (eds) Egypt and the Hellenistic World Proceedings of the International Collo-quium Leuven 24-26 May 1982 Leuven (Studia Hellenistica 27) pp 351-368
Schlicher JJ (1933) Non-Assertive Elements in the Language of the Roman Histo-rians CPh 28 289-300
Schmitt T (1989) Die Bedeutung des zweiten Punischen Krieges fuumlr den Frieden in Naupaktos in H Devijver - E Lipinski (eds) Punic wars Proceedings of the Conference held in Antwerp from the 23th to the 26th of November 1988 in Cooperation with the Departement of History of the laquoUniversitait Antwerpenraquo UFSIA Leuven (Studia Phoenicia 10) pp 229-239
Scholten JB (2000) The Politics of Plunder Aitolians and their koinon in the early Hellenistic Era Berkeley
144 MONICA DrsquoAGOSTINI
Scuderi R (2005) Filippo V e Perseo nei frammenti diodorei in C Bearzot - F Lan-ducci (a cura di) Diodoro e lrsquoaltra Grecia Macedonia Occidente Ellenismo nella Bi-blioteca Storica Atti del convegno Milano 15-16 gennaio 2004 Milano pp 383-405
Sklenaacuter RJ (2004) Sources and Individuality in Two Passages of Livy laquoHistoriaraquo 53 pp 302-310
Sordi M (1982) Timagene di Alessandria Uno storico ellenocentrico e filobarbaro ANRW II 30 1 pp 775-797
Thornton J (2014) Le guerre macedoniche Roma
Urban R (1979) Wachstum und Kriese des achaumlischen Bundes Quellenstudien zur entwicklung des Bundes von 280 bis 222 V Chr Wiesbaden
Urban R (1982) laquoGallisches Bewusstseinraquo und laquoRomkritikraquo bei Pompeius Trogus ANRW II 30 2 pp 1424-1443
Vannicelli P (1987) Lrsquoeconomia delle Storie di Eforo RFIC 115 pp 165-191
Vattuone R (2014) Giustino e lrsquoOccidente greco I VI-V secolo aC in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 261-277
Vollmer D (1990) Symploke das Uumlbergreifen der roumlmischen Expansion auf den grie-chischen Osten Untersuchungen zur roumlmischen Aussenpolitik am Ende des 3 Jh V Chr Stuttgart
Walbank FW (1957) A Historical Commentary on Polibius I Oxford
Walbank FW (1967) A Historical Commentary on Polybius II Oxford
Walbank FW (1933) Aratos of Sicyon Cambridge
Walbank FW (2002) Η ΤΩΝ ΟΛΩΝ ΕΛΠΙΣ and the Antigonids in FW Walbank (ed) Polybius Rome and the Hellenistic World Essays and Reflections West Nyack NY pp 127-136
Weber G (1997) Interaktion Repraumlsentation und Herrschaft Der Koumlnigshof im Hel-lenismus in A Winterling (hrsg) Zwischen lsquoHausrsquo und lsquoStaatrsquo antike Houmlfe im Ver-gleich Munich pp 27-72
Will E (19822) Histoire politique du Monde Helleacutenistique II Nancy
Zecchini G (1990) La storiografia lagide in H Verdin - G Schepens - E De Keyser (eds) Purposes of History Studies in Greek Historiography from the 4th to the 2nd Centuries BC Proceedings of the International Colloquium of Leuven 24-26 May 1988 Leuven (Studia Hellenistica 30) pp 213-232
Zecchini G (2003) Polibio e la tradizione orale in A Casanova - P Desideri (a cura di) Evento racconto scrittura nellrsquoantichitagrave classica Firenze pp 123-141
Finito di stamparenel mese di novembre 2015
da LegoDigit srlLavis (TN)
128 MONICA DrsquoAGOSTINI
dente presente anche nelle Storie la arricchisce con la vivida immagine di una tempesta di sangue conferendo una dimensione piugrave concreta e cruenta alla predizione infine il riferimento polibiano alle guerre dei Greci nellrsquoEpitome non riguarda piugrave le guerre tra le cittagrave e le leghe gre-che ma le guerre dei Greci con Macedoni Persiani e Galli Mentre la Grecia scompare sullo sfondo la minaccia Romana egrave meno vaga e piugrave concreta e presente che in Polibio e diventa lrsquounico argomento del di-scorso di Filippo V a Naupatto
Il discorso di Demetrio e quello di Filippo sono al centro del libro XXIX dellrsquoEpitome avendo il duplice scopo di evidenziare sia la poten-ziale aggressivitagrave dei Romani sia la grande tradizione militare della Ma-cedonia e il pieno diritto di Filippo di controllare la Grecia e lrsquoIlliria fi-no allrsquoAdriatico Se il discorso in Polibio si inseriva in un dibattito politi-co dove la Grecia e la Macedonia erano protagoniste alla pari della sce-na ellenica e internazionale nella versione che leggiamo in Trogo i ri-ferimenti alle dispute della realtagrave greca sono reinterpretati a favore di un punto di vista in cui la Macedonia egrave lrsquounico potere dellrsquoOriente gre-co Del dibattito politico di III secolo in Grecia che tanto stava a cuore a Polibio non vi egrave piugrave alcuna traccia in TrogoGiustino rimane soltanto lo scontro tra le due grandi potenze di Oriente e Occidente tra Filippo e Roma Questa prospettiva bipolare dei discorsi trogiani si ritrova nel-la conclusione del capitolo che se da un lato sottolinea ancora una vol-ta il timore di Filippo per Cartaginesi e Romani dallrsquoaltro esplicita che i Romani avevano paura dellrsquoantica gloria dei Macedoni laquovincitori dellrsquoO-rienteraquo e soprattutto di Filippo laquoinfiammato dallo zelo di emulare Ales-sandro che era ben noto come pronto alle guerre e instancabileraquo24
41-11 La Prima Guerra Macedonica
Dei prodromi della Prima Guerra Macedonica Giustino si interessa sol-tanto allrsquoalleanza antiromana tra Annibale e Filippo Questo trattato egrave noto da molte fonti secondo cui Filippo dopo aver appreso che i Roma-ni erano stati sconfitti di nuovo dai Cartaginesi a Canne nel 216 avreb-be mandato unrsquoambasceria ad Annibale per proporre unrsquoalleanza ma lrsquoambasciatore macedone sarebbe stato catturato da Roma sulla via del ritorno25
24 Iust XXIX 3 8 quippe terrebat eos et uetus Macedonum deuicti Orientis gloria et Philippus studio Alexandri aemulationis incensus quem promptum in bella industriumque cognouerant Alla gloria dei Macedoni avevamo giagrave trovato riferimento nei discorsi del libro XXVIII degli Etoli (2 12) e di Antigono Dosone (3 14) 25 Secondo Polyb VII 9 17 Filippo avrebbe aiutato Cartagine nella guerra con Roma in cambio di Corcira Epidamno e Apollonia e della restituzione a Demetrio di Faro del suo regno Inoltre Filippo e Annibale si impegnavano a soccorrersi a vicenda in caso di
IL DISCORSO DEL RE 129
A prescindere dai dettagli del fermo dellrsquoambasciatore macedone da parte romana egrave possibile fare qualche osservazione sul nesso tra questo lsquoincidentersquo diplomatico e lo scoppio della guerra Cassio Dione e Ap-piano riportano che la cattura del legato avrebbe causato una vendetta di Filippo contro i protettorati romani in Adriatico in particolare Cor-cira26 notizia assente in Polibio come in Livio e Plutarco (che da Poli-bio dipendono)27 In questi ultimi autori lrsquoattacco di Filippo in Adriati-co infatti non sarebbe legato allrsquoepisodio dellrsquoambasciatore ma alla de-cisione del sovrano di rompere con il consigliere Arato e di dare ascol-to ai cattivi consigli di Demetrio di Faro presa dopo la spedizione a Mes-sene nel 215214 La tradizione polibiana legge infatti in questi eventi la manifestazione del cambiamento dellrsquoindole di Filippo V da giusta a empia iniziata con lrsquoepisodio della stasis di Messene del 215 e compiu-ta con lrsquoassassinio di Arato del 21328 Nel libro XXIX di Giustino ben-cheacute si conservi traccia dellrsquoindole aggressiva di Filippo e del consiglio di Demetrio di Faro come prodromi dello scontro con Roma non vi sono indizi della metaboleacute del sovrano da giusto a empio e malvagio e neppu-re del ruolo che in tale cambiamento ricoprigrave lrsquoallontanamento tra Ara-to e Filippo
attacco da parte di Roma Mentre Peacutedech (1964) pp 382-383 ritiene sicura la consulta-zione a Roma di tali documenti Zecchini (2003) pp 123-141 come prima di lui Walbank (1957) I p 32 n 4 non ne egrave certo poicheacute Polibio viaggiograve proprio per poter reperire documenti e informazioni sugli eventi dove essi avvennero Altre fonti Liv XXIII 38 7 Plut Arat 51 2 Dio C XV 4 2 e App Mak Fr 1 Sul confronto delle fonti vd DrsquoAgostini (2011) pp 99-121 Sul trattato macedone-cartaginese vd Cassola (1962) pp 65-66 Wal-bank (1967) II pp 42-44 Will (19822) pp 83-84 Barreacute (1983) Longaretti (1989) pp 183-192 Golan (1995) pp 45-46 Eckstein (2008) pp 83-85 Intrieri (2011) pp 53-8226 Dio C XV 4 2 e App Mak Fr1 Filippo per vendicarsi della cattura del proprio amba-sciatore non solo attaccograve Corcira ma saputo dellrsquoarrivo di Levino durante la ritirata da Corcira saccheggiograve anche Apollonia e Orico alleate romane Levino avrebbe poi sconfit-to Filippo e recuperati gli alleati costringendo il re a bruciare le proprie navi e rientrare via terra Si riferisce a questo episodio probabilmente il Mak Fr 9 di Appiano che riporta lrsquoordine di Filippo di uccidere quanti erano sulle navi percheacute non dicessero ai Romani che le forze macedoni erano stremate DrsquoAgostini (2011) pp 99-12127 Polyb V 108-110 Liv XXIV 40 e Plut Arat 51 2 non menzionano Corcira nella narra-zione dellrsquoalleanza macedone-cartaginese e della cattura dellrsquoambasciatore Secondo Liv XXIII 38 7 lrsquoambasciatore sarebbe stato trattenuto a Roma 28 Polyb VII 11 8-11 e Plut Arat 49 1 Coppola (1993) pp 205-210 Dai frammenti di Polyb VII 10-12 e dalla narrazione di Plut Arat 49-51 sappiamo che Filippo era interve-nuto nella stasis di Messene tra oligarchici e democratici ma aveva di nascosto lasciato che i cittadini si massacrassero Una volta giunto Arato la guerra civile fu finalmente sedata ma il sovrano avrebbe voluto su consiglio di Demetrio di Faro approfittare della situazione e imporre una guarnigione nellrsquoacropoli della cittagrave che gli avrebbe conferito un vantaggio strategico per il controllo del Peloponneso Arato dissuase Filippo da per-seguire unrsquoazione militare in Peloponneso ma il re decise su consiglio di Demetrio di rivolgere la sua aggressivitagrave verso lrsquoIlliria prima e i protettorati romani Orico e Apollonia poi
130 MONICA DrsquoAGOSTINI
Dopo aver accennato alla stipula del trattato Giustino affastella ne-gli ultimi paragrafi del capitolo 4 gli eventi tra il 215 e il 205 quando Fi-lippo siglando la pace con Roma pone fine alla Prima Guerra Macedo-nica29 In particolare lrsquoEpitomatore sottolinea da un lato lrsquoingresso in guerra degli Etoli al fianco dei Romani e la successiva alleanza del preto-re Levino con Attalo dallrsquoaltro gli attacchi subiti da parte dei Dardani da Filippo oppresso dalle richieste degli Illiri Il libro dunque si chiude con Filippo in difficoltagrave aggravate dalla comparsa di Filopemene il leader degli Achei30 urtatosi con il re dei Macedoni convince la Lega Achea a staccarsi dallrsquoalleanza con la Macedonia sempre piugrave isolata Tale allon-tanamento egrave considerato da Giustino lrsquoesito di un fallito agguato a Fi-lopemene commissionato da Filippo V e dovuto al sospetto di un tradi-mento del condottiero acheo a favore di Roma Bencheacute anche Plutarco (Fil 12 2) e Pausania (VIII 50 4) menzionino il tentativo di assassinio di Filopemene da parte di Filippo la notizia dellrsquoatteggiamento filoroma-no del generale acheo non parrebbe vicino al ritratto polibiano che ve-de in Filopemene un eroe dellrsquoautonomia e dellrsquoindipendenza achea31
Libro XXX11-39 Cinoscefale
Lrsquoesordio del libro XXX introducendo il grande scontro di Cinoscefale tra Romani e Macedoni riprende la celebrazione della gloria macedo-ne argomento centrale dei discorsi del libro XXIX Con lrsquoeccezione dei primi capitoli sul deplorevole comportamento di Tolemeo IV in Egit-to32 il libro egrave infatti totalmente dedicato allo scontro tra le due potenze
29 Errington (2008) pp 185-190 La guerra egrave nota a noi soprattutto dai frammenti dei libri VIII-XI di Polibio dai passi di Liv XXIV 40 1-17 XXVI 24 1-26 4 XXVII 30 5-33 5 e XXVIII 5 1- 9 1 XXIX 12 1-15 e dalla Vita di Filopemene di Plutarco La sinteticitagrave del riassunto giustineo impedisce un puntuale paragone delle tradizioni Ad esempio la notizia dellrsquoalleanza tra Attalo e Roma sembra tornare in Liv XXVIII 5 1-4 dove perograve non troviamo Levino ma Sulpicio come rappresentante romano personaggio scompar-so in Giustino In maniera simile la pace di Fenice del 205 egrave sintetizzata in Giustino in una riga e non vi egrave traccia delle lunghe trattative che coinvolsero come mediatori anche Egitto Chio Mitilene e Atamania portarono a una prima pace separata tra Filippo e gli Etoli nel 206 e poi alla pace con Roma Le fonti parallele sono molto piugrave dettagliate anche su questi eventi Polyb XI 4 1-6 9 Liv XXVIII 5 13 e XXIX 12 8-16 e App Mak fr III Degno di nota egrave perograve il commento in Giustino secondo cui laquoi Romani erano per il momento soddisfatti di aver rinviato la guerra contro la Macedoniaraquo Lrsquointenzione ro-mana di riprendere la guerra con la Macedonia egrave infatti presente in tutte le fonti Polyb XI 6 7 Liv XXIX 1216 Dio C XVIII 9 (15) e App Mak Fr III e verragrave ripresa al libro XXX dellrsquoEpitome 30 Su Filopemene e Filippo vd Errington (1969) pp 51-69 e 83-84 vd anche Golan (1995) pp 115-132 Eckstein (2008) pp 103 e 360-36131 Pelling (1997) pp 135-13932 Lrsquoesordio del libro XXX egrave dedicato alle scabrose imprese del sovrano egiziano ovvero
IL DISCORSO DEL RE 131
dellrsquoEst e dellrsquoOvest La prima avvisaglia dellrsquoincombente guerra egrave la no-tizia dellrsquoaccordo di Filippo V e Antioco III per la spartizione dellrsquoEgitto governato dal sovrano-bambino Tolemeo V Il sovrano lagide nel 2032 chiese aiuto ai Romani che secondo TrogoGiustino gradirono la ri-chiesta drsquoaiuto percheacute cercavano pretesti per muovere guerra contro Fi-lippo A partire da Polibio numerose altre fonti ci testimoniano questo episodio mettendolo in relazione con lo scoppio della Seconda Guerra Macedonica ed esprimendo una condanna morale per lrsquoempia condotta del re antigonide che cospira contro un bambino33 al contrario nellrsquoE-pitome si esalta la potenza macedone evidenziando la paura dei Romani delle grandi imprese di Filippo (XXX 3 2)
nullius magis arma metuebant reputantibus quantum motum Pyrrhus parua Macedo-num manu in Italia fecisset quantasque res Macedones in Oriente gessissent
di nessun altro temevano maggiormente le armi poicheacute ripensavano a quanto sconvolgimento Pirro aveva provocato in Italia con una piccola schiera di Ma-cedoni e a quanto grandi imprese i Macedoni avevano compiuto in Oriente
La supremazia macedone egrave anche al centro del discorso in oratio obliqua di Filippo allrsquoincontro nel Golfo Maliaco tra i rappresentanti dei fronti coinvolti nella Seconda Guerra Macedonica34 NellrsquoEpitome infatti dopo
la Quarta Guerra Siriaca conclusa con sconfitta a Rafia contro Antioco III nel 217 e la corruzione del sovrano da parte di Agatocle e della sorella una cortigiana che avrebbe sedotto il re Giustino riferisce poi la morte del sovrano nel 204 e lrsquoascesa al trono del piccolo Tolemeo V Epifane sovrano sotto tutela di Tlepolemo dopo la morte di Agatocle e Sosibio 33 Eckstein (2008) pp 121-180 Thornton (2014) pp 65-88 In particolare sulla relazione tra il complotto e la sconfitta antigonide e seleucidica ad opera di Roma la superioritagrave morale romana ai regni ellenistici e la causalitagrave storica in Polibio (XV 20 6) vd Eck-stein (2008) pp 133-138 Ager (2009) pp 15-43 Landucci Gattinoni (2011) pp 89-105 Secondo Polyb III 2 8 XV 20 XVI 1 8-9 seguito da Liv XXXI 14 5 Filippo avrebbe ottenuto le basi tolemaiche in Egeo Samo e la Caria mentre Antioco avrebbe finalmente avuto mano libera in Celesiria e Fenicia oggetto di quasi un secolo di lotte tra Tolemei e Seleucidi La notizia del trattato permette a Polibio di dedicare alcuni paragrafi (XV 20) a condannare aspramente lrsquooperato di Filippo V e Antioco III definendoli empi e senza pudore e dichiarando che la Fortuna punigrave i due sovrani per il loro crudele operato por-tando i Romani contro di loro vd infra App Mak Fr IV trasmette delle clausole secondo cui Antioco avrebbe avuto lrsquoEgitto e Cipro mentre Filippo avrebbe ottenuto Cirene le Cicladi e la Ionia Infine secondo Porfirio FGrHist 260 F 45 lrsquoaccordo prevedeva che i due sovrani annettessero i possedimenti tolemaici confinanti con i rispettivi regni 34 Prima si menziona unrsquoambasceria del Senato a Filippo e Antioco percheacute laquosi astenessero dallrsquoEgittoraquo e la visita di Lepido in Egitto Quindi le lamentele a Roma di Attalo e i Rodii nei confronti di Filippo Egrave probabile che a questo punto Trogo inserisse la campagna di Filippo in Asia contro Attalo menzionata nel Prologo XXX ma tagliata nellrsquoEpitome La cronologia degli scambi diplomatici precedenti la Seconda Guerra Macedonica egrave stra-volta dalla sintesi dellrsquoEpitomatore e rende impossibile qualsiasi confronto con le altre
132 MONICA DrsquoAGOSTINI
il riassunto delle ambascerie nel Mediterraneo preludio allo scontro della prima fase della guerra35 maggior spazio egrave dato al tentativo di pa-ce a Nicea tra Roma Attalo i Rodii gli Achei e gli Etoli e Filippo V nel 198 In questa occasione Filippo rivendica la posizione di dominio dei Macedoni sui Greci ereditata da Filippo II e Alessandro suoi antenati e in virtugrave di tale supremazia macedone rifiuta che i Greci gli dettino le condizioni di pace ma chiede che sia il Senato a decidere Egrave significati-vo che non solo il discorso di Filippo non compaia in nessuna delle fon-ti parallele che descrivono nel particolare le posizioni degli ambasciato-ri di Achei Etoli Rodii e Attalo ma che Polibio (XVIII 8 8)36 affermi che era difficile sapere cosa si fossero detti Filippo e Flaminino durante i colloqui nel Golfo Maliaco Secondo la tradizione polibiana infatti il sovrano accompagnato da due philoi macedoni Apollodoro e Demoste-ne chiese di allontanare dalle trattative tutti tranne i Romani e discus-se la pace solamente con Flaminino Successivamente a causa dellrsquoinca-pacitagrave di trovare un accordo Filippo chiese due mesi di tregua e lrsquointer-vento del Senato Trogo dunque restituisce il discorso che il resto della tradizione riteneva impossibile da conoscere indicando chiaramente la presenza di una fonte diversa rispetto a Polibio su questo avvenimento piugrave informata sul punto di vista di Filippo e interessata a evidenziare la convinzione di Filippo V di avere un diritto di supremazia sulla Grecia in virtugrave delle imprese di Filippo II e Alessandro
La battaglia di Cinoscefale nel 197 momento risolutivo dello scontro tra Roma e Macedonia egrave lrsquoevento principale del libro XXX omina e pre-sagi introducono lrsquoevento campale lrsquoeruzione del vulcano di Santorini
fonti In Polyb XVI 24 3 App Mak Fr IV Liv XXXI 1 10 21 5 5 Paus I 36 5-6 vi sono differenti versioni della sequenza delle ambascerie che denunciarono a Roma lrsquoe-spansionismo macedone ma tutte concordano che le ambascerie precedettero lrsquoinvio dei legati romani in Oriente e che esse furono inviate anche da Atene e dagli Etoli Inoltre secondo la tradizione polibiana (Polyb XVI 27 1-4 34 1-7 Liv XXXI 2 3 6 3-8 4 18 1-9 Diod XXVIII 6) vi furono due diverse ambascerie di cui la seconda sarebbe stato un ultimatum al sovrano recapitato da Lepido In occasione di questa seconda ambasceria avvenuta durante il cruento assedio di Abido Filippo avrebbe detto che i Macedoni in ca-so di guerra si sarebbero difesi con valore In Giustino si puograve notare che ancora una volta dagli eventi sono omesse notizie fondamentali sui Greci nello specifico lrsquoambasceria di Atene la cui disputa con gli Acarnani fu il casus belli della guerra contro Filippo 35 Come i prodromi anche la prima parte della Seconda Guerra Macedonica egrave sintetizza-ta in Giustino e occupa solamente due paragrafi Come spesso accade nei passi sintetiz-zati dallrsquoEpitomatore si trovano le incongruenze maggiori con le fonti parallele tra cui si nota soprattutto la completa omissione di Giustino delle campagne di Publio Sulpicio Galba Massimo di Villio delle vittorie di Tito e Lucio Flaminino e dellrsquoassemblea del 198 che portograve gli Achei ad allearsi con Roma Polyb XXII e Liv XXXI 14 1- 46 16 XXXII 1 1-25 12 App Mak Fr VII Plut Fil 17 4 Flam 5 4 e Paus VII 8 1-236 Le trattattive sono descritte con particolari in Polyb XVIII 1-12 seguito da Liv XXXII 32 6-36 10 e Plut Flam 5 8 e 7 1-3
IL DISCORSO DEL RE 133
nel 197 e lrsquoemergere dellrsquoisola di Hiera e in contemporanea il terremo-to a Rodi Quindi nellrsquoEpitome si annuncia che laquoil nascente impero dei Romani avrebbe divorato quello antico dei Greci e dei Macedoni37raquo Nel passo ricevono spazio soprattutto i due discorsi contrapposti del re ma-cedone Filippo e del comandante romano Flaminino pronunciati pri-ma dello scontro campale e costruiti ciascuno in modo da celebrare le imprese delle due potenze38 Lrsquoenfasi data dalla contrapposizione reto-rica delle parole dei generali egrave tale da rendere suggestiva lrsquoipotesi che lo scontro dovesse essere il momento centrale non solo del libro XXX ma forse di tutta lrsquoopera trogiana
Filippo elenca le grandi vittorie del passato dei Macedoni contro Per-siani Battriani Indiani e le popolazioni drsquoAsia fino allrsquoestremo Orien-te esortando i suoi a combattere con valore percheacute laquola libertagrave egrave piugrave cara del predominio39raquo Il discorso di Flaminino egrave invece piugrave lungo articola-to in un paragone tra Macedoni e Romani alle passate imprese di con-quista macedoni vengono contrapposte le piugrave recenti vittorie romane a Cartagine in Sicilia Italia e Spagna alla grandezza di Alessandro Ma-gno egrave contrapposta quella di Annibale che pure dai Romani era stato sconfitto Lrsquoattenzione poi si concentra su Filippo i Macedoni non laquodo-vevano essere valutati per lrsquoantica forza ma per le forze attuali40raquo poicheacute Filippo non era lrsquoinvitto e invincibile Alessandro Magno ma un ragaz-zo che non riusciva a difendere i propri confini I Macedoni rivendica-vano il valore degli antenati mentre i Romani quello dei propri soldati poicheacute quelli che erano ligrave schierati erano gli stessi che avevano sconfitto Annibale Dopo una cosigrave grandiosa introduzione la battaglia egrave descritta in uno dei paragrafi piugrave significativi di tutta lrsquoopera
His adhortationibus utrimque concitati milites proelio concurrunt alteri Orientis alteri Occidentis imperio gloriantes ferentesque in bellum alii maiorum suorum antiquam et ob-soletam gloriam alii uirentem recentibus experimentis uirtutis florem [16] Sed Macedo-nas Romana Fortuna uicit
I soldati incitati da queste esortazioni dallrsquouna e dallrsquoaltra parte si lanciaro-no nel combattimento vantandosi gli uni del dominio dellrsquoOriente gli altri dellrsquoOccidente e recando in guerra gli uni lrsquoantica e sbiadita gloria dei loro an-
37 Iust XXX 4 4 Quo prodigio territis omnibus uates cecinere oriens Romanorum imperium uetus Graecorum ac Macedonum uoraturum38 Sui discorsi precedenti la battaglia nellrsquoantichitagrave se da considerare reali o costruzioni storiografiche vd Adler (2011) pp 6-839 Iust XXX 4 7 tantoque hoc bellum fortius quam illa sustinendum quanto sit imperio libertas carior40 Iust XXX 4 10 Sed nec Macedonas ueteri fama sed praesentibus uiribus aestimandos
134 MONICA DrsquoAGOSTINI
tenati gli altri il fiore del loro valore fresco e vigoroso per le recenti prove Ma la Fortuna dei Romani vinse i Macedoni
Questo punto di vista probabilmente giagrave trogiano contrappone la virtugrave romana (virtutis flos) celebrata nei discorsi antecedenti la battaglia al-la Fortuna romana (Romana Fortuna) che decise la vittoria interpretabi-le come destino favorevole o buona stella Piugrave che unrsquoaffermazione anti-romana41 come egrave spesso stata intesa si puograve evidenziare il carattere sim-patetico della fonte verso Filippo V destinato a porre fine alla gloria di Filippo II e Alessandro e forse un approccio nostalgico verso i grandi regni macedoni la cui egravera egrave ormai giunta alla fine Tale prospettiva egrave as-sente in Polibio e nella tradizione che da lui dipende poco interessata alle vicende della gloria macedone leggendo infatti i frammenti soprav-vissuti del libro XVIII delle Storie dopo lrsquoaccurata descrizione della bat-taglia (18-33 e 34-40)42 Polibio commenta lo scontro affermando che avrebbe dedicato alcuni capitoli allrsquoesame delle strategie militari delle due armate percheacute (XVIII 28 4-6)
χρήσιμον καὶ καλὸν ἂν εἴη τὸ τὴν διαφορὰν ἐρευνῆσαι καὶ παρὰ τί συμβαίνει Ῥωμαίους ἐπικρατεῖν καὶ τὸ πρωτεῖον ἐκφέρεσθαι τῶν κατὰ πόλεμον ἀγώνων [5] ἵνα μὴ τύχην λέγοντες μόνον μακαρίζωμεν τοὺς κρατοῦντας ἀλόγως καθάπερ οἱ μάταιοι τῶν ἀνθρώπων ἀλλ᾽ εἰδότες τὰς ἀληθεῖς αἰτίας ἐπαινῶμεν καὶ θαυμάζωμεν κατὰ λόγον τοὺς ἡγουμένους
Puograve essere cosa buona e utile esaminare le differenze e per quale motivo i Ro-mani prevalgono e riportano il primo premio nelle competizioni di guerra af-fincheacute non esaltiamo i vincitori senza una ragione parlando solo di fortuna co-me fanno gli sciocchi ma conoscendo le vere cause lodiamo e ammiriamo i co-mandanti seguendo una logica
Polibio dunque sembra rispondere a coloro che parlavano della buo-na stella dei Romani sottolineando che la vittoria nasceva dalla superio-re strategia militare della legione43 Un punto di vista quindi opposto a quello espresso nellrsquoEpitome che proprio di Romana Fortuna parla e riba-dito in chiusura al passo dove Polibio critica nuovamente quei Greci che ritenevano la vittoria romana incredibile (XVIII 32 13)
41 Urban (1982) pp 1424-1443 1435 Richter (1987) p 19 n 4 Alonso-Nuacutentildeez (1992) p 66 e Id (2002) pp 105-110 partic 108-109 Contra Heckel (1997) p 29 che ridimen-siona la categorizzazione di Trogo come storico anti-romano 42 Su Cinoscefale vd Walbank (1957) ad l Hammond (1988) pp 60-82 Sklenaacuter (2004) pp 302-310 Thornton (2014) pp 83-87 43 Sulla Fortuna in Polibio vd McGing (2010) pp 195-201 (con bibliografia) che distin-gue tra quando Polibio intenda caso e quando predeterminazione fato Vd anche Green (1990) pp 400-402 e Eckstein (2008) pp 132-138
IL DISCORSO DEL RE 135
Il punto di vista di Trogo sembra invece presente nei frammenti del-la Makedonikeacute di Appiano su Filippo V44 dove ci si riferisce a Cinoscefale come a una vittoria insperata (Mak 9 1)
ἡγούμενος δ᾽ οὔτε Ῥωμαίοις συμφέρειν οὔτε τοῖς Ἕλλησι Φιλίππου καθαιρεθέντος ἐπιπολάσαι τὴν Αἰτωλῶν βίαν τάχα δ᾽ αὐτὸν καὶ τὸ παράδοξον τῆς νίκης ἀγαπᾶν ἐποίει
Flaminino era consapevole che non sarebbe stato vantaggioso per i Romani o per i Greci che Filippo fosse deposto e che il potere etolico rimanesse incon-trastato forse lo aveva reso moderato nei suoi progetti lrsquoaver ottenuto una vit-toria insperata
Addirittura successivamente si accenna alla sorte avversa a Filippo nel-lo scontro
τὰ μὲν δὴ παρὰ τῶν ἄλλων φιλάνθρωπα ἦν τό τε τῆς τύχης ἄδηλον ἐξ ὧν ἔπαθεν ὁ Φίλιππος ὑφορωμένων καὶ τὸ πταῖσμα τοῦτο οὐ κατ᾽ ἀσθένειαν ἀλλὰ πλέον ἐκ συντυχίας αὐτὸν παθεῖν ἡγουμένων
Gli altri (Greci) erano inclini ad essere moderati vedendo con sospetto lrsquoincer-tezza della fortuna subita da Filippo e ritenendo che egli fosse incorso in questa sconfitta non tanto per la sua inferioritagrave quanto per la sfortuna
Il riferimento in Appiano e Trogo alla fortuna romanasfortuna ma-cedone a proposito di Cinoscefale egrave una traccia dellrsquoopinione politi-ca di quei Greci disprezzati da Polibio come uomini sciocchi καθάπερ οἱ μάταιοι τῶν ἀνθρώπων Tale posizione politica su Cinoscefale sarebbe dunque sopravvissuta nella tradizione storiografica di cui troviamo trac-cia in TrogoGiustino e Appiano
Per comprendere meglio alcune caratteristiche di questa tradizione puograve essere utile tornare ai due discorsi nellrsquoEpitome di Filippo e Flamini-no prima della battaglia Tali passi probabilmente trogiani45 non trova-no infatti riscontro nelle fonti parallele a noi pervenute Polibio (XVIII 18-27) seguito fedelmente da Livio (XXXIII 5-10) pur descrivendo le operazioni di guerra di Cinoscefale con dovizia di particolari non men-ziona un discorso di Filippo ai suoi armati prima della battaglia mentre il discorso di Flaminino per incoraggiare le truppe schierate (XVIII 23 2-6) nelle Storie egrave incentrato sulle vittorie di Sulpicio nella prima parte della guerra Pare dunque originale la versione trogiana che incentra-
44 Tra i frammenti consegnatici dagli Excerpta Constantiniana sono frequenti informazio-ni e osservazioni che rimandano a una prospettiva ellenistica sugli eventi DrsquoAgostini (2011) pp 99-121 45 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362
136 MONICA DrsquoAGOSTINI
ta sulla gloria macedone presenta Cinoscefale come il punto drsquoincon-tro e di scambio tra lrsquoegemonia macedone e lrsquoegemonia romana Non egrave una novitagrave che il leitmotiv delle Storie Filippiche e dunque dellrsquoEpitome sia la translatio imperii giagrave Alonso Nuntildeez definito da Santi Amantini laquouno dei piugrave noti esperti di questioni trogiano-giustineeraquo46 osservava che Tro-go esponeva nel suo perduto lavoro la teoria della successione degli im-peri mondiali secondo lo schema Assiria-Media-Persia-Macedonia-Roma osteggiata dai Parti47 In tale successione il ruolo da protagonista egrave rico-perto dallrsquoegemonia macedone48 che occupa allrsquoincirca 26 dei 44 libri e il cui ultimo vero momento di gloria egrave lo scontro con Roma appunto a Cinoscefale Lrsquoultima impresa macedone ha come esito la transizione del dominio universale da Oriente a Occidente e costituisce il tema cen-trale dellrsquointera vicenda di Filippo lrsquoimportanza della battaglia di Cino-scefale egrave perciograve esaltata nei discorsi sia di Filippo che di Flaminino che a loro volta sono il punto di arrivo delle argomentazioni esposte nelle parole di Demetrio di Faro e di Filippo stesso giagrave nel libro XXIX Le ora-tiones disposte retoricamente nei due libri descrivono due parabole op-poste da un lato quella romana che da lontana potenza desiderosa di espandersi cresce come una pioggia di sangue diventando il giovane e vigoroso potere che sottomesso Annibale egrave pronto a sconfiggere Filip-po Dallrsquoaltro quella macedone che originata con Filippo II personag-gio centrale per Trogo raggiunge il suo apice con la conquista dellrsquoege-monia ad opera di Alessandro Magno contro i Persiani per conoscere la fine con Filippo V il cui antico valore egrave ormai troppo lsquosbiaditorsquo per te-ner testa al vigore romano
La gloria macedone secondo Trogo inizia dunque con Filippo II e si conclude con Filippo V Perseo egrave infatti il malvagio responsabile dellrsquoan-nientamento di ciograve che rimaneva della monarchia macedone49 Trogo pone agli estremi della parabola macedone che occupa dal libro IX al XXX i due re di nome Filippo Filippo II e Filippo V come ribadito in piugrave luoghi dellrsquoEpitome sia in parti riassunte da Giustino che in passi piugrave genuinamente trogiani Dando per scontato che il titolo dellrsquoopera Sto-rie Filippiche si debba al desiderio di Trogo di rifarsi allrsquoopera di Teopom-po sul sovrano macedone egrave possibile che tale titolo sia stato perograve ripen-
46 Santi Amantini (2003) pp 99-11047 laquoPompeius Trogus expounded in his lost work the Historiae Philippicae a theory of the world empire suggestion according to the scheme Assyria-Media-Persia-Macedonia-Rome opposed by the Parthiansraquo Alonso-Nuacutentildeez (2002) pp 105-110 e 133-136 partic 105 Vd anche Richter (1987) pp 19-23 Momigliano (1980) pp 157-162 Alonso-Nuacutentildeez (1992) Heckel (1997) pp 1-41 Gabba (2003) pp 7-9 Santi Amantini (2003) pp 99-110 Mariotta (2014) pp 45-56 48 Franco (1993) pp 71-97 e Landucci (2014) pp 233-26149 Alonso-Nuacutentildeez (2002) pp 105-110 partic 108-109
IL DISCORSO DEL RE 137
sato da Trogo considerando che il periodo compreso tra le imprese dei due Filippo occupa 23 dellrsquoopera50 Si potrebbe allora suggerire che le Storie sono Filippiche poicheacute i due Filippo segnarono lrsquoinizio e la fine di quella che egrave nellrsquoopera di Trogo lrsquoegemonia incontrastata del mondo piugrave gloriosa di tutti i tempi51
La prospettiva ellenistica che vede nei due Filippo i limiti della grande egemonia macedone egrave di nuovo presente anche in Appiano nellrsquooraco-lo riportato nei frammenti della sua Makedonikeacute e noto anche da Pausa-nia (VII 8 9)
αὐχοῦντες βασιλεῦσι Μακηδόνες Ἀργεάδῃσιν ὑμῖν κοιρανέων ἀγαθὸν καὶ πῆμα Φίλιππος ἤτοι ὁ μὲν πρότερος πόλεσιν λαοῖσί τ᾽ ἄνακτας θήσει ὁ δ᾽ ὁπλότερος τιμὴν ἀπὸ πᾶσαν ὀλέσσει δμηθεὶς δ᾽ ἑσπερίοισιν ὑπ᾽ ἀνδράσιν ἐνθάδ᾽ ὀλεῖται
O Macedoni che andate orgogliosi dei re di stirpe argiva I re di nome Filippo saranno arbitri del bene e del male per voi Il primo vi renderagrave signori di cittagrave e popoli il secondo vi priveragrave di ogni onore sconfitto da uomini dellrsquoOcciden-te qui giace morto52
Senza voler entrare nel merito della discussione di tale oracolo di nuo-vo pare di incontrare nei due autori la medesima prospettiva lontana dalla condanna morale del re macedone espressa da Polibio secondo cui la sconfitta egrave il giusto esito della sua crudeltagrave ed empietagrave
Il libro giustineo si conclude menzionando le condizioni della pa-ce di Tempe53 e lrsquoira degli Etoli che videro ignorate le proprie richieste da Flaminino e perciograve cercarono lrsquoalleanza di Antioco contro Roma Se-condo il Prologo XXX il libro perograve proseguiva con le campagne di Antio-co III in Asia Minore contro Molone e Acheo e in Battriana fino ad ar-rivare allrsquoesordio dello scontro con Roma54 Il riassunto giustineo egrave trop-po sommario per permettere un confronto con le fonti parallele Egrave pe-
50 Sul rilievo della storia della Macedonia nellrsquoopera di Trogo e Giustino vd von Gutsch-midt (1894) pp 17-217 Richter (1987) p 28 n 29 Franco (1993) pp 71-97 51 Vd anche Urban (1982) pp 1424-1443 e Alonso-Nuacutentildeez (1992) p 58 52 Mak Fr 2 Vd DrsquoAgostini (2011) pp 99-121 In questa Walbank (2002) pp 127-136 propone di interpretare anche un poema di Alceo di Messene (Anth Pal 9518)53 Egrave probabile che Trogo fornisse piugrave particolari riguardo a questa pace per esempio si puograve ritenere che vi fosse menzione dellrsquoinvio a Roma del figlio Demetrio da parte di Filippo come ostaggio dato che a Iust XXXII 2 3 si richiama appunto tale avvenimento54 Polyb XVIII 34 1-39 7 42 1-45 12 Liv XXXIII 11 3-13 15 24 1-31 11 Plut Flam IX 1-8 App Mak Fr IX riferiscono di due diverse trattative di pace caratterizzate da un vivace dibattito tra chi voleva lrsquoannientamento della Macedonia come in Grecia gli Etoli e a Roma Marco Claudio Marcello e coloro che desideravano la pace con la Macedonia in primis Flaminino
138 MONICA DrsquoAGOSTINI
rograve da notare la mancanza sia nel Prologo che nel testo del libro degli av-venimenti delle celebrazioni Istmie del 196 quando Flaminino procla-mograve la libertagrave dei Greci Piugrave in generale in tutta la narrazione di Giustino delle complesse trattative del 197-196 manca qualsiasi riferimento alla li-bertagrave dei Greci punto nodale nella tradizione di Polibio che con questa sottolineatura esalta sia il ruolo tirannico della Macedonia sia la grande generositagrave dei Romani nei confronti della Grecia Il silenzio di TrogoGiustino su tale questione mostra il prevedibile disinteresse per gli affari dei Greci e nel contempo conferma la presenza di una tradizione che si occupa soprattutto della storia delle monarchie ellenistiche allrsquointer-no della quale la posizione dellrsquoEllade egrave subalterna
Libro XXXII23- 34 Demetrio e Perseo
Gli ultimi anni di regno di Filippo tra il 183 e il 179 sono narrati in un passo breve del libro XXXII Il racconto in Giustino che egrave coerente con il Prologo trogiano segue in maniera sintetica la tradizione polibiana su questi eventi giunta a noi in alcuni passi lacunosi di Polibio (XXIII 1 3-3 10 7 1-7 10 1-11 8) integrati dal racconto particolareggiato di Li-vio (XXXIX 46 7- 48 6 53 1-16 XL 3 3-16 3 201-24 8) e dalla narra-zione di Diodoro (XIX 25) e Plutarco (Aem VIII 11)55
Conclusioni
In questi libri dedicati a Filippo egrave forse possibile vedere in filigrana la rielaborazione voluta di Giustino dei corrispondenti libri trogiani Co-me Giustino stesso afferma nella Prefatio 3 lrsquoopera di Trogo era costruita secondo due criteri quello cronologico e quello per laquoconcatenazione di eventi56raquo ea omnia Pompeius diuisa temporibus et serie rerum digesta conposuit
55 Lrsquoutilizzo della tradizione polibiana in Trogo egrave confermato dallrsquoaderenza a Livio (XL 54 1-56 11) e Diodoro (XXIX 28) del racconto sul pentimento di Filippo per aver ucciso il figlio Demetrio lrsquointenzione di punire Perseo e la correlazione tra questo e la sua mor-te Questo libro egrave dunque differente nellrsquointeresse e nelle fonti dai libri XXIX e XXX poicheacute molto vicino alla tradizione polibiana in Livio Questi avvenimenti in Giustino sono da collegare con lrsquoascesa al trono di Perseo e non con lrsquoepilogo della celebrazione del valore macedone giagrave conclusasi in Giustino con Cinoscefale e la transizione dallrsquoim-perium macedone allrsquoimperium romano Vd Heckel (1997) p 7 Appiano invece riporta ancora una tradizione diversa da quella polibiana in un frammento della Makedonikeacute in particolare Appiano egrave attento al punto di vista macedone e presenta Filippo come una vittima delle circostanze (Mak IX) DrsquoAgostini (2011) pp 99-12156 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362 Alonso-Nuacutentildeez (2002) pp 133-136 He-ckel (1997) pp 1-41 Borgna (2014) pp 52-77
IL DISCORSO DEL RE 139
Serie rerum digesta sembrerebbe unrsquointerpretazione latina della formula κατὰ γένος che Diodoro usa per indicare la struttura della storia di Efo-ro sottolineandone la divisione per argomento57 In tale struttura per argomento dellrsquoEpitome tra i temi principali ci sono dunque il valore e la gloria dei sovrani ellenistici58 riscontrabile nei libri XXVIII-XXXI sui re-gni di Antigono Dosone Filippo V e Antioco III Tale tema presente di sicuro in Trogo egrave conservato nellrsquoazione dellrsquoEpitomatore e anzi come si vede dagli escerpta esaltato dalla selezione dei passi
Per quanto riguarda invece la Quellenforschung 59 egrave evidente che nel testo vi sia presenza di filoni non tradizionali sugli eventi poicheacute la posi-zione di Trogo appare spesso autonoma rispetto alle opinioni condivise dalla storiografia antica Questo aspetto dellrsquoEpitome evidente soprattut-to per ciograve che riguarda gli eventi ellenistici ha suscitato la grande curio-sitagrave degli studiosi che allontanatisi dalla proposta di von Gutschmid che voleva una totale ed esclusiva dipendenza di Trogo da Timagene ora in-dicano con sicurezza tra le fonti piugrave rilevanti per gli eventi ellenistici di III secolo utilizzate da Trogo almeno altri sei nomi oltre a Timagene Ie-ronimo Timeo Filarco Duride Polibio e Posidonio
Per quanto riguarda nello specifico la composizione dei libri XXIX e XXX non vi egrave alcun dubbio che in essi Trogo abbia utilizzato (anche riadattandola) una fonte poco attenta alle questioni di politica interna greca e al legame tra queste e quel ritratto di Filippo come sovrano mal-vagio ed empio che ritorna nella tradizione ufficiale di origine polibia-na passando poi da Polibio in Livio Diodoro e Plutarco60 Trogo pre-serva invece una tradizione ellenistica interessata alla figura di Filippo come ultimo barlume della gloria macedone tradizione che pare quasi una controparte e un completamento dellrsquoAb urbe condita romanocentri-ca di Livio Non si puograve perciograve a mio avviso escludere che per questa se-zione Trogo abbia usato una tradizione di matrice filoellenistica o sem-plicemente ellenisticocentrica unrsquoopera sui regni di diadochi ed epigo-ni che a tutti noi fa venire facilmente alla mente il Basileis o Perigrave Basileon dello storico grecoellenistico augusteo filobarbaro scettico (o critico) verso lrsquoegemonia romana Timagene di Alessandria (FGrHist 88)61
57 Su Eforo vd Vannicelli (1987) pp 165-191 e ora Parmeggiani (2011) 58 Simile legame vi egrave a mio avviso tra i libri XXVI e XXVII che invece affrontavano la crisi delle monarchie ellenistiche causata dalle guerre fraterne59 Vd von Gutschmid (1894) pp 17-217 Richter (1987) pp 17-30 partic 20-23 San-ti Amantini (1972) pp 56-109 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362 Urban (1982) pp 1424-1443 partic 1435 Mecca (2001) pp 199-222 Santi Amantini (2003) pp 99-110 Heckel (2012) pp 3-860 Scuderi (2005) pp 383-40561 Sordi (1982) pp 775-797 Heckel (1997) pp 30-34 Landucci (2014) pp 233-261 e Ead in questo volume
140 MONICA DrsquoAGOSTINI
ABSTRACT
Philip V of Macedon was the first of the Epigonoi to face Rome Several mod-ern reconstructions of the actions and the reign of Philip V have approached it largely from a Roman point of view using as sources Polybius and where Poly-bius is lost Livy The Polybian historiographical tradition tends to portray Phil-ip V as an enemy and a tyrant impious and cruel The Macedonian king was ea-ger to establish a universal and unjust dominion over Greece Italy and beyond and Rome engaged in the first two Macedonian Wars to fight the threat of his growing ambition Nevertheless Polybiusrsquo portrayal of Philip V was affected not only by Polybiusrsquo admiration for Roman political structures military power and overwhelming conquest but also his personal Achaean origins
Looking at in book 29 and 30 of Justinrsquos Epitome of Pompeius Trogus this pa-per focuses on the non Polybian tradition on Philip V this contribution is in-deed the first analysis of the Hellenistic approach to the clash between Rome and Macedonia in the 3rd-2nd Century BC The Epitome shows a considerable di-versity of interpretation from the other sources and reflects very different views of Philip Vrsquos actions that brought him into conflict against Rome In particular these views are more evident related to the accounts of the peace negotiations of Naupactus and the battle of Cynoscephalae in the Epitome the king appears as a courageous and skilled warrior the last of the great Macedonian rulers who fell victim to misfortune This portrayal which has several common features with Appianrsquos fragments of Philip V (Mak 9) counterbalances the Roman and Achaean standpoint present in Polybius providing a more Hellenistic perspec-tive that is likely to have been rooted in a historiographical tradition connect-ed to the losing side in the struggle between Rome and the Hellenistic world
BIBLIOGRAFIA
Adler E (2006) Whorsquos Antiroman Sallust and Pompeius Trogus on Mithridates CJ 101 pp 383-407
Adler E (2011) Valorizing the Barbarians Enemy speeches in Roman Historiography Austin
Ager SL (2003) An Uneasy Balance from the Death of Seleukos to the Battle of Raph-ia in A Erskine (ed) A Companion to the Hellenistic World Oxford pp 35-50
Ager SL (2009) Roman Perspectives on Greek Diplomacy The conceptual clash Greek diplomacy of compromise and Roman Bellum Iustum in C Eilers (ed) Diplomats and Diplomacy in the Roman World Leiden-Boston pp 15-43
Alonso-Nuacutentildeez JM (1992) La Historia Universal de Pompeyo Trogo Madrid
Alonso-Nuacutentildeez JM (2002) The Idea of Universal History in Greece From Herodotus to the Age of Augustus Amsterdam
Ballesteros Pastor L (2013) Pompeyo Trogo Justino y Mitriacutedates Comentario al Epiacutetome de las Historias Filiacutepicas (3716-3881) Hildesheim-Zuumlrich-New York
IL DISCORSO DEL RE 141
Barreacute ML (1983) The God-List in the Treaty between Hannibal and Philip V of Ma-cedon a Study in Light of the Ancient Near Eastern Treaty Tradition Baltimore-Lon-don
Beck H - Eckstein A (2015) sv ldquoAratos of Sicyon (231)rdquo in I Worthington (ed) Brillrsquos New Jacoby Brill Online
Borgna A (2014) Uno sguardo originale intorno a Roma Pompeo Trogo e Giustino laquoLa Biblioteca di ClassicoContemporaneoraquo 1 pp 52-77
Cassola F (1962) I gruppi politici romani nel III secolo aC Trieste
Champion CB (1997) The Nature of Authoritative Evidence in Polybios and Agelausrsquo Speech at Naupactos TAPhA 127 pp 111-128
Champion CB (2004) Cultural Politics in Polybiusrsquo Histories Berkeley
Coppola A (1993) Demetrio di Faro un protagonista dimenticato Roma
Criscuolo L (2011) I due testamenti di Tolemeo VIII Evergete II in A Joumlrdens - J F Quack (hrsg) Aumlgypten zwischen innerem Zwist und aumluszligerem Druck Die Zeit Ptole-maios VI bis VIII Wiesbaden pp 132-150
DrsquoAgostini M (2011) Filippo V e la Storia Romana di Appiano laquoAevumraquo 85 pp 99-121
Eckstein AM (1995) Moral vision in the Histories of Polybius Berkeley
Eckstein AM (2008) Rome enters in the Greek East From Anarchy to Hierarchy in the Hellenistic Mediterranean 230-217 BC Oxford
Eckstein AM (2013) Polybius Phylarchus and Historiographical Criticism CPh 108 4 pp 314-338
Errington RM (1969) Philopoemen Oxford
Errington RM (2008) A History of the Hellenistic World 323-30 BC Malden MA-Oxford
Forni G - Angeli Bertinelli MG (1982) Pompeo Trogo come fonte di storia ANRW II 30 2 pp 1298-1362
Franco C (1993) Trogo Giustino e i successori di Alessandro in L Braccesi - A Coppola - G Cresci Marrone - C Franco (a cura di) LrsquoAlessandro di Giustino dagli antichi ai moderni Roma pp 71-97
Gabba E (2003) Introduzione in D Foraboschi - SM Pizzetti (a cura di) La successione degli imperi e delle egemonie nelle relazioni internazionali Milano pp 7-9
Golan D (1995) The Res Graeciae in Polybius Four Studies Como
Green P (1990) Alexander to Actium The Historical Evolution of the Hellenistic Age Berkeley-Los Angeles
Gutschmid von A (1894) Die beiden ersten Buumlcher des Pompeius Trogus in A von Gutschmid - F Ruumlhl (hrsg) Kleine Schriften Leipzig pp 17-217
142 MONICA DrsquoAGOSTINI
Habicht C (1995) Athen Muumlnchen
Hammond NGL (1968) Illyris Rome and Macedon in 229-205 BC JRS 58 pp 1-21
Hammond NGL (1988) The Campaign and the Battle of Cynoscephalae in 197 BC JHS 108 pp 60-82
Heckel W (1997) Introduction (Part 2) in JC Yardley - W Heckel (eds) Ju-stin Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus Books 11-12 Alexander the Great Introduction Oxford pp 1-41
Heckel W (2012) Introduction in JC Yardley - P Wheatley - W Heckel (eds) Justin Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus II Books 13-15 The Successors to Alexander the Great Oxford pp 1-8
Huss W (1976) Untersuchungen zur Auszligenpolitik Ptolemaiosrsquo IV Muumlnchen
Huss W (2001) Aumlgypten in hellenistischer Zeit 332ndash30 v Chr Muumlnchen
Intrieri M (2011) Fra dialogo e conflitto Annibale e i Greci drsquoOccidente RStudFen 37 pp 53-82
Landucci F (2014) Filippo II e le Storie Filippiche un protagonista storico e storio-grafico in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 233-261
Landucci Gattinoni F (2011) Politica e ideologia in etagrave ellenistica laquoPolitica An-ticaraquo 1 pp 89-105
Leacutevy E (1994) Le discours drsquoAgeacutelaos de Naupacte in L Aigner Foresti - A Bar-zanograve - C Bearzot - L Prandi - G Zecchini (a cura di) Federazioni e federalismo nellrsquoEuropa antica Bergamo 21-25 settembre 1992 Milano (Alle radici della casa co-mune europea 1) pp 33-50
Longaretti L (1989) Lrsquoalleanza tra Annibale e Filippo V di Macedonia RIL 123 pp 183-192
Marasco G (1979-1980) La valutazione di Tolemeo IV Filopatore nella storiografia greca laquoSilenoraquo 5-6 pp 159-182
Mari M [- Musti D - Thornton J] (2002) Polibio Storie Volume III Libri V-VI Milano
Mariotta G (2014) Geografia e Geopolitica nelle Storie Filippiche in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 45-56
McGing B (2010) Polybiusrsquo Histories New York
McGing B (2013) Youthfulness in Polybius the case of Philip V of Macedon in B Gibson - T Harrison (eds) Polybius and his world Oxford pp 181-199
Meadows A (2013) Polybius Aratus and the History of the 140th Olympiad in B
IL DISCORSO DEL RE 143
Gibson - T Harrison (eds) Polybius and his World Essays in Honour of Frank Walbank Oxford pp 91-116
Mecca A (2001) Trogo Timagene e Polieno QS 54 pp 199-222
Meister K (1990) Die Griechische Geschichtsschreibung von den Anfaumlngen bis zum Ende des Hellenismus Stuttgart
Misch G (1949) Geschichte der Autobiographie I Frankfurt am Mein
Momigliano A (1980) Daniele e la teoria greca della successione degli imperi RAL 35 pp 157-162
Muccioli F (2013) Gli epiteti ufficiali dei re ellenistici Stuttgart (Historia Einzel-schriften 224)
Musti D (1978) Polibio e lrsquoimperialismo romano Napoli
Parmeggiani G (2011) Eforo di Cuma studi di storiografia greca Bologna
Peacutedech P (1964) La meacutethode historique de Polybe Paris
Pelling CBR [- Scardigli B - Manfredini M](1997) Plutarco Vite parallele Filopemene Tito Flaminino Milano
Richter H-D (1987) Untersuchungen zur hellenistischen Historiographie die Vorla-gen des Pompeius Trogus fuumlr die Darstellung der nachalexandrischen hellenistischen Ge-schichte (Iust 13-40) Frankfurt
Santi Amantini L (1972) Fonti e valore storico di Pompeo Trogo (Iustin XXXV e XXXVI) Genova
Santi Amantini L (1981) (a cura di) Giustino Storie Filippiche Epitome da Pom-peo Trogo Milano
Santi Amantini L (2003) Il tempo e i tempi nelle Storie Filippiche di Pompeo Tro-go RSA 33 pp 99-110
Schepens G (1983) Les rois ptolegravemaiumlques et lrsquohistoriographie Reacuteflexions sur la trans-formation de lrsquohistoire politique in E vanrsquot Dack - P van Dessel - W Van Gucht (eds) Egypt and the Hellenistic World Proceedings of the International Collo-quium Leuven 24-26 May 1982 Leuven (Studia Hellenistica 27) pp 351-368
Schlicher JJ (1933) Non-Assertive Elements in the Language of the Roman Histo-rians CPh 28 289-300
Schmitt T (1989) Die Bedeutung des zweiten Punischen Krieges fuumlr den Frieden in Naupaktos in H Devijver - E Lipinski (eds) Punic wars Proceedings of the Conference held in Antwerp from the 23th to the 26th of November 1988 in Cooperation with the Departement of History of the laquoUniversitait Antwerpenraquo UFSIA Leuven (Studia Phoenicia 10) pp 229-239
Scholten JB (2000) The Politics of Plunder Aitolians and their koinon in the early Hellenistic Era Berkeley
144 MONICA DrsquoAGOSTINI
Scuderi R (2005) Filippo V e Perseo nei frammenti diodorei in C Bearzot - F Lan-ducci (a cura di) Diodoro e lrsquoaltra Grecia Macedonia Occidente Ellenismo nella Bi-blioteca Storica Atti del convegno Milano 15-16 gennaio 2004 Milano pp 383-405
Sklenaacuter RJ (2004) Sources and Individuality in Two Passages of Livy laquoHistoriaraquo 53 pp 302-310
Sordi M (1982) Timagene di Alessandria Uno storico ellenocentrico e filobarbaro ANRW II 30 1 pp 775-797
Thornton J (2014) Le guerre macedoniche Roma
Urban R (1979) Wachstum und Kriese des achaumlischen Bundes Quellenstudien zur entwicklung des Bundes von 280 bis 222 V Chr Wiesbaden
Urban R (1982) laquoGallisches Bewusstseinraquo und laquoRomkritikraquo bei Pompeius Trogus ANRW II 30 2 pp 1424-1443
Vannicelli P (1987) Lrsquoeconomia delle Storie di Eforo RFIC 115 pp 165-191
Vattuone R (2014) Giustino e lrsquoOccidente greco I VI-V secolo aC in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 261-277
Vollmer D (1990) Symploke das Uumlbergreifen der roumlmischen Expansion auf den grie-chischen Osten Untersuchungen zur roumlmischen Aussenpolitik am Ende des 3 Jh V Chr Stuttgart
Walbank FW (1957) A Historical Commentary on Polibius I Oxford
Walbank FW (1967) A Historical Commentary on Polybius II Oxford
Walbank FW (1933) Aratos of Sicyon Cambridge
Walbank FW (2002) Η ΤΩΝ ΟΛΩΝ ΕΛΠΙΣ and the Antigonids in FW Walbank (ed) Polybius Rome and the Hellenistic World Essays and Reflections West Nyack NY pp 127-136
Weber G (1997) Interaktion Repraumlsentation und Herrschaft Der Koumlnigshof im Hel-lenismus in A Winterling (hrsg) Zwischen lsquoHausrsquo und lsquoStaatrsquo antike Houmlfe im Ver-gleich Munich pp 27-72
Will E (19822) Histoire politique du Monde Helleacutenistique II Nancy
Zecchini G (1990) La storiografia lagide in H Verdin - G Schepens - E De Keyser (eds) Purposes of History Studies in Greek Historiography from the 4th to the 2nd Centuries BC Proceedings of the International Colloquium of Leuven 24-26 May 1988 Leuven (Studia Hellenistica 30) pp 213-232
Zecchini G (2003) Polibio e la tradizione orale in A Casanova - P Desideri (a cura di) Evento racconto scrittura nellrsquoantichitagrave classica Firenze pp 123-141
Finito di stamparenel mese di novembre 2015
da LegoDigit srlLavis (TN)
IL DISCORSO DEL RE 129
A prescindere dai dettagli del fermo dellrsquoambasciatore macedone da parte romana egrave possibile fare qualche osservazione sul nesso tra questo lsquoincidentersquo diplomatico e lo scoppio della guerra Cassio Dione e Ap-piano riportano che la cattura del legato avrebbe causato una vendetta di Filippo contro i protettorati romani in Adriatico in particolare Cor-cira26 notizia assente in Polibio come in Livio e Plutarco (che da Poli-bio dipendono)27 In questi ultimi autori lrsquoattacco di Filippo in Adriati-co infatti non sarebbe legato allrsquoepisodio dellrsquoambasciatore ma alla de-cisione del sovrano di rompere con il consigliere Arato e di dare ascol-to ai cattivi consigli di Demetrio di Faro presa dopo la spedizione a Mes-sene nel 215214 La tradizione polibiana legge infatti in questi eventi la manifestazione del cambiamento dellrsquoindole di Filippo V da giusta a empia iniziata con lrsquoepisodio della stasis di Messene del 215 e compiu-ta con lrsquoassassinio di Arato del 21328 Nel libro XXIX di Giustino ben-cheacute si conservi traccia dellrsquoindole aggressiva di Filippo e del consiglio di Demetrio di Faro come prodromi dello scontro con Roma non vi sono indizi della metaboleacute del sovrano da giusto a empio e malvagio e neppu-re del ruolo che in tale cambiamento ricoprigrave lrsquoallontanamento tra Ara-to e Filippo
attacco da parte di Roma Mentre Peacutedech (1964) pp 382-383 ritiene sicura la consulta-zione a Roma di tali documenti Zecchini (2003) pp 123-141 come prima di lui Walbank (1957) I p 32 n 4 non ne egrave certo poicheacute Polibio viaggiograve proprio per poter reperire documenti e informazioni sugli eventi dove essi avvennero Altre fonti Liv XXIII 38 7 Plut Arat 51 2 Dio C XV 4 2 e App Mak Fr 1 Sul confronto delle fonti vd DrsquoAgostini (2011) pp 99-121 Sul trattato macedone-cartaginese vd Cassola (1962) pp 65-66 Wal-bank (1967) II pp 42-44 Will (19822) pp 83-84 Barreacute (1983) Longaretti (1989) pp 183-192 Golan (1995) pp 45-46 Eckstein (2008) pp 83-85 Intrieri (2011) pp 53-8226 Dio C XV 4 2 e App Mak Fr1 Filippo per vendicarsi della cattura del proprio amba-sciatore non solo attaccograve Corcira ma saputo dellrsquoarrivo di Levino durante la ritirata da Corcira saccheggiograve anche Apollonia e Orico alleate romane Levino avrebbe poi sconfit-to Filippo e recuperati gli alleati costringendo il re a bruciare le proprie navi e rientrare via terra Si riferisce a questo episodio probabilmente il Mak Fr 9 di Appiano che riporta lrsquoordine di Filippo di uccidere quanti erano sulle navi percheacute non dicessero ai Romani che le forze macedoni erano stremate DrsquoAgostini (2011) pp 99-12127 Polyb V 108-110 Liv XXIV 40 e Plut Arat 51 2 non menzionano Corcira nella narra-zione dellrsquoalleanza macedone-cartaginese e della cattura dellrsquoambasciatore Secondo Liv XXIII 38 7 lrsquoambasciatore sarebbe stato trattenuto a Roma 28 Polyb VII 11 8-11 e Plut Arat 49 1 Coppola (1993) pp 205-210 Dai frammenti di Polyb VII 10-12 e dalla narrazione di Plut Arat 49-51 sappiamo che Filippo era interve-nuto nella stasis di Messene tra oligarchici e democratici ma aveva di nascosto lasciato che i cittadini si massacrassero Una volta giunto Arato la guerra civile fu finalmente sedata ma il sovrano avrebbe voluto su consiglio di Demetrio di Faro approfittare della situazione e imporre una guarnigione nellrsquoacropoli della cittagrave che gli avrebbe conferito un vantaggio strategico per il controllo del Peloponneso Arato dissuase Filippo da per-seguire unrsquoazione militare in Peloponneso ma il re decise su consiglio di Demetrio di rivolgere la sua aggressivitagrave verso lrsquoIlliria prima e i protettorati romani Orico e Apollonia poi
130 MONICA DrsquoAGOSTINI
Dopo aver accennato alla stipula del trattato Giustino affastella ne-gli ultimi paragrafi del capitolo 4 gli eventi tra il 215 e il 205 quando Fi-lippo siglando la pace con Roma pone fine alla Prima Guerra Macedo-nica29 In particolare lrsquoEpitomatore sottolinea da un lato lrsquoingresso in guerra degli Etoli al fianco dei Romani e la successiva alleanza del preto-re Levino con Attalo dallrsquoaltro gli attacchi subiti da parte dei Dardani da Filippo oppresso dalle richieste degli Illiri Il libro dunque si chiude con Filippo in difficoltagrave aggravate dalla comparsa di Filopemene il leader degli Achei30 urtatosi con il re dei Macedoni convince la Lega Achea a staccarsi dallrsquoalleanza con la Macedonia sempre piugrave isolata Tale allon-tanamento egrave considerato da Giustino lrsquoesito di un fallito agguato a Fi-lopemene commissionato da Filippo V e dovuto al sospetto di un tradi-mento del condottiero acheo a favore di Roma Bencheacute anche Plutarco (Fil 12 2) e Pausania (VIII 50 4) menzionino il tentativo di assassinio di Filopemene da parte di Filippo la notizia dellrsquoatteggiamento filoroma-no del generale acheo non parrebbe vicino al ritratto polibiano che ve-de in Filopemene un eroe dellrsquoautonomia e dellrsquoindipendenza achea31
Libro XXX11-39 Cinoscefale
Lrsquoesordio del libro XXX introducendo il grande scontro di Cinoscefale tra Romani e Macedoni riprende la celebrazione della gloria macedo-ne argomento centrale dei discorsi del libro XXIX Con lrsquoeccezione dei primi capitoli sul deplorevole comportamento di Tolemeo IV in Egit-to32 il libro egrave infatti totalmente dedicato allo scontro tra le due potenze
29 Errington (2008) pp 185-190 La guerra egrave nota a noi soprattutto dai frammenti dei libri VIII-XI di Polibio dai passi di Liv XXIV 40 1-17 XXVI 24 1-26 4 XXVII 30 5-33 5 e XXVIII 5 1- 9 1 XXIX 12 1-15 e dalla Vita di Filopemene di Plutarco La sinteticitagrave del riassunto giustineo impedisce un puntuale paragone delle tradizioni Ad esempio la notizia dellrsquoalleanza tra Attalo e Roma sembra tornare in Liv XXVIII 5 1-4 dove perograve non troviamo Levino ma Sulpicio come rappresentante romano personaggio scompar-so in Giustino In maniera simile la pace di Fenice del 205 egrave sintetizzata in Giustino in una riga e non vi egrave traccia delle lunghe trattative che coinvolsero come mediatori anche Egitto Chio Mitilene e Atamania portarono a una prima pace separata tra Filippo e gli Etoli nel 206 e poi alla pace con Roma Le fonti parallele sono molto piugrave dettagliate anche su questi eventi Polyb XI 4 1-6 9 Liv XXVIII 5 13 e XXIX 12 8-16 e App Mak fr III Degno di nota egrave perograve il commento in Giustino secondo cui laquoi Romani erano per il momento soddisfatti di aver rinviato la guerra contro la Macedoniaraquo Lrsquointenzione ro-mana di riprendere la guerra con la Macedonia egrave infatti presente in tutte le fonti Polyb XI 6 7 Liv XXIX 1216 Dio C XVIII 9 (15) e App Mak Fr III e verragrave ripresa al libro XXX dellrsquoEpitome 30 Su Filopemene e Filippo vd Errington (1969) pp 51-69 e 83-84 vd anche Golan (1995) pp 115-132 Eckstein (2008) pp 103 e 360-36131 Pelling (1997) pp 135-13932 Lrsquoesordio del libro XXX egrave dedicato alle scabrose imprese del sovrano egiziano ovvero
IL DISCORSO DEL RE 131
dellrsquoEst e dellrsquoOvest La prima avvisaglia dellrsquoincombente guerra egrave la no-tizia dellrsquoaccordo di Filippo V e Antioco III per la spartizione dellrsquoEgitto governato dal sovrano-bambino Tolemeo V Il sovrano lagide nel 2032 chiese aiuto ai Romani che secondo TrogoGiustino gradirono la ri-chiesta drsquoaiuto percheacute cercavano pretesti per muovere guerra contro Fi-lippo A partire da Polibio numerose altre fonti ci testimoniano questo episodio mettendolo in relazione con lo scoppio della Seconda Guerra Macedonica ed esprimendo una condanna morale per lrsquoempia condotta del re antigonide che cospira contro un bambino33 al contrario nellrsquoE-pitome si esalta la potenza macedone evidenziando la paura dei Romani delle grandi imprese di Filippo (XXX 3 2)
nullius magis arma metuebant reputantibus quantum motum Pyrrhus parua Macedo-num manu in Italia fecisset quantasque res Macedones in Oriente gessissent
di nessun altro temevano maggiormente le armi poicheacute ripensavano a quanto sconvolgimento Pirro aveva provocato in Italia con una piccola schiera di Ma-cedoni e a quanto grandi imprese i Macedoni avevano compiuto in Oriente
La supremazia macedone egrave anche al centro del discorso in oratio obliqua di Filippo allrsquoincontro nel Golfo Maliaco tra i rappresentanti dei fronti coinvolti nella Seconda Guerra Macedonica34 NellrsquoEpitome infatti dopo
la Quarta Guerra Siriaca conclusa con sconfitta a Rafia contro Antioco III nel 217 e la corruzione del sovrano da parte di Agatocle e della sorella una cortigiana che avrebbe sedotto il re Giustino riferisce poi la morte del sovrano nel 204 e lrsquoascesa al trono del piccolo Tolemeo V Epifane sovrano sotto tutela di Tlepolemo dopo la morte di Agatocle e Sosibio 33 Eckstein (2008) pp 121-180 Thornton (2014) pp 65-88 In particolare sulla relazione tra il complotto e la sconfitta antigonide e seleucidica ad opera di Roma la superioritagrave morale romana ai regni ellenistici e la causalitagrave storica in Polibio (XV 20 6) vd Eck-stein (2008) pp 133-138 Ager (2009) pp 15-43 Landucci Gattinoni (2011) pp 89-105 Secondo Polyb III 2 8 XV 20 XVI 1 8-9 seguito da Liv XXXI 14 5 Filippo avrebbe ottenuto le basi tolemaiche in Egeo Samo e la Caria mentre Antioco avrebbe finalmente avuto mano libera in Celesiria e Fenicia oggetto di quasi un secolo di lotte tra Tolemei e Seleucidi La notizia del trattato permette a Polibio di dedicare alcuni paragrafi (XV 20) a condannare aspramente lrsquooperato di Filippo V e Antioco III definendoli empi e senza pudore e dichiarando che la Fortuna punigrave i due sovrani per il loro crudele operato por-tando i Romani contro di loro vd infra App Mak Fr IV trasmette delle clausole secondo cui Antioco avrebbe avuto lrsquoEgitto e Cipro mentre Filippo avrebbe ottenuto Cirene le Cicladi e la Ionia Infine secondo Porfirio FGrHist 260 F 45 lrsquoaccordo prevedeva che i due sovrani annettessero i possedimenti tolemaici confinanti con i rispettivi regni 34 Prima si menziona unrsquoambasceria del Senato a Filippo e Antioco percheacute laquosi astenessero dallrsquoEgittoraquo e la visita di Lepido in Egitto Quindi le lamentele a Roma di Attalo e i Rodii nei confronti di Filippo Egrave probabile che a questo punto Trogo inserisse la campagna di Filippo in Asia contro Attalo menzionata nel Prologo XXX ma tagliata nellrsquoEpitome La cronologia degli scambi diplomatici precedenti la Seconda Guerra Macedonica egrave stra-volta dalla sintesi dellrsquoEpitomatore e rende impossibile qualsiasi confronto con le altre
132 MONICA DrsquoAGOSTINI
il riassunto delle ambascerie nel Mediterraneo preludio allo scontro della prima fase della guerra35 maggior spazio egrave dato al tentativo di pa-ce a Nicea tra Roma Attalo i Rodii gli Achei e gli Etoli e Filippo V nel 198 In questa occasione Filippo rivendica la posizione di dominio dei Macedoni sui Greci ereditata da Filippo II e Alessandro suoi antenati e in virtugrave di tale supremazia macedone rifiuta che i Greci gli dettino le condizioni di pace ma chiede che sia il Senato a decidere Egrave significati-vo che non solo il discorso di Filippo non compaia in nessuna delle fon-ti parallele che descrivono nel particolare le posizioni degli ambasciato-ri di Achei Etoli Rodii e Attalo ma che Polibio (XVIII 8 8)36 affermi che era difficile sapere cosa si fossero detti Filippo e Flaminino durante i colloqui nel Golfo Maliaco Secondo la tradizione polibiana infatti il sovrano accompagnato da due philoi macedoni Apollodoro e Demoste-ne chiese di allontanare dalle trattative tutti tranne i Romani e discus-se la pace solamente con Flaminino Successivamente a causa dellrsquoinca-pacitagrave di trovare un accordo Filippo chiese due mesi di tregua e lrsquointer-vento del Senato Trogo dunque restituisce il discorso che il resto della tradizione riteneva impossibile da conoscere indicando chiaramente la presenza di una fonte diversa rispetto a Polibio su questo avvenimento piugrave informata sul punto di vista di Filippo e interessata a evidenziare la convinzione di Filippo V di avere un diritto di supremazia sulla Grecia in virtugrave delle imprese di Filippo II e Alessandro
La battaglia di Cinoscefale nel 197 momento risolutivo dello scontro tra Roma e Macedonia egrave lrsquoevento principale del libro XXX omina e pre-sagi introducono lrsquoevento campale lrsquoeruzione del vulcano di Santorini
fonti In Polyb XVI 24 3 App Mak Fr IV Liv XXXI 1 10 21 5 5 Paus I 36 5-6 vi sono differenti versioni della sequenza delle ambascerie che denunciarono a Roma lrsquoe-spansionismo macedone ma tutte concordano che le ambascerie precedettero lrsquoinvio dei legati romani in Oriente e che esse furono inviate anche da Atene e dagli Etoli Inoltre secondo la tradizione polibiana (Polyb XVI 27 1-4 34 1-7 Liv XXXI 2 3 6 3-8 4 18 1-9 Diod XXVIII 6) vi furono due diverse ambascerie di cui la seconda sarebbe stato un ultimatum al sovrano recapitato da Lepido In occasione di questa seconda ambasceria avvenuta durante il cruento assedio di Abido Filippo avrebbe detto che i Macedoni in ca-so di guerra si sarebbero difesi con valore In Giustino si puograve notare che ancora una volta dagli eventi sono omesse notizie fondamentali sui Greci nello specifico lrsquoambasceria di Atene la cui disputa con gli Acarnani fu il casus belli della guerra contro Filippo 35 Come i prodromi anche la prima parte della Seconda Guerra Macedonica egrave sintetizza-ta in Giustino e occupa solamente due paragrafi Come spesso accade nei passi sintetiz-zati dallrsquoEpitomatore si trovano le incongruenze maggiori con le fonti parallele tra cui si nota soprattutto la completa omissione di Giustino delle campagne di Publio Sulpicio Galba Massimo di Villio delle vittorie di Tito e Lucio Flaminino e dellrsquoassemblea del 198 che portograve gli Achei ad allearsi con Roma Polyb XXII e Liv XXXI 14 1- 46 16 XXXII 1 1-25 12 App Mak Fr VII Plut Fil 17 4 Flam 5 4 e Paus VII 8 1-236 Le trattattive sono descritte con particolari in Polyb XVIII 1-12 seguito da Liv XXXII 32 6-36 10 e Plut Flam 5 8 e 7 1-3
IL DISCORSO DEL RE 133
nel 197 e lrsquoemergere dellrsquoisola di Hiera e in contemporanea il terremo-to a Rodi Quindi nellrsquoEpitome si annuncia che laquoil nascente impero dei Romani avrebbe divorato quello antico dei Greci e dei Macedoni37raquo Nel passo ricevono spazio soprattutto i due discorsi contrapposti del re ma-cedone Filippo e del comandante romano Flaminino pronunciati pri-ma dello scontro campale e costruiti ciascuno in modo da celebrare le imprese delle due potenze38 Lrsquoenfasi data dalla contrapposizione reto-rica delle parole dei generali egrave tale da rendere suggestiva lrsquoipotesi che lo scontro dovesse essere il momento centrale non solo del libro XXX ma forse di tutta lrsquoopera trogiana
Filippo elenca le grandi vittorie del passato dei Macedoni contro Per-siani Battriani Indiani e le popolazioni drsquoAsia fino allrsquoestremo Orien-te esortando i suoi a combattere con valore percheacute laquola libertagrave egrave piugrave cara del predominio39raquo Il discorso di Flaminino egrave invece piugrave lungo articola-to in un paragone tra Macedoni e Romani alle passate imprese di con-quista macedoni vengono contrapposte le piugrave recenti vittorie romane a Cartagine in Sicilia Italia e Spagna alla grandezza di Alessandro Ma-gno egrave contrapposta quella di Annibale che pure dai Romani era stato sconfitto Lrsquoattenzione poi si concentra su Filippo i Macedoni non laquodo-vevano essere valutati per lrsquoantica forza ma per le forze attuali40raquo poicheacute Filippo non era lrsquoinvitto e invincibile Alessandro Magno ma un ragaz-zo che non riusciva a difendere i propri confini I Macedoni rivendica-vano il valore degli antenati mentre i Romani quello dei propri soldati poicheacute quelli che erano ligrave schierati erano gli stessi che avevano sconfitto Annibale Dopo una cosigrave grandiosa introduzione la battaglia egrave descritta in uno dei paragrafi piugrave significativi di tutta lrsquoopera
His adhortationibus utrimque concitati milites proelio concurrunt alteri Orientis alteri Occidentis imperio gloriantes ferentesque in bellum alii maiorum suorum antiquam et ob-soletam gloriam alii uirentem recentibus experimentis uirtutis florem [16] Sed Macedo-nas Romana Fortuna uicit
I soldati incitati da queste esortazioni dallrsquouna e dallrsquoaltra parte si lanciaro-no nel combattimento vantandosi gli uni del dominio dellrsquoOriente gli altri dellrsquoOccidente e recando in guerra gli uni lrsquoantica e sbiadita gloria dei loro an-
37 Iust XXX 4 4 Quo prodigio territis omnibus uates cecinere oriens Romanorum imperium uetus Graecorum ac Macedonum uoraturum38 Sui discorsi precedenti la battaglia nellrsquoantichitagrave se da considerare reali o costruzioni storiografiche vd Adler (2011) pp 6-839 Iust XXX 4 7 tantoque hoc bellum fortius quam illa sustinendum quanto sit imperio libertas carior40 Iust XXX 4 10 Sed nec Macedonas ueteri fama sed praesentibus uiribus aestimandos
134 MONICA DrsquoAGOSTINI
tenati gli altri il fiore del loro valore fresco e vigoroso per le recenti prove Ma la Fortuna dei Romani vinse i Macedoni
Questo punto di vista probabilmente giagrave trogiano contrappone la virtugrave romana (virtutis flos) celebrata nei discorsi antecedenti la battaglia al-la Fortuna romana (Romana Fortuna) che decise la vittoria interpretabi-le come destino favorevole o buona stella Piugrave che unrsquoaffermazione anti-romana41 come egrave spesso stata intesa si puograve evidenziare il carattere sim-patetico della fonte verso Filippo V destinato a porre fine alla gloria di Filippo II e Alessandro e forse un approccio nostalgico verso i grandi regni macedoni la cui egravera egrave ormai giunta alla fine Tale prospettiva egrave as-sente in Polibio e nella tradizione che da lui dipende poco interessata alle vicende della gloria macedone leggendo infatti i frammenti soprav-vissuti del libro XVIII delle Storie dopo lrsquoaccurata descrizione della bat-taglia (18-33 e 34-40)42 Polibio commenta lo scontro affermando che avrebbe dedicato alcuni capitoli allrsquoesame delle strategie militari delle due armate percheacute (XVIII 28 4-6)
χρήσιμον καὶ καλὸν ἂν εἴη τὸ τὴν διαφορὰν ἐρευνῆσαι καὶ παρὰ τί συμβαίνει Ῥωμαίους ἐπικρατεῖν καὶ τὸ πρωτεῖον ἐκφέρεσθαι τῶν κατὰ πόλεμον ἀγώνων [5] ἵνα μὴ τύχην λέγοντες μόνον μακαρίζωμεν τοὺς κρατοῦντας ἀλόγως καθάπερ οἱ μάταιοι τῶν ἀνθρώπων ἀλλ᾽ εἰδότες τὰς ἀληθεῖς αἰτίας ἐπαινῶμεν καὶ θαυμάζωμεν κατὰ λόγον τοὺς ἡγουμένους
Puograve essere cosa buona e utile esaminare le differenze e per quale motivo i Ro-mani prevalgono e riportano il primo premio nelle competizioni di guerra af-fincheacute non esaltiamo i vincitori senza una ragione parlando solo di fortuna co-me fanno gli sciocchi ma conoscendo le vere cause lodiamo e ammiriamo i co-mandanti seguendo una logica
Polibio dunque sembra rispondere a coloro che parlavano della buo-na stella dei Romani sottolineando che la vittoria nasceva dalla superio-re strategia militare della legione43 Un punto di vista quindi opposto a quello espresso nellrsquoEpitome che proprio di Romana Fortuna parla e riba-dito in chiusura al passo dove Polibio critica nuovamente quei Greci che ritenevano la vittoria romana incredibile (XVIII 32 13)
41 Urban (1982) pp 1424-1443 1435 Richter (1987) p 19 n 4 Alonso-Nuacutentildeez (1992) p 66 e Id (2002) pp 105-110 partic 108-109 Contra Heckel (1997) p 29 che ridimen-siona la categorizzazione di Trogo come storico anti-romano 42 Su Cinoscefale vd Walbank (1957) ad l Hammond (1988) pp 60-82 Sklenaacuter (2004) pp 302-310 Thornton (2014) pp 83-87 43 Sulla Fortuna in Polibio vd McGing (2010) pp 195-201 (con bibliografia) che distin-gue tra quando Polibio intenda caso e quando predeterminazione fato Vd anche Green (1990) pp 400-402 e Eckstein (2008) pp 132-138
IL DISCORSO DEL RE 135
Il punto di vista di Trogo sembra invece presente nei frammenti del-la Makedonikeacute di Appiano su Filippo V44 dove ci si riferisce a Cinoscefale come a una vittoria insperata (Mak 9 1)
ἡγούμενος δ᾽ οὔτε Ῥωμαίοις συμφέρειν οὔτε τοῖς Ἕλλησι Φιλίππου καθαιρεθέντος ἐπιπολάσαι τὴν Αἰτωλῶν βίαν τάχα δ᾽ αὐτὸν καὶ τὸ παράδοξον τῆς νίκης ἀγαπᾶν ἐποίει
Flaminino era consapevole che non sarebbe stato vantaggioso per i Romani o per i Greci che Filippo fosse deposto e che il potere etolico rimanesse incon-trastato forse lo aveva reso moderato nei suoi progetti lrsquoaver ottenuto una vit-toria insperata
Addirittura successivamente si accenna alla sorte avversa a Filippo nel-lo scontro
τὰ μὲν δὴ παρὰ τῶν ἄλλων φιλάνθρωπα ἦν τό τε τῆς τύχης ἄδηλον ἐξ ὧν ἔπαθεν ὁ Φίλιππος ὑφορωμένων καὶ τὸ πταῖσμα τοῦτο οὐ κατ᾽ ἀσθένειαν ἀλλὰ πλέον ἐκ συντυχίας αὐτὸν παθεῖν ἡγουμένων
Gli altri (Greci) erano inclini ad essere moderati vedendo con sospetto lrsquoincer-tezza della fortuna subita da Filippo e ritenendo che egli fosse incorso in questa sconfitta non tanto per la sua inferioritagrave quanto per la sfortuna
Il riferimento in Appiano e Trogo alla fortuna romanasfortuna ma-cedone a proposito di Cinoscefale egrave una traccia dellrsquoopinione politi-ca di quei Greci disprezzati da Polibio come uomini sciocchi καθάπερ οἱ μάταιοι τῶν ἀνθρώπων Tale posizione politica su Cinoscefale sarebbe dunque sopravvissuta nella tradizione storiografica di cui troviamo trac-cia in TrogoGiustino e Appiano
Per comprendere meglio alcune caratteristiche di questa tradizione puograve essere utile tornare ai due discorsi nellrsquoEpitome di Filippo e Flamini-no prima della battaglia Tali passi probabilmente trogiani45 non trova-no infatti riscontro nelle fonti parallele a noi pervenute Polibio (XVIII 18-27) seguito fedelmente da Livio (XXXIII 5-10) pur descrivendo le operazioni di guerra di Cinoscefale con dovizia di particolari non men-ziona un discorso di Filippo ai suoi armati prima della battaglia mentre il discorso di Flaminino per incoraggiare le truppe schierate (XVIII 23 2-6) nelle Storie egrave incentrato sulle vittorie di Sulpicio nella prima parte della guerra Pare dunque originale la versione trogiana che incentra-
44 Tra i frammenti consegnatici dagli Excerpta Constantiniana sono frequenti informazio-ni e osservazioni che rimandano a una prospettiva ellenistica sugli eventi DrsquoAgostini (2011) pp 99-121 45 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362
136 MONICA DrsquoAGOSTINI
ta sulla gloria macedone presenta Cinoscefale come il punto drsquoincon-tro e di scambio tra lrsquoegemonia macedone e lrsquoegemonia romana Non egrave una novitagrave che il leitmotiv delle Storie Filippiche e dunque dellrsquoEpitome sia la translatio imperii giagrave Alonso Nuntildeez definito da Santi Amantini laquouno dei piugrave noti esperti di questioni trogiano-giustineeraquo46 osservava che Tro-go esponeva nel suo perduto lavoro la teoria della successione degli im-peri mondiali secondo lo schema Assiria-Media-Persia-Macedonia-Roma osteggiata dai Parti47 In tale successione il ruolo da protagonista egrave rico-perto dallrsquoegemonia macedone48 che occupa allrsquoincirca 26 dei 44 libri e il cui ultimo vero momento di gloria egrave lo scontro con Roma appunto a Cinoscefale Lrsquoultima impresa macedone ha come esito la transizione del dominio universale da Oriente a Occidente e costituisce il tema cen-trale dellrsquointera vicenda di Filippo lrsquoimportanza della battaglia di Cino-scefale egrave perciograve esaltata nei discorsi sia di Filippo che di Flaminino che a loro volta sono il punto di arrivo delle argomentazioni esposte nelle parole di Demetrio di Faro e di Filippo stesso giagrave nel libro XXIX Le ora-tiones disposte retoricamente nei due libri descrivono due parabole op-poste da un lato quella romana che da lontana potenza desiderosa di espandersi cresce come una pioggia di sangue diventando il giovane e vigoroso potere che sottomesso Annibale egrave pronto a sconfiggere Filip-po Dallrsquoaltro quella macedone che originata con Filippo II personag-gio centrale per Trogo raggiunge il suo apice con la conquista dellrsquoege-monia ad opera di Alessandro Magno contro i Persiani per conoscere la fine con Filippo V il cui antico valore egrave ormai troppo lsquosbiaditorsquo per te-ner testa al vigore romano
La gloria macedone secondo Trogo inizia dunque con Filippo II e si conclude con Filippo V Perseo egrave infatti il malvagio responsabile dellrsquoan-nientamento di ciograve che rimaneva della monarchia macedone49 Trogo pone agli estremi della parabola macedone che occupa dal libro IX al XXX i due re di nome Filippo Filippo II e Filippo V come ribadito in piugrave luoghi dellrsquoEpitome sia in parti riassunte da Giustino che in passi piugrave genuinamente trogiani Dando per scontato che il titolo dellrsquoopera Sto-rie Filippiche si debba al desiderio di Trogo di rifarsi allrsquoopera di Teopom-po sul sovrano macedone egrave possibile che tale titolo sia stato perograve ripen-
46 Santi Amantini (2003) pp 99-11047 laquoPompeius Trogus expounded in his lost work the Historiae Philippicae a theory of the world empire suggestion according to the scheme Assyria-Media-Persia-Macedonia-Rome opposed by the Parthiansraquo Alonso-Nuacutentildeez (2002) pp 105-110 e 133-136 partic 105 Vd anche Richter (1987) pp 19-23 Momigliano (1980) pp 157-162 Alonso-Nuacutentildeez (1992) Heckel (1997) pp 1-41 Gabba (2003) pp 7-9 Santi Amantini (2003) pp 99-110 Mariotta (2014) pp 45-56 48 Franco (1993) pp 71-97 e Landucci (2014) pp 233-26149 Alonso-Nuacutentildeez (2002) pp 105-110 partic 108-109
IL DISCORSO DEL RE 137
sato da Trogo considerando che il periodo compreso tra le imprese dei due Filippo occupa 23 dellrsquoopera50 Si potrebbe allora suggerire che le Storie sono Filippiche poicheacute i due Filippo segnarono lrsquoinizio e la fine di quella che egrave nellrsquoopera di Trogo lrsquoegemonia incontrastata del mondo piugrave gloriosa di tutti i tempi51
La prospettiva ellenistica che vede nei due Filippo i limiti della grande egemonia macedone egrave di nuovo presente anche in Appiano nellrsquooraco-lo riportato nei frammenti della sua Makedonikeacute e noto anche da Pausa-nia (VII 8 9)
αὐχοῦντες βασιλεῦσι Μακηδόνες Ἀργεάδῃσιν ὑμῖν κοιρανέων ἀγαθὸν καὶ πῆμα Φίλιππος ἤτοι ὁ μὲν πρότερος πόλεσιν λαοῖσί τ᾽ ἄνακτας θήσει ὁ δ᾽ ὁπλότερος τιμὴν ἀπὸ πᾶσαν ὀλέσσει δμηθεὶς δ᾽ ἑσπερίοισιν ὑπ᾽ ἀνδράσιν ἐνθάδ᾽ ὀλεῖται
O Macedoni che andate orgogliosi dei re di stirpe argiva I re di nome Filippo saranno arbitri del bene e del male per voi Il primo vi renderagrave signori di cittagrave e popoli il secondo vi priveragrave di ogni onore sconfitto da uomini dellrsquoOcciden-te qui giace morto52
Senza voler entrare nel merito della discussione di tale oracolo di nuo-vo pare di incontrare nei due autori la medesima prospettiva lontana dalla condanna morale del re macedone espressa da Polibio secondo cui la sconfitta egrave il giusto esito della sua crudeltagrave ed empietagrave
Il libro giustineo si conclude menzionando le condizioni della pa-ce di Tempe53 e lrsquoira degli Etoli che videro ignorate le proprie richieste da Flaminino e perciograve cercarono lrsquoalleanza di Antioco contro Roma Se-condo il Prologo XXX il libro perograve proseguiva con le campagne di Antio-co III in Asia Minore contro Molone e Acheo e in Battriana fino ad ar-rivare allrsquoesordio dello scontro con Roma54 Il riassunto giustineo egrave trop-po sommario per permettere un confronto con le fonti parallele Egrave pe-
50 Sul rilievo della storia della Macedonia nellrsquoopera di Trogo e Giustino vd von Gutsch-midt (1894) pp 17-217 Richter (1987) p 28 n 29 Franco (1993) pp 71-97 51 Vd anche Urban (1982) pp 1424-1443 e Alonso-Nuacutentildeez (1992) p 58 52 Mak Fr 2 Vd DrsquoAgostini (2011) pp 99-121 In questa Walbank (2002) pp 127-136 propone di interpretare anche un poema di Alceo di Messene (Anth Pal 9518)53 Egrave probabile che Trogo fornisse piugrave particolari riguardo a questa pace per esempio si puograve ritenere che vi fosse menzione dellrsquoinvio a Roma del figlio Demetrio da parte di Filippo come ostaggio dato che a Iust XXXII 2 3 si richiama appunto tale avvenimento54 Polyb XVIII 34 1-39 7 42 1-45 12 Liv XXXIII 11 3-13 15 24 1-31 11 Plut Flam IX 1-8 App Mak Fr IX riferiscono di due diverse trattative di pace caratterizzate da un vivace dibattito tra chi voleva lrsquoannientamento della Macedonia come in Grecia gli Etoli e a Roma Marco Claudio Marcello e coloro che desideravano la pace con la Macedonia in primis Flaminino
138 MONICA DrsquoAGOSTINI
rograve da notare la mancanza sia nel Prologo che nel testo del libro degli av-venimenti delle celebrazioni Istmie del 196 quando Flaminino procla-mograve la libertagrave dei Greci Piugrave in generale in tutta la narrazione di Giustino delle complesse trattative del 197-196 manca qualsiasi riferimento alla li-bertagrave dei Greci punto nodale nella tradizione di Polibio che con questa sottolineatura esalta sia il ruolo tirannico della Macedonia sia la grande generositagrave dei Romani nei confronti della Grecia Il silenzio di TrogoGiustino su tale questione mostra il prevedibile disinteresse per gli affari dei Greci e nel contempo conferma la presenza di una tradizione che si occupa soprattutto della storia delle monarchie ellenistiche allrsquointer-no della quale la posizione dellrsquoEllade egrave subalterna
Libro XXXII23- 34 Demetrio e Perseo
Gli ultimi anni di regno di Filippo tra il 183 e il 179 sono narrati in un passo breve del libro XXXII Il racconto in Giustino che egrave coerente con il Prologo trogiano segue in maniera sintetica la tradizione polibiana su questi eventi giunta a noi in alcuni passi lacunosi di Polibio (XXIII 1 3-3 10 7 1-7 10 1-11 8) integrati dal racconto particolareggiato di Li-vio (XXXIX 46 7- 48 6 53 1-16 XL 3 3-16 3 201-24 8) e dalla narra-zione di Diodoro (XIX 25) e Plutarco (Aem VIII 11)55
Conclusioni
In questi libri dedicati a Filippo egrave forse possibile vedere in filigrana la rielaborazione voluta di Giustino dei corrispondenti libri trogiani Co-me Giustino stesso afferma nella Prefatio 3 lrsquoopera di Trogo era costruita secondo due criteri quello cronologico e quello per laquoconcatenazione di eventi56raquo ea omnia Pompeius diuisa temporibus et serie rerum digesta conposuit
55 Lrsquoutilizzo della tradizione polibiana in Trogo egrave confermato dallrsquoaderenza a Livio (XL 54 1-56 11) e Diodoro (XXIX 28) del racconto sul pentimento di Filippo per aver ucciso il figlio Demetrio lrsquointenzione di punire Perseo e la correlazione tra questo e la sua mor-te Questo libro egrave dunque differente nellrsquointeresse e nelle fonti dai libri XXIX e XXX poicheacute molto vicino alla tradizione polibiana in Livio Questi avvenimenti in Giustino sono da collegare con lrsquoascesa al trono di Perseo e non con lrsquoepilogo della celebrazione del valore macedone giagrave conclusasi in Giustino con Cinoscefale e la transizione dallrsquoim-perium macedone allrsquoimperium romano Vd Heckel (1997) p 7 Appiano invece riporta ancora una tradizione diversa da quella polibiana in un frammento della Makedonikeacute in particolare Appiano egrave attento al punto di vista macedone e presenta Filippo come una vittima delle circostanze (Mak IX) DrsquoAgostini (2011) pp 99-12156 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362 Alonso-Nuacutentildeez (2002) pp 133-136 He-ckel (1997) pp 1-41 Borgna (2014) pp 52-77
IL DISCORSO DEL RE 139
Serie rerum digesta sembrerebbe unrsquointerpretazione latina della formula κατὰ γένος che Diodoro usa per indicare la struttura della storia di Efo-ro sottolineandone la divisione per argomento57 In tale struttura per argomento dellrsquoEpitome tra i temi principali ci sono dunque il valore e la gloria dei sovrani ellenistici58 riscontrabile nei libri XXVIII-XXXI sui re-gni di Antigono Dosone Filippo V e Antioco III Tale tema presente di sicuro in Trogo egrave conservato nellrsquoazione dellrsquoEpitomatore e anzi come si vede dagli escerpta esaltato dalla selezione dei passi
Per quanto riguarda invece la Quellenforschung 59 egrave evidente che nel testo vi sia presenza di filoni non tradizionali sugli eventi poicheacute la posi-zione di Trogo appare spesso autonoma rispetto alle opinioni condivise dalla storiografia antica Questo aspetto dellrsquoEpitome evidente soprattut-to per ciograve che riguarda gli eventi ellenistici ha suscitato la grande curio-sitagrave degli studiosi che allontanatisi dalla proposta di von Gutschmid che voleva una totale ed esclusiva dipendenza di Trogo da Timagene ora in-dicano con sicurezza tra le fonti piugrave rilevanti per gli eventi ellenistici di III secolo utilizzate da Trogo almeno altri sei nomi oltre a Timagene Ie-ronimo Timeo Filarco Duride Polibio e Posidonio
Per quanto riguarda nello specifico la composizione dei libri XXIX e XXX non vi egrave alcun dubbio che in essi Trogo abbia utilizzato (anche riadattandola) una fonte poco attenta alle questioni di politica interna greca e al legame tra queste e quel ritratto di Filippo come sovrano mal-vagio ed empio che ritorna nella tradizione ufficiale di origine polibia-na passando poi da Polibio in Livio Diodoro e Plutarco60 Trogo pre-serva invece una tradizione ellenistica interessata alla figura di Filippo come ultimo barlume della gloria macedone tradizione che pare quasi una controparte e un completamento dellrsquoAb urbe condita romanocentri-ca di Livio Non si puograve perciograve a mio avviso escludere che per questa se-zione Trogo abbia usato una tradizione di matrice filoellenistica o sem-plicemente ellenisticocentrica unrsquoopera sui regni di diadochi ed epigo-ni che a tutti noi fa venire facilmente alla mente il Basileis o Perigrave Basileon dello storico grecoellenistico augusteo filobarbaro scettico (o critico) verso lrsquoegemonia romana Timagene di Alessandria (FGrHist 88)61
57 Su Eforo vd Vannicelli (1987) pp 165-191 e ora Parmeggiani (2011) 58 Simile legame vi egrave a mio avviso tra i libri XXVI e XXVII che invece affrontavano la crisi delle monarchie ellenistiche causata dalle guerre fraterne59 Vd von Gutschmid (1894) pp 17-217 Richter (1987) pp 17-30 partic 20-23 San-ti Amantini (1972) pp 56-109 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362 Urban (1982) pp 1424-1443 partic 1435 Mecca (2001) pp 199-222 Santi Amantini (2003) pp 99-110 Heckel (2012) pp 3-860 Scuderi (2005) pp 383-40561 Sordi (1982) pp 775-797 Heckel (1997) pp 30-34 Landucci (2014) pp 233-261 e Ead in questo volume
140 MONICA DrsquoAGOSTINI
ABSTRACT
Philip V of Macedon was the first of the Epigonoi to face Rome Several mod-ern reconstructions of the actions and the reign of Philip V have approached it largely from a Roman point of view using as sources Polybius and where Poly-bius is lost Livy The Polybian historiographical tradition tends to portray Phil-ip V as an enemy and a tyrant impious and cruel The Macedonian king was ea-ger to establish a universal and unjust dominion over Greece Italy and beyond and Rome engaged in the first two Macedonian Wars to fight the threat of his growing ambition Nevertheless Polybiusrsquo portrayal of Philip V was affected not only by Polybiusrsquo admiration for Roman political structures military power and overwhelming conquest but also his personal Achaean origins
Looking at in book 29 and 30 of Justinrsquos Epitome of Pompeius Trogus this pa-per focuses on the non Polybian tradition on Philip V this contribution is in-deed the first analysis of the Hellenistic approach to the clash between Rome and Macedonia in the 3rd-2nd Century BC The Epitome shows a considerable di-versity of interpretation from the other sources and reflects very different views of Philip Vrsquos actions that brought him into conflict against Rome In particular these views are more evident related to the accounts of the peace negotiations of Naupactus and the battle of Cynoscephalae in the Epitome the king appears as a courageous and skilled warrior the last of the great Macedonian rulers who fell victim to misfortune This portrayal which has several common features with Appianrsquos fragments of Philip V (Mak 9) counterbalances the Roman and Achaean standpoint present in Polybius providing a more Hellenistic perspec-tive that is likely to have been rooted in a historiographical tradition connect-ed to the losing side in the struggle between Rome and the Hellenistic world
BIBLIOGRAFIA
Adler E (2006) Whorsquos Antiroman Sallust and Pompeius Trogus on Mithridates CJ 101 pp 383-407
Adler E (2011) Valorizing the Barbarians Enemy speeches in Roman Historiography Austin
Ager SL (2003) An Uneasy Balance from the Death of Seleukos to the Battle of Raph-ia in A Erskine (ed) A Companion to the Hellenistic World Oxford pp 35-50
Ager SL (2009) Roman Perspectives on Greek Diplomacy The conceptual clash Greek diplomacy of compromise and Roman Bellum Iustum in C Eilers (ed) Diplomats and Diplomacy in the Roman World Leiden-Boston pp 15-43
Alonso-Nuacutentildeez JM (1992) La Historia Universal de Pompeyo Trogo Madrid
Alonso-Nuacutentildeez JM (2002) The Idea of Universal History in Greece From Herodotus to the Age of Augustus Amsterdam
Ballesteros Pastor L (2013) Pompeyo Trogo Justino y Mitriacutedates Comentario al Epiacutetome de las Historias Filiacutepicas (3716-3881) Hildesheim-Zuumlrich-New York
IL DISCORSO DEL RE 141
Barreacute ML (1983) The God-List in the Treaty between Hannibal and Philip V of Ma-cedon a Study in Light of the Ancient Near Eastern Treaty Tradition Baltimore-Lon-don
Beck H - Eckstein A (2015) sv ldquoAratos of Sicyon (231)rdquo in I Worthington (ed) Brillrsquos New Jacoby Brill Online
Borgna A (2014) Uno sguardo originale intorno a Roma Pompeo Trogo e Giustino laquoLa Biblioteca di ClassicoContemporaneoraquo 1 pp 52-77
Cassola F (1962) I gruppi politici romani nel III secolo aC Trieste
Champion CB (1997) The Nature of Authoritative Evidence in Polybios and Agelausrsquo Speech at Naupactos TAPhA 127 pp 111-128
Champion CB (2004) Cultural Politics in Polybiusrsquo Histories Berkeley
Coppola A (1993) Demetrio di Faro un protagonista dimenticato Roma
Criscuolo L (2011) I due testamenti di Tolemeo VIII Evergete II in A Joumlrdens - J F Quack (hrsg) Aumlgypten zwischen innerem Zwist und aumluszligerem Druck Die Zeit Ptole-maios VI bis VIII Wiesbaden pp 132-150
DrsquoAgostini M (2011) Filippo V e la Storia Romana di Appiano laquoAevumraquo 85 pp 99-121
Eckstein AM (1995) Moral vision in the Histories of Polybius Berkeley
Eckstein AM (2008) Rome enters in the Greek East From Anarchy to Hierarchy in the Hellenistic Mediterranean 230-217 BC Oxford
Eckstein AM (2013) Polybius Phylarchus and Historiographical Criticism CPh 108 4 pp 314-338
Errington RM (1969) Philopoemen Oxford
Errington RM (2008) A History of the Hellenistic World 323-30 BC Malden MA-Oxford
Forni G - Angeli Bertinelli MG (1982) Pompeo Trogo come fonte di storia ANRW II 30 2 pp 1298-1362
Franco C (1993) Trogo Giustino e i successori di Alessandro in L Braccesi - A Coppola - G Cresci Marrone - C Franco (a cura di) LrsquoAlessandro di Giustino dagli antichi ai moderni Roma pp 71-97
Gabba E (2003) Introduzione in D Foraboschi - SM Pizzetti (a cura di) La successione degli imperi e delle egemonie nelle relazioni internazionali Milano pp 7-9
Golan D (1995) The Res Graeciae in Polybius Four Studies Como
Green P (1990) Alexander to Actium The Historical Evolution of the Hellenistic Age Berkeley-Los Angeles
Gutschmid von A (1894) Die beiden ersten Buumlcher des Pompeius Trogus in A von Gutschmid - F Ruumlhl (hrsg) Kleine Schriften Leipzig pp 17-217
142 MONICA DrsquoAGOSTINI
Habicht C (1995) Athen Muumlnchen
Hammond NGL (1968) Illyris Rome and Macedon in 229-205 BC JRS 58 pp 1-21
Hammond NGL (1988) The Campaign and the Battle of Cynoscephalae in 197 BC JHS 108 pp 60-82
Heckel W (1997) Introduction (Part 2) in JC Yardley - W Heckel (eds) Ju-stin Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus Books 11-12 Alexander the Great Introduction Oxford pp 1-41
Heckel W (2012) Introduction in JC Yardley - P Wheatley - W Heckel (eds) Justin Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus II Books 13-15 The Successors to Alexander the Great Oxford pp 1-8
Huss W (1976) Untersuchungen zur Auszligenpolitik Ptolemaiosrsquo IV Muumlnchen
Huss W (2001) Aumlgypten in hellenistischer Zeit 332ndash30 v Chr Muumlnchen
Intrieri M (2011) Fra dialogo e conflitto Annibale e i Greci drsquoOccidente RStudFen 37 pp 53-82
Landucci F (2014) Filippo II e le Storie Filippiche un protagonista storico e storio-grafico in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 233-261
Landucci Gattinoni F (2011) Politica e ideologia in etagrave ellenistica laquoPolitica An-ticaraquo 1 pp 89-105
Leacutevy E (1994) Le discours drsquoAgeacutelaos de Naupacte in L Aigner Foresti - A Bar-zanograve - C Bearzot - L Prandi - G Zecchini (a cura di) Federazioni e federalismo nellrsquoEuropa antica Bergamo 21-25 settembre 1992 Milano (Alle radici della casa co-mune europea 1) pp 33-50
Longaretti L (1989) Lrsquoalleanza tra Annibale e Filippo V di Macedonia RIL 123 pp 183-192
Marasco G (1979-1980) La valutazione di Tolemeo IV Filopatore nella storiografia greca laquoSilenoraquo 5-6 pp 159-182
Mari M [- Musti D - Thornton J] (2002) Polibio Storie Volume III Libri V-VI Milano
Mariotta G (2014) Geografia e Geopolitica nelle Storie Filippiche in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 45-56
McGing B (2010) Polybiusrsquo Histories New York
McGing B (2013) Youthfulness in Polybius the case of Philip V of Macedon in B Gibson - T Harrison (eds) Polybius and his world Oxford pp 181-199
Meadows A (2013) Polybius Aratus and the History of the 140th Olympiad in B
IL DISCORSO DEL RE 143
Gibson - T Harrison (eds) Polybius and his World Essays in Honour of Frank Walbank Oxford pp 91-116
Mecca A (2001) Trogo Timagene e Polieno QS 54 pp 199-222
Meister K (1990) Die Griechische Geschichtsschreibung von den Anfaumlngen bis zum Ende des Hellenismus Stuttgart
Misch G (1949) Geschichte der Autobiographie I Frankfurt am Mein
Momigliano A (1980) Daniele e la teoria greca della successione degli imperi RAL 35 pp 157-162
Muccioli F (2013) Gli epiteti ufficiali dei re ellenistici Stuttgart (Historia Einzel-schriften 224)
Musti D (1978) Polibio e lrsquoimperialismo romano Napoli
Parmeggiani G (2011) Eforo di Cuma studi di storiografia greca Bologna
Peacutedech P (1964) La meacutethode historique de Polybe Paris
Pelling CBR [- Scardigli B - Manfredini M](1997) Plutarco Vite parallele Filopemene Tito Flaminino Milano
Richter H-D (1987) Untersuchungen zur hellenistischen Historiographie die Vorla-gen des Pompeius Trogus fuumlr die Darstellung der nachalexandrischen hellenistischen Ge-schichte (Iust 13-40) Frankfurt
Santi Amantini L (1972) Fonti e valore storico di Pompeo Trogo (Iustin XXXV e XXXVI) Genova
Santi Amantini L (1981) (a cura di) Giustino Storie Filippiche Epitome da Pom-peo Trogo Milano
Santi Amantini L (2003) Il tempo e i tempi nelle Storie Filippiche di Pompeo Tro-go RSA 33 pp 99-110
Schepens G (1983) Les rois ptolegravemaiumlques et lrsquohistoriographie Reacuteflexions sur la trans-formation de lrsquohistoire politique in E vanrsquot Dack - P van Dessel - W Van Gucht (eds) Egypt and the Hellenistic World Proceedings of the International Collo-quium Leuven 24-26 May 1982 Leuven (Studia Hellenistica 27) pp 351-368
Schlicher JJ (1933) Non-Assertive Elements in the Language of the Roman Histo-rians CPh 28 289-300
Schmitt T (1989) Die Bedeutung des zweiten Punischen Krieges fuumlr den Frieden in Naupaktos in H Devijver - E Lipinski (eds) Punic wars Proceedings of the Conference held in Antwerp from the 23th to the 26th of November 1988 in Cooperation with the Departement of History of the laquoUniversitait Antwerpenraquo UFSIA Leuven (Studia Phoenicia 10) pp 229-239
Scholten JB (2000) The Politics of Plunder Aitolians and their koinon in the early Hellenistic Era Berkeley
144 MONICA DrsquoAGOSTINI
Scuderi R (2005) Filippo V e Perseo nei frammenti diodorei in C Bearzot - F Lan-ducci (a cura di) Diodoro e lrsquoaltra Grecia Macedonia Occidente Ellenismo nella Bi-blioteca Storica Atti del convegno Milano 15-16 gennaio 2004 Milano pp 383-405
Sklenaacuter RJ (2004) Sources and Individuality in Two Passages of Livy laquoHistoriaraquo 53 pp 302-310
Sordi M (1982) Timagene di Alessandria Uno storico ellenocentrico e filobarbaro ANRW II 30 1 pp 775-797
Thornton J (2014) Le guerre macedoniche Roma
Urban R (1979) Wachstum und Kriese des achaumlischen Bundes Quellenstudien zur entwicklung des Bundes von 280 bis 222 V Chr Wiesbaden
Urban R (1982) laquoGallisches Bewusstseinraquo und laquoRomkritikraquo bei Pompeius Trogus ANRW II 30 2 pp 1424-1443
Vannicelli P (1987) Lrsquoeconomia delle Storie di Eforo RFIC 115 pp 165-191
Vattuone R (2014) Giustino e lrsquoOccidente greco I VI-V secolo aC in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 261-277
Vollmer D (1990) Symploke das Uumlbergreifen der roumlmischen Expansion auf den grie-chischen Osten Untersuchungen zur roumlmischen Aussenpolitik am Ende des 3 Jh V Chr Stuttgart
Walbank FW (1957) A Historical Commentary on Polibius I Oxford
Walbank FW (1967) A Historical Commentary on Polybius II Oxford
Walbank FW (1933) Aratos of Sicyon Cambridge
Walbank FW (2002) Η ΤΩΝ ΟΛΩΝ ΕΛΠΙΣ and the Antigonids in FW Walbank (ed) Polybius Rome and the Hellenistic World Essays and Reflections West Nyack NY pp 127-136
Weber G (1997) Interaktion Repraumlsentation und Herrschaft Der Koumlnigshof im Hel-lenismus in A Winterling (hrsg) Zwischen lsquoHausrsquo und lsquoStaatrsquo antike Houmlfe im Ver-gleich Munich pp 27-72
Will E (19822) Histoire politique du Monde Helleacutenistique II Nancy
Zecchini G (1990) La storiografia lagide in H Verdin - G Schepens - E De Keyser (eds) Purposes of History Studies in Greek Historiography from the 4th to the 2nd Centuries BC Proceedings of the International Colloquium of Leuven 24-26 May 1988 Leuven (Studia Hellenistica 30) pp 213-232
Zecchini G (2003) Polibio e la tradizione orale in A Casanova - P Desideri (a cura di) Evento racconto scrittura nellrsquoantichitagrave classica Firenze pp 123-141
Finito di stamparenel mese di novembre 2015
da LegoDigit srlLavis (TN)
130 MONICA DrsquoAGOSTINI
Dopo aver accennato alla stipula del trattato Giustino affastella ne-gli ultimi paragrafi del capitolo 4 gli eventi tra il 215 e il 205 quando Fi-lippo siglando la pace con Roma pone fine alla Prima Guerra Macedo-nica29 In particolare lrsquoEpitomatore sottolinea da un lato lrsquoingresso in guerra degli Etoli al fianco dei Romani e la successiva alleanza del preto-re Levino con Attalo dallrsquoaltro gli attacchi subiti da parte dei Dardani da Filippo oppresso dalle richieste degli Illiri Il libro dunque si chiude con Filippo in difficoltagrave aggravate dalla comparsa di Filopemene il leader degli Achei30 urtatosi con il re dei Macedoni convince la Lega Achea a staccarsi dallrsquoalleanza con la Macedonia sempre piugrave isolata Tale allon-tanamento egrave considerato da Giustino lrsquoesito di un fallito agguato a Fi-lopemene commissionato da Filippo V e dovuto al sospetto di un tradi-mento del condottiero acheo a favore di Roma Bencheacute anche Plutarco (Fil 12 2) e Pausania (VIII 50 4) menzionino il tentativo di assassinio di Filopemene da parte di Filippo la notizia dellrsquoatteggiamento filoroma-no del generale acheo non parrebbe vicino al ritratto polibiano che ve-de in Filopemene un eroe dellrsquoautonomia e dellrsquoindipendenza achea31
Libro XXX11-39 Cinoscefale
Lrsquoesordio del libro XXX introducendo il grande scontro di Cinoscefale tra Romani e Macedoni riprende la celebrazione della gloria macedo-ne argomento centrale dei discorsi del libro XXIX Con lrsquoeccezione dei primi capitoli sul deplorevole comportamento di Tolemeo IV in Egit-to32 il libro egrave infatti totalmente dedicato allo scontro tra le due potenze
29 Errington (2008) pp 185-190 La guerra egrave nota a noi soprattutto dai frammenti dei libri VIII-XI di Polibio dai passi di Liv XXIV 40 1-17 XXVI 24 1-26 4 XXVII 30 5-33 5 e XXVIII 5 1- 9 1 XXIX 12 1-15 e dalla Vita di Filopemene di Plutarco La sinteticitagrave del riassunto giustineo impedisce un puntuale paragone delle tradizioni Ad esempio la notizia dellrsquoalleanza tra Attalo e Roma sembra tornare in Liv XXVIII 5 1-4 dove perograve non troviamo Levino ma Sulpicio come rappresentante romano personaggio scompar-so in Giustino In maniera simile la pace di Fenice del 205 egrave sintetizzata in Giustino in una riga e non vi egrave traccia delle lunghe trattative che coinvolsero come mediatori anche Egitto Chio Mitilene e Atamania portarono a una prima pace separata tra Filippo e gli Etoli nel 206 e poi alla pace con Roma Le fonti parallele sono molto piugrave dettagliate anche su questi eventi Polyb XI 4 1-6 9 Liv XXVIII 5 13 e XXIX 12 8-16 e App Mak fr III Degno di nota egrave perograve il commento in Giustino secondo cui laquoi Romani erano per il momento soddisfatti di aver rinviato la guerra contro la Macedoniaraquo Lrsquointenzione ro-mana di riprendere la guerra con la Macedonia egrave infatti presente in tutte le fonti Polyb XI 6 7 Liv XXIX 1216 Dio C XVIII 9 (15) e App Mak Fr III e verragrave ripresa al libro XXX dellrsquoEpitome 30 Su Filopemene e Filippo vd Errington (1969) pp 51-69 e 83-84 vd anche Golan (1995) pp 115-132 Eckstein (2008) pp 103 e 360-36131 Pelling (1997) pp 135-13932 Lrsquoesordio del libro XXX egrave dedicato alle scabrose imprese del sovrano egiziano ovvero
IL DISCORSO DEL RE 131
dellrsquoEst e dellrsquoOvest La prima avvisaglia dellrsquoincombente guerra egrave la no-tizia dellrsquoaccordo di Filippo V e Antioco III per la spartizione dellrsquoEgitto governato dal sovrano-bambino Tolemeo V Il sovrano lagide nel 2032 chiese aiuto ai Romani che secondo TrogoGiustino gradirono la ri-chiesta drsquoaiuto percheacute cercavano pretesti per muovere guerra contro Fi-lippo A partire da Polibio numerose altre fonti ci testimoniano questo episodio mettendolo in relazione con lo scoppio della Seconda Guerra Macedonica ed esprimendo una condanna morale per lrsquoempia condotta del re antigonide che cospira contro un bambino33 al contrario nellrsquoE-pitome si esalta la potenza macedone evidenziando la paura dei Romani delle grandi imprese di Filippo (XXX 3 2)
nullius magis arma metuebant reputantibus quantum motum Pyrrhus parua Macedo-num manu in Italia fecisset quantasque res Macedones in Oriente gessissent
di nessun altro temevano maggiormente le armi poicheacute ripensavano a quanto sconvolgimento Pirro aveva provocato in Italia con una piccola schiera di Ma-cedoni e a quanto grandi imprese i Macedoni avevano compiuto in Oriente
La supremazia macedone egrave anche al centro del discorso in oratio obliqua di Filippo allrsquoincontro nel Golfo Maliaco tra i rappresentanti dei fronti coinvolti nella Seconda Guerra Macedonica34 NellrsquoEpitome infatti dopo
la Quarta Guerra Siriaca conclusa con sconfitta a Rafia contro Antioco III nel 217 e la corruzione del sovrano da parte di Agatocle e della sorella una cortigiana che avrebbe sedotto il re Giustino riferisce poi la morte del sovrano nel 204 e lrsquoascesa al trono del piccolo Tolemeo V Epifane sovrano sotto tutela di Tlepolemo dopo la morte di Agatocle e Sosibio 33 Eckstein (2008) pp 121-180 Thornton (2014) pp 65-88 In particolare sulla relazione tra il complotto e la sconfitta antigonide e seleucidica ad opera di Roma la superioritagrave morale romana ai regni ellenistici e la causalitagrave storica in Polibio (XV 20 6) vd Eck-stein (2008) pp 133-138 Ager (2009) pp 15-43 Landucci Gattinoni (2011) pp 89-105 Secondo Polyb III 2 8 XV 20 XVI 1 8-9 seguito da Liv XXXI 14 5 Filippo avrebbe ottenuto le basi tolemaiche in Egeo Samo e la Caria mentre Antioco avrebbe finalmente avuto mano libera in Celesiria e Fenicia oggetto di quasi un secolo di lotte tra Tolemei e Seleucidi La notizia del trattato permette a Polibio di dedicare alcuni paragrafi (XV 20) a condannare aspramente lrsquooperato di Filippo V e Antioco III definendoli empi e senza pudore e dichiarando che la Fortuna punigrave i due sovrani per il loro crudele operato por-tando i Romani contro di loro vd infra App Mak Fr IV trasmette delle clausole secondo cui Antioco avrebbe avuto lrsquoEgitto e Cipro mentre Filippo avrebbe ottenuto Cirene le Cicladi e la Ionia Infine secondo Porfirio FGrHist 260 F 45 lrsquoaccordo prevedeva che i due sovrani annettessero i possedimenti tolemaici confinanti con i rispettivi regni 34 Prima si menziona unrsquoambasceria del Senato a Filippo e Antioco percheacute laquosi astenessero dallrsquoEgittoraquo e la visita di Lepido in Egitto Quindi le lamentele a Roma di Attalo e i Rodii nei confronti di Filippo Egrave probabile che a questo punto Trogo inserisse la campagna di Filippo in Asia contro Attalo menzionata nel Prologo XXX ma tagliata nellrsquoEpitome La cronologia degli scambi diplomatici precedenti la Seconda Guerra Macedonica egrave stra-volta dalla sintesi dellrsquoEpitomatore e rende impossibile qualsiasi confronto con le altre
132 MONICA DrsquoAGOSTINI
il riassunto delle ambascerie nel Mediterraneo preludio allo scontro della prima fase della guerra35 maggior spazio egrave dato al tentativo di pa-ce a Nicea tra Roma Attalo i Rodii gli Achei e gli Etoli e Filippo V nel 198 In questa occasione Filippo rivendica la posizione di dominio dei Macedoni sui Greci ereditata da Filippo II e Alessandro suoi antenati e in virtugrave di tale supremazia macedone rifiuta che i Greci gli dettino le condizioni di pace ma chiede che sia il Senato a decidere Egrave significati-vo che non solo il discorso di Filippo non compaia in nessuna delle fon-ti parallele che descrivono nel particolare le posizioni degli ambasciato-ri di Achei Etoli Rodii e Attalo ma che Polibio (XVIII 8 8)36 affermi che era difficile sapere cosa si fossero detti Filippo e Flaminino durante i colloqui nel Golfo Maliaco Secondo la tradizione polibiana infatti il sovrano accompagnato da due philoi macedoni Apollodoro e Demoste-ne chiese di allontanare dalle trattative tutti tranne i Romani e discus-se la pace solamente con Flaminino Successivamente a causa dellrsquoinca-pacitagrave di trovare un accordo Filippo chiese due mesi di tregua e lrsquointer-vento del Senato Trogo dunque restituisce il discorso che il resto della tradizione riteneva impossibile da conoscere indicando chiaramente la presenza di una fonte diversa rispetto a Polibio su questo avvenimento piugrave informata sul punto di vista di Filippo e interessata a evidenziare la convinzione di Filippo V di avere un diritto di supremazia sulla Grecia in virtugrave delle imprese di Filippo II e Alessandro
La battaglia di Cinoscefale nel 197 momento risolutivo dello scontro tra Roma e Macedonia egrave lrsquoevento principale del libro XXX omina e pre-sagi introducono lrsquoevento campale lrsquoeruzione del vulcano di Santorini
fonti In Polyb XVI 24 3 App Mak Fr IV Liv XXXI 1 10 21 5 5 Paus I 36 5-6 vi sono differenti versioni della sequenza delle ambascerie che denunciarono a Roma lrsquoe-spansionismo macedone ma tutte concordano che le ambascerie precedettero lrsquoinvio dei legati romani in Oriente e che esse furono inviate anche da Atene e dagli Etoli Inoltre secondo la tradizione polibiana (Polyb XVI 27 1-4 34 1-7 Liv XXXI 2 3 6 3-8 4 18 1-9 Diod XXVIII 6) vi furono due diverse ambascerie di cui la seconda sarebbe stato un ultimatum al sovrano recapitato da Lepido In occasione di questa seconda ambasceria avvenuta durante il cruento assedio di Abido Filippo avrebbe detto che i Macedoni in ca-so di guerra si sarebbero difesi con valore In Giustino si puograve notare che ancora una volta dagli eventi sono omesse notizie fondamentali sui Greci nello specifico lrsquoambasceria di Atene la cui disputa con gli Acarnani fu il casus belli della guerra contro Filippo 35 Come i prodromi anche la prima parte della Seconda Guerra Macedonica egrave sintetizza-ta in Giustino e occupa solamente due paragrafi Come spesso accade nei passi sintetiz-zati dallrsquoEpitomatore si trovano le incongruenze maggiori con le fonti parallele tra cui si nota soprattutto la completa omissione di Giustino delle campagne di Publio Sulpicio Galba Massimo di Villio delle vittorie di Tito e Lucio Flaminino e dellrsquoassemblea del 198 che portograve gli Achei ad allearsi con Roma Polyb XXII e Liv XXXI 14 1- 46 16 XXXII 1 1-25 12 App Mak Fr VII Plut Fil 17 4 Flam 5 4 e Paus VII 8 1-236 Le trattattive sono descritte con particolari in Polyb XVIII 1-12 seguito da Liv XXXII 32 6-36 10 e Plut Flam 5 8 e 7 1-3
IL DISCORSO DEL RE 133
nel 197 e lrsquoemergere dellrsquoisola di Hiera e in contemporanea il terremo-to a Rodi Quindi nellrsquoEpitome si annuncia che laquoil nascente impero dei Romani avrebbe divorato quello antico dei Greci e dei Macedoni37raquo Nel passo ricevono spazio soprattutto i due discorsi contrapposti del re ma-cedone Filippo e del comandante romano Flaminino pronunciati pri-ma dello scontro campale e costruiti ciascuno in modo da celebrare le imprese delle due potenze38 Lrsquoenfasi data dalla contrapposizione reto-rica delle parole dei generali egrave tale da rendere suggestiva lrsquoipotesi che lo scontro dovesse essere il momento centrale non solo del libro XXX ma forse di tutta lrsquoopera trogiana
Filippo elenca le grandi vittorie del passato dei Macedoni contro Per-siani Battriani Indiani e le popolazioni drsquoAsia fino allrsquoestremo Orien-te esortando i suoi a combattere con valore percheacute laquola libertagrave egrave piugrave cara del predominio39raquo Il discorso di Flaminino egrave invece piugrave lungo articola-to in un paragone tra Macedoni e Romani alle passate imprese di con-quista macedoni vengono contrapposte le piugrave recenti vittorie romane a Cartagine in Sicilia Italia e Spagna alla grandezza di Alessandro Ma-gno egrave contrapposta quella di Annibale che pure dai Romani era stato sconfitto Lrsquoattenzione poi si concentra su Filippo i Macedoni non laquodo-vevano essere valutati per lrsquoantica forza ma per le forze attuali40raquo poicheacute Filippo non era lrsquoinvitto e invincibile Alessandro Magno ma un ragaz-zo che non riusciva a difendere i propri confini I Macedoni rivendica-vano il valore degli antenati mentre i Romani quello dei propri soldati poicheacute quelli che erano ligrave schierati erano gli stessi che avevano sconfitto Annibale Dopo una cosigrave grandiosa introduzione la battaglia egrave descritta in uno dei paragrafi piugrave significativi di tutta lrsquoopera
His adhortationibus utrimque concitati milites proelio concurrunt alteri Orientis alteri Occidentis imperio gloriantes ferentesque in bellum alii maiorum suorum antiquam et ob-soletam gloriam alii uirentem recentibus experimentis uirtutis florem [16] Sed Macedo-nas Romana Fortuna uicit
I soldati incitati da queste esortazioni dallrsquouna e dallrsquoaltra parte si lanciaro-no nel combattimento vantandosi gli uni del dominio dellrsquoOriente gli altri dellrsquoOccidente e recando in guerra gli uni lrsquoantica e sbiadita gloria dei loro an-
37 Iust XXX 4 4 Quo prodigio territis omnibus uates cecinere oriens Romanorum imperium uetus Graecorum ac Macedonum uoraturum38 Sui discorsi precedenti la battaglia nellrsquoantichitagrave se da considerare reali o costruzioni storiografiche vd Adler (2011) pp 6-839 Iust XXX 4 7 tantoque hoc bellum fortius quam illa sustinendum quanto sit imperio libertas carior40 Iust XXX 4 10 Sed nec Macedonas ueteri fama sed praesentibus uiribus aestimandos
134 MONICA DrsquoAGOSTINI
tenati gli altri il fiore del loro valore fresco e vigoroso per le recenti prove Ma la Fortuna dei Romani vinse i Macedoni
Questo punto di vista probabilmente giagrave trogiano contrappone la virtugrave romana (virtutis flos) celebrata nei discorsi antecedenti la battaglia al-la Fortuna romana (Romana Fortuna) che decise la vittoria interpretabi-le come destino favorevole o buona stella Piugrave che unrsquoaffermazione anti-romana41 come egrave spesso stata intesa si puograve evidenziare il carattere sim-patetico della fonte verso Filippo V destinato a porre fine alla gloria di Filippo II e Alessandro e forse un approccio nostalgico verso i grandi regni macedoni la cui egravera egrave ormai giunta alla fine Tale prospettiva egrave as-sente in Polibio e nella tradizione che da lui dipende poco interessata alle vicende della gloria macedone leggendo infatti i frammenti soprav-vissuti del libro XVIII delle Storie dopo lrsquoaccurata descrizione della bat-taglia (18-33 e 34-40)42 Polibio commenta lo scontro affermando che avrebbe dedicato alcuni capitoli allrsquoesame delle strategie militari delle due armate percheacute (XVIII 28 4-6)
χρήσιμον καὶ καλὸν ἂν εἴη τὸ τὴν διαφορὰν ἐρευνῆσαι καὶ παρὰ τί συμβαίνει Ῥωμαίους ἐπικρατεῖν καὶ τὸ πρωτεῖον ἐκφέρεσθαι τῶν κατὰ πόλεμον ἀγώνων [5] ἵνα μὴ τύχην λέγοντες μόνον μακαρίζωμεν τοὺς κρατοῦντας ἀλόγως καθάπερ οἱ μάταιοι τῶν ἀνθρώπων ἀλλ᾽ εἰδότες τὰς ἀληθεῖς αἰτίας ἐπαινῶμεν καὶ θαυμάζωμεν κατὰ λόγον τοὺς ἡγουμένους
Puograve essere cosa buona e utile esaminare le differenze e per quale motivo i Ro-mani prevalgono e riportano il primo premio nelle competizioni di guerra af-fincheacute non esaltiamo i vincitori senza una ragione parlando solo di fortuna co-me fanno gli sciocchi ma conoscendo le vere cause lodiamo e ammiriamo i co-mandanti seguendo una logica
Polibio dunque sembra rispondere a coloro che parlavano della buo-na stella dei Romani sottolineando che la vittoria nasceva dalla superio-re strategia militare della legione43 Un punto di vista quindi opposto a quello espresso nellrsquoEpitome che proprio di Romana Fortuna parla e riba-dito in chiusura al passo dove Polibio critica nuovamente quei Greci che ritenevano la vittoria romana incredibile (XVIII 32 13)
41 Urban (1982) pp 1424-1443 1435 Richter (1987) p 19 n 4 Alonso-Nuacutentildeez (1992) p 66 e Id (2002) pp 105-110 partic 108-109 Contra Heckel (1997) p 29 che ridimen-siona la categorizzazione di Trogo come storico anti-romano 42 Su Cinoscefale vd Walbank (1957) ad l Hammond (1988) pp 60-82 Sklenaacuter (2004) pp 302-310 Thornton (2014) pp 83-87 43 Sulla Fortuna in Polibio vd McGing (2010) pp 195-201 (con bibliografia) che distin-gue tra quando Polibio intenda caso e quando predeterminazione fato Vd anche Green (1990) pp 400-402 e Eckstein (2008) pp 132-138
IL DISCORSO DEL RE 135
Il punto di vista di Trogo sembra invece presente nei frammenti del-la Makedonikeacute di Appiano su Filippo V44 dove ci si riferisce a Cinoscefale come a una vittoria insperata (Mak 9 1)
ἡγούμενος δ᾽ οὔτε Ῥωμαίοις συμφέρειν οὔτε τοῖς Ἕλλησι Φιλίππου καθαιρεθέντος ἐπιπολάσαι τὴν Αἰτωλῶν βίαν τάχα δ᾽ αὐτὸν καὶ τὸ παράδοξον τῆς νίκης ἀγαπᾶν ἐποίει
Flaminino era consapevole che non sarebbe stato vantaggioso per i Romani o per i Greci che Filippo fosse deposto e che il potere etolico rimanesse incon-trastato forse lo aveva reso moderato nei suoi progetti lrsquoaver ottenuto una vit-toria insperata
Addirittura successivamente si accenna alla sorte avversa a Filippo nel-lo scontro
τὰ μὲν δὴ παρὰ τῶν ἄλλων φιλάνθρωπα ἦν τό τε τῆς τύχης ἄδηλον ἐξ ὧν ἔπαθεν ὁ Φίλιππος ὑφορωμένων καὶ τὸ πταῖσμα τοῦτο οὐ κατ᾽ ἀσθένειαν ἀλλὰ πλέον ἐκ συντυχίας αὐτὸν παθεῖν ἡγουμένων
Gli altri (Greci) erano inclini ad essere moderati vedendo con sospetto lrsquoincer-tezza della fortuna subita da Filippo e ritenendo che egli fosse incorso in questa sconfitta non tanto per la sua inferioritagrave quanto per la sfortuna
Il riferimento in Appiano e Trogo alla fortuna romanasfortuna ma-cedone a proposito di Cinoscefale egrave una traccia dellrsquoopinione politi-ca di quei Greci disprezzati da Polibio come uomini sciocchi καθάπερ οἱ μάταιοι τῶν ἀνθρώπων Tale posizione politica su Cinoscefale sarebbe dunque sopravvissuta nella tradizione storiografica di cui troviamo trac-cia in TrogoGiustino e Appiano
Per comprendere meglio alcune caratteristiche di questa tradizione puograve essere utile tornare ai due discorsi nellrsquoEpitome di Filippo e Flamini-no prima della battaglia Tali passi probabilmente trogiani45 non trova-no infatti riscontro nelle fonti parallele a noi pervenute Polibio (XVIII 18-27) seguito fedelmente da Livio (XXXIII 5-10) pur descrivendo le operazioni di guerra di Cinoscefale con dovizia di particolari non men-ziona un discorso di Filippo ai suoi armati prima della battaglia mentre il discorso di Flaminino per incoraggiare le truppe schierate (XVIII 23 2-6) nelle Storie egrave incentrato sulle vittorie di Sulpicio nella prima parte della guerra Pare dunque originale la versione trogiana che incentra-
44 Tra i frammenti consegnatici dagli Excerpta Constantiniana sono frequenti informazio-ni e osservazioni che rimandano a una prospettiva ellenistica sugli eventi DrsquoAgostini (2011) pp 99-121 45 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362
136 MONICA DrsquoAGOSTINI
ta sulla gloria macedone presenta Cinoscefale come il punto drsquoincon-tro e di scambio tra lrsquoegemonia macedone e lrsquoegemonia romana Non egrave una novitagrave che il leitmotiv delle Storie Filippiche e dunque dellrsquoEpitome sia la translatio imperii giagrave Alonso Nuntildeez definito da Santi Amantini laquouno dei piugrave noti esperti di questioni trogiano-giustineeraquo46 osservava che Tro-go esponeva nel suo perduto lavoro la teoria della successione degli im-peri mondiali secondo lo schema Assiria-Media-Persia-Macedonia-Roma osteggiata dai Parti47 In tale successione il ruolo da protagonista egrave rico-perto dallrsquoegemonia macedone48 che occupa allrsquoincirca 26 dei 44 libri e il cui ultimo vero momento di gloria egrave lo scontro con Roma appunto a Cinoscefale Lrsquoultima impresa macedone ha come esito la transizione del dominio universale da Oriente a Occidente e costituisce il tema cen-trale dellrsquointera vicenda di Filippo lrsquoimportanza della battaglia di Cino-scefale egrave perciograve esaltata nei discorsi sia di Filippo che di Flaminino che a loro volta sono il punto di arrivo delle argomentazioni esposte nelle parole di Demetrio di Faro e di Filippo stesso giagrave nel libro XXIX Le ora-tiones disposte retoricamente nei due libri descrivono due parabole op-poste da un lato quella romana che da lontana potenza desiderosa di espandersi cresce come una pioggia di sangue diventando il giovane e vigoroso potere che sottomesso Annibale egrave pronto a sconfiggere Filip-po Dallrsquoaltro quella macedone che originata con Filippo II personag-gio centrale per Trogo raggiunge il suo apice con la conquista dellrsquoege-monia ad opera di Alessandro Magno contro i Persiani per conoscere la fine con Filippo V il cui antico valore egrave ormai troppo lsquosbiaditorsquo per te-ner testa al vigore romano
La gloria macedone secondo Trogo inizia dunque con Filippo II e si conclude con Filippo V Perseo egrave infatti il malvagio responsabile dellrsquoan-nientamento di ciograve che rimaneva della monarchia macedone49 Trogo pone agli estremi della parabola macedone che occupa dal libro IX al XXX i due re di nome Filippo Filippo II e Filippo V come ribadito in piugrave luoghi dellrsquoEpitome sia in parti riassunte da Giustino che in passi piugrave genuinamente trogiani Dando per scontato che il titolo dellrsquoopera Sto-rie Filippiche si debba al desiderio di Trogo di rifarsi allrsquoopera di Teopom-po sul sovrano macedone egrave possibile che tale titolo sia stato perograve ripen-
46 Santi Amantini (2003) pp 99-11047 laquoPompeius Trogus expounded in his lost work the Historiae Philippicae a theory of the world empire suggestion according to the scheme Assyria-Media-Persia-Macedonia-Rome opposed by the Parthiansraquo Alonso-Nuacutentildeez (2002) pp 105-110 e 133-136 partic 105 Vd anche Richter (1987) pp 19-23 Momigliano (1980) pp 157-162 Alonso-Nuacutentildeez (1992) Heckel (1997) pp 1-41 Gabba (2003) pp 7-9 Santi Amantini (2003) pp 99-110 Mariotta (2014) pp 45-56 48 Franco (1993) pp 71-97 e Landucci (2014) pp 233-26149 Alonso-Nuacutentildeez (2002) pp 105-110 partic 108-109
IL DISCORSO DEL RE 137
sato da Trogo considerando che il periodo compreso tra le imprese dei due Filippo occupa 23 dellrsquoopera50 Si potrebbe allora suggerire che le Storie sono Filippiche poicheacute i due Filippo segnarono lrsquoinizio e la fine di quella che egrave nellrsquoopera di Trogo lrsquoegemonia incontrastata del mondo piugrave gloriosa di tutti i tempi51
La prospettiva ellenistica che vede nei due Filippo i limiti della grande egemonia macedone egrave di nuovo presente anche in Appiano nellrsquooraco-lo riportato nei frammenti della sua Makedonikeacute e noto anche da Pausa-nia (VII 8 9)
αὐχοῦντες βασιλεῦσι Μακηδόνες Ἀργεάδῃσιν ὑμῖν κοιρανέων ἀγαθὸν καὶ πῆμα Φίλιππος ἤτοι ὁ μὲν πρότερος πόλεσιν λαοῖσί τ᾽ ἄνακτας θήσει ὁ δ᾽ ὁπλότερος τιμὴν ἀπὸ πᾶσαν ὀλέσσει δμηθεὶς δ᾽ ἑσπερίοισιν ὑπ᾽ ἀνδράσιν ἐνθάδ᾽ ὀλεῖται
O Macedoni che andate orgogliosi dei re di stirpe argiva I re di nome Filippo saranno arbitri del bene e del male per voi Il primo vi renderagrave signori di cittagrave e popoli il secondo vi priveragrave di ogni onore sconfitto da uomini dellrsquoOcciden-te qui giace morto52
Senza voler entrare nel merito della discussione di tale oracolo di nuo-vo pare di incontrare nei due autori la medesima prospettiva lontana dalla condanna morale del re macedone espressa da Polibio secondo cui la sconfitta egrave il giusto esito della sua crudeltagrave ed empietagrave
Il libro giustineo si conclude menzionando le condizioni della pa-ce di Tempe53 e lrsquoira degli Etoli che videro ignorate le proprie richieste da Flaminino e perciograve cercarono lrsquoalleanza di Antioco contro Roma Se-condo il Prologo XXX il libro perograve proseguiva con le campagne di Antio-co III in Asia Minore contro Molone e Acheo e in Battriana fino ad ar-rivare allrsquoesordio dello scontro con Roma54 Il riassunto giustineo egrave trop-po sommario per permettere un confronto con le fonti parallele Egrave pe-
50 Sul rilievo della storia della Macedonia nellrsquoopera di Trogo e Giustino vd von Gutsch-midt (1894) pp 17-217 Richter (1987) p 28 n 29 Franco (1993) pp 71-97 51 Vd anche Urban (1982) pp 1424-1443 e Alonso-Nuacutentildeez (1992) p 58 52 Mak Fr 2 Vd DrsquoAgostini (2011) pp 99-121 In questa Walbank (2002) pp 127-136 propone di interpretare anche un poema di Alceo di Messene (Anth Pal 9518)53 Egrave probabile che Trogo fornisse piugrave particolari riguardo a questa pace per esempio si puograve ritenere che vi fosse menzione dellrsquoinvio a Roma del figlio Demetrio da parte di Filippo come ostaggio dato che a Iust XXXII 2 3 si richiama appunto tale avvenimento54 Polyb XVIII 34 1-39 7 42 1-45 12 Liv XXXIII 11 3-13 15 24 1-31 11 Plut Flam IX 1-8 App Mak Fr IX riferiscono di due diverse trattative di pace caratterizzate da un vivace dibattito tra chi voleva lrsquoannientamento della Macedonia come in Grecia gli Etoli e a Roma Marco Claudio Marcello e coloro che desideravano la pace con la Macedonia in primis Flaminino
138 MONICA DrsquoAGOSTINI
rograve da notare la mancanza sia nel Prologo che nel testo del libro degli av-venimenti delle celebrazioni Istmie del 196 quando Flaminino procla-mograve la libertagrave dei Greci Piugrave in generale in tutta la narrazione di Giustino delle complesse trattative del 197-196 manca qualsiasi riferimento alla li-bertagrave dei Greci punto nodale nella tradizione di Polibio che con questa sottolineatura esalta sia il ruolo tirannico della Macedonia sia la grande generositagrave dei Romani nei confronti della Grecia Il silenzio di TrogoGiustino su tale questione mostra il prevedibile disinteresse per gli affari dei Greci e nel contempo conferma la presenza di una tradizione che si occupa soprattutto della storia delle monarchie ellenistiche allrsquointer-no della quale la posizione dellrsquoEllade egrave subalterna
Libro XXXII23- 34 Demetrio e Perseo
Gli ultimi anni di regno di Filippo tra il 183 e il 179 sono narrati in un passo breve del libro XXXII Il racconto in Giustino che egrave coerente con il Prologo trogiano segue in maniera sintetica la tradizione polibiana su questi eventi giunta a noi in alcuni passi lacunosi di Polibio (XXIII 1 3-3 10 7 1-7 10 1-11 8) integrati dal racconto particolareggiato di Li-vio (XXXIX 46 7- 48 6 53 1-16 XL 3 3-16 3 201-24 8) e dalla narra-zione di Diodoro (XIX 25) e Plutarco (Aem VIII 11)55
Conclusioni
In questi libri dedicati a Filippo egrave forse possibile vedere in filigrana la rielaborazione voluta di Giustino dei corrispondenti libri trogiani Co-me Giustino stesso afferma nella Prefatio 3 lrsquoopera di Trogo era costruita secondo due criteri quello cronologico e quello per laquoconcatenazione di eventi56raquo ea omnia Pompeius diuisa temporibus et serie rerum digesta conposuit
55 Lrsquoutilizzo della tradizione polibiana in Trogo egrave confermato dallrsquoaderenza a Livio (XL 54 1-56 11) e Diodoro (XXIX 28) del racconto sul pentimento di Filippo per aver ucciso il figlio Demetrio lrsquointenzione di punire Perseo e la correlazione tra questo e la sua mor-te Questo libro egrave dunque differente nellrsquointeresse e nelle fonti dai libri XXIX e XXX poicheacute molto vicino alla tradizione polibiana in Livio Questi avvenimenti in Giustino sono da collegare con lrsquoascesa al trono di Perseo e non con lrsquoepilogo della celebrazione del valore macedone giagrave conclusasi in Giustino con Cinoscefale e la transizione dallrsquoim-perium macedone allrsquoimperium romano Vd Heckel (1997) p 7 Appiano invece riporta ancora una tradizione diversa da quella polibiana in un frammento della Makedonikeacute in particolare Appiano egrave attento al punto di vista macedone e presenta Filippo come una vittima delle circostanze (Mak IX) DrsquoAgostini (2011) pp 99-12156 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362 Alonso-Nuacutentildeez (2002) pp 133-136 He-ckel (1997) pp 1-41 Borgna (2014) pp 52-77
IL DISCORSO DEL RE 139
Serie rerum digesta sembrerebbe unrsquointerpretazione latina della formula κατὰ γένος che Diodoro usa per indicare la struttura della storia di Efo-ro sottolineandone la divisione per argomento57 In tale struttura per argomento dellrsquoEpitome tra i temi principali ci sono dunque il valore e la gloria dei sovrani ellenistici58 riscontrabile nei libri XXVIII-XXXI sui re-gni di Antigono Dosone Filippo V e Antioco III Tale tema presente di sicuro in Trogo egrave conservato nellrsquoazione dellrsquoEpitomatore e anzi come si vede dagli escerpta esaltato dalla selezione dei passi
Per quanto riguarda invece la Quellenforschung 59 egrave evidente che nel testo vi sia presenza di filoni non tradizionali sugli eventi poicheacute la posi-zione di Trogo appare spesso autonoma rispetto alle opinioni condivise dalla storiografia antica Questo aspetto dellrsquoEpitome evidente soprattut-to per ciograve che riguarda gli eventi ellenistici ha suscitato la grande curio-sitagrave degli studiosi che allontanatisi dalla proposta di von Gutschmid che voleva una totale ed esclusiva dipendenza di Trogo da Timagene ora in-dicano con sicurezza tra le fonti piugrave rilevanti per gli eventi ellenistici di III secolo utilizzate da Trogo almeno altri sei nomi oltre a Timagene Ie-ronimo Timeo Filarco Duride Polibio e Posidonio
Per quanto riguarda nello specifico la composizione dei libri XXIX e XXX non vi egrave alcun dubbio che in essi Trogo abbia utilizzato (anche riadattandola) una fonte poco attenta alle questioni di politica interna greca e al legame tra queste e quel ritratto di Filippo come sovrano mal-vagio ed empio che ritorna nella tradizione ufficiale di origine polibia-na passando poi da Polibio in Livio Diodoro e Plutarco60 Trogo pre-serva invece una tradizione ellenistica interessata alla figura di Filippo come ultimo barlume della gloria macedone tradizione che pare quasi una controparte e un completamento dellrsquoAb urbe condita romanocentri-ca di Livio Non si puograve perciograve a mio avviso escludere che per questa se-zione Trogo abbia usato una tradizione di matrice filoellenistica o sem-plicemente ellenisticocentrica unrsquoopera sui regni di diadochi ed epigo-ni che a tutti noi fa venire facilmente alla mente il Basileis o Perigrave Basileon dello storico grecoellenistico augusteo filobarbaro scettico (o critico) verso lrsquoegemonia romana Timagene di Alessandria (FGrHist 88)61
57 Su Eforo vd Vannicelli (1987) pp 165-191 e ora Parmeggiani (2011) 58 Simile legame vi egrave a mio avviso tra i libri XXVI e XXVII che invece affrontavano la crisi delle monarchie ellenistiche causata dalle guerre fraterne59 Vd von Gutschmid (1894) pp 17-217 Richter (1987) pp 17-30 partic 20-23 San-ti Amantini (1972) pp 56-109 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362 Urban (1982) pp 1424-1443 partic 1435 Mecca (2001) pp 199-222 Santi Amantini (2003) pp 99-110 Heckel (2012) pp 3-860 Scuderi (2005) pp 383-40561 Sordi (1982) pp 775-797 Heckel (1997) pp 30-34 Landucci (2014) pp 233-261 e Ead in questo volume
140 MONICA DrsquoAGOSTINI
ABSTRACT
Philip V of Macedon was the first of the Epigonoi to face Rome Several mod-ern reconstructions of the actions and the reign of Philip V have approached it largely from a Roman point of view using as sources Polybius and where Poly-bius is lost Livy The Polybian historiographical tradition tends to portray Phil-ip V as an enemy and a tyrant impious and cruel The Macedonian king was ea-ger to establish a universal and unjust dominion over Greece Italy and beyond and Rome engaged in the first two Macedonian Wars to fight the threat of his growing ambition Nevertheless Polybiusrsquo portrayal of Philip V was affected not only by Polybiusrsquo admiration for Roman political structures military power and overwhelming conquest but also his personal Achaean origins
Looking at in book 29 and 30 of Justinrsquos Epitome of Pompeius Trogus this pa-per focuses on the non Polybian tradition on Philip V this contribution is in-deed the first analysis of the Hellenistic approach to the clash between Rome and Macedonia in the 3rd-2nd Century BC The Epitome shows a considerable di-versity of interpretation from the other sources and reflects very different views of Philip Vrsquos actions that brought him into conflict against Rome In particular these views are more evident related to the accounts of the peace negotiations of Naupactus and the battle of Cynoscephalae in the Epitome the king appears as a courageous and skilled warrior the last of the great Macedonian rulers who fell victim to misfortune This portrayal which has several common features with Appianrsquos fragments of Philip V (Mak 9) counterbalances the Roman and Achaean standpoint present in Polybius providing a more Hellenistic perspec-tive that is likely to have been rooted in a historiographical tradition connect-ed to the losing side in the struggle between Rome and the Hellenistic world
BIBLIOGRAFIA
Adler E (2006) Whorsquos Antiroman Sallust and Pompeius Trogus on Mithridates CJ 101 pp 383-407
Adler E (2011) Valorizing the Barbarians Enemy speeches in Roman Historiography Austin
Ager SL (2003) An Uneasy Balance from the Death of Seleukos to the Battle of Raph-ia in A Erskine (ed) A Companion to the Hellenistic World Oxford pp 35-50
Ager SL (2009) Roman Perspectives on Greek Diplomacy The conceptual clash Greek diplomacy of compromise and Roman Bellum Iustum in C Eilers (ed) Diplomats and Diplomacy in the Roman World Leiden-Boston pp 15-43
Alonso-Nuacutentildeez JM (1992) La Historia Universal de Pompeyo Trogo Madrid
Alonso-Nuacutentildeez JM (2002) The Idea of Universal History in Greece From Herodotus to the Age of Augustus Amsterdam
Ballesteros Pastor L (2013) Pompeyo Trogo Justino y Mitriacutedates Comentario al Epiacutetome de las Historias Filiacutepicas (3716-3881) Hildesheim-Zuumlrich-New York
IL DISCORSO DEL RE 141
Barreacute ML (1983) The God-List in the Treaty between Hannibal and Philip V of Ma-cedon a Study in Light of the Ancient Near Eastern Treaty Tradition Baltimore-Lon-don
Beck H - Eckstein A (2015) sv ldquoAratos of Sicyon (231)rdquo in I Worthington (ed) Brillrsquos New Jacoby Brill Online
Borgna A (2014) Uno sguardo originale intorno a Roma Pompeo Trogo e Giustino laquoLa Biblioteca di ClassicoContemporaneoraquo 1 pp 52-77
Cassola F (1962) I gruppi politici romani nel III secolo aC Trieste
Champion CB (1997) The Nature of Authoritative Evidence in Polybios and Agelausrsquo Speech at Naupactos TAPhA 127 pp 111-128
Champion CB (2004) Cultural Politics in Polybiusrsquo Histories Berkeley
Coppola A (1993) Demetrio di Faro un protagonista dimenticato Roma
Criscuolo L (2011) I due testamenti di Tolemeo VIII Evergete II in A Joumlrdens - J F Quack (hrsg) Aumlgypten zwischen innerem Zwist und aumluszligerem Druck Die Zeit Ptole-maios VI bis VIII Wiesbaden pp 132-150
DrsquoAgostini M (2011) Filippo V e la Storia Romana di Appiano laquoAevumraquo 85 pp 99-121
Eckstein AM (1995) Moral vision in the Histories of Polybius Berkeley
Eckstein AM (2008) Rome enters in the Greek East From Anarchy to Hierarchy in the Hellenistic Mediterranean 230-217 BC Oxford
Eckstein AM (2013) Polybius Phylarchus and Historiographical Criticism CPh 108 4 pp 314-338
Errington RM (1969) Philopoemen Oxford
Errington RM (2008) A History of the Hellenistic World 323-30 BC Malden MA-Oxford
Forni G - Angeli Bertinelli MG (1982) Pompeo Trogo come fonte di storia ANRW II 30 2 pp 1298-1362
Franco C (1993) Trogo Giustino e i successori di Alessandro in L Braccesi - A Coppola - G Cresci Marrone - C Franco (a cura di) LrsquoAlessandro di Giustino dagli antichi ai moderni Roma pp 71-97
Gabba E (2003) Introduzione in D Foraboschi - SM Pizzetti (a cura di) La successione degli imperi e delle egemonie nelle relazioni internazionali Milano pp 7-9
Golan D (1995) The Res Graeciae in Polybius Four Studies Como
Green P (1990) Alexander to Actium The Historical Evolution of the Hellenistic Age Berkeley-Los Angeles
Gutschmid von A (1894) Die beiden ersten Buumlcher des Pompeius Trogus in A von Gutschmid - F Ruumlhl (hrsg) Kleine Schriften Leipzig pp 17-217
142 MONICA DrsquoAGOSTINI
Habicht C (1995) Athen Muumlnchen
Hammond NGL (1968) Illyris Rome and Macedon in 229-205 BC JRS 58 pp 1-21
Hammond NGL (1988) The Campaign and the Battle of Cynoscephalae in 197 BC JHS 108 pp 60-82
Heckel W (1997) Introduction (Part 2) in JC Yardley - W Heckel (eds) Ju-stin Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus Books 11-12 Alexander the Great Introduction Oxford pp 1-41
Heckel W (2012) Introduction in JC Yardley - P Wheatley - W Heckel (eds) Justin Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus II Books 13-15 The Successors to Alexander the Great Oxford pp 1-8
Huss W (1976) Untersuchungen zur Auszligenpolitik Ptolemaiosrsquo IV Muumlnchen
Huss W (2001) Aumlgypten in hellenistischer Zeit 332ndash30 v Chr Muumlnchen
Intrieri M (2011) Fra dialogo e conflitto Annibale e i Greci drsquoOccidente RStudFen 37 pp 53-82
Landucci F (2014) Filippo II e le Storie Filippiche un protagonista storico e storio-grafico in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 233-261
Landucci Gattinoni F (2011) Politica e ideologia in etagrave ellenistica laquoPolitica An-ticaraquo 1 pp 89-105
Leacutevy E (1994) Le discours drsquoAgeacutelaos de Naupacte in L Aigner Foresti - A Bar-zanograve - C Bearzot - L Prandi - G Zecchini (a cura di) Federazioni e federalismo nellrsquoEuropa antica Bergamo 21-25 settembre 1992 Milano (Alle radici della casa co-mune europea 1) pp 33-50
Longaretti L (1989) Lrsquoalleanza tra Annibale e Filippo V di Macedonia RIL 123 pp 183-192
Marasco G (1979-1980) La valutazione di Tolemeo IV Filopatore nella storiografia greca laquoSilenoraquo 5-6 pp 159-182
Mari M [- Musti D - Thornton J] (2002) Polibio Storie Volume III Libri V-VI Milano
Mariotta G (2014) Geografia e Geopolitica nelle Storie Filippiche in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 45-56
McGing B (2010) Polybiusrsquo Histories New York
McGing B (2013) Youthfulness in Polybius the case of Philip V of Macedon in B Gibson - T Harrison (eds) Polybius and his world Oxford pp 181-199
Meadows A (2013) Polybius Aratus and the History of the 140th Olympiad in B
IL DISCORSO DEL RE 143
Gibson - T Harrison (eds) Polybius and his World Essays in Honour of Frank Walbank Oxford pp 91-116
Mecca A (2001) Trogo Timagene e Polieno QS 54 pp 199-222
Meister K (1990) Die Griechische Geschichtsschreibung von den Anfaumlngen bis zum Ende des Hellenismus Stuttgart
Misch G (1949) Geschichte der Autobiographie I Frankfurt am Mein
Momigliano A (1980) Daniele e la teoria greca della successione degli imperi RAL 35 pp 157-162
Muccioli F (2013) Gli epiteti ufficiali dei re ellenistici Stuttgart (Historia Einzel-schriften 224)
Musti D (1978) Polibio e lrsquoimperialismo romano Napoli
Parmeggiani G (2011) Eforo di Cuma studi di storiografia greca Bologna
Peacutedech P (1964) La meacutethode historique de Polybe Paris
Pelling CBR [- Scardigli B - Manfredini M](1997) Plutarco Vite parallele Filopemene Tito Flaminino Milano
Richter H-D (1987) Untersuchungen zur hellenistischen Historiographie die Vorla-gen des Pompeius Trogus fuumlr die Darstellung der nachalexandrischen hellenistischen Ge-schichte (Iust 13-40) Frankfurt
Santi Amantini L (1972) Fonti e valore storico di Pompeo Trogo (Iustin XXXV e XXXVI) Genova
Santi Amantini L (1981) (a cura di) Giustino Storie Filippiche Epitome da Pom-peo Trogo Milano
Santi Amantini L (2003) Il tempo e i tempi nelle Storie Filippiche di Pompeo Tro-go RSA 33 pp 99-110
Schepens G (1983) Les rois ptolegravemaiumlques et lrsquohistoriographie Reacuteflexions sur la trans-formation de lrsquohistoire politique in E vanrsquot Dack - P van Dessel - W Van Gucht (eds) Egypt and the Hellenistic World Proceedings of the International Collo-quium Leuven 24-26 May 1982 Leuven (Studia Hellenistica 27) pp 351-368
Schlicher JJ (1933) Non-Assertive Elements in the Language of the Roman Histo-rians CPh 28 289-300
Schmitt T (1989) Die Bedeutung des zweiten Punischen Krieges fuumlr den Frieden in Naupaktos in H Devijver - E Lipinski (eds) Punic wars Proceedings of the Conference held in Antwerp from the 23th to the 26th of November 1988 in Cooperation with the Departement of History of the laquoUniversitait Antwerpenraquo UFSIA Leuven (Studia Phoenicia 10) pp 229-239
Scholten JB (2000) The Politics of Plunder Aitolians and their koinon in the early Hellenistic Era Berkeley
144 MONICA DrsquoAGOSTINI
Scuderi R (2005) Filippo V e Perseo nei frammenti diodorei in C Bearzot - F Lan-ducci (a cura di) Diodoro e lrsquoaltra Grecia Macedonia Occidente Ellenismo nella Bi-blioteca Storica Atti del convegno Milano 15-16 gennaio 2004 Milano pp 383-405
Sklenaacuter RJ (2004) Sources and Individuality in Two Passages of Livy laquoHistoriaraquo 53 pp 302-310
Sordi M (1982) Timagene di Alessandria Uno storico ellenocentrico e filobarbaro ANRW II 30 1 pp 775-797
Thornton J (2014) Le guerre macedoniche Roma
Urban R (1979) Wachstum und Kriese des achaumlischen Bundes Quellenstudien zur entwicklung des Bundes von 280 bis 222 V Chr Wiesbaden
Urban R (1982) laquoGallisches Bewusstseinraquo und laquoRomkritikraquo bei Pompeius Trogus ANRW II 30 2 pp 1424-1443
Vannicelli P (1987) Lrsquoeconomia delle Storie di Eforo RFIC 115 pp 165-191
Vattuone R (2014) Giustino e lrsquoOccidente greco I VI-V secolo aC in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 261-277
Vollmer D (1990) Symploke das Uumlbergreifen der roumlmischen Expansion auf den grie-chischen Osten Untersuchungen zur roumlmischen Aussenpolitik am Ende des 3 Jh V Chr Stuttgart
Walbank FW (1957) A Historical Commentary on Polibius I Oxford
Walbank FW (1967) A Historical Commentary on Polybius II Oxford
Walbank FW (1933) Aratos of Sicyon Cambridge
Walbank FW (2002) Η ΤΩΝ ΟΛΩΝ ΕΛΠΙΣ and the Antigonids in FW Walbank (ed) Polybius Rome and the Hellenistic World Essays and Reflections West Nyack NY pp 127-136
Weber G (1997) Interaktion Repraumlsentation und Herrschaft Der Koumlnigshof im Hel-lenismus in A Winterling (hrsg) Zwischen lsquoHausrsquo und lsquoStaatrsquo antike Houmlfe im Ver-gleich Munich pp 27-72
Will E (19822) Histoire politique du Monde Helleacutenistique II Nancy
Zecchini G (1990) La storiografia lagide in H Verdin - G Schepens - E De Keyser (eds) Purposes of History Studies in Greek Historiography from the 4th to the 2nd Centuries BC Proceedings of the International Colloquium of Leuven 24-26 May 1988 Leuven (Studia Hellenistica 30) pp 213-232
Zecchini G (2003) Polibio e la tradizione orale in A Casanova - P Desideri (a cura di) Evento racconto scrittura nellrsquoantichitagrave classica Firenze pp 123-141
Finito di stamparenel mese di novembre 2015
da LegoDigit srlLavis (TN)
IL DISCORSO DEL RE 131
dellrsquoEst e dellrsquoOvest La prima avvisaglia dellrsquoincombente guerra egrave la no-tizia dellrsquoaccordo di Filippo V e Antioco III per la spartizione dellrsquoEgitto governato dal sovrano-bambino Tolemeo V Il sovrano lagide nel 2032 chiese aiuto ai Romani che secondo TrogoGiustino gradirono la ri-chiesta drsquoaiuto percheacute cercavano pretesti per muovere guerra contro Fi-lippo A partire da Polibio numerose altre fonti ci testimoniano questo episodio mettendolo in relazione con lo scoppio della Seconda Guerra Macedonica ed esprimendo una condanna morale per lrsquoempia condotta del re antigonide che cospira contro un bambino33 al contrario nellrsquoE-pitome si esalta la potenza macedone evidenziando la paura dei Romani delle grandi imprese di Filippo (XXX 3 2)
nullius magis arma metuebant reputantibus quantum motum Pyrrhus parua Macedo-num manu in Italia fecisset quantasque res Macedones in Oriente gessissent
di nessun altro temevano maggiormente le armi poicheacute ripensavano a quanto sconvolgimento Pirro aveva provocato in Italia con una piccola schiera di Ma-cedoni e a quanto grandi imprese i Macedoni avevano compiuto in Oriente
La supremazia macedone egrave anche al centro del discorso in oratio obliqua di Filippo allrsquoincontro nel Golfo Maliaco tra i rappresentanti dei fronti coinvolti nella Seconda Guerra Macedonica34 NellrsquoEpitome infatti dopo
la Quarta Guerra Siriaca conclusa con sconfitta a Rafia contro Antioco III nel 217 e la corruzione del sovrano da parte di Agatocle e della sorella una cortigiana che avrebbe sedotto il re Giustino riferisce poi la morte del sovrano nel 204 e lrsquoascesa al trono del piccolo Tolemeo V Epifane sovrano sotto tutela di Tlepolemo dopo la morte di Agatocle e Sosibio 33 Eckstein (2008) pp 121-180 Thornton (2014) pp 65-88 In particolare sulla relazione tra il complotto e la sconfitta antigonide e seleucidica ad opera di Roma la superioritagrave morale romana ai regni ellenistici e la causalitagrave storica in Polibio (XV 20 6) vd Eck-stein (2008) pp 133-138 Ager (2009) pp 15-43 Landucci Gattinoni (2011) pp 89-105 Secondo Polyb III 2 8 XV 20 XVI 1 8-9 seguito da Liv XXXI 14 5 Filippo avrebbe ottenuto le basi tolemaiche in Egeo Samo e la Caria mentre Antioco avrebbe finalmente avuto mano libera in Celesiria e Fenicia oggetto di quasi un secolo di lotte tra Tolemei e Seleucidi La notizia del trattato permette a Polibio di dedicare alcuni paragrafi (XV 20) a condannare aspramente lrsquooperato di Filippo V e Antioco III definendoli empi e senza pudore e dichiarando che la Fortuna punigrave i due sovrani per il loro crudele operato por-tando i Romani contro di loro vd infra App Mak Fr IV trasmette delle clausole secondo cui Antioco avrebbe avuto lrsquoEgitto e Cipro mentre Filippo avrebbe ottenuto Cirene le Cicladi e la Ionia Infine secondo Porfirio FGrHist 260 F 45 lrsquoaccordo prevedeva che i due sovrani annettessero i possedimenti tolemaici confinanti con i rispettivi regni 34 Prima si menziona unrsquoambasceria del Senato a Filippo e Antioco percheacute laquosi astenessero dallrsquoEgittoraquo e la visita di Lepido in Egitto Quindi le lamentele a Roma di Attalo e i Rodii nei confronti di Filippo Egrave probabile che a questo punto Trogo inserisse la campagna di Filippo in Asia contro Attalo menzionata nel Prologo XXX ma tagliata nellrsquoEpitome La cronologia degli scambi diplomatici precedenti la Seconda Guerra Macedonica egrave stra-volta dalla sintesi dellrsquoEpitomatore e rende impossibile qualsiasi confronto con le altre
132 MONICA DrsquoAGOSTINI
il riassunto delle ambascerie nel Mediterraneo preludio allo scontro della prima fase della guerra35 maggior spazio egrave dato al tentativo di pa-ce a Nicea tra Roma Attalo i Rodii gli Achei e gli Etoli e Filippo V nel 198 In questa occasione Filippo rivendica la posizione di dominio dei Macedoni sui Greci ereditata da Filippo II e Alessandro suoi antenati e in virtugrave di tale supremazia macedone rifiuta che i Greci gli dettino le condizioni di pace ma chiede che sia il Senato a decidere Egrave significati-vo che non solo il discorso di Filippo non compaia in nessuna delle fon-ti parallele che descrivono nel particolare le posizioni degli ambasciato-ri di Achei Etoli Rodii e Attalo ma che Polibio (XVIII 8 8)36 affermi che era difficile sapere cosa si fossero detti Filippo e Flaminino durante i colloqui nel Golfo Maliaco Secondo la tradizione polibiana infatti il sovrano accompagnato da due philoi macedoni Apollodoro e Demoste-ne chiese di allontanare dalle trattative tutti tranne i Romani e discus-se la pace solamente con Flaminino Successivamente a causa dellrsquoinca-pacitagrave di trovare un accordo Filippo chiese due mesi di tregua e lrsquointer-vento del Senato Trogo dunque restituisce il discorso che il resto della tradizione riteneva impossibile da conoscere indicando chiaramente la presenza di una fonte diversa rispetto a Polibio su questo avvenimento piugrave informata sul punto di vista di Filippo e interessata a evidenziare la convinzione di Filippo V di avere un diritto di supremazia sulla Grecia in virtugrave delle imprese di Filippo II e Alessandro
La battaglia di Cinoscefale nel 197 momento risolutivo dello scontro tra Roma e Macedonia egrave lrsquoevento principale del libro XXX omina e pre-sagi introducono lrsquoevento campale lrsquoeruzione del vulcano di Santorini
fonti In Polyb XVI 24 3 App Mak Fr IV Liv XXXI 1 10 21 5 5 Paus I 36 5-6 vi sono differenti versioni della sequenza delle ambascerie che denunciarono a Roma lrsquoe-spansionismo macedone ma tutte concordano che le ambascerie precedettero lrsquoinvio dei legati romani in Oriente e che esse furono inviate anche da Atene e dagli Etoli Inoltre secondo la tradizione polibiana (Polyb XVI 27 1-4 34 1-7 Liv XXXI 2 3 6 3-8 4 18 1-9 Diod XXVIII 6) vi furono due diverse ambascerie di cui la seconda sarebbe stato un ultimatum al sovrano recapitato da Lepido In occasione di questa seconda ambasceria avvenuta durante il cruento assedio di Abido Filippo avrebbe detto che i Macedoni in ca-so di guerra si sarebbero difesi con valore In Giustino si puograve notare che ancora una volta dagli eventi sono omesse notizie fondamentali sui Greci nello specifico lrsquoambasceria di Atene la cui disputa con gli Acarnani fu il casus belli della guerra contro Filippo 35 Come i prodromi anche la prima parte della Seconda Guerra Macedonica egrave sintetizza-ta in Giustino e occupa solamente due paragrafi Come spesso accade nei passi sintetiz-zati dallrsquoEpitomatore si trovano le incongruenze maggiori con le fonti parallele tra cui si nota soprattutto la completa omissione di Giustino delle campagne di Publio Sulpicio Galba Massimo di Villio delle vittorie di Tito e Lucio Flaminino e dellrsquoassemblea del 198 che portograve gli Achei ad allearsi con Roma Polyb XXII e Liv XXXI 14 1- 46 16 XXXII 1 1-25 12 App Mak Fr VII Plut Fil 17 4 Flam 5 4 e Paus VII 8 1-236 Le trattattive sono descritte con particolari in Polyb XVIII 1-12 seguito da Liv XXXII 32 6-36 10 e Plut Flam 5 8 e 7 1-3
IL DISCORSO DEL RE 133
nel 197 e lrsquoemergere dellrsquoisola di Hiera e in contemporanea il terremo-to a Rodi Quindi nellrsquoEpitome si annuncia che laquoil nascente impero dei Romani avrebbe divorato quello antico dei Greci e dei Macedoni37raquo Nel passo ricevono spazio soprattutto i due discorsi contrapposti del re ma-cedone Filippo e del comandante romano Flaminino pronunciati pri-ma dello scontro campale e costruiti ciascuno in modo da celebrare le imprese delle due potenze38 Lrsquoenfasi data dalla contrapposizione reto-rica delle parole dei generali egrave tale da rendere suggestiva lrsquoipotesi che lo scontro dovesse essere il momento centrale non solo del libro XXX ma forse di tutta lrsquoopera trogiana
Filippo elenca le grandi vittorie del passato dei Macedoni contro Per-siani Battriani Indiani e le popolazioni drsquoAsia fino allrsquoestremo Orien-te esortando i suoi a combattere con valore percheacute laquola libertagrave egrave piugrave cara del predominio39raquo Il discorso di Flaminino egrave invece piugrave lungo articola-to in un paragone tra Macedoni e Romani alle passate imprese di con-quista macedoni vengono contrapposte le piugrave recenti vittorie romane a Cartagine in Sicilia Italia e Spagna alla grandezza di Alessandro Ma-gno egrave contrapposta quella di Annibale che pure dai Romani era stato sconfitto Lrsquoattenzione poi si concentra su Filippo i Macedoni non laquodo-vevano essere valutati per lrsquoantica forza ma per le forze attuali40raquo poicheacute Filippo non era lrsquoinvitto e invincibile Alessandro Magno ma un ragaz-zo che non riusciva a difendere i propri confini I Macedoni rivendica-vano il valore degli antenati mentre i Romani quello dei propri soldati poicheacute quelli che erano ligrave schierati erano gli stessi che avevano sconfitto Annibale Dopo una cosigrave grandiosa introduzione la battaglia egrave descritta in uno dei paragrafi piugrave significativi di tutta lrsquoopera
His adhortationibus utrimque concitati milites proelio concurrunt alteri Orientis alteri Occidentis imperio gloriantes ferentesque in bellum alii maiorum suorum antiquam et ob-soletam gloriam alii uirentem recentibus experimentis uirtutis florem [16] Sed Macedo-nas Romana Fortuna uicit
I soldati incitati da queste esortazioni dallrsquouna e dallrsquoaltra parte si lanciaro-no nel combattimento vantandosi gli uni del dominio dellrsquoOriente gli altri dellrsquoOccidente e recando in guerra gli uni lrsquoantica e sbiadita gloria dei loro an-
37 Iust XXX 4 4 Quo prodigio territis omnibus uates cecinere oriens Romanorum imperium uetus Graecorum ac Macedonum uoraturum38 Sui discorsi precedenti la battaglia nellrsquoantichitagrave se da considerare reali o costruzioni storiografiche vd Adler (2011) pp 6-839 Iust XXX 4 7 tantoque hoc bellum fortius quam illa sustinendum quanto sit imperio libertas carior40 Iust XXX 4 10 Sed nec Macedonas ueteri fama sed praesentibus uiribus aestimandos
134 MONICA DrsquoAGOSTINI
tenati gli altri il fiore del loro valore fresco e vigoroso per le recenti prove Ma la Fortuna dei Romani vinse i Macedoni
Questo punto di vista probabilmente giagrave trogiano contrappone la virtugrave romana (virtutis flos) celebrata nei discorsi antecedenti la battaglia al-la Fortuna romana (Romana Fortuna) che decise la vittoria interpretabi-le come destino favorevole o buona stella Piugrave che unrsquoaffermazione anti-romana41 come egrave spesso stata intesa si puograve evidenziare il carattere sim-patetico della fonte verso Filippo V destinato a porre fine alla gloria di Filippo II e Alessandro e forse un approccio nostalgico verso i grandi regni macedoni la cui egravera egrave ormai giunta alla fine Tale prospettiva egrave as-sente in Polibio e nella tradizione che da lui dipende poco interessata alle vicende della gloria macedone leggendo infatti i frammenti soprav-vissuti del libro XVIII delle Storie dopo lrsquoaccurata descrizione della bat-taglia (18-33 e 34-40)42 Polibio commenta lo scontro affermando che avrebbe dedicato alcuni capitoli allrsquoesame delle strategie militari delle due armate percheacute (XVIII 28 4-6)
χρήσιμον καὶ καλὸν ἂν εἴη τὸ τὴν διαφορὰν ἐρευνῆσαι καὶ παρὰ τί συμβαίνει Ῥωμαίους ἐπικρατεῖν καὶ τὸ πρωτεῖον ἐκφέρεσθαι τῶν κατὰ πόλεμον ἀγώνων [5] ἵνα μὴ τύχην λέγοντες μόνον μακαρίζωμεν τοὺς κρατοῦντας ἀλόγως καθάπερ οἱ μάταιοι τῶν ἀνθρώπων ἀλλ᾽ εἰδότες τὰς ἀληθεῖς αἰτίας ἐπαινῶμεν καὶ θαυμάζωμεν κατὰ λόγον τοὺς ἡγουμένους
Puograve essere cosa buona e utile esaminare le differenze e per quale motivo i Ro-mani prevalgono e riportano il primo premio nelle competizioni di guerra af-fincheacute non esaltiamo i vincitori senza una ragione parlando solo di fortuna co-me fanno gli sciocchi ma conoscendo le vere cause lodiamo e ammiriamo i co-mandanti seguendo una logica
Polibio dunque sembra rispondere a coloro che parlavano della buo-na stella dei Romani sottolineando che la vittoria nasceva dalla superio-re strategia militare della legione43 Un punto di vista quindi opposto a quello espresso nellrsquoEpitome che proprio di Romana Fortuna parla e riba-dito in chiusura al passo dove Polibio critica nuovamente quei Greci che ritenevano la vittoria romana incredibile (XVIII 32 13)
41 Urban (1982) pp 1424-1443 1435 Richter (1987) p 19 n 4 Alonso-Nuacutentildeez (1992) p 66 e Id (2002) pp 105-110 partic 108-109 Contra Heckel (1997) p 29 che ridimen-siona la categorizzazione di Trogo come storico anti-romano 42 Su Cinoscefale vd Walbank (1957) ad l Hammond (1988) pp 60-82 Sklenaacuter (2004) pp 302-310 Thornton (2014) pp 83-87 43 Sulla Fortuna in Polibio vd McGing (2010) pp 195-201 (con bibliografia) che distin-gue tra quando Polibio intenda caso e quando predeterminazione fato Vd anche Green (1990) pp 400-402 e Eckstein (2008) pp 132-138
IL DISCORSO DEL RE 135
Il punto di vista di Trogo sembra invece presente nei frammenti del-la Makedonikeacute di Appiano su Filippo V44 dove ci si riferisce a Cinoscefale come a una vittoria insperata (Mak 9 1)
ἡγούμενος δ᾽ οὔτε Ῥωμαίοις συμφέρειν οὔτε τοῖς Ἕλλησι Φιλίππου καθαιρεθέντος ἐπιπολάσαι τὴν Αἰτωλῶν βίαν τάχα δ᾽ αὐτὸν καὶ τὸ παράδοξον τῆς νίκης ἀγαπᾶν ἐποίει
Flaminino era consapevole che non sarebbe stato vantaggioso per i Romani o per i Greci che Filippo fosse deposto e che il potere etolico rimanesse incon-trastato forse lo aveva reso moderato nei suoi progetti lrsquoaver ottenuto una vit-toria insperata
Addirittura successivamente si accenna alla sorte avversa a Filippo nel-lo scontro
τὰ μὲν δὴ παρὰ τῶν ἄλλων φιλάνθρωπα ἦν τό τε τῆς τύχης ἄδηλον ἐξ ὧν ἔπαθεν ὁ Φίλιππος ὑφορωμένων καὶ τὸ πταῖσμα τοῦτο οὐ κατ᾽ ἀσθένειαν ἀλλὰ πλέον ἐκ συντυχίας αὐτὸν παθεῖν ἡγουμένων
Gli altri (Greci) erano inclini ad essere moderati vedendo con sospetto lrsquoincer-tezza della fortuna subita da Filippo e ritenendo che egli fosse incorso in questa sconfitta non tanto per la sua inferioritagrave quanto per la sfortuna
Il riferimento in Appiano e Trogo alla fortuna romanasfortuna ma-cedone a proposito di Cinoscefale egrave una traccia dellrsquoopinione politi-ca di quei Greci disprezzati da Polibio come uomini sciocchi καθάπερ οἱ μάταιοι τῶν ἀνθρώπων Tale posizione politica su Cinoscefale sarebbe dunque sopravvissuta nella tradizione storiografica di cui troviamo trac-cia in TrogoGiustino e Appiano
Per comprendere meglio alcune caratteristiche di questa tradizione puograve essere utile tornare ai due discorsi nellrsquoEpitome di Filippo e Flamini-no prima della battaglia Tali passi probabilmente trogiani45 non trova-no infatti riscontro nelle fonti parallele a noi pervenute Polibio (XVIII 18-27) seguito fedelmente da Livio (XXXIII 5-10) pur descrivendo le operazioni di guerra di Cinoscefale con dovizia di particolari non men-ziona un discorso di Filippo ai suoi armati prima della battaglia mentre il discorso di Flaminino per incoraggiare le truppe schierate (XVIII 23 2-6) nelle Storie egrave incentrato sulle vittorie di Sulpicio nella prima parte della guerra Pare dunque originale la versione trogiana che incentra-
44 Tra i frammenti consegnatici dagli Excerpta Constantiniana sono frequenti informazio-ni e osservazioni che rimandano a una prospettiva ellenistica sugli eventi DrsquoAgostini (2011) pp 99-121 45 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362
136 MONICA DrsquoAGOSTINI
ta sulla gloria macedone presenta Cinoscefale come il punto drsquoincon-tro e di scambio tra lrsquoegemonia macedone e lrsquoegemonia romana Non egrave una novitagrave che il leitmotiv delle Storie Filippiche e dunque dellrsquoEpitome sia la translatio imperii giagrave Alonso Nuntildeez definito da Santi Amantini laquouno dei piugrave noti esperti di questioni trogiano-giustineeraquo46 osservava che Tro-go esponeva nel suo perduto lavoro la teoria della successione degli im-peri mondiali secondo lo schema Assiria-Media-Persia-Macedonia-Roma osteggiata dai Parti47 In tale successione il ruolo da protagonista egrave rico-perto dallrsquoegemonia macedone48 che occupa allrsquoincirca 26 dei 44 libri e il cui ultimo vero momento di gloria egrave lo scontro con Roma appunto a Cinoscefale Lrsquoultima impresa macedone ha come esito la transizione del dominio universale da Oriente a Occidente e costituisce il tema cen-trale dellrsquointera vicenda di Filippo lrsquoimportanza della battaglia di Cino-scefale egrave perciograve esaltata nei discorsi sia di Filippo che di Flaminino che a loro volta sono il punto di arrivo delle argomentazioni esposte nelle parole di Demetrio di Faro e di Filippo stesso giagrave nel libro XXIX Le ora-tiones disposte retoricamente nei due libri descrivono due parabole op-poste da un lato quella romana che da lontana potenza desiderosa di espandersi cresce come una pioggia di sangue diventando il giovane e vigoroso potere che sottomesso Annibale egrave pronto a sconfiggere Filip-po Dallrsquoaltro quella macedone che originata con Filippo II personag-gio centrale per Trogo raggiunge il suo apice con la conquista dellrsquoege-monia ad opera di Alessandro Magno contro i Persiani per conoscere la fine con Filippo V il cui antico valore egrave ormai troppo lsquosbiaditorsquo per te-ner testa al vigore romano
La gloria macedone secondo Trogo inizia dunque con Filippo II e si conclude con Filippo V Perseo egrave infatti il malvagio responsabile dellrsquoan-nientamento di ciograve che rimaneva della monarchia macedone49 Trogo pone agli estremi della parabola macedone che occupa dal libro IX al XXX i due re di nome Filippo Filippo II e Filippo V come ribadito in piugrave luoghi dellrsquoEpitome sia in parti riassunte da Giustino che in passi piugrave genuinamente trogiani Dando per scontato che il titolo dellrsquoopera Sto-rie Filippiche si debba al desiderio di Trogo di rifarsi allrsquoopera di Teopom-po sul sovrano macedone egrave possibile che tale titolo sia stato perograve ripen-
46 Santi Amantini (2003) pp 99-11047 laquoPompeius Trogus expounded in his lost work the Historiae Philippicae a theory of the world empire suggestion according to the scheme Assyria-Media-Persia-Macedonia-Rome opposed by the Parthiansraquo Alonso-Nuacutentildeez (2002) pp 105-110 e 133-136 partic 105 Vd anche Richter (1987) pp 19-23 Momigliano (1980) pp 157-162 Alonso-Nuacutentildeez (1992) Heckel (1997) pp 1-41 Gabba (2003) pp 7-9 Santi Amantini (2003) pp 99-110 Mariotta (2014) pp 45-56 48 Franco (1993) pp 71-97 e Landucci (2014) pp 233-26149 Alonso-Nuacutentildeez (2002) pp 105-110 partic 108-109
IL DISCORSO DEL RE 137
sato da Trogo considerando che il periodo compreso tra le imprese dei due Filippo occupa 23 dellrsquoopera50 Si potrebbe allora suggerire che le Storie sono Filippiche poicheacute i due Filippo segnarono lrsquoinizio e la fine di quella che egrave nellrsquoopera di Trogo lrsquoegemonia incontrastata del mondo piugrave gloriosa di tutti i tempi51
La prospettiva ellenistica che vede nei due Filippo i limiti della grande egemonia macedone egrave di nuovo presente anche in Appiano nellrsquooraco-lo riportato nei frammenti della sua Makedonikeacute e noto anche da Pausa-nia (VII 8 9)
αὐχοῦντες βασιλεῦσι Μακηδόνες Ἀργεάδῃσιν ὑμῖν κοιρανέων ἀγαθὸν καὶ πῆμα Φίλιππος ἤτοι ὁ μὲν πρότερος πόλεσιν λαοῖσί τ᾽ ἄνακτας θήσει ὁ δ᾽ ὁπλότερος τιμὴν ἀπὸ πᾶσαν ὀλέσσει δμηθεὶς δ᾽ ἑσπερίοισιν ὑπ᾽ ἀνδράσιν ἐνθάδ᾽ ὀλεῖται
O Macedoni che andate orgogliosi dei re di stirpe argiva I re di nome Filippo saranno arbitri del bene e del male per voi Il primo vi renderagrave signori di cittagrave e popoli il secondo vi priveragrave di ogni onore sconfitto da uomini dellrsquoOcciden-te qui giace morto52
Senza voler entrare nel merito della discussione di tale oracolo di nuo-vo pare di incontrare nei due autori la medesima prospettiva lontana dalla condanna morale del re macedone espressa da Polibio secondo cui la sconfitta egrave il giusto esito della sua crudeltagrave ed empietagrave
Il libro giustineo si conclude menzionando le condizioni della pa-ce di Tempe53 e lrsquoira degli Etoli che videro ignorate le proprie richieste da Flaminino e perciograve cercarono lrsquoalleanza di Antioco contro Roma Se-condo il Prologo XXX il libro perograve proseguiva con le campagne di Antio-co III in Asia Minore contro Molone e Acheo e in Battriana fino ad ar-rivare allrsquoesordio dello scontro con Roma54 Il riassunto giustineo egrave trop-po sommario per permettere un confronto con le fonti parallele Egrave pe-
50 Sul rilievo della storia della Macedonia nellrsquoopera di Trogo e Giustino vd von Gutsch-midt (1894) pp 17-217 Richter (1987) p 28 n 29 Franco (1993) pp 71-97 51 Vd anche Urban (1982) pp 1424-1443 e Alonso-Nuacutentildeez (1992) p 58 52 Mak Fr 2 Vd DrsquoAgostini (2011) pp 99-121 In questa Walbank (2002) pp 127-136 propone di interpretare anche un poema di Alceo di Messene (Anth Pal 9518)53 Egrave probabile che Trogo fornisse piugrave particolari riguardo a questa pace per esempio si puograve ritenere che vi fosse menzione dellrsquoinvio a Roma del figlio Demetrio da parte di Filippo come ostaggio dato che a Iust XXXII 2 3 si richiama appunto tale avvenimento54 Polyb XVIII 34 1-39 7 42 1-45 12 Liv XXXIII 11 3-13 15 24 1-31 11 Plut Flam IX 1-8 App Mak Fr IX riferiscono di due diverse trattative di pace caratterizzate da un vivace dibattito tra chi voleva lrsquoannientamento della Macedonia come in Grecia gli Etoli e a Roma Marco Claudio Marcello e coloro che desideravano la pace con la Macedonia in primis Flaminino
138 MONICA DrsquoAGOSTINI
rograve da notare la mancanza sia nel Prologo che nel testo del libro degli av-venimenti delle celebrazioni Istmie del 196 quando Flaminino procla-mograve la libertagrave dei Greci Piugrave in generale in tutta la narrazione di Giustino delle complesse trattative del 197-196 manca qualsiasi riferimento alla li-bertagrave dei Greci punto nodale nella tradizione di Polibio che con questa sottolineatura esalta sia il ruolo tirannico della Macedonia sia la grande generositagrave dei Romani nei confronti della Grecia Il silenzio di TrogoGiustino su tale questione mostra il prevedibile disinteresse per gli affari dei Greci e nel contempo conferma la presenza di una tradizione che si occupa soprattutto della storia delle monarchie ellenistiche allrsquointer-no della quale la posizione dellrsquoEllade egrave subalterna
Libro XXXII23- 34 Demetrio e Perseo
Gli ultimi anni di regno di Filippo tra il 183 e il 179 sono narrati in un passo breve del libro XXXII Il racconto in Giustino che egrave coerente con il Prologo trogiano segue in maniera sintetica la tradizione polibiana su questi eventi giunta a noi in alcuni passi lacunosi di Polibio (XXIII 1 3-3 10 7 1-7 10 1-11 8) integrati dal racconto particolareggiato di Li-vio (XXXIX 46 7- 48 6 53 1-16 XL 3 3-16 3 201-24 8) e dalla narra-zione di Diodoro (XIX 25) e Plutarco (Aem VIII 11)55
Conclusioni
In questi libri dedicati a Filippo egrave forse possibile vedere in filigrana la rielaborazione voluta di Giustino dei corrispondenti libri trogiani Co-me Giustino stesso afferma nella Prefatio 3 lrsquoopera di Trogo era costruita secondo due criteri quello cronologico e quello per laquoconcatenazione di eventi56raquo ea omnia Pompeius diuisa temporibus et serie rerum digesta conposuit
55 Lrsquoutilizzo della tradizione polibiana in Trogo egrave confermato dallrsquoaderenza a Livio (XL 54 1-56 11) e Diodoro (XXIX 28) del racconto sul pentimento di Filippo per aver ucciso il figlio Demetrio lrsquointenzione di punire Perseo e la correlazione tra questo e la sua mor-te Questo libro egrave dunque differente nellrsquointeresse e nelle fonti dai libri XXIX e XXX poicheacute molto vicino alla tradizione polibiana in Livio Questi avvenimenti in Giustino sono da collegare con lrsquoascesa al trono di Perseo e non con lrsquoepilogo della celebrazione del valore macedone giagrave conclusasi in Giustino con Cinoscefale e la transizione dallrsquoim-perium macedone allrsquoimperium romano Vd Heckel (1997) p 7 Appiano invece riporta ancora una tradizione diversa da quella polibiana in un frammento della Makedonikeacute in particolare Appiano egrave attento al punto di vista macedone e presenta Filippo come una vittima delle circostanze (Mak IX) DrsquoAgostini (2011) pp 99-12156 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362 Alonso-Nuacutentildeez (2002) pp 133-136 He-ckel (1997) pp 1-41 Borgna (2014) pp 52-77
IL DISCORSO DEL RE 139
Serie rerum digesta sembrerebbe unrsquointerpretazione latina della formula κατὰ γένος che Diodoro usa per indicare la struttura della storia di Efo-ro sottolineandone la divisione per argomento57 In tale struttura per argomento dellrsquoEpitome tra i temi principali ci sono dunque il valore e la gloria dei sovrani ellenistici58 riscontrabile nei libri XXVIII-XXXI sui re-gni di Antigono Dosone Filippo V e Antioco III Tale tema presente di sicuro in Trogo egrave conservato nellrsquoazione dellrsquoEpitomatore e anzi come si vede dagli escerpta esaltato dalla selezione dei passi
Per quanto riguarda invece la Quellenforschung 59 egrave evidente che nel testo vi sia presenza di filoni non tradizionali sugli eventi poicheacute la posi-zione di Trogo appare spesso autonoma rispetto alle opinioni condivise dalla storiografia antica Questo aspetto dellrsquoEpitome evidente soprattut-to per ciograve che riguarda gli eventi ellenistici ha suscitato la grande curio-sitagrave degli studiosi che allontanatisi dalla proposta di von Gutschmid che voleva una totale ed esclusiva dipendenza di Trogo da Timagene ora in-dicano con sicurezza tra le fonti piugrave rilevanti per gli eventi ellenistici di III secolo utilizzate da Trogo almeno altri sei nomi oltre a Timagene Ie-ronimo Timeo Filarco Duride Polibio e Posidonio
Per quanto riguarda nello specifico la composizione dei libri XXIX e XXX non vi egrave alcun dubbio che in essi Trogo abbia utilizzato (anche riadattandola) una fonte poco attenta alle questioni di politica interna greca e al legame tra queste e quel ritratto di Filippo come sovrano mal-vagio ed empio che ritorna nella tradizione ufficiale di origine polibia-na passando poi da Polibio in Livio Diodoro e Plutarco60 Trogo pre-serva invece una tradizione ellenistica interessata alla figura di Filippo come ultimo barlume della gloria macedone tradizione che pare quasi una controparte e un completamento dellrsquoAb urbe condita romanocentri-ca di Livio Non si puograve perciograve a mio avviso escludere che per questa se-zione Trogo abbia usato una tradizione di matrice filoellenistica o sem-plicemente ellenisticocentrica unrsquoopera sui regni di diadochi ed epigo-ni che a tutti noi fa venire facilmente alla mente il Basileis o Perigrave Basileon dello storico grecoellenistico augusteo filobarbaro scettico (o critico) verso lrsquoegemonia romana Timagene di Alessandria (FGrHist 88)61
57 Su Eforo vd Vannicelli (1987) pp 165-191 e ora Parmeggiani (2011) 58 Simile legame vi egrave a mio avviso tra i libri XXVI e XXVII che invece affrontavano la crisi delle monarchie ellenistiche causata dalle guerre fraterne59 Vd von Gutschmid (1894) pp 17-217 Richter (1987) pp 17-30 partic 20-23 San-ti Amantini (1972) pp 56-109 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362 Urban (1982) pp 1424-1443 partic 1435 Mecca (2001) pp 199-222 Santi Amantini (2003) pp 99-110 Heckel (2012) pp 3-860 Scuderi (2005) pp 383-40561 Sordi (1982) pp 775-797 Heckel (1997) pp 30-34 Landucci (2014) pp 233-261 e Ead in questo volume
140 MONICA DrsquoAGOSTINI
ABSTRACT
Philip V of Macedon was the first of the Epigonoi to face Rome Several mod-ern reconstructions of the actions and the reign of Philip V have approached it largely from a Roman point of view using as sources Polybius and where Poly-bius is lost Livy The Polybian historiographical tradition tends to portray Phil-ip V as an enemy and a tyrant impious and cruel The Macedonian king was ea-ger to establish a universal and unjust dominion over Greece Italy and beyond and Rome engaged in the first two Macedonian Wars to fight the threat of his growing ambition Nevertheless Polybiusrsquo portrayal of Philip V was affected not only by Polybiusrsquo admiration for Roman political structures military power and overwhelming conquest but also his personal Achaean origins
Looking at in book 29 and 30 of Justinrsquos Epitome of Pompeius Trogus this pa-per focuses on the non Polybian tradition on Philip V this contribution is in-deed the first analysis of the Hellenistic approach to the clash between Rome and Macedonia in the 3rd-2nd Century BC The Epitome shows a considerable di-versity of interpretation from the other sources and reflects very different views of Philip Vrsquos actions that brought him into conflict against Rome In particular these views are more evident related to the accounts of the peace negotiations of Naupactus and the battle of Cynoscephalae in the Epitome the king appears as a courageous and skilled warrior the last of the great Macedonian rulers who fell victim to misfortune This portrayal which has several common features with Appianrsquos fragments of Philip V (Mak 9) counterbalances the Roman and Achaean standpoint present in Polybius providing a more Hellenistic perspec-tive that is likely to have been rooted in a historiographical tradition connect-ed to the losing side in the struggle between Rome and the Hellenistic world
BIBLIOGRAFIA
Adler E (2006) Whorsquos Antiroman Sallust and Pompeius Trogus on Mithridates CJ 101 pp 383-407
Adler E (2011) Valorizing the Barbarians Enemy speeches in Roman Historiography Austin
Ager SL (2003) An Uneasy Balance from the Death of Seleukos to the Battle of Raph-ia in A Erskine (ed) A Companion to the Hellenistic World Oxford pp 35-50
Ager SL (2009) Roman Perspectives on Greek Diplomacy The conceptual clash Greek diplomacy of compromise and Roman Bellum Iustum in C Eilers (ed) Diplomats and Diplomacy in the Roman World Leiden-Boston pp 15-43
Alonso-Nuacutentildeez JM (1992) La Historia Universal de Pompeyo Trogo Madrid
Alonso-Nuacutentildeez JM (2002) The Idea of Universal History in Greece From Herodotus to the Age of Augustus Amsterdam
Ballesteros Pastor L (2013) Pompeyo Trogo Justino y Mitriacutedates Comentario al Epiacutetome de las Historias Filiacutepicas (3716-3881) Hildesheim-Zuumlrich-New York
IL DISCORSO DEL RE 141
Barreacute ML (1983) The God-List in the Treaty between Hannibal and Philip V of Ma-cedon a Study in Light of the Ancient Near Eastern Treaty Tradition Baltimore-Lon-don
Beck H - Eckstein A (2015) sv ldquoAratos of Sicyon (231)rdquo in I Worthington (ed) Brillrsquos New Jacoby Brill Online
Borgna A (2014) Uno sguardo originale intorno a Roma Pompeo Trogo e Giustino laquoLa Biblioteca di ClassicoContemporaneoraquo 1 pp 52-77
Cassola F (1962) I gruppi politici romani nel III secolo aC Trieste
Champion CB (1997) The Nature of Authoritative Evidence in Polybios and Agelausrsquo Speech at Naupactos TAPhA 127 pp 111-128
Champion CB (2004) Cultural Politics in Polybiusrsquo Histories Berkeley
Coppola A (1993) Demetrio di Faro un protagonista dimenticato Roma
Criscuolo L (2011) I due testamenti di Tolemeo VIII Evergete II in A Joumlrdens - J F Quack (hrsg) Aumlgypten zwischen innerem Zwist und aumluszligerem Druck Die Zeit Ptole-maios VI bis VIII Wiesbaden pp 132-150
DrsquoAgostini M (2011) Filippo V e la Storia Romana di Appiano laquoAevumraquo 85 pp 99-121
Eckstein AM (1995) Moral vision in the Histories of Polybius Berkeley
Eckstein AM (2008) Rome enters in the Greek East From Anarchy to Hierarchy in the Hellenistic Mediterranean 230-217 BC Oxford
Eckstein AM (2013) Polybius Phylarchus and Historiographical Criticism CPh 108 4 pp 314-338
Errington RM (1969) Philopoemen Oxford
Errington RM (2008) A History of the Hellenistic World 323-30 BC Malden MA-Oxford
Forni G - Angeli Bertinelli MG (1982) Pompeo Trogo come fonte di storia ANRW II 30 2 pp 1298-1362
Franco C (1993) Trogo Giustino e i successori di Alessandro in L Braccesi - A Coppola - G Cresci Marrone - C Franco (a cura di) LrsquoAlessandro di Giustino dagli antichi ai moderni Roma pp 71-97
Gabba E (2003) Introduzione in D Foraboschi - SM Pizzetti (a cura di) La successione degli imperi e delle egemonie nelle relazioni internazionali Milano pp 7-9
Golan D (1995) The Res Graeciae in Polybius Four Studies Como
Green P (1990) Alexander to Actium The Historical Evolution of the Hellenistic Age Berkeley-Los Angeles
Gutschmid von A (1894) Die beiden ersten Buumlcher des Pompeius Trogus in A von Gutschmid - F Ruumlhl (hrsg) Kleine Schriften Leipzig pp 17-217
142 MONICA DrsquoAGOSTINI
Habicht C (1995) Athen Muumlnchen
Hammond NGL (1968) Illyris Rome and Macedon in 229-205 BC JRS 58 pp 1-21
Hammond NGL (1988) The Campaign and the Battle of Cynoscephalae in 197 BC JHS 108 pp 60-82
Heckel W (1997) Introduction (Part 2) in JC Yardley - W Heckel (eds) Ju-stin Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus Books 11-12 Alexander the Great Introduction Oxford pp 1-41
Heckel W (2012) Introduction in JC Yardley - P Wheatley - W Heckel (eds) Justin Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus II Books 13-15 The Successors to Alexander the Great Oxford pp 1-8
Huss W (1976) Untersuchungen zur Auszligenpolitik Ptolemaiosrsquo IV Muumlnchen
Huss W (2001) Aumlgypten in hellenistischer Zeit 332ndash30 v Chr Muumlnchen
Intrieri M (2011) Fra dialogo e conflitto Annibale e i Greci drsquoOccidente RStudFen 37 pp 53-82
Landucci F (2014) Filippo II e le Storie Filippiche un protagonista storico e storio-grafico in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 233-261
Landucci Gattinoni F (2011) Politica e ideologia in etagrave ellenistica laquoPolitica An-ticaraquo 1 pp 89-105
Leacutevy E (1994) Le discours drsquoAgeacutelaos de Naupacte in L Aigner Foresti - A Bar-zanograve - C Bearzot - L Prandi - G Zecchini (a cura di) Federazioni e federalismo nellrsquoEuropa antica Bergamo 21-25 settembre 1992 Milano (Alle radici della casa co-mune europea 1) pp 33-50
Longaretti L (1989) Lrsquoalleanza tra Annibale e Filippo V di Macedonia RIL 123 pp 183-192
Marasco G (1979-1980) La valutazione di Tolemeo IV Filopatore nella storiografia greca laquoSilenoraquo 5-6 pp 159-182
Mari M [- Musti D - Thornton J] (2002) Polibio Storie Volume III Libri V-VI Milano
Mariotta G (2014) Geografia e Geopolitica nelle Storie Filippiche in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 45-56
McGing B (2010) Polybiusrsquo Histories New York
McGing B (2013) Youthfulness in Polybius the case of Philip V of Macedon in B Gibson - T Harrison (eds) Polybius and his world Oxford pp 181-199
Meadows A (2013) Polybius Aratus and the History of the 140th Olympiad in B
IL DISCORSO DEL RE 143
Gibson - T Harrison (eds) Polybius and his World Essays in Honour of Frank Walbank Oxford pp 91-116
Mecca A (2001) Trogo Timagene e Polieno QS 54 pp 199-222
Meister K (1990) Die Griechische Geschichtsschreibung von den Anfaumlngen bis zum Ende des Hellenismus Stuttgart
Misch G (1949) Geschichte der Autobiographie I Frankfurt am Mein
Momigliano A (1980) Daniele e la teoria greca della successione degli imperi RAL 35 pp 157-162
Muccioli F (2013) Gli epiteti ufficiali dei re ellenistici Stuttgart (Historia Einzel-schriften 224)
Musti D (1978) Polibio e lrsquoimperialismo romano Napoli
Parmeggiani G (2011) Eforo di Cuma studi di storiografia greca Bologna
Peacutedech P (1964) La meacutethode historique de Polybe Paris
Pelling CBR [- Scardigli B - Manfredini M](1997) Plutarco Vite parallele Filopemene Tito Flaminino Milano
Richter H-D (1987) Untersuchungen zur hellenistischen Historiographie die Vorla-gen des Pompeius Trogus fuumlr die Darstellung der nachalexandrischen hellenistischen Ge-schichte (Iust 13-40) Frankfurt
Santi Amantini L (1972) Fonti e valore storico di Pompeo Trogo (Iustin XXXV e XXXVI) Genova
Santi Amantini L (1981) (a cura di) Giustino Storie Filippiche Epitome da Pom-peo Trogo Milano
Santi Amantini L (2003) Il tempo e i tempi nelle Storie Filippiche di Pompeo Tro-go RSA 33 pp 99-110
Schepens G (1983) Les rois ptolegravemaiumlques et lrsquohistoriographie Reacuteflexions sur la trans-formation de lrsquohistoire politique in E vanrsquot Dack - P van Dessel - W Van Gucht (eds) Egypt and the Hellenistic World Proceedings of the International Collo-quium Leuven 24-26 May 1982 Leuven (Studia Hellenistica 27) pp 351-368
Schlicher JJ (1933) Non-Assertive Elements in the Language of the Roman Histo-rians CPh 28 289-300
Schmitt T (1989) Die Bedeutung des zweiten Punischen Krieges fuumlr den Frieden in Naupaktos in H Devijver - E Lipinski (eds) Punic wars Proceedings of the Conference held in Antwerp from the 23th to the 26th of November 1988 in Cooperation with the Departement of History of the laquoUniversitait Antwerpenraquo UFSIA Leuven (Studia Phoenicia 10) pp 229-239
Scholten JB (2000) The Politics of Plunder Aitolians and their koinon in the early Hellenistic Era Berkeley
144 MONICA DrsquoAGOSTINI
Scuderi R (2005) Filippo V e Perseo nei frammenti diodorei in C Bearzot - F Lan-ducci (a cura di) Diodoro e lrsquoaltra Grecia Macedonia Occidente Ellenismo nella Bi-blioteca Storica Atti del convegno Milano 15-16 gennaio 2004 Milano pp 383-405
Sklenaacuter RJ (2004) Sources and Individuality in Two Passages of Livy laquoHistoriaraquo 53 pp 302-310
Sordi M (1982) Timagene di Alessandria Uno storico ellenocentrico e filobarbaro ANRW II 30 1 pp 775-797
Thornton J (2014) Le guerre macedoniche Roma
Urban R (1979) Wachstum und Kriese des achaumlischen Bundes Quellenstudien zur entwicklung des Bundes von 280 bis 222 V Chr Wiesbaden
Urban R (1982) laquoGallisches Bewusstseinraquo und laquoRomkritikraquo bei Pompeius Trogus ANRW II 30 2 pp 1424-1443
Vannicelli P (1987) Lrsquoeconomia delle Storie di Eforo RFIC 115 pp 165-191
Vattuone R (2014) Giustino e lrsquoOccidente greco I VI-V secolo aC in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 261-277
Vollmer D (1990) Symploke das Uumlbergreifen der roumlmischen Expansion auf den grie-chischen Osten Untersuchungen zur roumlmischen Aussenpolitik am Ende des 3 Jh V Chr Stuttgart
Walbank FW (1957) A Historical Commentary on Polibius I Oxford
Walbank FW (1967) A Historical Commentary on Polybius II Oxford
Walbank FW (1933) Aratos of Sicyon Cambridge
Walbank FW (2002) Η ΤΩΝ ΟΛΩΝ ΕΛΠΙΣ and the Antigonids in FW Walbank (ed) Polybius Rome and the Hellenistic World Essays and Reflections West Nyack NY pp 127-136
Weber G (1997) Interaktion Repraumlsentation und Herrschaft Der Koumlnigshof im Hel-lenismus in A Winterling (hrsg) Zwischen lsquoHausrsquo und lsquoStaatrsquo antike Houmlfe im Ver-gleich Munich pp 27-72
Will E (19822) Histoire politique du Monde Helleacutenistique II Nancy
Zecchini G (1990) La storiografia lagide in H Verdin - G Schepens - E De Keyser (eds) Purposes of History Studies in Greek Historiography from the 4th to the 2nd Centuries BC Proceedings of the International Colloquium of Leuven 24-26 May 1988 Leuven (Studia Hellenistica 30) pp 213-232
Zecchini G (2003) Polibio e la tradizione orale in A Casanova - P Desideri (a cura di) Evento racconto scrittura nellrsquoantichitagrave classica Firenze pp 123-141
Finito di stamparenel mese di novembre 2015
da LegoDigit srlLavis (TN)
132 MONICA DrsquoAGOSTINI
il riassunto delle ambascerie nel Mediterraneo preludio allo scontro della prima fase della guerra35 maggior spazio egrave dato al tentativo di pa-ce a Nicea tra Roma Attalo i Rodii gli Achei e gli Etoli e Filippo V nel 198 In questa occasione Filippo rivendica la posizione di dominio dei Macedoni sui Greci ereditata da Filippo II e Alessandro suoi antenati e in virtugrave di tale supremazia macedone rifiuta che i Greci gli dettino le condizioni di pace ma chiede che sia il Senato a decidere Egrave significati-vo che non solo il discorso di Filippo non compaia in nessuna delle fon-ti parallele che descrivono nel particolare le posizioni degli ambasciato-ri di Achei Etoli Rodii e Attalo ma che Polibio (XVIII 8 8)36 affermi che era difficile sapere cosa si fossero detti Filippo e Flaminino durante i colloqui nel Golfo Maliaco Secondo la tradizione polibiana infatti il sovrano accompagnato da due philoi macedoni Apollodoro e Demoste-ne chiese di allontanare dalle trattative tutti tranne i Romani e discus-se la pace solamente con Flaminino Successivamente a causa dellrsquoinca-pacitagrave di trovare un accordo Filippo chiese due mesi di tregua e lrsquointer-vento del Senato Trogo dunque restituisce il discorso che il resto della tradizione riteneva impossibile da conoscere indicando chiaramente la presenza di una fonte diversa rispetto a Polibio su questo avvenimento piugrave informata sul punto di vista di Filippo e interessata a evidenziare la convinzione di Filippo V di avere un diritto di supremazia sulla Grecia in virtugrave delle imprese di Filippo II e Alessandro
La battaglia di Cinoscefale nel 197 momento risolutivo dello scontro tra Roma e Macedonia egrave lrsquoevento principale del libro XXX omina e pre-sagi introducono lrsquoevento campale lrsquoeruzione del vulcano di Santorini
fonti In Polyb XVI 24 3 App Mak Fr IV Liv XXXI 1 10 21 5 5 Paus I 36 5-6 vi sono differenti versioni della sequenza delle ambascerie che denunciarono a Roma lrsquoe-spansionismo macedone ma tutte concordano che le ambascerie precedettero lrsquoinvio dei legati romani in Oriente e che esse furono inviate anche da Atene e dagli Etoli Inoltre secondo la tradizione polibiana (Polyb XVI 27 1-4 34 1-7 Liv XXXI 2 3 6 3-8 4 18 1-9 Diod XXVIII 6) vi furono due diverse ambascerie di cui la seconda sarebbe stato un ultimatum al sovrano recapitato da Lepido In occasione di questa seconda ambasceria avvenuta durante il cruento assedio di Abido Filippo avrebbe detto che i Macedoni in ca-so di guerra si sarebbero difesi con valore In Giustino si puograve notare che ancora una volta dagli eventi sono omesse notizie fondamentali sui Greci nello specifico lrsquoambasceria di Atene la cui disputa con gli Acarnani fu il casus belli della guerra contro Filippo 35 Come i prodromi anche la prima parte della Seconda Guerra Macedonica egrave sintetizza-ta in Giustino e occupa solamente due paragrafi Come spesso accade nei passi sintetiz-zati dallrsquoEpitomatore si trovano le incongruenze maggiori con le fonti parallele tra cui si nota soprattutto la completa omissione di Giustino delle campagne di Publio Sulpicio Galba Massimo di Villio delle vittorie di Tito e Lucio Flaminino e dellrsquoassemblea del 198 che portograve gli Achei ad allearsi con Roma Polyb XXII e Liv XXXI 14 1- 46 16 XXXII 1 1-25 12 App Mak Fr VII Plut Fil 17 4 Flam 5 4 e Paus VII 8 1-236 Le trattattive sono descritte con particolari in Polyb XVIII 1-12 seguito da Liv XXXII 32 6-36 10 e Plut Flam 5 8 e 7 1-3
IL DISCORSO DEL RE 133
nel 197 e lrsquoemergere dellrsquoisola di Hiera e in contemporanea il terremo-to a Rodi Quindi nellrsquoEpitome si annuncia che laquoil nascente impero dei Romani avrebbe divorato quello antico dei Greci e dei Macedoni37raquo Nel passo ricevono spazio soprattutto i due discorsi contrapposti del re ma-cedone Filippo e del comandante romano Flaminino pronunciati pri-ma dello scontro campale e costruiti ciascuno in modo da celebrare le imprese delle due potenze38 Lrsquoenfasi data dalla contrapposizione reto-rica delle parole dei generali egrave tale da rendere suggestiva lrsquoipotesi che lo scontro dovesse essere il momento centrale non solo del libro XXX ma forse di tutta lrsquoopera trogiana
Filippo elenca le grandi vittorie del passato dei Macedoni contro Per-siani Battriani Indiani e le popolazioni drsquoAsia fino allrsquoestremo Orien-te esortando i suoi a combattere con valore percheacute laquola libertagrave egrave piugrave cara del predominio39raquo Il discorso di Flaminino egrave invece piugrave lungo articola-to in un paragone tra Macedoni e Romani alle passate imprese di con-quista macedoni vengono contrapposte le piugrave recenti vittorie romane a Cartagine in Sicilia Italia e Spagna alla grandezza di Alessandro Ma-gno egrave contrapposta quella di Annibale che pure dai Romani era stato sconfitto Lrsquoattenzione poi si concentra su Filippo i Macedoni non laquodo-vevano essere valutati per lrsquoantica forza ma per le forze attuali40raquo poicheacute Filippo non era lrsquoinvitto e invincibile Alessandro Magno ma un ragaz-zo che non riusciva a difendere i propri confini I Macedoni rivendica-vano il valore degli antenati mentre i Romani quello dei propri soldati poicheacute quelli che erano ligrave schierati erano gli stessi che avevano sconfitto Annibale Dopo una cosigrave grandiosa introduzione la battaglia egrave descritta in uno dei paragrafi piugrave significativi di tutta lrsquoopera
His adhortationibus utrimque concitati milites proelio concurrunt alteri Orientis alteri Occidentis imperio gloriantes ferentesque in bellum alii maiorum suorum antiquam et ob-soletam gloriam alii uirentem recentibus experimentis uirtutis florem [16] Sed Macedo-nas Romana Fortuna uicit
I soldati incitati da queste esortazioni dallrsquouna e dallrsquoaltra parte si lanciaro-no nel combattimento vantandosi gli uni del dominio dellrsquoOriente gli altri dellrsquoOccidente e recando in guerra gli uni lrsquoantica e sbiadita gloria dei loro an-
37 Iust XXX 4 4 Quo prodigio territis omnibus uates cecinere oriens Romanorum imperium uetus Graecorum ac Macedonum uoraturum38 Sui discorsi precedenti la battaglia nellrsquoantichitagrave se da considerare reali o costruzioni storiografiche vd Adler (2011) pp 6-839 Iust XXX 4 7 tantoque hoc bellum fortius quam illa sustinendum quanto sit imperio libertas carior40 Iust XXX 4 10 Sed nec Macedonas ueteri fama sed praesentibus uiribus aestimandos
134 MONICA DrsquoAGOSTINI
tenati gli altri il fiore del loro valore fresco e vigoroso per le recenti prove Ma la Fortuna dei Romani vinse i Macedoni
Questo punto di vista probabilmente giagrave trogiano contrappone la virtugrave romana (virtutis flos) celebrata nei discorsi antecedenti la battaglia al-la Fortuna romana (Romana Fortuna) che decise la vittoria interpretabi-le come destino favorevole o buona stella Piugrave che unrsquoaffermazione anti-romana41 come egrave spesso stata intesa si puograve evidenziare il carattere sim-patetico della fonte verso Filippo V destinato a porre fine alla gloria di Filippo II e Alessandro e forse un approccio nostalgico verso i grandi regni macedoni la cui egravera egrave ormai giunta alla fine Tale prospettiva egrave as-sente in Polibio e nella tradizione che da lui dipende poco interessata alle vicende della gloria macedone leggendo infatti i frammenti soprav-vissuti del libro XVIII delle Storie dopo lrsquoaccurata descrizione della bat-taglia (18-33 e 34-40)42 Polibio commenta lo scontro affermando che avrebbe dedicato alcuni capitoli allrsquoesame delle strategie militari delle due armate percheacute (XVIII 28 4-6)
χρήσιμον καὶ καλὸν ἂν εἴη τὸ τὴν διαφορὰν ἐρευνῆσαι καὶ παρὰ τί συμβαίνει Ῥωμαίους ἐπικρατεῖν καὶ τὸ πρωτεῖον ἐκφέρεσθαι τῶν κατὰ πόλεμον ἀγώνων [5] ἵνα μὴ τύχην λέγοντες μόνον μακαρίζωμεν τοὺς κρατοῦντας ἀλόγως καθάπερ οἱ μάταιοι τῶν ἀνθρώπων ἀλλ᾽ εἰδότες τὰς ἀληθεῖς αἰτίας ἐπαινῶμεν καὶ θαυμάζωμεν κατὰ λόγον τοὺς ἡγουμένους
Puograve essere cosa buona e utile esaminare le differenze e per quale motivo i Ro-mani prevalgono e riportano il primo premio nelle competizioni di guerra af-fincheacute non esaltiamo i vincitori senza una ragione parlando solo di fortuna co-me fanno gli sciocchi ma conoscendo le vere cause lodiamo e ammiriamo i co-mandanti seguendo una logica
Polibio dunque sembra rispondere a coloro che parlavano della buo-na stella dei Romani sottolineando che la vittoria nasceva dalla superio-re strategia militare della legione43 Un punto di vista quindi opposto a quello espresso nellrsquoEpitome che proprio di Romana Fortuna parla e riba-dito in chiusura al passo dove Polibio critica nuovamente quei Greci che ritenevano la vittoria romana incredibile (XVIII 32 13)
41 Urban (1982) pp 1424-1443 1435 Richter (1987) p 19 n 4 Alonso-Nuacutentildeez (1992) p 66 e Id (2002) pp 105-110 partic 108-109 Contra Heckel (1997) p 29 che ridimen-siona la categorizzazione di Trogo come storico anti-romano 42 Su Cinoscefale vd Walbank (1957) ad l Hammond (1988) pp 60-82 Sklenaacuter (2004) pp 302-310 Thornton (2014) pp 83-87 43 Sulla Fortuna in Polibio vd McGing (2010) pp 195-201 (con bibliografia) che distin-gue tra quando Polibio intenda caso e quando predeterminazione fato Vd anche Green (1990) pp 400-402 e Eckstein (2008) pp 132-138
IL DISCORSO DEL RE 135
Il punto di vista di Trogo sembra invece presente nei frammenti del-la Makedonikeacute di Appiano su Filippo V44 dove ci si riferisce a Cinoscefale come a una vittoria insperata (Mak 9 1)
ἡγούμενος δ᾽ οὔτε Ῥωμαίοις συμφέρειν οὔτε τοῖς Ἕλλησι Φιλίππου καθαιρεθέντος ἐπιπολάσαι τὴν Αἰτωλῶν βίαν τάχα δ᾽ αὐτὸν καὶ τὸ παράδοξον τῆς νίκης ἀγαπᾶν ἐποίει
Flaminino era consapevole che non sarebbe stato vantaggioso per i Romani o per i Greci che Filippo fosse deposto e che il potere etolico rimanesse incon-trastato forse lo aveva reso moderato nei suoi progetti lrsquoaver ottenuto una vit-toria insperata
Addirittura successivamente si accenna alla sorte avversa a Filippo nel-lo scontro
τὰ μὲν δὴ παρὰ τῶν ἄλλων φιλάνθρωπα ἦν τό τε τῆς τύχης ἄδηλον ἐξ ὧν ἔπαθεν ὁ Φίλιππος ὑφορωμένων καὶ τὸ πταῖσμα τοῦτο οὐ κατ᾽ ἀσθένειαν ἀλλὰ πλέον ἐκ συντυχίας αὐτὸν παθεῖν ἡγουμένων
Gli altri (Greci) erano inclini ad essere moderati vedendo con sospetto lrsquoincer-tezza della fortuna subita da Filippo e ritenendo che egli fosse incorso in questa sconfitta non tanto per la sua inferioritagrave quanto per la sfortuna
Il riferimento in Appiano e Trogo alla fortuna romanasfortuna ma-cedone a proposito di Cinoscefale egrave una traccia dellrsquoopinione politi-ca di quei Greci disprezzati da Polibio come uomini sciocchi καθάπερ οἱ μάταιοι τῶν ἀνθρώπων Tale posizione politica su Cinoscefale sarebbe dunque sopravvissuta nella tradizione storiografica di cui troviamo trac-cia in TrogoGiustino e Appiano
Per comprendere meglio alcune caratteristiche di questa tradizione puograve essere utile tornare ai due discorsi nellrsquoEpitome di Filippo e Flamini-no prima della battaglia Tali passi probabilmente trogiani45 non trova-no infatti riscontro nelle fonti parallele a noi pervenute Polibio (XVIII 18-27) seguito fedelmente da Livio (XXXIII 5-10) pur descrivendo le operazioni di guerra di Cinoscefale con dovizia di particolari non men-ziona un discorso di Filippo ai suoi armati prima della battaglia mentre il discorso di Flaminino per incoraggiare le truppe schierate (XVIII 23 2-6) nelle Storie egrave incentrato sulle vittorie di Sulpicio nella prima parte della guerra Pare dunque originale la versione trogiana che incentra-
44 Tra i frammenti consegnatici dagli Excerpta Constantiniana sono frequenti informazio-ni e osservazioni che rimandano a una prospettiva ellenistica sugli eventi DrsquoAgostini (2011) pp 99-121 45 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362
136 MONICA DrsquoAGOSTINI
ta sulla gloria macedone presenta Cinoscefale come il punto drsquoincon-tro e di scambio tra lrsquoegemonia macedone e lrsquoegemonia romana Non egrave una novitagrave che il leitmotiv delle Storie Filippiche e dunque dellrsquoEpitome sia la translatio imperii giagrave Alonso Nuntildeez definito da Santi Amantini laquouno dei piugrave noti esperti di questioni trogiano-giustineeraquo46 osservava che Tro-go esponeva nel suo perduto lavoro la teoria della successione degli im-peri mondiali secondo lo schema Assiria-Media-Persia-Macedonia-Roma osteggiata dai Parti47 In tale successione il ruolo da protagonista egrave rico-perto dallrsquoegemonia macedone48 che occupa allrsquoincirca 26 dei 44 libri e il cui ultimo vero momento di gloria egrave lo scontro con Roma appunto a Cinoscefale Lrsquoultima impresa macedone ha come esito la transizione del dominio universale da Oriente a Occidente e costituisce il tema cen-trale dellrsquointera vicenda di Filippo lrsquoimportanza della battaglia di Cino-scefale egrave perciograve esaltata nei discorsi sia di Filippo che di Flaminino che a loro volta sono il punto di arrivo delle argomentazioni esposte nelle parole di Demetrio di Faro e di Filippo stesso giagrave nel libro XXIX Le ora-tiones disposte retoricamente nei due libri descrivono due parabole op-poste da un lato quella romana che da lontana potenza desiderosa di espandersi cresce come una pioggia di sangue diventando il giovane e vigoroso potere che sottomesso Annibale egrave pronto a sconfiggere Filip-po Dallrsquoaltro quella macedone che originata con Filippo II personag-gio centrale per Trogo raggiunge il suo apice con la conquista dellrsquoege-monia ad opera di Alessandro Magno contro i Persiani per conoscere la fine con Filippo V il cui antico valore egrave ormai troppo lsquosbiaditorsquo per te-ner testa al vigore romano
La gloria macedone secondo Trogo inizia dunque con Filippo II e si conclude con Filippo V Perseo egrave infatti il malvagio responsabile dellrsquoan-nientamento di ciograve che rimaneva della monarchia macedone49 Trogo pone agli estremi della parabola macedone che occupa dal libro IX al XXX i due re di nome Filippo Filippo II e Filippo V come ribadito in piugrave luoghi dellrsquoEpitome sia in parti riassunte da Giustino che in passi piugrave genuinamente trogiani Dando per scontato che il titolo dellrsquoopera Sto-rie Filippiche si debba al desiderio di Trogo di rifarsi allrsquoopera di Teopom-po sul sovrano macedone egrave possibile che tale titolo sia stato perograve ripen-
46 Santi Amantini (2003) pp 99-11047 laquoPompeius Trogus expounded in his lost work the Historiae Philippicae a theory of the world empire suggestion according to the scheme Assyria-Media-Persia-Macedonia-Rome opposed by the Parthiansraquo Alonso-Nuacutentildeez (2002) pp 105-110 e 133-136 partic 105 Vd anche Richter (1987) pp 19-23 Momigliano (1980) pp 157-162 Alonso-Nuacutentildeez (1992) Heckel (1997) pp 1-41 Gabba (2003) pp 7-9 Santi Amantini (2003) pp 99-110 Mariotta (2014) pp 45-56 48 Franco (1993) pp 71-97 e Landucci (2014) pp 233-26149 Alonso-Nuacutentildeez (2002) pp 105-110 partic 108-109
IL DISCORSO DEL RE 137
sato da Trogo considerando che il periodo compreso tra le imprese dei due Filippo occupa 23 dellrsquoopera50 Si potrebbe allora suggerire che le Storie sono Filippiche poicheacute i due Filippo segnarono lrsquoinizio e la fine di quella che egrave nellrsquoopera di Trogo lrsquoegemonia incontrastata del mondo piugrave gloriosa di tutti i tempi51
La prospettiva ellenistica che vede nei due Filippo i limiti della grande egemonia macedone egrave di nuovo presente anche in Appiano nellrsquooraco-lo riportato nei frammenti della sua Makedonikeacute e noto anche da Pausa-nia (VII 8 9)
αὐχοῦντες βασιλεῦσι Μακηδόνες Ἀργεάδῃσιν ὑμῖν κοιρανέων ἀγαθὸν καὶ πῆμα Φίλιππος ἤτοι ὁ μὲν πρότερος πόλεσιν λαοῖσί τ᾽ ἄνακτας θήσει ὁ δ᾽ ὁπλότερος τιμὴν ἀπὸ πᾶσαν ὀλέσσει δμηθεὶς δ᾽ ἑσπερίοισιν ὑπ᾽ ἀνδράσιν ἐνθάδ᾽ ὀλεῖται
O Macedoni che andate orgogliosi dei re di stirpe argiva I re di nome Filippo saranno arbitri del bene e del male per voi Il primo vi renderagrave signori di cittagrave e popoli il secondo vi priveragrave di ogni onore sconfitto da uomini dellrsquoOcciden-te qui giace morto52
Senza voler entrare nel merito della discussione di tale oracolo di nuo-vo pare di incontrare nei due autori la medesima prospettiva lontana dalla condanna morale del re macedone espressa da Polibio secondo cui la sconfitta egrave il giusto esito della sua crudeltagrave ed empietagrave
Il libro giustineo si conclude menzionando le condizioni della pa-ce di Tempe53 e lrsquoira degli Etoli che videro ignorate le proprie richieste da Flaminino e perciograve cercarono lrsquoalleanza di Antioco contro Roma Se-condo il Prologo XXX il libro perograve proseguiva con le campagne di Antio-co III in Asia Minore contro Molone e Acheo e in Battriana fino ad ar-rivare allrsquoesordio dello scontro con Roma54 Il riassunto giustineo egrave trop-po sommario per permettere un confronto con le fonti parallele Egrave pe-
50 Sul rilievo della storia della Macedonia nellrsquoopera di Trogo e Giustino vd von Gutsch-midt (1894) pp 17-217 Richter (1987) p 28 n 29 Franco (1993) pp 71-97 51 Vd anche Urban (1982) pp 1424-1443 e Alonso-Nuacutentildeez (1992) p 58 52 Mak Fr 2 Vd DrsquoAgostini (2011) pp 99-121 In questa Walbank (2002) pp 127-136 propone di interpretare anche un poema di Alceo di Messene (Anth Pal 9518)53 Egrave probabile che Trogo fornisse piugrave particolari riguardo a questa pace per esempio si puograve ritenere che vi fosse menzione dellrsquoinvio a Roma del figlio Demetrio da parte di Filippo come ostaggio dato che a Iust XXXII 2 3 si richiama appunto tale avvenimento54 Polyb XVIII 34 1-39 7 42 1-45 12 Liv XXXIII 11 3-13 15 24 1-31 11 Plut Flam IX 1-8 App Mak Fr IX riferiscono di due diverse trattative di pace caratterizzate da un vivace dibattito tra chi voleva lrsquoannientamento della Macedonia come in Grecia gli Etoli e a Roma Marco Claudio Marcello e coloro che desideravano la pace con la Macedonia in primis Flaminino
138 MONICA DrsquoAGOSTINI
rograve da notare la mancanza sia nel Prologo che nel testo del libro degli av-venimenti delle celebrazioni Istmie del 196 quando Flaminino procla-mograve la libertagrave dei Greci Piugrave in generale in tutta la narrazione di Giustino delle complesse trattative del 197-196 manca qualsiasi riferimento alla li-bertagrave dei Greci punto nodale nella tradizione di Polibio che con questa sottolineatura esalta sia il ruolo tirannico della Macedonia sia la grande generositagrave dei Romani nei confronti della Grecia Il silenzio di TrogoGiustino su tale questione mostra il prevedibile disinteresse per gli affari dei Greci e nel contempo conferma la presenza di una tradizione che si occupa soprattutto della storia delle monarchie ellenistiche allrsquointer-no della quale la posizione dellrsquoEllade egrave subalterna
Libro XXXII23- 34 Demetrio e Perseo
Gli ultimi anni di regno di Filippo tra il 183 e il 179 sono narrati in un passo breve del libro XXXII Il racconto in Giustino che egrave coerente con il Prologo trogiano segue in maniera sintetica la tradizione polibiana su questi eventi giunta a noi in alcuni passi lacunosi di Polibio (XXIII 1 3-3 10 7 1-7 10 1-11 8) integrati dal racconto particolareggiato di Li-vio (XXXIX 46 7- 48 6 53 1-16 XL 3 3-16 3 201-24 8) e dalla narra-zione di Diodoro (XIX 25) e Plutarco (Aem VIII 11)55
Conclusioni
In questi libri dedicati a Filippo egrave forse possibile vedere in filigrana la rielaborazione voluta di Giustino dei corrispondenti libri trogiani Co-me Giustino stesso afferma nella Prefatio 3 lrsquoopera di Trogo era costruita secondo due criteri quello cronologico e quello per laquoconcatenazione di eventi56raquo ea omnia Pompeius diuisa temporibus et serie rerum digesta conposuit
55 Lrsquoutilizzo della tradizione polibiana in Trogo egrave confermato dallrsquoaderenza a Livio (XL 54 1-56 11) e Diodoro (XXIX 28) del racconto sul pentimento di Filippo per aver ucciso il figlio Demetrio lrsquointenzione di punire Perseo e la correlazione tra questo e la sua mor-te Questo libro egrave dunque differente nellrsquointeresse e nelle fonti dai libri XXIX e XXX poicheacute molto vicino alla tradizione polibiana in Livio Questi avvenimenti in Giustino sono da collegare con lrsquoascesa al trono di Perseo e non con lrsquoepilogo della celebrazione del valore macedone giagrave conclusasi in Giustino con Cinoscefale e la transizione dallrsquoim-perium macedone allrsquoimperium romano Vd Heckel (1997) p 7 Appiano invece riporta ancora una tradizione diversa da quella polibiana in un frammento della Makedonikeacute in particolare Appiano egrave attento al punto di vista macedone e presenta Filippo come una vittima delle circostanze (Mak IX) DrsquoAgostini (2011) pp 99-12156 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362 Alonso-Nuacutentildeez (2002) pp 133-136 He-ckel (1997) pp 1-41 Borgna (2014) pp 52-77
IL DISCORSO DEL RE 139
Serie rerum digesta sembrerebbe unrsquointerpretazione latina della formula κατὰ γένος che Diodoro usa per indicare la struttura della storia di Efo-ro sottolineandone la divisione per argomento57 In tale struttura per argomento dellrsquoEpitome tra i temi principali ci sono dunque il valore e la gloria dei sovrani ellenistici58 riscontrabile nei libri XXVIII-XXXI sui re-gni di Antigono Dosone Filippo V e Antioco III Tale tema presente di sicuro in Trogo egrave conservato nellrsquoazione dellrsquoEpitomatore e anzi come si vede dagli escerpta esaltato dalla selezione dei passi
Per quanto riguarda invece la Quellenforschung 59 egrave evidente che nel testo vi sia presenza di filoni non tradizionali sugli eventi poicheacute la posi-zione di Trogo appare spesso autonoma rispetto alle opinioni condivise dalla storiografia antica Questo aspetto dellrsquoEpitome evidente soprattut-to per ciograve che riguarda gli eventi ellenistici ha suscitato la grande curio-sitagrave degli studiosi che allontanatisi dalla proposta di von Gutschmid che voleva una totale ed esclusiva dipendenza di Trogo da Timagene ora in-dicano con sicurezza tra le fonti piugrave rilevanti per gli eventi ellenistici di III secolo utilizzate da Trogo almeno altri sei nomi oltre a Timagene Ie-ronimo Timeo Filarco Duride Polibio e Posidonio
Per quanto riguarda nello specifico la composizione dei libri XXIX e XXX non vi egrave alcun dubbio che in essi Trogo abbia utilizzato (anche riadattandola) una fonte poco attenta alle questioni di politica interna greca e al legame tra queste e quel ritratto di Filippo come sovrano mal-vagio ed empio che ritorna nella tradizione ufficiale di origine polibia-na passando poi da Polibio in Livio Diodoro e Plutarco60 Trogo pre-serva invece una tradizione ellenistica interessata alla figura di Filippo come ultimo barlume della gloria macedone tradizione che pare quasi una controparte e un completamento dellrsquoAb urbe condita romanocentri-ca di Livio Non si puograve perciograve a mio avviso escludere che per questa se-zione Trogo abbia usato una tradizione di matrice filoellenistica o sem-plicemente ellenisticocentrica unrsquoopera sui regni di diadochi ed epigo-ni che a tutti noi fa venire facilmente alla mente il Basileis o Perigrave Basileon dello storico grecoellenistico augusteo filobarbaro scettico (o critico) verso lrsquoegemonia romana Timagene di Alessandria (FGrHist 88)61
57 Su Eforo vd Vannicelli (1987) pp 165-191 e ora Parmeggiani (2011) 58 Simile legame vi egrave a mio avviso tra i libri XXVI e XXVII che invece affrontavano la crisi delle monarchie ellenistiche causata dalle guerre fraterne59 Vd von Gutschmid (1894) pp 17-217 Richter (1987) pp 17-30 partic 20-23 San-ti Amantini (1972) pp 56-109 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362 Urban (1982) pp 1424-1443 partic 1435 Mecca (2001) pp 199-222 Santi Amantini (2003) pp 99-110 Heckel (2012) pp 3-860 Scuderi (2005) pp 383-40561 Sordi (1982) pp 775-797 Heckel (1997) pp 30-34 Landucci (2014) pp 233-261 e Ead in questo volume
140 MONICA DrsquoAGOSTINI
ABSTRACT
Philip V of Macedon was the first of the Epigonoi to face Rome Several mod-ern reconstructions of the actions and the reign of Philip V have approached it largely from a Roman point of view using as sources Polybius and where Poly-bius is lost Livy The Polybian historiographical tradition tends to portray Phil-ip V as an enemy and a tyrant impious and cruel The Macedonian king was ea-ger to establish a universal and unjust dominion over Greece Italy and beyond and Rome engaged in the first two Macedonian Wars to fight the threat of his growing ambition Nevertheless Polybiusrsquo portrayal of Philip V was affected not only by Polybiusrsquo admiration for Roman political structures military power and overwhelming conquest but also his personal Achaean origins
Looking at in book 29 and 30 of Justinrsquos Epitome of Pompeius Trogus this pa-per focuses on the non Polybian tradition on Philip V this contribution is in-deed the first analysis of the Hellenistic approach to the clash between Rome and Macedonia in the 3rd-2nd Century BC The Epitome shows a considerable di-versity of interpretation from the other sources and reflects very different views of Philip Vrsquos actions that brought him into conflict against Rome In particular these views are more evident related to the accounts of the peace negotiations of Naupactus and the battle of Cynoscephalae in the Epitome the king appears as a courageous and skilled warrior the last of the great Macedonian rulers who fell victim to misfortune This portrayal which has several common features with Appianrsquos fragments of Philip V (Mak 9) counterbalances the Roman and Achaean standpoint present in Polybius providing a more Hellenistic perspec-tive that is likely to have been rooted in a historiographical tradition connect-ed to the losing side in the struggle between Rome and the Hellenistic world
BIBLIOGRAFIA
Adler E (2006) Whorsquos Antiroman Sallust and Pompeius Trogus on Mithridates CJ 101 pp 383-407
Adler E (2011) Valorizing the Barbarians Enemy speeches in Roman Historiography Austin
Ager SL (2003) An Uneasy Balance from the Death of Seleukos to the Battle of Raph-ia in A Erskine (ed) A Companion to the Hellenistic World Oxford pp 35-50
Ager SL (2009) Roman Perspectives on Greek Diplomacy The conceptual clash Greek diplomacy of compromise and Roman Bellum Iustum in C Eilers (ed) Diplomats and Diplomacy in the Roman World Leiden-Boston pp 15-43
Alonso-Nuacutentildeez JM (1992) La Historia Universal de Pompeyo Trogo Madrid
Alonso-Nuacutentildeez JM (2002) The Idea of Universal History in Greece From Herodotus to the Age of Augustus Amsterdam
Ballesteros Pastor L (2013) Pompeyo Trogo Justino y Mitriacutedates Comentario al Epiacutetome de las Historias Filiacutepicas (3716-3881) Hildesheim-Zuumlrich-New York
IL DISCORSO DEL RE 141
Barreacute ML (1983) The God-List in the Treaty between Hannibal and Philip V of Ma-cedon a Study in Light of the Ancient Near Eastern Treaty Tradition Baltimore-Lon-don
Beck H - Eckstein A (2015) sv ldquoAratos of Sicyon (231)rdquo in I Worthington (ed) Brillrsquos New Jacoby Brill Online
Borgna A (2014) Uno sguardo originale intorno a Roma Pompeo Trogo e Giustino laquoLa Biblioteca di ClassicoContemporaneoraquo 1 pp 52-77
Cassola F (1962) I gruppi politici romani nel III secolo aC Trieste
Champion CB (1997) The Nature of Authoritative Evidence in Polybios and Agelausrsquo Speech at Naupactos TAPhA 127 pp 111-128
Champion CB (2004) Cultural Politics in Polybiusrsquo Histories Berkeley
Coppola A (1993) Demetrio di Faro un protagonista dimenticato Roma
Criscuolo L (2011) I due testamenti di Tolemeo VIII Evergete II in A Joumlrdens - J F Quack (hrsg) Aumlgypten zwischen innerem Zwist und aumluszligerem Druck Die Zeit Ptole-maios VI bis VIII Wiesbaden pp 132-150
DrsquoAgostini M (2011) Filippo V e la Storia Romana di Appiano laquoAevumraquo 85 pp 99-121
Eckstein AM (1995) Moral vision in the Histories of Polybius Berkeley
Eckstein AM (2008) Rome enters in the Greek East From Anarchy to Hierarchy in the Hellenistic Mediterranean 230-217 BC Oxford
Eckstein AM (2013) Polybius Phylarchus and Historiographical Criticism CPh 108 4 pp 314-338
Errington RM (1969) Philopoemen Oxford
Errington RM (2008) A History of the Hellenistic World 323-30 BC Malden MA-Oxford
Forni G - Angeli Bertinelli MG (1982) Pompeo Trogo come fonte di storia ANRW II 30 2 pp 1298-1362
Franco C (1993) Trogo Giustino e i successori di Alessandro in L Braccesi - A Coppola - G Cresci Marrone - C Franco (a cura di) LrsquoAlessandro di Giustino dagli antichi ai moderni Roma pp 71-97
Gabba E (2003) Introduzione in D Foraboschi - SM Pizzetti (a cura di) La successione degli imperi e delle egemonie nelle relazioni internazionali Milano pp 7-9
Golan D (1995) The Res Graeciae in Polybius Four Studies Como
Green P (1990) Alexander to Actium The Historical Evolution of the Hellenistic Age Berkeley-Los Angeles
Gutschmid von A (1894) Die beiden ersten Buumlcher des Pompeius Trogus in A von Gutschmid - F Ruumlhl (hrsg) Kleine Schriften Leipzig pp 17-217
142 MONICA DrsquoAGOSTINI
Habicht C (1995) Athen Muumlnchen
Hammond NGL (1968) Illyris Rome and Macedon in 229-205 BC JRS 58 pp 1-21
Hammond NGL (1988) The Campaign and the Battle of Cynoscephalae in 197 BC JHS 108 pp 60-82
Heckel W (1997) Introduction (Part 2) in JC Yardley - W Heckel (eds) Ju-stin Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus Books 11-12 Alexander the Great Introduction Oxford pp 1-41
Heckel W (2012) Introduction in JC Yardley - P Wheatley - W Heckel (eds) Justin Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus II Books 13-15 The Successors to Alexander the Great Oxford pp 1-8
Huss W (1976) Untersuchungen zur Auszligenpolitik Ptolemaiosrsquo IV Muumlnchen
Huss W (2001) Aumlgypten in hellenistischer Zeit 332ndash30 v Chr Muumlnchen
Intrieri M (2011) Fra dialogo e conflitto Annibale e i Greci drsquoOccidente RStudFen 37 pp 53-82
Landucci F (2014) Filippo II e le Storie Filippiche un protagonista storico e storio-grafico in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 233-261
Landucci Gattinoni F (2011) Politica e ideologia in etagrave ellenistica laquoPolitica An-ticaraquo 1 pp 89-105
Leacutevy E (1994) Le discours drsquoAgeacutelaos de Naupacte in L Aigner Foresti - A Bar-zanograve - C Bearzot - L Prandi - G Zecchini (a cura di) Federazioni e federalismo nellrsquoEuropa antica Bergamo 21-25 settembre 1992 Milano (Alle radici della casa co-mune europea 1) pp 33-50
Longaretti L (1989) Lrsquoalleanza tra Annibale e Filippo V di Macedonia RIL 123 pp 183-192
Marasco G (1979-1980) La valutazione di Tolemeo IV Filopatore nella storiografia greca laquoSilenoraquo 5-6 pp 159-182
Mari M [- Musti D - Thornton J] (2002) Polibio Storie Volume III Libri V-VI Milano
Mariotta G (2014) Geografia e Geopolitica nelle Storie Filippiche in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 45-56
McGing B (2010) Polybiusrsquo Histories New York
McGing B (2013) Youthfulness in Polybius the case of Philip V of Macedon in B Gibson - T Harrison (eds) Polybius and his world Oxford pp 181-199
Meadows A (2013) Polybius Aratus and the History of the 140th Olympiad in B
IL DISCORSO DEL RE 143
Gibson - T Harrison (eds) Polybius and his World Essays in Honour of Frank Walbank Oxford pp 91-116
Mecca A (2001) Trogo Timagene e Polieno QS 54 pp 199-222
Meister K (1990) Die Griechische Geschichtsschreibung von den Anfaumlngen bis zum Ende des Hellenismus Stuttgart
Misch G (1949) Geschichte der Autobiographie I Frankfurt am Mein
Momigliano A (1980) Daniele e la teoria greca della successione degli imperi RAL 35 pp 157-162
Muccioli F (2013) Gli epiteti ufficiali dei re ellenistici Stuttgart (Historia Einzel-schriften 224)
Musti D (1978) Polibio e lrsquoimperialismo romano Napoli
Parmeggiani G (2011) Eforo di Cuma studi di storiografia greca Bologna
Peacutedech P (1964) La meacutethode historique de Polybe Paris
Pelling CBR [- Scardigli B - Manfredini M](1997) Plutarco Vite parallele Filopemene Tito Flaminino Milano
Richter H-D (1987) Untersuchungen zur hellenistischen Historiographie die Vorla-gen des Pompeius Trogus fuumlr die Darstellung der nachalexandrischen hellenistischen Ge-schichte (Iust 13-40) Frankfurt
Santi Amantini L (1972) Fonti e valore storico di Pompeo Trogo (Iustin XXXV e XXXVI) Genova
Santi Amantini L (1981) (a cura di) Giustino Storie Filippiche Epitome da Pom-peo Trogo Milano
Santi Amantini L (2003) Il tempo e i tempi nelle Storie Filippiche di Pompeo Tro-go RSA 33 pp 99-110
Schepens G (1983) Les rois ptolegravemaiumlques et lrsquohistoriographie Reacuteflexions sur la trans-formation de lrsquohistoire politique in E vanrsquot Dack - P van Dessel - W Van Gucht (eds) Egypt and the Hellenistic World Proceedings of the International Collo-quium Leuven 24-26 May 1982 Leuven (Studia Hellenistica 27) pp 351-368
Schlicher JJ (1933) Non-Assertive Elements in the Language of the Roman Histo-rians CPh 28 289-300
Schmitt T (1989) Die Bedeutung des zweiten Punischen Krieges fuumlr den Frieden in Naupaktos in H Devijver - E Lipinski (eds) Punic wars Proceedings of the Conference held in Antwerp from the 23th to the 26th of November 1988 in Cooperation with the Departement of History of the laquoUniversitait Antwerpenraquo UFSIA Leuven (Studia Phoenicia 10) pp 229-239
Scholten JB (2000) The Politics of Plunder Aitolians and their koinon in the early Hellenistic Era Berkeley
144 MONICA DrsquoAGOSTINI
Scuderi R (2005) Filippo V e Perseo nei frammenti diodorei in C Bearzot - F Lan-ducci (a cura di) Diodoro e lrsquoaltra Grecia Macedonia Occidente Ellenismo nella Bi-blioteca Storica Atti del convegno Milano 15-16 gennaio 2004 Milano pp 383-405
Sklenaacuter RJ (2004) Sources and Individuality in Two Passages of Livy laquoHistoriaraquo 53 pp 302-310
Sordi M (1982) Timagene di Alessandria Uno storico ellenocentrico e filobarbaro ANRW II 30 1 pp 775-797
Thornton J (2014) Le guerre macedoniche Roma
Urban R (1979) Wachstum und Kriese des achaumlischen Bundes Quellenstudien zur entwicklung des Bundes von 280 bis 222 V Chr Wiesbaden
Urban R (1982) laquoGallisches Bewusstseinraquo und laquoRomkritikraquo bei Pompeius Trogus ANRW II 30 2 pp 1424-1443
Vannicelli P (1987) Lrsquoeconomia delle Storie di Eforo RFIC 115 pp 165-191
Vattuone R (2014) Giustino e lrsquoOccidente greco I VI-V secolo aC in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 261-277
Vollmer D (1990) Symploke das Uumlbergreifen der roumlmischen Expansion auf den grie-chischen Osten Untersuchungen zur roumlmischen Aussenpolitik am Ende des 3 Jh V Chr Stuttgart
Walbank FW (1957) A Historical Commentary on Polibius I Oxford
Walbank FW (1967) A Historical Commentary on Polybius II Oxford
Walbank FW (1933) Aratos of Sicyon Cambridge
Walbank FW (2002) Η ΤΩΝ ΟΛΩΝ ΕΛΠΙΣ and the Antigonids in FW Walbank (ed) Polybius Rome and the Hellenistic World Essays and Reflections West Nyack NY pp 127-136
Weber G (1997) Interaktion Repraumlsentation und Herrschaft Der Koumlnigshof im Hel-lenismus in A Winterling (hrsg) Zwischen lsquoHausrsquo und lsquoStaatrsquo antike Houmlfe im Ver-gleich Munich pp 27-72
Will E (19822) Histoire politique du Monde Helleacutenistique II Nancy
Zecchini G (1990) La storiografia lagide in H Verdin - G Schepens - E De Keyser (eds) Purposes of History Studies in Greek Historiography from the 4th to the 2nd Centuries BC Proceedings of the International Colloquium of Leuven 24-26 May 1988 Leuven (Studia Hellenistica 30) pp 213-232
Zecchini G (2003) Polibio e la tradizione orale in A Casanova - P Desideri (a cura di) Evento racconto scrittura nellrsquoantichitagrave classica Firenze pp 123-141
Finito di stamparenel mese di novembre 2015
da LegoDigit srlLavis (TN)
IL DISCORSO DEL RE 133
nel 197 e lrsquoemergere dellrsquoisola di Hiera e in contemporanea il terremo-to a Rodi Quindi nellrsquoEpitome si annuncia che laquoil nascente impero dei Romani avrebbe divorato quello antico dei Greci e dei Macedoni37raquo Nel passo ricevono spazio soprattutto i due discorsi contrapposti del re ma-cedone Filippo e del comandante romano Flaminino pronunciati pri-ma dello scontro campale e costruiti ciascuno in modo da celebrare le imprese delle due potenze38 Lrsquoenfasi data dalla contrapposizione reto-rica delle parole dei generali egrave tale da rendere suggestiva lrsquoipotesi che lo scontro dovesse essere il momento centrale non solo del libro XXX ma forse di tutta lrsquoopera trogiana
Filippo elenca le grandi vittorie del passato dei Macedoni contro Per-siani Battriani Indiani e le popolazioni drsquoAsia fino allrsquoestremo Orien-te esortando i suoi a combattere con valore percheacute laquola libertagrave egrave piugrave cara del predominio39raquo Il discorso di Flaminino egrave invece piugrave lungo articola-to in un paragone tra Macedoni e Romani alle passate imprese di con-quista macedoni vengono contrapposte le piugrave recenti vittorie romane a Cartagine in Sicilia Italia e Spagna alla grandezza di Alessandro Ma-gno egrave contrapposta quella di Annibale che pure dai Romani era stato sconfitto Lrsquoattenzione poi si concentra su Filippo i Macedoni non laquodo-vevano essere valutati per lrsquoantica forza ma per le forze attuali40raquo poicheacute Filippo non era lrsquoinvitto e invincibile Alessandro Magno ma un ragaz-zo che non riusciva a difendere i propri confini I Macedoni rivendica-vano il valore degli antenati mentre i Romani quello dei propri soldati poicheacute quelli che erano ligrave schierati erano gli stessi che avevano sconfitto Annibale Dopo una cosigrave grandiosa introduzione la battaglia egrave descritta in uno dei paragrafi piugrave significativi di tutta lrsquoopera
His adhortationibus utrimque concitati milites proelio concurrunt alteri Orientis alteri Occidentis imperio gloriantes ferentesque in bellum alii maiorum suorum antiquam et ob-soletam gloriam alii uirentem recentibus experimentis uirtutis florem [16] Sed Macedo-nas Romana Fortuna uicit
I soldati incitati da queste esortazioni dallrsquouna e dallrsquoaltra parte si lanciaro-no nel combattimento vantandosi gli uni del dominio dellrsquoOriente gli altri dellrsquoOccidente e recando in guerra gli uni lrsquoantica e sbiadita gloria dei loro an-
37 Iust XXX 4 4 Quo prodigio territis omnibus uates cecinere oriens Romanorum imperium uetus Graecorum ac Macedonum uoraturum38 Sui discorsi precedenti la battaglia nellrsquoantichitagrave se da considerare reali o costruzioni storiografiche vd Adler (2011) pp 6-839 Iust XXX 4 7 tantoque hoc bellum fortius quam illa sustinendum quanto sit imperio libertas carior40 Iust XXX 4 10 Sed nec Macedonas ueteri fama sed praesentibus uiribus aestimandos
134 MONICA DrsquoAGOSTINI
tenati gli altri il fiore del loro valore fresco e vigoroso per le recenti prove Ma la Fortuna dei Romani vinse i Macedoni
Questo punto di vista probabilmente giagrave trogiano contrappone la virtugrave romana (virtutis flos) celebrata nei discorsi antecedenti la battaglia al-la Fortuna romana (Romana Fortuna) che decise la vittoria interpretabi-le come destino favorevole o buona stella Piugrave che unrsquoaffermazione anti-romana41 come egrave spesso stata intesa si puograve evidenziare il carattere sim-patetico della fonte verso Filippo V destinato a porre fine alla gloria di Filippo II e Alessandro e forse un approccio nostalgico verso i grandi regni macedoni la cui egravera egrave ormai giunta alla fine Tale prospettiva egrave as-sente in Polibio e nella tradizione che da lui dipende poco interessata alle vicende della gloria macedone leggendo infatti i frammenti soprav-vissuti del libro XVIII delle Storie dopo lrsquoaccurata descrizione della bat-taglia (18-33 e 34-40)42 Polibio commenta lo scontro affermando che avrebbe dedicato alcuni capitoli allrsquoesame delle strategie militari delle due armate percheacute (XVIII 28 4-6)
χρήσιμον καὶ καλὸν ἂν εἴη τὸ τὴν διαφορὰν ἐρευνῆσαι καὶ παρὰ τί συμβαίνει Ῥωμαίους ἐπικρατεῖν καὶ τὸ πρωτεῖον ἐκφέρεσθαι τῶν κατὰ πόλεμον ἀγώνων [5] ἵνα μὴ τύχην λέγοντες μόνον μακαρίζωμεν τοὺς κρατοῦντας ἀλόγως καθάπερ οἱ μάταιοι τῶν ἀνθρώπων ἀλλ᾽ εἰδότες τὰς ἀληθεῖς αἰτίας ἐπαινῶμεν καὶ θαυμάζωμεν κατὰ λόγον τοὺς ἡγουμένους
Puograve essere cosa buona e utile esaminare le differenze e per quale motivo i Ro-mani prevalgono e riportano il primo premio nelle competizioni di guerra af-fincheacute non esaltiamo i vincitori senza una ragione parlando solo di fortuna co-me fanno gli sciocchi ma conoscendo le vere cause lodiamo e ammiriamo i co-mandanti seguendo una logica
Polibio dunque sembra rispondere a coloro che parlavano della buo-na stella dei Romani sottolineando che la vittoria nasceva dalla superio-re strategia militare della legione43 Un punto di vista quindi opposto a quello espresso nellrsquoEpitome che proprio di Romana Fortuna parla e riba-dito in chiusura al passo dove Polibio critica nuovamente quei Greci che ritenevano la vittoria romana incredibile (XVIII 32 13)
41 Urban (1982) pp 1424-1443 1435 Richter (1987) p 19 n 4 Alonso-Nuacutentildeez (1992) p 66 e Id (2002) pp 105-110 partic 108-109 Contra Heckel (1997) p 29 che ridimen-siona la categorizzazione di Trogo come storico anti-romano 42 Su Cinoscefale vd Walbank (1957) ad l Hammond (1988) pp 60-82 Sklenaacuter (2004) pp 302-310 Thornton (2014) pp 83-87 43 Sulla Fortuna in Polibio vd McGing (2010) pp 195-201 (con bibliografia) che distin-gue tra quando Polibio intenda caso e quando predeterminazione fato Vd anche Green (1990) pp 400-402 e Eckstein (2008) pp 132-138
IL DISCORSO DEL RE 135
Il punto di vista di Trogo sembra invece presente nei frammenti del-la Makedonikeacute di Appiano su Filippo V44 dove ci si riferisce a Cinoscefale come a una vittoria insperata (Mak 9 1)
ἡγούμενος δ᾽ οὔτε Ῥωμαίοις συμφέρειν οὔτε τοῖς Ἕλλησι Φιλίππου καθαιρεθέντος ἐπιπολάσαι τὴν Αἰτωλῶν βίαν τάχα δ᾽ αὐτὸν καὶ τὸ παράδοξον τῆς νίκης ἀγαπᾶν ἐποίει
Flaminino era consapevole che non sarebbe stato vantaggioso per i Romani o per i Greci che Filippo fosse deposto e che il potere etolico rimanesse incon-trastato forse lo aveva reso moderato nei suoi progetti lrsquoaver ottenuto una vit-toria insperata
Addirittura successivamente si accenna alla sorte avversa a Filippo nel-lo scontro
τὰ μὲν δὴ παρὰ τῶν ἄλλων φιλάνθρωπα ἦν τό τε τῆς τύχης ἄδηλον ἐξ ὧν ἔπαθεν ὁ Φίλιππος ὑφορωμένων καὶ τὸ πταῖσμα τοῦτο οὐ κατ᾽ ἀσθένειαν ἀλλὰ πλέον ἐκ συντυχίας αὐτὸν παθεῖν ἡγουμένων
Gli altri (Greci) erano inclini ad essere moderati vedendo con sospetto lrsquoincer-tezza della fortuna subita da Filippo e ritenendo che egli fosse incorso in questa sconfitta non tanto per la sua inferioritagrave quanto per la sfortuna
Il riferimento in Appiano e Trogo alla fortuna romanasfortuna ma-cedone a proposito di Cinoscefale egrave una traccia dellrsquoopinione politi-ca di quei Greci disprezzati da Polibio come uomini sciocchi καθάπερ οἱ μάταιοι τῶν ἀνθρώπων Tale posizione politica su Cinoscefale sarebbe dunque sopravvissuta nella tradizione storiografica di cui troviamo trac-cia in TrogoGiustino e Appiano
Per comprendere meglio alcune caratteristiche di questa tradizione puograve essere utile tornare ai due discorsi nellrsquoEpitome di Filippo e Flamini-no prima della battaglia Tali passi probabilmente trogiani45 non trova-no infatti riscontro nelle fonti parallele a noi pervenute Polibio (XVIII 18-27) seguito fedelmente da Livio (XXXIII 5-10) pur descrivendo le operazioni di guerra di Cinoscefale con dovizia di particolari non men-ziona un discorso di Filippo ai suoi armati prima della battaglia mentre il discorso di Flaminino per incoraggiare le truppe schierate (XVIII 23 2-6) nelle Storie egrave incentrato sulle vittorie di Sulpicio nella prima parte della guerra Pare dunque originale la versione trogiana che incentra-
44 Tra i frammenti consegnatici dagli Excerpta Constantiniana sono frequenti informazio-ni e osservazioni che rimandano a una prospettiva ellenistica sugli eventi DrsquoAgostini (2011) pp 99-121 45 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362
136 MONICA DrsquoAGOSTINI
ta sulla gloria macedone presenta Cinoscefale come il punto drsquoincon-tro e di scambio tra lrsquoegemonia macedone e lrsquoegemonia romana Non egrave una novitagrave che il leitmotiv delle Storie Filippiche e dunque dellrsquoEpitome sia la translatio imperii giagrave Alonso Nuntildeez definito da Santi Amantini laquouno dei piugrave noti esperti di questioni trogiano-giustineeraquo46 osservava che Tro-go esponeva nel suo perduto lavoro la teoria della successione degli im-peri mondiali secondo lo schema Assiria-Media-Persia-Macedonia-Roma osteggiata dai Parti47 In tale successione il ruolo da protagonista egrave rico-perto dallrsquoegemonia macedone48 che occupa allrsquoincirca 26 dei 44 libri e il cui ultimo vero momento di gloria egrave lo scontro con Roma appunto a Cinoscefale Lrsquoultima impresa macedone ha come esito la transizione del dominio universale da Oriente a Occidente e costituisce il tema cen-trale dellrsquointera vicenda di Filippo lrsquoimportanza della battaglia di Cino-scefale egrave perciograve esaltata nei discorsi sia di Filippo che di Flaminino che a loro volta sono il punto di arrivo delle argomentazioni esposte nelle parole di Demetrio di Faro e di Filippo stesso giagrave nel libro XXIX Le ora-tiones disposte retoricamente nei due libri descrivono due parabole op-poste da un lato quella romana che da lontana potenza desiderosa di espandersi cresce come una pioggia di sangue diventando il giovane e vigoroso potere che sottomesso Annibale egrave pronto a sconfiggere Filip-po Dallrsquoaltro quella macedone che originata con Filippo II personag-gio centrale per Trogo raggiunge il suo apice con la conquista dellrsquoege-monia ad opera di Alessandro Magno contro i Persiani per conoscere la fine con Filippo V il cui antico valore egrave ormai troppo lsquosbiaditorsquo per te-ner testa al vigore romano
La gloria macedone secondo Trogo inizia dunque con Filippo II e si conclude con Filippo V Perseo egrave infatti il malvagio responsabile dellrsquoan-nientamento di ciograve che rimaneva della monarchia macedone49 Trogo pone agli estremi della parabola macedone che occupa dal libro IX al XXX i due re di nome Filippo Filippo II e Filippo V come ribadito in piugrave luoghi dellrsquoEpitome sia in parti riassunte da Giustino che in passi piugrave genuinamente trogiani Dando per scontato che il titolo dellrsquoopera Sto-rie Filippiche si debba al desiderio di Trogo di rifarsi allrsquoopera di Teopom-po sul sovrano macedone egrave possibile che tale titolo sia stato perograve ripen-
46 Santi Amantini (2003) pp 99-11047 laquoPompeius Trogus expounded in his lost work the Historiae Philippicae a theory of the world empire suggestion according to the scheme Assyria-Media-Persia-Macedonia-Rome opposed by the Parthiansraquo Alonso-Nuacutentildeez (2002) pp 105-110 e 133-136 partic 105 Vd anche Richter (1987) pp 19-23 Momigliano (1980) pp 157-162 Alonso-Nuacutentildeez (1992) Heckel (1997) pp 1-41 Gabba (2003) pp 7-9 Santi Amantini (2003) pp 99-110 Mariotta (2014) pp 45-56 48 Franco (1993) pp 71-97 e Landucci (2014) pp 233-26149 Alonso-Nuacutentildeez (2002) pp 105-110 partic 108-109
IL DISCORSO DEL RE 137
sato da Trogo considerando che il periodo compreso tra le imprese dei due Filippo occupa 23 dellrsquoopera50 Si potrebbe allora suggerire che le Storie sono Filippiche poicheacute i due Filippo segnarono lrsquoinizio e la fine di quella che egrave nellrsquoopera di Trogo lrsquoegemonia incontrastata del mondo piugrave gloriosa di tutti i tempi51
La prospettiva ellenistica che vede nei due Filippo i limiti della grande egemonia macedone egrave di nuovo presente anche in Appiano nellrsquooraco-lo riportato nei frammenti della sua Makedonikeacute e noto anche da Pausa-nia (VII 8 9)
αὐχοῦντες βασιλεῦσι Μακηδόνες Ἀργεάδῃσιν ὑμῖν κοιρανέων ἀγαθὸν καὶ πῆμα Φίλιππος ἤτοι ὁ μὲν πρότερος πόλεσιν λαοῖσί τ᾽ ἄνακτας θήσει ὁ δ᾽ ὁπλότερος τιμὴν ἀπὸ πᾶσαν ὀλέσσει δμηθεὶς δ᾽ ἑσπερίοισιν ὑπ᾽ ἀνδράσιν ἐνθάδ᾽ ὀλεῖται
O Macedoni che andate orgogliosi dei re di stirpe argiva I re di nome Filippo saranno arbitri del bene e del male per voi Il primo vi renderagrave signori di cittagrave e popoli il secondo vi priveragrave di ogni onore sconfitto da uomini dellrsquoOcciden-te qui giace morto52
Senza voler entrare nel merito della discussione di tale oracolo di nuo-vo pare di incontrare nei due autori la medesima prospettiva lontana dalla condanna morale del re macedone espressa da Polibio secondo cui la sconfitta egrave il giusto esito della sua crudeltagrave ed empietagrave
Il libro giustineo si conclude menzionando le condizioni della pa-ce di Tempe53 e lrsquoira degli Etoli che videro ignorate le proprie richieste da Flaminino e perciograve cercarono lrsquoalleanza di Antioco contro Roma Se-condo il Prologo XXX il libro perograve proseguiva con le campagne di Antio-co III in Asia Minore contro Molone e Acheo e in Battriana fino ad ar-rivare allrsquoesordio dello scontro con Roma54 Il riassunto giustineo egrave trop-po sommario per permettere un confronto con le fonti parallele Egrave pe-
50 Sul rilievo della storia della Macedonia nellrsquoopera di Trogo e Giustino vd von Gutsch-midt (1894) pp 17-217 Richter (1987) p 28 n 29 Franco (1993) pp 71-97 51 Vd anche Urban (1982) pp 1424-1443 e Alonso-Nuacutentildeez (1992) p 58 52 Mak Fr 2 Vd DrsquoAgostini (2011) pp 99-121 In questa Walbank (2002) pp 127-136 propone di interpretare anche un poema di Alceo di Messene (Anth Pal 9518)53 Egrave probabile che Trogo fornisse piugrave particolari riguardo a questa pace per esempio si puograve ritenere che vi fosse menzione dellrsquoinvio a Roma del figlio Demetrio da parte di Filippo come ostaggio dato che a Iust XXXII 2 3 si richiama appunto tale avvenimento54 Polyb XVIII 34 1-39 7 42 1-45 12 Liv XXXIII 11 3-13 15 24 1-31 11 Plut Flam IX 1-8 App Mak Fr IX riferiscono di due diverse trattative di pace caratterizzate da un vivace dibattito tra chi voleva lrsquoannientamento della Macedonia come in Grecia gli Etoli e a Roma Marco Claudio Marcello e coloro che desideravano la pace con la Macedonia in primis Flaminino
138 MONICA DrsquoAGOSTINI
rograve da notare la mancanza sia nel Prologo che nel testo del libro degli av-venimenti delle celebrazioni Istmie del 196 quando Flaminino procla-mograve la libertagrave dei Greci Piugrave in generale in tutta la narrazione di Giustino delle complesse trattative del 197-196 manca qualsiasi riferimento alla li-bertagrave dei Greci punto nodale nella tradizione di Polibio che con questa sottolineatura esalta sia il ruolo tirannico della Macedonia sia la grande generositagrave dei Romani nei confronti della Grecia Il silenzio di TrogoGiustino su tale questione mostra il prevedibile disinteresse per gli affari dei Greci e nel contempo conferma la presenza di una tradizione che si occupa soprattutto della storia delle monarchie ellenistiche allrsquointer-no della quale la posizione dellrsquoEllade egrave subalterna
Libro XXXII23- 34 Demetrio e Perseo
Gli ultimi anni di regno di Filippo tra il 183 e il 179 sono narrati in un passo breve del libro XXXII Il racconto in Giustino che egrave coerente con il Prologo trogiano segue in maniera sintetica la tradizione polibiana su questi eventi giunta a noi in alcuni passi lacunosi di Polibio (XXIII 1 3-3 10 7 1-7 10 1-11 8) integrati dal racconto particolareggiato di Li-vio (XXXIX 46 7- 48 6 53 1-16 XL 3 3-16 3 201-24 8) e dalla narra-zione di Diodoro (XIX 25) e Plutarco (Aem VIII 11)55
Conclusioni
In questi libri dedicati a Filippo egrave forse possibile vedere in filigrana la rielaborazione voluta di Giustino dei corrispondenti libri trogiani Co-me Giustino stesso afferma nella Prefatio 3 lrsquoopera di Trogo era costruita secondo due criteri quello cronologico e quello per laquoconcatenazione di eventi56raquo ea omnia Pompeius diuisa temporibus et serie rerum digesta conposuit
55 Lrsquoutilizzo della tradizione polibiana in Trogo egrave confermato dallrsquoaderenza a Livio (XL 54 1-56 11) e Diodoro (XXIX 28) del racconto sul pentimento di Filippo per aver ucciso il figlio Demetrio lrsquointenzione di punire Perseo e la correlazione tra questo e la sua mor-te Questo libro egrave dunque differente nellrsquointeresse e nelle fonti dai libri XXIX e XXX poicheacute molto vicino alla tradizione polibiana in Livio Questi avvenimenti in Giustino sono da collegare con lrsquoascesa al trono di Perseo e non con lrsquoepilogo della celebrazione del valore macedone giagrave conclusasi in Giustino con Cinoscefale e la transizione dallrsquoim-perium macedone allrsquoimperium romano Vd Heckel (1997) p 7 Appiano invece riporta ancora una tradizione diversa da quella polibiana in un frammento della Makedonikeacute in particolare Appiano egrave attento al punto di vista macedone e presenta Filippo come una vittima delle circostanze (Mak IX) DrsquoAgostini (2011) pp 99-12156 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362 Alonso-Nuacutentildeez (2002) pp 133-136 He-ckel (1997) pp 1-41 Borgna (2014) pp 52-77
IL DISCORSO DEL RE 139
Serie rerum digesta sembrerebbe unrsquointerpretazione latina della formula κατὰ γένος che Diodoro usa per indicare la struttura della storia di Efo-ro sottolineandone la divisione per argomento57 In tale struttura per argomento dellrsquoEpitome tra i temi principali ci sono dunque il valore e la gloria dei sovrani ellenistici58 riscontrabile nei libri XXVIII-XXXI sui re-gni di Antigono Dosone Filippo V e Antioco III Tale tema presente di sicuro in Trogo egrave conservato nellrsquoazione dellrsquoEpitomatore e anzi come si vede dagli escerpta esaltato dalla selezione dei passi
Per quanto riguarda invece la Quellenforschung 59 egrave evidente che nel testo vi sia presenza di filoni non tradizionali sugli eventi poicheacute la posi-zione di Trogo appare spesso autonoma rispetto alle opinioni condivise dalla storiografia antica Questo aspetto dellrsquoEpitome evidente soprattut-to per ciograve che riguarda gli eventi ellenistici ha suscitato la grande curio-sitagrave degli studiosi che allontanatisi dalla proposta di von Gutschmid che voleva una totale ed esclusiva dipendenza di Trogo da Timagene ora in-dicano con sicurezza tra le fonti piugrave rilevanti per gli eventi ellenistici di III secolo utilizzate da Trogo almeno altri sei nomi oltre a Timagene Ie-ronimo Timeo Filarco Duride Polibio e Posidonio
Per quanto riguarda nello specifico la composizione dei libri XXIX e XXX non vi egrave alcun dubbio che in essi Trogo abbia utilizzato (anche riadattandola) una fonte poco attenta alle questioni di politica interna greca e al legame tra queste e quel ritratto di Filippo come sovrano mal-vagio ed empio che ritorna nella tradizione ufficiale di origine polibia-na passando poi da Polibio in Livio Diodoro e Plutarco60 Trogo pre-serva invece una tradizione ellenistica interessata alla figura di Filippo come ultimo barlume della gloria macedone tradizione che pare quasi una controparte e un completamento dellrsquoAb urbe condita romanocentri-ca di Livio Non si puograve perciograve a mio avviso escludere che per questa se-zione Trogo abbia usato una tradizione di matrice filoellenistica o sem-plicemente ellenisticocentrica unrsquoopera sui regni di diadochi ed epigo-ni che a tutti noi fa venire facilmente alla mente il Basileis o Perigrave Basileon dello storico grecoellenistico augusteo filobarbaro scettico (o critico) verso lrsquoegemonia romana Timagene di Alessandria (FGrHist 88)61
57 Su Eforo vd Vannicelli (1987) pp 165-191 e ora Parmeggiani (2011) 58 Simile legame vi egrave a mio avviso tra i libri XXVI e XXVII che invece affrontavano la crisi delle monarchie ellenistiche causata dalle guerre fraterne59 Vd von Gutschmid (1894) pp 17-217 Richter (1987) pp 17-30 partic 20-23 San-ti Amantini (1972) pp 56-109 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362 Urban (1982) pp 1424-1443 partic 1435 Mecca (2001) pp 199-222 Santi Amantini (2003) pp 99-110 Heckel (2012) pp 3-860 Scuderi (2005) pp 383-40561 Sordi (1982) pp 775-797 Heckel (1997) pp 30-34 Landucci (2014) pp 233-261 e Ead in questo volume
140 MONICA DrsquoAGOSTINI
ABSTRACT
Philip V of Macedon was the first of the Epigonoi to face Rome Several mod-ern reconstructions of the actions and the reign of Philip V have approached it largely from a Roman point of view using as sources Polybius and where Poly-bius is lost Livy The Polybian historiographical tradition tends to portray Phil-ip V as an enemy and a tyrant impious and cruel The Macedonian king was ea-ger to establish a universal and unjust dominion over Greece Italy and beyond and Rome engaged in the first two Macedonian Wars to fight the threat of his growing ambition Nevertheless Polybiusrsquo portrayal of Philip V was affected not only by Polybiusrsquo admiration for Roman political structures military power and overwhelming conquest but also his personal Achaean origins
Looking at in book 29 and 30 of Justinrsquos Epitome of Pompeius Trogus this pa-per focuses on the non Polybian tradition on Philip V this contribution is in-deed the first analysis of the Hellenistic approach to the clash between Rome and Macedonia in the 3rd-2nd Century BC The Epitome shows a considerable di-versity of interpretation from the other sources and reflects very different views of Philip Vrsquos actions that brought him into conflict against Rome In particular these views are more evident related to the accounts of the peace negotiations of Naupactus and the battle of Cynoscephalae in the Epitome the king appears as a courageous and skilled warrior the last of the great Macedonian rulers who fell victim to misfortune This portrayal which has several common features with Appianrsquos fragments of Philip V (Mak 9) counterbalances the Roman and Achaean standpoint present in Polybius providing a more Hellenistic perspec-tive that is likely to have been rooted in a historiographical tradition connect-ed to the losing side in the struggle between Rome and the Hellenistic world
BIBLIOGRAFIA
Adler E (2006) Whorsquos Antiroman Sallust and Pompeius Trogus on Mithridates CJ 101 pp 383-407
Adler E (2011) Valorizing the Barbarians Enemy speeches in Roman Historiography Austin
Ager SL (2003) An Uneasy Balance from the Death of Seleukos to the Battle of Raph-ia in A Erskine (ed) A Companion to the Hellenistic World Oxford pp 35-50
Ager SL (2009) Roman Perspectives on Greek Diplomacy The conceptual clash Greek diplomacy of compromise and Roman Bellum Iustum in C Eilers (ed) Diplomats and Diplomacy in the Roman World Leiden-Boston pp 15-43
Alonso-Nuacutentildeez JM (1992) La Historia Universal de Pompeyo Trogo Madrid
Alonso-Nuacutentildeez JM (2002) The Idea of Universal History in Greece From Herodotus to the Age of Augustus Amsterdam
Ballesteros Pastor L (2013) Pompeyo Trogo Justino y Mitriacutedates Comentario al Epiacutetome de las Historias Filiacutepicas (3716-3881) Hildesheim-Zuumlrich-New York
IL DISCORSO DEL RE 141
Barreacute ML (1983) The God-List in the Treaty between Hannibal and Philip V of Ma-cedon a Study in Light of the Ancient Near Eastern Treaty Tradition Baltimore-Lon-don
Beck H - Eckstein A (2015) sv ldquoAratos of Sicyon (231)rdquo in I Worthington (ed) Brillrsquos New Jacoby Brill Online
Borgna A (2014) Uno sguardo originale intorno a Roma Pompeo Trogo e Giustino laquoLa Biblioteca di ClassicoContemporaneoraquo 1 pp 52-77
Cassola F (1962) I gruppi politici romani nel III secolo aC Trieste
Champion CB (1997) The Nature of Authoritative Evidence in Polybios and Agelausrsquo Speech at Naupactos TAPhA 127 pp 111-128
Champion CB (2004) Cultural Politics in Polybiusrsquo Histories Berkeley
Coppola A (1993) Demetrio di Faro un protagonista dimenticato Roma
Criscuolo L (2011) I due testamenti di Tolemeo VIII Evergete II in A Joumlrdens - J F Quack (hrsg) Aumlgypten zwischen innerem Zwist und aumluszligerem Druck Die Zeit Ptole-maios VI bis VIII Wiesbaden pp 132-150
DrsquoAgostini M (2011) Filippo V e la Storia Romana di Appiano laquoAevumraquo 85 pp 99-121
Eckstein AM (1995) Moral vision in the Histories of Polybius Berkeley
Eckstein AM (2008) Rome enters in the Greek East From Anarchy to Hierarchy in the Hellenistic Mediterranean 230-217 BC Oxford
Eckstein AM (2013) Polybius Phylarchus and Historiographical Criticism CPh 108 4 pp 314-338
Errington RM (1969) Philopoemen Oxford
Errington RM (2008) A History of the Hellenistic World 323-30 BC Malden MA-Oxford
Forni G - Angeli Bertinelli MG (1982) Pompeo Trogo come fonte di storia ANRW II 30 2 pp 1298-1362
Franco C (1993) Trogo Giustino e i successori di Alessandro in L Braccesi - A Coppola - G Cresci Marrone - C Franco (a cura di) LrsquoAlessandro di Giustino dagli antichi ai moderni Roma pp 71-97
Gabba E (2003) Introduzione in D Foraboschi - SM Pizzetti (a cura di) La successione degli imperi e delle egemonie nelle relazioni internazionali Milano pp 7-9
Golan D (1995) The Res Graeciae in Polybius Four Studies Como
Green P (1990) Alexander to Actium The Historical Evolution of the Hellenistic Age Berkeley-Los Angeles
Gutschmid von A (1894) Die beiden ersten Buumlcher des Pompeius Trogus in A von Gutschmid - F Ruumlhl (hrsg) Kleine Schriften Leipzig pp 17-217
142 MONICA DrsquoAGOSTINI
Habicht C (1995) Athen Muumlnchen
Hammond NGL (1968) Illyris Rome and Macedon in 229-205 BC JRS 58 pp 1-21
Hammond NGL (1988) The Campaign and the Battle of Cynoscephalae in 197 BC JHS 108 pp 60-82
Heckel W (1997) Introduction (Part 2) in JC Yardley - W Heckel (eds) Ju-stin Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus Books 11-12 Alexander the Great Introduction Oxford pp 1-41
Heckel W (2012) Introduction in JC Yardley - P Wheatley - W Heckel (eds) Justin Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus II Books 13-15 The Successors to Alexander the Great Oxford pp 1-8
Huss W (1976) Untersuchungen zur Auszligenpolitik Ptolemaiosrsquo IV Muumlnchen
Huss W (2001) Aumlgypten in hellenistischer Zeit 332ndash30 v Chr Muumlnchen
Intrieri M (2011) Fra dialogo e conflitto Annibale e i Greci drsquoOccidente RStudFen 37 pp 53-82
Landucci F (2014) Filippo II e le Storie Filippiche un protagonista storico e storio-grafico in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 233-261
Landucci Gattinoni F (2011) Politica e ideologia in etagrave ellenistica laquoPolitica An-ticaraquo 1 pp 89-105
Leacutevy E (1994) Le discours drsquoAgeacutelaos de Naupacte in L Aigner Foresti - A Bar-zanograve - C Bearzot - L Prandi - G Zecchini (a cura di) Federazioni e federalismo nellrsquoEuropa antica Bergamo 21-25 settembre 1992 Milano (Alle radici della casa co-mune europea 1) pp 33-50
Longaretti L (1989) Lrsquoalleanza tra Annibale e Filippo V di Macedonia RIL 123 pp 183-192
Marasco G (1979-1980) La valutazione di Tolemeo IV Filopatore nella storiografia greca laquoSilenoraquo 5-6 pp 159-182
Mari M [- Musti D - Thornton J] (2002) Polibio Storie Volume III Libri V-VI Milano
Mariotta G (2014) Geografia e Geopolitica nelle Storie Filippiche in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 45-56
McGing B (2010) Polybiusrsquo Histories New York
McGing B (2013) Youthfulness in Polybius the case of Philip V of Macedon in B Gibson - T Harrison (eds) Polybius and his world Oxford pp 181-199
Meadows A (2013) Polybius Aratus and the History of the 140th Olympiad in B
IL DISCORSO DEL RE 143
Gibson - T Harrison (eds) Polybius and his World Essays in Honour of Frank Walbank Oxford pp 91-116
Mecca A (2001) Trogo Timagene e Polieno QS 54 pp 199-222
Meister K (1990) Die Griechische Geschichtsschreibung von den Anfaumlngen bis zum Ende des Hellenismus Stuttgart
Misch G (1949) Geschichte der Autobiographie I Frankfurt am Mein
Momigliano A (1980) Daniele e la teoria greca della successione degli imperi RAL 35 pp 157-162
Muccioli F (2013) Gli epiteti ufficiali dei re ellenistici Stuttgart (Historia Einzel-schriften 224)
Musti D (1978) Polibio e lrsquoimperialismo romano Napoli
Parmeggiani G (2011) Eforo di Cuma studi di storiografia greca Bologna
Peacutedech P (1964) La meacutethode historique de Polybe Paris
Pelling CBR [- Scardigli B - Manfredini M](1997) Plutarco Vite parallele Filopemene Tito Flaminino Milano
Richter H-D (1987) Untersuchungen zur hellenistischen Historiographie die Vorla-gen des Pompeius Trogus fuumlr die Darstellung der nachalexandrischen hellenistischen Ge-schichte (Iust 13-40) Frankfurt
Santi Amantini L (1972) Fonti e valore storico di Pompeo Trogo (Iustin XXXV e XXXVI) Genova
Santi Amantini L (1981) (a cura di) Giustino Storie Filippiche Epitome da Pom-peo Trogo Milano
Santi Amantini L (2003) Il tempo e i tempi nelle Storie Filippiche di Pompeo Tro-go RSA 33 pp 99-110
Schepens G (1983) Les rois ptolegravemaiumlques et lrsquohistoriographie Reacuteflexions sur la trans-formation de lrsquohistoire politique in E vanrsquot Dack - P van Dessel - W Van Gucht (eds) Egypt and the Hellenistic World Proceedings of the International Collo-quium Leuven 24-26 May 1982 Leuven (Studia Hellenistica 27) pp 351-368
Schlicher JJ (1933) Non-Assertive Elements in the Language of the Roman Histo-rians CPh 28 289-300
Schmitt T (1989) Die Bedeutung des zweiten Punischen Krieges fuumlr den Frieden in Naupaktos in H Devijver - E Lipinski (eds) Punic wars Proceedings of the Conference held in Antwerp from the 23th to the 26th of November 1988 in Cooperation with the Departement of History of the laquoUniversitait Antwerpenraquo UFSIA Leuven (Studia Phoenicia 10) pp 229-239
Scholten JB (2000) The Politics of Plunder Aitolians and their koinon in the early Hellenistic Era Berkeley
144 MONICA DrsquoAGOSTINI
Scuderi R (2005) Filippo V e Perseo nei frammenti diodorei in C Bearzot - F Lan-ducci (a cura di) Diodoro e lrsquoaltra Grecia Macedonia Occidente Ellenismo nella Bi-blioteca Storica Atti del convegno Milano 15-16 gennaio 2004 Milano pp 383-405
Sklenaacuter RJ (2004) Sources and Individuality in Two Passages of Livy laquoHistoriaraquo 53 pp 302-310
Sordi M (1982) Timagene di Alessandria Uno storico ellenocentrico e filobarbaro ANRW II 30 1 pp 775-797
Thornton J (2014) Le guerre macedoniche Roma
Urban R (1979) Wachstum und Kriese des achaumlischen Bundes Quellenstudien zur entwicklung des Bundes von 280 bis 222 V Chr Wiesbaden
Urban R (1982) laquoGallisches Bewusstseinraquo und laquoRomkritikraquo bei Pompeius Trogus ANRW II 30 2 pp 1424-1443
Vannicelli P (1987) Lrsquoeconomia delle Storie di Eforo RFIC 115 pp 165-191
Vattuone R (2014) Giustino e lrsquoOccidente greco I VI-V secolo aC in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 261-277
Vollmer D (1990) Symploke das Uumlbergreifen der roumlmischen Expansion auf den grie-chischen Osten Untersuchungen zur roumlmischen Aussenpolitik am Ende des 3 Jh V Chr Stuttgart
Walbank FW (1957) A Historical Commentary on Polibius I Oxford
Walbank FW (1967) A Historical Commentary on Polybius II Oxford
Walbank FW (1933) Aratos of Sicyon Cambridge
Walbank FW (2002) Η ΤΩΝ ΟΛΩΝ ΕΛΠΙΣ and the Antigonids in FW Walbank (ed) Polybius Rome and the Hellenistic World Essays and Reflections West Nyack NY pp 127-136
Weber G (1997) Interaktion Repraumlsentation und Herrschaft Der Koumlnigshof im Hel-lenismus in A Winterling (hrsg) Zwischen lsquoHausrsquo und lsquoStaatrsquo antike Houmlfe im Ver-gleich Munich pp 27-72
Will E (19822) Histoire politique du Monde Helleacutenistique II Nancy
Zecchini G (1990) La storiografia lagide in H Verdin - G Schepens - E De Keyser (eds) Purposes of History Studies in Greek Historiography from the 4th to the 2nd Centuries BC Proceedings of the International Colloquium of Leuven 24-26 May 1988 Leuven (Studia Hellenistica 30) pp 213-232
Zecchini G (2003) Polibio e la tradizione orale in A Casanova - P Desideri (a cura di) Evento racconto scrittura nellrsquoantichitagrave classica Firenze pp 123-141
Finito di stamparenel mese di novembre 2015
da LegoDigit srlLavis (TN)
134 MONICA DrsquoAGOSTINI
tenati gli altri il fiore del loro valore fresco e vigoroso per le recenti prove Ma la Fortuna dei Romani vinse i Macedoni
Questo punto di vista probabilmente giagrave trogiano contrappone la virtugrave romana (virtutis flos) celebrata nei discorsi antecedenti la battaglia al-la Fortuna romana (Romana Fortuna) che decise la vittoria interpretabi-le come destino favorevole o buona stella Piugrave che unrsquoaffermazione anti-romana41 come egrave spesso stata intesa si puograve evidenziare il carattere sim-patetico della fonte verso Filippo V destinato a porre fine alla gloria di Filippo II e Alessandro e forse un approccio nostalgico verso i grandi regni macedoni la cui egravera egrave ormai giunta alla fine Tale prospettiva egrave as-sente in Polibio e nella tradizione che da lui dipende poco interessata alle vicende della gloria macedone leggendo infatti i frammenti soprav-vissuti del libro XVIII delle Storie dopo lrsquoaccurata descrizione della bat-taglia (18-33 e 34-40)42 Polibio commenta lo scontro affermando che avrebbe dedicato alcuni capitoli allrsquoesame delle strategie militari delle due armate percheacute (XVIII 28 4-6)
χρήσιμον καὶ καλὸν ἂν εἴη τὸ τὴν διαφορὰν ἐρευνῆσαι καὶ παρὰ τί συμβαίνει Ῥωμαίους ἐπικρατεῖν καὶ τὸ πρωτεῖον ἐκφέρεσθαι τῶν κατὰ πόλεμον ἀγώνων [5] ἵνα μὴ τύχην λέγοντες μόνον μακαρίζωμεν τοὺς κρατοῦντας ἀλόγως καθάπερ οἱ μάταιοι τῶν ἀνθρώπων ἀλλ᾽ εἰδότες τὰς ἀληθεῖς αἰτίας ἐπαινῶμεν καὶ θαυμάζωμεν κατὰ λόγον τοὺς ἡγουμένους
Puograve essere cosa buona e utile esaminare le differenze e per quale motivo i Ro-mani prevalgono e riportano il primo premio nelle competizioni di guerra af-fincheacute non esaltiamo i vincitori senza una ragione parlando solo di fortuna co-me fanno gli sciocchi ma conoscendo le vere cause lodiamo e ammiriamo i co-mandanti seguendo una logica
Polibio dunque sembra rispondere a coloro che parlavano della buo-na stella dei Romani sottolineando che la vittoria nasceva dalla superio-re strategia militare della legione43 Un punto di vista quindi opposto a quello espresso nellrsquoEpitome che proprio di Romana Fortuna parla e riba-dito in chiusura al passo dove Polibio critica nuovamente quei Greci che ritenevano la vittoria romana incredibile (XVIII 32 13)
41 Urban (1982) pp 1424-1443 1435 Richter (1987) p 19 n 4 Alonso-Nuacutentildeez (1992) p 66 e Id (2002) pp 105-110 partic 108-109 Contra Heckel (1997) p 29 che ridimen-siona la categorizzazione di Trogo come storico anti-romano 42 Su Cinoscefale vd Walbank (1957) ad l Hammond (1988) pp 60-82 Sklenaacuter (2004) pp 302-310 Thornton (2014) pp 83-87 43 Sulla Fortuna in Polibio vd McGing (2010) pp 195-201 (con bibliografia) che distin-gue tra quando Polibio intenda caso e quando predeterminazione fato Vd anche Green (1990) pp 400-402 e Eckstein (2008) pp 132-138
IL DISCORSO DEL RE 135
Il punto di vista di Trogo sembra invece presente nei frammenti del-la Makedonikeacute di Appiano su Filippo V44 dove ci si riferisce a Cinoscefale come a una vittoria insperata (Mak 9 1)
ἡγούμενος δ᾽ οὔτε Ῥωμαίοις συμφέρειν οὔτε τοῖς Ἕλλησι Φιλίππου καθαιρεθέντος ἐπιπολάσαι τὴν Αἰτωλῶν βίαν τάχα δ᾽ αὐτὸν καὶ τὸ παράδοξον τῆς νίκης ἀγαπᾶν ἐποίει
Flaminino era consapevole che non sarebbe stato vantaggioso per i Romani o per i Greci che Filippo fosse deposto e che il potere etolico rimanesse incon-trastato forse lo aveva reso moderato nei suoi progetti lrsquoaver ottenuto una vit-toria insperata
Addirittura successivamente si accenna alla sorte avversa a Filippo nel-lo scontro
τὰ μὲν δὴ παρὰ τῶν ἄλλων φιλάνθρωπα ἦν τό τε τῆς τύχης ἄδηλον ἐξ ὧν ἔπαθεν ὁ Φίλιππος ὑφορωμένων καὶ τὸ πταῖσμα τοῦτο οὐ κατ᾽ ἀσθένειαν ἀλλὰ πλέον ἐκ συντυχίας αὐτὸν παθεῖν ἡγουμένων
Gli altri (Greci) erano inclini ad essere moderati vedendo con sospetto lrsquoincer-tezza della fortuna subita da Filippo e ritenendo che egli fosse incorso in questa sconfitta non tanto per la sua inferioritagrave quanto per la sfortuna
Il riferimento in Appiano e Trogo alla fortuna romanasfortuna ma-cedone a proposito di Cinoscefale egrave una traccia dellrsquoopinione politi-ca di quei Greci disprezzati da Polibio come uomini sciocchi καθάπερ οἱ μάταιοι τῶν ἀνθρώπων Tale posizione politica su Cinoscefale sarebbe dunque sopravvissuta nella tradizione storiografica di cui troviamo trac-cia in TrogoGiustino e Appiano
Per comprendere meglio alcune caratteristiche di questa tradizione puograve essere utile tornare ai due discorsi nellrsquoEpitome di Filippo e Flamini-no prima della battaglia Tali passi probabilmente trogiani45 non trova-no infatti riscontro nelle fonti parallele a noi pervenute Polibio (XVIII 18-27) seguito fedelmente da Livio (XXXIII 5-10) pur descrivendo le operazioni di guerra di Cinoscefale con dovizia di particolari non men-ziona un discorso di Filippo ai suoi armati prima della battaglia mentre il discorso di Flaminino per incoraggiare le truppe schierate (XVIII 23 2-6) nelle Storie egrave incentrato sulle vittorie di Sulpicio nella prima parte della guerra Pare dunque originale la versione trogiana che incentra-
44 Tra i frammenti consegnatici dagli Excerpta Constantiniana sono frequenti informazio-ni e osservazioni che rimandano a una prospettiva ellenistica sugli eventi DrsquoAgostini (2011) pp 99-121 45 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362
136 MONICA DrsquoAGOSTINI
ta sulla gloria macedone presenta Cinoscefale come il punto drsquoincon-tro e di scambio tra lrsquoegemonia macedone e lrsquoegemonia romana Non egrave una novitagrave che il leitmotiv delle Storie Filippiche e dunque dellrsquoEpitome sia la translatio imperii giagrave Alonso Nuntildeez definito da Santi Amantini laquouno dei piugrave noti esperti di questioni trogiano-giustineeraquo46 osservava che Tro-go esponeva nel suo perduto lavoro la teoria della successione degli im-peri mondiali secondo lo schema Assiria-Media-Persia-Macedonia-Roma osteggiata dai Parti47 In tale successione il ruolo da protagonista egrave rico-perto dallrsquoegemonia macedone48 che occupa allrsquoincirca 26 dei 44 libri e il cui ultimo vero momento di gloria egrave lo scontro con Roma appunto a Cinoscefale Lrsquoultima impresa macedone ha come esito la transizione del dominio universale da Oriente a Occidente e costituisce il tema cen-trale dellrsquointera vicenda di Filippo lrsquoimportanza della battaglia di Cino-scefale egrave perciograve esaltata nei discorsi sia di Filippo che di Flaminino che a loro volta sono il punto di arrivo delle argomentazioni esposte nelle parole di Demetrio di Faro e di Filippo stesso giagrave nel libro XXIX Le ora-tiones disposte retoricamente nei due libri descrivono due parabole op-poste da un lato quella romana che da lontana potenza desiderosa di espandersi cresce come una pioggia di sangue diventando il giovane e vigoroso potere che sottomesso Annibale egrave pronto a sconfiggere Filip-po Dallrsquoaltro quella macedone che originata con Filippo II personag-gio centrale per Trogo raggiunge il suo apice con la conquista dellrsquoege-monia ad opera di Alessandro Magno contro i Persiani per conoscere la fine con Filippo V il cui antico valore egrave ormai troppo lsquosbiaditorsquo per te-ner testa al vigore romano
La gloria macedone secondo Trogo inizia dunque con Filippo II e si conclude con Filippo V Perseo egrave infatti il malvagio responsabile dellrsquoan-nientamento di ciograve che rimaneva della monarchia macedone49 Trogo pone agli estremi della parabola macedone che occupa dal libro IX al XXX i due re di nome Filippo Filippo II e Filippo V come ribadito in piugrave luoghi dellrsquoEpitome sia in parti riassunte da Giustino che in passi piugrave genuinamente trogiani Dando per scontato che il titolo dellrsquoopera Sto-rie Filippiche si debba al desiderio di Trogo di rifarsi allrsquoopera di Teopom-po sul sovrano macedone egrave possibile che tale titolo sia stato perograve ripen-
46 Santi Amantini (2003) pp 99-11047 laquoPompeius Trogus expounded in his lost work the Historiae Philippicae a theory of the world empire suggestion according to the scheme Assyria-Media-Persia-Macedonia-Rome opposed by the Parthiansraquo Alonso-Nuacutentildeez (2002) pp 105-110 e 133-136 partic 105 Vd anche Richter (1987) pp 19-23 Momigliano (1980) pp 157-162 Alonso-Nuacutentildeez (1992) Heckel (1997) pp 1-41 Gabba (2003) pp 7-9 Santi Amantini (2003) pp 99-110 Mariotta (2014) pp 45-56 48 Franco (1993) pp 71-97 e Landucci (2014) pp 233-26149 Alonso-Nuacutentildeez (2002) pp 105-110 partic 108-109
IL DISCORSO DEL RE 137
sato da Trogo considerando che il periodo compreso tra le imprese dei due Filippo occupa 23 dellrsquoopera50 Si potrebbe allora suggerire che le Storie sono Filippiche poicheacute i due Filippo segnarono lrsquoinizio e la fine di quella che egrave nellrsquoopera di Trogo lrsquoegemonia incontrastata del mondo piugrave gloriosa di tutti i tempi51
La prospettiva ellenistica che vede nei due Filippo i limiti della grande egemonia macedone egrave di nuovo presente anche in Appiano nellrsquooraco-lo riportato nei frammenti della sua Makedonikeacute e noto anche da Pausa-nia (VII 8 9)
αὐχοῦντες βασιλεῦσι Μακηδόνες Ἀργεάδῃσιν ὑμῖν κοιρανέων ἀγαθὸν καὶ πῆμα Φίλιππος ἤτοι ὁ μὲν πρότερος πόλεσιν λαοῖσί τ᾽ ἄνακτας θήσει ὁ δ᾽ ὁπλότερος τιμὴν ἀπὸ πᾶσαν ὀλέσσει δμηθεὶς δ᾽ ἑσπερίοισιν ὑπ᾽ ἀνδράσιν ἐνθάδ᾽ ὀλεῖται
O Macedoni che andate orgogliosi dei re di stirpe argiva I re di nome Filippo saranno arbitri del bene e del male per voi Il primo vi renderagrave signori di cittagrave e popoli il secondo vi priveragrave di ogni onore sconfitto da uomini dellrsquoOcciden-te qui giace morto52
Senza voler entrare nel merito della discussione di tale oracolo di nuo-vo pare di incontrare nei due autori la medesima prospettiva lontana dalla condanna morale del re macedone espressa da Polibio secondo cui la sconfitta egrave il giusto esito della sua crudeltagrave ed empietagrave
Il libro giustineo si conclude menzionando le condizioni della pa-ce di Tempe53 e lrsquoira degli Etoli che videro ignorate le proprie richieste da Flaminino e perciograve cercarono lrsquoalleanza di Antioco contro Roma Se-condo il Prologo XXX il libro perograve proseguiva con le campagne di Antio-co III in Asia Minore contro Molone e Acheo e in Battriana fino ad ar-rivare allrsquoesordio dello scontro con Roma54 Il riassunto giustineo egrave trop-po sommario per permettere un confronto con le fonti parallele Egrave pe-
50 Sul rilievo della storia della Macedonia nellrsquoopera di Trogo e Giustino vd von Gutsch-midt (1894) pp 17-217 Richter (1987) p 28 n 29 Franco (1993) pp 71-97 51 Vd anche Urban (1982) pp 1424-1443 e Alonso-Nuacutentildeez (1992) p 58 52 Mak Fr 2 Vd DrsquoAgostini (2011) pp 99-121 In questa Walbank (2002) pp 127-136 propone di interpretare anche un poema di Alceo di Messene (Anth Pal 9518)53 Egrave probabile che Trogo fornisse piugrave particolari riguardo a questa pace per esempio si puograve ritenere che vi fosse menzione dellrsquoinvio a Roma del figlio Demetrio da parte di Filippo come ostaggio dato che a Iust XXXII 2 3 si richiama appunto tale avvenimento54 Polyb XVIII 34 1-39 7 42 1-45 12 Liv XXXIII 11 3-13 15 24 1-31 11 Plut Flam IX 1-8 App Mak Fr IX riferiscono di due diverse trattative di pace caratterizzate da un vivace dibattito tra chi voleva lrsquoannientamento della Macedonia come in Grecia gli Etoli e a Roma Marco Claudio Marcello e coloro che desideravano la pace con la Macedonia in primis Flaminino
138 MONICA DrsquoAGOSTINI
rograve da notare la mancanza sia nel Prologo che nel testo del libro degli av-venimenti delle celebrazioni Istmie del 196 quando Flaminino procla-mograve la libertagrave dei Greci Piugrave in generale in tutta la narrazione di Giustino delle complesse trattative del 197-196 manca qualsiasi riferimento alla li-bertagrave dei Greci punto nodale nella tradizione di Polibio che con questa sottolineatura esalta sia il ruolo tirannico della Macedonia sia la grande generositagrave dei Romani nei confronti della Grecia Il silenzio di TrogoGiustino su tale questione mostra il prevedibile disinteresse per gli affari dei Greci e nel contempo conferma la presenza di una tradizione che si occupa soprattutto della storia delle monarchie ellenistiche allrsquointer-no della quale la posizione dellrsquoEllade egrave subalterna
Libro XXXII23- 34 Demetrio e Perseo
Gli ultimi anni di regno di Filippo tra il 183 e il 179 sono narrati in un passo breve del libro XXXII Il racconto in Giustino che egrave coerente con il Prologo trogiano segue in maniera sintetica la tradizione polibiana su questi eventi giunta a noi in alcuni passi lacunosi di Polibio (XXIII 1 3-3 10 7 1-7 10 1-11 8) integrati dal racconto particolareggiato di Li-vio (XXXIX 46 7- 48 6 53 1-16 XL 3 3-16 3 201-24 8) e dalla narra-zione di Diodoro (XIX 25) e Plutarco (Aem VIII 11)55
Conclusioni
In questi libri dedicati a Filippo egrave forse possibile vedere in filigrana la rielaborazione voluta di Giustino dei corrispondenti libri trogiani Co-me Giustino stesso afferma nella Prefatio 3 lrsquoopera di Trogo era costruita secondo due criteri quello cronologico e quello per laquoconcatenazione di eventi56raquo ea omnia Pompeius diuisa temporibus et serie rerum digesta conposuit
55 Lrsquoutilizzo della tradizione polibiana in Trogo egrave confermato dallrsquoaderenza a Livio (XL 54 1-56 11) e Diodoro (XXIX 28) del racconto sul pentimento di Filippo per aver ucciso il figlio Demetrio lrsquointenzione di punire Perseo e la correlazione tra questo e la sua mor-te Questo libro egrave dunque differente nellrsquointeresse e nelle fonti dai libri XXIX e XXX poicheacute molto vicino alla tradizione polibiana in Livio Questi avvenimenti in Giustino sono da collegare con lrsquoascesa al trono di Perseo e non con lrsquoepilogo della celebrazione del valore macedone giagrave conclusasi in Giustino con Cinoscefale e la transizione dallrsquoim-perium macedone allrsquoimperium romano Vd Heckel (1997) p 7 Appiano invece riporta ancora una tradizione diversa da quella polibiana in un frammento della Makedonikeacute in particolare Appiano egrave attento al punto di vista macedone e presenta Filippo come una vittima delle circostanze (Mak IX) DrsquoAgostini (2011) pp 99-12156 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362 Alonso-Nuacutentildeez (2002) pp 133-136 He-ckel (1997) pp 1-41 Borgna (2014) pp 52-77
IL DISCORSO DEL RE 139
Serie rerum digesta sembrerebbe unrsquointerpretazione latina della formula κατὰ γένος che Diodoro usa per indicare la struttura della storia di Efo-ro sottolineandone la divisione per argomento57 In tale struttura per argomento dellrsquoEpitome tra i temi principali ci sono dunque il valore e la gloria dei sovrani ellenistici58 riscontrabile nei libri XXVIII-XXXI sui re-gni di Antigono Dosone Filippo V e Antioco III Tale tema presente di sicuro in Trogo egrave conservato nellrsquoazione dellrsquoEpitomatore e anzi come si vede dagli escerpta esaltato dalla selezione dei passi
Per quanto riguarda invece la Quellenforschung 59 egrave evidente che nel testo vi sia presenza di filoni non tradizionali sugli eventi poicheacute la posi-zione di Trogo appare spesso autonoma rispetto alle opinioni condivise dalla storiografia antica Questo aspetto dellrsquoEpitome evidente soprattut-to per ciograve che riguarda gli eventi ellenistici ha suscitato la grande curio-sitagrave degli studiosi che allontanatisi dalla proposta di von Gutschmid che voleva una totale ed esclusiva dipendenza di Trogo da Timagene ora in-dicano con sicurezza tra le fonti piugrave rilevanti per gli eventi ellenistici di III secolo utilizzate da Trogo almeno altri sei nomi oltre a Timagene Ie-ronimo Timeo Filarco Duride Polibio e Posidonio
Per quanto riguarda nello specifico la composizione dei libri XXIX e XXX non vi egrave alcun dubbio che in essi Trogo abbia utilizzato (anche riadattandola) una fonte poco attenta alle questioni di politica interna greca e al legame tra queste e quel ritratto di Filippo come sovrano mal-vagio ed empio che ritorna nella tradizione ufficiale di origine polibia-na passando poi da Polibio in Livio Diodoro e Plutarco60 Trogo pre-serva invece una tradizione ellenistica interessata alla figura di Filippo come ultimo barlume della gloria macedone tradizione che pare quasi una controparte e un completamento dellrsquoAb urbe condita romanocentri-ca di Livio Non si puograve perciograve a mio avviso escludere che per questa se-zione Trogo abbia usato una tradizione di matrice filoellenistica o sem-plicemente ellenisticocentrica unrsquoopera sui regni di diadochi ed epigo-ni che a tutti noi fa venire facilmente alla mente il Basileis o Perigrave Basileon dello storico grecoellenistico augusteo filobarbaro scettico (o critico) verso lrsquoegemonia romana Timagene di Alessandria (FGrHist 88)61
57 Su Eforo vd Vannicelli (1987) pp 165-191 e ora Parmeggiani (2011) 58 Simile legame vi egrave a mio avviso tra i libri XXVI e XXVII che invece affrontavano la crisi delle monarchie ellenistiche causata dalle guerre fraterne59 Vd von Gutschmid (1894) pp 17-217 Richter (1987) pp 17-30 partic 20-23 San-ti Amantini (1972) pp 56-109 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362 Urban (1982) pp 1424-1443 partic 1435 Mecca (2001) pp 199-222 Santi Amantini (2003) pp 99-110 Heckel (2012) pp 3-860 Scuderi (2005) pp 383-40561 Sordi (1982) pp 775-797 Heckel (1997) pp 30-34 Landucci (2014) pp 233-261 e Ead in questo volume
140 MONICA DrsquoAGOSTINI
ABSTRACT
Philip V of Macedon was the first of the Epigonoi to face Rome Several mod-ern reconstructions of the actions and the reign of Philip V have approached it largely from a Roman point of view using as sources Polybius and where Poly-bius is lost Livy The Polybian historiographical tradition tends to portray Phil-ip V as an enemy and a tyrant impious and cruel The Macedonian king was ea-ger to establish a universal and unjust dominion over Greece Italy and beyond and Rome engaged in the first two Macedonian Wars to fight the threat of his growing ambition Nevertheless Polybiusrsquo portrayal of Philip V was affected not only by Polybiusrsquo admiration for Roman political structures military power and overwhelming conquest but also his personal Achaean origins
Looking at in book 29 and 30 of Justinrsquos Epitome of Pompeius Trogus this pa-per focuses on the non Polybian tradition on Philip V this contribution is in-deed the first analysis of the Hellenistic approach to the clash between Rome and Macedonia in the 3rd-2nd Century BC The Epitome shows a considerable di-versity of interpretation from the other sources and reflects very different views of Philip Vrsquos actions that brought him into conflict against Rome In particular these views are more evident related to the accounts of the peace negotiations of Naupactus and the battle of Cynoscephalae in the Epitome the king appears as a courageous and skilled warrior the last of the great Macedonian rulers who fell victim to misfortune This portrayal which has several common features with Appianrsquos fragments of Philip V (Mak 9) counterbalances the Roman and Achaean standpoint present in Polybius providing a more Hellenistic perspec-tive that is likely to have been rooted in a historiographical tradition connect-ed to the losing side in the struggle between Rome and the Hellenistic world
BIBLIOGRAFIA
Adler E (2006) Whorsquos Antiroman Sallust and Pompeius Trogus on Mithridates CJ 101 pp 383-407
Adler E (2011) Valorizing the Barbarians Enemy speeches in Roman Historiography Austin
Ager SL (2003) An Uneasy Balance from the Death of Seleukos to the Battle of Raph-ia in A Erskine (ed) A Companion to the Hellenistic World Oxford pp 35-50
Ager SL (2009) Roman Perspectives on Greek Diplomacy The conceptual clash Greek diplomacy of compromise and Roman Bellum Iustum in C Eilers (ed) Diplomats and Diplomacy in the Roman World Leiden-Boston pp 15-43
Alonso-Nuacutentildeez JM (1992) La Historia Universal de Pompeyo Trogo Madrid
Alonso-Nuacutentildeez JM (2002) The Idea of Universal History in Greece From Herodotus to the Age of Augustus Amsterdam
Ballesteros Pastor L (2013) Pompeyo Trogo Justino y Mitriacutedates Comentario al Epiacutetome de las Historias Filiacutepicas (3716-3881) Hildesheim-Zuumlrich-New York
IL DISCORSO DEL RE 141
Barreacute ML (1983) The God-List in the Treaty between Hannibal and Philip V of Ma-cedon a Study in Light of the Ancient Near Eastern Treaty Tradition Baltimore-Lon-don
Beck H - Eckstein A (2015) sv ldquoAratos of Sicyon (231)rdquo in I Worthington (ed) Brillrsquos New Jacoby Brill Online
Borgna A (2014) Uno sguardo originale intorno a Roma Pompeo Trogo e Giustino laquoLa Biblioteca di ClassicoContemporaneoraquo 1 pp 52-77
Cassola F (1962) I gruppi politici romani nel III secolo aC Trieste
Champion CB (1997) The Nature of Authoritative Evidence in Polybios and Agelausrsquo Speech at Naupactos TAPhA 127 pp 111-128
Champion CB (2004) Cultural Politics in Polybiusrsquo Histories Berkeley
Coppola A (1993) Demetrio di Faro un protagonista dimenticato Roma
Criscuolo L (2011) I due testamenti di Tolemeo VIII Evergete II in A Joumlrdens - J F Quack (hrsg) Aumlgypten zwischen innerem Zwist und aumluszligerem Druck Die Zeit Ptole-maios VI bis VIII Wiesbaden pp 132-150
DrsquoAgostini M (2011) Filippo V e la Storia Romana di Appiano laquoAevumraquo 85 pp 99-121
Eckstein AM (1995) Moral vision in the Histories of Polybius Berkeley
Eckstein AM (2008) Rome enters in the Greek East From Anarchy to Hierarchy in the Hellenistic Mediterranean 230-217 BC Oxford
Eckstein AM (2013) Polybius Phylarchus and Historiographical Criticism CPh 108 4 pp 314-338
Errington RM (1969) Philopoemen Oxford
Errington RM (2008) A History of the Hellenistic World 323-30 BC Malden MA-Oxford
Forni G - Angeli Bertinelli MG (1982) Pompeo Trogo come fonte di storia ANRW II 30 2 pp 1298-1362
Franco C (1993) Trogo Giustino e i successori di Alessandro in L Braccesi - A Coppola - G Cresci Marrone - C Franco (a cura di) LrsquoAlessandro di Giustino dagli antichi ai moderni Roma pp 71-97
Gabba E (2003) Introduzione in D Foraboschi - SM Pizzetti (a cura di) La successione degli imperi e delle egemonie nelle relazioni internazionali Milano pp 7-9
Golan D (1995) The Res Graeciae in Polybius Four Studies Como
Green P (1990) Alexander to Actium The Historical Evolution of the Hellenistic Age Berkeley-Los Angeles
Gutschmid von A (1894) Die beiden ersten Buumlcher des Pompeius Trogus in A von Gutschmid - F Ruumlhl (hrsg) Kleine Schriften Leipzig pp 17-217
142 MONICA DrsquoAGOSTINI
Habicht C (1995) Athen Muumlnchen
Hammond NGL (1968) Illyris Rome and Macedon in 229-205 BC JRS 58 pp 1-21
Hammond NGL (1988) The Campaign and the Battle of Cynoscephalae in 197 BC JHS 108 pp 60-82
Heckel W (1997) Introduction (Part 2) in JC Yardley - W Heckel (eds) Ju-stin Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus Books 11-12 Alexander the Great Introduction Oxford pp 1-41
Heckel W (2012) Introduction in JC Yardley - P Wheatley - W Heckel (eds) Justin Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus II Books 13-15 The Successors to Alexander the Great Oxford pp 1-8
Huss W (1976) Untersuchungen zur Auszligenpolitik Ptolemaiosrsquo IV Muumlnchen
Huss W (2001) Aumlgypten in hellenistischer Zeit 332ndash30 v Chr Muumlnchen
Intrieri M (2011) Fra dialogo e conflitto Annibale e i Greci drsquoOccidente RStudFen 37 pp 53-82
Landucci F (2014) Filippo II e le Storie Filippiche un protagonista storico e storio-grafico in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 233-261
Landucci Gattinoni F (2011) Politica e ideologia in etagrave ellenistica laquoPolitica An-ticaraquo 1 pp 89-105
Leacutevy E (1994) Le discours drsquoAgeacutelaos de Naupacte in L Aigner Foresti - A Bar-zanograve - C Bearzot - L Prandi - G Zecchini (a cura di) Federazioni e federalismo nellrsquoEuropa antica Bergamo 21-25 settembre 1992 Milano (Alle radici della casa co-mune europea 1) pp 33-50
Longaretti L (1989) Lrsquoalleanza tra Annibale e Filippo V di Macedonia RIL 123 pp 183-192
Marasco G (1979-1980) La valutazione di Tolemeo IV Filopatore nella storiografia greca laquoSilenoraquo 5-6 pp 159-182
Mari M [- Musti D - Thornton J] (2002) Polibio Storie Volume III Libri V-VI Milano
Mariotta G (2014) Geografia e Geopolitica nelle Storie Filippiche in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 45-56
McGing B (2010) Polybiusrsquo Histories New York
McGing B (2013) Youthfulness in Polybius the case of Philip V of Macedon in B Gibson - T Harrison (eds) Polybius and his world Oxford pp 181-199
Meadows A (2013) Polybius Aratus and the History of the 140th Olympiad in B
IL DISCORSO DEL RE 143
Gibson - T Harrison (eds) Polybius and his World Essays in Honour of Frank Walbank Oxford pp 91-116
Mecca A (2001) Trogo Timagene e Polieno QS 54 pp 199-222
Meister K (1990) Die Griechische Geschichtsschreibung von den Anfaumlngen bis zum Ende des Hellenismus Stuttgart
Misch G (1949) Geschichte der Autobiographie I Frankfurt am Mein
Momigliano A (1980) Daniele e la teoria greca della successione degli imperi RAL 35 pp 157-162
Muccioli F (2013) Gli epiteti ufficiali dei re ellenistici Stuttgart (Historia Einzel-schriften 224)
Musti D (1978) Polibio e lrsquoimperialismo romano Napoli
Parmeggiani G (2011) Eforo di Cuma studi di storiografia greca Bologna
Peacutedech P (1964) La meacutethode historique de Polybe Paris
Pelling CBR [- Scardigli B - Manfredini M](1997) Plutarco Vite parallele Filopemene Tito Flaminino Milano
Richter H-D (1987) Untersuchungen zur hellenistischen Historiographie die Vorla-gen des Pompeius Trogus fuumlr die Darstellung der nachalexandrischen hellenistischen Ge-schichte (Iust 13-40) Frankfurt
Santi Amantini L (1972) Fonti e valore storico di Pompeo Trogo (Iustin XXXV e XXXVI) Genova
Santi Amantini L (1981) (a cura di) Giustino Storie Filippiche Epitome da Pom-peo Trogo Milano
Santi Amantini L (2003) Il tempo e i tempi nelle Storie Filippiche di Pompeo Tro-go RSA 33 pp 99-110
Schepens G (1983) Les rois ptolegravemaiumlques et lrsquohistoriographie Reacuteflexions sur la trans-formation de lrsquohistoire politique in E vanrsquot Dack - P van Dessel - W Van Gucht (eds) Egypt and the Hellenistic World Proceedings of the International Collo-quium Leuven 24-26 May 1982 Leuven (Studia Hellenistica 27) pp 351-368
Schlicher JJ (1933) Non-Assertive Elements in the Language of the Roman Histo-rians CPh 28 289-300
Schmitt T (1989) Die Bedeutung des zweiten Punischen Krieges fuumlr den Frieden in Naupaktos in H Devijver - E Lipinski (eds) Punic wars Proceedings of the Conference held in Antwerp from the 23th to the 26th of November 1988 in Cooperation with the Departement of History of the laquoUniversitait Antwerpenraquo UFSIA Leuven (Studia Phoenicia 10) pp 229-239
Scholten JB (2000) The Politics of Plunder Aitolians and their koinon in the early Hellenistic Era Berkeley
144 MONICA DrsquoAGOSTINI
Scuderi R (2005) Filippo V e Perseo nei frammenti diodorei in C Bearzot - F Lan-ducci (a cura di) Diodoro e lrsquoaltra Grecia Macedonia Occidente Ellenismo nella Bi-blioteca Storica Atti del convegno Milano 15-16 gennaio 2004 Milano pp 383-405
Sklenaacuter RJ (2004) Sources and Individuality in Two Passages of Livy laquoHistoriaraquo 53 pp 302-310
Sordi M (1982) Timagene di Alessandria Uno storico ellenocentrico e filobarbaro ANRW II 30 1 pp 775-797
Thornton J (2014) Le guerre macedoniche Roma
Urban R (1979) Wachstum und Kriese des achaumlischen Bundes Quellenstudien zur entwicklung des Bundes von 280 bis 222 V Chr Wiesbaden
Urban R (1982) laquoGallisches Bewusstseinraquo und laquoRomkritikraquo bei Pompeius Trogus ANRW II 30 2 pp 1424-1443
Vannicelli P (1987) Lrsquoeconomia delle Storie di Eforo RFIC 115 pp 165-191
Vattuone R (2014) Giustino e lrsquoOccidente greco I VI-V secolo aC in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 261-277
Vollmer D (1990) Symploke das Uumlbergreifen der roumlmischen Expansion auf den grie-chischen Osten Untersuchungen zur roumlmischen Aussenpolitik am Ende des 3 Jh V Chr Stuttgart
Walbank FW (1957) A Historical Commentary on Polibius I Oxford
Walbank FW (1967) A Historical Commentary on Polybius II Oxford
Walbank FW (1933) Aratos of Sicyon Cambridge
Walbank FW (2002) Η ΤΩΝ ΟΛΩΝ ΕΛΠΙΣ and the Antigonids in FW Walbank (ed) Polybius Rome and the Hellenistic World Essays and Reflections West Nyack NY pp 127-136
Weber G (1997) Interaktion Repraumlsentation und Herrschaft Der Koumlnigshof im Hel-lenismus in A Winterling (hrsg) Zwischen lsquoHausrsquo und lsquoStaatrsquo antike Houmlfe im Ver-gleich Munich pp 27-72
Will E (19822) Histoire politique du Monde Helleacutenistique II Nancy
Zecchini G (1990) La storiografia lagide in H Verdin - G Schepens - E De Keyser (eds) Purposes of History Studies in Greek Historiography from the 4th to the 2nd Centuries BC Proceedings of the International Colloquium of Leuven 24-26 May 1988 Leuven (Studia Hellenistica 30) pp 213-232
Zecchini G (2003) Polibio e la tradizione orale in A Casanova - P Desideri (a cura di) Evento racconto scrittura nellrsquoantichitagrave classica Firenze pp 123-141
Finito di stamparenel mese di novembre 2015
da LegoDigit srlLavis (TN)
IL DISCORSO DEL RE 135
Il punto di vista di Trogo sembra invece presente nei frammenti del-la Makedonikeacute di Appiano su Filippo V44 dove ci si riferisce a Cinoscefale come a una vittoria insperata (Mak 9 1)
ἡγούμενος δ᾽ οὔτε Ῥωμαίοις συμφέρειν οὔτε τοῖς Ἕλλησι Φιλίππου καθαιρεθέντος ἐπιπολάσαι τὴν Αἰτωλῶν βίαν τάχα δ᾽ αὐτὸν καὶ τὸ παράδοξον τῆς νίκης ἀγαπᾶν ἐποίει
Flaminino era consapevole che non sarebbe stato vantaggioso per i Romani o per i Greci che Filippo fosse deposto e che il potere etolico rimanesse incon-trastato forse lo aveva reso moderato nei suoi progetti lrsquoaver ottenuto una vit-toria insperata
Addirittura successivamente si accenna alla sorte avversa a Filippo nel-lo scontro
τὰ μὲν δὴ παρὰ τῶν ἄλλων φιλάνθρωπα ἦν τό τε τῆς τύχης ἄδηλον ἐξ ὧν ἔπαθεν ὁ Φίλιππος ὑφορωμένων καὶ τὸ πταῖσμα τοῦτο οὐ κατ᾽ ἀσθένειαν ἀλλὰ πλέον ἐκ συντυχίας αὐτὸν παθεῖν ἡγουμένων
Gli altri (Greci) erano inclini ad essere moderati vedendo con sospetto lrsquoincer-tezza della fortuna subita da Filippo e ritenendo che egli fosse incorso in questa sconfitta non tanto per la sua inferioritagrave quanto per la sfortuna
Il riferimento in Appiano e Trogo alla fortuna romanasfortuna ma-cedone a proposito di Cinoscefale egrave una traccia dellrsquoopinione politi-ca di quei Greci disprezzati da Polibio come uomini sciocchi καθάπερ οἱ μάταιοι τῶν ἀνθρώπων Tale posizione politica su Cinoscefale sarebbe dunque sopravvissuta nella tradizione storiografica di cui troviamo trac-cia in TrogoGiustino e Appiano
Per comprendere meglio alcune caratteristiche di questa tradizione puograve essere utile tornare ai due discorsi nellrsquoEpitome di Filippo e Flamini-no prima della battaglia Tali passi probabilmente trogiani45 non trova-no infatti riscontro nelle fonti parallele a noi pervenute Polibio (XVIII 18-27) seguito fedelmente da Livio (XXXIII 5-10) pur descrivendo le operazioni di guerra di Cinoscefale con dovizia di particolari non men-ziona un discorso di Filippo ai suoi armati prima della battaglia mentre il discorso di Flaminino per incoraggiare le truppe schierate (XVIII 23 2-6) nelle Storie egrave incentrato sulle vittorie di Sulpicio nella prima parte della guerra Pare dunque originale la versione trogiana che incentra-
44 Tra i frammenti consegnatici dagli Excerpta Constantiniana sono frequenti informazio-ni e osservazioni che rimandano a una prospettiva ellenistica sugli eventi DrsquoAgostini (2011) pp 99-121 45 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362
136 MONICA DrsquoAGOSTINI
ta sulla gloria macedone presenta Cinoscefale come il punto drsquoincon-tro e di scambio tra lrsquoegemonia macedone e lrsquoegemonia romana Non egrave una novitagrave che il leitmotiv delle Storie Filippiche e dunque dellrsquoEpitome sia la translatio imperii giagrave Alonso Nuntildeez definito da Santi Amantini laquouno dei piugrave noti esperti di questioni trogiano-giustineeraquo46 osservava che Tro-go esponeva nel suo perduto lavoro la teoria della successione degli im-peri mondiali secondo lo schema Assiria-Media-Persia-Macedonia-Roma osteggiata dai Parti47 In tale successione il ruolo da protagonista egrave rico-perto dallrsquoegemonia macedone48 che occupa allrsquoincirca 26 dei 44 libri e il cui ultimo vero momento di gloria egrave lo scontro con Roma appunto a Cinoscefale Lrsquoultima impresa macedone ha come esito la transizione del dominio universale da Oriente a Occidente e costituisce il tema cen-trale dellrsquointera vicenda di Filippo lrsquoimportanza della battaglia di Cino-scefale egrave perciograve esaltata nei discorsi sia di Filippo che di Flaminino che a loro volta sono il punto di arrivo delle argomentazioni esposte nelle parole di Demetrio di Faro e di Filippo stesso giagrave nel libro XXIX Le ora-tiones disposte retoricamente nei due libri descrivono due parabole op-poste da un lato quella romana che da lontana potenza desiderosa di espandersi cresce come una pioggia di sangue diventando il giovane e vigoroso potere che sottomesso Annibale egrave pronto a sconfiggere Filip-po Dallrsquoaltro quella macedone che originata con Filippo II personag-gio centrale per Trogo raggiunge il suo apice con la conquista dellrsquoege-monia ad opera di Alessandro Magno contro i Persiani per conoscere la fine con Filippo V il cui antico valore egrave ormai troppo lsquosbiaditorsquo per te-ner testa al vigore romano
La gloria macedone secondo Trogo inizia dunque con Filippo II e si conclude con Filippo V Perseo egrave infatti il malvagio responsabile dellrsquoan-nientamento di ciograve che rimaneva della monarchia macedone49 Trogo pone agli estremi della parabola macedone che occupa dal libro IX al XXX i due re di nome Filippo Filippo II e Filippo V come ribadito in piugrave luoghi dellrsquoEpitome sia in parti riassunte da Giustino che in passi piugrave genuinamente trogiani Dando per scontato che il titolo dellrsquoopera Sto-rie Filippiche si debba al desiderio di Trogo di rifarsi allrsquoopera di Teopom-po sul sovrano macedone egrave possibile che tale titolo sia stato perograve ripen-
46 Santi Amantini (2003) pp 99-11047 laquoPompeius Trogus expounded in his lost work the Historiae Philippicae a theory of the world empire suggestion according to the scheme Assyria-Media-Persia-Macedonia-Rome opposed by the Parthiansraquo Alonso-Nuacutentildeez (2002) pp 105-110 e 133-136 partic 105 Vd anche Richter (1987) pp 19-23 Momigliano (1980) pp 157-162 Alonso-Nuacutentildeez (1992) Heckel (1997) pp 1-41 Gabba (2003) pp 7-9 Santi Amantini (2003) pp 99-110 Mariotta (2014) pp 45-56 48 Franco (1993) pp 71-97 e Landucci (2014) pp 233-26149 Alonso-Nuacutentildeez (2002) pp 105-110 partic 108-109
IL DISCORSO DEL RE 137
sato da Trogo considerando che il periodo compreso tra le imprese dei due Filippo occupa 23 dellrsquoopera50 Si potrebbe allora suggerire che le Storie sono Filippiche poicheacute i due Filippo segnarono lrsquoinizio e la fine di quella che egrave nellrsquoopera di Trogo lrsquoegemonia incontrastata del mondo piugrave gloriosa di tutti i tempi51
La prospettiva ellenistica che vede nei due Filippo i limiti della grande egemonia macedone egrave di nuovo presente anche in Appiano nellrsquooraco-lo riportato nei frammenti della sua Makedonikeacute e noto anche da Pausa-nia (VII 8 9)
αὐχοῦντες βασιλεῦσι Μακηδόνες Ἀργεάδῃσιν ὑμῖν κοιρανέων ἀγαθὸν καὶ πῆμα Φίλιππος ἤτοι ὁ μὲν πρότερος πόλεσιν λαοῖσί τ᾽ ἄνακτας θήσει ὁ δ᾽ ὁπλότερος τιμὴν ἀπὸ πᾶσαν ὀλέσσει δμηθεὶς δ᾽ ἑσπερίοισιν ὑπ᾽ ἀνδράσιν ἐνθάδ᾽ ὀλεῖται
O Macedoni che andate orgogliosi dei re di stirpe argiva I re di nome Filippo saranno arbitri del bene e del male per voi Il primo vi renderagrave signori di cittagrave e popoli il secondo vi priveragrave di ogni onore sconfitto da uomini dellrsquoOcciden-te qui giace morto52
Senza voler entrare nel merito della discussione di tale oracolo di nuo-vo pare di incontrare nei due autori la medesima prospettiva lontana dalla condanna morale del re macedone espressa da Polibio secondo cui la sconfitta egrave il giusto esito della sua crudeltagrave ed empietagrave
Il libro giustineo si conclude menzionando le condizioni della pa-ce di Tempe53 e lrsquoira degli Etoli che videro ignorate le proprie richieste da Flaminino e perciograve cercarono lrsquoalleanza di Antioco contro Roma Se-condo il Prologo XXX il libro perograve proseguiva con le campagne di Antio-co III in Asia Minore contro Molone e Acheo e in Battriana fino ad ar-rivare allrsquoesordio dello scontro con Roma54 Il riassunto giustineo egrave trop-po sommario per permettere un confronto con le fonti parallele Egrave pe-
50 Sul rilievo della storia della Macedonia nellrsquoopera di Trogo e Giustino vd von Gutsch-midt (1894) pp 17-217 Richter (1987) p 28 n 29 Franco (1993) pp 71-97 51 Vd anche Urban (1982) pp 1424-1443 e Alonso-Nuacutentildeez (1992) p 58 52 Mak Fr 2 Vd DrsquoAgostini (2011) pp 99-121 In questa Walbank (2002) pp 127-136 propone di interpretare anche un poema di Alceo di Messene (Anth Pal 9518)53 Egrave probabile che Trogo fornisse piugrave particolari riguardo a questa pace per esempio si puograve ritenere che vi fosse menzione dellrsquoinvio a Roma del figlio Demetrio da parte di Filippo come ostaggio dato che a Iust XXXII 2 3 si richiama appunto tale avvenimento54 Polyb XVIII 34 1-39 7 42 1-45 12 Liv XXXIII 11 3-13 15 24 1-31 11 Plut Flam IX 1-8 App Mak Fr IX riferiscono di due diverse trattative di pace caratterizzate da un vivace dibattito tra chi voleva lrsquoannientamento della Macedonia come in Grecia gli Etoli e a Roma Marco Claudio Marcello e coloro che desideravano la pace con la Macedonia in primis Flaminino
138 MONICA DrsquoAGOSTINI
rograve da notare la mancanza sia nel Prologo che nel testo del libro degli av-venimenti delle celebrazioni Istmie del 196 quando Flaminino procla-mograve la libertagrave dei Greci Piugrave in generale in tutta la narrazione di Giustino delle complesse trattative del 197-196 manca qualsiasi riferimento alla li-bertagrave dei Greci punto nodale nella tradizione di Polibio che con questa sottolineatura esalta sia il ruolo tirannico della Macedonia sia la grande generositagrave dei Romani nei confronti della Grecia Il silenzio di TrogoGiustino su tale questione mostra il prevedibile disinteresse per gli affari dei Greci e nel contempo conferma la presenza di una tradizione che si occupa soprattutto della storia delle monarchie ellenistiche allrsquointer-no della quale la posizione dellrsquoEllade egrave subalterna
Libro XXXII23- 34 Demetrio e Perseo
Gli ultimi anni di regno di Filippo tra il 183 e il 179 sono narrati in un passo breve del libro XXXII Il racconto in Giustino che egrave coerente con il Prologo trogiano segue in maniera sintetica la tradizione polibiana su questi eventi giunta a noi in alcuni passi lacunosi di Polibio (XXIII 1 3-3 10 7 1-7 10 1-11 8) integrati dal racconto particolareggiato di Li-vio (XXXIX 46 7- 48 6 53 1-16 XL 3 3-16 3 201-24 8) e dalla narra-zione di Diodoro (XIX 25) e Plutarco (Aem VIII 11)55
Conclusioni
In questi libri dedicati a Filippo egrave forse possibile vedere in filigrana la rielaborazione voluta di Giustino dei corrispondenti libri trogiani Co-me Giustino stesso afferma nella Prefatio 3 lrsquoopera di Trogo era costruita secondo due criteri quello cronologico e quello per laquoconcatenazione di eventi56raquo ea omnia Pompeius diuisa temporibus et serie rerum digesta conposuit
55 Lrsquoutilizzo della tradizione polibiana in Trogo egrave confermato dallrsquoaderenza a Livio (XL 54 1-56 11) e Diodoro (XXIX 28) del racconto sul pentimento di Filippo per aver ucciso il figlio Demetrio lrsquointenzione di punire Perseo e la correlazione tra questo e la sua mor-te Questo libro egrave dunque differente nellrsquointeresse e nelle fonti dai libri XXIX e XXX poicheacute molto vicino alla tradizione polibiana in Livio Questi avvenimenti in Giustino sono da collegare con lrsquoascesa al trono di Perseo e non con lrsquoepilogo della celebrazione del valore macedone giagrave conclusasi in Giustino con Cinoscefale e la transizione dallrsquoim-perium macedone allrsquoimperium romano Vd Heckel (1997) p 7 Appiano invece riporta ancora una tradizione diversa da quella polibiana in un frammento della Makedonikeacute in particolare Appiano egrave attento al punto di vista macedone e presenta Filippo come una vittima delle circostanze (Mak IX) DrsquoAgostini (2011) pp 99-12156 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362 Alonso-Nuacutentildeez (2002) pp 133-136 He-ckel (1997) pp 1-41 Borgna (2014) pp 52-77
IL DISCORSO DEL RE 139
Serie rerum digesta sembrerebbe unrsquointerpretazione latina della formula κατὰ γένος che Diodoro usa per indicare la struttura della storia di Efo-ro sottolineandone la divisione per argomento57 In tale struttura per argomento dellrsquoEpitome tra i temi principali ci sono dunque il valore e la gloria dei sovrani ellenistici58 riscontrabile nei libri XXVIII-XXXI sui re-gni di Antigono Dosone Filippo V e Antioco III Tale tema presente di sicuro in Trogo egrave conservato nellrsquoazione dellrsquoEpitomatore e anzi come si vede dagli escerpta esaltato dalla selezione dei passi
Per quanto riguarda invece la Quellenforschung 59 egrave evidente che nel testo vi sia presenza di filoni non tradizionali sugli eventi poicheacute la posi-zione di Trogo appare spesso autonoma rispetto alle opinioni condivise dalla storiografia antica Questo aspetto dellrsquoEpitome evidente soprattut-to per ciograve che riguarda gli eventi ellenistici ha suscitato la grande curio-sitagrave degli studiosi che allontanatisi dalla proposta di von Gutschmid che voleva una totale ed esclusiva dipendenza di Trogo da Timagene ora in-dicano con sicurezza tra le fonti piugrave rilevanti per gli eventi ellenistici di III secolo utilizzate da Trogo almeno altri sei nomi oltre a Timagene Ie-ronimo Timeo Filarco Duride Polibio e Posidonio
Per quanto riguarda nello specifico la composizione dei libri XXIX e XXX non vi egrave alcun dubbio che in essi Trogo abbia utilizzato (anche riadattandola) una fonte poco attenta alle questioni di politica interna greca e al legame tra queste e quel ritratto di Filippo come sovrano mal-vagio ed empio che ritorna nella tradizione ufficiale di origine polibia-na passando poi da Polibio in Livio Diodoro e Plutarco60 Trogo pre-serva invece una tradizione ellenistica interessata alla figura di Filippo come ultimo barlume della gloria macedone tradizione che pare quasi una controparte e un completamento dellrsquoAb urbe condita romanocentri-ca di Livio Non si puograve perciograve a mio avviso escludere che per questa se-zione Trogo abbia usato una tradizione di matrice filoellenistica o sem-plicemente ellenisticocentrica unrsquoopera sui regni di diadochi ed epigo-ni che a tutti noi fa venire facilmente alla mente il Basileis o Perigrave Basileon dello storico grecoellenistico augusteo filobarbaro scettico (o critico) verso lrsquoegemonia romana Timagene di Alessandria (FGrHist 88)61
57 Su Eforo vd Vannicelli (1987) pp 165-191 e ora Parmeggiani (2011) 58 Simile legame vi egrave a mio avviso tra i libri XXVI e XXVII che invece affrontavano la crisi delle monarchie ellenistiche causata dalle guerre fraterne59 Vd von Gutschmid (1894) pp 17-217 Richter (1987) pp 17-30 partic 20-23 San-ti Amantini (1972) pp 56-109 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362 Urban (1982) pp 1424-1443 partic 1435 Mecca (2001) pp 199-222 Santi Amantini (2003) pp 99-110 Heckel (2012) pp 3-860 Scuderi (2005) pp 383-40561 Sordi (1982) pp 775-797 Heckel (1997) pp 30-34 Landucci (2014) pp 233-261 e Ead in questo volume
140 MONICA DrsquoAGOSTINI
ABSTRACT
Philip V of Macedon was the first of the Epigonoi to face Rome Several mod-ern reconstructions of the actions and the reign of Philip V have approached it largely from a Roman point of view using as sources Polybius and where Poly-bius is lost Livy The Polybian historiographical tradition tends to portray Phil-ip V as an enemy and a tyrant impious and cruel The Macedonian king was ea-ger to establish a universal and unjust dominion over Greece Italy and beyond and Rome engaged in the first two Macedonian Wars to fight the threat of his growing ambition Nevertheless Polybiusrsquo portrayal of Philip V was affected not only by Polybiusrsquo admiration for Roman political structures military power and overwhelming conquest but also his personal Achaean origins
Looking at in book 29 and 30 of Justinrsquos Epitome of Pompeius Trogus this pa-per focuses on the non Polybian tradition on Philip V this contribution is in-deed the first analysis of the Hellenistic approach to the clash between Rome and Macedonia in the 3rd-2nd Century BC The Epitome shows a considerable di-versity of interpretation from the other sources and reflects very different views of Philip Vrsquos actions that brought him into conflict against Rome In particular these views are more evident related to the accounts of the peace negotiations of Naupactus and the battle of Cynoscephalae in the Epitome the king appears as a courageous and skilled warrior the last of the great Macedonian rulers who fell victim to misfortune This portrayal which has several common features with Appianrsquos fragments of Philip V (Mak 9) counterbalances the Roman and Achaean standpoint present in Polybius providing a more Hellenistic perspec-tive that is likely to have been rooted in a historiographical tradition connect-ed to the losing side in the struggle between Rome and the Hellenistic world
BIBLIOGRAFIA
Adler E (2006) Whorsquos Antiroman Sallust and Pompeius Trogus on Mithridates CJ 101 pp 383-407
Adler E (2011) Valorizing the Barbarians Enemy speeches in Roman Historiography Austin
Ager SL (2003) An Uneasy Balance from the Death of Seleukos to the Battle of Raph-ia in A Erskine (ed) A Companion to the Hellenistic World Oxford pp 35-50
Ager SL (2009) Roman Perspectives on Greek Diplomacy The conceptual clash Greek diplomacy of compromise and Roman Bellum Iustum in C Eilers (ed) Diplomats and Diplomacy in the Roman World Leiden-Boston pp 15-43
Alonso-Nuacutentildeez JM (1992) La Historia Universal de Pompeyo Trogo Madrid
Alonso-Nuacutentildeez JM (2002) The Idea of Universal History in Greece From Herodotus to the Age of Augustus Amsterdam
Ballesteros Pastor L (2013) Pompeyo Trogo Justino y Mitriacutedates Comentario al Epiacutetome de las Historias Filiacutepicas (3716-3881) Hildesheim-Zuumlrich-New York
IL DISCORSO DEL RE 141
Barreacute ML (1983) The God-List in the Treaty between Hannibal and Philip V of Ma-cedon a Study in Light of the Ancient Near Eastern Treaty Tradition Baltimore-Lon-don
Beck H - Eckstein A (2015) sv ldquoAratos of Sicyon (231)rdquo in I Worthington (ed) Brillrsquos New Jacoby Brill Online
Borgna A (2014) Uno sguardo originale intorno a Roma Pompeo Trogo e Giustino laquoLa Biblioteca di ClassicoContemporaneoraquo 1 pp 52-77
Cassola F (1962) I gruppi politici romani nel III secolo aC Trieste
Champion CB (1997) The Nature of Authoritative Evidence in Polybios and Agelausrsquo Speech at Naupactos TAPhA 127 pp 111-128
Champion CB (2004) Cultural Politics in Polybiusrsquo Histories Berkeley
Coppola A (1993) Demetrio di Faro un protagonista dimenticato Roma
Criscuolo L (2011) I due testamenti di Tolemeo VIII Evergete II in A Joumlrdens - J F Quack (hrsg) Aumlgypten zwischen innerem Zwist und aumluszligerem Druck Die Zeit Ptole-maios VI bis VIII Wiesbaden pp 132-150
DrsquoAgostini M (2011) Filippo V e la Storia Romana di Appiano laquoAevumraquo 85 pp 99-121
Eckstein AM (1995) Moral vision in the Histories of Polybius Berkeley
Eckstein AM (2008) Rome enters in the Greek East From Anarchy to Hierarchy in the Hellenistic Mediterranean 230-217 BC Oxford
Eckstein AM (2013) Polybius Phylarchus and Historiographical Criticism CPh 108 4 pp 314-338
Errington RM (1969) Philopoemen Oxford
Errington RM (2008) A History of the Hellenistic World 323-30 BC Malden MA-Oxford
Forni G - Angeli Bertinelli MG (1982) Pompeo Trogo come fonte di storia ANRW II 30 2 pp 1298-1362
Franco C (1993) Trogo Giustino e i successori di Alessandro in L Braccesi - A Coppola - G Cresci Marrone - C Franco (a cura di) LrsquoAlessandro di Giustino dagli antichi ai moderni Roma pp 71-97
Gabba E (2003) Introduzione in D Foraboschi - SM Pizzetti (a cura di) La successione degli imperi e delle egemonie nelle relazioni internazionali Milano pp 7-9
Golan D (1995) The Res Graeciae in Polybius Four Studies Como
Green P (1990) Alexander to Actium The Historical Evolution of the Hellenistic Age Berkeley-Los Angeles
Gutschmid von A (1894) Die beiden ersten Buumlcher des Pompeius Trogus in A von Gutschmid - F Ruumlhl (hrsg) Kleine Schriften Leipzig pp 17-217
142 MONICA DrsquoAGOSTINI
Habicht C (1995) Athen Muumlnchen
Hammond NGL (1968) Illyris Rome and Macedon in 229-205 BC JRS 58 pp 1-21
Hammond NGL (1988) The Campaign and the Battle of Cynoscephalae in 197 BC JHS 108 pp 60-82
Heckel W (1997) Introduction (Part 2) in JC Yardley - W Heckel (eds) Ju-stin Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus Books 11-12 Alexander the Great Introduction Oxford pp 1-41
Heckel W (2012) Introduction in JC Yardley - P Wheatley - W Heckel (eds) Justin Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus II Books 13-15 The Successors to Alexander the Great Oxford pp 1-8
Huss W (1976) Untersuchungen zur Auszligenpolitik Ptolemaiosrsquo IV Muumlnchen
Huss W (2001) Aumlgypten in hellenistischer Zeit 332ndash30 v Chr Muumlnchen
Intrieri M (2011) Fra dialogo e conflitto Annibale e i Greci drsquoOccidente RStudFen 37 pp 53-82
Landucci F (2014) Filippo II e le Storie Filippiche un protagonista storico e storio-grafico in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 233-261
Landucci Gattinoni F (2011) Politica e ideologia in etagrave ellenistica laquoPolitica An-ticaraquo 1 pp 89-105
Leacutevy E (1994) Le discours drsquoAgeacutelaos de Naupacte in L Aigner Foresti - A Bar-zanograve - C Bearzot - L Prandi - G Zecchini (a cura di) Federazioni e federalismo nellrsquoEuropa antica Bergamo 21-25 settembre 1992 Milano (Alle radici della casa co-mune europea 1) pp 33-50
Longaretti L (1989) Lrsquoalleanza tra Annibale e Filippo V di Macedonia RIL 123 pp 183-192
Marasco G (1979-1980) La valutazione di Tolemeo IV Filopatore nella storiografia greca laquoSilenoraquo 5-6 pp 159-182
Mari M [- Musti D - Thornton J] (2002) Polibio Storie Volume III Libri V-VI Milano
Mariotta G (2014) Geografia e Geopolitica nelle Storie Filippiche in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 45-56
McGing B (2010) Polybiusrsquo Histories New York
McGing B (2013) Youthfulness in Polybius the case of Philip V of Macedon in B Gibson - T Harrison (eds) Polybius and his world Oxford pp 181-199
Meadows A (2013) Polybius Aratus and the History of the 140th Olympiad in B
IL DISCORSO DEL RE 143
Gibson - T Harrison (eds) Polybius and his World Essays in Honour of Frank Walbank Oxford pp 91-116
Mecca A (2001) Trogo Timagene e Polieno QS 54 pp 199-222
Meister K (1990) Die Griechische Geschichtsschreibung von den Anfaumlngen bis zum Ende des Hellenismus Stuttgart
Misch G (1949) Geschichte der Autobiographie I Frankfurt am Mein
Momigliano A (1980) Daniele e la teoria greca della successione degli imperi RAL 35 pp 157-162
Muccioli F (2013) Gli epiteti ufficiali dei re ellenistici Stuttgart (Historia Einzel-schriften 224)
Musti D (1978) Polibio e lrsquoimperialismo romano Napoli
Parmeggiani G (2011) Eforo di Cuma studi di storiografia greca Bologna
Peacutedech P (1964) La meacutethode historique de Polybe Paris
Pelling CBR [- Scardigli B - Manfredini M](1997) Plutarco Vite parallele Filopemene Tito Flaminino Milano
Richter H-D (1987) Untersuchungen zur hellenistischen Historiographie die Vorla-gen des Pompeius Trogus fuumlr die Darstellung der nachalexandrischen hellenistischen Ge-schichte (Iust 13-40) Frankfurt
Santi Amantini L (1972) Fonti e valore storico di Pompeo Trogo (Iustin XXXV e XXXVI) Genova
Santi Amantini L (1981) (a cura di) Giustino Storie Filippiche Epitome da Pom-peo Trogo Milano
Santi Amantini L (2003) Il tempo e i tempi nelle Storie Filippiche di Pompeo Tro-go RSA 33 pp 99-110
Schepens G (1983) Les rois ptolegravemaiumlques et lrsquohistoriographie Reacuteflexions sur la trans-formation de lrsquohistoire politique in E vanrsquot Dack - P van Dessel - W Van Gucht (eds) Egypt and the Hellenistic World Proceedings of the International Collo-quium Leuven 24-26 May 1982 Leuven (Studia Hellenistica 27) pp 351-368
Schlicher JJ (1933) Non-Assertive Elements in the Language of the Roman Histo-rians CPh 28 289-300
Schmitt T (1989) Die Bedeutung des zweiten Punischen Krieges fuumlr den Frieden in Naupaktos in H Devijver - E Lipinski (eds) Punic wars Proceedings of the Conference held in Antwerp from the 23th to the 26th of November 1988 in Cooperation with the Departement of History of the laquoUniversitait Antwerpenraquo UFSIA Leuven (Studia Phoenicia 10) pp 229-239
Scholten JB (2000) The Politics of Plunder Aitolians and their koinon in the early Hellenistic Era Berkeley
144 MONICA DrsquoAGOSTINI
Scuderi R (2005) Filippo V e Perseo nei frammenti diodorei in C Bearzot - F Lan-ducci (a cura di) Diodoro e lrsquoaltra Grecia Macedonia Occidente Ellenismo nella Bi-blioteca Storica Atti del convegno Milano 15-16 gennaio 2004 Milano pp 383-405
Sklenaacuter RJ (2004) Sources and Individuality in Two Passages of Livy laquoHistoriaraquo 53 pp 302-310
Sordi M (1982) Timagene di Alessandria Uno storico ellenocentrico e filobarbaro ANRW II 30 1 pp 775-797
Thornton J (2014) Le guerre macedoniche Roma
Urban R (1979) Wachstum und Kriese des achaumlischen Bundes Quellenstudien zur entwicklung des Bundes von 280 bis 222 V Chr Wiesbaden
Urban R (1982) laquoGallisches Bewusstseinraquo und laquoRomkritikraquo bei Pompeius Trogus ANRW II 30 2 pp 1424-1443
Vannicelli P (1987) Lrsquoeconomia delle Storie di Eforo RFIC 115 pp 165-191
Vattuone R (2014) Giustino e lrsquoOccidente greco I VI-V secolo aC in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 261-277
Vollmer D (1990) Symploke das Uumlbergreifen der roumlmischen Expansion auf den grie-chischen Osten Untersuchungen zur roumlmischen Aussenpolitik am Ende des 3 Jh V Chr Stuttgart
Walbank FW (1957) A Historical Commentary on Polibius I Oxford
Walbank FW (1967) A Historical Commentary on Polybius II Oxford
Walbank FW (1933) Aratos of Sicyon Cambridge
Walbank FW (2002) Η ΤΩΝ ΟΛΩΝ ΕΛΠΙΣ and the Antigonids in FW Walbank (ed) Polybius Rome and the Hellenistic World Essays and Reflections West Nyack NY pp 127-136
Weber G (1997) Interaktion Repraumlsentation und Herrschaft Der Koumlnigshof im Hel-lenismus in A Winterling (hrsg) Zwischen lsquoHausrsquo und lsquoStaatrsquo antike Houmlfe im Ver-gleich Munich pp 27-72
Will E (19822) Histoire politique du Monde Helleacutenistique II Nancy
Zecchini G (1990) La storiografia lagide in H Verdin - G Schepens - E De Keyser (eds) Purposes of History Studies in Greek Historiography from the 4th to the 2nd Centuries BC Proceedings of the International Colloquium of Leuven 24-26 May 1988 Leuven (Studia Hellenistica 30) pp 213-232
Zecchini G (2003) Polibio e la tradizione orale in A Casanova - P Desideri (a cura di) Evento racconto scrittura nellrsquoantichitagrave classica Firenze pp 123-141
Finito di stamparenel mese di novembre 2015
da LegoDigit srlLavis (TN)
136 MONICA DrsquoAGOSTINI
ta sulla gloria macedone presenta Cinoscefale come il punto drsquoincon-tro e di scambio tra lrsquoegemonia macedone e lrsquoegemonia romana Non egrave una novitagrave che il leitmotiv delle Storie Filippiche e dunque dellrsquoEpitome sia la translatio imperii giagrave Alonso Nuntildeez definito da Santi Amantini laquouno dei piugrave noti esperti di questioni trogiano-giustineeraquo46 osservava che Tro-go esponeva nel suo perduto lavoro la teoria della successione degli im-peri mondiali secondo lo schema Assiria-Media-Persia-Macedonia-Roma osteggiata dai Parti47 In tale successione il ruolo da protagonista egrave rico-perto dallrsquoegemonia macedone48 che occupa allrsquoincirca 26 dei 44 libri e il cui ultimo vero momento di gloria egrave lo scontro con Roma appunto a Cinoscefale Lrsquoultima impresa macedone ha come esito la transizione del dominio universale da Oriente a Occidente e costituisce il tema cen-trale dellrsquointera vicenda di Filippo lrsquoimportanza della battaglia di Cino-scefale egrave perciograve esaltata nei discorsi sia di Filippo che di Flaminino che a loro volta sono il punto di arrivo delle argomentazioni esposte nelle parole di Demetrio di Faro e di Filippo stesso giagrave nel libro XXIX Le ora-tiones disposte retoricamente nei due libri descrivono due parabole op-poste da un lato quella romana che da lontana potenza desiderosa di espandersi cresce come una pioggia di sangue diventando il giovane e vigoroso potere che sottomesso Annibale egrave pronto a sconfiggere Filip-po Dallrsquoaltro quella macedone che originata con Filippo II personag-gio centrale per Trogo raggiunge il suo apice con la conquista dellrsquoege-monia ad opera di Alessandro Magno contro i Persiani per conoscere la fine con Filippo V il cui antico valore egrave ormai troppo lsquosbiaditorsquo per te-ner testa al vigore romano
La gloria macedone secondo Trogo inizia dunque con Filippo II e si conclude con Filippo V Perseo egrave infatti il malvagio responsabile dellrsquoan-nientamento di ciograve che rimaneva della monarchia macedone49 Trogo pone agli estremi della parabola macedone che occupa dal libro IX al XXX i due re di nome Filippo Filippo II e Filippo V come ribadito in piugrave luoghi dellrsquoEpitome sia in parti riassunte da Giustino che in passi piugrave genuinamente trogiani Dando per scontato che il titolo dellrsquoopera Sto-rie Filippiche si debba al desiderio di Trogo di rifarsi allrsquoopera di Teopom-po sul sovrano macedone egrave possibile che tale titolo sia stato perograve ripen-
46 Santi Amantini (2003) pp 99-11047 laquoPompeius Trogus expounded in his lost work the Historiae Philippicae a theory of the world empire suggestion according to the scheme Assyria-Media-Persia-Macedonia-Rome opposed by the Parthiansraquo Alonso-Nuacutentildeez (2002) pp 105-110 e 133-136 partic 105 Vd anche Richter (1987) pp 19-23 Momigliano (1980) pp 157-162 Alonso-Nuacutentildeez (1992) Heckel (1997) pp 1-41 Gabba (2003) pp 7-9 Santi Amantini (2003) pp 99-110 Mariotta (2014) pp 45-56 48 Franco (1993) pp 71-97 e Landucci (2014) pp 233-26149 Alonso-Nuacutentildeez (2002) pp 105-110 partic 108-109
IL DISCORSO DEL RE 137
sato da Trogo considerando che il periodo compreso tra le imprese dei due Filippo occupa 23 dellrsquoopera50 Si potrebbe allora suggerire che le Storie sono Filippiche poicheacute i due Filippo segnarono lrsquoinizio e la fine di quella che egrave nellrsquoopera di Trogo lrsquoegemonia incontrastata del mondo piugrave gloriosa di tutti i tempi51
La prospettiva ellenistica che vede nei due Filippo i limiti della grande egemonia macedone egrave di nuovo presente anche in Appiano nellrsquooraco-lo riportato nei frammenti della sua Makedonikeacute e noto anche da Pausa-nia (VII 8 9)
αὐχοῦντες βασιλεῦσι Μακηδόνες Ἀργεάδῃσιν ὑμῖν κοιρανέων ἀγαθὸν καὶ πῆμα Φίλιππος ἤτοι ὁ μὲν πρότερος πόλεσιν λαοῖσί τ᾽ ἄνακτας θήσει ὁ δ᾽ ὁπλότερος τιμὴν ἀπὸ πᾶσαν ὀλέσσει δμηθεὶς δ᾽ ἑσπερίοισιν ὑπ᾽ ἀνδράσιν ἐνθάδ᾽ ὀλεῖται
O Macedoni che andate orgogliosi dei re di stirpe argiva I re di nome Filippo saranno arbitri del bene e del male per voi Il primo vi renderagrave signori di cittagrave e popoli il secondo vi priveragrave di ogni onore sconfitto da uomini dellrsquoOcciden-te qui giace morto52
Senza voler entrare nel merito della discussione di tale oracolo di nuo-vo pare di incontrare nei due autori la medesima prospettiva lontana dalla condanna morale del re macedone espressa da Polibio secondo cui la sconfitta egrave il giusto esito della sua crudeltagrave ed empietagrave
Il libro giustineo si conclude menzionando le condizioni della pa-ce di Tempe53 e lrsquoira degli Etoli che videro ignorate le proprie richieste da Flaminino e perciograve cercarono lrsquoalleanza di Antioco contro Roma Se-condo il Prologo XXX il libro perograve proseguiva con le campagne di Antio-co III in Asia Minore contro Molone e Acheo e in Battriana fino ad ar-rivare allrsquoesordio dello scontro con Roma54 Il riassunto giustineo egrave trop-po sommario per permettere un confronto con le fonti parallele Egrave pe-
50 Sul rilievo della storia della Macedonia nellrsquoopera di Trogo e Giustino vd von Gutsch-midt (1894) pp 17-217 Richter (1987) p 28 n 29 Franco (1993) pp 71-97 51 Vd anche Urban (1982) pp 1424-1443 e Alonso-Nuacutentildeez (1992) p 58 52 Mak Fr 2 Vd DrsquoAgostini (2011) pp 99-121 In questa Walbank (2002) pp 127-136 propone di interpretare anche un poema di Alceo di Messene (Anth Pal 9518)53 Egrave probabile che Trogo fornisse piugrave particolari riguardo a questa pace per esempio si puograve ritenere che vi fosse menzione dellrsquoinvio a Roma del figlio Demetrio da parte di Filippo come ostaggio dato che a Iust XXXII 2 3 si richiama appunto tale avvenimento54 Polyb XVIII 34 1-39 7 42 1-45 12 Liv XXXIII 11 3-13 15 24 1-31 11 Plut Flam IX 1-8 App Mak Fr IX riferiscono di due diverse trattative di pace caratterizzate da un vivace dibattito tra chi voleva lrsquoannientamento della Macedonia come in Grecia gli Etoli e a Roma Marco Claudio Marcello e coloro che desideravano la pace con la Macedonia in primis Flaminino
138 MONICA DrsquoAGOSTINI
rograve da notare la mancanza sia nel Prologo che nel testo del libro degli av-venimenti delle celebrazioni Istmie del 196 quando Flaminino procla-mograve la libertagrave dei Greci Piugrave in generale in tutta la narrazione di Giustino delle complesse trattative del 197-196 manca qualsiasi riferimento alla li-bertagrave dei Greci punto nodale nella tradizione di Polibio che con questa sottolineatura esalta sia il ruolo tirannico della Macedonia sia la grande generositagrave dei Romani nei confronti della Grecia Il silenzio di TrogoGiustino su tale questione mostra il prevedibile disinteresse per gli affari dei Greci e nel contempo conferma la presenza di una tradizione che si occupa soprattutto della storia delle monarchie ellenistiche allrsquointer-no della quale la posizione dellrsquoEllade egrave subalterna
Libro XXXII23- 34 Demetrio e Perseo
Gli ultimi anni di regno di Filippo tra il 183 e il 179 sono narrati in un passo breve del libro XXXII Il racconto in Giustino che egrave coerente con il Prologo trogiano segue in maniera sintetica la tradizione polibiana su questi eventi giunta a noi in alcuni passi lacunosi di Polibio (XXIII 1 3-3 10 7 1-7 10 1-11 8) integrati dal racconto particolareggiato di Li-vio (XXXIX 46 7- 48 6 53 1-16 XL 3 3-16 3 201-24 8) e dalla narra-zione di Diodoro (XIX 25) e Plutarco (Aem VIII 11)55
Conclusioni
In questi libri dedicati a Filippo egrave forse possibile vedere in filigrana la rielaborazione voluta di Giustino dei corrispondenti libri trogiani Co-me Giustino stesso afferma nella Prefatio 3 lrsquoopera di Trogo era costruita secondo due criteri quello cronologico e quello per laquoconcatenazione di eventi56raquo ea omnia Pompeius diuisa temporibus et serie rerum digesta conposuit
55 Lrsquoutilizzo della tradizione polibiana in Trogo egrave confermato dallrsquoaderenza a Livio (XL 54 1-56 11) e Diodoro (XXIX 28) del racconto sul pentimento di Filippo per aver ucciso il figlio Demetrio lrsquointenzione di punire Perseo e la correlazione tra questo e la sua mor-te Questo libro egrave dunque differente nellrsquointeresse e nelle fonti dai libri XXIX e XXX poicheacute molto vicino alla tradizione polibiana in Livio Questi avvenimenti in Giustino sono da collegare con lrsquoascesa al trono di Perseo e non con lrsquoepilogo della celebrazione del valore macedone giagrave conclusasi in Giustino con Cinoscefale e la transizione dallrsquoim-perium macedone allrsquoimperium romano Vd Heckel (1997) p 7 Appiano invece riporta ancora una tradizione diversa da quella polibiana in un frammento della Makedonikeacute in particolare Appiano egrave attento al punto di vista macedone e presenta Filippo come una vittima delle circostanze (Mak IX) DrsquoAgostini (2011) pp 99-12156 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362 Alonso-Nuacutentildeez (2002) pp 133-136 He-ckel (1997) pp 1-41 Borgna (2014) pp 52-77
IL DISCORSO DEL RE 139
Serie rerum digesta sembrerebbe unrsquointerpretazione latina della formula κατὰ γένος che Diodoro usa per indicare la struttura della storia di Efo-ro sottolineandone la divisione per argomento57 In tale struttura per argomento dellrsquoEpitome tra i temi principali ci sono dunque il valore e la gloria dei sovrani ellenistici58 riscontrabile nei libri XXVIII-XXXI sui re-gni di Antigono Dosone Filippo V e Antioco III Tale tema presente di sicuro in Trogo egrave conservato nellrsquoazione dellrsquoEpitomatore e anzi come si vede dagli escerpta esaltato dalla selezione dei passi
Per quanto riguarda invece la Quellenforschung 59 egrave evidente che nel testo vi sia presenza di filoni non tradizionali sugli eventi poicheacute la posi-zione di Trogo appare spesso autonoma rispetto alle opinioni condivise dalla storiografia antica Questo aspetto dellrsquoEpitome evidente soprattut-to per ciograve che riguarda gli eventi ellenistici ha suscitato la grande curio-sitagrave degli studiosi che allontanatisi dalla proposta di von Gutschmid che voleva una totale ed esclusiva dipendenza di Trogo da Timagene ora in-dicano con sicurezza tra le fonti piugrave rilevanti per gli eventi ellenistici di III secolo utilizzate da Trogo almeno altri sei nomi oltre a Timagene Ie-ronimo Timeo Filarco Duride Polibio e Posidonio
Per quanto riguarda nello specifico la composizione dei libri XXIX e XXX non vi egrave alcun dubbio che in essi Trogo abbia utilizzato (anche riadattandola) una fonte poco attenta alle questioni di politica interna greca e al legame tra queste e quel ritratto di Filippo come sovrano mal-vagio ed empio che ritorna nella tradizione ufficiale di origine polibia-na passando poi da Polibio in Livio Diodoro e Plutarco60 Trogo pre-serva invece una tradizione ellenistica interessata alla figura di Filippo come ultimo barlume della gloria macedone tradizione che pare quasi una controparte e un completamento dellrsquoAb urbe condita romanocentri-ca di Livio Non si puograve perciograve a mio avviso escludere che per questa se-zione Trogo abbia usato una tradizione di matrice filoellenistica o sem-plicemente ellenisticocentrica unrsquoopera sui regni di diadochi ed epigo-ni che a tutti noi fa venire facilmente alla mente il Basileis o Perigrave Basileon dello storico grecoellenistico augusteo filobarbaro scettico (o critico) verso lrsquoegemonia romana Timagene di Alessandria (FGrHist 88)61
57 Su Eforo vd Vannicelli (1987) pp 165-191 e ora Parmeggiani (2011) 58 Simile legame vi egrave a mio avviso tra i libri XXVI e XXVII che invece affrontavano la crisi delle monarchie ellenistiche causata dalle guerre fraterne59 Vd von Gutschmid (1894) pp 17-217 Richter (1987) pp 17-30 partic 20-23 San-ti Amantini (1972) pp 56-109 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362 Urban (1982) pp 1424-1443 partic 1435 Mecca (2001) pp 199-222 Santi Amantini (2003) pp 99-110 Heckel (2012) pp 3-860 Scuderi (2005) pp 383-40561 Sordi (1982) pp 775-797 Heckel (1997) pp 30-34 Landucci (2014) pp 233-261 e Ead in questo volume
140 MONICA DrsquoAGOSTINI
ABSTRACT
Philip V of Macedon was the first of the Epigonoi to face Rome Several mod-ern reconstructions of the actions and the reign of Philip V have approached it largely from a Roman point of view using as sources Polybius and where Poly-bius is lost Livy The Polybian historiographical tradition tends to portray Phil-ip V as an enemy and a tyrant impious and cruel The Macedonian king was ea-ger to establish a universal and unjust dominion over Greece Italy and beyond and Rome engaged in the first two Macedonian Wars to fight the threat of his growing ambition Nevertheless Polybiusrsquo portrayal of Philip V was affected not only by Polybiusrsquo admiration for Roman political structures military power and overwhelming conquest but also his personal Achaean origins
Looking at in book 29 and 30 of Justinrsquos Epitome of Pompeius Trogus this pa-per focuses on the non Polybian tradition on Philip V this contribution is in-deed the first analysis of the Hellenistic approach to the clash between Rome and Macedonia in the 3rd-2nd Century BC The Epitome shows a considerable di-versity of interpretation from the other sources and reflects very different views of Philip Vrsquos actions that brought him into conflict against Rome In particular these views are more evident related to the accounts of the peace negotiations of Naupactus and the battle of Cynoscephalae in the Epitome the king appears as a courageous and skilled warrior the last of the great Macedonian rulers who fell victim to misfortune This portrayal which has several common features with Appianrsquos fragments of Philip V (Mak 9) counterbalances the Roman and Achaean standpoint present in Polybius providing a more Hellenistic perspec-tive that is likely to have been rooted in a historiographical tradition connect-ed to the losing side in the struggle between Rome and the Hellenistic world
BIBLIOGRAFIA
Adler E (2006) Whorsquos Antiroman Sallust and Pompeius Trogus on Mithridates CJ 101 pp 383-407
Adler E (2011) Valorizing the Barbarians Enemy speeches in Roman Historiography Austin
Ager SL (2003) An Uneasy Balance from the Death of Seleukos to the Battle of Raph-ia in A Erskine (ed) A Companion to the Hellenistic World Oxford pp 35-50
Ager SL (2009) Roman Perspectives on Greek Diplomacy The conceptual clash Greek diplomacy of compromise and Roman Bellum Iustum in C Eilers (ed) Diplomats and Diplomacy in the Roman World Leiden-Boston pp 15-43
Alonso-Nuacutentildeez JM (1992) La Historia Universal de Pompeyo Trogo Madrid
Alonso-Nuacutentildeez JM (2002) The Idea of Universal History in Greece From Herodotus to the Age of Augustus Amsterdam
Ballesteros Pastor L (2013) Pompeyo Trogo Justino y Mitriacutedates Comentario al Epiacutetome de las Historias Filiacutepicas (3716-3881) Hildesheim-Zuumlrich-New York
IL DISCORSO DEL RE 141
Barreacute ML (1983) The God-List in the Treaty between Hannibal and Philip V of Ma-cedon a Study in Light of the Ancient Near Eastern Treaty Tradition Baltimore-Lon-don
Beck H - Eckstein A (2015) sv ldquoAratos of Sicyon (231)rdquo in I Worthington (ed) Brillrsquos New Jacoby Brill Online
Borgna A (2014) Uno sguardo originale intorno a Roma Pompeo Trogo e Giustino laquoLa Biblioteca di ClassicoContemporaneoraquo 1 pp 52-77
Cassola F (1962) I gruppi politici romani nel III secolo aC Trieste
Champion CB (1997) The Nature of Authoritative Evidence in Polybios and Agelausrsquo Speech at Naupactos TAPhA 127 pp 111-128
Champion CB (2004) Cultural Politics in Polybiusrsquo Histories Berkeley
Coppola A (1993) Demetrio di Faro un protagonista dimenticato Roma
Criscuolo L (2011) I due testamenti di Tolemeo VIII Evergete II in A Joumlrdens - J F Quack (hrsg) Aumlgypten zwischen innerem Zwist und aumluszligerem Druck Die Zeit Ptole-maios VI bis VIII Wiesbaden pp 132-150
DrsquoAgostini M (2011) Filippo V e la Storia Romana di Appiano laquoAevumraquo 85 pp 99-121
Eckstein AM (1995) Moral vision in the Histories of Polybius Berkeley
Eckstein AM (2008) Rome enters in the Greek East From Anarchy to Hierarchy in the Hellenistic Mediterranean 230-217 BC Oxford
Eckstein AM (2013) Polybius Phylarchus and Historiographical Criticism CPh 108 4 pp 314-338
Errington RM (1969) Philopoemen Oxford
Errington RM (2008) A History of the Hellenistic World 323-30 BC Malden MA-Oxford
Forni G - Angeli Bertinelli MG (1982) Pompeo Trogo come fonte di storia ANRW II 30 2 pp 1298-1362
Franco C (1993) Trogo Giustino e i successori di Alessandro in L Braccesi - A Coppola - G Cresci Marrone - C Franco (a cura di) LrsquoAlessandro di Giustino dagli antichi ai moderni Roma pp 71-97
Gabba E (2003) Introduzione in D Foraboschi - SM Pizzetti (a cura di) La successione degli imperi e delle egemonie nelle relazioni internazionali Milano pp 7-9
Golan D (1995) The Res Graeciae in Polybius Four Studies Como
Green P (1990) Alexander to Actium The Historical Evolution of the Hellenistic Age Berkeley-Los Angeles
Gutschmid von A (1894) Die beiden ersten Buumlcher des Pompeius Trogus in A von Gutschmid - F Ruumlhl (hrsg) Kleine Schriften Leipzig pp 17-217
142 MONICA DrsquoAGOSTINI
Habicht C (1995) Athen Muumlnchen
Hammond NGL (1968) Illyris Rome and Macedon in 229-205 BC JRS 58 pp 1-21
Hammond NGL (1988) The Campaign and the Battle of Cynoscephalae in 197 BC JHS 108 pp 60-82
Heckel W (1997) Introduction (Part 2) in JC Yardley - W Heckel (eds) Ju-stin Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus Books 11-12 Alexander the Great Introduction Oxford pp 1-41
Heckel W (2012) Introduction in JC Yardley - P Wheatley - W Heckel (eds) Justin Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus II Books 13-15 The Successors to Alexander the Great Oxford pp 1-8
Huss W (1976) Untersuchungen zur Auszligenpolitik Ptolemaiosrsquo IV Muumlnchen
Huss W (2001) Aumlgypten in hellenistischer Zeit 332ndash30 v Chr Muumlnchen
Intrieri M (2011) Fra dialogo e conflitto Annibale e i Greci drsquoOccidente RStudFen 37 pp 53-82
Landucci F (2014) Filippo II e le Storie Filippiche un protagonista storico e storio-grafico in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 233-261
Landucci Gattinoni F (2011) Politica e ideologia in etagrave ellenistica laquoPolitica An-ticaraquo 1 pp 89-105
Leacutevy E (1994) Le discours drsquoAgeacutelaos de Naupacte in L Aigner Foresti - A Bar-zanograve - C Bearzot - L Prandi - G Zecchini (a cura di) Federazioni e federalismo nellrsquoEuropa antica Bergamo 21-25 settembre 1992 Milano (Alle radici della casa co-mune europea 1) pp 33-50
Longaretti L (1989) Lrsquoalleanza tra Annibale e Filippo V di Macedonia RIL 123 pp 183-192
Marasco G (1979-1980) La valutazione di Tolemeo IV Filopatore nella storiografia greca laquoSilenoraquo 5-6 pp 159-182
Mari M [- Musti D - Thornton J] (2002) Polibio Storie Volume III Libri V-VI Milano
Mariotta G (2014) Geografia e Geopolitica nelle Storie Filippiche in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 45-56
McGing B (2010) Polybiusrsquo Histories New York
McGing B (2013) Youthfulness in Polybius the case of Philip V of Macedon in B Gibson - T Harrison (eds) Polybius and his world Oxford pp 181-199
Meadows A (2013) Polybius Aratus and the History of the 140th Olympiad in B
IL DISCORSO DEL RE 143
Gibson - T Harrison (eds) Polybius and his World Essays in Honour of Frank Walbank Oxford pp 91-116
Mecca A (2001) Trogo Timagene e Polieno QS 54 pp 199-222
Meister K (1990) Die Griechische Geschichtsschreibung von den Anfaumlngen bis zum Ende des Hellenismus Stuttgart
Misch G (1949) Geschichte der Autobiographie I Frankfurt am Mein
Momigliano A (1980) Daniele e la teoria greca della successione degli imperi RAL 35 pp 157-162
Muccioli F (2013) Gli epiteti ufficiali dei re ellenistici Stuttgart (Historia Einzel-schriften 224)
Musti D (1978) Polibio e lrsquoimperialismo romano Napoli
Parmeggiani G (2011) Eforo di Cuma studi di storiografia greca Bologna
Peacutedech P (1964) La meacutethode historique de Polybe Paris
Pelling CBR [- Scardigli B - Manfredini M](1997) Plutarco Vite parallele Filopemene Tito Flaminino Milano
Richter H-D (1987) Untersuchungen zur hellenistischen Historiographie die Vorla-gen des Pompeius Trogus fuumlr die Darstellung der nachalexandrischen hellenistischen Ge-schichte (Iust 13-40) Frankfurt
Santi Amantini L (1972) Fonti e valore storico di Pompeo Trogo (Iustin XXXV e XXXVI) Genova
Santi Amantini L (1981) (a cura di) Giustino Storie Filippiche Epitome da Pom-peo Trogo Milano
Santi Amantini L (2003) Il tempo e i tempi nelle Storie Filippiche di Pompeo Tro-go RSA 33 pp 99-110
Schepens G (1983) Les rois ptolegravemaiumlques et lrsquohistoriographie Reacuteflexions sur la trans-formation de lrsquohistoire politique in E vanrsquot Dack - P van Dessel - W Van Gucht (eds) Egypt and the Hellenistic World Proceedings of the International Collo-quium Leuven 24-26 May 1982 Leuven (Studia Hellenistica 27) pp 351-368
Schlicher JJ (1933) Non-Assertive Elements in the Language of the Roman Histo-rians CPh 28 289-300
Schmitt T (1989) Die Bedeutung des zweiten Punischen Krieges fuumlr den Frieden in Naupaktos in H Devijver - E Lipinski (eds) Punic wars Proceedings of the Conference held in Antwerp from the 23th to the 26th of November 1988 in Cooperation with the Departement of History of the laquoUniversitait Antwerpenraquo UFSIA Leuven (Studia Phoenicia 10) pp 229-239
Scholten JB (2000) The Politics of Plunder Aitolians and their koinon in the early Hellenistic Era Berkeley
144 MONICA DrsquoAGOSTINI
Scuderi R (2005) Filippo V e Perseo nei frammenti diodorei in C Bearzot - F Lan-ducci (a cura di) Diodoro e lrsquoaltra Grecia Macedonia Occidente Ellenismo nella Bi-blioteca Storica Atti del convegno Milano 15-16 gennaio 2004 Milano pp 383-405
Sklenaacuter RJ (2004) Sources and Individuality in Two Passages of Livy laquoHistoriaraquo 53 pp 302-310
Sordi M (1982) Timagene di Alessandria Uno storico ellenocentrico e filobarbaro ANRW II 30 1 pp 775-797
Thornton J (2014) Le guerre macedoniche Roma
Urban R (1979) Wachstum und Kriese des achaumlischen Bundes Quellenstudien zur entwicklung des Bundes von 280 bis 222 V Chr Wiesbaden
Urban R (1982) laquoGallisches Bewusstseinraquo und laquoRomkritikraquo bei Pompeius Trogus ANRW II 30 2 pp 1424-1443
Vannicelli P (1987) Lrsquoeconomia delle Storie di Eforo RFIC 115 pp 165-191
Vattuone R (2014) Giustino e lrsquoOccidente greco I VI-V secolo aC in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 261-277
Vollmer D (1990) Symploke das Uumlbergreifen der roumlmischen Expansion auf den grie-chischen Osten Untersuchungen zur roumlmischen Aussenpolitik am Ende des 3 Jh V Chr Stuttgart
Walbank FW (1957) A Historical Commentary on Polibius I Oxford
Walbank FW (1967) A Historical Commentary on Polybius II Oxford
Walbank FW (1933) Aratos of Sicyon Cambridge
Walbank FW (2002) Η ΤΩΝ ΟΛΩΝ ΕΛΠΙΣ and the Antigonids in FW Walbank (ed) Polybius Rome and the Hellenistic World Essays and Reflections West Nyack NY pp 127-136
Weber G (1997) Interaktion Repraumlsentation und Herrschaft Der Koumlnigshof im Hel-lenismus in A Winterling (hrsg) Zwischen lsquoHausrsquo und lsquoStaatrsquo antike Houmlfe im Ver-gleich Munich pp 27-72
Will E (19822) Histoire politique du Monde Helleacutenistique II Nancy
Zecchini G (1990) La storiografia lagide in H Verdin - G Schepens - E De Keyser (eds) Purposes of History Studies in Greek Historiography from the 4th to the 2nd Centuries BC Proceedings of the International Colloquium of Leuven 24-26 May 1988 Leuven (Studia Hellenistica 30) pp 213-232
Zecchini G (2003) Polibio e la tradizione orale in A Casanova - P Desideri (a cura di) Evento racconto scrittura nellrsquoantichitagrave classica Firenze pp 123-141
Finito di stamparenel mese di novembre 2015
da LegoDigit srlLavis (TN)
IL DISCORSO DEL RE 137
sato da Trogo considerando che il periodo compreso tra le imprese dei due Filippo occupa 23 dellrsquoopera50 Si potrebbe allora suggerire che le Storie sono Filippiche poicheacute i due Filippo segnarono lrsquoinizio e la fine di quella che egrave nellrsquoopera di Trogo lrsquoegemonia incontrastata del mondo piugrave gloriosa di tutti i tempi51
La prospettiva ellenistica che vede nei due Filippo i limiti della grande egemonia macedone egrave di nuovo presente anche in Appiano nellrsquooraco-lo riportato nei frammenti della sua Makedonikeacute e noto anche da Pausa-nia (VII 8 9)
αὐχοῦντες βασιλεῦσι Μακηδόνες Ἀργεάδῃσιν ὑμῖν κοιρανέων ἀγαθὸν καὶ πῆμα Φίλιππος ἤτοι ὁ μὲν πρότερος πόλεσιν λαοῖσί τ᾽ ἄνακτας θήσει ὁ δ᾽ ὁπλότερος τιμὴν ἀπὸ πᾶσαν ὀλέσσει δμηθεὶς δ᾽ ἑσπερίοισιν ὑπ᾽ ἀνδράσιν ἐνθάδ᾽ ὀλεῖται
O Macedoni che andate orgogliosi dei re di stirpe argiva I re di nome Filippo saranno arbitri del bene e del male per voi Il primo vi renderagrave signori di cittagrave e popoli il secondo vi priveragrave di ogni onore sconfitto da uomini dellrsquoOcciden-te qui giace morto52
Senza voler entrare nel merito della discussione di tale oracolo di nuo-vo pare di incontrare nei due autori la medesima prospettiva lontana dalla condanna morale del re macedone espressa da Polibio secondo cui la sconfitta egrave il giusto esito della sua crudeltagrave ed empietagrave
Il libro giustineo si conclude menzionando le condizioni della pa-ce di Tempe53 e lrsquoira degli Etoli che videro ignorate le proprie richieste da Flaminino e perciograve cercarono lrsquoalleanza di Antioco contro Roma Se-condo il Prologo XXX il libro perograve proseguiva con le campagne di Antio-co III in Asia Minore contro Molone e Acheo e in Battriana fino ad ar-rivare allrsquoesordio dello scontro con Roma54 Il riassunto giustineo egrave trop-po sommario per permettere un confronto con le fonti parallele Egrave pe-
50 Sul rilievo della storia della Macedonia nellrsquoopera di Trogo e Giustino vd von Gutsch-midt (1894) pp 17-217 Richter (1987) p 28 n 29 Franco (1993) pp 71-97 51 Vd anche Urban (1982) pp 1424-1443 e Alonso-Nuacutentildeez (1992) p 58 52 Mak Fr 2 Vd DrsquoAgostini (2011) pp 99-121 In questa Walbank (2002) pp 127-136 propone di interpretare anche un poema di Alceo di Messene (Anth Pal 9518)53 Egrave probabile che Trogo fornisse piugrave particolari riguardo a questa pace per esempio si puograve ritenere che vi fosse menzione dellrsquoinvio a Roma del figlio Demetrio da parte di Filippo come ostaggio dato che a Iust XXXII 2 3 si richiama appunto tale avvenimento54 Polyb XVIII 34 1-39 7 42 1-45 12 Liv XXXIII 11 3-13 15 24 1-31 11 Plut Flam IX 1-8 App Mak Fr IX riferiscono di due diverse trattative di pace caratterizzate da un vivace dibattito tra chi voleva lrsquoannientamento della Macedonia come in Grecia gli Etoli e a Roma Marco Claudio Marcello e coloro che desideravano la pace con la Macedonia in primis Flaminino
138 MONICA DrsquoAGOSTINI
rograve da notare la mancanza sia nel Prologo che nel testo del libro degli av-venimenti delle celebrazioni Istmie del 196 quando Flaminino procla-mograve la libertagrave dei Greci Piugrave in generale in tutta la narrazione di Giustino delle complesse trattative del 197-196 manca qualsiasi riferimento alla li-bertagrave dei Greci punto nodale nella tradizione di Polibio che con questa sottolineatura esalta sia il ruolo tirannico della Macedonia sia la grande generositagrave dei Romani nei confronti della Grecia Il silenzio di TrogoGiustino su tale questione mostra il prevedibile disinteresse per gli affari dei Greci e nel contempo conferma la presenza di una tradizione che si occupa soprattutto della storia delle monarchie ellenistiche allrsquointer-no della quale la posizione dellrsquoEllade egrave subalterna
Libro XXXII23- 34 Demetrio e Perseo
Gli ultimi anni di regno di Filippo tra il 183 e il 179 sono narrati in un passo breve del libro XXXII Il racconto in Giustino che egrave coerente con il Prologo trogiano segue in maniera sintetica la tradizione polibiana su questi eventi giunta a noi in alcuni passi lacunosi di Polibio (XXIII 1 3-3 10 7 1-7 10 1-11 8) integrati dal racconto particolareggiato di Li-vio (XXXIX 46 7- 48 6 53 1-16 XL 3 3-16 3 201-24 8) e dalla narra-zione di Diodoro (XIX 25) e Plutarco (Aem VIII 11)55
Conclusioni
In questi libri dedicati a Filippo egrave forse possibile vedere in filigrana la rielaborazione voluta di Giustino dei corrispondenti libri trogiani Co-me Giustino stesso afferma nella Prefatio 3 lrsquoopera di Trogo era costruita secondo due criteri quello cronologico e quello per laquoconcatenazione di eventi56raquo ea omnia Pompeius diuisa temporibus et serie rerum digesta conposuit
55 Lrsquoutilizzo della tradizione polibiana in Trogo egrave confermato dallrsquoaderenza a Livio (XL 54 1-56 11) e Diodoro (XXIX 28) del racconto sul pentimento di Filippo per aver ucciso il figlio Demetrio lrsquointenzione di punire Perseo e la correlazione tra questo e la sua mor-te Questo libro egrave dunque differente nellrsquointeresse e nelle fonti dai libri XXIX e XXX poicheacute molto vicino alla tradizione polibiana in Livio Questi avvenimenti in Giustino sono da collegare con lrsquoascesa al trono di Perseo e non con lrsquoepilogo della celebrazione del valore macedone giagrave conclusasi in Giustino con Cinoscefale e la transizione dallrsquoim-perium macedone allrsquoimperium romano Vd Heckel (1997) p 7 Appiano invece riporta ancora una tradizione diversa da quella polibiana in un frammento della Makedonikeacute in particolare Appiano egrave attento al punto di vista macedone e presenta Filippo come una vittima delle circostanze (Mak IX) DrsquoAgostini (2011) pp 99-12156 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362 Alonso-Nuacutentildeez (2002) pp 133-136 He-ckel (1997) pp 1-41 Borgna (2014) pp 52-77
IL DISCORSO DEL RE 139
Serie rerum digesta sembrerebbe unrsquointerpretazione latina della formula κατὰ γένος che Diodoro usa per indicare la struttura della storia di Efo-ro sottolineandone la divisione per argomento57 In tale struttura per argomento dellrsquoEpitome tra i temi principali ci sono dunque il valore e la gloria dei sovrani ellenistici58 riscontrabile nei libri XXVIII-XXXI sui re-gni di Antigono Dosone Filippo V e Antioco III Tale tema presente di sicuro in Trogo egrave conservato nellrsquoazione dellrsquoEpitomatore e anzi come si vede dagli escerpta esaltato dalla selezione dei passi
Per quanto riguarda invece la Quellenforschung 59 egrave evidente che nel testo vi sia presenza di filoni non tradizionali sugli eventi poicheacute la posi-zione di Trogo appare spesso autonoma rispetto alle opinioni condivise dalla storiografia antica Questo aspetto dellrsquoEpitome evidente soprattut-to per ciograve che riguarda gli eventi ellenistici ha suscitato la grande curio-sitagrave degli studiosi che allontanatisi dalla proposta di von Gutschmid che voleva una totale ed esclusiva dipendenza di Trogo da Timagene ora in-dicano con sicurezza tra le fonti piugrave rilevanti per gli eventi ellenistici di III secolo utilizzate da Trogo almeno altri sei nomi oltre a Timagene Ie-ronimo Timeo Filarco Duride Polibio e Posidonio
Per quanto riguarda nello specifico la composizione dei libri XXIX e XXX non vi egrave alcun dubbio che in essi Trogo abbia utilizzato (anche riadattandola) una fonte poco attenta alle questioni di politica interna greca e al legame tra queste e quel ritratto di Filippo come sovrano mal-vagio ed empio che ritorna nella tradizione ufficiale di origine polibia-na passando poi da Polibio in Livio Diodoro e Plutarco60 Trogo pre-serva invece una tradizione ellenistica interessata alla figura di Filippo come ultimo barlume della gloria macedone tradizione che pare quasi una controparte e un completamento dellrsquoAb urbe condita romanocentri-ca di Livio Non si puograve perciograve a mio avviso escludere che per questa se-zione Trogo abbia usato una tradizione di matrice filoellenistica o sem-plicemente ellenisticocentrica unrsquoopera sui regni di diadochi ed epigo-ni che a tutti noi fa venire facilmente alla mente il Basileis o Perigrave Basileon dello storico grecoellenistico augusteo filobarbaro scettico (o critico) verso lrsquoegemonia romana Timagene di Alessandria (FGrHist 88)61
57 Su Eforo vd Vannicelli (1987) pp 165-191 e ora Parmeggiani (2011) 58 Simile legame vi egrave a mio avviso tra i libri XXVI e XXVII che invece affrontavano la crisi delle monarchie ellenistiche causata dalle guerre fraterne59 Vd von Gutschmid (1894) pp 17-217 Richter (1987) pp 17-30 partic 20-23 San-ti Amantini (1972) pp 56-109 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362 Urban (1982) pp 1424-1443 partic 1435 Mecca (2001) pp 199-222 Santi Amantini (2003) pp 99-110 Heckel (2012) pp 3-860 Scuderi (2005) pp 383-40561 Sordi (1982) pp 775-797 Heckel (1997) pp 30-34 Landucci (2014) pp 233-261 e Ead in questo volume
140 MONICA DrsquoAGOSTINI
ABSTRACT
Philip V of Macedon was the first of the Epigonoi to face Rome Several mod-ern reconstructions of the actions and the reign of Philip V have approached it largely from a Roman point of view using as sources Polybius and where Poly-bius is lost Livy The Polybian historiographical tradition tends to portray Phil-ip V as an enemy and a tyrant impious and cruel The Macedonian king was ea-ger to establish a universal and unjust dominion over Greece Italy and beyond and Rome engaged in the first two Macedonian Wars to fight the threat of his growing ambition Nevertheless Polybiusrsquo portrayal of Philip V was affected not only by Polybiusrsquo admiration for Roman political structures military power and overwhelming conquest but also his personal Achaean origins
Looking at in book 29 and 30 of Justinrsquos Epitome of Pompeius Trogus this pa-per focuses on the non Polybian tradition on Philip V this contribution is in-deed the first analysis of the Hellenistic approach to the clash between Rome and Macedonia in the 3rd-2nd Century BC The Epitome shows a considerable di-versity of interpretation from the other sources and reflects very different views of Philip Vrsquos actions that brought him into conflict against Rome In particular these views are more evident related to the accounts of the peace negotiations of Naupactus and the battle of Cynoscephalae in the Epitome the king appears as a courageous and skilled warrior the last of the great Macedonian rulers who fell victim to misfortune This portrayal which has several common features with Appianrsquos fragments of Philip V (Mak 9) counterbalances the Roman and Achaean standpoint present in Polybius providing a more Hellenistic perspec-tive that is likely to have been rooted in a historiographical tradition connect-ed to the losing side in the struggle between Rome and the Hellenistic world
BIBLIOGRAFIA
Adler E (2006) Whorsquos Antiroman Sallust and Pompeius Trogus on Mithridates CJ 101 pp 383-407
Adler E (2011) Valorizing the Barbarians Enemy speeches in Roman Historiography Austin
Ager SL (2003) An Uneasy Balance from the Death of Seleukos to the Battle of Raph-ia in A Erskine (ed) A Companion to the Hellenistic World Oxford pp 35-50
Ager SL (2009) Roman Perspectives on Greek Diplomacy The conceptual clash Greek diplomacy of compromise and Roman Bellum Iustum in C Eilers (ed) Diplomats and Diplomacy in the Roman World Leiden-Boston pp 15-43
Alonso-Nuacutentildeez JM (1992) La Historia Universal de Pompeyo Trogo Madrid
Alonso-Nuacutentildeez JM (2002) The Idea of Universal History in Greece From Herodotus to the Age of Augustus Amsterdam
Ballesteros Pastor L (2013) Pompeyo Trogo Justino y Mitriacutedates Comentario al Epiacutetome de las Historias Filiacutepicas (3716-3881) Hildesheim-Zuumlrich-New York
IL DISCORSO DEL RE 141
Barreacute ML (1983) The God-List in the Treaty between Hannibal and Philip V of Ma-cedon a Study in Light of the Ancient Near Eastern Treaty Tradition Baltimore-Lon-don
Beck H - Eckstein A (2015) sv ldquoAratos of Sicyon (231)rdquo in I Worthington (ed) Brillrsquos New Jacoby Brill Online
Borgna A (2014) Uno sguardo originale intorno a Roma Pompeo Trogo e Giustino laquoLa Biblioteca di ClassicoContemporaneoraquo 1 pp 52-77
Cassola F (1962) I gruppi politici romani nel III secolo aC Trieste
Champion CB (1997) The Nature of Authoritative Evidence in Polybios and Agelausrsquo Speech at Naupactos TAPhA 127 pp 111-128
Champion CB (2004) Cultural Politics in Polybiusrsquo Histories Berkeley
Coppola A (1993) Demetrio di Faro un protagonista dimenticato Roma
Criscuolo L (2011) I due testamenti di Tolemeo VIII Evergete II in A Joumlrdens - J F Quack (hrsg) Aumlgypten zwischen innerem Zwist und aumluszligerem Druck Die Zeit Ptole-maios VI bis VIII Wiesbaden pp 132-150
DrsquoAgostini M (2011) Filippo V e la Storia Romana di Appiano laquoAevumraquo 85 pp 99-121
Eckstein AM (1995) Moral vision in the Histories of Polybius Berkeley
Eckstein AM (2008) Rome enters in the Greek East From Anarchy to Hierarchy in the Hellenistic Mediterranean 230-217 BC Oxford
Eckstein AM (2013) Polybius Phylarchus and Historiographical Criticism CPh 108 4 pp 314-338
Errington RM (1969) Philopoemen Oxford
Errington RM (2008) A History of the Hellenistic World 323-30 BC Malden MA-Oxford
Forni G - Angeli Bertinelli MG (1982) Pompeo Trogo come fonte di storia ANRW II 30 2 pp 1298-1362
Franco C (1993) Trogo Giustino e i successori di Alessandro in L Braccesi - A Coppola - G Cresci Marrone - C Franco (a cura di) LrsquoAlessandro di Giustino dagli antichi ai moderni Roma pp 71-97
Gabba E (2003) Introduzione in D Foraboschi - SM Pizzetti (a cura di) La successione degli imperi e delle egemonie nelle relazioni internazionali Milano pp 7-9
Golan D (1995) The Res Graeciae in Polybius Four Studies Como
Green P (1990) Alexander to Actium The Historical Evolution of the Hellenistic Age Berkeley-Los Angeles
Gutschmid von A (1894) Die beiden ersten Buumlcher des Pompeius Trogus in A von Gutschmid - F Ruumlhl (hrsg) Kleine Schriften Leipzig pp 17-217
142 MONICA DrsquoAGOSTINI
Habicht C (1995) Athen Muumlnchen
Hammond NGL (1968) Illyris Rome and Macedon in 229-205 BC JRS 58 pp 1-21
Hammond NGL (1988) The Campaign and the Battle of Cynoscephalae in 197 BC JHS 108 pp 60-82
Heckel W (1997) Introduction (Part 2) in JC Yardley - W Heckel (eds) Ju-stin Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus Books 11-12 Alexander the Great Introduction Oxford pp 1-41
Heckel W (2012) Introduction in JC Yardley - P Wheatley - W Heckel (eds) Justin Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus II Books 13-15 The Successors to Alexander the Great Oxford pp 1-8
Huss W (1976) Untersuchungen zur Auszligenpolitik Ptolemaiosrsquo IV Muumlnchen
Huss W (2001) Aumlgypten in hellenistischer Zeit 332ndash30 v Chr Muumlnchen
Intrieri M (2011) Fra dialogo e conflitto Annibale e i Greci drsquoOccidente RStudFen 37 pp 53-82
Landucci F (2014) Filippo II e le Storie Filippiche un protagonista storico e storio-grafico in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 233-261
Landucci Gattinoni F (2011) Politica e ideologia in etagrave ellenistica laquoPolitica An-ticaraquo 1 pp 89-105
Leacutevy E (1994) Le discours drsquoAgeacutelaos de Naupacte in L Aigner Foresti - A Bar-zanograve - C Bearzot - L Prandi - G Zecchini (a cura di) Federazioni e federalismo nellrsquoEuropa antica Bergamo 21-25 settembre 1992 Milano (Alle radici della casa co-mune europea 1) pp 33-50
Longaretti L (1989) Lrsquoalleanza tra Annibale e Filippo V di Macedonia RIL 123 pp 183-192
Marasco G (1979-1980) La valutazione di Tolemeo IV Filopatore nella storiografia greca laquoSilenoraquo 5-6 pp 159-182
Mari M [- Musti D - Thornton J] (2002) Polibio Storie Volume III Libri V-VI Milano
Mariotta G (2014) Geografia e Geopolitica nelle Storie Filippiche in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 45-56
McGing B (2010) Polybiusrsquo Histories New York
McGing B (2013) Youthfulness in Polybius the case of Philip V of Macedon in B Gibson - T Harrison (eds) Polybius and his world Oxford pp 181-199
Meadows A (2013) Polybius Aratus and the History of the 140th Olympiad in B
IL DISCORSO DEL RE 143
Gibson - T Harrison (eds) Polybius and his World Essays in Honour of Frank Walbank Oxford pp 91-116
Mecca A (2001) Trogo Timagene e Polieno QS 54 pp 199-222
Meister K (1990) Die Griechische Geschichtsschreibung von den Anfaumlngen bis zum Ende des Hellenismus Stuttgart
Misch G (1949) Geschichte der Autobiographie I Frankfurt am Mein
Momigliano A (1980) Daniele e la teoria greca della successione degli imperi RAL 35 pp 157-162
Muccioli F (2013) Gli epiteti ufficiali dei re ellenistici Stuttgart (Historia Einzel-schriften 224)
Musti D (1978) Polibio e lrsquoimperialismo romano Napoli
Parmeggiani G (2011) Eforo di Cuma studi di storiografia greca Bologna
Peacutedech P (1964) La meacutethode historique de Polybe Paris
Pelling CBR [- Scardigli B - Manfredini M](1997) Plutarco Vite parallele Filopemene Tito Flaminino Milano
Richter H-D (1987) Untersuchungen zur hellenistischen Historiographie die Vorla-gen des Pompeius Trogus fuumlr die Darstellung der nachalexandrischen hellenistischen Ge-schichte (Iust 13-40) Frankfurt
Santi Amantini L (1972) Fonti e valore storico di Pompeo Trogo (Iustin XXXV e XXXVI) Genova
Santi Amantini L (1981) (a cura di) Giustino Storie Filippiche Epitome da Pom-peo Trogo Milano
Santi Amantini L (2003) Il tempo e i tempi nelle Storie Filippiche di Pompeo Tro-go RSA 33 pp 99-110
Schepens G (1983) Les rois ptolegravemaiumlques et lrsquohistoriographie Reacuteflexions sur la trans-formation de lrsquohistoire politique in E vanrsquot Dack - P van Dessel - W Van Gucht (eds) Egypt and the Hellenistic World Proceedings of the International Collo-quium Leuven 24-26 May 1982 Leuven (Studia Hellenistica 27) pp 351-368
Schlicher JJ (1933) Non-Assertive Elements in the Language of the Roman Histo-rians CPh 28 289-300
Schmitt T (1989) Die Bedeutung des zweiten Punischen Krieges fuumlr den Frieden in Naupaktos in H Devijver - E Lipinski (eds) Punic wars Proceedings of the Conference held in Antwerp from the 23th to the 26th of November 1988 in Cooperation with the Departement of History of the laquoUniversitait Antwerpenraquo UFSIA Leuven (Studia Phoenicia 10) pp 229-239
Scholten JB (2000) The Politics of Plunder Aitolians and their koinon in the early Hellenistic Era Berkeley
144 MONICA DrsquoAGOSTINI
Scuderi R (2005) Filippo V e Perseo nei frammenti diodorei in C Bearzot - F Lan-ducci (a cura di) Diodoro e lrsquoaltra Grecia Macedonia Occidente Ellenismo nella Bi-blioteca Storica Atti del convegno Milano 15-16 gennaio 2004 Milano pp 383-405
Sklenaacuter RJ (2004) Sources and Individuality in Two Passages of Livy laquoHistoriaraquo 53 pp 302-310
Sordi M (1982) Timagene di Alessandria Uno storico ellenocentrico e filobarbaro ANRW II 30 1 pp 775-797
Thornton J (2014) Le guerre macedoniche Roma
Urban R (1979) Wachstum und Kriese des achaumlischen Bundes Quellenstudien zur entwicklung des Bundes von 280 bis 222 V Chr Wiesbaden
Urban R (1982) laquoGallisches Bewusstseinraquo und laquoRomkritikraquo bei Pompeius Trogus ANRW II 30 2 pp 1424-1443
Vannicelli P (1987) Lrsquoeconomia delle Storie di Eforo RFIC 115 pp 165-191
Vattuone R (2014) Giustino e lrsquoOccidente greco I VI-V secolo aC in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 261-277
Vollmer D (1990) Symploke das Uumlbergreifen der roumlmischen Expansion auf den grie-chischen Osten Untersuchungen zur roumlmischen Aussenpolitik am Ende des 3 Jh V Chr Stuttgart
Walbank FW (1957) A Historical Commentary on Polibius I Oxford
Walbank FW (1967) A Historical Commentary on Polybius II Oxford
Walbank FW (1933) Aratos of Sicyon Cambridge
Walbank FW (2002) Η ΤΩΝ ΟΛΩΝ ΕΛΠΙΣ and the Antigonids in FW Walbank (ed) Polybius Rome and the Hellenistic World Essays and Reflections West Nyack NY pp 127-136
Weber G (1997) Interaktion Repraumlsentation und Herrschaft Der Koumlnigshof im Hel-lenismus in A Winterling (hrsg) Zwischen lsquoHausrsquo und lsquoStaatrsquo antike Houmlfe im Ver-gleich Munich pp 27-72
Will E (19822) Histoire politique du Monde Helleacutenistique II Nancy
Zecchini G (1990) La storiografia lagide in H Verdin - G Schepens - E De Keyser (eds) Purposes of History Studies in Greek Historiography from the 4th to the 2nd Centuries BC Proceedings of the International Colloquium of Leuven 24-26 May 1988 Leuven (Studia Hellenistica 30) pp 213-232
Zecchini G (2003) Polibio e la tradizione orale in A Casanova - P Desideri (a cura di) Evento racconto scrittura nellrsquoantichitagrave classica Firenze pp 123-141
Finito di stamparenel mese di novembre 2015
da LegoDigit srlLavis (TN)
138 MONICA DrsquoAGOSTINI
rograve da notare la mancanza sia nel Prologo che nel testo del libro degli av-venimenti delle celebrazioni Istmie del 196 quando Flaminino procla-mograve la libertagrave dei Greci Piugrave in generale in tutta la narrazione di Giustino delle complesse trattative del 197-196 manca qualsiasi riferimento alla li-bertagrave dei Greci punto nodale nella tradizione di Polibio che con questa sottolineatura esalta sia il ruolo tirannico della Macedonia sia la grande generositagrave dei Romani nei confronti della Grecia Il silenzio di TrogoGiustino su tale questione mostra il prevedibile disinteresse per gli affari dei Greci e nel contempo conferma la presenza di una tradizione che si occupa soprattutto della storia delle monarchie ellenistiche allrsquointer-no della quale la posizione dellrsquoEllade egrave subalterna
Libro XXXII23- 34 Demetrio e Perseo
Gli ultimi anni di regno di Filippo tra il 183 e il 179 sono narrati in un passo breve del libro XXXII Il racconto in Giustino che egrave coerente con il Prologo trogiano segue in maniera sintetica la tradizione polibiana su questi eventi giunta a noi in alcuni passi lacunosi di Polibio (XXIII 1 3-3 10 7 1-7 10 1-11 8) integrati dal racconto particolareggiato di Li-vio (XXXIX 46 7- 48 6 53 1-16 XL 3 3-16 3 201-24 8) e dalla narra-zione di Diodoro (XIX 25) e Plutarco (Aem VIII 11)55
Conclusioni
In questi libri dedicati a Filippo egrave forse possibile vedere in filigrana la rielaborazione voluta di Giustino dei corrispondenti libri trogiani Co-me Giustino stesso afferma nella Prefatio 3 lrsquoopera di Trogo era costruita secondo due criteri quello cronologico e quello per laquoconcatenazione di eventi56raquo ea omnia Pompeius diuisa temporibus et serie rerum digesta conposuit
55 Lrsquoutilizzo della tradizione polibiana in Trogo egrave confermato dallrsquoaderenza a Livio (XL 54 1-56 11) e Diodoro (XXIX 28) del racconto sul pentimento di Filippo per aver ucciso il figlio Demetrio lrsquointenzione di punire Perseo e la correlazione tra questo e la sua mor-te Questo libro egrave dunque differente nellrsquointeresse e nelle fonti dai libri XXIX e XXX poicheacute molto vicino alla tradizione polibiana in Livio Questi avvenimenti in Giustino sono da collegare con lrsquoascesa al trono di Perseo e non con lrsquoepilogo della celebrazione del valore macedone giagrave conclusasi in Giustino con Cinoscefale e la transizione dallrsquoim-perium macedone allrsquoimperium romano Vd Heckel (1997) p 7 Appiano invece riporta ancora una tradizione diversa da quella polibiana in un frammento della Makedonikeacute in particolare Appiano egrave attento al punto di vista macedone e presenta Filippo come una vittima delle circostanze (Mak IX) DrsquoAgostini (2011) pp 99-12156 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362 Alonso-Nuacutentildeez (2002) pp 133-136 He-ckel (1997) pp 1-41 Borgna (2014) pp 52-77
IL DISCORSO DEL RE 139
Serie rerum digesta sembrerebbe unrsquointerpretazione latina della formula κατὰ γένος che Diodoro usa per indicare la struttura della storia di Efo-ro sottolineandone la divisione per argomento57 In tale struttura per argomento dellrsquoEpitome tra i temi principali ci sono dunque il valore e la gloria dei sovrani ellenistici58 riscontrabile nei libri XXVIII-XXXI sui re-gni di Antigono Dosone Filippo V e Antioco III Tale tema presente di sicuro in Trogo egrave conservato nellrsquoazione dellrsquoEpitomatore e anzi come si vede dagli escerpta esaltato dalla selezione dei passi
Per quanto riguarda invece la Quellenforschung 59 egrave evidente che nel testo vi sia presenza di filoni non tradizionali sugli eventi poicheacute la posi-zione di Trogo appare spesso autonoma rispetto alle opinioni condivise dalla storiografia antica Questo aspetto dellrsquoEpitome evidente soprattut-to per ciograve che riguarda gli eventi ellenistici ha suscitato la grande curio-sitagrave degli studiosi che allontanatisi dalla proposta di von Gutschmid che voleva una totale ed esclusiva dipendenza di Trogo da Timagene ora in-dicano con sicurezza tra le fonti piugrave rilevanti per gli eventi ellenistici di III secolo utilizzate da Trogo almeno altri sei nomi oltre a Timagene Ie-ronimo Timeo Filarco Duride Polibio e Posidonio
Per quanto riguarda nello specifico la composizione dei libri XXIX e XXX non vi egrave alcun dubbio che in essi Trogo abbia utilizzato (anche riadattandola) una fonte poco attenta alle questioni di politica interna greca e al legame tra queste e quel ritratto di Filippo come sovrano mal-vagio ed empio che ritorna nella tradizione ufficiale di origine polibia-na passando poi da Polibio in Livio Diodoro e Plutarco60 Trogo pre-serva invece una tradizione ellenistica interessata alla figura di Filippo come ultimo barlume della gloria macedone tradizione che pare quasi una controparte e un completamento dellrsquoAb urbe condita romanocentri-ca di Livio Non si puograve perciograve a mio avviso escludere che per questa se-zione Trogo abbia usato una tradizione di matrice filoellenistica o sem-plicemente ellenisticocentrica unrsquoopera sui regni di diadochi ed epigo-ni che a tutti noi fa venire facilmente alla mente il Basileis o Perigrave Basileon dello storico grecoellenistico augusteo filobarbaro scettico (o critico) verso lrsquoegemonia romana Timagene di Alessandria (FGrHist 88)61
57 Su Eforo vd Vannicelli (1987) pp 165-191 e ora Parmeggiani (2011) 58 Simile legame vi egrave a mio avviso tra i libri XXVI e XXVII che invece affrontavano la crisi delle monarchie ellenistiche causata dalle guerre fraterne59 Vd von Gutschmid (1894) pp 17-217 Richter (1987) pp 17-30 partic 20-23 San-ti Amantini (1972) pp 56-109 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362 Urban (1982) pp 1424-1443 partic 1435 Mecca (2001) pp 199-222 Santi Amantini (2003) pp 99-110 Heckel (2012) pp 3-860 Scuderi (2005) pp 383-40561 Sordi (1982) pp 775-797 Heckel (1997) pp 30-34 Landucci (2014) pp 233-261 e Ead in questo volume
140 MONICA DrsquoAGOSTINI
ABSTRACT
Philip V of Macedon was the first of the Epigonoi to face Rome Several mod-ern reconstructions of the actions and the reign of Philip V have approached it largely from a Roman point of view using as sources Polybius and where Poly-bius is lost Livy The Polybian historiographical tradition tends to portray Phil-ip V as an enemy and a tyrant impious and cruel The Macedonian king was ea-ger to establish a universal and unjust dominion over Greece Italy and beyond and Rome engaged in the first two Macedonian Wars to fight the threat of his growing ambition Nevertheless Polybiusrsquo portrayal of Philip V was affected not only by Polybiusrsquo admiration for Roman political structures military power and overwhelming conquest but also his personal Achaean origins
Looking at in book 29 and 30 of Justinrsquos Epitome of Pompeius Trogus this pa-per focuses on the non Polybian tradition on Philip V this contribution is in-deed the first analysis of the Hellenistic approach to the clash between Rome and Macedonia in the 3rd-2nd Century BC The Epitome shows a considerable di-versity of interpretation from the other sources and reflects very different views of Philip Vrsquos actions that brought him into conflict against Rome In particular these views are more evident related to the accounts of the peace negotiations of Naupactus and the battle of Cynoscephalae in the Epitome the king appears as a courageous and skilled warrior the last of the great Macedonian rulers who fell victim to misfortune This portrayal which has several common features with Appianrsquos fragments of Philip V (Mak 9) counterbalances the Roman and Achaean standpoint present in Polybius providing a more Hellenistic perspec-tive that is likely to have been rooted in a historiographical tradition connect-ed to the losing side in the struggle between Rome and the Hellenistic world
BIBLIOGRAFIA
Adler E (2006) Whorsquos Antiroman Sallust and Pompeius Trogus on Mithridates CJ 101 pp 383-407
Adler E (2011) Valorizing the Barbarians Enemy speeches in Roman Historiography Austin
Ager SL (2003) An Uneasy Balance from the Death of Seleukos to the Battle of Raph-ia in A Erskine (ed) A Companion to the Hellenistic World Oxford pp 35-50
Ager SL (2009) Roman Perspectives on Greek Diplomacy The conceptual clash Greek diplomacy of compromise and Roman Bellum Iustum in C Eilers (ed) Diplomats and Diplomacy in the Roman World Leiden-Boston pp 15-43
Alonso-Nuacutentildeez JM (1992) La Historia Universal de Pompeyo Trogo Madrid
Alonso-Nuacutentildeez JM (2002) The Idea of Universal History in Greece From Herodotus to the Age of Augustus Amsterdam
Ballesteros Pastor L (2013) Pompeyo Trogo Justino y Mitriacutedates Comentario al Epiacutetome de las Historias Filiacutepicas (3716-3881) Hildesheim-Zuumlrich-New York
IL DISCORSO DEL RE 141
Barreacute ML (1983) The God-List in the Treaty between Hannibal and Philip V of Ma-cedon a Study in Light of the Ancient Near Eastern Treaty Tradition Baltimore-Lon-don
Beck H - Eckstein A (2015) sv ldquoAratos of Sicyon (231)rdquo in I Worthington (ed) Brillrsquos New Jacoby Brill Online
Borgna A (2014) Uno sguardo originale intorno a Roma Pompeo Trogo e Giustino laquoLa Biblioteca di ClassicoContemporaneoraquo 1 pp 52-77
Cassola F (1962) I gruppi politici romani nel III secolo aC Trieste
Champion CB (1997) The Nature of Authoritative Evidence in Polybios and Agelausrsquo Speech at Naupactos TAPhA 127 pp 111-128
Champion CB (2004) Cultural Politics in Polybiusrsquo Histories Berkeley
Coppola A (1993) Demetrio di Faro un protagonista dimenticato Roma
Criscuolo L (2011) I due testamenti di Tolemeo VIII Evergete II in A Joumlrdens - J F Quack (hrsg) Aumlgypten zwischen innerem Zwist und aumluszligerem Druck Die Zeit Ptole-maios VI bis VIII Wiesbaden pp 132-150
DrsquoAgostini M (2011) Filippo V e la Storia Romana di Appiano laquoAevumraquo 85 pp 99-121
Eckstein AM (1995) Moral vision in the Histories of Polybius Berkeley
Eckstein AM (2008) Rome enters in the Greek East From Anarchy to Hierarchy in the Hellenistic Mediterranean 230-217 BC Oxford
Eckstein AM (2013) Polybius Phylarchus and Historiographical Criticism CPh 108 4 pp 314-338
Errington RM (1969) Philopoemen Oxford
Errington RM (2008) A History of the Hellenistic World 323-30 BC Malden MA-Oxford
Forni G - Angeli Bertinelli MG (1982) Pompeo Trogo come fonte di storia ANRW II 30 2 pp 1298-1362
Franco C (1993) Trogo Giustino e i successori di Alessandro in L Braccesi - A Coppola - G Cresci Marrone - C Franco (a cura di) LrsquoAlessandro di Giustino dagli antichi ai moderni Roma pp 71-97
Gabba E (2003) Introduzione in D Foraboschi - SM Pizzetti (a cura di) La successione degli imperi e delle egemonie nelle relazioni internazionali Milano pp 7-9
Golan D (1995) The Res Graeciae in Polybius Four Studies Como
Green P (1990) Alexander to Actium The Historical Evolution of the Hellenistic Age Berkeley-Los Angeles
Gutschmid von A (1894) Die beiden ersten Buumlcher des Pompeius Trogus in A von Gutschmid - F Ruumlhl (hrsg) Kleine Schriften Leipzig pp 17-217
142 MONICA DrsquoAGOSTINI
Habicht C (1995) Athen Muumlnchen
Hammond NGL (1968) Illyris Rome and Macedon in 229-205 BC JRS 58 pp 1-21
Hammond NGL (1988) The Campaign and the Battle of Cynoscephalae in 197 BC JHS 108 pp 60-82
Heckel W (1997) Introduction (Part 2) in JC Yardley - W Heckel (eds) Ju-stin Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus Books 11-12 Alexander the Great Introduction Oxford pp 1-41
Heckel W (2012) Introduction in JC Yardley - P Wheatley - W Heckel (eds) Justin Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus II Books 13-15 The Successors to Alexander the Great Oxford pp 1-8
Huss W (1976) Untersuchungen zur Auszligenpolitik Ptolemaiosrsquo IV Muumlnchen
Huss W (2001) Aumlgypten in hellenistischer Zeit 332ndash30 v Chr Muumlnchen
Intrieri M (2011) Fra dialogo e conflitto Annibale e i Greci drsquoOccidente RStudFen 37 pp 53-82
Landucci F (2014) Filippo II e le Storie Filippiche un protagonista storico e storio-grafico in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 233-261
Landucci Gattinoni F (2011) Politica e ideologia in etagrave ellenistica laquoPolitica An-ticaraquo 1 pp 89-105
Leacutevy E (1994) Le discours drsquoAgeacutelaos de Naupacte in L Aigner Foresti - A Bar-zanograve - C Bearzot - L Prandi - G Zecchini (a cura di) Federazioni e federalismo nellrsquoEuropa antica Bergamo 21-25 settembre 1992 Milano (Alle radici della casa co-mune europea 1) pp 33-50
Longaretti L (1989) Lrsquoalleanza tra Annibale e Filippo V di Macedonia RIL 123 pp 183-192
Marasco G (1979-1980) La valutazione di Tolemeo IV Filopatore nella storiografia greca laquoSilenoraquo 5-6 pp 159-182
Mari M [- Musti D - Thornton J] (2002) Polibio Storie Volume III Libri V-VI Milano
Mariotta G (2014) Geografia e Geopolitica nelle Storie Filippiche in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 45-56
McGing B (2010) Polybiusrsquo Histories New York
McGing B (2013) Youthfulness in Polybius the case of Philip V of Macedon in B Gibson - T Harrison (eds) Polybius and his world Oxford pp 181-199
Meadows A (2013) Polybius Aratus and the History of the 140th Olympiad in B
IL DISCORSO DEL RE 143
Gibson - T Harrison (eds) Polybius and his World Essays in Honour of Frank Walbank Oxford pp 91-116
Mecca A (2001) Trogo Timagene e Polieno QS 54 pp 199-222
Meister K (1990) Die Griechische Geschichtsschreibung von den Anfaumlngen bis zum Ende des Hellenismus Stuttgart
Misch G (1949) Geschichte der Autobiographie I Frankfurt am Mein
Momigliano A (1980) Daniele e la teoria greca della successione degli imperi RAL 35 pp 157-162
Muccioli F (2013) Gli epiteti ufficiali dei re ellenistici Stuttgart (Historia Einzel-schriften 224)
Musti D (1978) Polibio e lrsquoimperialismo romano Napoli
Parmeggiani G (2011) Eforo di Cuma studi di storiografia greca Bologna
Peacutedech P (1964) La meacutethode historique de Polybe Paris
Pelling CBR [- Scardigli B - Manfredini M](1997) Plutarco Vite parallele Filopemene Tito Flaminino Milano
Richter H-D (1987) Untersuchungen zur hellenistischen Historiographie die Vorla-gen des Pompeius Trogus fuumlr die Darstellung der nachalexandrischen hellenistischen Ge-schichte (Iust 13-40) Frankfurt
Santi Amantini L (1972) Fonti e valore storico di Pompeo Trogo (Iustin XXXV e XXXVI) Genova
Santi Amantini L (1981) (a cura di) Giustino Storie Filippiche Epitome da Pom-peo Trogo Milano
Santi Amantini L (2003) Il tempo e i tempi nelle Storie Filippiche di Pompeo Tro-go RSA 33 pp 99-110
Schepens G (1983) Les rois ptolegravemaiumlques et lrsquohistoriographie Reacuteflexions sur la trans-formation de lrsquohistoire politique in E vanrsquot Dack - P van Dessel - W Van Gucht (eds) Egypt and the Hellenistic World Proceedings of the International Collo-quium Leuven 24-26 May 1982 Leuven (Studia Hellenistica 27) pp 351-368
Schlicher JJ (1933) Non-Assertive Elements in the Language of the Roman Histo-rians CPh 28 289-300
Schmitt T (1989) Die Bedeutung des zweiten Punischen Krieges fuumlr den Frieden in Naupaktos in H Devijver - E Lipinski (eds) Punic wars Proceedings of the Conference held in Antwerp from the 23th to the 26th of November 1988 in Cooperation with the Departement of History of the laquoUniversitait Antwerpenraquo UFSIA Leuven (Studia Phoenicia 10) pp 229-239
Scholten JB (2000) The Politics of Plunder Aitolians and their koinon in the early Hellenistic Era Berkeley
144 MONICA DrsquoAGOSTINI
Scuderi R (2005) Filippo V e Perseo nei frammenti diodorei in C Bearzot - F Lan-ducci (a cura di) Diodoro e lrsquoaltra Grecia Macedonia Occidente Ellenismo nella Bi-blioteca Storica Atti del convegno Milano 15-16 gennaio 2004 Milano pp 383-405
Sklenaacuter RJ (2004) Sources and Individuality in Two Passages of Livy laquoHistoriaraquo 53 pp 302-310
Sordi M (1982) Timagene di Alessandria Uno storico ellenocentrico e filobarbaro ANRW II 30 1 pp 775-797
Thornton J (2014) Le guerre macedoniche Roma
Urban R (1979) Wachstum und Kriese des achaumlischen Bundes Quellenstudien zur entwicklung des Bundes von 280 bis 222 V Chr Wiesbaden
Urban R (1982) laquoGallisches Bewusstseinraquo und laquoRomkritikraquo bei Pompeius Trogus ANRW II 30 2 pp 1424-1443
Vannicelli P (1987) Lrsquoeconomia delle Storie di Eforo RFIC 115 pp 165-191
Vattuone R (2014) Giustino e lrsquoOccidente greco I VI-V secolo aC in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 261-277
Vollmer D (1990) Symploke das Uumlbergreifen der roumlmischen Expansion auf den grie-chischen Osten Untersuchungen zur roumlmischen Aussenpolitik am Ende des 3 Jh V Chr Stuttgart
Walbank FW (1957) A Historical Commentary on Polibius I Oxford
Walbank FW (1967) A Historical Commentary on Polybius II Oxford
Walbank FW (1933) Aratos of Sicyon Cambridge
Walbank FW (2002) Η ΤΩΝ ΟΛΩΝ ΕΛΠΙΣ and the Antigonids in FW Walbank (ed) Polybius Rome and the Hellenistic World Essays and Reflections West Nyack NY pp 127-136
Weber G (1997) Interaktion Repraumlsentation und Herrschaft Der Koumlnigshof im Hel-lenismus in A Winterling (hrsg) Zwischen lsquoHausrsquo und lsquoStaatrsquo antike Houmlfe im Ver-gleich Munich pp 27-72
Will E (19822) Histoire politique du Monde Helleacutenistique II Nancy
Zecchini G (1990) La storiografia lagide in H Verdin - G Schepens - E De Keyser (eds) Purposes of History Studies in Greek Historiography from the 4th to the 2nd Centuries BC Proceedings of the International Colloquium of Leuven 24-26 May 1988 Leuven (Studia Hellenistica 30) pp 213-232
Zecchini G (2003) Polibio e la tradizione orale in A Casanova - P Desideri (a cura di) Evento racconto scrittura nellrsquoantichitagrave classica Firenze pp 123-141
Finito di stamparenel mese di novembre 2015
da LegoDigit srlLavis (TN)
IL DISCORSO DEL RE 139
Serie rerum digesta sembrerebbe unrsquointerpretazione latina della formula κατὰ γένος che Diodoro usa per indicare la struttura della storia di Efo-ro sottolineandone la divisione per argomento57 In tale struttura per argomento dellrsquoEpitome tra i temi principali ci sono dunque il valore e la gloria dei sovrani ellenistici58 riscontrabile nei libri XXVIII-XXXI sui re-gni di Antigono Dosone Filippo V e Antioco III Tale tema presente di sicuro in Trogo egrave conservato nellrsquoazione dellrsquoEpitomatore e anzi come si vede dagli escerpta esaltato dalla selezione dei passi
Per quanto riguarda invece la Quellenforschung 59 egrave evidente che nel testo vi sia presenza di filoni non tradizionali sugli eventi poicheacute la posi-zione di Trogo appare spesso autonoma rispetto alle opinioni condivise dalla storiografia antica Questo aspetto dellrsquoEpitome evidente soprattut-to per ciograve che riguarda gli eventi ellenistici ha suscitato la grande curio-sitagrave degli studiosi che allontanatisi dalla proposta di von Gutschmid che voleva una totale ed esclusiva dipendenza di Trogo da Timagene ora in-dicano con sicurezza tra le fonti piugrave rilevanti per gli eventi ellenistici di III secolo utilizzate da Trogo almeno altri sei nomi oltre a Timagene Ie-ronimo Timeo Filarco Duride Polibio e Posidonio
Per quanto riguarda nello specifico la composizione dei libri XXIX e XXX non vi egrave alcun dubbio che in essi Trogo abbia utilizzato (anche riadattandola) una fonte poco attenta alle questioni di politica interna greca e al legame tra queste e quel ritratto di Filippo come sovrano mal-vagio ed empio che ritorna nella tradizione ufficiale di origine polibia-na passando poi da Polibio in Livio Diodoro e Plutarco60 Trogo pre-serva invece una tradizione ellenistica interessata alla figura di Filippo come ultimo barlume della gloria macedone tradizione che pare quasi una controparte e un completamento dellrsquoAb urbe condita romanocentri-ca di Livio Non si puograve perciograve a mio avviso escludere che per questa se-zione Trogo abbia usato una tradizione di matrice filoellenistica o sem-plicemente ellenisticocentrica unrsquoopera sui regni di diadochi ed epigo-ni che a tutti noi fa venire facilmente alla mente il Basileis o Perigrave Basileon dello storico grecoellenistico augusteo filobarbaro scettico (o critico) verso lrsquoegemonia romana Timagene di Alessandria (FGrHist 88)61
57 Su Eforo vd Vannicelli (1987) pp 165-191 e ora Parmeggiani (2011) 58 Simile legame vi egrave a mio avviso tra i libri XXVI e XXVII che invece affrontavano la crisi delle monarchie ellenistiche causata dalle guerre fraterne59 Vd von Gutschmid (1894) pp 17-217 Richter (1987) pp 17-30 partic 20-23 San-ti Amantini (1972) pp 56-109 Forni - Angeli Bertinelli (1982) pp 1298-1362 Urban (1982) pp 1424-1443 partic 1435 Mecca (2001) pp 199-222 Santi Amantini (2003) pp 99-110 Heckel (2012) pp 3-860 Scuderi (2005) pp 383-40561 Sordi (1982) pp 775-797 Heckel (1997) pp 30-34 Landucci (2014) pp 233-261 e Ead in questo volume
140 MONICA DrsquoAGOSTINI
ABSTRACT
Philip V of Macedon was the first of the Epigonoi to face Rome Several mod-ern reconstructions of the actions and the reign of Philip V have approached it largely from a Roman point of view using as sources Polybius and where Poly-bius is lost Livy The Polybian historiographical tradition tends to portray Phil-ip V as an enemy and a tyrant impious and cruel The Macedonian king was ea-ger to establish a universal and unjust dominion over Greece Italy and beyond and Rome engaged in the first two Macedonian Wars to fight the threat of his growing ambition Nevertheless Polybiusrsquo portrayal of Philip V was affected not only by Polybiusrsquo admiration for Roman political structures military power and overwhelming conquest but also his personal Achaean origins
Looking at in book 29 and 30 of Justinrsquos Epitome of Pompeius Trogus this pa-per focuses on the non Polybian tradition on Philip V this contribution is in-deed the first analysis of the Hellenistic approach to the clash between Rome and Macedonia in the 3rd-2nd Century BC The Epitome shows a considerable di-versity of interpretation from the other sources and reflects very different views of Philip Vrsquos actions that brought him into conflict against Rome In particular these views are more evident related to the accounts of the peace negotiations of Naupactus and the battle of Cynoscephalae in the Epitome the king appears as a courageous and skilled warrior the last of the great Macedonian rulers who fell victim to misfortune This portrayal which has several common features with Appianrsquos fragments of Philip V (Mak 9) counterbalances the Roman and Achaean standpoint present in Polybius providing a more Hellenistic perspec-tive that is likely to have been rooted in a historiographical tradition connect-ed to the losing side in the struggle between Rome and the Hellenistic world
BIBLIOGRAFIA
Adler E (2006) Whorsquos Antiroman Sallust and Pompeius Trogus on Mithridates CJ 101 pp 383-407
Adler E (2011) Valorizing the Barbarians Enemy speeches in Roman Historiography Austin
Ager SL (2003) An Uneasy Balance from the Death of Seleukos to the Battle of Raph-ia in A Erskine (ed) A Companion to the Hellenistic World Oxford pp 35-50
Ager SL (2009) Roman Perspectives on Greek Diplomacy The conceptual clash Greek diplomacy of compromise and Roman Bellum Iustum in C Eilers (ed) Diplomats and Diplomacy in the Roman World Leiden-Boston pp 15-43
Alonso-Nuacutentildeez JM (1992) La Historia Universal de Pompeyo Trogo Madrid
Alonso-Nuacutentildeez JM (2002) The Idea of Universal History in Greece From Herodotus to the Age of Augustus Amsterdam
Ballesteros Pastor L (2013) Pompeyo Trogo Justino y Mitriacutedates Comentario al Epiacutetome de las Historias Filiacutepicas (3716-3881) Hildesheim-Zuumlrich-New York
IL DISCORSO DEL RE 141
Barreacute ML (1983) The God-List in the Treaty between Hannibal and Philip V of Ma-cedon a Study in Light of the Ancient Near Eastern Treaty Tradition Baltimore-Lon-don
Beck H - Eckstein A (2015) sv ldquoAratos of Sicyon (231)rdquo in I Worthington (ed) Brillrsquos New Jacoby Brill Online
Borgna A (2014) Uno sguardo originale intorno a Roma Pompeo Trogo e Giustino laquoLa Biblioteca di ClassicoContemporaneoraquo 1 pp 52-77
Cassola F (1962) I gruppi politici romani nel III secolo aC Trieste
Champion CB (1997) The Nature of Authoritative Evidence in Polybios and Agelausrsquo Speech at Naupactos TAPhA 127 pp 111-128
Champion CB (2004) Cultural Politics in Polybiusrsquo Histories Berkeley
Coppola A (1993) Demetrio di Faro un protagonista dimenticato Roma
Criscuolo L (2011) I due testamenti di Tolemeo VIII Evergete II in A Joumlrdens - J F Quack (hrsg) Aumlgypten zwischen innerem Zwist und aumluszligerem Druck Die Zeit Ptole-maios VI bis VIII Wiesbaden pp 132-150
DrsquoAgostini M (2011) Filippo V e la Storia Romana di Appiano laquoAevumraquo 85 pp 99-121
Eckstein AM (1995) Moral vision in the Histories of Polybius Berkeley
Eckstein AM (2008) Rome enters in the Greek East From Anarchy to Hierarchy in the Hellenistic Mediterranean 230-217 BC Oxford
Eckstein AM (2013) Polybius Phylarchus and Historiographical Criticism CPh 108 4 pp 314-338
Errington RM (1969) Philopoemen Oxford
Errington RM (2008) A History of the Hellenistic World 323-30 BC Malden MA-Oxford
Forni G - Angeli Bertinelli MG (1982) Pompeo Trogo come fonte di storia ANRW II 30 2 pp 1298-1362
Franco C (1993) Trogo Giustino e i successori di Alessandro in L Braccesi - A Coppola - G Cresci Marrone - C Franco (a cura di) LrsquoAlessandro di Giustino dagli antichi ai moderni Roma pp 71-97
Gabba E (2003) Introduzione in D Foraboschi - SM Pizzetti (a cura di) La successione degli imperi e delle egemonie nelle relazioni internazionali Milano pp 7-9
Golan D (1995) The Res Graeciae in Polybius Four Studies Como
Green P (1990) Alexander to Actium The Historical Evolution of the Hellenistic Age Berkeley-Los Angeles
Gutschmid von A (1894) Die beiden ersten Buumlcher des Pompeius Trogus in A von Gutschmid - F Ruumlhl (hrsg) Kleine Schriften Leipzig pp 17-217
142 MONICA DrsquoAGOSTINI
Habicht C (1995) Athen Muumlnchen
Hammond NGL (1968) Illyris Rome and Macedon in 229-205 BC JRS 58 pp 1-21
Hammond NGL (1988) The Campaign and the Battle of Cynoscephalae in 197 BC JHS 108 pp 60-82
Heckel W (1997) Introduction (Part 2) in JC Yardley - W Heckel (eds) Ju-stin Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus Books 11-12 Alexander the Great Introduction Oxford pp 1-41
Heckel W (2012) Introduction in JC Yardley - P Wheatley - W Heckel (eds) Justin Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus II Books 13-15 The Successors to Alexander the Great Oxford pp 1-8
Huss W (1976) Untersuchungen zur Auszligenpolitik Ptolemaiosrsquo IV Muumlnchen
Huss W (2001) Aumlgypten in hellenistischer Zeit 332ndash30 v Chr Muumlnchen
Intrieri M (2011) Fra dialogo e conflitto Annibale e i Greci drsquoOccidente RStudFen 37 pp 53-82
Landucci F (2014) Filippo II e le Storie Filippiche un protagonista storico e storio-grafico in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 233-261
Landucci Gattinoni F (2011) Politica e ideologia in etagrave ellenistica laquoPolitica An-ticaraquo 1 pp 89-105
Leacutevy E (1994) Le discours drsquoAgeacutelaos de Naupacte in L Aigner Foresti - A Bar-zanograve - C Bearzot - L Prandi - G Zecchini (a cura di) Federazioni e federalismo nellrsquoEuropa antica Bergamo 21-25 settembre 1992 Milano (Alle radici della casa co-mune europea 1) pp 33-50
Longaretti L (1989) Lrsquoalleanza tra Annibale e Filippo V di Macedonia RIL 123 pp 183-192
Marasco G (1979-1980) La valutazione di Tolemeo IV Filopatore nella storiografia greca laquoSilenoraquo 5-6 pp 159-182
Mari M [- Musti D - Thornton J] (2002) Polibio Storie Volume III Libri V-VI Milano
Mariotta G (2014) Geografia e Geopolitica nelle Storie Filippiche in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 45-56
McGing B (2010) Polybiusrsquo Histories New York
McGing B (2013) Youthfulness in Polybius the case of Philip V of Macedon in B Gibson - T Harrison (eds) Polybius and his world Oxford pp 181-199
Meadows A (2013) Polybius Aratus and the History of the 140th Olympiad in B
IL DISCORSO DEL RE 143
Gibson - T Harrison (eds) Polybius and his World Essays in Honour of Frank Walbank Oxford pp 91-116
Mecca A (2001) Trogo Timagene e Polieno QS 54 pp 199-222
Meister K (1990) Die Griechische Geschichtsschreibung von den Anfaumlngen bis zum Ende des Hellenismus Stuttgart
Misch G (1949) Geschichte der Autobiographie I Frankfurt am Mein
Momigliano A (1980) Daniele e la teoria greca della successione degli imperi RAL 35 pp 157-162
Muccioli F (2013) Gli epiteti ufficiali dei re ellenistici Stuttgart (Historia Einzel-schriften 224)
Musti D (1978) Polibio e lrsquoimperialismo romano Napoli
Parmeggiani G (2011) Eforo di Cuma studi di storiografia greca Bologna
Peacutedech P (1964) La meacutethode historique de Polybe Paris
Pelling CBR [- Scardigli B - Manfredini M](1997) Plutarco Vite parallele Filopemene Tito Flaminino Milano
Richter H-D (1987) Untersuchungen zur hellenistischen Historiographie die Vorla-gen des Pompeius Trogus fuumlr die Darstellung der nachalexandrischen hellenistischen Ge-schichte (Iust 13-40) Frankfurt
Santi Amantini L (1972) Fonti e valore storico di Pompeo Trogo (Iustin XXXV e XXXVI) Genova
Santi Amantini L (1981) (a cura di) Giustino Storie Filippiche Epitome da Pom-peo Trogo Milano
Santi Amantini L (2003) Il tempo e i tempi nelle Storie Filippiche di Pompeo Tro-go RSA 33 pp 99-110
Schepens G (1983) Les rois ptolegravemaiumlques et lrsquohistoriographie Reacuteflexions sur la trans-formation de lrsquohistoire politique in E vanrsquot Dack - P van Dessel - W Van Gucht (eds) Egypt and the Hellenistic World Proceedings of the International Collo-quium Leuven 24-26 May 1982 Leuven (Studia Hellenistica 27) pp 351-368
Schlicher JJ (1933) Non-Assertive Elements in the Language of the Roman Histo-rians CPh 28 289-300
Schmitt T (1989) Die Bedeutung des zweiten Punischen Krieges fuumlr den Frieden in Naupaktos in H Devijver - E Lipinski (eds) Punic wars Proceedings of the Conference held in Antwerp from the 23th to the 26th of November 1988 in Cooperation with the Departement of History of the laquoUniversitait Antwerpenraquo UFSIA Leuven (Studia Phoenicia 10) pp 229-239
Scholten JB (2000) The Politics of Plunder Aitolians and their koinon in the early Hellenistic Era Berkeley
144 MONICA DrsquoAGOSTINI
Scuderi R (2005) Filippo V e Perseo nei frammenti diodorei in C Bearzot - F Lan-ducci (a cura di) Diodoro e lrsquoaltra Grecia Macedonia Occidente Ellenismo nella Bi-blioteca Storica Atti del convegno Milano 15-16 gennaio 2004 Milano pp 383-405
Sklenaacuter RJ (2004) Sources and Individuality in Two Passages of Livy laquoHistoriaraquo 53 pp 302-310
Sordi M (1982) Timagene di Alessandria Uno storico ellenocentrico e filobarbaro ANRW II 30 1 pp 775-797
Thornton J (2014) Le guerre macedoniche Roma
Urban R (1979) Wachstum und Kriese des achaumlischen Bundes Quellenstudien zur entwicklung des Bundes von 280 bis 222 V Chr Wiesbaden
Urban R (1982) laquoGallisches Bewusstseinraquo und laquoRomkritikraquo bei Pompeius Trogus ANRW II 30 2 pp 1424-1443
Vannicelli P (1987) Lrsquoeconomia delle Storie di Eforo RFIC 115 pp 165-191
Vattuone R (2014) Giustino e lrsquoOccidente greco I VI-V secolo aC in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 261-277
Vollmer D (1990) Symploke das Uumlbergreifen der roumlmischen Expansion auf den grie-chischen Osten Untersuchungen zur roumlmischen Aussenpolitik am Ende des 3 Jh V Chr Stuttgart
Walbank FW (1957) A Historical Commentary on Polibius I Oxford
Walbank FW (1967) A Historical Commentary on Polybius II Oxford
Walbank FW (1933) Aratos of Sicyon Cambridge
Walbank FW (2002) Η ΤΩΝ ΟΛΩΝ ΕΛΠΙΣ and the Antigonids in FW Walbank (ed) Polybius Rome and the Hellenistic World Essays and Reflections West Nyack NY pp 127-136
Weber G (1997) Interaktion Repraumlsentation und Herrschaft Der Koumlnigshof im Hel-lenismus in A Winterling (hrsg) Zwischen lsquoHausrsquo und lsquoStaatrsquo antike Houmlfe im Ver-gleich Munich pp 27-72
Will E (19822) Histoire politique du Monde Helleacutenistique II Nancy
Zecchini G (1990) La storiografia lagide in H Verdin - G Schepens - E De Keyser (eds) Purposes of History Studies in Greek Historiography from the 4th to the 2nd Centuries BC Proceedings of the International Colloquium of Leuven 24-26 May 1988 Leuven (Studia Hellenistica 30) pp 213-232
Zecchini G (2003) Polibio e la tradizione orale in A Casanova - P Desideri (a cura di) Evento racconto scrittura nellrsquoantichitagrave classica Firenze pp 123-141
Finito di stamparenel mese di novembre 2015
da LegoDigit srlLavis (TN)
140 MONICA DrsquoAGOSTINI
ABSTRACT
Philip V of Macedon was the first of the Epigonoi to face Rome Several mod-ern reconstructions of the actions and the reign of Philip V have approached it largely from a Roman point of view using as sources Polybius and where Poly-bius is lost Livy The Polybian historiographical tradition tends to portray Phil-ip V as an enemy and a tyrant impious and cruel The Macedonian king was ea-ger to establish a universal and unjust dominion over Greece Italy and beyond and Rome engaged in the first two Macedonian Wars to fight the threat of his growing ambition Nevertheless Polybiusrsquo portrayal of Philip V was affected not only by Polybiusrsquo admiration for Roman political structures military power and overwhelming conquest but also his personal Achaean origins
Looking at in book 29 and 30 of Justinrsquos Epitome of Pompeius Trogus this pa-per focuses on the non Polybian tradition on Philip V this contribution is in-deed the first analysis of the Hellenistic approach to the clash between Rome and Macedonia in the 3rd-2nd Century BC The Epitome shows a considerable di-versity of interpretation from the other sources and reflects very different views of Philip Vrsquos actions that brought him into conflict against Rome In particular these views are more evident related to the accounts of the peace negotiations of Naupactus and the battle of Cynoscephalae in the Epitome the king appears as a courageous and skilled warrior the last of the great Macedonian rulers who fell victim to misfortune This portrayal which has several common features with Appianrsquos fragments of Philip V (Mak 9) counterbalances the Roman and Achaean standpoint present in Polybius providing a more Hellenistic perspec-tive that is likely to have been rooted in a historiographical tradition connect-ed to the losing side in the struggle between Rome and the Hellenistic world
BIBLIOGRAFIA
Adler E (2006) Whorsquos Antiroman Sallust and Pompeius Trogus on Mithridates CJ 101 pp 383-407
Adler E (2011) Valorizing the Barbarians Enemy speeches in Roman Historiography Austin
Ager SL (2003) An Uneasy Balance from the Death of Seleukos to the Battle of Raph-ia in A Erskine (ed) A Companion to the Hellenistic World Oxford pp 35-50
Ager SL (2009) Roman Perspectives on Greek Diplomacy The conceptual clash Greek diplomacy of compromise and Roman Bellum Iustum in C Eilers (ed) Diplomats and Diplomacy in the Roman World Leiden-Boston pp 15-43
Alonso-Nuacutentildeez JM (1992) La Historia Universal de Pompeyo Trogo Madrid
Alonso-Nuacutentildeez JM (2002) The Idea of Universal History in Greece From Herodotus to the Age of Augustus Amsterdam
Ballesteros Pastor L (2013) Pompeyo Trogo Justino y Mitriacutedates Comentario al Epiacutetome de las Historias Filiacutepicas (3716-3881) Hildesheim-Zuumlrich-New York
IL DISCORSO DEL RE 141
Barreacute ML (1983) The God-List in the Treaty between Hannibal and Philip V of Ma-cedon a Study in Light of the Ancient Near Eastern Treaty Tradition Baltimore-Lon-don
Beck H - Eckstein A (2015) sv ldquoAratos of Sicyon (231)rdquo in I Worthington (ed) Brillrsquos New Jacoby Brill Online
Borgna A (2014) Uno sguardo originale intorno a Roma Pompeo Trogo e Giustino laquoLa Biblioteca di ClassicoContemporaneoraquo 1 pp 52-77
Cassola F (1962) I gruppi politici romani nel III secolo aC Trieste
Champion CB (1997) The Nature of Authoritative Evidence in Polybios and Agelausrsquo Speech at Naupactos TAPhA 127 pp 111-128
Champion CB (2004) Cultural Politics in Polybiusrsquo Histories Berkeley
Coppola A (1993) Demetrio di Faro un protagonista dimenticato Roma
Criscuolo L (2011) I due testamenti di Tolemeo VIII Evergete II in A Joumlrdens - J F Quack (hrsg) Aumlgypten zwischen innerem Zwist und aumluszligerem Druck Die Zeit Ptole-maios VI bis VIII Wiesbaden pp 132-150
DrsquoAgostini M (2011) Filippo V e la Storia Romana di Appiano laquoAevumraquo 85 pp 99-121
Eckstein AM (1995) Moral vision in the Histories of Polybius Berkeley
Eckstein AM (2008) Rome enters in the Greek East From Anarchy to Hierarchy in the Hellenistic Mediterranean 230-217 BC Oxford
Eckstein AM (2013) Polybius Phylarchus and Historiographical Criticism CPh 108 4 pp 314-338
Errington RM (1969) Philopoemen Oxford
Errington RM (2008) A History of the Hellenistic World 323-30 BC Malden MA-Oxford
Forni G - Angeli Bertinelli MG (1982) Pompeo Trogo come fonte di storia ANRW II 30 2 pp 1298-1362
Franco C (1993) Trogo Giustino e i successori di Alessandro in L Braccesi - A Coppola - G Cresci Marrone - C Franco (a cura di) LrsquoAlessandro di Giustino dagli antichi ai moderni Roma pp 71-97
Gabba E (2003) Introduzione in D Foraboschi - SM Pizzetti (a cura di) La successione degli imperi e delle egemonie nelle relazioni internazionali Milano pp 7-9
Golan D (1995) The Res Graeciae in Polybius Four Studies Como
Green P (1990) Alexander to Actium The Historical Evolution of the Hellenistic Age Berkeley-Los Angeles
Gutschmid von A (1894) Die beiden ersten Buumlcher des Pompeius Trogus in A von Gutschmid - F Ruumlhl (hrsg) Kleine Schriften Leipzig pp 17-217
142 MONICA DrsquoAGOSTINI
Habicht C (1995) Athen Muumlnchen
Hammond NGL (1968) Illyris Rome and Macedon in 229-205 BC JRS 58 pp 1-21
Hammond NGL (1988) The Campaign and the Battle of Cynoscephalae in 197 BC JHS 108 pp 60-82
Heckel W (1997) Introduction (Part 2) in JC Yardley - W Heckel (eds) Ju-stin Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus Books 11-12 Alexander the Great Introduction Oxford pp 1-41
Heckel W (2012) Introduction in JC Yardley - P Wheatley - W Heckel (eds) Justin Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus II Books 13-15 The Successors to Alexander the Great Oxford pp 1-8
Huss W (1976) Untersuchungen zur Auszligenpolitik Ptolemaiosrsquo IV Muumlnchen
Huss W (2001) Aumlgypten in hellenistischer Zeit 332ndash30 v Chr Muumlnchen
Intrieri M (2011) Fra dialogo e conflitto Annibale e i Greci drsquoOccidente RStudFen 37 pp 53-82
Landucci F (2014) Filippo II e le Storie Filippiche un protagonista storico e storio-grafico in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 233-261
Landucci Gattinoni F (2011) Politica e ideologia in etagrave ellenistica laquoPolitica An-ticaraquo 1 pp 89-105
Leacutevy E (1994) Le discours drsquoAgeacutelaos de Naupacte in L Aigner Foresti - A Bar-zanograve - C Bearzot - L Prandi - G Zecchini (a cura di) Federazioni e federalismo nellrsquoEuropa antica Bergamo 21-25 settembre 1992 Milano (Alle radici della casa co-mune europea 1) pp 33-50
Longaretti L (1989) Lrsquoalleanza tra Annibale e Filippo V di Macedonia RIL 123 pp 183-192
Marasco G (1979-1980) La valutazione di Tolemeo IV Filopatore nella storiografia greca laquoSilenoraquo 5-6 pp 159-182
Mari M [- Musti D - Thornton J] (2002) Polibio Storie Volume III Libri V-VI Milano
Mariotta G (2014) Geografia e Geopolitica nelle Storie Filippiche in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 45-56
McGing B (2010) Polybiusrsquo Histories New York
McGing B (2013) Youthfulness in Polybius the case of Philip V of Macedon in B Gibson - T Harrison (eds) Polybius and his world Oxford pp 181-199
Meadows A (2013) Polybius Aratus and the History of the 140th Olympiad in B
IL DISCORSO DEL RE 143
Gibson - T Harrison (eds) Polybius and his World Essays in Honour of Frank Walbank Oxford pp 91-116
Mecca A (2001) Trogo Timagene e Polieno QS 54 pp 199-222
Meister K (1990) Die Griechische Geschichtsschreibung von den Anfaumlngen bis zum Ende des Hellenismus Stuttgart
Misch G (1949) Geschichte der Autobiographie I Frankfurt am Mein
Momigliano A (1980) Daniele e la teoria greca della successione degli imperi RAL 35 pp 157-162
Muccioli F (2013) Gli epiteti ufficiali dei re ellenistici Stuttgart (Historia Einzel-schriften 224)
Musti D (1978) Polibio e lrsquoimperialismo romano Napoli
Parmeggiani G (2011) Eforo di Cuma studi di storiografia greca Bologna
Peacutedech P (1964) La meacutethode historique de Polybe Paris
Pelling CBR [- Scardigli B - Manfredini M](1997) Plutarco Vite parallele Filopemene Tito Flaminino Milano
Richter H-D (1987) Untersuchungen zur hellenistischen Historiographie die Vorla-gen des Pompeius Trogus fuumlr die Darstellung der nachalexandrischen hellenistischen Ge-schichte (Iust 13-40) Frankfurt
Santi Amantini L (1972) Fonti e valore storico di Pompeo Trogo (Iustin XXXV e XXXVI) Genova
Santi Amantini L (1981) (a cura di) Giustino Storie Filippiche Epitome da Pom-peo Trogo Milano
Santi Amantini L (2003) Il tempo e i tempi nelle Storie Filippiche di Pompeo Tro-go RSA 33 pp 99-110
Schepens G (1983) Les rois ptolegravemaiumlques et lrsquohistoriographie Reacuteflexions sur la trans-formation de lrsquohistoire politique in E vanrsquot Dack - P van Dessel - W Van Gucht (eds) Egypt and the Hellenistic World Proceedings of the International Collo-quium Leuven 24-26 May 1982 Leuven (Studia Hellenistica 27) pp 351-368
Schlicher JJ (1933) Non-Assertive Elements in the Language of the Roman Histo-rians CPh 28 289-300
Schmitt T (1989) Die Bedeutung des zweiten Punischen Krieges fuumlr den Frieden in Naupaktos in H Devijver - E Lipinski (eds) Punic wars Proceedings of the Conference held in Antwerp from the 23th to the 26th of November 1988 in Cooperation with the Departement of History of the laquoUniversitait Antwerpenraquo UFSIA Leuven (Studia Phoenicia 10) pp 229-239
Scholten JB (2000) The Politics of Plunder Aitolians and their koinon in the early Hellenistic Era Berkeley
144 MONICA DrsquoAGOSTINI
Scuderi R (2005) Filippo V e Perseo nei frammenti diodorei in C Bearzot - F Lan-ducci (a cura di) Diodoro e lrsquoaltra Grecia Macedonia Occidente Ellenismo nella Bi-blioteca Storica Atti del convegno Milano 15-16 gennaio 2004 Milano pp 383-405
Sklenaacuter RJ (2004) Sources and Individuality in Two Passages of Livy laquoHistoriaraquo 53 pp 302-310
Sordi M (1982) Timagene di Alessandria Uno storico ellenocentrico e filobarbaro ANRW II 30 1 pp 775-797
Thornton J (2014) Le guerre macedoniche Roma
Urban R (1979) Wachstum und Kriese des achaumlischen Bundes Quellenstudien zur entwicklung des Bundes von 280 bis 222 V Chr Wiesbaden
Urban R (1982) laquoGallisches Bewusstseinraquo und laquoRomkritikraquo bei Pompeius Trogus ANRW II 30 2 pp 1424-1443
Vannicelli P (1987) Lrsquoeconomia delle Storie di Eforo RFIC 115 pp 165-191
Vattuone R (2014) Giustino e lrsquoOccidente greco I VI-V secolo aC in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 261-277
Vollmer D (1990) Symploke das Uumlbergreifen der roumlmischen Expansion auf den grie-chischen Osten Untersuchungen zur roumlmischen Aussenpolitik am Ende des 3 Jh V Chr Stuttgart
Walbank FW (1957) A Historical Commentary on Polibius I Oxford
Walbank FW (1967) A Historical Commentary on Polybius II Oxford
Walbank FW (1933) Aratos of Sicyon Cambridge
Walbank FW (2002) Η ΤΩΝ ΟΛΩΝ ΕΛΠΙΣ and the Antigonids in FW Walbank (ed) Polybius Rome and the Hellenistic World Essays and Reflections West Nyack NY pp 127-136
Weber G (1997) Interaktion Repraumlsentation und Herrschaft Der Koumlnigshof im Hel-lenismus in A Winterling (hrsg) Zwischen lsquoHausrsquo und lsquoStaatrsquo antike Houmlfe im Ver-gleich Munich pp 27-72
Will E (19822) Histoire politique du Monde Helleacutenistique II Nancy
Zecchini G (1990) La storiografia lagide in H Verdin - G Schepens - E De Keyser (eds) Purposes of History Studies in Greek Historiography from the 4th to the 2nd Centuries BC Proceedings of the International Colloquium of Leuven 24-26 May 1988 Leuven (Studia Hellenistica 30) pp 213-232
Zecchini G (2003) Polibio e la tradizione orale in A Casanova - P Desideri (a cura di) Evento racconto scrittura nellrsquoantichitagrave classica Firenze pp 123-141
Finito di stamparenel mese di novembre 2015
da LegoDigit srlLavis (TN)
IL DISCORSO DEL RE 141
Barreacute ML (1983) The God-List in the Treaty between Hannibal and Philip V of Ma-cedon a Study in Light of the Ancient Near Eastern Treaty Tradition Baltimore-Lon-don
Beck H - Eckstein A (2015) sv ldquoAratos of Sicyon (231)rdquo in I Worthington (ed) Brillrsquos New Jacoby Brill Online
Borgna A (2014) Uno sguardo originale intorno a Roma Pompeo Trogo e Giustino laquoLa Biblioteca di ClassicoContemporaneoraquo 1 pp 52-77
Cassola F (1962) I gruppi politici romani nel III secolo aC Trieste
Champion CB (1997) The Nature of Authoritative Evidence in Polybios and Agelausrsquo Speech at Naupactos TAPhA 127 pp 111-128
Champion CB (2004) Cultural Politics in Polybiusrsquo Histories Berkeley
Coppola A (1993) Demetrio di Faro un protagonista dimenticato Roma
Criscuolo L (2011) I due testamenti di Tolemeo VIII Evergete II in A Joumlrdens - J F Quack (hrsg) Aumlgypten zwischen innerem Zwist und aumluszligerem Druck Die Zeit Ptole-maios VI bis VIII Wiesbaden pp 132-150
DrsquoAgostini M (2011) Filippo V e la Storia Romana di Appiano laquoAevumraquo 85 pp 99-121
Eckstein AM (1995) Moral vision in the Histories of Polybius Berkeley
Eckstein AM (2008) Rome enters in the Greek East From Anarchy to Hierarchy in the Hellenistic Mediterranean 230-217 BC Oxford
Eckstein AM (2013) Polybius Phylarchus and Historiographical Criticism CPh 108 4 pp 314-338
Errington RM (1969) Philopoemen Oxford
Errington RM (2008) A History of the Hellenistic World 323-30 BC Malden MA-Oxford
Forni G - Angeli Bertinelli MG (1982) Pompeo Trogo come fonte di storia ANRW II 30 2 pp 1298-1362
Franco C (1993) Trogo Giustino e i successori di Alessandro in L Braccesi - A Coppola - G Cresci Marrone - C Franco (a cura di) LrsquoAlessandro di Giustino dagli antichi ai moderni Roma pp 71-97
Gabba E (2003) Introduzione in D Foraboschi - SM Pizzetti (a cura di) La successione degli imperi e delle egemonie nelle relazioni internazionali Milano pp 7-9
Golan D (1995) The Res Graeciae in Polybius Four Studies Como
Green P (1990) Alexander to Actium The Historical Evolution of the Hellenistic Age Berkeley-Los Angeles
Gutschmid von A (1894) Die beiden ersten Buumlcher des Pompeius Trogus in A von Gutschmid - F Ruumlhl (hrsg) Kleine Schriften Leipzig pp 17-217
142 MONICA DrsquoAGOSTINI
Habicht C (1995) Athen Muumlnchen
Hammond NGL (1968) Illyris Rome and Macedon in 229-205 BC JRS 58 pp 1-21
Hammond NGL (1988) The Campaign and the Battle of Cynoscephalae in 197 BC JHS 108 pp 60-82
Heckel W (1997) Introduction (Part 2) in JC Yardley - W Heckel (eds) Ju-stin Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus Books 11-12 Alexander the Great Introduction Oxford pp 1-41
Heckel W (2012) Introduction in JC Yardley - P Wheatley - W Heckel (eds) Justin Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus II Books 13-15 The Successors to Alexander the Great Oxford pp 1-8
Huss W (1976) Untersuchungen zur Auszligenpolitik Ptolemaiosrsquo IV Muumlnchen
Huss W (2001) Aumlgypten in hellenistischer Zeit 332ndash30 v Chr Muumlnchen
Intrieri M (2011) Fra dialogo e conflitto Annibale e i Greci drsquoOccidente RStudFen 37 pp 53-82
Landucci F (2014) Filippo II e le Storie Filippiche un protagonista storico e storio-grafico in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 233-261
Landucci Gattinoni F (2011) Politica e ideologia in etagrave ellenistica laquoPolitica An-ticaraquo 1 pp 89-105
Leacutevy E (1994) Le discours drsquoAgeacutelaos de Naupacte in L Aigner Foresti - A Bar-zanograve - C Bearzot - L Prandi - G Zecchini (a cura di) Federazioni e federalismo nellrsquoEuropa antica Bergamo 21-25 settembre 1992 Milano (Alle radici della casa co-mune europea 1) pp 33-50
Longaretti L (1989) Lrsquoalleanza tra Annibale e Filippo V di Macedonia RIL 123 pp 183-192
Marasco G (1979-1980) La valutazione di Tolemeo IV Filopatore nella storiografia greca laquoSilenoraquo 5-6 pp 159-182
Mari M [- Musti D - Thornton J] (2002) Polibio Storie Volume III Libri V-VI Milano
Mariotta G (2014) Geografia e Geopolitica nelle Storie Filippiche in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 45-56
McGing B (2010) Polybiusrsquo Histories New York
McGing B (2013) Youthfulness in Polybius the case of Philip V of Macedon in B Gibson - T Harrison (eds) Polybius and his world Oxford pp 181-199
Meadows A (2013) Polybius Aratus and the History of the 140th Olympiad in B
IL DISCORSO DEL RE 143
Gibson - T Harrison (eds) Polybius and his World Essays in Honour of Frank Walbank Oxford pp 91-116
Mecca A (2001) Trogo Timagene e Polieno QS 54 pp 199-222
Meister K (1990) Die Griechische Geschichtsschreibung von den Anfaumlngen bis zum Ende des Hellenismus Stuttgart
Misch G (1949) Geschichte der Autobiographie I Frankfurt am Mein
Momigliano A (1980) Daniele e la teoria greca della successione degli imperi RAL 35 pp 157-162
Muccioli F (2013) Gli epiteti ufficiali dei re ellenistici Stuttgart (Historia Einzel-schriften 224)
Musti D (1978) Polibio e lrsquoimperialismo romano Napoli
Parmeggiani G (2011) Eforo di Cuma studi di storiografia greca Bologna
Peacutedech P (1964) La meacutethode historique de Polybe Paris
Pelling CBR [- Scardigli B - Manfredini M](1997) Plutarco Vite parallele Filopemene Tito Flaminino Milano
Richter H-D (1987) Untersuchungen zur hellenistischen Historiographie die Vorla-gen des Pompeius Trogus fuumlr die Darstellung der nachalexandrischen hellenistischen Ge-schichte (Iust 13-40) Frankfurt
Santi Amantini L (1972) Fonti e valore storico di Pompeo Trogo (Iustin XXXV e XXXVI) Genova
Santi Amantini L (1981) (a cura di) Giustino Storie Filippiche Epitome da Pom-peo Trogo Milano
Santi Amantini L (2003) Il tempo e i tempi nelle Storie Filippiche di Pompeo Tro-go RSA 33 pp 99-110
Schepens G (1983) Les rois ptolegravemaiumlques et lrsquohistoriographie Reacuteflexions sur la trans-formation de lrsquohistoire politique in E vanrsquot Dack - P van Dessel - W Van Gucht (eds) Egypt and the Hellenistic World Proceedings of the International Collo-quium Leuven 24-26 May 1982 Leuven (Studia Hellenistica 27) pp 351-368
Schlicher JJ (1933) Non-Assertive Elements in the Language of the Roman Histo-rians CPh 28 289-300
Schmitt T (1989) Die Bedeutung des zweiten Punischen Krieges fuumlr den Frieden in Naupaktos in H Devijver - E Lipinski (eds) Punic wars Proceedings of the Conference held in Antwerp from the 23th to the 26th of November 1988 in Cooperation with the Departement of History of the laquoUniversitait Antwerpenraquo UFSIA Leuven (Studia Phoenicia 10) pp 229-239
Scholten JB (2000) The Politics of Plunder Aitolians and their koinon in the early Hellenistic Era Berkeley
144 MONICA DrsquoAGOSTINI
Scuderi R (2005) Filippo V e Perseo nei frammenti diodorei in C Bearzot - F Lan-ducci (a cura di) Diodoro e lrsquoaltra Grecia Macedonia Occidente Ellenismo nella Bi-blioteca Storica Atti del convegno Milano 15-16 gennaio 2004 Milano pp 383-405
Sklenaacuter RJ (2004) Sources and Individuality in Two Passages of Livy laquoHistoriaraquo 53 pp 302-310
Sordi M (1982) Timagene di Alessandria Uno storico ellenocentrico e filobarbaro ANRW II 30 1 pp 775-797
Thornton J (2014) Le guerre macedoniche Roma
Urban R (1979) Wachstum und Kriese des achaumlischen Bundes Quellenstudien zur entwicklung des Bundes von 280 bis 222 V Chr Wiesbaden
Urban R (1982) laquoGallisches Bewusstseinraquo und laquoRomkritikraquo bei Pompeius Trogus ANRW II 30 2 pp 1424-1443
Vannicelli P (1987) Lrsquoeconomia delle Storie di Eforo RFIC 115 pp 165-191
Vattuone R (2014) Giustino e lrsquoOccidente greco I VI-V secolo aC in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 261-277
Vollmer D (1990) Symploke das Uumlbergreifen der roumlmischen Expansion auf den grie-chischen Osten Untersuchungen zur roumlmischen Aussenpolitik am Ende des 3 Jh V Chr Stuttgart
Walbank FW (1957) A Historical Commentary on Polibius I Oxford
Walbank FW (1967) A Historical Commentary on Polybius II Oxford
Walbank FW (1933) Aratos of Sicyon Cambridge
Walbank FW (2002) Η ΤΩΝ ΟΛΩΝ ΕΛΠΙΣ and the Antigonids in FW Walbank (ed) Polybius Rome and the Hellenistic World Essays and Reflections West Nyack NY pp 127-136
Weber G (1997) Interaktion Repraumlsentation und Herrschaft Der Koumlnigshof im Hel-lenismus in A Winterling (hrsg) Zwischen lsquoHausrsquo und lsquoStaatrsquo antike Houmlfe im Ver-gleich Munich pp 27-72
Will E (19822) Histoire politique du Monde Helleacutenistique II Nancy
Zecchini G (1990) La storiografia lagide in H Verdin - G Schepens - E De Keyser (eds) Purposes of History Studies in Greek Historiography from the 4th to the 2nd Centuries BC Proceedings of the International Colloquium of Leuven 24-26 May 1988 Leuven (Studia Hellenistica 30) pp 213-232
Zecchini G (2003) Polibio e la tradizione orale in A Casanova - P Desideri (a cura di) Evento racconto scrittura nellrsquoantichitagrave classica Firenze pp 123-141
Finito di stamparenel mese di novembre 2015
da LegoDigit srlLavis (TN)
142 MONICA DrsquoAGOSTINI
Habicht C (1995) Athen Muumlnchen
Hammond NGL (1968) Illyris Rome and Macedon in 229-205 BC JRS 58 pp 1-21
Hammond NGL (1988) The Campaign and the Battle of Cynoscephalae in 197 BC JHS 108 pp 60-82
Heckel W (1997) Introduction (Part 2) in JC Yardley - W Heckel (eds) Ju-stin Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus Books 11-12 Alexander the Great Introduction Oxford pp 1-41
Heckel W (2012) Introduction in JC Yardley - P Wheatley - W Heckel (eds) Justin Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus II Books 13-15 The Successors to Alexander the Great Oxford pp 1-8
Huss W (1976) Untersuchungen zur Auszligenpolitik Ptolemaiosrsquo IV Muumlnchen
Huss W (2001) Aumlgypten in hellenistischer Zeit 332ndash30 v Chr Muumlnchen
Intrieri M (2011) Fra dialogo e conflitto Annibale e i Greci drsquoOccidente RStudFen 37 pp 53-82
Landucci F (2014) Filippo II e le Storie Filippiche un protagonista storico e storio-grafico in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 233-261
Landucci Gattinoni F (2011) Politica e ideologia in etagrave ellenistica laquoPolitica An-ticaraquo 1 pp 89-105
Leacutevy E (1994) Le discours drsquoAgeacutelaos de Naupacte in L Aigner Foresti - A Bar-zanograve - C Bearzot - L Prandi - G Zecchini (a cura di) Federazioni e federalismo nellrsquoEuropa antica Bergamo 21-25 settembre 1992 Milano (Alle radici della casa co-mune europea 1) pp 33-50
Longaretti L (1989) Lrsquoalleanza tra Annibale e Filippo V di Macedonia RIL 123 pp 183-192
Marasco G (1979-1980) La valutazione di Tolemeo IV Filopatore nella storiografia greca laquoSilenoraquo 5-6 pp 159-182
Mari M [- Musti D - Thornton J] (2002) Polibio Storie Volume III Libri V-VI Milano
Mariotta G (2014) Geografia e Geopolitica nelle Storie Filippiche in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 45-56
McGing B (2010) Polybiusrsquo Histories New York
McGing B (2013) Youthfulness in Polybius the case of Philip V of Macedon in B Gibson - T Harrison (eds) Polybius and his world Oxford pp 181-199
Meadows A (2013) Polybius Aratus and the History of the 140th Olympiad in B
IL DISCORSO DEL RE 143
Gibson - T Harrison (eds) Polybius and his World Essays in Honour of Frank Walbank Oxford pp 91-116
Mecca A (2001) Trogo Timagene e Polieno QS 54 pp 199-222
Meister K (1990) Die Griechische Geschichtsschreibung von den Anfaumlngen bis zum Ende des Hellenismus Stuttgart
Misch G (1949) Geschichte der Autobiographie I Frankfurt am Mein
Momigliano A (1980) Daniele e la teoria greca della successione degli imperi RAL 35 pp 157-162
Muccioli F (2013) Gli epiteti ufficiali dei re ellenistici Stuttgart (Historia Einzel-schriften 224)
Musti D (1978) Polibio e lrsquoimperialismo romano Napoli
Parmeggiani G (2011) Eforo di Cuma studi di storiografia greca Bologna
Peacutedech P (1964) La meacutethode historique de Polybe Paris
Pelling CBR [- Scardigli B - Manfredini M](1997) Plutarco Vite parallele Filopemene Tito Flaminino Milano
Richter H-D (1987) Untersuchungen zur hellenistischen Historiographie die Vorla-gen des Pompeius Trogus fuumlr die Darstellung der nachalexandrischen hellenistischen Ge-schichte (Iust 13-40) Frankfurt
Santi Amantini L (1972) Fonti e valore storico di Pompeo Trogo (Iustin XXXV e XXXVI) Genova
Santi Amantini L (1981) (a cura di) Giustino Storie Filippiche Epitome da Pom-peo Trogo Milano
Santi Amantini L (2003) Il tempo e i tempi nelle Storie Filippiche di Pompeo Tro-go RSA 33 pp 99-110
Schepens G (1983) Les rois ptolegravemaiumlques et lrsquohistoriographie Reacuteflexions sur la trans-formation de lrsquohistoire politique in E vanrsquot Dack - P van Dessel - W Van Gucht (eds) Egypt and the Hellenistic World Proceedings of the International Collo-quium Leuven 24-26 May 1982 Leuven (Studia Hellenistica 27) pp 351-368
Schlicher JJ (1933) Non-Assertive Elements in the Language of the Roman Histo-rians CPh 28 289-300
Schmitt T (1989) Die Bedeutung des zweiten Punischen Krieges fuumlr den Frieden in Naupaktos in H Devijver - E Lipinski (eds) Punic wars Proceedings of the Conference held in Antwerp from the 23th to the 26th of November 1988 in Cooperation with the Departement of History of the laquoUniversitait Antwerpenraquo UFSIA Leuven (Studia Phoenicia 10) pp 229-239
Scholten JB (2000) The Politics of Plunder Aitolians and their koinon in the early Hellenistic Era Berkeley
144 MONICA DrsquoAGOSTINI
Scuderi R (2005) Filippo V e Perseo nei frammenti diodorei in C Bearzot - F Lan-ducci (a cura di) Diodoro e lrsquoaltra Grecia Macedonia Occidente Ellenismo nella Bi-blioteca Storica Atti del convegno Milano 15-16 gennaio 2004 Milano pp 383-405
Sklenaacuter RJ (2004) Sources and Individuality in Two Passages of Livy laquoHistoriaraquo 53 pp 302-310
Sordi M (1982) Timagene di Alessandria Uno storico ellenocentrico e filobarbaro ANRW II 30 1 pp 775-797
Thornton J (2014) Le guerre macedoniche Roma
Urban R (1979) Wachstum und Kriese des achaumlischen Bundes Quellenstudien zur entwicklung des Bundes von 280 bis 222 V Chr Wiesbaden
Urban R (1982) laquoGallisches Bewusstseinraquo und laquoRomkritikraquo bei Pompeius Trogus ANRW II 30 2 pp 1424-1443
Vannicelli P (1987) Lrsquoeconomia delle Storie di Eforo RFIC 115 pp 165-191
Vattuone R (2014) Giustino e lrsquoOccidente greco I VI-V secolo aC in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 261-277
Vollmer D (1990) Symploke das Uumlbergreifen der roumlmischen Expansion auf den grie-chischen Osten Untersuchungen zur roumlmischen Aussenpolitik am Ende des 3 Jh V Chr Stuttgart
Walbank FW (1957) A Historical Commentary on Polibius I Oxford
Walbank FW (1967) A Historical Commentary on Polybius II Oxford
Walbank FW (1933) Aratos of Sicyon Cambridge
Walbank FW (2002) Η ΤΩΝ ΟΛΩΝ ΕΛΠΙΣ and the Antigonids in FW Walbank (ed) Polybius Rome and the Hellenistic World Essays and Reflections West Nyack NY pp 127-136
Weber G (1997) Interaktion Repraumlsentation und Herrschaft Der Koumlnigshof im Hel-lenismus in A Winterling (hrsg) Zwischen lsquoHausrsquo und lsquoStaatrsquo antike Houmlfe im Ver-gleich Munich pp 27-72
Will E (19822) Histoire politique du Monde Helleacutenistique II Nancy
Zecchini G (1990) La storiografia lagide in H Verdin - G Schepens - E De Keyser (eds) Purposes of History Studies in Greek Historiography from the 4th to the 2nd Centuries BC Proceedings of the International Colloquium of Leuven 24-26 May 1988 Leuven (Studia Hellenistica 30) pp 213-232
Zecchini G (2003) Polibio e la tradizione orale in A Casanova - P Desideri (a cura di) Evento racconto scrittura nellrsquoantichitagrave classica Firenze pp 123-141
Finito di stamparenel mese di novembre 2015
da LegoDigit srlLavis (TN)
IL DISCORSO DEL RE 143
Gibson - T Harrison (eds) Polybius and his World Essays in Honour of Frank Walbank Oxford pp 91-116
Mecca A (2001) Trogo Timagene e Polieno QS 54 pp 199-222
Meister K (1990) Die Griechische Geschichtsschreibung von den Anfaumlngen bis zum Ende des Hellenismus Stuttgart
Misch G (1949) Geschichte der Autobiographie I Frankfurt am Mein
Momigliano A (1980) Daniele e la teoria greca della successione degli imperi RAL 35 pp 157-162
Muccioli F (2013) Gli epiteti ufficiali dei re ellenistici Stuttgart (Historia Einzel-schriften 224)
Musti D (1978) Polibio e lrsquoimperialismo romano Napoli
Parmeggiani G (2011) Eforo di Cuma studi di storiografia greca Bologna
Peacutedech P (1964) La meacutethode historique de Polybe Paris
Pelling CBR [- Scardigli B - Manfredini M](1997) Plutarco Vite parallele Filopemene Tito Flaminino Milano
Richter H-D (1987) Untersuchungen zur hellenistischen Historiographie die Vorla-gen des Pompeius Trogus fuumlr die Darstellung der nachalexandrischen hellenistischen Ge-schichte (Iust 13-40) Frankfurt
Santi Amantini L (1972) Fonti e valore storico di Pompeo Trogo (Iustin XXXV e XXXVI) Genova
Santi Amantini L (1981) (a cura di) Giustino Storie Filippiche Epitome da Pom-peo Trogo Milano
Santi Amantini L (2003) Il tempo e i tempi nelle Storie Filippiche di Pompeo Tro-go RSA 33 pp 99-110
Schepens G (1983) Les rois ptolegravemaiumlques et lrsquohistoriographie Reacuteflexions sur la trans-formation de lrsquohistoire politique in E vanrsquot Dack - P van Dessel - W Van Gucht (eds) Egypt and the Hellenistic World Proceedings of the International Collo-quium Leuven 24-26 May 1982 Leuven (Studia Hellenistica 27) pp 351-368
Schlicher JJ (1933) Non-Assertive Elements in the Language of the Roman Histo-rians CPh 28 289-300
Schmitt T (1989) Die Bedeutung des zweiten Punischen Krieges fuumlr den Frieden in Naupaktos in H Devijver - E Lipinski (eds) Punic wars Proceedings of the Conference held in Antwerp from the 23th to the 26th of November 1988 in Cooperation with the Departement of History of the laquoUniversitait Antwerpenraquo UFSIA Leuven (Studia Phoenicia 10) pp 229-239
Scholten JB (2000) The Politics of Plunder Aitolians and their koinon in the early Hellenistic Era Berkeley
144 MONICA DrsquoAGOSTINI
Scuderi R (2005) Filippo V e Perseo nei frammenti diodorei in C Bearzot - F Lan-ducci (a cura di) Diodoro e lrsquoaltra Grecia Macedonia Occidente Ellenismo nella Bi-blioteca Storica Atti del convegno Milano 15-16 gennaio 2004 Milano pp 383-405
Sklenaacuter RJ (2004) Sources and Individuality in Two Passages of Livy laquoHistoriaraquo 53 pp 302-310
Sordi M (1982) Timagene di Alessandria Uno storico ellenocentrico e filobarbaro ANRW II 30 1 pp 775-797
Thornton J (2014) Le guerre macedoniche Roma
Urban R (1979) Wachstum und Kriese des achaumlischen Bundes Quellenstudien zur entwicklung des Bundes von 280 bis 222 V Chr Wiesbaden
Urban R (1982) laquoGallisches Bewusstseinraquo und laquoRomkritikraquo bei Pompeius Trogus ANRW II 30 2 pp 1424-1443
Vannicelli P (1987) Lrsquoeconomia delle Storie di Eforo RFIC 115 pp 165-191
Vattuone R (2014) Giustino e lrsquoOccidente greco I VI-V secolo aC in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 261-277
Vollmer D (1990) Symploke das Uumlbergreifen der roumlmischen Expansion auf den grie-chischen Osten Untersuchungen zur roumlmischen Aussenpolitik am Ende des 3 Jh V Chr Stuttgart
Walbank FW (1957) A Historical Commentary on Polibius I Oxford
Walbank FW (1967) A Historical Commentary on Polybius II Oxford
Walbank FW (1933) Aratos of Sicyon Cambridge
Walbank FW (2002) Η ΤΩΝ ΟΛΩΝ ΕΛΠΙΣ and the Antigonids in FW Walbank (ed) Polybius Rome and the Hellenistic World Essays and Reflections West Nyack NY pp 127-136
Weber G (1997) Interaktion Repraumlsentation und Herrschaft Der Koumlnigshof im Hel-lenismus in A Winterling (hrsg) Zwischen lsquoHausrsquo und lsquoStaatrsquo antike Houmlfe im Ver-gleich Munich pp 27-72
Will E (19822) Histoire politique du Monde Helleacutenistique II Nancy
Zecchini G (1990) La storiografia lagide in H Verdin - G Schepens - E De Keyser (eds) Purposes of History Studies in Greek Historiography from the 4th to the 2nd Centuries BC Proceedings of the International Colloquium of Leuven 24-26 May 1988 Leuven (Studia Hellenistica 30) pp 213-232
Zecchini G (2003) Polibio e la tradizione orale in A Casanova - P Desideri (a cura di) Evento racconto scrittura nellrsquoantichitagrave classica Firenze pp 123-141
Finito di stamparenel mese di novembre 2015
da LegoDigit srlLavis (TN)
144 MONICA DrsquoAGOSTINI
Scuderi R (2005) Filippo V e Perseo nei frammenti diodorei in C Bearzot - F Lan-ducci (a cura di) Diodoro e lrsquoaltra Grecia Macedonia Occidente Ellenismo nella Bi-blioteca Storica Atti del convegno Milano 15-16 gennaio 2004 Milano pp 383-405
Sklenaacuter RJ (2004) Sources and Individuality in Two Passages of Livy laquoHistoriaraquo 53 pp 302-310
Sordi M (1982) Timagene di Alessandria Uno storico ellenocentrico e filobarbaro ANRW II 30 1 pp 775-797
Thornton J (2014) Le guerre macedoniche Roma
Urban R (1979) Wachstum und Kriese des achaumlischen Bundes Quellenstudien zur entwicklung des Bundes von 280 bis 222 V Chr Wiesbaden
Urban R (1982) laquoGallisches Bewusstseinraquo und laquoRomkritikraquo bei Pompeius Trogus ANRW II 30 2 pp 1424-1443
Vannicelli P (1987) Lrsquoeconomia delle Storie di Eforo RFIC 115 pp 165-191
Vattuone R (2014) Giustino e lrsquoOccidente greco I VI-V secolo aC in C Bearzot - F Landucci (a cura di) Studi sullrsquo Epitome di Giustino I Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia Milano pp 261-277
Vollmer D (1990) Symploke das Uumlbergreifen der roumlmischen Expansion auf den grie-chischen Osten Untersuchungen zur roumlmischen Aussenpolitik am Ende des 3 Jh V Chr Stuttgart
Walbank FW (1957) A Historical Commentary on Polibius I Oxford
Walbank FW (1967) A Historical Commentary on Polybius II Oxford
Walbank FW (1933) Aratos of Sicyon Cambridge
Walbank FW (2002) Η ΤΩΝ ΟΛΩΝ ΕΛΠΙΣ and the Antigonids in FW Walbank (ed) Polybius Rome and the Hellenistic World Essays and Reflections West Nyack NY pp 127-136
Weber G (1997) Interaktion Repraumlsentation und Herrschaft Der Koumlnigshof im Hel-lenismus in A Winterling (hrsg) Zwischen lsquoHausrsquo und lsquoStaatrsquo antike Houmlfe im Ver-gleich Munich pp 27-72
Will E (19822) Histoire politique du Monde Helleacutenistique II Nancy
Zecchini G (1990) La storiografia lagide in H Verdin - G Schepens - E De Keyser (eds) Purposes of History Studies in Greek Historiography from the 4th to the 2nd Centuries BC Proceedings of the International Colloquium of Leuven 24-26 May 1988 Leuven (Studia Hellenistica 30) pp 213-232
Zecchini G (2003) Polibio e la tradizione orale in A Casanova - P Desideri (a cura di) Evento racconto scrittura nellrsquoantichitagrave classica Firenze pp 123-141
Finito di stamparenel mese di novembre 2015
da LegoDigit srlLavis (TN)