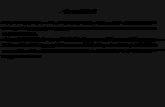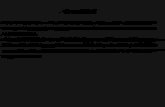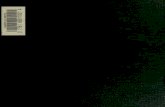Centro Nazionale Malattie Rare
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Centro Nazionale Malattie Rare
Centro Nazionale Malattie Rare
Le terapie non convenzionali in Italia:
i primi dati
Formazione continua:sperimentazione
e prospettive all’ISS
Bollettino Epidemiologico Nazionale
ISSN 0394-9303Post
e Ita
liane
S.p
.A.-
Spe
dizi
one
in a
bbon
amen
to p
osta
le a
rtic
olo
2 co
mm
a 20
/c le
gge
662/
96 -
Rom
a
Volume 14 - Numero 7/8Luglio/Agosto 2001
E d i t o r i a l e
Vo
l. 14- n
. 7/8 - Lug
lio/A
go
sto 2001
Centro NazionaleMalattie Rare . . . . . . . . . . . . . 3
Le terapie non convezionali in Italia: i primi dati . . . . . . . 11
Formazione continua: sperimentazionee prospettive all’ISS . . . . . . . 15
Il convegno del mese . . . . . 18
Bookmark . . . . . . . . . . . . . . 20
BENFocolaio epidemico di salmonellosi in una scuola materna . . . . . . . iSalute, autonomia e integrazione sociale degli anziani nel comune di Caltanissetta - 2001 . . . . ii
La molteplicità e la multidisciplinarie-tà delle attività in Istituto hanno portato,in questo numero, a dare spazio a due ar-gomenti tra loro distanti: il Registro na-zionale delle Malattie Rare, istituito pres-so l’ISS e il Progetto terapie non conven-zionali, coordinato dall’Istituto, volto acondurre una valutazione ponderata su un“fenomeno” che, in quest’ultimo decen-nio, interessa sempre più da vicino ancheil nostro Paese.
Presso l'Istituto operano numerosi Regi-stri epidemiologici per la sorveglianza di spe-cifiche patologie che rappresentano sistemiinformativi in grado di monitorare l'anda-mento e le dimensioni di alcune patologiein Italia, di programmare per esse un effica-ce intervento sanitario, confrontandosi conquanto già realizzato in altri Paesi e in am-bito internazionale. Solo per citarne alcuni,ricordiamo il Registro nazionale AIDS, il Re-gistro nazionale degli ipotiroidei congeniti,Registro nazionale della legionellosi, il Re-gistro nazionale della malattia di Creutz-feldt-Jakob e sindromi correlate, il Registronazionale e regionale del sangue e del pla-sma, il Sistema epidemiologico integratodell'epatite virale acuta (SEIEVA). All'attivi-tà istituzionale di monitoraggio e sorve-glianza, è spesso associata un'attività di ri-cerca poiché la qualità stessa dei Registri èin grado di promuovere studi collaborativi,diretti a migliorare le conoscenze relative al-la patologia di riferimento.
Al di là degli obiettivi specifici per cuisono stati istituiti, tali Registri, coordinatidall'Istituto, oltre a essere il punto di rac-cordo tra Centri regionali e interregionalie a operare nell’ambito di specifici proget-ti europei, rappresentano una significativafonte di informazione, vista la facilità concui sono reperibili i dati in Internet (nel si-
to dell’Istituto), anche per i non addet-ti ai lavori.
Direttore responsabile: Enrico GaraciVice Direttore: Franco PiccinnoRedattore capo: Paola De Castro
Redazione: Carla Faralli, Lorenza Scotti, Alessandro SpurioProgetto grafico: Eugenio Morassi, Franco Timitilli
Grafica: Cosimo Marino CurianòComposizione e distribuzione: Giovanna Morini, Patrizia Mochi
Sviluppo versione Web (http://www.iss.it/notiziario): Marco Ferrari, Stefano Guderzo
Istituto Superiore di SanitàPresidente: Enrico Garaci - Direttore generale: Romano R. Di Giacomo
Viale Regina Elena, 299 - 00161 RomaTel. 0649901 - Fax 0649387118
e-Mail: [email protected] - Sito Web: http://www.iss.itTelex 610071 ISTSAN I - Telegr. ISTISAN - 00161 Roma
Iscritto al n. 475/88 del 16 settembre 1988. Registro Stampa Tribunale di Roma© Istituto Superiore di Sanità 2001
Numero chiuso in redazione il 30 luglio 2001Stampa: Chicca - Tivoli
IV Programma nazionale di ricerca sull’AIDS . . . . . . . 19Epatite B in Italia: a che punto siano a 10 annidall’introduzione della vaccinazione di massa . . . . .19
Centro Nazionale Malattie Rare
Le terapie non convenzionali in Italia:
i primi dati
Formazione continua:sperimentazione
e prospettive all’ISS
Bollettino Epidemiologico Nazionale
ISSN 0394-9303Post
e Ita
liane
S.p
.A.-
Spe
dizi
one
in a
bbon
amen
to p
osta
le a
rtic
olo
2 co
mm
a 20
/c le
gge
662/
96 -
Rom
aVolume 14 - Numero 7/8
Luglio/Agosto 2001
S o m m a r i o
e Malattie Rare (MR) sono de-finite sulla base di una bassa
prevalenza nella popolazio-ne e il loro numero è sti-
mato dall’Organizzazione Mondia-le della Sanità intorno a 5 000.
I problemi connessi conqueste patologiesono molti, a co-minciare dall’ar-bitrarietà delladefinizione.
Il limite dioccorrenza nellap o p o l a z i o n e ,unico elemento di definizio-ne della condizione di “rari-tà” risulta diverso nei vari Paesi.
Il Congresso degli Stati Uniti hafissato la soglia di 200 000 casi nel-la popolazione totale, mentre il Par-lamento Europeo ha definito un li-mite di prevalenza non superiore a5 casi su 10 000 abitanti nella po-polazione europea.
Nel nostro Paese, il Ministerodella Sanità ha elaborato il Regola-mento di istituzione della Rete Na-zionale delle Malattie Rare e di esen-zione dalla partecipazione al costodelle relative prestazioni sanitarieper circa 350 MR (DM 18 maggio2001, n. 279, GU n. 160, del12.07.2001 Suppl. Ord. n. 180/L).
Questo documento, disegna larete clinico-epidemiologica delleMR, che si articola in Presidi ac-creditati e in Centri interregionalidi riferimento, proponendo unagestione unitaria e integrata delproblema.
I Centri interregionali provve-deranno all’invio di dati epidemio-logici all’Istituto Superiore di Sani-tà (ISS) per implementare il Regi-stro Nazionale MR.
L’accomunare tali patologie sot-to la dicitura “Malattie Rare” ha leseguenti motivazioni:
• la rarità: da tale caratteristica di-pendono in parte le difficoltà deipazienti a ottenere una diagnosiappropriata e tempestiva e untrattamento idoneo. In particola-
re, i percorsi diagnostico-tera-peutici sono complicati dall’esi-
guo numero distrutture sanitariee operatori sanita-ri (e spesso dallaloro non omoge-nea distribuzionesul territorio na-zionale) in grado
di fornire risposte soddisfacentiai bisogni di salute di pazienti af-fetti da MR. Ciò è dovuto al fat-to che la risposta deve esseredi alto livelloqua l i ta t ivo :queste malat-tie necessitanodi un'assisten-za ultraspecia-listica, volen-do intenderecon ciò il pos-sesso e l’utiliz-zo di conoscenze che van-no oltre la formazione sulpiano teorico (le MR spesso nonsono trattate sui libri di medici-na) e l’esperienza clinica non so-lo di base ma anche specialistica.La scarsa disponibilità di cono-scenze scientifiche, che scaturiscedalla rarità, determina spesso lun-
ghi tempi di latenza tra esordiodella patologia e diagnosi che in-cidono negativamente sulla pro-gnosi del paziente. La difficoltà acondividere esperienze clinichedetermina invece criteri diagno-stici fortemente disomogenei. Lararità incide anche sulle possibili-tà della ricerca clinica, in quantola valutazione di nuove terapie è
spesso resa difficoltosa dall’esi-guo numero di pazienti arruo-
labili nei trial cli-nici. Il ricorso auna casistica mul-ticentrica può,inoltre, diminuirela qualità dellostudio, in quantoi criteri di recluta-mento e tratta-mento possono
essere disomogenei;• la numerosità: nel loro insieme
le MR rappresentano circa il10% delle patologie umane co-nosciute e interessano comples-sivamente una frazione impor-tante della popolazione, ciòmotiva interventi di sanità pub-blica comuni e coordinati;
Centro Nazionale Malattie Rare
Domenica Taruscio1, Antonella Allegritti1, Giuliano D’Agnolo2,Cristina D’Ippolito3, Vincenzo Falbo1, Giovanna Floridia1,
Donato Greco3, Giulia Grilli1, Natalia Mancino1,Cesarina Marongiu4, Tarcisio Niglio4
Valeria Patriarca3, Chiara Pescucci1, Paolo Salerno1,Moges Seyoum Ido1, Marco Salvatore1,
Maria Antonietta Stazi3 e Fabrizio Tosto1
1 Centro Nazionale Malattie Rare, Laboratorio di Ultrastrutture2 Laboratorio di Biologia Cellulare
3 Laboratorio di Epidemiologia e Biostatistica4 Servizio Elaborazione Dati
Domenica Taruscio
Vo
l. 14
- n
. 7/8
- L
ug
lio/A
go
sto
200
1
Le Malattie Rare stimate nel mondo
sono circa 5 000
Il 10% delle patologie oggi conosciute è rappresentato da Malattie Rare
• la natura genetica: la maggiorparte di queste patologie è ge-neticamente determinata e ciòinduce a comuni approcci diprevenzione (individuazione deifattori di rischio, screening deiportatori, ecc.), di diagnosi (dif-fusione e validazione delle tec-niche di genetica molecolare ecitogenetica), di trattamento(scarsità di opzioni terapeutichevalide) e infine di riabilitazione(prevenzione e controllo degliesiti invalidanti);
• il contenuto emotivo dei pa-zienti e dei loro familiari: questivivono un’esperienza doppia-mente dolorosa rappresentata siadalla condizione morbosa chedalla condizione di solitudine, le-gata quest’ultima alla scarsità diconoscenze scientificamente dis-ponibili (“poco si conosce sullamia malattia”) e professional-mente utilizzabili (“il mediconon (ri)conosce la mia malattia”).Per questi motivi le MR sono
spesso definite "orfane", intendendocon ciò prive di risorse e attenzioni.
In realtà i due appellativi forsenon sono utilizzabili indifferente-mente e ciò in ragione dei seguen-ti motivi:• la rarità è una misura quantita-
tiva, che può quindi essereespressa direttamente attraversoun valore numerico, mentre lacondizione di orfana, che rap-presenta in definitiva la diffi-
coltà del Sistema Sanitario Na-zionale a rispondere adeguata-mente ai bisogni di salute deipazienti affetti dalla malattia co-sì definita, non è direttamentemisurabile. È altresì possibiledefinire degli indicatori cheesprimano le carenze assisten-ziali riferite a una specifica ma-lattia (incidenza/prevalenza del-la malattia e distribuzione dellestrutture sanitarie in grado dieffettuare diagnosi, trattamentoe riabilitazione, flussi assisten-ziali, ritardo diagnostico, ecc.);
• non tutte le MR sono “orfane”:per alcune di queste patologiele risorse e le attenzioni sono no-tevoli. Ad esempio, nel nostroPaese, la sorveglianza delle mal-formazioni congenite ha avutoin questi ultimi anni una note-vole espansione che si è realizza-ta anche nell’attività di alcuniRegistri sia regionali che inter-regionali che consentono la sor-veglianza di circa 250 000 na-scite all’anno che, seppur nonuniformemente distribuite, rap-presentano il 45% dei nati nelnostro Paese. La fenilchetonuriae l’ipotiroidismo congenito so-no MR sottoposte a screeningneonatale obbligatorio e que-st’ultima è soggetta a un sistemadi sorveglianza imperniato sul-l’attività di un Registro Nazio-nale (Registro degli ipotiroideicongeniti) istituito presso l’ISS.
L'ATTIVITÀ DEL CENTRO NAZIONALEMALATTIE RARE
Gli obiettivi del Centro Nazio-nale Malattie Rare (CNMR), atti-vato all'interno dell'ISS, sono i se-guenti:• realizzazione del Registro Na-
zionale MR;• attività di ricerca;• standardizzazione e assicurazio-
ne di qualità dei test genetici;• attività connesse con i farmaci
orfani;• formazione degli operatori sani-
tari, miglioramento dei rappor-ti fra le istituzioni, i cittadini ele associazioni dei pazienti e deifamiliari;
• collegamento nazionale (IRCCS,università, altri istituto di ricerca,ospedali, ecc.) e internazionalecon altre strutture pubbliche chesi occupano di MR (Network ofPublic Health Institutions onRare Diseases - NEPHIRD ecollaborazione con i Centers forDisease Control and Prevention,Atlanta-USA, EMEA - Commit-tee for Orphan Medicinal Pro-ducts e Organizzazione Mondia-le della Sanità).
INDAGINE CONOSCITIVALe attuali attività del CNMR
sono state precedute da un’inda-gine conoscitiva effettuata nel1999-2000, svolta allo scopo diottenere indicazioni sulla distri-buzione nel territorio nazionale direclutamenti/archivi/registri dipatologie rare.
L’individuazione di 600 strut-ture (Centri diagnostici, Centri te-rapeutici, Associazioni di pazien-ti/famiglie, Associazioni di volon-tariato, Istituti di ricerca, Osserva-tori epidemiologici, ecc.) che per leloro caratteristiche erano poten-zialmente in possesso di dati sani-tari organizzati su pazienti affetti daMR è stata effettuata sulla base difonti multiple (Ministero della Sa-nità, ISS, Guida ai Servizi Sanitari,Internet, Guida Monaci, ecc.).
Vo
l. 14- n
. 7/8 - Lug
lio/A
go
sto 2001
Vo
l. 14
- n
. 7/8
- L
ug
lio/A
go
sto
20
01
Le strutture individuate sonostate invitate a compilare una sche-da (Scheda Indagine Conoscitiva)per segnalare la presenza di recluta-menti/archivi/registri di MR (ogruppi di queste) e a inviarla al-l'ISS, per fax e per posta.
Su un totale di 563 strutturecontattate, hanno aderito all’inizia-tiva 239 centri, con una rispon-denza del 42,4% (239/563).
Complessivamente, 144 strut-ture hanno riferito della presenza didati sanitari organizzati su pazientiaffetti da MR e inviato i relativi da-ti richiesti, mentre 95 strutturehanno riferito di non possedere re-clutamenti/archivi/registri delle pa-tologie oggetto di questa indagine.
In totale, 1 350 schede (ognunadelle quali riporta un sistema orga-nizzato di dati sanitari) sono statearchiviate presso l'ISS. Sono staterilevate circa 600 patologie rare ogruppi di patologie (Tabella 1).
Nella Figura 1 è evidenziata ladistribuzione delle patologie segna-late in base alla classificazione ICD-IX-CM, mentre nella Tabella 2 èriportata la distribuzione regionaledei reclutamenti/archivi/registri.
IL REGISTRO NAZIONALEMALATTIE RARE
L’istituzione presso l’ISS del Re-gistro Nazionale MR (DM del24.04.2000, GU n. 131 del7.06.2000 e DM 18 maggio 2001,n. 279, GU n. 160, del 12.07.2001Suppl. Ord. n. 180/L) ha lo scopodi ottenere informazioni epidemio-logiche (in primo luogo il numerodi casi di una determinata malattiae relativa distribuzione sul territo-rio) utili a definire le dimensionidel problema.
Il Registro è uno strumento perdefinire la prevalenza/incidenzadelle MR, identificare i possibilifattori di rischio, supportare la ri-cerca clinica e promuovere il con-fronto tra operatori sanitari per ladefinizione di criteri diagnostici.Fornirà, inoltre, elementi utili all’i-dentificazione delle priorità relative
agli interventi di sanità pubblicavolti al miglioramento della quali-tà dell'assistenza ai pazienti.
In questa fase di attività, vieneproposta la Scheda di arruolamen-to definitiva (cfr. p. 6), che derivada una elaborazione di quella pre-sentata su questo stesso Notiziario(Vol. 13 - n. 8).
La Scheda, che si propone di ri-levare i casi incidenti di MR a par-tire da gennaio 2001, è divisa indue parti.
Nella prima (Parte A) vengonorilevati: i dati anagrafici del pa-ziente in forma contratta (primedue lettere del cognome e primedue lettere del nome) e alcuni datidi interesse socio-economico, qua-li il grado di istruzione e la profes-sione del paziente o dei genitori
qualora il paziente abbia un’età in-feriore a 25 anni.
Nella seconda parte (Parte B)vengono registrati i dati sanitari:nome della malattia, gli esamidiagnostici effettuati, la data diesordio della sintomatologia, ladata della diagnosi e i criteri dia-gnostici utilizzati per la definizio-ne di caso.
Oltre a dati di incidenza e/oprevalenza, la Scheda di arruola-mento si propone di acquisire in-formazioni relativamente alle ri-sorse impiegate nella diagnosi, itempi di latenza tra esordio dellasintomatologia e diagnosi, l'utiliz-zazione di criteri diagnostici nelladefinizione di caso.
Le due parti della Scheda di ar-ruolamento (A e B) vengono mante-
Tabella 1 - Indagine conoscitiva: risposta delle strutture coinvolte nel-l’indagine
Strutture contattate 563
Strutture che hanno aderito all’iniziativa 239 (239/563, 42,4%)
Strutture che hanno inviato dati all’ISS 144
Strutture che hanno riferito di non possedere dati sanitari organizzati 95
Schede che riportano il possesso di dati sanitari organizzati 1 350
Numero di patologie rilevate 600
���
���
��������
�����
����� ��� �������� ���������� ��� ������������ ���������� � ������� ���������
������
����� �� ������ � ���� ������ ����������
����� �� ������ ������� � ���� ������ �� �����
����� �� ������ ����������
������������ ��������
���
Figura 1 - Distribuzione delle malattie rilevate nel corso dell’indagine co-noscitiva. Classificazione ICD-IX-CM
Parte A
a1) Data di compilazione . . . . . . . . . . . .
Compilatore
a2) Cognome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a3) Nome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a4) Telefono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a5) Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a6) E-mail . . . . . . . . . . . . . . .
a7) Ente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a8) Divisione o Reparto o UO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a9) Indirizzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a10) CAP a11) Città . . . . . . . . . . . . . . . .
Dati paziente
a12) (prime due lettere del Cognome) a13) (prime due lettere del nome)
a14) Sesso (M/F) a15) Anno di nascita
a16) Comune di nascita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a17) Prov. a18) Stato . . . . . . . . . . . . . . . . .
a19) Comune di residenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a20) Prov. a21) CAP
a22) Scolarità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a23) Professione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Se il paziente ha meno di 25 anni:
a24) Scolarità paterna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a25) Professione paterna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a26) Scolarità materna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a27) Professione materna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vo
l. 14- n
. 7/8 - Lug
lio/A
go
sto 2001
(*) La raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati secondo la normativa vigente (Legge 675/96 e successi-ve integrazioni). Avvertenza: si rammenta che nella Parte B della scheda non è consentito riportare alcun elemento identificativodel paziente.N.B. È possibile scaricare la scheda direttamente dal sito: www.malattierare.iss.it
Scheda di arruolamento*
Arruolamento di singoli casi per la realizzazione del Registro Nazionale Malattie Rare
in collaborazione con i Registri già operanti sul territorio
Vo
l. 14
- n
. 7/8
- L
ug
lio/A
go
sto
20
01
Parte B
b1) Data di compilazione . . . . . . . . . . . .
b2) Codice scheda MR . . . . . . . . . . . . . .
Compilatore
b3) Cognome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b4) Nome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b5) Telefono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b6) Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b7)E-mail . . . . . . . . . . . . . . .
b8) Ente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b9) Divisione o Reparto o UO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b10) Indirizzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b11) CAP . . . . . . . . . . b12) Città . . . . . . . . . . . . .
B13) Nome della “Malattia rara”
Esami effettuati sul paziente
b14) Esame clinico (elencare segni e sintomi correlati alla patologia)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b15) Esami strumentali Neg. Pos. Dubbio
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b16) Esami di laboratorio
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b17) Data di esordio della patologia . . . . . . . . . . . . . b18) Data diagnosi . . . . .
b19) Ente reparto che ha effettuato la diagnosi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Definizione di caso (indicare i criteri clinici e/o strumentali e/o di laboratorio che sono utilizzati nella sua strut-tura per formulare la diagnosi della patologia descritta)
b20) Criteri clinici:
b21) Criteri strumentali:
b22) Criteri di laboratorio:
nute separate in tutte le fasi del trat-tamento dei dati (trasmissione, ar-chiviazione ed elaborazione), rispon-dendo alle disposizioni di legge dellanormativa vigente (Legge 675/96 esuccessive integrazioni) per la tuteladella riservatezza del paziente.
Infine, è stata elaborata un’ap-propriata nota informativa per ilpaziente in collaborazione con ilservizio di consulenza sulla Legge675/96 attivo presso l’ISS. Lo sco-po di questo documento è di espli-citare ai soggetti coinvolti le finali-tà e le modalità del trattamento deiloro dati sanitari e anagrafici, i sog-getti ai quali possono essere tra-smessi, i diritti dell'interessato e lecoordinate del responsabile deltrattamento dei dati.
L’ATTIVITÀ DI RICERCAÈ evidente che l'intervento sa-
nitario nei confronti delle MR de-ve essere migliorato grazie a un in-cremento delle conoscenze scienti-fiche. Le numerose lacune conosci-tive, la diversificazione presente al-l'interno delle MR e la presenza dinumerose specializzazioni settoria-li impongono un approccio inter-disciplinare. È indispensabileun'interazione fra metodologie,
culture e linguaggi degli ambiti ge-netico, clinico, farmacologico, epi-demiologico, ecc. La diversità del-le specializzazioni coinvolte e la nu-merosità dei centri con specifichecompetenze richiedono sforzi co-ordinati per affrontare le grandiquestioni relative alle MR. È im-portante che l'ISS promuova atti-vità di ricerca scientifica orientan-dola su priorità di sanità pub-blica ben definite.
Attualmente,l’attività dell’ISSè volta a studisperimentali siasu meccanismidi regolazionegenica nell’uo-mo (geni hPER1e SYB2), sia suanalisi di alterazioni geneti-che in tumori rari (mesote-liomi, tumori del pancreas, linfomimaligni).
Sono in fase di avvio ulterioristudi su altre patologie rare selezio-nate, quali narcolessia, sindrome diRett, sindrome di Moebius, sin-drome di Ondine. Ciò verrà realiz-zato in collaborazione con centri dieccellenza nazionali e internaziona-li impegnati nei vari settori.
PROGETTO NAZIONALE PER LA STANDARDIZZAZIONEE L’ASSICURAZIONE DI QUALITÀ DEI TESTGENETICI
Data l’importanza delle patolo-gie genetiche nell’ambito delle MRe l’uso crescente di test genetici, èfondamentale sviluppare e garanti-re criteri e parametri per l’assicura-zione di qualità di questi strumen-ti diagnostici.
Il Progetto nazionale per la stan-dardizzazione e l’assicurazione diqualità dei test genetici (DLvo502/92 art.12, comma 2, lettera a) sipropone, su base volontaria dei la-boratori partecipanti, di garantire laverifica dei controlli per assicurare lavalidità, l’accuratezza, la precisione,la riproducibilità dei test genetici giàin uso sul territorio nazionale.
I continui progressi delle tecni-che di genetica molecolare e il se-quenziamento quasi totale delDNA umano hanno portato all’i-dentificazione di molti geni re-sponsabili di malattia o di aumen-tata suscettibilità di malattia. Ciòha condotto allo sviluppo di nu-merosi test genetici, molti dei qua-li sono già correntemente in uso
nella pratica clinica e utilizza-ti routinariamente in diagnosi
prenatale e post-natale. È prevedi-bile che la gam-ma dei test gene-tici si allarghi fi-no a modificareprofondamente ilpanorama delladiagnostica e del-
la clinica attuali.Tale sviluppo richiederà cau-
tela e verifiche sperimentali dellaqualità dei test genetici; le variantimetodologiche riportate in lettera-tura devono essere sottoposte a unaattenta validazione interlaboratorio,allo scopo di individuare i protocol-li più affidabili e più efficienti. Inol-tre, occorre che i metodi selezionatisiano resi più idonei all’uso clinicoattraverso protocolli standardizzati,
Vo
l. 14- n
. 7/8 - Lug
lio/A
go
sto 2001
Il giusto approccio per affrontare
le patologie rare è di carattere
interdisciplinare
Tabella 2 - Distribuzione regionale dei reclutamenti/archivi/registri rilevatinel corso dell’indagine conoscitiva 1999-2000
Regione Frequenza Percentuale Percentuale cumulativa
Lombardia 362 26,81 26,81Liguria 130 9,63 36,44Lazio 124 9,19 45,63Puglia 120 8,89 54,52Sardegna 119 8,81 63,33Abruzzo 92 6,81 70,14Emilia-Romagna 79 5,85 75,99Campania 73 5,41 81,40Toscana 69 5,11 86,56Veneto 68 5,04 91,55Piemonte 63 4,67 96,22Calabria 22 1,63 97,85Friuli-Venezia Giulia 16 1,19 99,04Marche 5 0,37 99,41Sicilia 4 0,30 99,71Trentino-Alto Adige 3 0,22 99,93Umbria 1 0,07 100,00
Totale 1 350 100,00 -
che ne siano valutati i criteri di ap-plicazione e che vengano definiti icriteri per la realizzazione di un si-stema di assicurazione di qualità.
Attualmente in Italia vi è un cer-to divario quali-quantitativo tra i la-boratori che eseguono test genetici;tale divario potrebbe ulteriormenteaccentuarsi nel tempo generandoprofonde differenze sul territorionazionale rispetto alla disponibilitàdi test sicuri ed efficaci.
Il Progetto dell’ISS si colloca trale linee prioritarie del Piano Sanita-rio Nazionale 1998-2000 che, nel-l’obiettivo “Portare la sanità italianain Europa”, pone l’accento sulla ne-cessità di interventi finalizzati all’a-deguamento della rete dei laborato-ri diagnostici ai principi di qualità,efficacia ed efficienza.
Il Progetto si articola nelle se-guenti attività:• assicurazione di qualità dei test
genetici (citogenetica e geneticamolecolare) eseguiti nei labora-tori partecipanti;
• elaborazione di raccomandazioniper un programma permanentedi assicurazione di qualità dei testgenetici che dovrà estendersialla formazione del perso-nale, allestrutture deilaboratori eai loro pro-grammi in-terni ed ester-ni di control-lo di qualità;
• diffusione diun’informazione tecnicaadeguata, disponibilitàdi standard idonei e armonizza-zione dei metodi utilizzati neilaboratori diffusi sul territorionazionale.Il Progetto è cominciato a livel-
lo operativo all’inizio del 2001; co-involge 80 laboratori pubblici di-stribuiti su tutto il territorio nazio-nale ed è attualmente incentrato sulcontrollo esterno di qualità dei se-guenti test genetici: test di geneticamolecolare per la diagnosi di fibro-
si cistica, di sindrome X-fragile, dibeta-talassemia e di poliposi adeno-matosa familiare e per il controlloesterno di qualità in citogeneticanella diagnosi prenatale, postnatalee oncologica.
FARMACI ORFANIUno dei problemi delle MR è la
mancanza di terapie adeguate lega-ta alla difficoltà di riuscire a trova-re farmaci efficaci. La ricerca clini-ca risulta difficile: i pazienti sonopochi e distribuiti in vaste aree geo-
grafiche, ma la difficoltà mag-giore è dovuta a un fattore
economico. Infat-ti, per ottenerenuovi farmaci ènecessario investi-re nella ricerca cli-nica e nella speri-mentazione. LeMR hanno unnumero esiguo di
malati, se considerate singolar-mente, e pertanto non hanno un
mercato sufficientemente ampioper lo sviluppo dei farmaci. Il far-maco per le MR rimane perciò sen-za sponsor, cioè orfano.
Allo scopo di far fronte a parte diquesti problemi, sono state poste inatto varie normative nei diversi Pae-si: negli USA l’Orphan Drug Act(1983), in Giappone l’Orphan DrugLegislation (1993), a Singapore l’Or-phan Legislation (1997) e in Austra-lia l’Orphan Legislation (1998).
Il riconoscimento europeo delreale problema dei farmaci orfani siè avuto con la regolamentazione(CE n. 141/2000) del ParlamentoEuropeo e del Consiglio dell'Unio-ne Europea. Successivamente si so-no stabilite le disposizioni di appli-cazione dei criteri previsti per l'as-segnazione della qualifica di medi-cinale orfano nonché la definizionedei concetti di medicinale "simile"e "clinicamente superiore", con ilregolamento CE n. 847/2000 dellaCommissione.
Sulla base di questo regolamen-to è stato istituito il Committee forOrphan Medicinal Products(COMP) che è preposto alla desi-gnazione dei farmaci orfani.
L’interesse e la volontà di concen-trare, non solo a livello europeo mamondiale, l’attenzione sulle MR e suifarmaci orfani fa sì che i pazienti af-fetti da MR possano usufruire deibenefici derivanti dalle nuove terapiema anche dalle migliori possibilità diprevenzione e diagnosi.
In Italia, il CNMR, nell’obietti-vo di voler migliorare la qualità del-la vita dei pazienti affetti da MR, sipropone di diffondere le informa-zioni riguardanti le patologie rare ei farmaci orfani, tramite il sito-web.
Tra le attività del CNMR, svol-te in questo ambito, si evidenzianoin modo particolare quelle relativeall’inventario dei farmaci orfani ecensimento dei trial clinici esisten-ti sul territorio nazionale.V
ol.
14-
n. 7
/8 -
Lu
glio
/Ag
ost
o
2001
Il Centro NazionaleMalattie Rare
ha creato il sito-web:www.malattierare.iss.it
LA FORMAZIONEDEGLI OPERATORI SANITARI E I RAPPORTI CON I CITTADINI E LE ASSOCIAZIONI
Il CNMR è impegnato in atti-vità di formazione degli operatorisanitari attraverso la realizzazionedi corsi, convegni, congressi eworkshop.
L'impegno tende a rag-giungere il du-plice scopo disensibilizzare glioperatori sanita-ri alle problema-tiche propriedelle MR (diffi-coltà diagnosticae quindi necessi-tà di condividere le sceltediagnostiche e terapeutichecon altri colleghi) e di promuovereil confronto su specifiche patologieallo scopo di diffondere i progressiin ambito medico.
Infine, il Centro svolge attività distudio e documentazione finalizzataa rispondere ai quesiti dei cittadini.
L' impegno a fornire un’infor-mazione chiara ed esaustiva è resocomplesso dalla difficile reperibi-lità delle informazioni stesse.
Nel sito web del CNMR è pre-sente uno spazio specifico dove èpossibile consultare un elenco del-le Associazioni dei pazienti e deifamiliari con relativo indirizzo, re-capito telefonico e indirizzo di po-sta elettronica, suddiviso per re-gione.
NETWORK OF PUBLICHEALTH INSTITUTIONS RARE DISEASES (NEPHIRD)
Il Progetto NEPHIRD, coor-dinato dall'ISS (Responsabilescientifico: D. Taruscio), è fi-nanziato dalla Commissione Eu-ropea nell'ambito delle azioni disanità pubblica intraprese a favo-re delle MR.
NEPHIRD rappresenta un net-work a cui collaborano 15 Pae-
si europei, il cui scopo prin-
cipale è di realizzare modelli per laraccolta di dati epidemiologici sul-le MR, mediante il confronto diesperienze e iniziative tra le istitu-zioni di sanità pubblica dei Paesipartecipanti.
Come prima fase, è in corso unostudio conoscitivo sulle iniziative disanità pubblica intraprese nei Paesi
partecipanti.Si prevede come risultato in-
termedio la defi-nizione di alcuniaspetti metodolo-gici riguardanti il"minimum dataset", la copertura,la qualità dei datie i flussi informa-tivi; il risultato fi-
nale sarà l’elaborazione di rac-comandazioni e/o linee guida a li-
vello europeo.Nell’ambito del portale web de-
dicato alle MR, un sito è dedicato alprogetto NEPHIRD (http://-www.cnmr.iss.it/NEPHIRD/in-dex.htm. Questo spazio potrà esse-re utile per diffondere informazio-ni raccolte sulle MR e facilitare lacollaborazione internazionale, traoperatori di sanità pubblica, asso-ciazioni di pazienti e organizzazio-ni non profit.
CONCLUSIONILe diverse attività del CNMR,
condividono gli obiettivi relativi almiglioramento e alla diffusione del-le conoscenze scientifiche e dellaqualità della vita dei pazienti affet-ti da MR.
Sarà possibile raggiungere questiobiettivi se le strategie di sanitàpubblica terranno conto della "ra-rità" di queste patologie.
Il nostro sistema sanitario ri-sponde con più facilità ai bisogni disalute più frequenti anche perché, aprescindere dall'allocazione delle ri-sorse, risulta quasi naturale unamaggiore prontezza nella risposta aeventi consueti.
Noi riteniamo che le attività del-l’Istituto possano contribuire a da-re risposte appropriate a un proble-ma che è complessivamente impo-nente e che richiede un uso rilevan-te di risorse.
Riferimenti bibliografici
Decision No. 1295/1999/EC of the Eu-ropean Parliament and Council of 29April 1999 (Official Journal L 155,22/06/1999 p. 0001).
Taruscio D, Cerbo M. Ann Ist Super Sa-nità, 1999; 35(2): 237-44.
Taruscio D, Paradisi S, Zamboni G, et al.Genes Chromosomes Cancer 2000; 28:294-9.
Taruscio D, Zoraqi GK, Falchi M, et al.Gene 2000; 253: 161-70.
Regolamento (CE) N. 141/2000 del Par-lamento Europeo e del Consiglio del 16Dicembre 1999 concernente i medicina-li orfani - O.J. L018 22.01.2000: 1-5.
Regolamento (CE) N. 847/2000 dellaCommissione del 27 Aprile 2000 “Asse-gnazione della qualifica di Medicinale Or-fano nonché la definizione dei concetti diMedicinale "Simile" e "Clinicamente Su-periore" - O.J. L103 28.04.2000: 5-8.
Per ulteriori informazioni consultare il sito:
www.malattierare.iss.it
Vo
l. 14- n
. 7/8 - Lug
lio/A
go
sto 2001
In briefNational Centre for Rare Diseases
Diseases are defined “rare” if they have a low prevalence. In Europe adisease affecting fewer than 5 individuals out of 10,000 people is consi-dered rare. Rare diseases (RD) are grouped together because they: 1) arenumerous, accounting for 10% of all diseases known today, 2) often needa highly specialised care, 3) are mostly of genetic origin and 4) are sociallyvisible. To address the problems related to RD, a National Centre for RareDiseases is established within the National Health Institute (Istituto Supe-riore di Sanità). This article present the different activities carried out bythe Centre.
Il Progetto NEPHIRD,dedicato alle Malattie
Rare, coinvolge 15 Paesi europei
Inse
rto
BEN
- N
oti
ziar
io IS
S V
ol.
14-
n. 7
/8 -
Lu
glio
/Ag
ost
o 2
001
Studi dal territorio
FOCOLAIO EPIDEMICO DI SALMONELLOSI IN UNA SCUOLA MATERNA
Il Servizio di Epidemiologia e Pre-venzione (SEP) della ASL Napoli 4,tra il 5 e il 10 aprile 2001, ha rice-vuto cinque notifiche di casi di sal-monellosi di gruppo D, tutte relati-ve a bambine di San Giuseppe Ve-suviano (26 636 abitanti), di etàcompresa tra i tre e i cinque anni.Le notifiche provenivano da ospe-dali appartenenti ad ASL diverse do-ve le bambine erano state ricovera-te; quattro casi frequentavano dueclassi di una stessa scuola materna.La data di insorgenza dei sintomiera stata nel fine settimana tra il 30marzo e il 2 aprile.
Il giorno 9 aprile il SEP si è atti-vato per condurre un'indagine epi-demiologica al fine di verificare lapresenza di un focolaio epidemico,le sue dimensioni e identificare ilveicolo di infezione. L'indagine haraccolto ulteriori informazioni suicasi notificati e si è concentrata sul-la possibile esposizione comune al-la mensa scolastica di 4 dei 5 casinotificati. Il giorno 11 è stata con-tattata la scuola materna pochigiorni prima della chiusura per levacanze di Pasqua (15 aprile). Nonè stato possibile prelevare campio-ni di alimenti, né di ingredienti uti-lizzati nelle due settimane prece-denti. Dalla scuola è stato ottenu-to l’accesso ai registri scolastici difrequenza, gli elenchi dei 120 iscrit-ti con i relativi recapiti e i menù deipasti serviti nei giorni immediata-mente precedenti l'insorgenza deisintomi dei casi. Sono state intervi-state le mamme dei bambini as-senti per più di due giorni tra la fi-ne di marzo e l’inizio di aprile peridentificare ulteriori casi. I genitoridelle due classi in cui si erano veri-ficati i casi sono stati intervistati trail 24 e il 26 aprile circa le preferen-ze alimentari dei loro figli.
Ai fini della descrizione del fo-colaio epidemico è stato definito“caso” ogni bambino residente nelcomune che tra il 20 marzo e l’8aprile aveva presentato diarrea (al-meno tre scariche al giorno) con al-meno uno dei seguenti sintomi:febbre � 38°C, dolori addominali,nausea o vomito.
Sono stati così identificati 19casi. Tutti avevano presentato diar-rea (100%), febbre elevata (79%),dolori addominali (58%) e nau-sea/vomito (21%), tra il 30 marzoe il 2 aprile. La curva epidemica in-dica che tutti i casi hanno manife-stato sintomi nel giro di 4 giorni,periodo di tempo compatibile conun'esposizione puntiforme da fon-te comune e il tempo di incubazio-ne per salmonellosi. In base allacurva epidemica è presumibile chel'esposizione sia avvenuta nei gior-ni 28, in cui era stata servita unafrittata fatta con circa 100 uova, o29 marzo, in cui erano state servi-te polpette di pollo di preparazioneindustriale.
I ceppi di salmonella identifica-ti negli ospedali non erano staticonservati e quindi è stata impossi-bile un'ulteriore caratterizzazionedel batterio. L'anamnesi alimenta-re dei casi ospedalizzati non avevafornito alcuna informazione utileall’individuazione dell’alimento so-spetto, e le interviste alle mammedei bambini delle due classi sonostate scarsamente informative conrisposte poco discriminanti, impe-dendo di formulare qualsiasi ipote-si sul veicolo della malattia.
Solo l'associazione temporale(tutti i casi si sono ammalati a di-stanza di poche ore o giorni), diluogo e di persona (quattro bam-bini della stessa età, stesso sesso,frequentanti la stessa scuola ma-terna), ha permesso di identificareil focolaio epidemico ed evidenzia-
re la probabile esposizione comu-ne alla mensa scolastica, dal mo-mento che i casi avevano condivisopasti comuni solo a scuola. Diversifattori hanno, invece, contribuitoalla mancata identificazione delveicolo, della fonte dell'infezione edella modalità di trasmissione.Quello più rilevante è senz’altro ilritardo nella segnalazione dei casirispetto all’inizio della malattia,che, da un lato non ha consentitodi raccogliere informazioni suffi-cienti sui cibi consumati poco pri-ma dell'inizio dei sintomi, dall’altrodi reperire campioni di alimenti perl’identificazione del veicolo. Inoltre,la conduzione dell'indagine ha sof-ferto per i tempi necessari all’otte-nimento di informazioni utili daparte della scuola e perché si è svol-ta a cavallo delle festività pasquali.Il ritardo è anche probabilmente lacausa della inattendibilità delle ri-sposte date dalle mamme in occa-sione delle interviste, condottequando l'episodio epidemico eraormai sotto controllo e quindi c'e-ra minore interesse a collaborare.
Infine, i laboratori ospedalieri,principalmente interessati all’iden-tificazione del microrganismo ai fi-ni della terapia, hanno sottovaluta-to l’importanza della sierotipizza-zione finalizzata alla sorveglianzaepidemiologica, per cui non hannoconservato le colture.
Questa indagine però ha evi-denziato soprattutto il gap esisten-te tra l'attuale livello organizzativoe i potenziali interventi di controlloe quindi ha fornito l’occasione peridentificare i punti da potenziare: • migliorare due aspetti della sor-
veglianza delle malattie tra-smesse da alimenti nella regio-ne Campania: la tempestivitàdella segnalazione rendendopiù efficiente il flusso informati-vo e la sensibilità, aumentando
Maria Grazia Panico (Servizio di Epidemiologia, ASL Napoli 4), Benvon Cotter(Laboratorio di Epidemiologia e Biostatistica, ISS) e Emilio Russo (Distretto Sani-tario n. 79 ASL Napoli 4)
la propensione alla notifica daparte dei medici di famiglia e in-cludendo segnalazioni direttedai laboratori di microbiologia;
• ripristinare il laboratorio di rife-rimento regionale per la sorve-glianza delle salmonelle, per ef-fettuare la sierotipizzazione;
• promuovere la collaborazionetra medici di famiglia, operato-ri di sanità pubblica e operatoricommerciali diffondendo l’in-formazione sui focolai che si ve-rificano e sui risultati delle in-dagini epidemiologiche.
Il commentoStefania SalmasoLaboratoriodi Epidemiologia e Biostatistica
Le salmonellosi costituiscono unimportante problema di sanità pub-blica nei Paesi industrializzati, es-sendo le salmonelle tra i patogenipiù frequentemente responsabili diepidemie di origine alimentare (1).Gli alimenti che più frequentemen-te agiscono da veicolo dell'infezio-ne sono carni, pollame, uova e i lo-ro derivati che, se contaminati al-l'origine e non sottoposti a un ade-guato trattamento termico, costi-tuiscono un terreno di crescita idea-le per i batteri. L'espansione dellaristorazione collettiva e dell'utilizzodi alimenti commerciali pronti damangiare ha anche contribuito alladiffusione di salmonelle da veicoliinusuali: è recente la segnalazionedi nove casi di salmonellosi associa-ti a consumo di insalata confezio-nata pronta al consumo (2).
La conoscenza dell'agente ezio-logico e dei determinanti di conta-minazione sono elementi essenzia-li per l’adozione delle misure dicontrollo e la prevenzione di ulte-riori analoghi episodi.
In Italia ogni anno vengono no-tificati circa 10 000 casi di salmo-nellosi non tifoidee e circa 700 fo-colai epidemici di malattie infettiveda alimenti (3).
È opinione comune che questovalore sottostimi di molto la realeincidenza di epidemie di origine ali-mentare, che spesso si verificano inambito familiare, oppure non sonoindagate microbiologicamente edepidemiologicamente.
L’indagine dei colleghi della ASLNapoli 4, a partire dalla notifica di
quattro casi, ha individuato un fo-colaio che aveva coinvolto 19 bam-bini di una scuola materna, ma nonha raggiunto evidenze conclusivesull’alimento in causa né sul modoin cui questo era stato contamina-to né su eventuali errori nella pre-parazione e conservazione.
Vale ancora la pena indagare gliepisodi di tossinfezione alimenta-re, considerato che l’indagine è im-pegnativa in termini di tempo e ri-sorse? È utile dare diffusione ai rap-porti sui focolai, ancorché noncompletamente esplicativi? La ri-sposta a entrambi i requisiti è af-fermativa per le seguenti ragioni:• la salmonellosi è una malattia
potenzialmente severa e puòcausare morte; inoltre, può pro-vocare importanti perdite eco-nomiche sia per le cure medi-che che per costi indiretti, com-presi perdite per gli esercizicommerciali coinvolti;
• se il veicolo è un alimento com-merciale, l’indagine è essenzia-le per identificarlo e interrom-pere la trasmissione;
• l’individuazione dell’alimento incausa e di errori nella prepara-zione o conservazione rappre-senta un’informazione preziosaper alimentaristi e consumatori,in quanto è possibile saperequali sono i cibi la cui prepara-zione e conservazione necessitadi maggior attenzione, peresempio il tiramisù (4);
• l’individuazione della salmonel-la, la sua tipizzazione come sie-ro e/o fagotipo consente di con-trollare la diffusione geograficadelle salmonelle. L’episodio riportato era tecnica-
mente difficile da indagare, in quan-to ha riguardato bambini molto pic-coli, nell’approssimarsi delle feste diPasqua, quest’anno prolungate dal-la vicinanza del 25 aprile.
Ciononostante, l'indagine hamesso in luce numerose disfunzio-ni del sistema di segnalazione econtrollo in caso di focolaio.
Sembra particolarmente impor-tante il richiamo alla tempestivitàdella segnalazione, ma anche ai tem-pi di reazione, che sono cruciali peril successo di qualsiasi indagine diun'epidemia.
Quando si decide di intervenire ènecessario farlo in breve tempo: l’in-dagine è una gara contro il tempo.
Più tempo passa e più difficile è tro-vare residui alimentari, avere la listadei potenzialmente esposti, e menoprobabile che costoro ricordino ciòche hanno mangiato.
Una seconda considerazione èche l’intervento nelle tossinfezionialimentari è una "guerra che si pre-para in tempo di pace". La macchi-na organizzativa per affrontare un'e-pidemia deve essere messa a punto,rodata e mantenuta in assenza diepidemia, perché al momento op-portuno le capacità di successo sia-no massime. Alcuni rapporti devonoessere ben funzionanti: quello con illaboratorio di microbiologia, quellotra epidemiologi, igienisti degli ali-menti e veterinari. Infatti, un’indagi-ne può considerarsi veramente utilequando oltre all’alimento in causavengono ricostruite tutte le fasi del-la preparazione degli alimenti: dal-l’approvvigionamento delle materieprime, fino al consumo e individuatii punti di maggior rischio per la con-taminazione.
Alla fine, la documentazione sulfocolaio deve essere diffusa a tutticoloro che sono interessati: alimen-taristi, operatori si sanità pubblica ecoloro che hanno la responsabilitàdella segnalazione. Questo è il solomodo per far comprendere in prati-ca che la segnalazione e l’indagineservono per tutelare la salute.
Riferimenti bibliografici
1. WHO. Controllo della salmonellosi: ilruolo dell'igiene degli animali e deiprodotti di origine animale. Schedeinformative n. 2/91.
2. O’Brien S, Fisher I. EurosurveillanceWeekly 2001; 6: 010628 (http://www.eurosurv.org/2001/010628.html)
3. Ministero della Sanità. Bollettino Epi-demiologico Nazionale. Infezioni etossinfezioni alimentari (http://www.sanita.it/sanita/malinf/bollepid/indice.asp).
4. Panico MG, Primiano F, Nappi F, etal. Eurosurveillance 1999; 4: 47:8.
SALUTE, AUTONOMIA E INTEGRAZIONE SOCIALEDEGLI ANZIANI NEL COMUNE DI CALTANISSETTA - 2001
Negli ultimi decenni, in Italia, èaumentata la proporzione degli an-ziani: nel 1990 gli ultra sessantacin-quenni erano il 15%, nel 1999 era-no il 18%, nel prossimo decennio
Inserto
BEN
- No
tiziario ISS V
ol. 14
- n. 7/8 - Lu
glio
/Ag
osto
2001
Inse
rto
BEN
- N
oti
ziar
io IS
S V
ol.
14-
n. 7
/8 -
Lu
glio
/Ag
ost
o 2
001
questo valore è destinato a crescerefino al 21%. Questo fenomeno tro-va le sue origini nella riduzione del-la natalità e in una consistente ridu-zione della mortalità per tutte le cau-se, già evidenziata in letteratura apartire dalla fine degli anni ’70 (1).
L’invecchiamento della popola-zione ha conseguenze di tipo so-ciale ed economico. L’età è il prin-cipale determinante della salute e,dopo i 65 anni, progressivamenteall’aumentare dell’età, aumenta ilrischio di morte, di malattia, di di-sabilità con conseguente perditadell’autonomia e isolamento socia-le (1). Pertanto, una consistentefetta delle risorse del Servizio Sani-tario Nazionale e cioè il 37% dei ri-coveri ospedalieri (2) e il 50% del-la spesa farmaceutica (3) è desti-nata a favore degli anziani.
In risposta ai mutamenti demo-grafici, è stato redatto il ProgettoObiettivo Anziani (POA), un docu-mento allegato al Piano SanitarioNazionale 1998-2000, che indivi-dua le strategie che Regioni e ASLpossono adottare per migliorare lecondizioni di vita di questa partevulnerabile della popolazione.
I dati sulle condizioni di salutedegli anziani in Italia sono scarsi,pertanto, nell’ambito del corso “Epi-demiologia in azione”, svoltosi nelmaggio 2001 a Caltanissetta, si èpensato di realizzare un’indaginecon lo scopo di descrivere lo stato disalute, il livello di autosufficienza e laqualità dell’inserimento sociale de-gli anziani, fornendo così, alla pro-grammazione locale, dati attuali sul-le condizioni di vita degli anziani.
A tal fine è stato estratto dalle li-ste anagrafiche del comune di Calta-nissetta un campione casuale di 233anziani di età uguale o superiore a 70anni. Ciascun individuo selezionato èstato abbinato al proprio medico difamiglia. Informazioni sullo stato disalute e mentale, i bisogni di assi-stenza e le malattie di cui era affettol’assistito sono state raccolte attra-verso un questionario inviato ai me-dici curanti prima dell’inizio dell’inda-gine. Nei giorni 11-18 maggio 2001,i partecipanti al corso, dopo una se-duta di addestramento, hanno inter-vistato a domicilio gli anziani arruola-ti, utilizzando il questionario ADL (Ac-tivities of Daily Living) che indaga sul-
la possibilità di svolgere le attività del-la vita quotidiana primarie (muoversida una stanza all’altra, lavarsi, farsi ilbagno o la doccia, vestirsi, mangiare,andare al bagno da solo), il questio-nario IADL (Instrumental Activities ofDaily Living) che indaga sulle attivitàstrumentali (prepararsi da mangiare,rassettare la casa, portare buste dellaspesa, ecc.); inoltre, sono state ag-giunte alcune domande per valutareil livello di integrazione nella famigliae nella comunità.
In base alle risposte al questio-nario ADL è stato calcolato l’indicedi Katz (4) e gli esaminati sono sta-ti classificati in autosufficienti (ingrado di effettuare da soli tutte leattività della vita quotidiana), par-zialmente dipendenti (incapaci dieffettuare almeno un’attività dellavita quotidiana, escludendo il fare ilbagno e/o vestirsi), disabili (incapa-ci, oltre a lavarsi o vestirsi, di anda-re al bagno da soli e/o spostarsi dauna stanza all’altra, e/o mangiare,e/o essere incontinenti). Sono staticonsiderati “socialmente non isola-ti” coloro che nelle ultime due set-timane avevano avuto contatti an-che solo telefonici al di fuori delproprio nucleo di conviventi.
I dati sono stati analizzati con ilsoftware epidemiologico EPI INFO,per calcolare le prevalenze percentualie i relativi intervalli fiduciali al 95% .
In totale, l’81% del campione èstato intervistato. Il 56% era rappre-sentato da donne e il 44% da uomi-ni con età mediana di 76 anni; que-sta distribuzione era simile a quella
della popolazione, di età uguale osuperiore a 70 anni residente in Cal-tanissetta. Il 95% aveva frequentatoalcune classi della scuola elementaree il 98% aveva il telefono.
La maggior parte degli anzianisoffriva di malattie croniche e neces-sitava di farmaci e controlli medici re-golari. Le 5 patologie più frequentierano l’osteoartrosi (71%), l’iperten-sione (59%), la broncopneumopatiacronico ostruttiva (BPCO; 30%), lecardiopatie (27%) e il diabete (16%).Il 94% era stato visitato dal propriomedico curante almeno una voltanell’arco dell’ultimo anno.
I risultati relativi al grado di au-tosufficienza, per l’intera popola-zione e per gruppo di età, sono ri-portati nella Figura. In condizioni digrave dipendenza era il 22% degliesaminati (IC95%: 16-28), ma con-siderando gli ultra ottantenni que-sta percentuale arrivava al 50%(IC95%: 36-64). Tra gli anziani au-tosufficienti era rara la mancanzadi autonomia nelle attività di tipostrumentale, tranne l’incapacità aeseguire lavori di casa pesanti.
Per gli anziani con dipendenzalieve o grave, la famiglia rappresen-tava la principale fonte di sostegnoe aiuto (Tabella). In misura minoregli anziani ricevevano aiuto, per pra-ticare le terapie abituali, da perso-nale a pagamento. Dai dati raccoltiil ruolo di supporto svolto dagli entiterritoriali appare minore.
Il 26% viveva da solo, il 45%con il coniuge o con persone dellastessa generazione, il 29% con i fi-
�
�
!
"
#���� ���������� $���� ����������
% &" ���� ' " ����
Figura - Anziani non autosufficienti per età (Caltanissetta, 2001)
gli. Queste proporzioni si modifica-no in base al livello di autonomia:solo il 6% degli anziani gravemen-te dipendente viveva da solo, men-tre il 42% viveva con i figli e il 37%con il coniuge o i fratelli.
Le persone non autosufficientierano più spesso isolate: infatti i 24anziani (13%) che avevano dichiara-to di non avere avuto negli ultimi 15giorni rapporti sociali al di fuori del-la casa, neanche telefonici, erano incondizioni di non autosufficienza.
Il commentoSimona GiampaoliLaboratoriodi Epidemiologia e Biostatistica
I risultati dell’indagine non sonorappresentativi della realtà italiana,in quanto provengono da una po-polazione anziana residente in uncomune; pur tuttavia fanno partedi un campione di popolazione ge-nerale, pertanto possono suscitarealcune considerazioni.
Negli ultra settantenni il 22%non è autosufficiente. Il rischio diperdita dell’autonomia è alto al disopra degli 80 anni (50%), mentretra i 70 e gli 80 anni il 54% degli an-ziani è completamente autonomo, il36% ha una dipendenza lieve e il re-stante 10% non è autosufficiente.
Gli anziani autonomi o lieve-mente dipendenti possono costi-tuire, come afferma il POA, un’im-portante risorsa: è possibile stimo-lare il protagonismo di questogruppo per sviluppare aggregazio-ni sociali volte a ridurre l’isolamen-to e a favorire l’auto-aiuto. Gli osta-coli alla comunicazione sono scarsi,gran parte di loro è in grado di leg-gere, scrivere e telefonare.
Dal punto di vista della salute,sia da parte dell’anziano, che daparte del medico di medicina ge-nerale, esiste una sorta di accetta-zione della malattia come inevita-bile conseguenza dell'età, mentreanche in età avanzata molto si puòfare in termini di prevenzione pri-maria e secondaria. Si tratta diadottare stili di vita adeguati, im-plementando attività fisica, sce-gliendo una sana alimentazione,abolendo l’abitudine al fumo e, lad-dove non basta lo stile di vita, at-tuando un adeguato controllo far-macologico. Le malattie più fre-quenti sono quelle cardiovascolari,in particolare l’ipertensione arterio-sa, il diabete, la BPCO, la catarattae i problemi oculari, la sordità, ladepressione e le malattie mentali,l’ipertrofia prostatica: su queste pa-tologie i medici di medicina gene-rale devono avere sicure compe-tenze e realizzare senza esitazionele possibili terapie; è infatti ormainoto che esistono terapie efficaci eben tollerate anche negli anziani.
I bisogni degli anziani con disabi-lità sono di due tipi: l’aiuto per i la-vori domestici e l’integrazione socia-le. L’assistenza per i bisogni primari equella infermieristica riguardano unaminoranza di anziani; quelli con gra-ve perdita dell’autonomia, secondole informazioni raccolte dai medici difamiglia, sono intorno al 10%.
L’assistenza agli anziani vienesvolta prevalentemente dalla fami-glia. Questo è sicuramente un puntodi forza per la pianificazione dei ser-vizi, ma il carico assistenziale della fa-miglia può diventare troppo alto; per-tanto è di fondamentale importanzatrovare opportune modalità per so-stenere le persone coinvolte, che so-
no in genere di età media e sulle qua-li spesso gravano le richieste prove-nienti sia dai figli che dai genitori an-ziani. Interventi efficaci possono es-sere orientati alla costituzione di cen-tri anziani specializzati e attrezzati incui gli anziani possano trascorrereparte della giornata ed essere impe-gnati in semplici attività, oppure percoloro che hanno maggiore difficol-tà, nell’organizzazione di adeguataassistenza domiciliare. In questo mo-do viene favorito lo sviluppo dei rap-porti sociali che andrebbero al di là diquelli rappresentati dai familiari o daivicini di casa.
Riferimenti bibliografici
1. Maggi S, Farchi G, Crepaldi G. Epi-demiologia della cronicità in Italia.In: Rapporto Sanità 2001. Ed. Falci-telli N, Trabucchi M, Vanara F. Bo-logna: Il Mulino; 2001. p. 103-21.
2. Ministero della Sanità. http://www.sanita.it/sdo/Dati99/indicatoriDo-manda.xls (p. 74)
3. Giuseppe Traversa (comunicazionepersonale)
4. Katz S, Downs TD, Cash HR, et al.Geronotologist 1970; 10: 20-30.
Partecipanti al corso “Epidemiologiain azione”: M.P. Antonietti (Aosta), G.Battistella (Treviso), A. Battisti (Roma), N.Bertozzi (Cesena), L. Busani (Roma), R.Candura (Trapani), P. Capriani (Roma), N.Casuccio (Palermo), S. Coccioli (Lucca), C.Culotta (Genova), A. D' Argenzio (S. Ma-ria C.V.), A. De Togni (Ferrara), S. Di Noia(Bari), L. Drogo (Caltanissetta), G. Ferrera(Ragusa), O. Frongia (Oristano), C. Man-cini (Ancona), L. Marinaro (Alba), F. Mi-chieletto (Venezia), G. Modolo (Torino), G.Montagano (Potenza), M. Morbidoni (An-cona), A. Nastri (Tremestieri Etneo), A.Pasquale (Città Di Castello), R. Passatem-po (Recanati), R. Pizzuti (Napoli), D. Pro-tano (Caserta), C. Raffaelli (Viareggio), M.Salaris (Rimini), S. Sammarco (Palermo), P.Vaccaro (Raffadali), L. Zanzani (Rimini), F.Zappia (Marina Siderno)Staff: M. Ciccozzi, A. Bella, P. D’Arge-nio, N. Binkin (Laboratorio di Epidemio-logia e Biostatistica, ISS), G. Salamina(Servizio di Epidemiologia ASL Gruglia-sco - Torino)
Tabella - Bisogni e fonte di assistenza per gli anziani non autosufficienti (Cal-tanissetta, 2001)
Fonte di assistenza Lavarsi Rassettare Terapie Pratichela casa abituali amministrative
n. (%) n. (%) n. (%) n. (%)
Personale Comune 2 (3) 10 (7) 0 (0) 1 (1)Personale ASL 13 (17) 0 (0) 2 (2) 0 (0)Personale a pagamento 0 (0) 65 (43) 14 (14) 6 (5)Familiari 61 (79) 73 (48) 60 (59) 105 (84)Vicini 1 (1) 2 (1) 9 (9) 6 (5)Altro 0 (0) 2 (1) 16 (16) 6 (5)
Totale 77 (100) 152 (100) 101 (100) 124 (100)
Inserto
BEN
- No
tiziario ISS V
ol. 14
- n. 7/8 - Lu
glio
/Ag
osto
2001
Donato Greco,Nancy Binkin, Paolo D’Argenio
Comitato editoriale BEN
Full English version is available at:www.ben.iss.it
e-Mail: [email protected]
el corso degli ultimi de-cenni si stanno diffon-dendo nel mondo occi-dentale in maniera
sempre più evidente vari tipi ditrattamenti, rimedi e filoso-fie terapeuti-che adottaticome cure peruna serie nontrascurabile diproblemi e dis-turbi clinici.Questo insie-me di pratiche,molto articolato, viene tal-volta denominato nel suo com-plesso con termini vari: medicinealternative, complementari, inte-grative, tradizionali, non ortodos-se, olistiche, naturali, dolci, ecc.
Il principale elemento comunea questi approcci, eterogenei e avolte conflittuali tra loro, è il fattodi avere radici e ispirazioni estraneeal modello adottato dalla modernamedicina scientifica, consideratocome paradigma di riferimento neiPaesi occidentali.
Il termine che più probabil-mente, per via della sua neutrali-tà, connota meglio questo uni-verso è "non convenzionale" in-tendendo con questo terminepratiche che non sono integratenel modello di cura dominante,in quanto non completamente inaccordo con esso per ragioni diordine culturale, scientifico, me-dico ed economico.
Dalla volontà di condurre unavalutazione ponderata di questo fe-nomeno dai contorni complessi ènato il Progetto terapie non con-venzionali coordinato dall’IstitutoSuperiore di Sanità.
I principali obiettivi di questoprogetto sono:• raccogliere sistematicamente
informazioni che consentanodi analizzare e comprende-re i presupposti e le moti-
vazioni delcrescente uti-lizzo delle te-rapie nonconvenzionalinella popola-zione;• identificare estudiare possi-
bili aree di rischio per la salute;• raccogliere tutti gli elementi og-
gettivamente verificabili in me-rito a efficacia, sicurezza e qua-lità di queste pratiche definen-do degli standard metodo-logici di riferimento perla loro valu-tazione.
Complessiva-mente il Pro-getto dovreb-be, alla suaconclusione,offrire una ba-se scientifica sucui discutereper poter meglio definireuna strategia nazionale in questosettore.
LE RAGIONI PER UN APPROFONDIMENTO
Nell’affrontare la questione dicome la moderna medicina scien-
tifica possa confrontarsi con que-ste pratiche, cercando di inqua-drare il problema in un contestodi razionalità e di tutela dei dirit-ti e della salute dei cittadini, unodei primi passi è certamente quel-lo di caratterizzare quella parte dipopolazione che ricerca in questepratiche una possibile risposta aipropri problemi di salute, identi-ficandone anche le motivazioni.Per queste ragioni, una parte im-portante del Progetto, i cui primirisultati sono di seguito descrittiriguarda la necessità di stimarel’entità del fenomeno in Italia,
delineandone, nel contem-po, le principali caratteristi-
che. L’occasio-ne nasce dallacollaborazionetra l’IstitutoSuperiore diSanità e l’I-STAT, graziealla quale nel-l ’ i n d a g i n e"Condizioni
di salute e ricorso ai servizi sa-nitari" condotta su un campionedi 60 000 famiglie (pari a circa140 000 individui) una specificasezione del questionario è statamodificata, rispetto alle prece-denti versioni, per poter racco-gliere elementi conoscitivi più
Vo
l. 14
- n
. 7/8
- L
ug
lio/A
go
sto
20
01
Le terapie non convenzionali
in Italia: i primi dati
Roberto Raschetti1, Francesca Menniti-Ippolito1,Emanuela Forcella1, Emanuela Bologna2,
Gabriella Sebastiani2 e Linda Laura Sabbadini2
1 Laboratorio di Epidemiologia e Biostatistica, Istituto Superiore di Sanità2 Servizio Struttura e Dinamica Sociale, ISTAT
Nel mondo occidentale si sta diffondendo semprepiù il ricorso alle terapie
non convenzionali
L’ISS coordina il Progettoterapie non convenzionali
volto a valutare il complesso fenomenodelle medicine naturali
F. Menniti Ippolito
dettagliati sul ricorso degli italia-ni alle terapie non convenzionali.
Tale indagine per le sue dimen-sioni, per la tecnica di raccolta deidati, per la ricchezza delle informa-zioni raccolte rappresenta la più im-portante finora condotta a livellointernazionale.
In questa nota sono illustrati iprimi dati descrittivi del fenome-no relativamente alle interviste ef-fettuate nei mesi settembre-di-cembre 1999 a 30 000 famiglie(oltre 70 000 individui), presen-tati ufficialmente il 18 aprile2001 nel corso di una riunioneche si è svolta presso l’Istituto Su-periore di Sanità.
LA FREQUENZA E LA DISTRIBUZIONE DELL’USO DELLE TERAPIENON CONVENZIONALI IN ITALIA
Sono circa 9 milioni, pari al15,6 % della popolazione, gli ita-liani che hanno fatto ricorso ad al-meno una terapia non convenzio-nale nel triennio 1997-99. La tera-pia più utilizzata è l’omeopatia, se-guita dai trattamenti manuali(osteopatia e chiropratica) e dalla fi-toterapia (Figura 1).
Già nella precedente indaginecondotta dall’ISTAT nel 1994 eracontenuta una domanda sull’uso di
terapie alternative nei tre anniprecedenti l’intervista.
Confrontando i dati dell’ultimaindagine con quelli relativi al trien-nio 1992-94, notiamo un notevoleincremento. Considerando solo l'o-meopatia, l’agopuntura e la fitote-rapia si è passati dall'8,3% del 1994al 12% nel 1999 (i dati del trien-nio 1992-94 non comprendono in-formazioni relative ai trattamentimanuali e “altre” terapie).
Sulla base dei pochi dati dispo-nibili a livello internazionale (deri-vanti da tipologie di studi molto di-verse, spesso di piccole dimensionie non campionari), si stima che ol-tre un quarto della popolazione eu-ropea avrebbe fatto ricorso almenouna volta, nell’arco di un anno, a
un tipo qualsiasi di terapia nonconvenzionale. L’Italia, dunque, sisituerebbe ai livelli più bassi rispet-to agli altri Paesi occidentali.
QUALI UTILIZZATORI?Anche in Italia, come in altri
Paesi europei, sono le donne a ri-correre più frequentemente a que-ste pratiche (con un rapporto don-ne-uomini di 1,5) nella fascia di etàcompresa tra 35 e 44 anni (25,4%delle donne).
Vi è un consistente utilizzo an-che nei bambini di età compresatra 0 e 14 anni (il 9,2%), con unaparticolare propensione verso l’o-meopatia (il 7,7% dei soggetti).Tale ricorso in età pediatrica è ov-viamente mediato dalle abitudinie dagli atteggiamenti culturali del-la famiglia.
La propensione a ricorrere a ta-li terapie aumenta anche con il li-vello di scolarizzazione: il 24,1%dei laureati e diplomati ha utilizza-to almeno un tipo di medicina nonconvenzionale, contro il 18,8% dicoloro che sono in possesso di li-cenza media, e l’11,2% di quelli chehanno la sola licenza elementare onessun titolo di studio.
Dal punto di vista della distri-buzione geografica la maggior par-te degli utenti si trova nelle regioni
Vo
l. 14- n
. 7/8 - Lug
lio/A
go
sto 2001
Figura 1 - Il ricorso alle terapie non convenzionali in Italia (1997-1999)
�
�
�
�
�
!
%
"
(
��������� ��������������� ���
���������� ���� �� � ����
"��
%
��"
��(
���� ���������������������
dell’Italia settentrionale, soprattut-to nel Nord-Est, dove quasi un ita-liano su quattro utilizza almenouna terapia non convenzionale, perpassare al Centro con un italianosu sei, fino al Sud con un italianosu quindici (Figura 2).
GLI ATTEGGIAMENTI E LE MOTIVAZIONI
A tutti gli intervistati è statochiesto se ritenevano utili i me-todi di cura non convenzio-nali anche sen-za averli speri-mentati diret-tamente.
Nel com-plesso, il 39,8%dei soggetti haespresso ungiudizio positi-vo per almenoun tipo di medicina non con-venzionale. Al contrario, circail 23,1% definisce tali metodi di cu-ra non utili, mentre il 37,1% delcampione dichiara di non essere ingrado di esprimere alcun giudizio.
Analizzando le motivazioni al-la base del giudizio di utilità, que-ste si articolano come riportato inTabella 1.
Questi dati pongono in luceun atteggiamento di ridotta accet-tabilità da parte dei cittadini neiriguardi degli eventuali effetti av-versi talvolta legati all’utilizzo diterapie farmacologiche standard,mentre sembrerebbero ridimen-
sionare notevolmente la rile-vanza del ruolo giocato dal
rapporto inter-personale trapaziente e me-dico, spesso ci-tata come prin-cipale motiva-zione alla basedel ricorso aqueste terapie.
Chi si avvi-cina alle medicine non conven-
zionali lo fa soprattutto su indica-zione di un medico (38% dei casi)o su indicazione di altre persone(30,9%). Il 27,2% compie questascelta di propria iniziativa. Il 4,6%
sembra essere guidato dalle infor-mazioni provenienti dai mass me-dia, mentre il 5,5% si adegua a unainiziativa dei genitori.
In ogni caso, sono prevalente-mente i laureati (33,3% dei casi) adecidere autonomamente di ricor-rere alle terapie non convenzionali,percentuale che scende al 18,5%tra coloro che hanno il titolo di stu-dio più basso. Le informazioni suimass media raggiungono maggior-mente chi possiede un titolo di stu-dio più alto.
Complessivamente, in oltre il59,6% dei casi il medico di fami-glia è al corrente della decisione delpaziente e questo fatto porta a pen-sare a un atteggiamento non rigidodi una parte della classe medica neiconfronti di queste pratiche.
Chi ricorre alle terapie non con-venzionali lo fa nella maggior par-te dei casi per curare sindromi acu-te dolorose. Un’altra ragione im-portante, indicata dagli utilizzatori,è quella relativa al desiderio di ungenerico miglioramento della qua-lità della vita, ragione questa forte-mente sottolineata soprattutto da-gli utenti della fitoterapia.
In molti casi chi utilizza questeterapie ricorre nel tempo a differen-ti pratiche: circa la metà di quelli chedichiarano di aver utilizzato l’omeo-patia ha, nell’arco di tempo consi-derato, fatto ricorso anche ad altrimetodi; lo stesso dicasi per coloroche hanno fatto uso di trattamentimanuali. Questo dato fa pensare aun atteggiamento culturale favore-volmente indirizzato in genera-le verso un’altra medicina.V
ol.
14-
n. 7
/8 -
Lu
glio
/Ag
ost
o
2001
Quasi il 40% di chi ricorrealle terapie
non convenzionali lo fa su indicazione di un medico
Figura 2 - Distribuzione geografica degli utilizzatori di terapie non convenzio-nali. Nord-Est = 1 italiano su 4; Centro = 1 italiano su 6; Sud = 1 italiano su 15
Tabella 1 - Motivazioni espresse inbase al giudizio di utilità delle terapienon convenzionali
Motivazioni
Minore tossicità 71%Unica alternativa 22,6%Maggiore efficacia 20,5%Miglior rapporto
medico/paziente 13,2%Convinzioni culturali 10%
���
���
����
Complessivamente sembra esse-re elevato il livello di soddisfazionedi chi ricorre alle terapie non con-venzionali; quasi il 70 % di chi viha fatto ricorso dichiara di avernericevuto dei benefici.
UNA PRIMA RIFLESSIONEQuesti dati consentono di
avere una primafotografia delladiffusione in Ita-lia delle terapienon convenzio-nali. Sulla basedei dati raccoltiattraverso le in-terviste condottenell’ambito dell’indagine 1999-2000 sulle "Condizioni di salute ericorso ai servizi sanitari" sarannocondotti degli ulteriori approfondi-menti che consentiranno di corre-lare con maggiore precisione la pre-valenza d’uso di queste pratichenella popolazione italiana con le ca-ratteristiche socio-economiche esanitarie degli intervistati.
In ogni caso alcuni elementisembrano già emergere:
• la quota, pur consistente,di popolazione che ricorre a
queste pratiche pone l’Italia nel-la parte bassa di una ipotetica“classifica” europea;
• vi è complessivamente un at-teggiamento non pregiudizial-mente negativo nei riguardi diun possibile uso delle terapie
non convenzionali, conuna quota consistente di
popolazioneche però nonsembra pos-sedere infor-mazioni ido-nee a espri-mere un giu-dizio;• si eviden-
zia un profilo dell’utilizzatoremedio articolato come: donna dietà media, con alto livello cultu-
rale e di probabile buon livelloeconomico (vista anche la distri-buzione territoriale italiana);
• le ragioni alla base del ricorsoalle terapie non convenzionalisembrano derivare da una ri-cerca di trattamenti che possa-no proporsi con un più altogrado di tollerabilità e sicurez-za; ciò sembra anche confer-mato dalla quota di bambinitrattati, ad esempio, con l’o-meopatia;
• un dato certamente singolare, so-prattutto se confrontato con da-ti internazionali, è quello relativoal ruolo dei medici italiani; daquesti primi dati emerge un at-teggiamento elastico o quantomeno tollerante da parte del me-dico verso questi tipi di terapie. V
ol. 14
- n. 7/8 - Lu
glio
/Ag
osto
2001
In briefUse of unconventional medicine in Italy
Few data are available on the prevalence of use of alternative therapies inItaly and very little is known about the health problems for which these ther-apies are used. The National Institute of Statistics (ISTAT) conducts periodical-ly a “Multi-purpose survey among Italian families” in order to gain informa-tion on health conditions and health services utilisation. The survey also col-lects data on lifestyle, physical activity, diet, drug use, prevention, chronic dis-eases, etc. In collaboration with ISTAT, the Italian National Institute of Healthsuggested the inclusion of some questions with the objective to estimate theprevalence of use of the main alternative therapies in the population.
L’utilizzatore medio di terapie
non convenzionali è donnacon alto livello culturale
Vo
l. 14
- n
. 7/8
- L
ug
lio/A
go
sto
20
01
na delle quattro funzio-ni che la legge di rifor-ma assegna all’IstitutoSuperiore di Sanità è
rappresentata dalla formazione.L’ente realizza azioni formative neivari contesti di propria pertinenza(dall’epidemiologia, alla gestione,alla comunicazione sociale, oltreche in vari aspetti tecnici e tecno-logici altamente specialistici) se-condo tre tipologie:• la formazione continua, accre-
ditabile secondo i parametri e gliindicatori previsti dalla Com-missione nazionale per l’educa-zione continua in medicina(ECM);
• la formazione mirata e specifi-ca, offerta ai dirigenti di area disanità pubblica e ai direttori sa-nitari di azienda USL e ospeda-liera;
• l’impostazione e la realizzazionedel progetto speciale di attiva-zione della scuola nazionale disanità pubblica.Tali attività si rivolgono sia al
personale del Servizio SanitarioNazionale (SSN) che ad ope-ratori stranieri,residenti in Paesidell’Unione, inPaesi in tran-sizione (l’areabalcanica e me-dio-orientale,l’ex Unione So-vietica, la CinaPopolare, il Su-dafrica) e in Pae-si in via di svi-luppo (soprattutto dell’areaafricana).
Per quanto concerne il segmen-to del mercato formativo a cui l’en-te si rivolge, esso è rappresentato es-senzialmente dalla formazione pro-fessionale nell’ambito della sanitàpubblica, secondo l’elenco di profi-li stabilito dal DPR 484/97. Suquesta base, e per orientare l’offer-ta in modo non autoreferenziato,ma basato sulla lettura del bisognoe sulla ricerca sistematica della rile-vanza e dell’appropriatezza, si ècompiuta una valutazione rapidadelle richieste del personale di quel-l’ambito.
I risultati essenziali indicano, tral’altro, che si tratta di una popola-zione che in oltre il 65 % dei casi hagià frequentato corsi di natura ma-nageriale, attrezzandosi per proprioconto per poter gestire la propriarealtà professionale secondo quantoindicato dalla normativa (Figura 1).È quindi un pubblico maturo,orientato, alla ricerca di qualifica-zioni specifiche rispetto alla richie-sta lavorativa a cui si trova a dovercorrispondere. Inoltre, è un pubbli-
co che richiede un’attenzio-ne organizzata, non occasio-
nale, rivolta abisogni formati-vi altamente in-dividualizzati,tali da permet-tere il manteni-mento degli im-pegni lavorativie delle respon-sabilità dirigen-ziali da cui nonsi può esimere,
sia pure per motivi di studio.Infine, è chiara e convincente la ri-chiesta per un approccio formativoche tenga in conto conoscenze pre-gresse importanti, un percorso pro-
fessionale spesso di grande rilevan-za, qualificato, anche se non sem-pre pertinente.
È interessante notare come, inassenza di un’offerta organizzata daparte del gestore pubblico, altri so-no i soggetti che comunque abitanoil mercato della formazione, il qua-le, contrariamente a quanti molti,soprattutto nel settore pubblico ri-tengono, non si sottopone ai vinco-li normativi, ma tenta di qualificar-si, utilizzando il disponibile e orien-tandosi, per lo più, verso struttureuniversitarie (soprattutto private, inoltre il 48% dei casi). Non era loscopo di questa ricerca di definire icosti della formazione pregressa, maesiste un’evidenza aneddotica che latipologia di maggiore frequenza siaanche più costosa, rispetto alla li-mitata offerta pubblica, di circa die-ci volte.
Dati questi elementi conosciti-vi, si è provveduto ad esprimere unalinea di intervento che ha portato a:• elaborare un percorso di rileva-
zione del bisogno formativo delpersonale del SSN rispetto al-l’attuazione della politica sanita-ria dettata dal Ministero dellaSanità, presente nel Piano Sani-tario Nazionale e recepita daisingoli Piani Sanitari Regionali,con specifico riferimento allanormativa relativa alla forma-zione delle dirigenze sanitarie;
• compilare un inventario nazio-nale delle offerte formative peridentificare le competenzedidattiche e metodologi-
Formazione continua:sperimentazione
e prospettive all’ISS
Ranieri Guerra
Segreteria per le Attività Culturali
Le attività di formazionedell’ISS si rivolgono
sia al personale del Servizio Sanitario
Nazionaleche a operatori stranieri
Vo
l. 14- n
. 7/8 - Lug
lio/A
go
sto 2001
che e le competenze settorialispecialistiche, con lo scopo dicreare una rete formativa globa-le a livello nazionale che possacorrispondere ai bisogni forma-tivi complessi del SSN;
• elaborare curricula formativi dif-ferenziati per ciascun profiloprofessionale dell’area di sanitàpubblica;
• sviluppare cicli formativi secon-do una metodologia orientataper problemi (problem basedlearning) amministrata sia resi-denzialmente (presso l’ISS epresso le sedi decentrate parte-cipanti alla rete formativa cita-ta), che a distanza, attraverso re-ti Internet governate dal sitoISS, in collaborazione con Re-gioni e ASL.L’analisi che ne è conseguita ha
permesso di evidenziare l’esistenza,almeno percepita, di una profondadiscrepanza tra le capacità profes-sionali del personale sanitario, i bi-sogni di salute delle comunità e imezzi per affrontare correttamentetali bisogni che il personale sanita-rio stesso acquisisce durante il pro-prio iter formativo.
La strategia che deriva si basa suifondamenti della didattica innova-tiva per adulti, sintetizzata dall'ap-
proccio formativo basato suproblemi, realizzato da varie
strutture internazionali a cui l'ISSsi è ispirato nella sua attività di cen-tro collaborativo dell'OMS per l'in-novazione didattica.
Gli elementi essenziali che rap-presentano il contenuto che vieneofferto attraverso questo approcciometodologico diverso rispetto altradizionale sono:• il monitoraggio dello stato di sa-
lute per identificarne tempesti-vamente rischi e problemi diimportanza collettiva;
• la diagnosi e l’indagine conti-nua sui rischi e sui determi-nanti di morbo-mortalità nel-la comunità che portino alla
valutazione dei bilanci e dei bi-sogni individuali e collettivi disalute;
• l’informazione, l’educazione e lapromozione della capacità di au-togestione della propria saluteper le comunità e i singoli indi-vidui che la compongono;
• la realizzazione di un’alleanza edi una concertazione tra istitu-zioni, individui e gruppi socialiche possano definire le proble-matiche sanitarie e realizzareazioni correttive e promotivedella salute come bene e diritto;
• lo sviluppo e la formulazione dipolitiche, progetti e piani cheperseguano la salute degli indi-vidui e delle collettività;
• la valutazione dell’efficacia, del-l’efficienza, dell’accessibilità (fi-sica, culturale, economico-fi-nanziaria e sociale) e della qua-lità dei servizi sanitari resi all’in-dividuo e alla collettività;
• l’impostazione e la conduzionedi attività di ricerca operativa edi ricerca-intervento miranti al-l’innovazione tecnico-scientificae all’erogazione di servizi e pre-stazioni efficaci.Questa offerta verrà erogata at-
traverso un sistema misto di didatti-ca attiva, organizzata sia residenzial-mente, che, in maniera sempre mag-giore, a distanza, con gli strumenti
Figura 2 - Evoluzione della formazione a distanza: da un processo estensi-vo di prima (A) e seconda (B) generazione si passa a un processo intensivocaratterizzato da una forte interazione fra i partecipanti
�"
�!
��
��
�
"
!
�
�
)� *�
����������������� �������������
Figura 1 - Fruitori di corsi di management (direttori sanitari AUSL e AO)
�
���������������
������
������ �������
������
!�!�����������
������
� �
della web-education (Figura 2), or-mai tecnologicamente affidabili e va-lidati, sia pure in ambiti diversi ri-spetto a quello sanitario, con unformato che si basa su tre elementifondamentali: il consenso esperto,ovvero l’evidenza scientifica in me-rito all’argomento di cui si tratta, dacui poter derivare uno standard diriferimento su cui misurare la didat-tica, da un lato, e la successiva ac-quisizione di capacità e conoscenze,dall'altro; la formulazione del pro-gramma didattico, coerentementecon gli obiettivi di apprendimentostabiliti e secondo un approccio me-todologico innovativo e rilevante ri-spetto alle nuove esigenze formativedel sistema; l’esame di competenzadei fruitori, amministrato in rete inmaniera interattiva e responsabiliz-zante (Figura 3).
A prescindere dall’opportunitàche una seria formazione a distan-za teleassistita garantisce, i suoi li-velli di economicità sono ampia-mente verificati: la media di acqui-sto di formazione virtuale a distan-za in Nordamerica si aggira sullequindici ore/anno, con un esborsopari a circa dieci dollari USA percredito orario certificato.
Uno studio dettagliato compiu-to dall'ISS sui costi per garantire aimedici di sanità pubblica cento oredi fruibilità telematica assistita inItalia, attraverso una rete Internetad ampia banda, accessibile perventiquattro ore al giorno, con lacostituzione di cinquanta stazionimirror diffuse in sede regionale e diun server con funzioni di centroservizi indica in circa 1,8 miliardidi lire/anno il costo diretto, a cuiaggiungere, naturalmente, il costoindiretto individuale di ciascun col-legamento telefonico, pari a circa180 lire a chiamata, aumentabiledella tariffa a consumo per gli scat-ti urbani.
Il costo capitario orario diret-to con il sistema che l’ISS sta met-tendo a punto, e che rappresentalo stato dell’arte della tecnologiaformativa a distanza, valutando
l'effettiva copertura nazionale al-meno al 70%, è di circa 6 500 li-re, quindi più che dimezzato ri-spetto a quanto accade negli StatiUniti. È da sottolineare comequesto tipo di risorsa si presta an-che a garantire vantaggi collatera-li, quali il reperimento di biblio-grafia e lo scambio di consulenzareciproca e supporto tecnico qua-lificato nella discussione clinica,investendo, in tal modo, tutte letre aree su cui la formazione con-tinua nel nostro Paese si articola:riviste, libri e materiale cartaceo(in questo caso sostituito da ma-teriale virtuale) per il 67,7%, cor-si e seminari per l'11,5%, discus-sioni cliniche per il 9,2%.
Lo scenario in cui l’ISS si muo-ve fa riferimento al contesto inte-rattivo e polifunzionale che sta ra-pidamente subentrando alla for-mazione a distanza passiva, erogata
in maniera non interattiva. Le ca-ratteristiche fondamentali del siste-ma, realizzato con tecnologia Lo-tus-IBM, sono la grande accessibi-lità, la flessibilità e l’interattività chepermettono l’adattamento meto-dologico e didattico per problemi,che costituisce il cardine dell’ap-proccio formativo dell’ISS.
In conclusione, è utile sottoli-neare come l’attuale impostazionenormativa e la realizzazione dellostrumento accreditante, avviata dalMinistero della Sanità, promuova-no efficacemente un dibattito tec-nico-scientifico e organizzativo sul-la formazione professionale conti-nua. Di questa tutti hanno semprericonosciuto l’importanza fonda-mentale, senza però avviare una ri-flessione sistematica su approcci,strumenti, metodi e risorse: ora sia-mo chiamati ad analisi e valutazio-ni precedentemente limitate.
Vo
l. 14
- n
. 7/8
- L
ug
lio/A
go
sto
20
01
In briefContinuing education: trials and perspectives at ISS
The evolution of the Italian National Health Service has brought about theimpelling necessity of providing a Continuing Education System that wouldkeep the health workers in line with the health services’ technical demand. TheISS is tailoring its training activities around such dynamic context and with theuse of latest technology.
Figura 3 - Gestione dell’eMaster in cui docenti, studenti e gestori hannoesclusivamente un punto d’accesso a Internet
"� ����
#�$���� %�����
li effetti biologici delleparticelle aerodisperse(aerosol) che entrano nelsistema respiratorio uma-
no dipendono dalla natura delle par-ticelle stesse e dal luogo della loro de-posizione. Viene generalmente as-sunto che gli eventuali effetti patolo-gici siano proporzionali alla massadelle particelle con determinato dia-metro aerodinamico (Da), depositatesia nel complesso del tratto respirato-rio, che nelle singole regioni in cui es-so puo essere suddiviso. Sulla base diqueste evidenze gli organismi di nor-mazione internazionali ed europei, inaccordo con l’ACGIH statunitense,hanno effettuato la revisione delle de-finizioni adottate in passato per le fra-zioni dimensionali di aerosol che sidepositano lungo il tratto respiratorioumano (UNI, 1994; UNI, 1998;ACGIH, 1996), individuando trefrazioni con specifico rilievo sanita-rio: la frazione inalabile, la frazionetoracica, e la frazione respirabile.
Lo scopo principale di queste ini-ziative di standardizzazione è deter-minato dalla necessità di raccoglieredati più armonizzati e rappresenta-tivi della effettiva esposizione uma-na, al fine di consentire una più ri-gorosa valutazione del rischio sani-tario, base essenziale per stabilire va-lori standard di riferimento per laprevenzione sanitaria. Questo nuo-vo sistema di riferimenti ha un rile-vante impatto sulla pratica dell’atti-vità dell’igiene industriale e ambien-tale, in quanto comporta la scelta el’uso di nuovi sistemi di campiona-mento e la revisione dei valori limi-te di esposizione (TLV) basati sulleprecedenti definizioni.
Durante il Seminario che si è te-nuto in Istituto il 20 e il 21 giugnosono stati affrontati e approfondititutti questi temi e sono state illu-strate le nuove norme di riferimen-to e ampiamente discusse le impli-
cazioni tecniche derivanti dalla loroapplicazione pratica. In particolare,sono stati presentati i più recenti ri-sultati degli studi mirati allo svilup-po di strumenti che meglio rispon-dono ai criteri dettati dalle nuove
convenzioni per il campionamentodelle specifiche frazioni.
Nel corso dei lavori è stato af-frontato anche il problema deter-minato dall’introduzione delle nuo-ve norme nell’ordinamento legisla-tivo e le sue ripercussioni sulla ri-formulazione dei TLV. Il Semina-rio, che prosegue l’iniziativa semi-nariale effettuata nel 2000 sul temadelle polveri aerodisperse, ha rap-presentato un’occasione di infor-mazione e di discussione per glioperatori del Servizio Sanitario Na-zionale e per tutti coloro che han-no interesse ad approfondire le co-noscenze sui problemi di campio-namento e di misura delle polveriaerodisperse ai fini sanitari. È nelleprevisioni degli organizzatori ripe-tere questi appuntamenti annuali,dedicandoli, anno per anno all’esa-me di temi, sempre associati alleparticelle aerodisperse, ma anchefocalizzati su specifici argomenti,quali la silice cristallina, le particel-le di origine biologica, le polveri or-ganiche, e altri ancora, sicuramen-te emergenti per interesse scientifi-co e sanitario.
Vo
l. 14- n
. 7/8 - Lug
lio/A
go
sto 2001
Il convegno del meseLa misura dell’esposizione alle varie frazionidi polveri aerodisperse: il quadro normativo
e la scelta della strumentazione
In briefMeasurement of exposure to airborne particle fractions: the legislati-ve framework and the choice of the instruments
The seminar held at ISS on June 20-21, 2001, addressed several importantissues relating to the measurement of airborne dust at workplace: the imple-mentation of new, internationally agreed, particle size-selective sampling de-finitions of inhalable, thoracic, and respirable dust; the collection performan-ce of traditional and recently developed sampling instruments, in comparisonwith the new sampling conventions; the improved criteria for weighing col-lected aerosols; the application of the established analytical techniques to thedetermination of specific health-relevant components of the different dust frac-tions; the problems faced for converting current “total” dust limits to limitsbased on the new dust definitios. The seminar has been an opportunity for in-formation and debate among the national sanitary service personnel and tho-se interested in getting up-to-date knowledge on scientific and technical pro-gress on the exposure to airborne dusts.
Achille Marconi
Laboratorio di Igiene Ambientale
Vo
l. 14
- n
. 7/8
- L
ug
lio/A
go
sto
20
01
EPATITE B IN ITALIA: A CHE PUNTO SIAMO A 10 ANNI DALL’INTRODUZIONE DELLA VACCINAZIONE DI MASSA
Istituto Superiore di Sanità - Roma, 20-21 settembre 2001
L’Italia è stato il primo Paese al mondo a introdurre la vaccinazione anti-epatite B di tutti i nuovi natie degli adolescenti, adottando in tal modo un’efficace strategia di prevenzione di una infezione
che può avere gravi conseguenze come la cirrosi epatica e l’epatocarcinoma.Il Convegno vedrà la presenza di autorevoli ricercatori italiani e stranieri e sarà l’occasione
per fare il punto sulla vaccinazione anti-epatite B in Italia a dieci anni di distanza dall’introduzione della legge e per confrontarsi con le esperienze di altre aree geografiche
(altri Paesi europei, gli Stati Uniti, l’Africa e l’Asia). Verranno inoltre presentati i progressi conseguitiin tema di terapia dei soggetti portatori cronici del virus B.
Direttore del ConvegnoAlfonso Mele
Laboratorio di Epidemiologia e BiostatisticaIstituto Superiore di Sanità
Tel. 06 4990 3182 Fax 06 4938 7173
Segreteria tecnicaS. Crateri, G. Iantosca, V. Wenzel
Laboratorio di Epidemiologia e BiostatisticaIstituto Superiore di Sanità
Tel. 06 4990 2982 Fax 06 4938 7173
e-Mail: [email protected], [email protected], [email protected]
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀIV PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCA SULL’AIDS
Articolazione, responsabilità e finanziamento del Programma
1) Progetto: EpidemiologiaResponsabile scientifico: Dr Giovanni Rezza; Finanziamento previsto: £ 1 000 000 000
2) Progetto: Patologia, clinica e terapia dell’infezione da HIVResponsabile scientifico: Dr Stefano Vella; Finanziamento previsto: £ 5 900 000 000
3) Progetto: Patogenesi e immunità mirate all’individuazione di nuovi bersagli chemioterapici, immunoterapici e di prevenzione vaccinale
Responsabile scientifico: Prof.ssa Paola Verani; Finanziamento previsto: £ 8 900 000 000
4) Progetto: Infezioni opportunistiche e tubercolosiResponsabile scientifico: Prof. Antonio Cassone; Finanziamento previsto: £ 2 700 000 000
È disponibile su richiesta e online il “IV Programma Nazionale di Ricerca sull’AIDS” pubblicato come supplemento al Notiziario Vol. 14 - n. 6 giugno 2001.
Ogni ulteriore informazione e le schede per la compilazione delle proposte di ricerca devono essere richieste a:
Giovanni CaricatiLaboratorio di Virologia
Istituto Superiore di SanitàTel.: 06 4938 7145, 06 4990 3226, 06 4990 3280
Fax: 06 4990 2813e-Mail: [email protected] o [email protected]
Bookmark
Sul sito del Centro di Ricerche Cliniche per le Malattie Raredell’Istituto Mario Negri è possibile recuperare informazioni,aggiornamenti e indirizzi utili per i pazienti affetti da patologie rare e per i medici.
www.irfmn.mnegri.it/info/acd/default.htm
orphanet.infobiogen.fr/
È il sito ufficiale dell’NIH (National Institute of Health) statunitense, dove è possibile trovare informazioni,sullo stato attuale della ricerca e sulle pubblicazioni scientifiche relativamente alle patologie rare.
rarediseases.info.nih.gov/ord/
La Redazione del Notiziario
è a disposizione dei lettori per accogliere commenti e suggerimenti e rendere
questo strumento sempre più utile e rispondente
alle reali esigenze degli operatori sanitari
Viale Regina Elena, 29900161 Roma
Tel. 06 4990 3374Fax 06 4990 2253
e-Mail: [email protected]://www.iss.it/notiziario
Notiziariodell’Istituto Superiore di Sanità
Esperienze di cardiochirurgia fetale sperimentale
Rapporto annuale sulla Legionellosi in Italia nel 2000
Nei prossimi numeri
Database relativo alle Malattie Rare (ne vengono descritte oltre 900 che interessano solo pazienti francesi) e ai farmaci orfani.