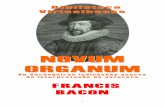Castrum Novum. Quaderno 2, 2013
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Castrum Novum. Quaderno 2, 2013
1
Con questo nuovo quaderno presentiamo i risultati delle ultime due campagne di ricerca nel sito dell’antica città di Castrum Novum, proseguendo nel solco di quanto già raccontato nel Quader-
no 1 uscito due anni orsono. Insieme ai colleghi e amici francesi dell’Università di Amiens e di Lille 3, con gli studenti e i volontari del Gruppo Archeologico del Territorio Cerite, abbiamo continuato il lavoro per riportare alla luce la storia e l’archeologia dell’insediamento coloniale romano, prima che il degrado e lo scarso interesse ne cancellassero del tutto la memoria. Una corsa contro il tempo per cercare di trasformare in un “parco archeologico urbano” quello che ad oggi è un insieme di resti antichi tra loro scollegati, in-comprensibili per i visitatori e abbandonati a se stessi. Grazie alla disponibilità e alla stretta collaborazione instaurata con i funzionari della Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale è stato possibile giungere ad una concessione di scavo formale al nostro Museo Civico da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali che consentirà alla ricerca di progredire nel tempo in sicurezza e tranquillità.
Giunti al quarto anno di attività possiamo raccogliere i principali dati emersi dagli scavi e dagli studi per proporre una prima sintesi delle acquisizioni, utile alle future ricerche a alla divulgazione scientiica. Quest’ultimo aspetto ci sta particolarmente a cuore in quanto l’informazione e il coinvolgimento dei cittadini è un elemento fondamentale per la crescita civile e culturale del territorio. Senza una seria di-vulgazione viene meno il senso stesso della ricerca. E’ per questo che oltre all’attività scientiica di scavo, ricognizione e di studio molte energie sono state impegnate sul campo con conferenze, visite guidate e lezioni a scuola rivolte in particolare ai più giovani che sono il futuro del nostro Paese.
Questo nuovo quaderno raccoglie diversi contributi utili per ricostruire la storia, l’archeologia e la to-pograia antica dell’abitato. In particolare, le ricerche svolte a terra e sui fondali antistanti l’insediamento consentono alcune nuove letture dei resti monumentali e della realtà urbana alla luce della recenti acqui-sizioni. I contributi di studio approfondiscono la storia degli scavi e delle scoperte, nonché la conoscenza di alcune delle opere statuarie e delle epigrai rinvenute a partire dal XVIII secolo.
Si raccolgono in modo sistematico i nuovi dati forniti dagli scavi nella zona termale della “Villa delle Guardiole” e nell’ “Ediicio quadrato”, aperti sul tracciato di quella che si ritiene essere l’antica via Aurelia. Una delle più importanti novità che si presenta ai lettori in questa pubblicazione è senza dubbio quella costituita dai risultati delle prospezioni magnetometriche svolte sulla collina dominante il mare, sotto la quale è certamente situato il cuore dell’antico centro di Castrum Novum. L’indagine ha rivelato per la prima volta l’impianto urbano di una parte della città con numerose strutture ed ediici organizzati all’in-terno di un tessuto regolare di notevole interesse.
Inine, certamente di non secondaria importanza, la ricerca sugli antichi portolani e i dati emersi dalle ricognizioni subacquee del Centro Studi Marittimi del GATC operante presso il Museo del Mare; i ma-teriali scoperti sui fondali apportano notevoli conoscenze sia in relazione alla storia e alla topograia dei grandi impianti ittici siti sulla costa castronovana, sia sulla probabile struttura dell’approdo e sulla lunga frequentazione dell’area portuale.
Il Direttore del Museo Civico di Santa Marinella Dott. Flavio Enei
I recenti scavi di Castrum Novum hanno portato alla luce altre inestimabili testimonianze del nostro passato e permesso di impreziosire una storia già ricca di innumerevoli reperti che insistono su
tutto il nostro comprensorio. Di questi ritrovamenti, illustrati e descritti nel volume che ho il piacere di presentare, va dato giusto
merito al direttore del Museo del Mare e della Navigazione Antica di Santa Marinella, dott. Flavio Enei, il quale sta portando avanti il progetto di recupero e valorizzazione dell’importante sito archeologico della nostra città. Il progetto Castrum Novum viene realizzato in stretta collaborazione con la Dott.ssa Rossella Zaccagnini della Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale, le Professoresse Sara Nardi Combescure e Marie Laurence Haack dell’Università francese di Amiens, il Prof. Grégoire Poccardi dell’Università di Lille3 e i numerosi volontari per i beni culturali del Gruppo Archeologico del Territorio Cerite. Grazie a questo progetto Santa Marinella prosegue nella riscoperta del suo ingen-te patrimonio storico-archeologico. L’Amministrazione Comunale che ho l’onore di rappresentare si impegnerà, da qui e per il futuro, a valorizzare tutto ciò per cercare di trasformarlo in un’occasione di crescita civile, culturale e turistica della città.
Lo dobbiamo a noi stessi e alle nuove generazioni.
Il Sindaco di Santa Marinella Roberto Bacheca
2
1. Castrum Novum: le nuove indagini
1.1 L’ediicio termale: il balneum del complesso de “Le Guardiole”
A partire del mese di settembre 2010 si è proceduto alla documentazione graica e fotograica delle rovine del “bal-neum delle Guardiole” (zona A, settore I)1. L’area è situa-ta in corrispondenza del km 64, 4 della via Aurelia, a nord dell’abitato di Castrum Novum, su un pianoro limitato a sud dal fosso dal quale prende il nome (Figg. 1, 2). Per quello che riguarda il toponimo, Dennis ne attribuisce l’origine alla presenza di sepolture etrusche nella località vi-cina di Pontone del castrato, riutilizzate come postazioni di guardia2. E’ possibile comunque che esso sia da far derivare dalla parola longobarda warda che signiica luogo di osser-vazione, così come proposto per la località la Guardiola, situata nell’area di Monteromano3.Gli ambienti del balneum, orientati in senso NO-SE, erano già stati scavati nel 1970 dalla Soprintendenza Archeologi-ca per l’Etruria Meridionale4. All’inizio dei lavori erano in-teramente coperti di vegetazione ed i resti visibili in cattivo stato di conservazione, nonostante i restauri efettuati dalla Soprintendenza. Questi ultimi coprono le strutture messe alla luce, ostacolando in alcuni casi la lettura delle relazioni stratigraiche.L’Ambiente 1 conservava le tracce di un mosaico con tes-sere in bianco e nero, il quale era originariamente posato su di uno strato di frammenti di pietra e di laterizi legati da malta (Fig. 1). Dell’Ambiente 2 resta una vasca (USM 2), ricoperta di uno strato di cocciopesto (USM 3) e alimentata da un canale, situato a sud. E’ possibile che si trattasse del rigidarium del balneum: la vasca sembra impostarsi su una struttura ante-riore, aiancata da due ambienti absidati, questi ultimi obli-terati dal muro 1 e dal canale. Sul lato nord dell’ambiente sono ancora ben visibili le tracce di una fossa che, rompen-do il pavimento ha messo in luce il canale sottostante, che si divide in due rami (Fig. 4), coperto da laterizi con bolli del 120 d.C. (Cfr. p. 5). L’Ambiente 3 è delimitato dai muri 5, 6, 7, 8 e 9. Al momen-to dello scavo del 1970, fu rinvenuta una pavimentazione di tegole legate da malta grigio chiara (USM 1), coperta da uno strato di cocciopesto (USM 8), sul quale all’epoca era-no ancora visibili le tracce di suspensurae. Si tratta del vano d’intercapedine di un ipocausto, le cui pareti interne sono rivestite da un muro di mattoni e tegole, disposti a ilari re-golari (USM 4). I paramenti dei muri 8 e 9 (USM 6), il cui aspetto originale è stato pesantemente alterato dai restauri moderni, sono in opus mixtum con pannelli inquadrati da blocchetti squadrati di pietra e tegole.
1 Preliminari con la suddivisione convenzionale in zone e settori in Enei et al. 2011, Haack et al. 2012 e Haack et al. 2013.2 Dennis 1848, I, p. 295, Del Lungo 1996, I, p. 269. Queste sepolture furono scavate nel 1840 dalla Duchessa di Sermoneta.3 Scapaticci Perfetti 2000, p. 219.4 Gianfrotta 1972, p. 115.
A un livello inferiore (circa 20 cm) sono situati i due Am-bienti 6 e 7 che erano in origine comunicanti fra di loro. In essi era già stato individuato un praefurnium (Ambiente 6), che alimentava gli Ambienti 3 e 7: quest’ultimo verosi-milmente un calidarium, conservava alcune suspensurae in bessali, in origine alte 50 centimetri e durante le campagne degli anni Settanta aveva restituito tracce di tubuli, lungo le pareti. L’ipocausto dell’Ambiente 7 presenta forti analogie con quello dell’ambiente 3: le pareti sono rivestite da un muro in tegole sbozzate e mattoni disposti a ilari regolari (USM 20 e USM 19) e il pavimento (USM 12) è anch’esso costi-tuito da uno strato di tegole di forma rettangolare di di-mensioni medie di 40 x 60 cm. Quest’ultimo è preceduto da due strati di preparazione: l’USM 10 composto da pezzi irregolari di pietra calcarea, legati da malta di colore grigio chiaro al quale si sovrappone l’USM 11, uno strato di malta grigia chiara piuttosto compatta. Rispetto alle immagini pubblicate negli anni Settanta, delle antiche suspensurae in bessali restano poche e labili tracce e i restauri del muro USM 19 (anch’esso in opera mista), hanno obliterato i tubuli descritti nella bibliograia prece-dente e dei quali si conservano delle immagini5.Il canale che collega l’ipocausto dell’ambiente 7 al praefur-nium dell’ambiente 6 è iancheggiato da due pietre disposte verticalmente (USM 14 e 15) che dovevano appartenere ad un archetto, al quale accenna P. A. Gianfrotta nella sua de-scrizione6. E’ in questa zona che si situa l’USM 13, uno strato di malta chiara caratterizzato dalla presenza di mac-chie nere e rosse, dovute al contatto con il fuoco. L’ingresso al praefurnium è situato nella parete sud e si apre, come nel caso della latrina, su un corridoio di servizio. Ad esso si accedeva per mezzo di tre scalini di cui si conservano ancora le tracce.L’Ambiente 5 è relativo a una latrina, ancora in buono sta-to di conservazione, con pavimento in opus spicatum e cir-condata su due lati da un canaletto rivestito in cocciopesto (Fig. 3).Ad una fase successiva all’abbandono del complesso sembra appartenere l’Ambiente 4. Si tratta di una struttura perfet-tamente orientata N-S, aperta sul lato S, il cui paramento (USM 5) è caratterizzato da blocchi di calcare e pezzi di tegole di reimpiego, disposti su ilari regolari. Di essa sono ancora conservate le fondazioni (USM 9), mentre non si ha alcuna traccia di pavimento, che forse doveva essere costitu-ito da uno spesso strato di terra battuta. La destinazione e la datazione di questo ambiente restano ancora da deinire.Nel corso della campagna di settembre 2011, all’esterno del complesso termale è stato aperto un primo saggio stratigra-ico (sondaggio I). In esso sono emerse tracce di strutture crollate il cui scavo è stato svolto nelle campagne successive (Fig. 5). Come abbiamo già indicato in altre sedi7, l’insieme di questi dati, anche se ancora povero, permette di eviden-
5 Gianfrotta 1972, pp. 404-405.6 Gianfrotta 1972, p. 405.7 In particolare Enei et al. 2011.
3
ziare alcune divergenze d’interpretazione, rispetto alle con-clusioni proposte in precedenza dai ricercatori. Stando alla descrizione dello scavo, pubblicata nel volume di P. A. Gianfrotta8, le rovine del balneum erano ricoper-te da uno strato archeologico databile ai primi decenni del II secolo d.C9. Al complesso furono attribuite due fasi co-struttive: la prima dalla ine del I secolo a.C. agli inizi del I secolo d.C. ed una seconda che corrisponde alla metà del I secolo d.C.Un’analisi più accurata della stratigraia delle strutture mu-rarie, unita allo studio del materiale ceramico del balneum, ha permesso di delineare una successione di fasi diversa, da inquadrare per ora tra il I e il III secolo d.C. ed una fase suc-cessiva all’utilizzazione del complesso come balneum.Alla fase più antica (fase 1) dovrebbero appartenere il muro 4 dell’Ambiente 2 e i due ambienti absidati di cui restano le fondazioni. Questi ultimi sembrerebbero condannati dalla costruzione del rigidarium, al quale sono relativi il muro 1 e il canale situato a sud (fase 2). E’ solo in epoca successiva (fase 3) che il balneum deve aver assunto l’aspetto attuale con la costruzione di una serie di ambienti perfettamente orientati fra di loro e che presentano le stesse caratteristiche costruttive: paramenti in opus incertum o mixtum (laddo-ve visibili) e pareti rivestite di mattoni e tegole, disposti a ilari regolari per le intercapedini degli ipocausti. E’ molto
8 Gianfrotta 1972, pp. 100-110.9 La lista del materiale più interessante rinvenuto nel corso delle indagini è pubblicata in Gianfrotta 1972, pp. 106-109.
probabile che in questa occasione il rigidarium abbia perduto la sua funzione originale in quan-to il canale connesso viene obliterato dal tracciato orientale del muro 7. La fase più recente (fase 4) è rappresentata dall’Ambiente 4, le cui fondazioni si appoggiano direttamente su quelle dei muri 6 e 10. Quest’ultimo, i cui paramenti esterni sono realizzati con materiale recuperato dalle strutture del balneum, è sicuramente databile a un periodo successivo all’abbandono del sito. Allo stato at-tuale delle ricerche è ancora impossibile fornire una datazione per questo ediicio ma è verosimile pensare che si tratti di un’epoca in cui parte delle rovine del balneum erano ancora ben visibili.Le rovine delle Guardiole (Zona A) che compren-dono l’ediicio quadrato (Settore II) ed il balneum (settore I) sono state tradizionalmente attribuite ad un’unica villa di epoca romana, della quale dovevano verosimilmente far parte le peschiere, situate ad Ovest del fosso. Osservando la pianta dei resti archeologici rilevati in terra e in mare in questo settore, ci si rende conto che non esiste al-cuna coerenza nell’orientamento dell’insieme di queste strutture.Al contrario, dal punto di vista topograico esisto-no analogie fra il balneum del settore I e l’edii-cio del settore II. La loro breve distanza potrebbe addirittura far supporre che si tratti di un unico complesso, la cui funzione potrebbe spiegarsi con quella di una statio, situata lungo la Via Aurelia e connessa strettamente all’antico scalo portuale di
Castrum Novum.Nel corso del II secolo d.C., la costruzione del por-
to artiiciale di Centumcellae da parte di Traiano deve aver comportato senz’altro la diminuzione dei traici marittimi sugli scali di Pyrgi, Castrum Novum e Graviscae, a favore del nuovo porto. Lo stesso Plinio il Giovane elogia l’inizia-tiva traianea come necessaria in questo tratto di costa, da lui stesso deinito importuosum10.Nonostante ciò, è possibile che già dalla ine del II-III seco-lo d. C., Pyrgi, Castrum Novum e Graviscae abbiano prose-guito le proprie attività portuali in quanto positiones, così come saranno menzionate più tardi nell’Itinerario Maritti-mo11. Stando a G. Uggeri12, queste ultime avevano funzione di scali intermedi, stabiliti lungo gli itinerari marittimi, che riprendono l’organizzazione delle mutationes-mansiones degli itinerari terrestri, soprattutto in questo tratto della rotta tra Roma e Arles, che gli antichi ci descrivono come importuoso.13
Sara Nardi Combescure
10 C. Plini Caecili Secundi, Epist. Lib., VI, 31, 15, 17.11 It. Marit. 498, 1. 12 Uggeri 1968.13 Uggeri 1968, p. 247, che rimanda a Cic., Orat., III.19 (infe-rum Tuscum scopulosum atque infestus ) e a Plin., Ep., VI, 31.
Fig. 1. Il balneum della villa de Le Guardiole con indicati i diversi ambienti (1 - 7).
4
Fig. 2. Planimetria generale del balneum delle Guardiole.
Fig. 3. La forica del balneum pavimentata in opus spicatum (Amb. 5)
Fig. 4. La nuova area di scavo aperta subito a nord dell’Ambiente 5 (sondaggio I)
Fig. 5 Il canale 1 al di sotto dell’Ambiente 2 nel punto in cui si suddivide in due rami.
Fig. 3
Fig. 4
Fig. 5
5
Il materiale iscritto
Iscrizioni su vasi di ceramica sigillata italica 1) Stampiglio in planta pedis, sul fondo interno (US 111) . L’iscrizione è situata al centro di un cerchio e si legge :P. LORE(ivs) CRET(icvs)L’iscrizione è conosciuta in altri tre esemplari, trovati in Italia centrale e riportati in OCK 20001. L’iscrizione è da-tabile dal 15 d. C. ino alla ine del I secolo d.C. 2) Iscrizione sul fondo esterno, all’esterno del vaso (US 112). Iscrizione graita con lettere disposte ad arco di cerchio: T III HS
Bolli laterizi 1) Bollo proveniente dalla copertura della fogna (canale 1): APRILIS CN(aei) DOMIT(i)La formula onomastica è nota in altri esemplari laziali (CIL, XV 1110, 7 ; CIL, XV 1110, 8), come il Palatino (CIL, XV 1109 ; CIL, XV 1110, 1 ; CIL, XV 1110, 2 ; CIL, XV 1110, 3 ; CIL, XV 1110, 4 ; CIL, XV 1110, 5), e in un bollo ritrovato durante gli scavi di Torre Chiaruccia nel 1879 (CIL, XV 1110, 6 = CIL, XI 6672, 67). Queste iscrizioni sono datate nel CIL al 120 d.C. (Fig. 1).
2) Bollo su frammento di bipedale proveniente dal canale 1. Lo stampo è amputato della metà del suo testo. L’iscrizione si legge diicilmente. Da interpretarsi forse come: [- - -]I APRI[- - -]
3) Bollo su frammento di bipedale proveniente dallo strato di humus che copre l’US 123 (Fig. 2).[opus doliare ex iglinis] CLA(udi) / ALEXANDRIL’iscrizione è conosciuta da altre attestazioni : a S. Severa dallo scavo della Chiesa nella Piazza della Rocca2, a Alsium
1 Oxé 2000, p. 262, n. 1036.2 Enei 2013, nn. 2-4 pp.186, 187
(CIL, XV 2165, 1 = CIL, XI 6689, 76), a Ostia (CIL, XV 2165, 2 a = CIL, XIV 89, 28° = IPOstie-B, 386, 15 a; CIL, XV 2165, 2 b = CIL, XIV 4089, 28 b = IPOstie-B, 386, 15 b)3 e a Roma (CIL, XV 7945). Si data al II secolo d.C.
Iscrizione su istula di piomboFistula proveniente dall’US 202[- - -]DI[-] L(V)NENSIS [- - -]L’iscrizione è mutila in quanto il bollo si conserva per soli 15 cm, quando normalmente questo tipo di bolli misurano attorno ai 30 cm di lunghezza. Le lettere mancanti sono nu-merose. Solo il cognomen Lunensis è leggibile ed inedito per quello che riguarda questo tipo di materiale (Fig. 3). Possiamo proporre alcune ipotesi : a) potrebbe trattarsi del cognomen del senatore del II secolo d.C., M. Clodius Lunensis, cos. suf. nel 105 d.C., proprieta-rio del terreno dova la istula è stata scoperta b) potrebbe trattarsi del nome di un plumbarius domesticus, come Felix Clodi Lunensis s(er) fecit.E’ anche possibile che nel testo originale igurassero i due nomi, quello del senatore e quello del plumbarius.Purtoppo non esistono ancora elementi chiari per stabili-re se il balneum fosse pubblico o privato, elementi che po-trebbero essere signiicativi nell’interpretazione di questo testo.
Marie-Laurence Haack
3 Per Ostia Cfr. Steinby 1978, n. 1147.
Fig. 3. La istula iscritta dal balneum della villa delle Guardiole.
Fig. 1. Bollo laterizio APRILIS CN(aei) DOMIT(i)
Fig. 2. Bollo lateri-zio [opus doliare ex iglinis] CLA(udi) / ALEXANDRI
I rinvenimenti
Nel corso della nuova indagine condotta nel balneum, negli anni 2012 e 2013, sono stati rinvenuti diversi materiali ce-ramici, metallici, vitrei, numismatici ed osteologici tuttora in corso di studio e documentazione. I reperti, provenienti dall’humus supericiale rimescolato e dallo scavo delle va-rie unità stratigraiche, documentano la frequentazione dell’impianto termale, protrattasi dall’epoca augustea al-meno ino al III secolo d.C. In attesa dello sviluppo degli studi, si presenta in questa sede una prima informazione sui principali materiali rinvenuti
6
Le ceramiche e gli altri materiali
Dall’attività di ripulitura degli strati supericiali, svoltasi nel settore I nell’area occupata dai resti del complesso ter-male, efettuata con il ine di riportare alla luce i livelli ar-cheologici scavati durante la campagna del 1970, è emersa una discreta quantità di materiale archeologico signiicativa da un punto di vista crono-tipologico.La classe ceramica più antica rinvenuta, è rappresentata da diversi frammenti di ceramica a vernice nera, di epoca romano-repubblicana (II-I sec. a.C.), dei quali non è stato possibile però fornire alcuna datazione precisa. La ceramica comune appare rappresentata da una notevole quantità di frammenti, tra i quali è stato possibile identiicare almeno un orlo di olla assimilabile al tipo 3 da Torre Spaccata1, in-quadrabile tra la prima e la seconda metà del II secolo a.C. e un orlo di ceramica comune da cucina di olla vicina al tipo 7 da Sutri2, databile tra il 120 e il 140 d.C., entrambi rinvenuti all’interno dell’ambiente 3 identiicato come un tepidarium3; mentre dall’US 111, strato compreso tra gli ambienti 4, 6 e 3, proviene un orlo di olla genericamente databile tra il I ed il II secolo d.C.La classe ceramica della sigillata italica e tardo italica appa-re, ino ad ora, la meno rappresentativa da un punto di vista quantitativo ma rilevante per la sua qualità. Va segnalata infatti la presenza di due frammenti apparte-nenti ad una coppa, con decorazione esterna raigurante una igura umana, con bollo sul fondo (Fig. 4) ed un fram-mento con girali d’acanto.Dall’US 111 proviene inoltre un orlo di coppa riconduci-bile alla produzione tardo-italica, databile tra la prima metà del I sec. d.C. e gli inizi del II secolo d.C.Senza dubbio, la quantità più rilevante di materiale cerami-co rinvenuto in questo settore appartiene alla classe cerami-ca africana da cucina detta “a patina cenerognola”.Negli strati di nuova individuazione tale classe appare pre-sente sia con frammenti riferibili alla forma della casseruola Ostia III (6)4, databile tra la prima metà del II e la ine del IV sec. d.C. (Hayes ine II sec. d.C.- metà del III d.C.), sia del piatto coperchio, assimilabile alla forma Ostia I (3 e 7)5, riconducibile ad un arco cronologico che dal II secolo d.C. giunge sino al IV-V secolo d.C.Quest’ultima tipologia di reperti ceramici rappresenta la testimonianza più tarda e chiude anche cronologicamente il contesto relativo alla rassegna delle classi ceramiche rin-venute nelle ultime due campagne di scavo nel sito del bal-neum delle Guardiole.All’interno del gruppo del materiale ittile va segnalato anche il rinvenimento di un bollo rettangolare quasi inte-gro (cm 10x4; h lett. cm 2,3) su tegola, recante l’iscrizio-ne C.Eren.C[…] ed attribuibile alla tarda età repubblicana (Fig. 1).Inine si ricorda il rinvenimento di un frammento di orlo appartenente ad un dolium, grande contenitore utilizzato per la raccolta e lo stoccaggio degli alimenti (Fig. 2) e di
1 BERTOLDI 2011, p. 702 OLCESE 2003, tav. X, p. 121.3 ENEI et alii 20114 TORTORELLA 1981, tav. CVII, p. 2185 TORTORELLA 1981, tav. CIV, p. 212
Fig. 4 Frammenti di coppa in sigillata tardo italica decorata
Fig. 1 Bollo su tegola recante l’iscrizione C.Eren.C[…]
Fig. 2 Frammento di orlo di grande contenitore (Dolio)
Fig. 3 Alcuni reperti in ferro e in bronzo
7
un piccolo frammento di impasto non tornito rinvenuto in occasione dell’apertura del nuovo sondaggio di scavo nell’area nord-est del complesso termale. Durante le opera-zioni di scavo della suddetta area (Sondaggio I) sono emersi diversi elementi metallici, tra i quali una ibula in bronzo dall’ US 118, alcuni chiodi in bronzo di diverse dimensio-ni, un frammento in piombo forse pertinente ad una istula plumbea ed alcuni oggetti genericamente catalogabili come pendagli (Figg. 3, 4).Seppur con la dovuta cautela, l’analisi del materiale arche-ologico rinvenuto sembra indicare una frequentazione del sito che, a partire almeno dal II sec. a.C., giunge forse sino agli inizi del IV secolo d.C. Tuttavia non è da escludere un rialzamento della cronologia dell’ultima fase di vita del bal-neum al III se non addirittura al II secolo d.C., in connes-sione con quanto riportato dal Gianfrotta6 e prendendo in considerazione la fase iniziale di produzione della ceramica africana da cucina a patina cenerognola (Ostia I, Ostia III)7 che rappresenta il terminus più recente a nostra disposizio-ne. Certamente le indagini degli ultimi anni efettuate in questo settore hanno restituito un quadro piuttosto gene-rale della frequentazione del sito che solo le future attività di scavo potranno chiarire maggiormente.
Luca Desibio
6 GIANFROTTA 1972, p. 1067 TORTORELLA 1981
I vetri
In occasione della campagna di scavo efettuata nel 2012 presso il complesso de “Le Guardiole”, oltre ad una cospicua serie di materiali ceramici, gli strati indagati hanno restitui-to anche diversi frammenti vitrei. Si presenta in questa sede una prima analisi dei reperti presenti nelle Unità Stratigrai-che 102, 103, 106, 107, 110 e 111 del settore I. Nonostante le ridotte dimensioni della maggior parte dei frammenti si è comunque giunti al riconoscimento di alcuni esemplari. È stato possibile efettuare una prima catalogazione dei pezzi, suddivisi in orli, alcuni fondi, 2 ansette e 2 frammenti di decorazione parietale, che hanno ricondotto alle seguenti categorie di manufatti: unguentari, coppette, aryballoi, bic-chieri, piatti.
UnguentariNumerosi frammenti rinvenuti attestano soprattutto la presenza di unguentari (o balsamari) che riconducono principalmente a due tipologie, quelli olliformi o coppette e quelli a corpo tubolare.Per quanto concerne il pri-mo tipo, diversi pezzi sono stati rintracciati nelle unità stratigraiche 102 e 106, riferibili alla forma n. 44 della classiicazione Isings1. Dall’unità 102 provengo-no un frammento di orlo inclinato verso l’esterno con estremità arrotondata, ripiegata e cava all’inter-no, di colore biancastro e di scarsa trasparenza e un frammento di orlo ribattu-to all’interno e appiattito. Entrambi i pezzi sono ri-conducibili al I sec. d.C.2
Nello strato 106 sono stati rinvenuti 3 frammenti di orli che, anche se non ap-partenenti allo stesso esem-plare presentano caratteri-stiche simili: tutti e tre sono di un colore bianco opaco, però il primo ha l’orlo incli-nato verso l’esterno, ripie-gato con estremità ribattuta superiormente e cavo all’in-terno; il secondo e il terzo invece presentano l’orlo spor-gente verso l’esterno, arrotondato. Anche per questi fram-menti è ipotizzabile una collocazione cronologica intorno alla metà del I sec. d.C. Generalmente le tipologie di un-guentari o balsamari olliformi si diferenziano dalla olla di forma analoga perché molto più piccoli, al massimo 10 cm di altezza. Probabilmente questo era un tipo di vasetto usa-to come recipiente per vari usi domestici, più che destinati a contenere balsami. I balsamari olliformi non sono afatto
1 Isings 1957, p. 1002 Ravagnan 1994, p. 58 n. 81
Fig. 1. Unguentario in vetro dal balneum delle Guardiole
Fig. 4. Fibula in bronzo dall’US 118
8
omogenei, anzi variano per genere di bocca e di labbro. Per tale motivo se ne possono distinguere tre tipi: 1. senza collo –con labbro ribattuto; 2. senza collo - con labbro a doppia ribattitura; 3. collo imbutiforme - con il labbro ri-piegato a cordoncino. A volte sono provvisti di coperchi di vetro, di cui si conoscono due tipologie3, entrambe a disco piatto ma uno con presa a forma di collo di bottiglia e l’al-tro con presa a forma di bottone4.Più comuni, nel nostro caso, sono i frammenti riferibili a unguentari a sezione tubolare, detti anche “lagrimali”. Que-sti balsamari hanno la forma di un tubo, in cui il ventre è distinto dal collo solamente da una leggera strozzatura. Anche questi potevano essere di tre tipi, in base alla pro-porzione fra ventre e collo, avere uno spessore tra il sottile e il medio e generalmente un colore azzurrino pallido. Dal momento che il fondo non era piatto, questi unguentari non potevano stare in piedi, perciò probabilmente doveva-no essere rivestiti con un involucro di raia o cotone, che permetteva così di appenderli. Forse, la strozzatura fra ven-tre e collo aveva appunto la funzione di fornire un punto di attacco per il rivestimento. Gli unguentari tubolari sono molto difusi in tutte le regioni dell’Impero dall’inizio del I al II secolo d.C. con un periodo di massima difusione in età lavia5. Inoltre, nell’US102 è stato rinvenuto un fram-mento di un fondo di colore azzurro trasparente, mentre nella 107 un orlo svasato, tagliato e arrotondato, a collo ci-lindrico di colore azzurro trasparente e un fondo con resti di parete, di colore verde trasparente, dal corpo tubolare, leggermente espanso verso il fondo sul quale si imposta un collo cilindrico6 (Fig.2).
3 Calvi 1968, pp. 31-324 Calvi 1968, pp. 31-325 Maccabruni 1983, p. 112; Calvi 1968, p. 33; per un con-fronto tipologico vedi Lissia – Zandi 1994, p.1136 Lissia – Zandi 1994, p. 113
I balsamari dovevano essere oggetti a bassissimo costo, il cui unico scopo era quello di fungere da recipienti monouso per essenze e olii destinati ai funerali, o comunque conte-nere aromata, forse non di gran pregio, per il commercio al minuto; gli artigiani soiavano quindi a canna libera per produrre delle iale che rispondessero a requisiti utilitaristi-ci, ma nella cui fabbricazione non vi fosse interesse ad alcu-na ricerca formale o stilistica7.
CoppetteDue frammenti di fondi, rinvenuti nell’unità 102, corri-spondenti ad un piede ad anello, cavo all’interno, di color giallo/marrone trasparente8, e ad una decorazione parietale a “cordoncino” in rilievo, acromo e semitrasparente, po-trebbero ricondursi a delle coppette, probabilmente usate come recipienti per miscelare e servire. Questi utensili pos-sono considerarsi come un’evidente derivazione da prototi-pi metallici. La cronologia sembra circoscritta alla seconda metà del I secolo d.C.9
AryballoiLe unità stratigraiche 102 e 106 hanno restituito inoltre 2 piccole anse riferibili probabilmente, in virtù di confronti stilistici e morfologici, a degli aryballoi. Queste 2 ansette possono deinirsi nastriformi e dovevano essere attaccate in 2 punti sulla spalla del vasetto. Dallo strato 102 proviene quella color verde scuro che termina con un risvolto supe-riore verso l’esterno riconducibile alla forma n. 61 Isings10; l’altra, invece, dell’US 106 - sempre confrontabile con la forma 61 Isings e con il tipo 10 De Tommaso11 - è legger-mente più piccola, con una colorazione tra il verde e il mar-rone chiaro (Fig. 3). Possono ascriversi approssimativamen-te intorno alla seconda metà del I sec. d.C.L’aryballos è un piccolo vaso per profumi e olii, di solito ovale o di forma globulare, con il collo stretto e due ansette poste lateralmente. La produzione in vetro di questa tipo-logia di recipiente, in Italia, è attestata a partire dalla prima metà del I sec. d.C., e doveva essere connessa all’uso terma-le; spesso poteva essere fornita di catenelle bronzee per la sospensione12.
BicchieriUn unico frammento nell’US103 è ascrivibile ad un bic-chiere: si tratta di un fondo con piede a disco, di spessore medio, somigliante alle forme nn. 34 o 37 della classiica-zione Isings13, con cronologia attestata nella seconda metà dei I sec. d.C.Generalmente i bicchieri potevano essere di grandi, me-die e piccole dimensioni; avere corpo ovoidale, cilindrico, campaniforme o rastremato verso la base; presentare spesso la parete decorata e il fondo piatto con piede ad anello o conico.
7 Gabucci 2000, p. 948 Toniolo 2000, p. 292 n. 2899 Gabucci 2000, p. 96; per il confronto tipologico vedi Rava-gnan 1994, p.191 n.38010 Ravagnan 1994, p. 44 n. 52, tav. V11 De Tommaso 1990, p. 4412 Mollo – Framarin 2002, p. 1813 Toniolo 2000, p. 103 n. 238, tav. IV
Fig. 2. Frammenti di unguentari a corpo tubulare ritrovati nell’US 102 e nell’ US 107
1
1
2
2
3
Fig. 3. Anse di Aryballoi : dall’US 106 e dall’US 102
9
PiattiIl motivo ondeggiante in rilevo con sfaccettature, che caratte-rizza un frammento di orlo rinvenuto nell’US 106, potrebbe riferirsi ad una ciotola o ad un piatto, date le grandi dimensioni. Un esemplare di piatto con decorazione simile si trova nel museo archeologico di Murano14, inquadrato cronologica-mente nella seconda metà del I sec. d.C.15 (Fig. 4). I piatti, le cui caratteristiche morfologiche erano varie - di forma cilindrica, troncoconica, conica o carenata; con orlo tagliato o orizzontale, o labbro ingrossato, a cordoncino, ar-rotondato, ripiegato all’esterno; parete verticale, sagomata o svasata e leggermente concava; fondo piatto o concavo, o base con piede ad anello o con basso piede svasato16 - ovvia-mente trovavano ampio utilizzo per le esigenze della mensa, ben accolti per la loro funzionalità e impermeabilità. Come già detto in precedenza, anche i piatti traevano ispirazione dai contemporanei servizi in ceramica: le forme apode, ana-loghe alle patere della sigillata, ricorrono frequentemente nel I secolo, realizzate in vetro comune azzurro e verde17. Lo studio di tali suppellettili vitree si è rivelato essenziale al ine di ricavare dati importanti su alcuni aspetti ancora non chiari, relativi a questo contesto; ad esempio, circa le fasi di vita e di utilizzo del balneum, che si possono circoscrivere intorno al I secolo d.C., ma anche riguardo le tipologie di utensili più difuse e utilizzate. Si auspica che le ulteriori indagini archeologiche che si efettueranno nei prossimi anni siano foriere di nuovi ele-menti utili a fare maggiore chiarezza.
Maria Teresa Levanto, Viviana Sia
14 Ravagnan 1994, p. 224 n. 45115 Newby - Painter 1991, pp. 13-14, tav. IV c16 Ferrari 1998, p. 18117 www.iccd.beniculturali.it/getFile.php?id=175
I materiali numismatici dal balneum
Nel settore di scavo riconosciuto come ambiente termale, sono state recuperate tre monete che formano (anche se il campione è troppo esiguo, per essere considerato un dato aidabile) un ritrovamento molto coerente per nominali e intervallo tem-porale. Si tratta di tre Assi di epoca imperiale che vanno dal primo anno del principato di Domiziano alla metà di quello di Traiano. Più speciicatamente, abbiamo un Asse dell’imperato-re Domiziano (inv. 23) datato all’81 d.C., con al rovescio Mi-nerva nell’atto di scagliare una lancia, tipologia molto comune nella monetazione di Domiziano, che considerava Minerva la sua divinità tutelare: l’esemplare risulta sostanzialmente ben conservato anche se usurato da una lunga circolazione. Abbia-mo poi due Assi dell’imperatore Traiano, databili entrambi nell’arco temporale che va dal 103 al 111 d.C.Il primo Asse con al rovescio la Fortuna stante con cornucopia e timone si presenta in discreto stato di conservazione, anche se con alcune concrezioni e punti di corrosione; l’usura della capigliatura del ritratto sembra indicare una media circolazio-ne. Il secondo Asse ha come rovescio una vittoria che innalza un trofeo di armi, chiara allusione alle vittoriose campagne mi-litari che Traiano aveva condotto contro la Dacia; scarsa risulta la conservazione di questo esemplare che presenta mancanze di metallo del tondello ed estese concrezioni che pregiudicano in alcuni punti la lettura della moneta, tanto che non è in que-sto caso possibile stabilire il livello di usura da circolazione.
Paolo Caponnetto
Inventario n. 23 Nominale: Asse.Autorità emittente: Impero Romano, imperatore Domiziano.Dritto: Testa laureata di Domiziano a destra. Scritta: Nell’intorno “IMP. CAES. DIVI VESP. F. DO-MITIAN. AVG. P.M.” (Imperatore Cesare Domiziano Augusto Ponteice Massimo, iglio del divo Vespasiano).Rovescio: Minerva avanza a destra brandendo un giavel-lotto e reggendo uno scudo tondo.Scritta: Nell’intorno “TR.P. COS. VII DES. VIII P.P.” (Tribuno della plebe, console per la settima volta e designa-to per l’ottava, padre della patria) nel campo “SC” (senato consulto).Peso: g 9,7 Diametro medio: 26 mm Metallo: AEZecca: Roma Posizione dei conii: 200°Data: 81 d.C. Osservazioni: Moneta in patina verde sme-raldo di modulo regolare e ben centrata, molto usurata dal-la circolazione, con piccoli punti di corrosione sia al dritto che al rovescio.Bibl.: RIC vol. II Domiziano n. 237 Londra 1926 ristam-pa 2001
Fig. 4. Frammento di orlo decorato proveniente dall’US 106
10
Gli “anforischi” di Castrum Novum: una tipologia in cerca di identità
Gli scavi efettuati a Castrum Novum all’interno del bal-neum dal 2010 al 2013 hanno restituito un numero esiguo di manufatti in terracotta aferenti alla cosiddetta classe dei “vasetti ovoidi e piriformi” denominati comunemente “an-forischi”. I “vasetti”, dalla morfologia piriforme, sono stati rinvenuti nelle immediate adiacenze dell’ingresso dell’ipocausto rela-tivo all’ambiente A3 (nn. 2, 3, 4). Un quarto “anforisco”(n. 1) è emerso lungo il muro di fondazione (USM 9) dell’am-biente A4. Il numero 4 proviene dallo strato 118 mentre gli altri esemplari sono stati ritrovati all’interno di uno strato inquinato da depositi di terra successivi allo scavo del 1970 e per questo denominato US 0. Il numero 3 era ricoperto da una scura patina di cenere derivante dal contatto con l’area di combustione dell’ambiente A3 identiicato con il calda-rium dell’impianto termale.1. Vasetto piriforme, ricomposto da due frammenti comba-cianti perfettamente, corrispondente al tipo Pavolini 16b. Campagna di scavo 2010. Zona A, Settore I, US 0. Alt. cm 15, diametro orlo cm 6,5, espansione massima cm 6,5. Orlo distinto dal corpo, inclinato verso l’interno. Puntale qua-drato pieno. Argilla beige chiara, porosa e friabile, tracce di engobbio nocciola. Presenza di piccoli crateri e grumi di argilla sulla pancia al massimo dell’espansione. Scanalature sulla supericie. Probabili tracce di pece all’imboccatura1. (ig. 1)2. Vasetto piriforme corrispondente al tipo Pavolini 15b. Campagna di scavo 2011. Zona A, Sett. 1, US 0. Alt. cm 10, diametro orlo 4,5 cm, espansione massima cm 4,5. Orlo frammentario non distinto dal corpo. Argilla rosata. Punta-le pieno. Scanalature sulla supericie (Fig. 2)3. Vasetto piriforme corrispondente al tipo Pavolini 15b. Campagna di scavo 2011. Zona A, Sett. 1, US 0 Alt. cm 7, espansione massima 4,5 cm. Privo dell’orlo. Argilla rosata. Puntale pieno. Scanalature sulla supericie (Fig. 3)4. Vasetto piriforme, integro, corrispondente al tipo Pavoli-ni 15b. Campagna di scavo 2013. Zona A, Sett. 1, US 118. Alt. cm 11, diametro orlo cm 5, espansione massima cm 5,3.Orlo non distinto dal corpo. Argilla beige chiara con inclusi di colore bianco e tracce di mica. Piccolo cratere sulla super-icie del corpo. Puntale pieno. Scanalature sulla supericie (Fig. 4).
Nell’ambito della ceramica comune, questa particolare ti-pologia non ha trovato una deinizione precisa in quanto la sua destinazione d’uso sfugge ancora a qualsiasi tentativo di
1 Questo particolare notato dalla scrivente sull’imboccatura del “vasetto” potrebbe risultare di grande importanza per stabilire non tanto il primario quanto uno dei numerosi criteri di utilizzo di questa tipologia di manufatti come vedremo in seguito. Il rico-noscimento del pigmento scuro come pece, indelebile e dall’in-confondibile odore catramoso sulla supericie del vasetto è stato possibile grazie ad un’analisi empirica suggerita dall’amico ed esperto in archeologia sperimentale Pino Pulitani. Ovviamente una risposta certa può essere data solamente da analisi di labo-ratorio.
interpretazione.La classiicazione tipolo-gica seguita da queste bre-vi note è quella stabilita da Pavolini, basata sullo studio dei materiali pro-venienti dalle Terme del Nuotatore di Ostia2. Come aveva già chiarito lo studioso, essendo mate-riale proveniente da depositi, il criterio adottato è esclusiva-mente tipologico. Da qui scaturisce la necessità di efettuare approfondimenti e confronti su materiali simili provenienti da contesti stratigraici nel tentativo di stabilirne l’esatta cronologia e funzione. Riguardo quest’ultima sussistono
2 Pavolini 1980, pp. 993-1020 con una ricca bibliograia pre-cedente. I “vasetti” sono distinti in 18 tipi principali compren-denti forme ovoidi e piriformi. A queste ultime sono da colle-gare i “vasetti” castronovani che risultano così appartenere alla tipologia più complessa ed articolata suddivisa 3 gruppi in base alle caratteristiche dell’orlo che può presentarsi parzialmente di-stinto, distinto oppure non distinto dal corpo: Pavolini 1980, pp. 1000-1004.
Fig. 1. Vasetto piriforme n. 1, tipo 16b.
Fig. 2. Vasetto piriforme n. 2, tipo 15b.
Fig. 3. Vasetto piriforme n. 3, tipo 15b.
Fig. 4. Vasetto piriforme n. 4, tipo 15b.
11
ancora dubbi e interrogativi poiché le svariate ipotesi avan-zate circa la funzione dei “vasetti” non sono state sufragate totalmente da un riscontro archeologico oppure risultano prive di corrispondenza univoca il che farebbe pensare a casi di riuso del manufatto piuttosto che alla sua funzione pri-maria.Vale la pena di ricapitolare le principali teorie circa l’uso di questi manufatti ancora in cerca di identità e soprattut-to di un termine che indichi il perché della loro genesi. In accordo con l’opinione corrente, nel presente studio viene mantenuto il generico nome di “vasetti”3 indicante appunto questi particolari manufatti ceramici conluiti nella più am-pia produzione di ceramica comune, accanto a forme ben deinite nella funzione e nella nomenclatura.Cominciamo con un breve identikit utile a delineare le caratteristiche morfologiche dei “vasetti” per poi passare all’analisi delle interpretazioni circa il probabile uso cui erano destinati. Essi risultano essere di fattura grossolana, a volte rozza, tale da delineare un proilo irregolare e asim-metrico, privi di anse, con un piccolo puntale generalmente cilindrico, che priva il “vasetto” della possibilità di reggersi in modo autonomo e imboccatura svasata, a volte esagera-ta. Il collo presenta una strozzatura più o meno accentuata e il corpo un’espansione più o meno evidente nella parte centrale, presente con scanalature a spirale, caratteristiche che rendono tali vasetti simili a piccole anfore e che hanno dato origine alla loro denominazione corrente: anforischi4. In corrispondenza della parte centrale del corpo sono evi-denti piccoli grumi di argilla e piccole cavità, imperfezioni causate dallo stretto contatto dei vasetti durante la fase di essiccazione5. L’altezza rilevata dai campioni ostiensi (poco più di 300) è compresa tra i 6,5 e i 19,3 cm6.Il grande dilemma circa l’uso di questi “curiosi” manufatti ha coinvolto una grande schiera di studiosi. Tenteremo di riassumere brevemente, cominciando dalla teoria più difu-sa secondo la quale i vasetti venivano usati per chiudere le anfore da trasporto, rovesciati e inilati nel tappo di sughero, legno o altro materiale issato al collo dell’anfora mediante pece, argilla o gesso7. In questo modo il corpo del vasetto sporgente all’esterno era usato come presa per estrarre il tappo, manovra facilitata dalle scanalature presenti sulla sua supericie8. Anche Emilio Rodriguez Almeida stabilì un
3 Carlo Pavolini dichiara di aver preferito mantenere la generica deinizione usata in OSTIA I-IV poiché sulla funzione dei “va-setti”, anche al termine della mia indagine, permangono dubbi e interrogativi: Pavolini 1980, p. 993.4 In realtà la denominazione di “vasetti ovoidi e piriformi” risul-terebbe impropria per il tipo n. 8 che tende ad assumere forma ci-lindrica: per le particolarità morfologiche si rimanda a Pavolini 1980, pp. 994-995. 5 La presenza di queste reiterate imperfezioni sulla supericie dei “vasetti” denota uno scopo utilitaristico dei manufatti, privi di qualsiasi attributo estetico, ed assimilabili a semplici oggetti d’uso: Pavolini 1980, pp. 994-995.6 Pavolini 1980, p. 995. 7 Pavolini 19808 Questa teoria avanzata da Loeschcke nel 1939 suggerirebbe piuttosto una funzione di cavatappi di anfora, sulla scorta forse dell’impiego di pigne issate all’interno di tappi di sughero delle anfore della nave di Albenga : Pavolini 1980, pp. 1009-1010 con bibliograia precedente.
nesso tra “vasetti” e anfore formulando una teoria tecnica-mente valida ed esauriente che potrebbe essere ora sufra-gata dal ritrovamento da parte di chi scrive dell’anforisco 1 di Castrum Novum. Secondo lo studioso spagnolo i vasetti venivano usati come ventose o cucurbitula9 per aprire i tappi delle anfore10. Spalmata l’imboccatura con la pece bollente, il vasetto veniva poggiato sulla supericie del tappo e grazie alla condensazione dell’aria all’interno del corpo ceramico si provocava una trazione per aspirazione che riusciva a sfal-dare la malta o il gesso che issavano il tappo al collo dell’an-fora, favorendo così l’apertura del contenitore11. Premetto che Pavolini, pur considerando la teoria molto interessante e plausibilissima dal punto di vista tecnico, sottolineò la mancanza di un riscontro documentabile unendo a ciò la constatazione circa la totale assenza di pece sull’imbocca-tura dei “vasetti” ostiensi12. Come già si è accennato, le pro-babili tracce di pece sull’imboccatura dell’ “anforisco” 1 di Castrum Novum potrebbero costituire un elemento a favore della teoria di Almeida. Tra le varie altre ipotesi di utiliz-zo dei “vasetti” come lampade13, unguentari14, elementi per la costruzione di volte15, unità di misura16, quella avanzata dalla Annecchino, come possibili ritilli, ossia bossoli per il
9 Il termine adottato da Almeida deriva dalle analogie dei “vaset-ti” con lo strumento chirurgico adoperato dai medici romani per efettuare i salassi in relazione alla forma e al funzionamento (Cfr. BUONOPANE, 2011, pp. 123-129.j10 RODRIGUEZ – ALMEIDA 1974, pp. 813-81811 Una descrizione particolareggiata del funzionamento della ventosa a trazione mediante aspirazione in RODRIGUEZ-ALMEIDA 1974, pp. 815-817. Un’errata interpretazione della teoria di Almeida in Disantarosa 2009, pp. 134-135 che vede i cucurbitula usati per aspirare l’aria e consentire la conservazione dei prodotti sotto vuoto.12 Pavolini 1980, pp. 1010-1011.13 Questa teoria formulata da ValneaScrinari si basa sull’osserva-zione morfologica dei vasetti, che in presenza del fondo a pun-tale, venivano inilati nei lampadari mediante appositi sostegni: Pavolini 1980, pp. 1011-1012. L’analisi dei vasetti ostiensi non ha però restituito nessuna traccia di bruciato che possa avallare l’interessante ipotesi: ibidem.14 La corrente anglosassone propende per questa interpretazione anche se è stato osservato che unguentari e lacrimatoi, oltre ad avere una base di appoggio, presentano una fattura meno grosso-lana rispetto a quella riscontrabile nei nostri “vasetti”: Pavolini 1980, p. 1011. L’utilizzo in ambito funerario inoltre potrebbe es-sere documentato da alcuni ritrovamenti, in particolare presso le necropoli di Ampurias e di Tarragona: Pavolini 1980, p. 1011; Disantarosa 2009, p. 134, nota 84.15 L’utilizzo come elementi costruttivi delle volte è documentato soltanto per il tipo 9 o campaniforme, più adatto allo scopo ri-spetto al tipo ovoide e piriforme, riscontrato a Pompei nella volta di un forno fuori Porta Ercolanese: Pavolini 1980 p.1011. Per la costruzione delle volte, invece, era impiegato il comunissimo tubo ittile cilindrico con piccolo puntale attestato in Africa a partire dal II secolo d.C. e largamente difuso ino al VII nell’ar-chitettura imperiale, tardoantica e paleocristiana: Arslan, 1965, pp. 45-53; Pavolini 1980, p.1011 con bibliograia precedente. 16 L’ipotesi di utilizzo dei “vasetti” come unità di misura per la me-scita nella vendita al dettaglio del liquido contenuto nelle anfore in : Disantarosa 2009, p.135 con bibliograia precedente.
12
gioco dei dadi17, era stata inora l’unica ad avere avuto un riscontro archeologico grazie al ritrovamento di un vaset-to piriforme con un dado incastrato nel collo all’interno di una sepoltura nella necropoli romana di Bevagna18.Le due ipotesi a confronto, ritilli o cucurbitula, fanno ri-lettere. Mentre per i ritilli non si spiegherebbe il perché del collo a volte troppo stretto per la fuoriuscita del dado, per l’ipotesi del vasetto-ventosa questo particolare non cre-erebbe alcuna diicoltà.ll ritrovamento del piriforme con il dado incastrato nella tomba potrebbe essere legato ad un uso secondario del ma-nufatto mentre la presenza della pece sull’imboccatura del vasetto potrebbe accordarsi con la funzione di cucurbitula avanzata da Almeida avvicinando così i “vasetti” al mondo del commercio e alle anfore anche se resterebbe da chiarire come mai una simile tipologia ceramica sembra terminare quasi improvvisamente, alla ine del II secolo d.C19.I vasetti nn. 2, 3, 4 corrispondono per caratteristiche mor-fologiche al tipo 15b della tipologia delineata da Pavolini, la quale, attestata a partire dalla seconda metà del I secolo d.C. (attestazioni a Pompei, Albintimilium, strati di età la-via delle Terme del Nuotatore di Ostia), rivela una maggiore concentrazione in età traianea20.Il vasetto n. 1 appartiene invece ad una tipologia che si di-stacca nettamente dal punto di vista cronologico dalla pre-cedente. Il tipo 16b, con il quale il nostro vasetto può essere identiicato, appartiene ad una produzione compresa tra la ine del I e la ine del II secolo d.C. Le attestazioni mag-giori si hanno in età adrianea, periodo in cui le altre pro-duzioni tendono a scomparire. Di contro all’afermazione di un’estinzione in epoca severiana21, alla luce di studi più recenti, si ritiene ora che la produzione, per quanto riguarda i dati di Ostia, non raggiunga la ine del II secolo d.C.22
Riscontri notevoli si hanno con le produzioni ostiensi anche per quanto riguarda le caratteristiche delle argille. L’argilla rosata dei tipi 15b è aine a quella delle principali tipolo-gie (brocche, bottiglie) attestate in grande quantità nelle stratigraie delle Terme del Nuotatore fra l’età lavia e l’età traianea23. Dal momento che le caratteristiche delle argille, pur nella loro varietà, non trovano riscontro nelle produzioni di anfo-re da trasporto provenienti dalle varie province imperiali da-tabili fra il I e il II secolo d.C. , è lecito ipotizzare la presenza di una produzione locale e con forme proprie in mancanza di ulteriori notizie relative a forni e scarichi24.
17 Pavolini 1980, p. 1012; DISANTAROSA 2009, p.134.18 Pavolini 2000, p.375; DISANTAROSA 2009, p. 134 nota 84.19 Da tenere presente che le indicazioni cronologiche fornite dalla bibliograia esistente e dai contesti ostiensi editi e inediti sono abbastanza scarse e per questo suscettibili di approfondimenti e rettiiche. Come scrive Pavolini: l’afermazione che il periodo di massima o esclusiva utilizzazione concida con il I sec. d.C., fatta propria da molti di coloro che se ne sono occupati, risulta abba-stanza discutibile. E ancora più dubbia è l’epoca della loro scom-parsa: Pavolini 1980, p. 1004.20 Idem, pp. 1004-100921 Idem, p. 1009; Pavolini 2000, p.376.22 Ibidem23 Pavolini 1980, p. 1008.24 Pavolini 1980, pp. 1007-1009.
Il tipo 16b, presente a Castrum Novum con un unico esem-plare, presenta caratteristiche ceramiche diferenti. L’analisi dei vasetti ostiensi della medesima tipologia aveva rivelato l’atipicità dal punto di vista della consistenza dall’argil-la, morbida o addirittura farinosa, non riscontrabile negli altri tipi. L’ipotesi di Pavolini è che i tipi 16-17 siano di produzione non locale e non italica e provenienti da zone di formazione vulcanica del Mediterraneo ad esclusione dell’Africa settentrionale25, evidenziando così, nell’ambito dello studio della ceramica comune ostiense, una prevalenza quasi assoluta delle produzioni locali e romane o comunque italiche26, ino ai primi decenni del II secolo d.C., sostituite a partire da quest’epoca da manufatti d’importazione pro-vinciale27.Le caratteristiche tecniche dei vasetti 15b di Castrum No-vum essendo identiche a quelle sopracitate e riconducibili quindi ad aree di produzione laziale o romana non ofrono spunti di rilessione diversi da quelli indicati nell’excursus relativo alla funzione d’uso. Al contrario il vasetto 16b, di provenienza presumibilmente provinciale, potrebbe co-stituire una prova concreta, un unicum, di un uso legato strettamente alla sfera del commercio e dei contenitori da trasporto.La questione relativa a questa particolare ed enigmatica clas-se ceramica enunciata nel titolo di questa breve messa a pun-to rimane ancora aperta. In ultima analisi resta comunque valido il concetto di versatilità e multifunzionalità di un og-getto che, a prescindere dalla sua funzione d’uso primaria, poteva essere applicato, sia per la praticità della sua forma sia per la resistenza del materiale impiegato, in vari ambiti della vita quotidiana28.
Alessandra Squaglia
25 In Pavolini 1980, pp.1008-1009, si formulava l’ipotesi di una provenienza ispanica, come “merce d’accompagno” in relazione alle anfore da garum importate ad Ostia. Allo stato attuale, in at-tesa di un’analisi chimica delle argille, l’ipotesi è ancora al vaglio in quanto nessun manufatto tra quelli presenti ad Ostia con le stesse caratteristiche ceramiche è riferibile con certezza a produ-zioni spagnole (Pavolini 2000, pp. 377-378, in part. nota 16). 26 Altre aree di produzione di “vasetti” erano presenti, oltre che ad Ostia, nel suburbio di Roma come documentano gli scarichi del-la fornace di La Celsa sulla Via Flaminia (Pavolini 2000, p.376, nota 11). Inoltre la fornace individuata presso Villa Sciarra sul Gia-nicolo stabilisce con certezza che i “vasetti” erano prodotti anche a Roma (Pavolini 1980, pp.1012-1013, nota 44).27 Idem, p.100828 Idem, pp. 1012-1013; Pavolini 2000, p. 375
13
I materiali lapidei da costruzione
In questo articolo, che vuole essere soltanto uno studio preli-minare sui materiali lapidei rinvenuti nel contesto della Villa de “Le Guardiole”, non ci sofermeremo troppo sulla geologia del territorio, assai complessa, ed escluderemo la trattazione dei laterizi, con l’intenzione di rimandare il tutto ad un successivo lavoro più approfondito. Il comune di S. Marinella si trova nel cosiddetto comprensorio dei Monti della Tolfa, un’area geologica di circa 75.000 ettari. Lo strato su cui oggi viviamo era anticamente un fondale mari-no che emerse nel periodo miocenico-pliocenico1 causando la
nascita dell’odierno Lazio; testimonianza di tale sollevamento è il lysch (dallo svizzero “china scivolosa”). Questo basamento se-dimentario di potenza chilometrica è il risultato di un comples-so susseguirsi di alternanze stratigraiche sedimentarie e copre tutto il territorio corrispondente all’antica Castrum Novum, mentre sono assenti pietre dure (basalto, granito) e tui. La pre-senza unicamente di rocce sedimentarie ne comportò un sfrut-tamento intenso già durante il bronzo inale (facies protovilla-noviana) con il primo sinecismo (incastellamento) dei Monti della Tolfa e continuò sia in epoca etrusco-romana2 che in quel-la altomedioevale. Analizzando l’ordine crono-stratigraico dei tanti strati litologici possiamo afermare che furono impiegati, a causa della loro maggiore compattezza, quattro principali tipo-logie litiche: Calcare lyscioide, Macigno, calcarenite bioclastica e travertino. Il lysch della Tolfa3 è diviso in due serie crono-stra-tigraiche (una argilloso-calcarea risalente al cretaceo-oligocene ed una calcareo-marnosa riconducibile all’oligocene-miocene) ed è formato da strati sedimentari torbiditici in alternanze cicli-che di livelli di arenaria, argilla, marna, argilloscisti varicolori e calcare. Al suo interno4 è presente un calcare duro e paesinizzato di colore giallo, conosciuto comunemente come Pietra Paesina (Pp) e assimilato all’Alberese toscano. Il Macigno (dal latino machineus, macina) è un’arenaria quarzoso-feldspatica a ce-mento calcareo-argilloso a grana medio-ine e la sua deinizione geologica è ancora controversa a causa dell’utilizzo generico del termine “macigno”. Riferendoci alla serie Toscana, ma senza di-lungarci troppo, possiamo dire che alla semplice analisi visiva se
ne possono distinguere tre tipi: la cosiddetta Pietraforte (Mp), dura e compatta e di colore grigio bruno o marrone giallognolo, si sfalda in modo cipollare al gelo; la cosiddetta Pietra morta o “bigio”(Mb), di aspetto pulverulento e friabile all’attrito, pre-senta un colore bruno o, se alterato, tendente al rosso; inine la cosiddetta Pietra serena (Ms), di colore azzurrognolo e facil-mente lavorabile. La calcarenite bioclastica è un’ arenaria sedi-mentata con sabbia giallognola e calcare organogeno (gusci di ostreidi, pettinidi, gasteropodi). Ne esistono due tipi, contigui in strato ma diferenti per aspetto e quantità di gusci calcarei: uno, più rimescolato, è detto Macco tarquiniese ed un secondo, più compatto, si presenta in lastroni simile alla Pietra panchina toscana (Pct). Il travertino (Tr), una roccia calcarea di colore biancastro con possibili striature ocra, si è formato per deposito chimico di carbonato di calcio e nel nostro comprensorio è per lo più idrotermale. I suoi principali aioramenti si trovano nei pressi di Civitavecchia e S. Severa (Loc. Pian Sultano nel comu-ne di Tolfa).
Nella villa romana de “Le Guardiole”5 si riconosce una continu-ità di vita che spazia all’incirca dal III sec. a.C. al III sec. d.C. In questo lungo periodo la struttura ha subito varie modiiche ed integrazioni, spesso efettuate anche con l’impiego di materiale di recupero.6 Da una prima analisi si evince che il materiale la-pideo maggiormente utilizzato è il macigno (Mp, Mb) (Fig. 2) seguito dall’arenaria (Pct) e in minima parte da altre rocce come ghiaia di iume, Pietra paesina e Pietraforte di colore grigio bru-no. Attraverso uno studio ricognitivo del comprensorio di Ca-strum Novum si sono individuati almeno quattro siti utilizzati come cave (Fig. 1). Di queste, due erano in uso già in epoca etru-sca e il materiale qui estratto si ritrova nelle murature a secco del vicino pagus etrusco della Castellina del Marangone. A causa della ricostruzione del porto di Civitavecchia le cave in questio-ne subirono un grande sfruttamento nel secondo dopoguerra e in quella delle Volpelle (Fig. 3) da cui si estrae Pietra panchina toscana fu scoperta una tomba etrusca ad edicola7 costruita con lo stesso materiale. Lungo la costa di Torre Chiaruccia sono in-vece presenti iloni di Mp e Mb, naturalmente fratturati in bloc-chi (Fig. 4) e palesemente assimilabili a quelli impiegati nella muratura della villa, sia per l’aspetto torbiditico che colorime-trico. Lo spessore dei blocchi in macigno risulta poi essere quello naturale dello strato geologico (l’aioramento appariva come un’ampia pavimentazione dello spessore medio di 30 cm; l’estra-zione avveniva facendo leva tra le tante fratture naturalmente
Fig. 1 Veduta aerea di Capolinaro : 1- Zona di estrazione adiacente Torre Chiaruccia, 2-Castrum Novum, 3-Villa de“Le Guardiole”, 4-Cava de “La Castellina”, 5-Cava delle Volpelle, 6-Poggio de “La Castellina”, 7- Cava di Poggio del Principe. Fig. 2 Parte di muratura del balneum attinente la villa, 1- blocchi
di macigno “bigio”, 2- macigno “pietraforte”, 3- pietra panchina
14
presenti nel banco e solo qualora la lastra avesse presentato una supericie troppo ampia veniva spaccata manualmente in pezzi più piccoli). In base allo studio fatto sulla romanizzazione dei Monti della Tolfa risulta che in epoca repubblicana, per i primi ediici, si preferì utilizzare materiale lapideo locale piuttosto che importato, il che comportò l’apertura di piccole cave il più pos-sibile vicino al luogo di messa in opera (esempi sono in località Macchia di Freddara, Sferracavallo e Mattonara).
Proprio sulla base di questa afermazione possiamo ritenere di aver individuato la provenienza di alcuni materiali come ad esempio la Pietra panchina toscana che veniva estratta dalla vi-cina cava delle Volpelle (seppure nel caso speciico si può, a ra-gione, ipotizzare l’utilizzo di blocchi provenienti dalla necropo-li del vicino abitato etrusco della Castellina e reimpiegati nella struttura in questione). Il macigno Mp e Mb proviene invece da una cava costiera nei pressi di Torre Chiaruccia, probabilmente ad oggi scomparsa a causa dell’innalzamento del livello marino8 rispetto all’epoca romana. Per quanto riguarda inine la prove-nienza degli altri materiali lapidei, questa richiede un ulteriore approfondimento ma ne possiamo comunque supporre un am-bito corrispondente al comprensorio di S. Marinella.
Glauco Stracci
1 Alberti et al. Note illustrative della carta geologica d’Italia 1:100000. Foglio 136 Tuscania. Foglio 142 Civitavecchia, 1970. 2 Bastianelli, L’abitato etrusco sul poggio detto La Castellina. Ass.arch.Centumcellae, Boll., n.6, anno XV, 1981. 3 Civitelli, Corda, Nuovi dati sulla Pietraforte. Geologica romana, 21, 1982. 4 Civitelli et al., Alcune considerazioni sulla genesi della Pietra Paesina. Geologica romana,9, 1970. 5 Enei et al., Castrum Novum, quaderno 1, 2011. 6 Gianfrotta, Castrum Novum, Forma Italiae, Regio VII, III, 1972. 7 Toti , Rinvenimento di tre tombe etrusche tarde nel territorio ca-stronovano, Not. Scavi, vol. XV, 1961.8 Schmiedt, Il livello antico del mar Tirreno, 1972.
Fig. 3 Cava delle Volpelle.
Fig. 4 Aioramento di Macigno “Pietraforte.”
1.2 L’ediicio a pianta quadrata sull’antica via Aurelia
Le nuove indagini svolte tra il 2011 e il 2013 hanno per-messo di approfondire la conoscenza del complesso a pianta quadrangolare, a suo tempo deinito “villa”, aperto direttamente sulla via glareata che si è voluto identiicare con la sede della via Aurelia Vetus1 (Area A settore II). La ri-pulitura delle strutture messe in luce in occasione degli sca-vi del 1970 e l’esplorazione di alcuni settori all’epoca non indagati, ha consentito di acquisire una nuova planimetria dell’ediicio e di raccogliere ulteriori informazioni, relative alla sua frequentazione e alle diverse fasi edilizie2 (Figg. 1, 2). Numerosi nuovi dati sono emersi dai recenti scavi, no-nostante le evidenti spoliazioni, avvenute nei secoli, che hanno comportato la scomparsa totale degli alzati e anche
di gran parte dei crolli antichi, asportati per il recupero dei materiali da costruzione. Rimosso lo strato di circa 20 cm di humus che ricopre i resti delle strutture è iniziata l’in-dagine della stratigraia ancora conservata all’interno degli ambienti e in diversi settori dell’area oggetto d’indagine.L’ediicio si presenta a pianta quadrata con lati di circa 22 metri, orientato nord-est / sud-ovest con accesso dalla stra-da, rivolto in direzione del mare, verso sud-ovest. L’intera costruzione risulta ediicata in pietra locale con muri for-mati da scapoli di calcare, macigno, scaglia, pietraforte e qualche ciottolo luitato uniti con argilla e poca malta ricca di calce (Cfr. p. 13). Una tecnica edilizia semplice con uso parsimonioso di laterizi limitato ad alcune speciiche strut-ture. Evidente all’interno delle murature il riuso di blocchi squadrati in scaglia, di certo pertinenti ad una fase edilizia più antica dell’ediicio stesso o di un altro sito nelle vicinan-ze. Nel suo interno la costruzione si articola in almeno 14 ambienti diversi per alcuni dei quali è stato possibile rico-noscere le originarie funzioni. I dati disponibili consento-no di ricostruire l’esistenza di un probabile portico, ampio circa 3 metri, situato sulla fronte dell’ediicio a protezione dell’ingresso (Ambiente 7). Di tale struttura restano le fondazioni del muro rivolto alla strada e quelle di due pila-stri che dovevano sorreggere il tetto.
1 Gianfrotta 1972, p. 115, sito 90.2 Per lo scavo degli anni Settanta Cfr. Gianfrotta 1972, pp.115-117.
Fig. 1. Panoramica generale dei resti dell’ediicio a pianta quadrata.
15
Fig. 2. Pianta dell’ediicio alla luce delle recenti acquisizioni degli anni 2012-2013. In evidenza i numeri degli ambienti (1 - 14) e la distribuzione delle monete (numeri piccoli). In marrone le strutture murarie, in azzurro i manufatti idraulici (vasche, pozzo, condotti), in giallo-arancio dolia e anfore usate come serbatoi, in rosso il praefurnium del balneum.
14
13
12 11
6
8
5
4
2
10
1
7
3
15
20
25
30 mt
10
5
4
3
2
1
0
0,5
16
Lo scavo ha evidenziato i resti dell’ultimo piano di calpestio, caratterizzato da un itto battuto di frammenti di scaglia nella zona sud, di ciottoli e frammenti di tegole nella parte nord dove, durante gli scavi del 1970, venne documentata la presenza dei resti di un dolio oggi non più rilevabili3. Le numerose monete rinvenute sul piano di calpestio (Cfr. pp. 28 - 37) e i resti di un macinello manuale in pietra lavica trovato sulla strada segnalano in loco la presenza di proba-bili attività commerciali (Fig. 3). Molto interessante anche il rinvenimento di un anello in argento in ottime condizio-ni di conservazione (Fig. 4). Il lato meridionale del portico sembrerebbe chiuso da un ambiente rettangolare, appog-giato alle murature preesistenti, con un lato interamente costruito in blocchi squadrati di scaglia di chiaro riutilizzo (Ambiente 10). Il ritrovamento al suo interno di un ago da rete e di un amo in bronzo, dei gusci di alcuni molluschi bivalvi e di un peso da bilancia potrebbe far identiicare il piccolo ambiente come possibile sede di una taberna gestita da pescatori, sita “fronte strada”, per la rivendita di pesce e molluschi (Fig. 5). L’ingresso principale dell’ediicio doveva aprirsi quasi nel mezzo del lato sud della costruzione in un tratto di muro oggi quasi scomparso a causa di antiche e moderne aspor-tazioni di materiale. Un secondo ingresso, sempre protetto dal portico, è invece ancora ben riconoscibile pochi metri più a nord. In questo caso si conserva la soglia della porta in lastre di scaglia, ampia circa 1,50 m, con ancora evidenti le tracce dell’alloggio dei cardini e la parte inferiore di un originario stipite laterale realizzato con lo stesso materiale (Fig. 6). Lo scavo dell’area circostante ha messo in luce i resti di un’anfora, una probabile Dressel 20, tagliata a metà ed inissa nel terreno subito sul lato destro dell’ingresso come probabile vaschetta di raccolta (Fig. 7). Di notevole interesse i dati provenienti dallo scavo dello strato di prepa-razione per l’alloggiamento della soglia, contenente alcuni
3 Foto in Gianfrotta 1972, p. 116, ig. 245.
Fig. 3. Il macinello in pietra lavica riusato in antico nel piano stradale
Fig. 4. Anello in argento dal piano di calpestio del portico (Ambiente 7).
Fig. 5. Materiali dall’Ambiente 10: 1. Amo da pesca in bronzo, 2. Peso da bilancia in pietra (312 gr), 3. Ago da rete in bronzo.
1
2
3
Fig. 6. Soglia della porta di accesso all’Ambiente 11
Fig. 7. I resti dell’anfora rinvenuta nel portico subito all’esterno della porta d’ingresso all’Ambiente 11.
17
frammenti di ceramica africana da cucina, databili nel I-II secolo d.C., che costituiscono un interessante terminus post quem per la messa in opera dell’elemento architettonico. Lo strato di preparazione copriva anche i resti di una con-duttura in piombo (istula aquaria) ancora collocata nella sua posizione originale, tagliata in due frammenti, passante subito al di sotto della porta (Fig. 8). L’interno dell’edii-cio è caratterizzato da uno schema regolare con ambienti distribuiti sui rispettivi lati di una zona centrale ancora non indagata, probabile atrio-cortile, e con un ampio porticato che chiude il lato opposto all’ingresso, appoggiandosi forse al muro di fondo della costruzione. Entrando sulla destra il lato meridionale è occupato da tre ambienti aiancati, di dimensioni e probabili funzioni diverse (Ambienti 2, 4, 5). L’Ambiente 2 si rivela una grande stanza a pianta quadrata, di 5 m. di lato, con murature spesse circa 60 cm (Fig. 9). Lo scavo tuttora in corso non ha ancora raggiunto livelli pavimentali ma nello strato di abbandono sono presenti interessanti reperti che potrebbero essere utili per l’identi-icazione della sua funzione e delle attività svolte nel suo in-terno nell’ultima fase di vita. Di particolare interesse appare il ritrovamento di un grande peso da bilancia in marmo di circa 31,2 kg, un grosso uncino, chiodi e parte di una staf-fa triangolare con sommità ad anello, un iltro in piombo, monete e gusci di molluschi marini (Figg. 10, 11). Insieme a questo genere di oggetti, riconducibili ad attività di lavo-razione di prodotti e possibile vendita, sono stati rinvenuti un balsamario in ceramica e un particolare piccolo oggetto in bronzo, caratterizzato da una lamina a forma di cuore sostenuta da un corto manico tornito, ricollegabili forse al maquillage femminile (Fig. 12).Molto interessanti anche i risultati dello scavo condotto nel vicino Ambiente 4 dove è stato possibile raggiungere il piano pavimentale formato da un battuto di terra, ciottoli luitati e calce (Fig. 13).
Fig. 8. La istula in piombo rinvenuta nell’Ambiente 11.
Fig. 9. L’Ambiente 2. Visione generale.
Fig. 10. Oggetto in ferro dall’Ambiente 2.
Fig. 11. Grande peso ovale in marmo (31,2 kg) con tracce dell’immanicatura per la presa. Dall’Ambiente 2.
Fig. 12. Piccolo oggetto in lamina di bronzo a forma di cuore con decorazione incisa sul margine (specchio mi ni a tu r i s t i c o? ) . Dall’Ambiente 2.
18
Nel pavimento è inserito un canaletto di scolo costruito con coppi rovesciati messi in opera con poca calce e argilla (Fig. 14). Tale canale doveva essere posto ai piedi di un probabile ban-co da cucina del quale restano solo labili tracce dei pilastri laterali di sostegno, in pietra e tegole legate con malta ricca di calce, lungo il lato sud della stanza. Nello strato di abban-dono che copriva il pavimento (US 18), sono stati rinvenuti numerosi frammenti di vasellame da cucina e da mensa che attestano la presenza di almeno 4 olle da fuoco, 3 coperchi, 2 tegami, 3 brocche, 2 anfore (Tipo Dressel 1) che insie-me ai resti di gusci di molluschi e carboni consentono di identiicare l’ambiente con una cucina provvista, inoltre, di almeno una piccola lucerna con becco ad incudine, una coppa in vetro, un bicchiere a pareti sottili, un piatto in si-gillata italica liscia e un balsamario in ceramica. Lo studio
preliminare dei materiali sembra inquadrare il contesto e la datazione dei reperti più recenti nell’ambito dell’epoca augustea o giulio-claudia.Ancora poche notizie ha fornito lo scavo appena iniziato dell’Ambiente 5 dove è tornata in luce una probabile soglia di porta, formata da più lastre in pietra, con uno scalino di ingresso alla stanza a pianta quadrangolare di 3,50x3,30 m (Fig. 15). All’esterno dell’ambiente, a ridosso del muro, è aiorato il fondo di un dolio ancora in posto, presso l’an-golo nord. Il dolium doveva essere collocato in piedi con la base interrata di circa 30 cm al di sotto dell’antico piano di calpestio (Fig. 16). Sul lato opposto rispetto agli ambien-ti descritti entrando nell’ediicio, sulla sinistra si trova una piccola stanza a pianta quasi quadrata, di m 2,50x2,40, con probabile porta d’ingresso sul lato rivolto a sud-est (Am-biente 1).
Fig. 13. Ambiente 4. Veduta generale.
Fig. 14. Ambiente 4. Il condotto inserito nel pavimento.
Fig. 15. Ambiente 5. Sulla destra i resti del probabile ingresso.
Fig. 16. I resti della base del dolio rinvenuti all’esterno dell’Ambiente 5.
19
Lo scavo ha messo in luce i lacerti dell’ultima pavimentazio-ne realizzata in terra battuta con ciottoli luitati, frammenti di tegole e poca calce, simile a quella rinvenuta nell’Am-biente 4 (Fig. 17). Nel piano di calpestio dell’ambiente sono stati riconosciuti i resti di un buco di palo con due frammenti di tegole usate come zeppe di riempimento, da interpretare come traccia relativa all’esistenza di una strut-tura lignea. Sul pavimento giacevano diverse monete due delle quali, un denario di Adriano del 134-138 d.C. e un dupondio di Commodo del 183 d.C., sembrano attestare la frequentazione della stanza nel pieno II secolo d.C. e pro-babilmente ancora nei primi decenni del seguente (Cfr. p. 30 nn. 2, 3). Quasi adiacente al lato NE. dell’Ambiente 1 è situato un pozzo con imbocco a pianta circolare di circa 80 cm, già in-dividuato in occasione degli scavi degli anni Settanta e mai completamente esplorato, a causa dell’acqua ancora presen-te al suo interno4. Intorno alla struttura rimangono i resti di una pavimentazione a lastre di pietra irregolari con una sorta di condotto formato da un coppo disposto in vertica-le, inserito sul margine appositamente scavato di una lastra e riempito da uno strato di terra con all’interno frammenti di un’anfora di tipo Dressel 2/4. Potrebbe trattarsi anche in questo caso di un buco di palo con i relativi materiali d’inzeppatura e riempimento (Figg. 18, 19).
4 Gianfrotta 1972, p. 115, ig. 243
Fig. 17. I resti dell’Ambiente 1. Visione generale.
Fig. 18. Visione dell’area circostante il pozzo con i resti di una pavimentazione a lastre di pietra.
Fig. 19. Frammenti di un’anfora tipo Dressel 2/4 usati come riempimento all’interno di un probabile buco di palo, insieme con parte di un coppo inisso in verticale.
Fig. 20. Ambiente 6. Visione generale.
Fig. 21. La vasca quadrata rivestita in opus signinum nell’Ambiente 6.
20
La presenza di una istula plumbea per l’adduzione dell’ac-qua inserita nella parete nord dell’ambiente e il pavimento su suspensurae lascia ipotizzare l’esistenza di una vasca per immersioni in acqua calda all’interno di quello che sembra essere un caldarium. Il riscaldamento avveniva tramite un forno rinvenuto adiacente al muro nord dell’Ambiente 6. L’aria calda veniva immessa sotto al pavimento tramite un canale, lungo circa 2 metri e largo 60 cm, con pareti rivesti-te in laterizi che si rivelano ipercotti e fortemente rovinati dall’esposizione al calore (Fig. 23).
L’intero lato nord-ovest dell’ediicio, alle spalle dell’Am-biente 1 e del pozzo, è caratterizzato dalla presenza di un piccolo complesso termale, un balneum comprendente una vasca fredda e almeno un ambiente riscaldato. Ben leggibile nella sua pianta rettangolare di 3,20x2,50 m, risulta essere l’Ambiente 6 all’interno del quale, presso l’angolo meri-dionale, è situata una vasca quadrata di circa 1,10 m di lato con fondo e pareti rivestite in opus signinum (Figg. 20, 21). La stanza, probabile rigidarium, al momento dello scavo presentava i resti di un pavimento in cubetti di laterizio di circa 10 cm, oggi scomparso5. Adiacente al lato nord si trova un altro ambiente (Ambien-te 13), a pianta rettangolare di m 5,00x3,50 circa, esplorato in occasione delle indagini degli anni Settanta e ora rico-perto al di sotto di una stradina vicinale in terra battuta. La struttura conservava in posto numerose pilae pertinenti all’intercapedine dell’impianto di riscaldamento, appog-giate su un fondo in sesquipedali. Tra le suspensurae risulta-vano crollati diversi grandi frammenti della pavimentazione musiva sovrastante, in origine stesa su un piano di mattoni bipedali (Fig. 22). Il mosaico, datato in epoca augustea, presentava il fondo “formato da tessere bianche, messe in opera orizzontalmente disposte a formare un intreccio a ca-nestro da cui ad intervalli regolari sporgono leggermente delle crocette di tessere nere con una bianca centrale, inse-rite in senso verticale, che danno luogo a ilari rettilinei”6.
5 Gianfrotta 1972, p. 115 ig. 2426 Gianfrotta 1972, p. 113 ig. 238, 239; p. 114 igg. 240, 241; p.116.
Fig. 22 Ediicio a pianta quadrata: a) resti dell’ambiente riscaldato. Visibili alcune suspensurae e parte del crollo del pavimento a mo-saico (da Gianrotta 1972) b) Particolare del pavimento crollato nell’ambiente riscaldato dell’ediicio a pianta quadrata (da Gian-rotta 1972).
Fig. 24 Ediicio a pianta quadrata: la sepoltura entro anfora ari-cana rinvenuta nel crollo dell’ambiente riscaldato (da Gianrotta 1972).
Fig. 23. I resti del canale del praefurnium.
21
La storia dell’Ambiente 13 termina con il crollo della pa-vimentazione musiva nell’intercapedine sottostante; nello strato di abbandono risulta scavata una fossa per ospitare una sepoltura infantile del tipo ad enkytrismos con il picco-lo defunto racchiuso entro un’anfora “africana grande”, de-posta sul pavimento dell’intercapedine (Fig. 24). Tale tipo di sepoltura, certamente di epoca tardo imperiale, costitui-sce un importante termine ultimo di riferimento per l’avve-nuto abbandono dell’ediicio, da collocare intorno alla ine del III secolo d.C. al più tardi nell’ambito del IV7. Poche informazioni sono disponibili per quanto riguarda gli altri due ambienti situati sui rispettivi locali dell’Ambiente 13, oggi ricoperti. Solo nel caso dell’Ambiente 12 alcune foto dell’epoca degli scavi lasciano intravedere una stanza rettan-golare con un probabile canale di scolo a sezione quadrata, sito lungo il lato nord, con tracce dell’antica copertura a lastre di pietra8. Nessuna descrizione risulta dell’Ambiente 14. Nell’area interessata dal balneum è compreso anche un altro locale di diicile identiicazione, accessibile tramite l’ingresso laterale nel portico, ancora segnalato dalla soglia in posto. Si tratta dell’Ambiente 11 al di sotto del quale sono stati rintracciati due canali di scolo delle acque prove-nienti dalle vasche dell’impianto termale. Un breve tratto di fognatura, realizzata con coppi rovesciati protetti sui lati da lastre di scaglia, sembra fuoriuscire dalla vasca quadra-ta dell’Ambiente 6 per andare a conluire in una canaletta più lunga, foderata e coperta in lastre di pietra che, con una leggera pendenza, va ad inilarsi al di sotto della soglia d’in-gresso, per proseguire in direzione della strada e del mare. Il
7 Gianfrotta 1972, p. 117, ig. 250.8 Gianfrotta 1972, p. 113, ig. 293.
canale principale di scolo è probabile che provenga dall’in-terno dell’Ambiente 13 dove doveva essere posizionata al-meno una vasca calda (Fig. 25). Tali impianti di spurgo del-le acque dovevano passare al di sotto del livello pavimentale dell’Ambiente 11 del quale non sembrano restare tracce. E’ probabile che fosse in terra battuta e ciottoli come gli altri rinvenuti nell’ediicio. La stanza potrebbe essere identiica-ta come un vano di ingresso verso i locali termali o viceversa in direzione dell’area centrale dell’ediicio, passando vicino al pozzo, prima che un tramezzo in muratura lo chiudesse, nell’ultima fase di vita del complesso. Qualora l’ambiente non sia collegato agli altri vicini, potrebbe essere signiica-tiva la presenza di un dolio, situato nell’angolo nord-ovest della stanza, visto durante gli scavi del 1970 ma oggi non più rintracciabile, in quanto interrato sotto la strada vicina-le. Il grande recipiente, addossato in piedi all’angolo tra due pareti, potrebbe indicare anche in questo caso una possibile destinazione commerciale della struttura, aperta sul porti-co prospiciente la strada.Per concludere la descrizione dell’ediicio nel suo insieme, va registrato che l’intero lato nord-ovest della costruzione risulta occupato da un’ampia zona porticata, una tettoia che doveva essere appoggiata al muro di recinzione di fon-do e su almeno 4 grandi pilastri frontali (forse cinque) le cui fondazioni sono state scoperte durante l’ultima campa-gna di scavi nel 2013 (Fig. 26). Sembra si tratti di pilastri in muratura, a pianta quadrata di almeno 60 cm di spessore, considerando che le strutture di fondazione si presentano con circa 80 cm di lato. La zona interna al porticato (Am-biente 8), risulta solo in parte esplorabile in quanto com-presa in un ampio settore dell’ediicio inito al di sotto dei giardini delle villette adiacenti l’area archeologica.
Fig. 25. Le due canalette di scolo rinvenute al di sotto del calpestio dell’Ambiente 11.
Fig. 26. Le basi dei quattro pilastri del portico che chiudeva l’ediicio verso il fondo.
22
Nella zona indagata, nell’an-golo nord-est, sono emersi i resti di una vaschetta rettan-golare per l’acqua, addossata al muro e rivestita in coccio-pesto, una probabile vasca di raccolta di una fontanella la cui funzione resta non interpretabile allo stato at-tuale delle conoscenze (Fig 27). Sull’intera zona circo-stante, coperto dallo strato di humus, è tornato in luce un notevole strato di mace-rie (US 5), composto quasi esclusivamente da scapoli di pietra insieme a numerose tegole e coppi da attribuire al crollo delle murature e del tetto dell’ambiente (Fig. 28). La distribuzione e la posizione dei reperti, che appaiono non esattamente in situ, lasciano intravedere un possibile successivo livel-lamento del crollo avvenuto per ini di riuso dell’area e/o di spoglio del materiale. Dallo strato provengono un frammento di anfora del tipo Dressel 1 e due monete, una dell’imperatore Tiberio del 36-37 d.C. (Cfr. p. 32, n.17) e una di Nerone risalente al 66 d.C.
Fig. 27. I resti della vaschetta rivestita in signino rinvenuta nell’Ambiente 8.
Fig. 28. Il vasto strato di crollo con tegole e scapoli di pietra (US 5) aiorato nell’Ambiente 8.
23
Sul lato opposto del porticato, verso l’angolo nord dell’edi-icio, lo scavo ha invece messo in luce le tracce di alcune strutture precarie di diicile identiicazione, appoggiate al primo pilastro del portico, forse nelle ultime fasi di vita del complesso. Si tratta di brevi tratti di murature a secco che deiniscono un piccolo ambiente (Ambiente 9) e almeno un altro recinto rettangolare di soli 1,40x0,80 m, formato con frammenti di tegole e lastrine di pietra inisse vertical-mente nel terreno (Fig. 29). All’interno del perimetro sus-sistono tracce di un battuto pavimentale in terra e piccoli ciottoli luitati tra i quali sono presenti alcuni manufatti attribuibili ad industrie preistoriche. Allo stato attuale delle indagini il cosiddetto “Ediicio qua-drato”, a suo tempo identiicato come una “villa”, sembra presentare delle caratteristiche anomale rispetto alla norma delle ville rurali note nel territorio e nell’Etruria tirrenica (Fig. 30). Va rilevato che nel complesso non sono ancora stati individuati locali o resti di impianti certamente fun-zionali ad attività collegabili alla lavorazione di prodotti agricoli, come ad esempio un torcularium e una cella dolia-ria per la produzione vinicola, o grandi macine da frantoio per la produzione di olio o di farina. Tali assenze lasciano immaginare che all’interno del complesso fossero ospitate funzioni ed attività diverse rispetto a quelle normalmente presenti nelle ville rustiche; in via di ipotesi anche collega-bili alla gestione del grande complesso di peschiere site nel mare subito antistante. Un importante settore dell’ediicio, nell’angolo nord-ovest, è occupato da un piccolo balneum “privato” provvisto di almeno una vasca calda e di una fred-da, molto spartano nella decorazione, privo di importanti rivestimenti marmorei. Tuttavia, qualora l’ingresso avve-nisse anche dall’Ambiente 11, aperto verso la strada, si po-trebbe anche pensare ad un uso della struttura non esclusi-vamente privato.I materiali rinvenuti nel portico e negli Ambienti 2 e 10 potrebbero indicare la presenza di attività commerciali legate forse alla rivendita del pescato. L’ampio spazio co-perto, sito lungo il muro di fondo dell’ediicio, potrebbe aver ospitato depositi, stalle e attività di lavorazione di vario genere. Interessante la presenza di una cucina provvista di un instrumentum formato, nel I secolo d.C., da una base di almeno 4 olle da fuoco e due tegami. La posizione del complesso, aperto sulla strada, e la sua pianta simile a quella di una grande domus ad atrio di tipo pompeiano, potrebbe-ro indicare una destinazione diversa da quella di centro di produzione agricola. Vale la pena considerare la possibilità che almeno nella fase di vita di epoca imperiale, nel I e II secolo d.C., l’ediicio possa essere stato trasformato in una caupona, un’osteria con annessa rivendita di prodotti ittici e piccolo albergo con balneum per la sosta e il temporaneo ricovero di viandanti, in transito da e per Centumcellae (Fig. 31). Restano da deinire le fasi più antiche dell’ediicio di epoca romana repubblicana, indiziate dalla presenza di materia-li edilizi riusati nelle murature, tra i quali diversi blocchi squadrati di scaglia, ceramiche a vernice nera e varie mone-te databili nel III-II secolo a.C., rinvenute come residui ne-gli strati di epoca imperiale. Signiicativa anche la presenza di alcuni frammenti ceramici di epoca etrusca tra i quali un piede di forma chiusa in bucchero nero, qualche parete in impasto rosso bruno e poche tegole in impasto di I fase che
documentano una forma di frequentazione dell’area già in epoca arcaica, nell’ambito del VI secolo a.C. In conclusione, l’ediicio in corso di scavo presenta tracce di utilizzo che si protraggono per circa cinque secoli tra l’epoca romana repubblicana e quella imperiale. I materiali ceramici e numismatici inora rinvenuti consentono di ipo-tizzare che la costruzione primitiva possa essere realmente avvenuta nella seconda metà del III secolo a.C. o, al più tardi nel II, forse intorno alla metà, come sembrano testi-moniare diversi assi della nota serie della prua della nave tra i quali uno pertinente ad una emissione della gens Sempro-nia, datato 172-151 a.C. (Cfr. p. 31, n. 9), uno della gens Saufeia del 152 a.C. (Cfr. p. 37, n. 62) e uno della Atilia del 148 a.C. Dopo le successive fasi di vita che appaiono ben documen-tate, tra il I secolo a.C. e il II secolo d.C., il termine ultimo per la frequentazione del complesso è issato dalla presen-za di alcune ceramiche africane da cucina e da diverse mo-nete emesse sotto l’imperatore Commodo, tra il 183 e il 189 d.C., da un sesterzio di Settimio Severo (Cfr. p. 35, n. 43) del 197-198 d.C. e inine soprattutto da un sesterzio dell’imperatore Alessandro Severo, coniato nel 231 d.C. (Cfr. p. 32, n. 21) (Fig. 32). Alla luce dei dati disponibili è verosimile che l’ediicio sia stato abbandonato a partire dalla metà del III secolo d.C., al più tardi alla ine dello stesso o nei primi decenni del IV, quando tra i ruderi del balneum venne sepolto un bambino, all’interno di un’anfora tipo “africana tarda”.
Flavio Enei
Fig. 29. Tracce di una struttura a pianta rettangolare sita tra l’Ambiente 9 e il portico (Amb. 8).
24
Fig. 30. Panoramica generale dell’ediicio quadrato in corso di scavo.
Fig. 31. Prima ipotesi di distribuzione degli ambienti funzionali all’interno dell’ediicio quadrato. A Nord Ovest la zona del balneum (Azzurro), a Sud Est gli ambienti residenziali con una cuci-na (Giallo) e una probabile taberna nel portico con afaccio sulla strada (Verde). Nell’interno dell’ediicio è presente un cortile aperto (probabile atrio) chiuso sul fondo da un’ampa area porticata adibita a zona di deposito/lavoro o ad un proba-bile hortus.
Portico
Via Publica
Custode
Balneum
Balneum
Ambienti residenziali
Taberna
Taberna
Cucina
Cortile (Atrium)
Area di deposito/lavoro (Hortus?)
25
Fig. 32. La distribuzione delle monete nell’ediicio quadrato. In evidenza le monete di epoca romana repubblicana (III - I secolo a.C.) (cer-chio celeste), le monete di epoca primo imperiale (I secolo d.C.) (cerchio nero) e quelle relative all’ultima requentazione degli ambienti (II - III sec. d.C.) (cerchio rosso). Di particolare interesse le monete di piena epoca imperiale, adrianea e antonina, distribuite in buon numero negli ambienti 1 e 2, aperti sul portico a ridosso della strada. Dal piano di calpestio del portico (Ambiente 7) proviene la moneta più tarda inora rinvenuta nell’ediicio, un sesterzio dell’imperatore Alessandro Severo del 231 d.C. (Cr. p.32, n. 21) (cerchio verde).
14
813
30
56
20
14
12
57
2
613
65
55
6
21
25
26
29
54
18
9
6
1315
20
25
30 mt
710
2
4
5
12 111
3
9
52
16 11
10
8
53
48 15
7
1 47
50
38
46
60 33 63
37
62
35
34
40
41
39
49 36
51944
42
43
32
45
31
59
17
58
10
5
4
3
2
1
0
0,5
26
La ceramica e gli altri materiali dall’ediicio quadrato
L’analisi del materiale archeologico rinvenuto all’interno dell’ediicio a pianta quadrata ubicato a nord del balneum delle Guardiole ha permesso l’individuazione di una lunga continuità di vita inquadrabile all’interno di un arco cro-nologico che, a partire dal III secolo a.C., sembra giungere sino al III-IV secolo d.C. (Cfr. p. 23)In questo settore, la classe della ceramica a vernice nera rap-presenta l’elemento cronologicamente più antico; in parti-colare in questo caso si tratta di un orlo di una coppetta as-similabile alla forma Morel 2538 databile alla seconda metà del III secolo a.C.,1 e di un orlo di coppetta genericamente attribuibile al II secolo a.C., rinvenuto all’interno dell’am-biente 11 (US 0).La ceramica comune appare ben rappresentata da diversi frammenti e da altri reperti meglio conservati: tra questi va segnalato il rinvenimento, nell’ambiente 11, della parte su-periore di una brocca, databile tra gli ultimi decenni del III e gli inizi del II secolo a.C. ed assimilabile al tipo 2 da Città dello Sport (Fig. 1)2.Dagli Ambienti 7 e 11, contigui e separati solamente da un setto murario, proviene la maggior parte dei reperti in ce-ramica comune per i quali si sono resi possibili alcuni con-fronti.Dall’Ambiente 7, in particolare, provengono due fram-menti di piatto-coperchio riconducibili al tipo 1 di Gabii, databili tra la ine del III e il I secolo a.C. e l’orlo di un’olla di epoca tardo-repubblicana3.Dallo stesso ambiente, inoltre, proviene un frammento di pentola dell’età augustea e in uso ino all’età di Traiano, mentre nell’Ambiente 11, oltre alla brocca sopra citata, è stato rinvenuto un frammento di tegame per il quale si ha un confronto con il tipo Sutri 2 del II secolo a.C. e una par-te di orlo con ansa appartenenti ad una brocca del II secolo a.C.4 La classe ceramica della sigillata italica appare qui rap-presentata da pochi frammenti: tra questi, tutti rinvenuti all’interno dell’US 3, sono da segnalare due frammenti di piatto entrambi assimilabili alla forma Goudineau 39 da-tabili tra l’età augustea ed il II sec. d.C.5 ed un frammento di una forma incerta sul quale è presente un bollo in planta pedis recante l’iscrizione C.ME[---], sulla base del quale è possibile datare il frammento genericamente alla seconda metà del I secolo d.C. (Fig. 2). Dall’Ambiente 7, proviene un altro frammento di orlo di coppa in terra sigillata italica anch’esso riferibile alla forma Goudineau 39 ma databile ai primi anni del I secolo a.C. Anche in questo settore, la ce-ramica più frequentemente rinvenuta appartiene alla classe della ceramica africana a patina cenerognola. Dall’Ambien-te 7, inoltre, provengono diversi orli appartenenti alla forma della casseruola e del piatto-coperchio databili tra la ine del II ed il IV secolo d.C. Dall’Ambiente 8 (US 5), provengo-no altri frammenti della stessa classe ceramica, inquadrabili all’interno del medesimo arco cronologico.
1 MOREL 1981, pl. 54, p. 181.2 BERTOLDI 2011, p. 70.3 OLCESE 2003, tav. XX, p. 89.4 OLCESE 2003, tav. XIV, p. 86.5 CARANDINI 1981, tav. CXIX , p. 384.
Fig. 1. Porzione superiore di brocca in ceramica comune
Fig. 2. Bollo in planta pedis recante l’iscrizione C.Me[---]
Fig. 3. Frammento di mattone con bollo [---]Fig.Caes[---]
1
2
3
4
5
6
7
Fig. 4. Alcuni reperti in ferro e in bronzo
27
L’US 5 presenta una supericie assai irregolare composta da diversi frammenti di materiale da costruzione e cera-mica misti a terra: tra i materiali presenti al suo interno, meritano di essere ricordati un’ansa di un’anfora Dressel 20 ed un frammento di bollo laterizio orbicolare del qua-le è visibile solamente la parte sinistra recante l’iscrizione [ex]FIG.CAES[---] (Fig. 3).Anche in questo settore sono venuti alla luce diversi ma-teriali metallici, per lo più chiodi in bronzo e in ferro di varie dimensioni e due anelli in bronzo di diferenti dimensioni (Fig. 4).Dall’Ambiente 8 proviene inoltre un reperto particolare di diicile interpretazione: si tratta di una lastra di pietra locale con due linee incise che sembrano formare i tratti di una lettera (N?) (Fig. 5).Durante lo scavo di alcuni ambienti (in particolare gli ambienti 7 e 11), sono state rinvenute alcune tessere di mosaico bianche e nere, appartenenti, forse, a quel pa-vimento a mosaico retto da suspensurae messo in luce a nord del pozzo durante la campagna di scavi del 1970 quando, nella stessa occasione, nei pressi del medesimo pavimento si rinvenne anche una istula plumbea.6
Nel 2012 al di sotto della muratura che divide attual-mente gli ambienti 7 ed 11 è stata rinvenuta una seconda istula plumbea, spezzata in due che, nella sua interezza, raggiunge circa i 110 cm e rappresenta un importante elemento da porre in connessione con il rinvenimento efettuato nel 1970.Un altro elemento particolarmente interessante rinvenu-to durante le prime attività scavo è rappresentato da un frammento in marmo lungo circa 25 cm, probabile ele-mento architettonico/decorativo: il frammento presen-ta una supericie più liscia dell’altra, con due lati regolari (inferiore e destro), un terzo lato con vistosa frattura (sinistro) ed un quarto lato (quello superiore) con un andamento irregolare (Fig. 6).Nelle ultime campagne di scavo la messa in luce di più ambienti ha portato all’individuazione della parte in-feriore di un’anfora e di un fondo di dolio ubicati agli angoli delle strutture murarie ed in particolare di quelle degli Ambienti 5 e 7. È probabile che questi oggetti aves-sero lo scopo di captare le acque piovane o comunque di svolgere la funzione di grandi contenitori di acqua, forse con qualche relazione con l’attività lavorativa che si svol-geva tra gli Ambienti 7 ed 11.All’interno di uno di essi, in particolare in quello rinvenu-to nell’Ambiente 7, sono stati trovati alcuni frammenti di ceramica comune, ceramica africana a patina cenerognola, un frammento di lucerna in ceramica comune ed un chio-do in ferro.
Il materiale archeologico ino ad oggi recuperato permette di attestare una continuità di vita della struttura della dura-ta di almeno sei secoli.Il rinvenimento della ceramica a vernice nera e della cera-mica africana a patina cenerognola fornisce le basi per sta-bilire i due estremi cronologici relativi all’inizio ed alla ine dell’attività di vita del sito: il III secolo a.C. sembra corri-spondere ad una prima fase di attività dell’ediicio, mentre
6 GIANFROTTA 1972, p. 116
il periodo a cavallo tra il III ed il IV secolo d.C. rappresen-terebbe, con una certa sicurezza, l’ultima fase di vita. Alcu-ne forme in ceramica comune e in sigillata italica, inoltre, forniscono elementi importanti di datazione e confermano l’occupazione del sito durante la tarda età repubblicana e la prima età imperiale.Non è da escludere tuttavia, sulla base dei ritrovamenti e della particolare concentrazione di materiale archeologico più tardo in determinati ambienti, come ad esempio l’am-biente 7, che alcune strutture possano aver avuto una du-rata di vita più lunga di altre ed una diversa destinazione d’uso con l’abbandono di alcuni ambienti già durante il II ed il III secolo d.C.
Luca Desibio
Fig. 5. Ambiente 8, US 5: rammento di lastra in pietra con linee incise (possibile rammento di iscrizione)
Fig. 6. Lastra di marmo bianco sagomata di probabile funzione decorativa.
28
I materiali numismatici dall’ediicio quadrato
In quello che viene genericamente deinito “Ediicio quadra-to”, i ritrovamenti numismatici assommano ad un totale di 65 unità. Le prime 29 monete sono state rinvenute nelle campa-gne 2010-2012: i nominali sono per la maggior parte di basso valore, fanno eccezione un Denario d’argento di epoca impe-riale e un Quinario sempre d’argento di epoca repubblicana. Delle monete rimanenti abbiamo 2 Sesterzi di epoca imperiale in oricalco (una lega di rame e zinco), 2 Dupondi imperiali sempre in oricalco, 19 Assi di cui 2 di epoca repubblicana in bronzo e 17 di epoca imperiale in rame. Completano la serie 2 Semissi repubblicani in bronzo, 1 Quadrante repubblicano in bronzo e 1 Quadrante imperiale in rame.Come accennato, accanto ai nominali enei per traici minuti spicca un Denario dell’imperatore Adriano (inv. 3), conio in argento di consistente valore essendo all’epoca all’incirca la paga giornaliera di un legionario, nel cui rovescio è raigura-ta la personiicazione della Salus. La moneta è ben conservata con pochi segni di circolazione ed è ben leggibile nonostante la presenza di depositi minerali di colore verde e bruno.Il secondo esemplare in argento è un Quinario di epoca repub-blicana, emissione dell’89 a.C. della gens Porcia. Il suo valore è la metà di un denario e deve il suo nome al fatto che in origine sul dritto della moneta era riportato il numero V indicante la sua tarifa in Assi; successivamente la svalutazione del bron-zo ha portato questo valore a 8 Assi ma il nome è rimasto. Lo stato di conservazione è pessimo, caratterizzato da una forte usura, indice probabilmente di una lunga circolazione. Tra i nominali enei di maggior valore abbiamo un Sesterzio di Commodo (inv. 16), molto ben conservato e arricchito da una bella patina verde chiaro, usurato da una lunga circolazione. L’altro sesterzio rivenuto è di Alessandro Severo (inv. 21) con al rovescio una vittoria alata; anche questo ben conservato, presenta la stessa usura da circolazione, è datato al 231 d.C. e fa da chiusura temporale alle monete ritrovate nell’ediicio.La metà di un Sesterzio, oppure il doppio di un Asse, è il Du-pondio. Di questo nominale sono stati ritrovati due esemplari. Il primo fu emesso dall’imperatore Adriano: il suo peso basso (anche se questo fatto non era infrequente) e le tracce della co-rona radiata sul ritratto dell’imperatore (molto tenui, causa la cattiva conservazione del tondello), hanno fatto sorgere alcuni dubbi sul nominale; per questi motivi anche la datazione non è stata stabilita con precisione e viene genericamente assegnata al periodo del principato di Adriano tra il 117 e il 138 d.C. Nessun dubbio per quanto riguarda il Dupondio di Commo-do (inv. 2), usurato ma perfettamente integro, con una grade-vole patina verde chiaro, datato al 183 a.C., che presenta al rovescio la personiicazione della Salute. Nutrita è la quantità di Assi rinvenuti, ben diciassette, che co-prono un arco temporale che va dal II secolo a. C. al principato di Commodo. Per primi abbiamo due assi di epoca repubbli-cana, entrambi appartenenti alla riduzione Unciale, databili al II secolo a.C. Uno di questi, anche se mal conservato e con estesi fenome-ni di corrosione, riporta il nome del magistrato monetario L. Sempronio Pitio (inv. 9) a cui il Crawford assegna la data di emissione tra il 172 e il 151 a.C.Del secondo esemplare lo stato di conservazione è tale che non
è stato possibile risalire al nome del magistrato monetario, an-che se la posizione del segno di valore “I” davanti alla prua ne indica la presenza.Proseguendo in ordine cronologico abbiamo un Asse del ma-gistrato monetario L. Surdinus a nome di Augusto (inv. 27) databile al 15 a.C. La moneta si presenta in discreta conserva-zione tranne per alcune corrosioni che hanno fatto saltare la patina all’altezza della testa; la fattura denuncia alcuni difetti tipici dell’epoca, come un notevole decentramento e parzia-le cancellazione della scritta dovuta a debolezze di conio o ad una non uniforme applicazione della pressione durante la co-niazione.Segue un Asse di Tiberio per il iglio Druso Minore, databile al 21-22 d.C. (inv. 20), ben conservato, con scritte in altorilievo, un altro di Tiberio (inv. 11) questa volta a suo nome, databile al 35-36 d.C., raigurante al rovescio un caduceo, moneta in discreta conservazione e ben centrata, anche se presenta segni di una lunga circolazione. Ancora un Asse di Tiberio (inv. 17) datato al 36-37 d.C., con al rovescio un timone sovrapposto al globo terrestre; l’esem-plare presenta vistose concrezioni al dritto tali da rendere il-leggibile il ritratto. Quasi intatto è un Asse di Nerone con al rovescio le porte del tempio di Giano, datato al 65 d.C. (inv. 7), moneta molto evocativa che celebra il periodo di pace che attraversava l’impero. La gens Flavia è rappresentata da un Asse di Domiziano, avente al rovescio la fortuna (inv. 25), datato probabilmente al 90-91 d.C., la cautela è dovuta alle corrosioni che hanno interessato il bordo e le scritte della moneta, rendendone diicile la lettura. Dopo un salto temporale di circa quarant’anni troviamo due Assi di Adriano, entrambi datati tra il 134-138 d.C., il primo con al rovescio la Felicità che stringe la mano all’imperatore (inv. 18), splendidamente conservato, mentre il secondo, con il rovescio dell’annona, è talmente corroso da risultare quasi illeggibile. L’imperatore Antonino Pio è rappresentato da due Assi: un esemplare con al rovescio la Provvidenza, datato 156-157 d.C. (inv. 4) proveniente dai giardini contigui all’area di scavo rinvenuto da un abitante del luogo; dall’ediicio provie-ne invece l’altro Asse con al rovescio una scritta celebrativa in corona di alloro con data 145 d.C. Decisamente malconcio è l’Asse di Marco Aurelio da Cesare, emesso sotto il principato di Antonino Pio, datato anch’esso al 145 d.C., con al rovescio la personiicazione dell’Ilarità. Per ultimo abbiamo un Asse di Commodo del 183-184 d.C. (inv. 6) che raigura al rovescio Ercole, fatto abbastanza comune nelle emissioni di questo imperatore che amava deinirsi come l’Ercole romano.Due sono i Semisse, moneta che valeva la metà di un Asse, en-trambi di epoca repubblicana. Uno di questi, datato al III seco-lo a.C., è la moneta più antica rinvenuta nell’ediicio quadrato; lo stato di usura e i depositi l’hanno resa del tutto illeggibile, ma dal peso e dalla forma del tondello, ricavato per fusione, è possibile assegnarla alla riduzione Sestantaria. Più recen-te è l’altro Semisse, datato al II a.C., anch’esso conservato in maniera pessima ma che lascia intravedere al dritto la testa di Saturno o (Giove); questa, insieme al peso, sono elementi che l’attribuiscono alla serie Prora della riduzione Unciale.Chiudono questo esame del materiale numismatico trovato nell’ediicio due Quadranti, monete del valore di un quarto di Asse, uno di epoca repubblicana databile al I secolo a.C., in pessimo stato di conservazione appartenente alla riduzione
29
Semiunciale, l’altro di epoca imperiale, emesso sotto il prin-cipato di Nerva e datato tra il 96 e il 98 d.C. (inv. 29); ben conservato presenta al dritto un Modio (strumento con cui i romani misuravano le quantità di grano) con spighe che sbu-cano fuori e al rovescio un Caduceo.
Gli ultimi rinvenimentiLa nuova campagna di scavi 2013 nell’ediico quadrato ha por-tato alla luce altre 36 monete per la quasi totalità romane delle quali forniamo una breve descrizione preliminare.Possiamo dividerle in romane (34 monete) e di area Magno Greca e Siceliota (2 monete): tra quest’ultime abbiamo un Obolo di Hipponion (odierna Vibo Valentia, colonia di Lo-cri), databile tra il 325 e il 294 a.C. (inv. 42).Secondo il Seltmann la moneta venne emessa durante la domi-nazione di Agatocle (Attianese vol. 2 pag. 41). Non è stato an-cora possibile identiicare la zecca della seconda moneta (inv. 65) forse di provenienza siceliota.Delle 33 monete romane il valore più comune è dato dagli Assi ben 19, di cui 6 repubblicani, e 13 imperiali, gli Assi repub-blicani appartengono tutti alla riduzione unciale databile al II secolo a.C. Un caso particolare è dato da un Asse dimezzato (inv. 40) il cui utilizzo di necessità si è protratto in epoca tardo repubblicana; di altri tre è stata possibile la lettura dei simboli o dei nomi dei magistrati, che hanno permesso una datazione precisa: Asse gens Saufeia (inv. 62) datato al 152 a.C., Asse con monogramma TP (inv. 48) datato al 169-158 a.C. e un Asse gens Atilia datato 148 a.C.Gli Assi del periodo imperiale coprono un periodo di poco più di un secolo e mezzo, che va dal principato di Augusto a quello di Lucio Vero e Marco Aurelio.Dei suddetti Assi, tre sono di Augusto, appartenenti alla serie dei magistrati monetali con SC al rovescio; mentre per uno non è stato possibile identiicare il magistrato, data la pessima conservazione, gli altri due sono rispettivamente di M. Maeci-lius Tullus (inv. 50) datato 7 a.C. e di Volusus Valerio Messalla, datato 6 a.C. Proseguendo in ordine cronologico, troviamo un Asse di Tibe-rio per il iglio Druso datato 21-22 d.C., moneta già trovata nel corso degli scavi del 2012; poi un Asse del nipote Claudio con al rovescio Minerva nell’atto di brandire un giavellotto (inv. 55) datato tra il 50 e il 55 d.C. Con due monete dal rovescio identico ma la testa orientata in direzioni diferenti, abbiamo due Assi del iglio adottivo Nerone, raiguranti la vittoria alata che regge uno scudo con la scritta SPQR, entrambi datati al 66 d.C. Degno di menzione è quello trovato nell’ambiente 2 (inv. 49) di conservazione splendida cui è dedicata la copertina di questo quaderno. Cambiando dinastia troviamo un Asse di Vespasiano per il iglio Tito, con l’Equitas al rovescio (inv. 34), datato 74 d.C. Poi, con un notevole salto temporale, abbiamo tre Assi di Antonino Pio ma curiosamente nessuno dei tre con il suo volto: infatti in uno è raigurata la iglia Faustina (inv. 61) con al rovescio l’Hilaritas, datato al 145-146 d.C. mentre gli altri due sono dedicati al iglio adottivo e futuro imperato-re Marco Aurelio, con al rovescio rispettivamente l’Hilaritas (inv. 32), datato al 145 d.C. e la Pietas (inv. 52), quest’ultimo di superba conservazione e di stile rainato, datato tra il 149 e il 150 d.C. Chiudono la serie cronologica due Assi di Lu-cio Vero, collega di Marco Aurelio, raiguranti il primo Marte (inv. 56) e il secondo la vittoria, entrambi datati tra il 163 e il 164 d.C. Come multipli dell’asse sono stati rinvenuti due Du-
pondi di epoca imperiale, il primo dell’imperatore Nerva (inv. 30) datato 96 d.C. con al rovescio due mani che si stringono e nel campo un’aquila legionaria e una prua di nave, eccezionale testimonianza di un momento diicile nei rapporti tra impe-ratore e pretoriani, il secondo emesso dall’imperatore Com-modo per la moglie Crispina, con al rovescio Giunone Lucina, databile tra il 180 e il 192 d.C. Multipli del valore di quattro Assi sono due Sesterzi, uno di Settimio Severo con un Genio sacriicante al rovescio (inv. 43), datato tra il 197 e il 198 d.C. e uno di Domiziano (inv. 59), datato 85 d.C. che al rovescio mostra l’imperatore incoronato dalla vittoria celebrazione del trionfo sui Chatti e l’annessione nei conini imperiali degli Agri Decumates, regione germanica compresa fra i corsi iniziali di Reno e Danubio.I rinvenimenti monetali hanno riguardato anche i sottomulti-pli dell’Asse, in particolare due Semissi (valore di mezzo Asse) della serie testa di Saturno prua di nave, entrambi appartenenti alla riduzione semiunciale, databili al I sec. a.C.Un quarto di valore di un Asse faceva un Quadrante: di questi l’ediicio quadrato ne ha restituiti quattro, uno repubblicano, probabilmente di I secolo a.C., anche se lo stato di conserva-zione è talmente pessimo da pregiudicare una più esatta cata-logazione e i restanti tre imperiali, della dinastia Giulio Clau-dia, di cui uno di Caligola datato tra il 40 e il 41 d.C. (inv. 46) che commemora l’abolizione della tassa augustea dell’ 1% su tutte le vendite a favore dell’erario militare, il secondo di Clau-dio (inv. 44) raigurante un Modio datato al 42 d.C. e il terzo emesso da Nerone nel 64 d.C. (inv. 47) raigurante una civetta su un altare e al rovescio un ramoscello.Fino ad ora la descrizione ha riguardato la monetazione enea, cioè le monete di metallo o lega vile come bronzo, rame o ori-calco che servivano per i piccoli acquisti di tutti i giorni; per scambi di maggior entità esisteva il Denario, una moneta in argento di grande difusione tale da potersi considerare il dol-laro del mondo antico. In questa campagna di scavo ne sono stati rinvenuti cinque tutti di epoca repubblicana e purtroppo in pessime condizio-ni di conservazione; quello meglio conservato è un Denario del monetiere C. Censorinus della gens Marcia che il Crawford data all’ 88 a.C. (inv. 31) con al dritto le teste accollate di Numa Pompilio e Anco Marzio e al rovescio un cavallerizzo acrobata (Desultor) con due cavalli al galoppo. Molto decentrato oltre che mal conservato è poi il Denario della gens Volteia 78 a.C. con testa di Liber al dritto e Cerere su un carro trainato da serpenti. Secondo il Mommsen la moneta è un riferimento ai Ludi Cereales tenuti a Roma nel mese di Aprile.Dal basso peso e da alcune macchie rossastre che emergono tra i depositi si può dedurre che probabilmente siamo in presenza di un Denario Suberato, cioè di una moneta di rame rivestita d’argento, una specie di falso di Stato. Decisamente illeggibile è il nome del monetiere di un altro Denario, con al dritto la testa elmata di Roma e una vittoria su biga al rovescio: dalla tipologia si direbbe un Denario del II secolo a.C. Anche se il quarto Denario è molto malridotto, è possibile distinguere al dritto una galera che, insieme al basso peso, ne fanno un tipico Denario legionario di Marco Antonio, datato dal Crawford tra il 32 e il 31 a.C. Nulla è possibile dire sull’ultima moneta, tranne che è un De-nario forse di epoca repubblicana.
Paolo Caponnetto
30
Inventario n. 3 Nominale: DenarioAutorità emittente: Impero Romano, imperatore Adriano.Dritto: Testa nuda a destra di Adriano.Scritta: Nell’intorno “HADRIANVS AVG. COS. III P.P.” (Adriano Augusto console per la terza volta padre della patria).Rovescio: Salute stante a sinistra sacriica con una patera sopra un altare rotondo, mentre con la mano sinistra regge uno scet-tro. Scritta: Nell’intorno “SALVS AVG.” (Salute dell’augusto). Peso: g 3,3 Diametro medio: 17 mm Metallo: AG Zecca: Roma Posizione Conii: 170° Data: 134 – 138 d.C.Osservazioni: La moneta presenta degli spessi depositi minerali, altrimenti si presenta in buona conservazione, leggermente de-centrata al rovescio.Bibl.: RIC Vol. II n.268 London 1926Ambiente 1
Inventario n. 2 Nominale: DupondioAutorità emittente: Impero Romano, imperatore Commodo.Dritto: Busto con corona radiata a destra di Commodo.Scritta: Nell’intorno “M. COMMODVS ANTONINVS AVG. PIVS.” (Marco Commodo Antonino Augusto Pio)Rovescio: Salute stante a sinistra nutre un serpente che si erge da un altare, e regge uno scettro.Scritta: Nell’intorno “SALVS AVG. TR.P. VIII IMP. VI COS. IIII P.P.” (Salute dell’augusto potestà tribunizia ottava, acclamato Imperatore per la sesta volta, console per la quarta volta, padre della patria) nel campo “S.C.” (senato consulto).Peso: g 12,3 Diametro medio: 25 mmMetallo: AE Zecca: Roma Posizione conii: 180°Data: 183 d.C. Osservazioni: Patina verde, usurata, presenza di corrosioni al rovescio. Bibl.: RIC vol. III n.390 London 1930Ambiente 1
Inventario n. 4 Nominale: AsseAutorità emittente: Impero Romano, imperatore Antonino Pio.Dritto: Testa laureata a destra di Antonino PioScritta: Nell’intorno “ANTONINVS AVG. PIVS P.P. IMP. II” (Antonino augusto pio padre della patria imperatore per la seconda volta).Rovescio: Provvidenza stante a sinistra indica con la mano destra un grande globo e regge una cornucopia.Scritta: Nel campo “S.C.” (senato consulto) nell’intorno “TR.POT. XX COS. IIII” (Tribuno della plebe per la ventesima volta, console per la quarta volta).Peso: g 9,2 Diametro medio: 24,5 mm Metallo: AE Zecca: Roma Posizione conii: 200° Data: 156 - 157 d.C.Osservazioni: Moneta di modulo irregolare con lieve mancanza di metallo in basso a sinistra al dritto, patina marrone presenta diversi punti di corrosione.Bibl.: RIC vol. III Antonino Pio n.972 London 1930 ristampa 2003Erratica dal giardino adiacente il lato NE dell’area di scavo.
Inventario n. 6 Nominale: AsseAutorità emittente: Impero Romano, imperatore Commodo.Dritto: Testa laureata a destra di CommodoScritta: Nell’intorno “M.COMMODVS ANTON. AVG. PIVS.”(Marco Commodo Antonino Augusto Pio)Rovescio: Ercole stante con testa a destra, regge una clava e una pelle di animale.Scritta: Nell’intorno “ TR.P. VIIII IMP. VI COS. IIII P.P.” (potestà tribunizia nona, acclamato Imperatore per la sesta volta, console per la quarta volta, padre della patria) nel campo “S.C.” (senato consulto).Peso: g 10,7 Diametro medio: 24,5 mm Metallo: AEZecca: Roma Posizione conii: 180° Data: 183-184 d.C.Osservazioni: Patina verde chiaro. Bibl.: RIC vol. III n.427 London 1930Ambiente 1
31
Inventario n. 7 Nominale: Asse.Autorità emittente: Impero Romano, imperatore Nerone.Dritto: Testa laureata a destra di NeroneScritta: Nell’intorno “NERO CAESAR AVG. GER. IMP.”(Nerone cesare augusto germanico imperatore).Rovescio: Vista frontale del tempio di Giano con porta sulla destra.Scritta: nell’intorno “PACE P.R. VBIQ. PARTA IANVM CL-VSIT” (Poiché il popolo romano è in pace ovunque (Nerone) potè chiudere le porte del tempio di Giano) nel campo “S.C.” (senatoconsulto).Peso: g 11,7 Diametro medio: 27 mm Metallo: AEZecca: Roma Posizione conii: 150° Data: 65 d.C.Osservazioni: Conservazione eccezionale, rilievi alti, patina verde uniforme, ma molto fragile, colpo sul bordo al rovescio. Bibl.: RIC vol. I n.304 London 1984Ambiente 2
Inventario n. 9 Nominale: Asse (riduzione unciale).Autorita emittente: Repubblica Romana, gens Sempronia.Dritto: Testa Giano bifronte.Scritta: Sopra la testa “I” (segno di valore).Rovescio: Prua di nave a destra. Scritta: Sotto “ROMA” sopra la prua “L. SEMP” (L. Sempro-nius Pitio). Peso: g 23,5Diametro medio: 30,0 mm Metallo: AEZecca: Roma Posizione conii: Illeggibile.Data: 172-151 a.C. Osservazioni: Patina verde, moneta molto usurata, con estesi fenomeni di corrosione.Bibl.: BMCRR Roma 718-722 Londra 1910 CATALLI n. 281 pag.154 Roma 2001RRC vol. I n.216/2 Cambridge 1974 ristampa 1983Ambiente 7
Inventario n. 11 Nominale: Asse.Autorità emittente: Impero Romano, imperatore Tiberio.Dritto: Testa laureata a sinistra di Tiberio.Scritta: Nell’intorno “TI. CAESAR DIVI AVG. F. AVGVST. IMP VIII” (Tiberio cesare iglio del divo Augusto, Augusto im-peratore ottavo).Rovescio: Caduceo alato.Scritta: Nell’intorno “PONTIF. MAXIM. TRIBVN. PO-TEST. XXXVII” (Ponteice massimo potestà tribunizia trenta-settesima) nel campo “S.C.” (senato consulto). Peso: g 10,3 Diametro medio: 27 mm Metallo: AEZecca: Roma Posizione conii: 175° Data: 35 - 36 d.C.Osservazioni: Patina verde uniforme.Bibl.: RIC vol. I Tiberio n.59 London 1984 ristampa 1999 CNR 1976 vol. IX n.306Ambiente 7
Inventario n. 16 Nominale: Sesterzio.Autorità emittente: Impero Romano, imperatore Commodo.Dritto: Testa laureata a destra di CommodoScritta: Nell’intorno “M.COMMOD. ANT. P. FELIX AVG. BRIT. P.P.”(Marco Commodo Antonino Pio felice Augusto britannico padre della patria).Rovescio: Roma seduta su uno scudo a sinistra regge una vittoria sulla mano destra e una lancia con la mano sinistra.Scritta: Nell’intorno “ROMAE AETERNAE COS. V P.P.” (Console di Roma eterna per la quinta volta e padre della patria) nel campo “S.C.” (senato consulto).Peso: g 20,6 Diametro medio: 27 mm Metallo: AEZecca: Roma Posizione conii: 0° Data: 186 -189 d.C. Osser-vazioni: Patina verde chiaro uniforme, usurata ma ben leggibile, modulo stretto. Bibl.: RIC vol. III Commodo n. 550 London 1930Ambiente 7
32
Inventario n. 21 Nominale: Sesterzio.Autorità emittente: Impero Romano, imperatore Alessandro Severo.Dritto: Testa laureata a destra con un leggero drappeggio sulla spalla di Alessandro Severo.Scritta: Nell’intorno “IMP. ALEXANDER PIVS AVG.” (Im-peratore Alessandro pio augusto).Rovescio: Vittoria alata stante a sinistra regge con la mano destra una corona di alloro e con la sinistra un ramo di palma.Scritta: Nell’intorno “P.M. TR.P. X COS. III P.P.” (Ponteice massimo, tribuno della plebe per la decima volta, console per la terza volta, padre della patria) nel campo in basso “S.C.” (senato consulto). Peso: g 26,1 Diametro medio: 31 mmMetallo: AE Zecca: Roma Posizione dei conii: 0°Data: 231 d.C. Osservazioni: Patina porosa verde chiaro uni-forme, usurata ma ben leggibile, peso lievemente eccedente per l’epoca.Bibl.: RIC vol. IV Alessandro Severo n.521 London 1936Ambiente 7
Inventario n. 20 Nominale: Asse.Autorità emittente: Impero Romano, imperatore Tiberio per Druso Minore.Dritto: Testa nuda a sinistra di Druso minore.Scritta: Nell’intorno “DRVSVS. CAESAR. TI. AVG. F. DIVI. AVG. N.” (Druso cesare iglio dell’augusto Tiberio e nipote del divo augusto).Rovescio: “S.C.” (Senato consulto).Scritta: Nell’intorno “PONTIF. TRIBVN. POTEST. ITER.” (Ponteice massimo, potestà tribunizia per la seconda volta). Peso: g 10,5 Diametro medio: 28,5 mmMetallo: AE Zecca: Roma Posizione conii: 20°Data: 21- 22 d.C. Osservazioni: Patina verde uniforme, buona conservazione, colpo sul bordo superiore del rovescio Bibl.: RIC vol. I Tiberio n.45 London 1984 ristampa 1999 CNR 1976 vol. XI n.10 FirenzeAmbiente 9
Inventario n. 17 Nominale: Asse.Autorità emittente: Impero Romano, imperatore Tiberio.Dritto: Testa laureata a sinistra di Tiberio.Scritta: Nell’intorno “TI. CAESAR DIVI AVG. F. AVGVST. IMP VIII” (Tiberio cesare iglio del divo Augusto, Augusto im-peratore ottavo).Rovescio: Timone posto verticalmente sul globo terrestre attra-versato da una banda, piccolo globo in basso a destra del timone.Scritta: Nell’intorno “PONTIF. MAX. TR. POT. XXXIIX” (Ponteice massimo potestà tribunizia trentottesima) nel campo “S.C.” (senato consulto).Peso: g 8,1 Diametro medio: 26 mm Metallo: AEZecca: Roma Posizione conii: 160°Data: 36 - 37 d.C. Osservazioni: Patina verde uniforme, estese concrezioni sul dritto, modulo ovalizzato.Bibl.: RIC vol. I Tiberio n.64 London 1984 ristampa 1999 CNR vol. IX n.278 Firenze 1976Ambiente 8
Inventario n. 18 Nominale: Asse.Autorità emittente: Impero Romano, imperatore Adriano.Dritto: Busto laureato a destra di Adriano.Scritta: Nell’intorno “HADRIANVS AVG. COS. III P.P.” (Adriano augusto console per la terza volta padre della patria).Rovescio: Adriano stante a destra con in mano un rotolo, stringe la mano alla felicità stante a sinistra che regge un caduceo).Scritta: Nell’intorno “FELICITAS AVG.” (felicità dell’augu-sto) in esergo “S.C.” (Senato consulto).Peso: g 12,1 Diametro medio: 25 mm Metallo: AEZecca: Roma Posizione conii: 215° Data: 134 - 138 d.C.Osservazioni: Moneta in ottimo stato di conservazione patina verde, presenta un inizio di cancro del bronzo sul bordo a sinistra al dritto. Bibl.: RIC vol. II Adriano n. 805 London 1926Ambiente 7
33
Inventario n. 27 Nominale: Asse.Autorità emittente: Impero Romano, imperatore Augusto.Dritto: Testa a destra di AugustoScritta: Nell’intorno “CAESAR AVGVSTVS TRIBVNIC. POTEST.” (Cesare Augusto tribuno della plebe).Rovescio: Scritta “S.C.” (senato consulto)Scritta: Nell’intorno “L. SVRDINVS III VIR AAAFF” (L. Surdinus triunviro monetale per fondere e battere bronzo, argen-to e oro). Peso: g 10,7 Diametro medio: 27,5 mmMetallo: AE Zecca: Roma Posizione dei conii: 90°Data: 15 a.C. Osservazioni: Moneta in patina verde chiaro con vistose mancanze, molto decentrata, e debolezza di conio special-mente nella parte inferiore del rovescio.Bibl.: RIC vol. I Augusto n.386 London 1984 ristampa 1999Dal cortile presso il pozzo
Inventario n. 25 Nominale: Asse.Autorità emittente: Impero Romano, imperatore Domiziano.Dritto: Testa laureata di Domiziano a destra. Scritta: Nell’intorno “IMP. CAES. DOMIT. AVG. GERM. COS. XV CENS. PER. P.P.” (Imperatore cesare Domiziano au-gusto germanico console per la quindicesima volta censore perpe-tuo padre della patria).Rovescio: La Fortuna stante a sinistra regge un timone e una cor-nucopia.Scritta: Nell’intorno “FORTVNAE AVGVSTI” (Fortuna dell’augusto) nel campo “SC” (senato consulto)Peso: g 8,5 Diametro medio: 27 mm Metallo: AEZecca: Roma Posizione conii: 165° Data: 90-91 d.C.Osservazioni: Moneta in patina verde con forti corrosioni spe-cialmente sui bordi, che la rendono di diicile lettura. La data e stata desunta dalla scritta COS XV che si intravede sul bordo, ma esistono anche altre emissioni con: COS XII, COS XIII, COS IIII, COS XVI, COS XVII. Rispettivamente descritti sul RIC ai numeri: 333, 353, 371, 407, 422.Bibl.:RIC vol. II Domiziano n.394 Londra 1926 ristampa 2001Ambiente 7
Inventario n.29 Nominale: Quadrante.Autorità emittente: Impero Romano, imperatore Nerva.Dritto: Modio con quattro spighe di grano.Scritta: “IMP. NERVA CAES. AVG.” (imperatore Nerva Ce-sare Augusto).Rovescio: Caduceo alato.Scritta: nel campo “S.C.” (Senato consulto) Peso: g 1,9 Diametro medio: 14,5 mm Metallo: AEZecca: Roma Posizione conii: 170° Data: 96 – 98 d.C.Osservazioni: Moneta con patina verde, in buona conservazio-ne, decentrata al dritto.Bibl.: RIC Vol. II Nerva n.113 London 1926Ambiente 7
Inventario n. 30 Nominale: Dupondio.Autorità emittente: Impero Romano, imperatore Nerva.Dritto: Testa radiata a destra.Scritta: “IMP. NERVA CAES. AVG. P.M. TR.P. COS III P.P. ” (imperatore Nerva cesare augusto Ponteice massimo, tribuno della plebe, console per la terza volta, padre della patria).Rovescio: Due mani strette che reggono un aquila legionaria, alla base di questa una prua di nave.Scritta: Nell’intorno “CONCORDIA EXERCITVVM” (concordia esercito) nel campo “S.C.” (Senato consulto) Peso: g 10,3 Diametro medio: 26,30 mm Metallo: AEZecca: Roma Posizione conii: 165° Data: 96 d.C.Osservazioni: Moneta con patina verde, in buona conservazione, usurata.Bibl.: RIC Vol. II Nerva n.81 London 1926Ambiente 8
Inventario n. 31 Nominale: Denario.Autorità emittente: Repubblica romana, gens Marcia.Dritto: Teste accollate di Numa Pompilio e Anco Marzio.Scritta: Anepigrafe. Dietro le teste una marca di controllo.Rovescio: Desultor al galoppo su due cavalli.Scritta: In esergo “C.CENSO” (C. Censorinus) sotto i cavalli una marca di controllo. Peso: g 3,6 Diametro medio: 19,00 mm Metallo: AGZecca: Roma Posizione conii: 150° Data: 88 a.C.Osservazioni: Moneta con spessa patina nera, molto usurata dalla circolazione.Bibl.: RRC Vol. I n.346/1 Cambridge 1974 ristampa 1983Ambiente 4
34
Inventario n. 42 Nominale: Obolo.Autorità emittente: Hipponion.Dritto: Testa di Atena con elmo corinzio ornato da grifoni a destra.Scritta: Sopra “ΣΩΤΕΙΡΑ”Rovescio: Nike stante a sinistra con frusta e scettro.Scritta: Di ianco “ΕΙΠΩΝΙΕΩΝ”. Peso: g 6,1 Diametro medio: 21,8 mmMetallo: AE Zecca: Hipponion. Posizione conii: 235°Data: 324-294 a.C. Osservazioni: Patina verde scuro, estese e spesse concrezioni.Bibl.: Calabria Greca Attianese vol.2 Hipponion n.722 Santa Severina 1977 De Luca editoreAmbiente 2
Inventario n. 32 Nominale: Asse.Autorità emittente: Impero Romano, imperatore Antonino Pio per Marco Aurelio.Dritto: Testa nuda di Marco Aurelio a destra.Scritta: Nell’intorno “AVRELIVS CAESAR AVG. PII F. COS. II” (Aurelio cesare, iglio del pio augusto, console secondo). Rovescio: Hilaritas stante a sinistra regge una lunga palma e una cornucopia. Scritta: Nell’intorno “HILARITAS” nel campo “SC” (senato consulto).Peso: g 9,3 Diametro medio: 24,3 mm Metallo: AEZecca: Roma Posizione dei conii: 25° Data: 145 d.C.Osservazioni: Patina verde, buona conservazione, ben centrata. Bibl.: RIC vol. III Antonino Pio n.1260 London 1930 ristampa 2003Ambiente 2
Inventario n. 34 Nominale: Asse.Autorità emittente: Impero Romano, imperatore Vespasiano per Tito cesare.Dritto: Testa laureata di Tito a destra. Scritta: Nell’intorno “T. CAESAR. IMP. COS. III CENS.” (Tito cesare, imperatore, console per la terza volta, censore).Rovescio: L’Equità stante a sinistra regge un’asta e una bilancia.Scritta: Nell’intorno “AEQVITAS AVGVST” (Equità dell’au-gusto) nel campo “SC” (senato consulto)Peso: g 11,2 Diametro medio: 27,1 mm Metallo: AEZecca: Roma Posizione conii: 180° Data: 74 d.C.Osservazioni: Moneta in patina verde scuro, presenta molte sfe-rule concrezionate sulla supericie.Bibl.: RIC vol. II Vespasiano n.666 Londra 1926 ristampa 2001Ambiente 2
Inventario n. 40 Nominale: Asse dimezzato (riduzione unciale) Autorità emittente: Repubblica Romana.Dritto: Testa di Giano. Scritta: Illeggibile.Rovescio: Prua di nave a destra. Scritta: IlleggibilePeso: g 9,9 Diametro medio: 30,5 mm Metallo: AEZecca: Roma. Posizione conii: IlleggibileData: II secolo a.C. Osservazioni: La moneta è stata divisa a metà per motivi di necessità dovuti alla carenza di divisionale eneo da parte della zecca di Roma in epoca tardo repubblicana.Bibl.: RRC Roma dal n. 56 e seguenti Cambridge 1974 ristampa 1983Ambiente 2
35
Inventario n. 43 Nominale: Sesterzio.Autorità emittente: Impero Romano, imperatore Settimio Severo.Dritto: Testa laureata a destra di Settimio Severo.Scritta: Nell’intorno “L.SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. X” (Lucio Settimio Severo Pertinace Augusto imperatore per la decima volta).Rovescio: Genio stante a sinistra sacriica con una patera sopra un altare, con l’altra mano regge delle spighe.Scritta: Nell’intorno “P.M. TR.P. V COS. II P.P.” (Ponteice massimo, tribuno della plebe per la quinta volta, console per la seconda volta, padre della patria) nel campo in basso “S.C.” (senato consulto).Peso: g 16,4 Diametro medio: 25,8 mm Metallo: AEZecca: Roma Posizione dei conii: 15° Data: 197-198 d.C.Osservazioni: Patina porosa verde chiaro, di modulo stretto, parte della scritta è rimasta fuori, peso calante.Bibl.: RIC vol. IV Settimio Severo n.743 London 1936Ambiente 2
Inventario n.46 Nominale: Quadrante.Autorità emittente: Impero Romano, imperatore Caligola.Dritto: Pileus con ai lati le lettere “S.C.” (Senato Consulto).Scritta: Nell’intorno “C. CAESAR DIVI AVG. PRON. AVG.” (Caio Cesare pronipote del divo Augusto, Augusto).Rovescio: Scritta “R.C.C.” (Remissio Ducentesima)*Scritta: Nell’intorno “PON.M. TR.P. IIII P.P. COS. TERT.”. (Ponteice Massimo, Tribuno della plebe per la quarta volta, Pa-dre della patria, Console per la terza volta). Peso: g 3,1 Diametro medio: 17,6 mm Metallo: AEZecca: Roma. Posizione conii: 160° Data: 40-41 d.C.Osservazioni: Patina verde conservazione buona, ben centrata, la lettera C al centro del rovescio è stata asportata da una corro-sione che ha interessato la lettera R e il numero IIII in basso. * Le lettere RCC ricordano l’annullamento della tassa voluta da Augusto del 1% su tutte le vendite a favore dell’erario militareBibl.: RIC vol. I Caligola n.52 London 1984Ambiente 2
Inventario n. 47 Nominale: Quadrante.Autorità emittente: Impero Romano, imperatore Nerone.Dritto: Civetta sopra un altare inghirlandato.Scritta: Nell’intorno “NERO CLAV.CAE. AVG.”. (Nero Clau-dio, Cesare, Augusto.) Rovescio: Ramoscello.Scritta: Nell’intorno “GER. P.M. TR.P. IMP. P.P.”. (Germa-nico, Ponteice Massimo, Tribuno della plebe, Imperatore, Padre della patria). Nel campo “S.C.” (Senato Consulto)Peso: g 1,8 Diametro medio: 14 mm Metallo: AEZecca: Roma. Posizione conii: 180° Data: 64 d.C.Osservazioni: Patina verde, decentrata al dritto.Bibl.: RIC vol. I Nerone n.258 London 1984Ambiente 2
Inventario n. 48 Nominale: Asse (riduzione unciale)Autorità emittente: Repubblica Romana.Dritto: Testa di Giano.Legenda: Sopra la testa “I” (segno di valore).Rovescio: Prua di nave a destra.Scritta: Sopra monogramma “TP” (signiicato sconosciuto), davanti la prua “I” (segno di valore),Sotto “ROMA” Peso: g 25,2 Diametro medio: 30,7 mm Metallo: AEZecca: Roma. Posizione conii: 240° Data: 169 - 158. a.C. Osservazioni: Patina verde, notevole usura.Bibl.: RRC Roma n.177/1 Cambridge 1974 ristampa 1983Ambiente 10
Inventario n. 44 Nominale: Quadrante.Autorità emittente: Impero Romano, imperatore Claudio.Dritto: Modio con tre piedi.Scritta: Nell’intorno “TI. CLAVDIVS CAESAR AVG.” (Tiberio Claudio Cesare Augusto).Rovescio: Scritta “S.C.” (senato consulto)Scritta: Nell’intorno “PON.M. TR.P. IMP. P.P. COS.II”. (Ponteice Massimo, Tribuno della plebe, Imperatore, Padre della patria, Console per la seconda volta). Peso: g 2,6 Diametro medio: 16,5 mm Metallo: AEZecca: Roma. Posizione conii: 180° Data: 42 d.C.Osservazioni: Patina verde conservazione perfetta.Bibl.: RIC vol. I Claudio n.90 London 1984Ambiente 2
36
Inventario n. 52 Nominale: Asse.Autorità emittente: Impero Romano, imperatore Antonino Pio per Marco Aurelio.Dritto: Testa nuda di Marco Aurelio a destra.Scritta: Nell’intorno “AVRELIVS CAESAR AVG. PII F. ” (Aurelio Cesare iglio del Pio Augusto). Rovescio: Pietà stante a sinistra, regge un’asta, la mano destra tiene una scatola di profumo al di sopra di un bambino.Scritta: Nell’intorno “TR.POT. III COS. II” (Tribuno della plebe per la terza volta, console per la seconda volta) nel campo “SC” (senato consulto) in esergo “PIETAS” (Pietà).Peso: g 11,2 Diametro medio: 26,2 mm Metallo: AEZecca: Roma Posizione dei conii: 20° Data: 149 - 150 d.C.Osservazioni: Patina verde, presenza di alcune piccole corrosio-ni nel campo, altrimenti conservazione perfetta. Bibl.: RIC vol. III Antonino Pio n.1293 London 1930 ristampa 2003Ambiente 7
Inventario n. 50 Nominale: Asse.Autorità emittente: Impero Romano, imperatore Augusto.Dritto: Testa a destra di Augusto.Scritta: Nell’intorno “CAESAR AVGVSTVS PONT. MAX. TRIBVNIC. POT.” (Cesare Augusto Ponteice massimo, tri-buno della plebe).Rovescio: Scritta “S.C.” (senato consulto)Scritta: Nell’intorno “M. MAECILIVS TVLLVS III.VIR. A.A.A.F.F.” (M. Maecilius Tullus triunviro monetale per fonde-re e battere bronzo, argento e oro).Peso: g 11,0 Diametro medio: 27,5 mm Metallo: AEZecca: Roma Posizione dei conii: 225° Data: 7 a.C.Osservazioni: Patina verde non uniforme molto corrosa al drit-to, debolezze di conio sui bordi al dritto e al rovescio, contorno perlinato.Bibl.: RIC vol. I Augusto n.435 London 1984 ristampa 1999Cortile presso Ambiente 2
Inventario n. 55 Nominale: Asse.Autorità emittente: Impero Romano, imperatore Claudio.Dritto: Testa nuda a sinistra di Claudio.Scritta: Nell’intorno “TI. CLAVDIVS CAESAR AVG. P.M. TR.P. IMP. P.P.” (Tiberio Claudio Cesare, Augusto Ponteice Massimo, Tribuno della Plebe, Imperatore, Padre della patria).Rovescio: Minerva elmata brandisce un giavellotto, e si proteg-ge con uno scudo. Scritta: Nel campo “S.C.” (Senato consulto). Peso: g 11,6 Diametro medio: 29,80 mm Metallo: AE Zecca: Roma Posizione conii: 160° Data: 50- 54 d.C.Osservazioni: Patina verde, chiazzata a dritto, conservazione discreta anche se presenta estesi fenomeni di concrezione, usura media.Bibl.: RIC vol. I Claudio n.116 London 1984 ristampa 1999Cortile presso il pozzo
Inventario n. 49 Nominale: Asse.Autorità emittente: Impero Romano, imperatore Nerone.Dritto: Testa laureata a sinistra di NeroneScritta: Nell’intorno “IMP. NERO CAESAR AVG. GERM.”(Imperatore Nerone Cesare Augusto Germanico).Rovescio: Vittoria alata porta uno scudo con scritta.Scritta: Sullo scudo “S.P.Q.R.” (Senato del popolo romano) nel campo “S.C.” (senatoconsulto).Peso: g 12,3 Diametro medio: 27,30 mm Metallo: AEZecca: Roma Posizione conii: 170° Data: 66 d.C.Osservazioni: Conservazione molto buona, patina verde chiaro, poco o niente usurata. Bibl.: RIC vol. I Nerone n.352 London 1984Ambiente 2
37
Inventario n. 65 Nominale: non id.Autorità emittente: non id.Dritto: Testa maschile a destra. Scritta: non id.Rovescio: Tripode Scritta: non id.Peso: g 2,5 Diametro medio: 15,8 mm Metallo: AEZecca: non id. Posizione conii: 0°Data: non id. Osservazioni: Patina verde conservazione scarsa.Ambiente 1
Inventario n. 56 Nominale: Asse.Autorità emittente: Impero Romano, imperatore Lucio Vero.Dritto: Testa nuda di Lucio Vero a destra. Scritta: Nell’intorno “L. VERVS AVG. ARMENIACVS.” (Lucio Vero, Augusto, Armenico).Rovescio: Marte avanzante a sinistra, regge una vittoria, un tro-feo e un parazonium.Scritta: Nell’intorno “TR.P. IIII IMP. II COS. II” (Tribuno della plebe per la quarta volta, acclamato imperatore per la secon-da volta, e console per la seconda volta) nel campo “SC” (senato consulto)Peso: g 9,8 Diametro medio: 24,6 mm Metallo: AEZecca: Roma Posizione conii: 200° Data: 163-164 d.C.Osservazioni: Moneta in patina verde, al dritto concrezione do-vuta a un vecchio colpo.Bibl.: RIC vol. III Lucio Vero n.1377 Londra 1930 ristampa 2003Cortile centrale
Inventario n. 59 Nominale: Sesterzio.Autorità emittente: Impero Romano, imperatore Domiziano.Dritto: Testa laureata con egida a destra di Domiziano.Scritta: Nell’intorno “IMP. CAES. DOMIT. GERM. COS.XI CENS. POT. P.P.” (Imperatore, Cesare, Domiziano, Ger-manico, Console per l’undicesima volta, Potestà censoria, Padre della Patria).Rovescio: Domiziano stante a sinistra viene incoronato dalla vit-toria. Scritta: In esergo “S.C.” (senato consulto).Peso: g 25,2 Diametro medio: 35,1 mm Metallo: AEZecca: Roma Posizione dei conii: 180° Data: 85 d.C.Osservazioni: Patina verde chiaro, di modulo largo, molto usurata. Bibl.: RIC mancaAmbiente 5
Inventario n. 61 Nominale: Asse.Autorità emittente: Impero Romano, imperatore Antonino Pio per Faustina minore.Dritto: Busto di Faustina minore a destra.Scritta: Nell’intorno “FAVSTINAE AVG. PII AVG. FIL. ” (Faustina Augusta Pia, iglia dell’Augusto). Rovescio: Hilaritas stante a destra si aggiusta il velo a regge una lunga palma. Scritta: Nell’intorno “HILARITAS” nel campo “SC” (senato consulto).Peso: g 8,8 Diametro medio: 28,2 mm Metallo: AEZecca: Roma Posizione dei conii: 0° Data: 145 - 146 d.C.Osservazioni: Patina bruno verde, buona conservazione, ton-dello molto ovalizzato usurata. Bibl.: RIC vol. III Antonino Pio n.1396 London 1930 ristampa 2003Ambiente 1
Inventario n. 62 Nominale: Asse (riduzione unciale)Autorità emittente: Repubblica Romana, gens Saufeia.Dritto: Testa di Giano.Scritta: Sopra la testa “I” (segno di valore).Rovescio: Prua di nave a destra.Scritta: Sopra “L.SAVF” (L. Saufeius). Sotto “ROMA”Peso: g 26,5 Diametro medio: 32,5 mm Metallo: AE Zecca: Roma. Posizione conii: 180° Data: 152 a.C. Osservazioni: Patina verde, usurata.Bibl.: RRC Roma n. 204/2 Cambridge 1974 ristampa 1983Ambiente 2
38
L’ediicio a pianta quadrata: una prima ipotesi di ricostruzione
L’ediicio quadrato sco-perto in occasione degli scavi negli anni Settan-ta1, situato a Nord – Est della via Aurelia antica nel complesso identii-cato come “Le Guardio-le” (zona A settore II), è stato oggetto di indagine nelle campagne di ricer-ca del 2011-13.La struttura, a pianta quadrangolare con lati lunghi approssimativa-mente 22 metri, è orien-tata con la fronte lungo il margine della strada, dalla quale dista circa 3 metri (Crf. p. 14). All’in-terno dell’ediicio erano già stati identiicati diversi ambienti: il lato Nord-Ovest presenta un vano riscaldato ca-ratterizzato da suspensurae in laterizi e dalla pavimentazione in mosaico datato all’epoca augustea, mentre nell’ambiente adiacente è stata ritrovata una pavimentazione in piccoli cu-betti di laterizio2. Al di sotto di questi ambienti è stata scoperta una canaletta di scolo e poco distante un pozzo.Nel corso delle campagne di scavo 2012-13 l’indagine di queste strutture termali è stata ampliata anche se ancora non è stato possibile efettuare un’ipotesi deinitiva sulle loro speciiche funzioni.All’interno dell’ediicio, nell’area Sud-Est, sono stati rico-nosciuti alcuni ambienti tra loro vicini, grazie al ritrova-mento delle strutture murarie (Ambienti 2, 4 e 5). Subito all’esterno dell’Ambiente 5 a pochi centimetri dal muro Nord-Est, verso l’interno dell’ediicio è stato portato alla
1 GIANFROTTA 1972, pp. 110 - 1172 ENEI 2011, p. 12
luce il fondo di un dolio. Vicino a quest’ambiente, nell’area Nord- Est (Ambiente 8) è stato messo in evidenza un cospi-cuo strato di tegole, coppi e mattoni che per la loro singola-re disposizione orizzontale fanno pensare più ad uno strato di battuto (di una probabile seconda fase) che ad un crollo; inoltre, sempre nell’Ambiente 8, nell’angolo tra l’ambiente 5 e il muro perimetrale di Sud-Est, è stata individuata una vaschetta di cocciopesto.Nell’area Sud-Ovest dell’ediicio invece è stata ritrovata parte di una istula plumbea lunga all’incirca un metro e mezzo che passava al di sotto dell’ambiente 11 e verosimil-mente serviva per alimentare l’adiacente impianto termale.Importanti sono stati i rinvenimenti di numerose mone-te concentrate per lo più nell’area Ovest e di un anellino d’argento. I diversi tipi di materiali rinvenuti permettono di ipotizzare un ambito cronologico di occupazione che
va dal III – II secolo a.C. alla ine del III d.C. (Cfr. p. 23)
Le ipotesi ricostruttiveData la lacunosità delle strutture rinve-nute, non è stato ancora possibile accer-tare con sicurezza la funzione dell’edii-cio, ma i dati raccolti hanno permesso di formulare alcune ipotesi di ricostruzione che portano a pensare a diverse fasi di vita. Osservando in pianta la struttura si nota la somiglianza con la tipologia della “Domus Italica” che in origine si compo-neva di un atrio sul quale si afacciavano simmetricamente su un lato e sull’altro i cubicula per poi terminare in un giardino rettangolare nella parte posteriore della casa3. Al centro dell’atrio probabilmente doveva esserci un impluvium di cui anco-
3 CREMA 1959, pp. 251 - 252.
Fig. 1. Ipotesi ricostruttiva della ronte dell’ediicio afacciata sulla strada.
Fig. 2. Visione ricostruttiva particolare del portico dell’ediicio.
39
ra non ne è stata trovata traccia. Come si nota, gli Ambienti 2, 4 e 5 rispecchierebbero i cubicula, mentre gli Ambienti 1 e 11, originariamente uniti, comporrebbero le strutture ediicate simmetricamente nella parte opposta. Le fonda-zioni di pilastri messe in evidenza nell’area posteriore della struttura potrebbero far pensare ad un’area porticata in af-faccio sull’hortus.Se così fosse, le strutture corrispondenti agli Ambienti 12, 13 e 14, insieme al pozzo e alla diversa suddivisione degli ambienti, corrisponderebbero ad una fase successiva dell’ediicio.Un confronto si potrebbe fare con le strutture che nella colonia di Cosa, fondata come Castrum Novum sulla via Aurelia nel 273 a.C., vengono identiicate come “Casa 2”.4 Esse vengono deinite abitazioni prive di sfarzo, non grandi quanto le ville ma neanche troppo piccole come le insulae; un esempio è la “Casa Colonica di Giardino Vecchio”5 che presentava una distribuzione specializzata degli ambienti. I rimaneggiamenti subìti dai vani dell’ediicio fanno pen-sare ad una seconda fase come casa rustica, fattoria o una probabile mansio o mutatio (Fig. 1).Il ritrovamento della fondazione di un pilastro, distante pochi centimetri dalla crepidine della via Aurelia antica, con accanto una itta concentrazione di tegole e coppi, fa pensare alla presenza di una tettoia o un portico che col-merebbe la distanza tra la fronte e la via Aurelia, ponendosi direttamente sulla strada (Fig. 2). Il rinvenimento di numerose monete concentrate sotto l’eventuale tettoia nei pressi della soglia e del pilastro non solo segnalano qualche forma di commercio ma anche che la pavimentazione potesse essere realizzata con assi di le-gno tra le quali si sarebbero potute inilare le monete. La fondazione del pilastro, inoltre, per le sue dimensioni po-trebbe non solo essere la base di un sostegno della tettoia ma anche far supporre l’esistenza di un eventuale secon-do piano dell’ediicio, costruito in opera deperibile come l’opus craticium.Il ritrovamento di parte di un’anfora e di un dolium nei pressi della soglia dell’ambiente 11 (dove sono anche state ritrovate numerose monete) potrebbe far pensare all’uso di questo vano come ambiente di servizio o taberna, visto il suo afaccio diretto sulla via Aurelia. La presenza di un eventuale secondo piano si immagina an-che per la soglia principale, tra l’ambiente 1 e 2 che, sempre ipoteticamente, darebbe l’accesso al cortile interno (atrio); se fosse così presupporrebbe sicuramente un ambiente su-periore. La presenza di elementi come la vaschetta di coc-ciopesto e i dolia nel pavimento non esclude l’uso dell’edi-icio come fattoria di produzione, ma le informazioni al riguardo sono ancora troppo limitate.
Maria Teresa LevantoFederica Crocetti (graica)
4 CARANDINI 2002 p. 55.5 CARANDINI 2002 pp. 142 – 143.
1.3 La stratigraphie côtière au niveau de la colonie de Castrum Novum: résultats des trois premières campagnes d’étude
La colonie de Castrum Novum est située en bord de mer, au niveau d’une côte en régression sous l’efet de l’érosion marine. Cette érosion a provoqué la création d’une stratigraphie naturelle qui a coupé la ville antique en deux parties : une partie immergée et une partie qui est restée hors de l’eau (ig. 1). Par chance, cette érosion travaille le littoral à la manière d’un archéologue, c’est-à-dire qu’elle taille la paroi de manière plus ou moins verticale, laissant apparaître les niveaux géologiques et archéologiques en place sur une longueur de plus de 250 m. Ainsi, le travail de la mer, s’il détruit à fur et à mesure les structures apparentes, permet aussi de lire, sur plusieurs centaines de mètres, l’histoire du site et crée un document que peu d’archéologues ont eu à leur portèe.
I - Description de la stratigraphie naturelle
Cet impressionnant document se trouve au nord du Capo Linaro. Il abrite dans sa partie méridionale, sur environ une petite centaine de mètres, d’importants niveaux d’occupation qui remonte à l’époque villanovienne (IXe - VIIIe siècle av. J.-C. environ). Au nord, les traces de cette occupation de l’Âge du Fer ont presque été entièrement détruites par l’implantation de la colonie romaine au milieu du IIIe siècle av. J.-C. et seules des résidus ont été épargnés par les aménagements de l’époque romaine conservés sur plus de 150 m. Une grande partie de la côte qui nous concerne est occupée par des palaitte : cabanons construits sur la mer et reliés au rivage par des passerelles sur pilotis en bois. Si les poteaux en bois des passerelles de ces cabanes sont une gêne pour l’étude de la stratigraphie, ils assurent toutefois une certaine protection contre les vagues. Autre aide importante est la bienveillance d’un certain nombre de personnes concessionnaires de palaitte qui nous ont grandement facilité l’accès et le travail de terrain1.
1 Je voudrais remercier en particulier Giovanni Biagioli et Fausto Bacchetti pour leur accueil et leur aide, sans oublier d’associer à ces remerciements, les membres du Yacht Club de Santa Mari-nella en commençant par son président Claudio Caneva.
Fig. 1: vue panoramique de la stratigraphie côtière (avec le Capo Linaro en arrière-plan)
40
Lors du lancement de la mission italo-française en 2010, la première décision fut de diviser la stratigraphie en deux secteurs : un secteur 1, dans la partie méridionale, où sont conservés les niveaux de l’âge de Fer et un secteur 2, dans la partie septentrionale, où sont conservées les structures de la ville romaine.Travailler sur un tel document est compliqué, il a donc été décidé, lors de la première campagne, en septembre 2010, de commencer par concevoir une méthode de travail en choisissant une partie limitée de la stratigraphie. Une structure imposante dépassait de la paroi au sud de la partie romaine de la stratigraphie: il fut procédé à son nettoyage et à son relevé et la structure en question s’est révélée être un balneum. C’est à partir de cette expérience qu’il fut décidé de commencer l’étude de l’ensemble de la coupe l’année d’après en débutant, par commodité, par la partie romaine, depuis le nord de la section, à proximité d’une petite casemate datant de la seconde guerre mondiale.
II - Les méthodes de travail
La stratigraphie est un document qui fait environ 4 mètres de haut, depuis les niveaux géologiques qu’au substrat végétal. Pour des raisons de sécurité, il est interdit de fouiller, car elle jouxte la via Aurelia moderne (Strada Statale 1) au nord et la via Marconi au sud et la fragilité même de la paroi demande beaucoup de prudence.La méthode de travail a consisté à relever la partie «romaine» de la stratigraphique par tranches. Pour ce secteur, quatre sous-sections ont été créées en fonction des réalités topographiques de la zone Après nettoyage, le travail de relever a consisté tout d’abord à:1 - créer des axes gradués situés au plus près de la paroi;2 - dessiner en plan les contours de la falaise et l’insérer dans un document planimétrique du secteur;
Fig. 2: Canalisation « républicaine » (égout n° 1)
Fig. 3 : Canalisation d’époque impériale (égout n° 5)
Fig. 4: vue de la stratigraphie avec deux niveaux de construction
Fig. 5: mur en opus reticulatum-mixtum d’époque impériale (structure n° 15)
41
3 - relever les structures apparentes en fonction de leur position sur les axes établis, aussi bien en verticale qu’en horizontale;4 - procéder à une couverture photographique, si possible continue, du document archéologique, malgré les obstacles matériels rencontrés, en particulier, les poteaux en bois des passerelles des cabanons construits sur cette portion de la cote;5 - intégrer toute la documentation dans la trame topographique du site2.
2 L’équipe responsable depuis 2012 de la partie topographique et architecturale du site est composée de Nathalie André (architecte DPLG) et de Véronique Picard : IRAA - USR 3155 du CNRS, Université de Pau et du pays d’Adour.
Fig. 7: vue de la structure interne du mur de terrassement n° 17 (c, d, et e)
Fig. 8 : parement en opus reticulatum du mur de terrassement 17a
Fig. 9: vue verticale du puits hydraulique de la structure n° 20
Fig. 6: Mur de terrassement n° 17 (c, d, e et f )
42
III -Le secteur 2: description des vestiges visibles de la ville romaine
La stratigraphie naturelle nous permet de voir les vestiges de la colonie sur plus de 150 mètres. Au nord, les renforcements de la via Aurelia moderne, en particulier un mur de soutènement la protégeant du ressac de la mer, a caché les structures romaines existantes à ce niveau; au sud, la limite de la ville romaine est visible par l’absence de vestiges de cette époque et l’apparition des niveaux bien conservés de l’époque villanovienne (secteur 1).Les structures visibles sont de plusieurs natures: dans les niveaux les plus bas, nous trouvons des canalisations, au nombre de cinq, construites en partie dans les strates géologiques dont la fonction était de servir d’égouts. Les plus anciennes ont été construites en blocs de pierre (époque républicaine), alors que les plus récentes (époque impériale) sont maçonnées en opus caementicium avec parements en briques recouverts en bâtière faite en briques (Fig. 2 et 3).
Au-dessus, nous trouvons, à distance régulière, des vestiges d’édiices dont la plupart ne peuvent pas être identiiés: fondations de murs et murs eux-mêmes, préparations de sol et revêtements souvent de mosaïque, enduits peints à la base des murs (Fig. 4). Une partie de ses structures murales émergent de la paroi et permettent d’étudier leur technique de construction. Par exemple, la structure 15 est une construction en opus reticulatum mixtum à chaînage de briques. Cette technique est caractéristique de la période lavienne ou antonine (Fig. 5).La très grande majorité des vestiges retrouvés ont des directions axées sur les points cardinaux, ce qui suggerèe l’existence d’un urbanisme reguliére de la colonie romaine. Les résultats obtenus par la prospection géophysique menée par la société ATS s.r.l dépendant de l’Université de Sienne (S. Campana et F. Pericci) en novembre 2011 conirme cette organisation régulière de la ville (Cfr. p. 46).Si la majorité des vestiges ne sont visibles qu’en stratigraphie, certains autres, plus massifs, débordent des parois. Le premier exemple est le balneum étudié en 2010 dont nous pouvons voir une partie de la baignoire chaufée de plan semi-circulaire encadré par son couloir de service situé en contrebas et dont la paroi extérieure, en opus caementicium, a été coulée dans les niveaux géologiques. Les vestiges de cet édiice se poursuivent au sud par la presence en stratigraphie pentêtre d’un autre bassin (voir quaderno 1). Les trois dernières campagnes (2011 à 2013) nous ont permis de dégager et d’étudier une autre structure importante (n° 17) située à la limite entre les sous-secteurs 2 et 3 et que l’on peut suivre sur une distance de plus de 15 m (Figg. 6 et 7). Elle est conservée en plusieurs tronçons, fractionnement dû en partie par la présence d’un torrent, qui sert toujours, de nos jours, de canal d’évacuation des eaux de pluie (Fig. 6). La structure 17 était revêtue d’un parement en opus reticulatum qui a été en partie démonté (Fig. 8). Son nettoyage complet a permis de comprendre qu’il s’agissait d’un mur imposant composé de deux murets de 0,70 m d’épaisseur liés à un noyau en argile compacté créant ainsi une structure de 3,40 m d’épaisseur. Si les
parements extérieurs des deux murets ont été réalisés dans la technique de l’opus reticulatum, on note toutefois une diférence de niveau entre la rangée inférieure en cette technique du muret oriental (situé à un mètre au-dessus du niveau de la plage) par rapport à celle du muret occidental qui, lui, n’est pas visible, car sous le niveau de cette même plage. Cette diférence implique que le niveau de circulation du côté ouest, vers le port, était probablement plus bas d’un mètre voire plus que du côté est (vers la ville) et que cette structure avait probablement une fonction de mur de terrassement.On constate enin la présence d’une structure hydraulique 20, composée d’un puits et d’un bassin de stockage de l’eau captée, qui est venue s’appuyer sur le mur de terrassement 17 (Fig. 9). Sa fonction est mystérieuse, car nous ne connaissons pas la destination de cette réalisation: quel type d’édiice devait-elle ravitailler en eau ?
Excepté le balneum, il est diicile de donner une limite et une fonction aux vestiges étudiés. Certains d’entre eux devaient être des maisons, d’autres des bâtiments publics, avec leurs pavements de mosaïque et leurs enduits peints sur les murs comme cela est encore visible. Toutefois, seule une fouille sous la via Aurelia moderne pourrait résoudre cette question, ce qui est diicilement envisageable. Autre problème est l’impossibilité de repérer, pour l’instant, la présence d’une viabilité entre les structures existantes et donc de pouvoir déterminer, au moins, la longueur ou la largeur des insulae de la colonie romaine. Enin, l’interdiction de fouiller et l’absence de matériel céramique ou autre en stratigraphie ne permet pas d’ainer les datations des structures observées, seules les techniques de constructions peuvent nous y aider et permettre d’établir une chronologie relative.
Ces quatre premières campagnes ont donc permis d’étudier plus de 150 m. de stratigraphie (Fig. 10). Il reste, à présent, à achever l’analyse et le relever de l’extrémité méridionale de la partie romaine de la stratigraphie, puis à étudier le secteur 1 où se situent les niveaux remarquablement bien conservés de l’époque de l’âge du Fer. Si, contrairement au secteur « romain », aucune structure maçonnée n’est visible, ces niveaux protohistoriques se caractérisent par la présence de sols compacts et de niveaux d’occupation composés d’importants dépôts de tessons de céramique. Les niveaux villanoviens ne s’arrêtent pas avec la in du secteur 1 et le commencement du secteur 2, car la partie méridionale de ce dernier secteur abrite encore des traces de cette période reculèe, visibles entre les fondations des édiices romains. Elles indiquent la limite septentrionale de l’occupation humaine au début du Ier millénaire avant J.-C. au nord du Capo Linaro (Cfr. p. 44).Enin, au-delà de secteur 1, vers la pointe du Capo Linaro, il existait, il y a encore quelques années, un grand mur romain en opus reticulatum appartenant probablement à une villa maritime. Cette documentation disparue, mais connue par des photographies récentes, devra, elle aussi, être étudiée et insérée dans le document inal.
Gregoìre Poccardi
43
Fig. 10 : Castrum Novum, Zone B : relevé d'une partie de la section stratigraphique de la ligne de côte exposé à l'érosion marine (document réalisé par N. André et V. Picard).
1 2 3 4 5 mt0
44
spesso strato. All’interno della sezione, ad una profondità di circa 150 cm dalla supericie di calpestio attuale, è visibile un lungo strato, spesso circa 15 cm, biancastro (probabilmente dovuto a calcinazione) al cui interno, in zone circoscritte, si sono rinvenute lenti carboniose e chiazze di terra rubefatta e qualche raro frammento ceramico (Fig 1; Fig 2).Nello strato sovrastante quello biancastro, si sono rinvenuti numerosi frammenti di olle di medie dimensioni, d’impasto rossiccio, con orlo svasato o estrolesso talvolta recanti deco-razione con cordone plastico posto tra orlo e spalla. I fram-menti in molti casi presentano ampie tracce di annerimento da combustione (Fig 3).Oltre alle olle sono presenti forme aperte di piccole dimen-sioni quali ciotole e tazze carenate, talora con ansa a nastro
soprelevata (Fig. 4). Dallo studio dei re-perti, sembra possibile la collocazione cronologica del deposito alla prima età del Ferro.All’interno dello strato sottostante lo stra-to biancastro (US 7), è stato rinvenuto uno strumento in selce su supporto laminare,
Pietrame1 mt
9
8
7
4
65
2
3
1
0Carboni
Ceramica Lama in selce
2. Contributi agli studi2.1 Le presenze pre-protostoriche:
un insediamento produttivo costiero dell’età del Ferro
Le uniche evidenze archeologiche ascrivibili ad epoche pre o protostoriche sono state riscontrate all’interno della sezione formatasi lungo la scarpata ubicata a brevissima distanza dal-la via Aurelia, per azione costante e implacabile del mare. La porzione di sezione maggiormente signiicativa, estesa per più di dieci metri di lunghezza, si trova nella zona immediata-mente a nord di Torre Chiaruccia, ove è stato individuato un notevole accumulo di frammenti ceramici all’interno di uno
Fig. 1. Tratto della sezione sulla spiaggia interessato dalle presenze dell’età del ferro.
Fig. 2. Castrum Novum – sezione altezza Pala-itta RA 448. US 1: Basamento in cemento della passerella del-la palaitta.US 2: Terra marrone scuro con rammenti cera-mici, pietrame, ciottoli.US 3: Abbondanti accumuli di rammenti cera-mici, raro pietrame qualche porzione di carbone.US 4: Terra molto scura a grana sottile con qual-che ciottolo di medie dimensioni e rari rammenti ceramici.US 5: Supericie antropizzata, biancastra con raro pietrame di piccolissime dimensioni e chiazze di materiale combusto.US 6: Lenti carboniose con alterazioni rubefatte.US 7: Terra sabbiosa giallastra con granelli di pie-tra nera (lama in selce). US 8: Strato geologico con itto pietrame. US 9: Banco geologico di pietraforte.
Fig. 3. Orli di olle dalla sezione sulla spiaggia.
45
mutilo di tallone, recante ritocco semplice diretto, sia mar-ginale che profondo, su uno dei margini laterali; due intac-cature alternate interessano l’altro margine laterale (Fig. 5). Le caratteristiche del manufatto sembrerebbero rimandare la sua esecuzione ad un periodo precedente rispetto a quello dell’accumulo ceramico.Sono state rinvenute inoltre, decontestualizzate, ai piedi dell’ampia sezione, due ibule in bronzo di piccole dimen-sioni: la prima è una ibula ad arco semplice, leggermente ingrossato, mutilata di ardiglione e stafa (Fig. 6); la seconda è una ibula a sanguisuga recante decorazione incisa a bande di linee parallele alternate, mancante di ardiglione e molla (Fig. 7). Entrambi i manufatti sono ascrivibili alla prima età del Ferro.Durante l’ultima fase del Bronzo inale e soprattutto il primo Ferro si assiste in buona parte dell’Etruria ad un abbandono degli insediamenti su altura in favore di posizioni maggior-mente vicine alle coste. Il fenomeno viene giustiicato da una larga parte di studiosi, come conseguenza di un diferente assetto politico-territoriale e il consistente controllo del ter-ritorio con la creazione di atelier produttivi o “poli industria-li” in zone prescelte dalle comunità1 , ovvero quale razionale conseguenza della pressione demograica all’interno di abi-tati centrali e conseguente popolamento di zone periferiche di interesse commerciale2.Sarebbe plausibile ascrivere il deposito in questione proprio ad insediamenti di tal genere, in cui il consistente accumu-lo di frammenti potrebbe indicare non tanto la presenza di luoghi abitativi, quanto piuttosto la pratica della rottura in-tenzionale del contenitore per il recupero del contenuto che, data la vicinanza col mare, potrebbe essere ad esso collegato quali pani di sale e composti alimentari a base di sale, solidi-icati in seguito ad esposizione al fuoco3.Proprio in località Torre Chiaruccia, verso la ine degli anni Cinquanta, è stata efettuata una serie di saggi di scavo, ad est e ad ovest del Fosso delle Guardiole, a seguito della se-gnalazione di una situazione analoga a quella qui presentata. In tale occasione è venuta alla luce una buca sul fondo della quale erano presenti pietrame e ampie tracce di combustione (Fig 8)4, interpretata come una struttura (forse una fornace), connessa alla produzione del contenuto delle olle delle quali sono stati rinvenuti una gran quantità di frammenti.Ulteriori strutture incavate ma rivestite di argilla ed inter-pretate come connesse ad attività di stoccaggio, sono docu-mentate nel civitavecchiese5, mentre si ha segnalazione di depositi di materiali ascrivibili al periodo considerato lungo l’intera fascia costiera compresa tra Cerveteri e Tarquinia6.La porzione di stratigraia esaminata, comprensiva di am-pio deposito ceramico e superici combuste, rimanderebbe dunque all’esistenza di un sito analogo a quelli indagati, e dunque plausibilmente atto ad una qualche produzione ali-mentare connessa all’uso del fuoco.
Valentina Asta, Marco Fatucci
1 Pacciarelli, 2000, pp. 170-1792 Colonna, 1986, pp. 90-1183 Belardelli et alii, 2006, pp.233-270 4 Barbaranelli, 1956, p. 4805 Toti, 1962, p. 2026 Pacciarelli, 1991, pp. 163-208.
Fig. 5. Frammento di lama in selce dalla sezione
Fig. 6. Fibula in bronzo ad arco caduta dalla sezioneFig. 7. Fibula in bronzo del tipo a sanguisuga caduta dalla sezione
Fig. 4. Frammento di ansa a nastro sopraelevata dalla sezione.
Fig. 8. Buca con tracce di combustione documentata sulla sezione (da Barbaranelli 1956)
0 1 cm
0 1 cm
0 1 cm0 1 cm
46
2.2 Le indagini magnetometriche sull’area della città antica:
le prime immagini dell’abitato sepolto di Castrum Novum
Nel novembre del 2011, su incarico del laboratorio CNRS dell’Ecole Normale Supérieure di Parigi, la ditta ATS dell’Università di Siena ha potuto eseguire una prima in-dagine magnetometrica sul rilievo dominante la costa, tra il Casale Alibrandi e la via Aurelia, nell’area di circa 14.000 mq, sita subito a nord-ovest della via che dalla strada statale conduce al casale1 (Figg. 1-3). Il rilievo, che raggiunge quota 7,4 m s.l.m, da tempo incolto e preservato dalle costruzioni grazie al vincolo archeologi-co, coincide con un settore senza dubbio importante dell’antica città di Castrum Novum i cui resti murari aiorano in più punti, sia sulla sommità che lungo le pen-dici. La prospezione non ha potuto riguar-dare la zona meridionale dell’abitato, sita a ridosso dell’odierna via Giulio Cesare, dove nel 1977 in occasione di sondaggi di scavo eseguiti dalla Soprintendenza erano stati rinvenuti diversi resti di ediici an-tichi e almeno dieci sepolture del tipo a cappuccina (Fig. 9).Nella zona sommitale oggetto dell’inda-gine, prima della prospezione, dopo lo sfalcio della rigogliosa copertura vegetale, è stata efettuata una ricognizione siste-matica dell’area che ha consentito di re-gistrare la presenza di numerosi materiali ceramici ed edilizi aioranti. Tra i reperti si segnalano frammenti di anfore di epoca repubblicana ed imperiale, ceramica a vernice nera, sigillata italica e tardo italica, ceramica africana di produzione A, C e D, africana da cucina, dolia. Moltissime tegole e coppi associati con la-
1 Le indagini sono state efettuate il 2.11.2011 sotto la direzione scientiica del Prof. S. Campana, acquisite, elaborate ed interpre-tate dal Dr. F. Pericci e dagli scriventi. E’ stato usato un magneto-metro luxgate Foerster a 4 sensori con GPS integrato.
terizi, cubilia in calcare, tessere musive bianche e nere, tesse-re musive in pasta vitrea colorata, parti di lastre in marmo, elementi di opus sectile marmoreo. Si è veriicata la presenza di una struttura in opera cementizia conservata per circa 2 metri di altezza, presso il limite del campo adiacente alla via Aurelia (Fig. 4) e di un grande accumulo di macerie con parti di blocchi squadrati, frammenti di marmo, cubilia in calcare e di scapoli da costruzione quasi nel mezzo del ter-reno.
Fig. 1. Preparazione del magnetometro
Fig. 2. Momento della rilevazione sul campo
Fig. 4. Strutture semiaioranti sulla sommità del rilievo, a ridosso della strada moderna.
Fig. 3. Localizzazione delle aree dove sono state eseguite le prospezioni (A e B).
47
Fig. 5. Risultato delle prospezione magnetometrica. Ben visibile il reticolo delle strut-ture sepolte.
Fig. 6. Prima interpretazione del ri-lievo. In evidenza le principali ano-malie e gli allineamenti.
Fig. 8. Particolare ingrandito del risultato della magnetometria: in evidenza i resti della città se-polta organizzata con uno schema regolare, all’interno di un recinto rettangolare, forse coincidente con le mura del castrum di epoca repubblicana.
Fig. 7. Pianta delle anomalie e dei disturbi riscontrati
48
Tali resti indicano chiaramente la presenza di importanti strutture in opera reticolata e laterizia sepolte appena sot-to l’attuale piano di calpestio, in alcuni punti senza dub-bio conservate in elevato per oltre un metro. I materiali di supericie indicano una frequentazione protrattasi dal III secolo a.C. ino almeno al IV-V secolo d.C.
La prospezione è stata svolta a copertura quasi integrale dell’area rilevata ed accessibile con risultati molto signii-cativi ed interessanti per la deinizione della topograia di questa parte dell’abitato dell’antica Castrum Novum. Di particolare interesse è la zona centrale dell’area indagata nella quale, come risulta evidente dalla restituzione dei dati magnetometrici, si trovano allineamenti che presumi-bilmente si possono ricondurre alla parte abitativa dell’in-sediamento (Figg. 5 - 8). I dati esaminati mostrano quello che possiamo identiicare come un impianto urbanistico regolare con ediici di forma quadrangolare con all’interno ambienti ampi in media circa 3x3 m con valori magnetici medi compresi tra –40-0,01/+0,01+30. L’impianto urbano è stato rilevato per almeno 95 m in di-
rezione est-ovest e per circa 62 m sul lato nord-sud. Nella zona sud dell’area indagata risultano di particolare inte-resse delle anomalie di forma rettilinea che si dispongono tra loro parallele in direzione est-ovest. L’allineamento più a nord, lungo circa 98 metri, è interrotto per la presenza di un’anomalia circolare mentre l’altro ha invece una lun-ghezza di circa 63 metri. La distanza fra le linee è di circa 8 metri mentre i valori magnetici sono compresi tra –15-0,3/+0,01+40. Sulla base di quanto detto per forma, di-mensioni e valori magnetici è possibile ipotizzare che ci si trovi in presenza di una strada principale e/o di un muro importante che a sud dell’area abitata corre in direzione est ovest. In via di ipotesi potrebbe trattarsi del lungo portico segnalato dall’ispettore Annovazzi in occasione degli scavi del 1879.2 Nella metà sud dell’area indagata è interessante notare come si abbiano degli allineamenti che con orien-tamento totalmente diverso rispetto al contesto suddetto, corrono in direzione NE-SO.
2 Per il lungo portico con colonne liscie e scanalate vedi Anno-vazzi 1879, p. 136.
Fig. 9. Castrum Novum: posizionamento su base catastale delle trincee esplorative efettuate nel 1977 dalla Soprintendenza Archeologica. In rosso le strutture murarie e le “tombe a cappuccina” individuate.
49
E’ possibile ipotizzare che le tre linee, tra loro parallele ed equidistanti (15 m l’una dall’altra), possano far parte di un paesaggio agrario ormai scomparso ma non troppo lontano nel tempo. Possiamo attribuire queste tracce alla presenza di sistemi di divisione dei campi oppure, vista la distanza regolare delle linee, a un impianto legato ad un intervento per la realizzazione di una vigna. Gli elaborati lasciano in-travedere un tessuto edilizio molto itto con ediici dispo-sti in uno schema urbano senza dubbio regolare, orientato E-O (Fig. 10).
E’ possibile riconoscere molti ambienti aiancati, di diver-se dimensioni, almeno un lungo muro rettilineo e tracce di altri ortogonali posti a deinire quasi il perimetro di un perfetto rettangolo di circa 100x70 m. In via d’ipotesi la presenza di tali tracce rivelate dalla prospezione potrebbe essere riferita alle mura della colonia medio-repubblicana e quindi al castrum del III secolo a.C., sul quale si sarebbe in seguito sviluppato l’abitato di epoca imperiale.
Flavio Enei, Grégoire Poccardi
Fig. 10. Posizionamento dei risultati della prospezione nella topograia moderna (a cura di Nathalie André e Veronique Picard).
50
2.3 Scavi archeologici a Castrum Novum. Una ricognizione delle fonti
Trovandosi immediatamente a nord di Roma, su una delle più importanti vie di comunicazione, la parte costiera dell’Etruria meridionale ebbe a sofrire in maniera particolare dell’invasio-ne dei Goti di Alarico prima e della guerra greco-gotica poi. A Pyrgi ed Alsium è documentata la sopravvivenza di sia pur piccoli centri abitati, che si consolidarono lentamente e si svi-lupparono in età medievale e rinascimentale. Nel caso di Ca-strum Novum, invece, dove il primo strato archeologico sotto il piano di campagna è costantemente databile in età romana in tutte le occasioni di scavo inora documentate, possiamo afermare con una certa sicurezza che le invasioni barbariche abbiano causato l’esodo della popolazione dalla zona, che è rimasta inediicata praticamente ino ai giorni nostri.
Il mancato sviluppo del culto dei santi Secondiano, Veriano e Marcelliano, ritenuti, a torto o a ragione, martiri castronova-ni1 ma venerati altrove, tra Tarquinia e Tuscania, può costitu-ire un altro indizio della totale disgregazione della comunità di Capo Linaro già in epoca tardoantica. E’ probabile che la popolazione superstite si sia stabilita a Centumcellae o che abbia trovato nelle grandiose strutture della villa di Ulpiano, poco più a sud, le condizioni per la ri-presa della vita associata che portò alla formazione di Santa Marinella.
1 Si veda la ricostruzione di A. Squaglia “I Santi perduti di Ca-strum Novum” in questo stesso Quaderno, p. 68
Castrum Novum continuò ad essere segnalata nelle carte geo-graiche2 e a vivere nella memoria: secoli dopo la testimonian-za illustre di Rutilio Namaziano, troviamo citazioni sporadi-che in resoconti di viaggio o descrizioni dell’Italia di autori che, impressionati dall’estensione dei resti della peschiera visi-bili sott’acqua, inivano per dare dell’antica Castrum Novum l’immagine di una città sprofondata in mare.3 Punto di riferimento per tutti, la Torre della Chiaruccia, ele-mento della linea di fortiicazioni costiere voluta da Pio V nel 1567 e da allora presidiata costantemente da una piccola guar-nigione.Nel 1776, anno in cui ebbero inizio i primi scavi archeologici che si ricordino sul sito di Castrum Novum, “la Chiaruccia” è il nome di una tenuta agricola di proprietà della Reverenda Camera Apostolica: un appezzamento di forma quasi trian-golare di circa 700 ettari delimitato a sud-ovest dal mare, a nord dal iume Marangone, che la divideva dal territorio di
Civitavecchia, e ad est dal fosso di Punton del Castrato che segnava il conine col territorio di Santa Marinella, proprietà del Pio Istituto di Santo Spirito.
2 Vedi S. Nardi Combescure “La terra vista dal mare: Capoli-naro e Santa Marinella nei portolani di epoca medievale e moder-na” in questo stesso Quaderno, p. 903 Per tutti, Nissen 1883, vol. II, 1, p. 334 “Il terreno si è abbas-sato in questa zona perché le mura romane presso Torre Chiaruccia sono sott’acqua. Queste mura appartengono alla colonia romana di Castrum Novum che formava, circa 4-5 miglia da Centumcellae, il lato nord del promontorio”.
Fig. 1. “Pianta della Tenuta Camerale della Chiaruccia nel territorio della Tolfa” redatta dal perito agrimensore pubblico Benedetto Pergi il 3 aprile 1776
51
La Camera Apostolica dava in appalto novennale la coltiva-zione a grano nelle zone pianeggianti, che occupano circa un terzo dell’area, mentre gestiva direttamente lo sfruttamento della macchia che ricopriva il resto: legna da ardere e carbone, che vendeva “alla vela” a Santa Severa e in altre località della costa. Si tratta di attività non stanziali o che richiedevano ri-coveri solo provvisori. In tutta quest’area, gli unici fabbricati riportati dalla pianta eseguita nello stesso anno (Fig. 1) sono la Torre della Chiaruccia sulla costa, con un piccolo ediicio annesso, un fontanile in località Macchia del fontanile, il pon-te dell’Aurelia sul Marangone e una struttura a punta in Mac-chia San Silvestro, che potrebbe essere una grande capanna di frasche per i carbonai o il simbolo cartograico di un’area a ienili.Non abbiamo informazioni sulle ragioni che spinsero la curia pontiicia ad intraprendere proprio in questa tenuta uno sca-vo “per rinvenire antichità, da collocarsi nel Museo Vaticano”,4 come faceva in quegli anni in località di maggior prestigio come il Foro romano, Ostia, Tivoli, Palestrina ecc. Possiamo supporre che siano state valutate positivamente proprio l’as-senza sul sito di strutture medievali e moderne, che avrebbe-ro complicato l’attività di scavo, insieme con il possesso del terreno, la sua collocazione a cavallo di un’importante via di comunicazione come l’Aurelia e la possibilità di ricorrere alla via d’acqua, da Civitavecchia a Ripa grande, nel cuore di Roma, per il trasporto di carichi pesanti. Deve aver inluito molto sulla decisione anche il dottor Gaetano Torraca, igura di spicco della vita culturale civitavecchiese, medico ma anche esperto di antichità, alla cui competenza la Camera Apostoli-ca si rimetterà sempre quando si tratti dei territori di Civita-vecchia e Tolfa. Oltre che dalle cronache apparse nelle riviste letterarie pubblicate all’epoca a Roma, “Antologia”, “Diario” e “Il Cracas”5, le vicende degli scavi pontiici possono essere ricostruite con lo spoglio parallelo di documenti originali del-la Reverenda Camera Apostolica, oggi conservati in diverse sezioni dell’archivio di Stato di Roma: “Antichità e belle arti”, che contiene le “giustiicazioni” del Museo Pio Clementino (rendiconti di spesa con ricevute e relativi mandati di paga-mento a carico dell’Impresa del lotto, che inanziava scavi, restauri e la costruzione stessa del Museo); “Epistolario”, in realtà il protocollo in uscita della corrispondenza di carattere amministrativo della camera Apostolica; “Comuni”, dove sot-to la voce “Tolfa” si trovano tutti i documenti che attestano rendita e passaggi di proprietà della tenuta “la Chiaruccia”.Dall’esame di questi documenti,6 nell’ultimo quarto del
4 Archivio di Stato di Roma, archivio Camerale, titolo II, episto-lario, busta 184, 24 agosto 1776.5 Ampi stralci dei loro articoli sono pubblicati in Pietrange-li 1943, voce Castrum Novum, mentre gli articoli di Antologia sono riprodotti integralmente in Gatc 2013.6 I manoscritti camerali dell’Archivio di Stato, quelli conserva-ti nella Biblioteca vaticana e altri conservati nel fondo Lanciani all’Istituto di archeologia e storia dell’arte sono stati esaminati più volte da Carlo Pietrangeli, direttore generale dei Monumenti,
Fig. 2 a, b, c. “Nota e prezzi de’ Monumenti antichi di marmo, e me-tallo ritrovati negli scavi della Chiaruccia già colonia de’Castrono-vani dal principio di Decembre 1776 a tutto il mese d’Aprile 1777” La nota è irmata da Gianbattista Visconti e Gaspare Sibilla ma, secondo Carlo Pietrangeli, è di mano di Ennio Quirino Visconti
a
b
c
52
XVIII secolo risultano condotte almeno quattro campagne di scavo: dal 26 novembre 1776 al 7 giugno 1777 la prima, con direttore Giovanni Corradi; la seconda dal 9 dicembre 1777 al 31 maggio 1778 con direttore Sandrini; dal 10 gennaio al 1° aprile 1779 la terza campagna, direttore Venceslao Pezzolli, mentre la quarta, che ebbe luogo dopo che la tenuta camerale era stata concessa in eniteusi perpetua a Giuseppe Alibran-di e suoi discendenti, fu condotta nella primavera del 1796 dall’Alibrandi stesso.L’intenzione di intraprendere lo scavo fu notiicata dal pro-tesoriere generale della Reverenda Camera Apostolica, car-dinal Guglielmo Pallotta, a Clemente Pucitta, referente della Camera in Civitavecchia per tutto ciò che riguardava il patri-monio e le attività economiche, con una lettera del 24 agosto del 1776. Seguirà il sopralluogo di Gianbattista Visconti, al-lora Commissario delle Antichità presso il Museo Pontiicio, e dello scultore Gaspare Sibilla, restauratore di opere antiche fra i più attivi nei Musei Vaticani. Subito dopo, il 26 novem-bre 1776 venne aperto il cantiere con l’impiego di manova-lanza locale diretta da Giovanni Corradi, che aveva una lunga esperienza di ricerca di opere d’arte antiche, coadiuvato da due capisquadra che aveva portato con se da Roma.La prima campagna di scavo, la più fortunata, portò al recupe-ro di numerose statue di buona fattura e in ottime condizioni, la maggior parte delle quali sono esposte nel Museo Pio Cle-mentino in Vaticano.7 Alla lista dei pezzi ritrovati a Castrum Novum che lo stesso Gianbattista Visconti redasse poco prima della conclusione di questa campagna (Fig. 2) vanno aggiun-ti una quantità di frammenti di marmo, parti anatomiche da igure umane, blocchi o elementi architettonici smontati che fornirono materiale ai restauratori delle statue e per l’arreda-mento del Museo Pio Clementino, allora in via di completa-mento.8 Una quantità imprecisata di frammenti di marmo e di condotti di piombo furono venduti a peso in Civitavecchia9
Musei e Gallerie pontiicie dal 1978 al 1996 e in precedenza re-sponsabile della Sovrintendenza ai Musei, Gallerie, Monumenti e Scavi del Comune di Roma, principalmente allo scopo di stabilire la provenienza dei pezzi di scultura esposti nelle sale dei Musei va-ticani. Nel 1972 Isabella Cipriani li ha riesaminati, nel tentativo di stabilire dove precisamente si fossero svolti gli scavi settecente-schi. Cipriani conosceva il lavoro che Alfredo Gianfrotta andava completando su Castrum Novum per il progetto Forma Italiae e nella sua ricerca ha fornito molti elementi utili, ma purtroppo non deinitivi, per la risoluzione del problema. 7 Si veda “Le statue di Castrum Novum” in questo stesso Qua-derno, p. 598 “Nota di diversi marmi esistenti nella Dogana di Ripagrande, trasportati dalle cave di Civitavecchia” redatta da Gaspare Sibilla, Archivio di Stato di Roma, archivio Camerale, titolo II, antichi-tà e belle arti, busta 17, tra il 9 maggio e il 6 giugno 1777, dove “Cave” sta per scavi.9 Il 19 marzo del 1777 il cardinal Pallotta scrive a Clemente Pucit-ta: “Dalla relazione del sig. cav. Torraca sento che nelli scavi si tra-scurino li pezzi de’marmi, ed altri [------] colorati che si rinvengono. Ciò non m’è piaciuto, mentre si cavano denari ancor da’ rantumi, e nei giorni passati ho fatto di quegli ritrovati nello scavo di Otricoli una bella vendita alli scarpellini a ragione di sette scudi per carret-tata. Bramo pertanto che tutto ciò si trovarà in questo genere si rechi con una barchetta in Civitavecchia ed allorché, più comodamente, nel principio di giugno sarà egli al agio di disporne. Sono intanto...”..
mentre la ceramica fu gettata via10 e inì probabilmente nello strato di riempimento delle aree scavate.11 Si lavorava sei giorni su sette e non ci furono interruzioni per tutto il periodo, se non le feste comandate. Dal calcolo delle giornate retribuite come risultano dai rendiconti mensili, il numero di operai impiegati variava tra un minimo di 12 e un massimo del doppio, a seconda dei periodi. La seconda campagna ebbe inizio nello stesso anno, dopo l’in-terruzione estiva. Giovanni Corradi era impegnato a Roma, negli scavi nell’Orto di Sant’Antonio abate presso Santa Ma-ria Maggiore e fu lo stesso Pucitta ad intraprendere l’opera, con l’assistenza di un giovane direttore, tal Sandrini, inviato da Roma assieme a tre capisquadra. Durante questa campa-gna furono recuperate un numero minore di statue che nel-la prima,12 anche se fra esse igura uno dei pochi simulacri di Priapo a grandezza naturale che si conservino,13 ma la scoper-ta più sensazionale fu un gruzzolo di 122 monete d’oro di età imperiale, dissotterrate, con i resti del cofanetto ligneo che le conteneva, “in sito ristrettissimo, alla profondità di poco men d’un palmo”.14 Il cardinale dispose particolari precauzioni per il trasporto a Roma del tesoretto e fece elargire una gratiica a ciascuno degli operai, accompagnata dalla comminazione di pene severe per chiunque tentasse di impadronirsi di qualche reperto di valore. Queste monete costituirono subito il pezzo forte del medagliere vaticano ed i doppioni furono scambiati da Visconti con pezzi che mancavano alle serie della mone-tazione romana antica. Esistono diverse descrizioni di queste monete,15 particolarmente preziose perché l’intero gruppo
Archivio di Stato di Roma, archivio Camerale, titolo II, epistola-rio, busta 185.10 “Nel resto, il ritrarsi nel terreno di Castronuovo delle monete di rame, e de’rantumi di marmo, ed iscrizioni tronche, e di pezzi di marmo lavorati a cornici, e capitelli, non è meraviglia, giacché ne’due scavi precedenti moltissimi vi furono abbandonati come inu-tili, sicome eziandio copiosi rammenti di vasi, ed altre opere di terra cotta”. Così si esprime nel 1795 Clemente Pucitta a sostegno della sua opinione negativa sull’opportunità di intraprendere una nuo-va campagna di scavo, sottopostagli dal nuovo Cardinale tesorie-re. Archivio di Stato di Roma, archivio Camerale, titolo II, anti-chità e belle arti, busta 11, fascicolo 270, Tolfa, 15 aprile 1795.11 A conclusione della seconda campagna di scavo, Pucitta ingag-giò un capomastro locale per cancellare le tracce dei lavori. Lo attesta una ricevuta di 71 scudi e 62 bajocchi irmata il 2 giugno 1778 da Benedetto Capalti “per aver fatto spianare, e riempire li scavi della Chiaruccia di due anni e ridurre al pristino”. Archivio di Stato di Roma, archivio Camerale, titolo II, antichità e belle arti, busta 18, 2 giugno 1778. 12 Dei reperti del 1778 esiste una seconda lista di Visconti, conserva-ta nella Biblioteca vaticana e pubblicata in Cipriani, 1972, pag. 31513 Il giudizio è di Ennio Quirino Visconti, “Il Museo Pio Cle-mentino”, vol. 1, tavola L14 Torraca in “Antologia”, n. 44, maggio 177815 Tutte pubblicate da Cipriani 1972, pag. 314 segg. L’impor-tanza attribuita all’epoca a questo ritrovamento si può giudicare dal fatto che E. Q. Visconti abbia voluto dedicare due tavole della sua guida al Museo Pio Clementino di scultura ad alcune di queste monete, perché in esse si potevano riscontrare modelli iconograici utili per l’identiicazione dei ritratti marmorei (Visconti 1782, vol. 1, appendici 8 e 9. L’appendice 9 è riprodotta qui in Fig. 3)
53
andò disperso durante l’occupazione francese di Roma nel 1798 (Fig. 3). Fra le voci di spesa riportate in tutti i rendiconti mensili di questa seconda campagna, che si concluse il 31 maggio 1778, appare costantemente una somma non trascurabile per “olio consumato ne lumi nelle cave oscure”16. Una voce simile non è riscontrabile nei rendiconti delle altre campagne e potrebbe essere attribuita o ad una modiica della tecnica di scavo, in galleria anziché a cielo aperto, dovuta al nuovo direttore o al tentativo di penetrare negli ambienti sotterranei di ediici di cui però non si fa cenno in nessun documento. In almeno un’occasione, lo scavo deve aver raggiunto il pomerio della città antica, dal momento che furono portate alla luce diverse sepolture allineate lungo una strada.17 Nel mese di gennaio,
16 Si veda per tutti il rendiconto di gennaio 1778, Archivio di Stato di Roma, archivio Camerale, titolo II, antichità e belle arti, busta 18, 4 febbraio 177817 “Oltre l’iscrizione... si sono scoperti moltissimi pavimenti di sot-tili lastre di marmo e di opera a mosaico, ma non espressiva, alcuni rantumi di iscrizioni e qualche pezzo di scoltura guasto ed inutile. Li pezzi che io serbo de’metalli come di monete, di chiodi, d’ami, achi da rete per la pesca, se ne sono raccolti moltissimi, ma assai più se ne raccorrebbero, se li tempi presentemente piovosi non cagionas-sero l’impasto della terra, nella quale ne debbono rimanere in mol-tissima quantità. Si è discoperta una strada, oltre, e lungo la qua-le, trovasi gran numero di sepolcri co’ cadaveri distrutti, e qualche moneta. Que’sarcofagi, non sono intieri, ma formati con lastroni, e co’travertini. Questo luogo dovrà stimarsi fuori dell’abbitato”. Così Clemente Pucitta al cardinale tesoriere il 24 gennaio 1778. Ar-
prima della scoperta delle monete d’oro, il numero di operai presenti sullo scavo raggiunse la cifra record di 30: al momen-to di saldare il conto, il cardinale tesoriere raccomandò a Pu-citta di ridurre la manodopera almeno della metà. Nel gennaio del 1779 il cardinale tesoriere, quasi senza preav-viso, spedì a Civitavecchia Venceslao Pezzolli, altra igura di capocantiere con esperienza di recupero di opere d’arte, col compito di veriicare la correttezza degli scavi efettuati ino ad allora e di proseguirli in sostituzione di Sandrini, che era deceduto. Pezzolli, che aveva portato con sé ben 4 capisqua-dra, si rese ben presto conto che con gli scavi precedenti si era dato fondo a quanto di buono si poteva ricavare per il Museo18 e si mise in giro con la sua squadra a praticare saggi dovunque vi fosse una segnalazione o riscontrasse segno di presenza di antichità. In un’occasione sarebbe stato imprigionato per aver scavato senza permesso in un terreno di proprietà del Santo Spirito a Tarquinia, se il cardinal Pallotta non fosse intervenu-to presso il Commendatore del Pio Istituto a Roma.In efetti, dal lato del recupero di opere d’arte, questa terza campagna fu un fallimento: tutto quello che se ne ricavò fu-rono circa 230 kilogrammi di condotti di piombo, venduti secondo le istruzioni. Giudicando oramai inutile insistere nell’impresa, se non anche pericoloso, il cardinal Pallotta deve aver chiuso la campagna anzitempo: l’ultimo giorno di scavo rendicontato è il 1° aprile 1779. In seguito, l’appaltatore della tenuta “La Chiaruccia” subaf-ittò il fondo ad un pastore, che lo tenne a pascolo per tut-ta la durata del contratto, 9 anni. Cessata la rendita agricola, esaurita la “vena” archeologica, la Reverenda Camera decise di cedere la tenuta in eniteusi perpetua. Il bando è del 9 marzo 1790, ma il rapporto giuridico avrebbe avuto eicacia solo alla scadenza del novennio di appalto, il 1° ottobre del 1794. Si aggiudicò il contratto Giuseppe Alibrandi, soprattutto per il suo impegno ad apportare migliorie al fondo.19
Per coincidenza, proprio in quel periodo il Papa ricevette la supplica di un tal Francesco Spadoni perché gli venisse aida-ta la direzione di una quarta campagna di scavi, dal momento che, a parer suo, le precedenti erano state condotte male.20
chivio di Stato di Roma, archivio Camerale, titolo II, epistolario, busta 187. 18 “Circa il cavo fatto l’anno scorzo son arrivati al vergine perché era tutto terreno senza verun segno di ruina di fabrica antica”. Così si esprime Pezzolli scrivendo al cardinal Pallotta il 17 gennaio 1779. Archivio di Stato di Roma, archivio Camerale, titolo II, epistola-rio, busta 189.19 In efetti, nella zona, l’unico altro ediicio precedente la lot-tizzazione del secondo dopoguerra, oltre la torre militare, è un casale denominato “Alibrandi”, risalente al XIX secolo, che sorge proprio sul sito del castrum antico.20 “Dopo la sua guarigione [lo scrivente, Domenico Spadoni, parla in terza persona] portatosi per curiosità a vedere l’abbandonata in-trapresa, a suo credere parveli mal condotta per le ragioni seguenti. Secondo il parere di Livio, Castronuovo, Pirgo, e gl’altri luoghi ivi contigui, erano situati sulla marina. Infatti le antiche vestigia sono tuttora sulla strada prossima alla marina; lo scavo all’opposto fù diretto all’altura. In secondo luogo lo scavo suddetto non si sprofon-dava a trovare l’antica strada, ma era eseguito supericialmente, e diramato. Giacché si trovano le stanze alla strada si dovrìa, a parer debole dell’oratore, seguire le traccie di tali stanze, e del condotto di piombo, che deve portare ad un qualche ediicio, ma ciò merita una
Fig. 3. Tavola dall’appendice al volume 1 della guida al Museo Pio Clementino, di Ennio Quirino Visconti, con la riproduzione al n. 16 di un aureo di Traiano con personiicazione della Germania paciicata, al n. 17 di un aureo di Adriano con ritratto della ma-dre adottiva Plotina e, al n. 18, aureo di Adriano con ritratto della suocera Matidia. Le monete facevano parte del tesoretto rinvenuto a Castrum Novum nel 1778 e poi trafugato dai Musei vaticani nel 1798.
54
Il cardinale Pallotta era caduto in disgrazia e così il nuovo tesoriere si rivolse direttamente a Clemente Pucitta, che era sempre il riscontro uiciale della reverenda Camera a Civita-vecchia, per avere il suo parere in merito. Pucitta rispose con un riepilogo molto lucido degli scavi precedenti e con l’opi-nione altrettanto netta - condivisa con il dr. Torraca - che non vi fosse altro da ritrovare nel sito.21 Molto probabilmente, a se-guito di questo giudizio la richiesta di Spadoni fu fatta cadere nel vuoto. La Reverenda Camera da allora cessò di organizza-re scavi alla Chiaruccia e ripiegò su forme diverse di sfrutta-mento del luogo, lasciando che si assumessero il rischio eco-nomico dello scavo soggetti privati, cui concedeva la licenza riservandosi un terzo del ricavato. E’ quanto accadrà all’inizio del 1796, quando sarà proprio il nuovo eniteuta della tenuta, Giuseppe Alibrandi, ad ottenere la licenza. Conformemente agli impegni, il 21 aprile 1796 Alibrandi denunciò solo il ri-trovamento di una igura femminile panneggiata, corrosa, e mancante di testa, braccia e gambe. Nel corso del XIX secolo questo schema si ripeterà più vol-te: c’è notizia di scavi efettuati su licenza camerale da Pietro e Lorenzo Alibrandi22 tra il 1829 e il 1840 e nelle “Notizie degli scavi di antichità” del 1879 si trovano alcuni rapporti dell’Ispettore della Soprintendenza alle belle arti di Civita-vecchia, D. Annovazzi, sull’andamento degli scavi efettuati su licenza dall’allora proprietario della tenuta “la Chiaruccia”, tale “Aliprandi Valentini”. E’ verosimile che si tratti di un altro membro della famiglia Alibrandi, a cui il titolo di proprietà deve essere giunto con la trasformazione del contratto di eni-teusi per usucapione o per la sistemazione dei rapporti giuri-dici con l’ex Stato della Chiesa efettuata dallo Stato unitario italiano.Dai rapporti di Annovazzi si deduce che l’interesse maggio-re del nuovo scavatore era per le necropoli presenti nell’area della tenuta: stando alle indicazioni topograiche alquan-to generiche, si direbbero quella sul poggio della Castellina e quella già scavate da Abecken per conto della duchessa di Sermoneta nel 1840 sul Punton del Castrato. Per quanto ri-guarda il sito del castrum, molto importante il rapporto della scoperta di un lungo tratto di un portico lungo l’Aurelia in una zona densa di ediici, probabilmente lì dove la consolare attraversava la città costituendone il decumano.23 Purtroppo
indefessa assistenza per non lasciare la buona traccia, e profondare ino a rinvenire il piano dell’antica città, essendo troppo verisimile, che le rovine, le terre, che dal disopra calano alla marina, e le mace-rie addossate per li tanti risarcimenti delle strade, abbino ricolmate, e nascoste le antiche fabriche”. Archivio di Stato di Roma, archivio Camerale, titolo II, antichità e belle arti, busta 11, fascicolo 270, Tolfa, 15 aprile 1795 21 Archivio di Stato di Roma, archivio Camerale, titolo II, anti-chità e belle arti, busta 11, fascicolo 270, Tolfa, 15 aprile 179522 Archivio di Stato di Roma, Camerlengato, parte II, titolo IV, busta 201, come riportato da Sara Nardi Combescure in Castrum Novum. Storia ed archeologia di una colonia romana nel territorio di santa Marinella, quaderno n. 1, Santa Marinella, 2011, pag. 723 “Si è discoperto presso alla strada Aurelia il lato sud est, lungo circa met. 100, di un piantato a basi di colonne che alcuni credono spettare alla Basilica e Foro di Castronovo, ma che per la sua posi-zione speciale, e per vederlo attorniato da fondamenta di caseggiati, spartiti in camere per uso di abitazioni, sembra sia uno di quei por-
i dati utili per la localizzazione del portico si riferiscono ad altri ruderi allora scoperti e oggi non più visibili: due vasche in muratura ritrovate nei pressi del portico, l’una poco lungi a sud, presso alla spiaggia del mare, che “aveva il pavimento di rozzo musaico a quadretti bianchi”, l’altra a pochi metri a sud-ovest.24 Con l’identiicazione anche di uno solo di questi elementi, ammesso che ne resti qualcosa, non sarebbe diicile individuare il luogo dove sorgevano gli altri e in particolare veriicare se la posizione del portico sia compatibile con alcu-ne lunghe tracce evidenziate dalle prospezioni geomagnetiche efettuate nel 2012.25 Poche altre sono le indicazioni utili che si possono ricavare da questo rapporto:“e nei molti tasti fatti al terreno in varie direzioni, non si sono trovati che muri fonda-mentali di costruzioni, alla profondità di non più di un metro, come è avvenuto in tutte queste escavazioni su di una supericie generalmente piana, ed in parte un poco elevata a levante della tenuta, dove si sono dissotterrati dei tratti di muro in pietra viva della spessezza d’un buon metro, che pare sieno le fondamen-ta delle muraglie di circonvallazione del paese da quel lato”.26 Il rapporto si conclude con la descrizione del materiale itti-le, la trascrizione di quattro diversi bolli laterizi impressi su mattoni di centimetri 48 x 58 e dell’unica lapide ritrovata in quell’occasione, quella funeraria del milite Labero Proculo27 ora nella galleria lapidaria dei Musei Vaticani. Quasi un secolo dopo, per la serie “Italia romana, municipi e colonie” dell’Istituto di studi romani, Salvatore Bastianelli non scrisse sulla scorta di nuovi scavi, ma si dedicò alla siste-mazione delle fonti precedenti, tutte quelle qui citate cui si aggiungono gli appunti - più che gli studi - di Raniero Men-garelli del 1942. Fu sulla base delle informazioni ricavabili da tutte queste fonti, da lui vagliate attentamente, dalla ricogni-zione dei resti ancora visibili sul terreno e da qualche isolato saggio di scavo, da lui eseguito in località “la Castellina”, che Bastianelli tentò di localizzare il centro urbano di Castrum Novum e la sua necropoli. Per quanto riguarda il castrum vero e proprio, Bastianelli lo colloca di fronte alle strutture visibili sott’acqua, nella convinzione che si tratti di “una larga zona della città, completamente sommersa per una profondità di circa 50 cm”28. Nel proseguimento della sua monograia, Bastianel-li aferma di aver determinato con esattezza l’ubicazione del teatro (la cui esistenza è attestata da un’ iscrizione di Lucio Ateio Capitone29) “sopra una breve altura poco lontano da Ca-sale Alibrandi”.30
tici che vi costruì a sue spese L. Ateio Capitone, come si rileva dalla lapide dissotterrata nel 1777”. Notizie, 1879, pag. 13624 Notizie, 1879, pag. 13725 Vedi F. Enei, G. Poccardi “Le indagini magnetometriche sull’area della città antica” in questo stesso Quaderno, p. 4626 Notizie, 1879, pag. 13727 CIL XI 358228 Così, Bastianelli situa l’abitato di Castrum Novum “sulla riva del mare ... per una lunghezza di circa 400 metri, ed una larghezza che doveva superare di poco i 300 metri, occupando il pianoro così detto “La Bufolareccia”; e spingendosi a sud ino al Casale Alibran-di. Da quel lato, le mura urbane, di cui rimangono alcune tracce, passavano nelle immediate vicinanze del casale stesso”. Bastia-nelli, 1954, p. 10329 CIL XI 358330 Bastianelli 1954, p. 106
55
Secondo l’autore, i ruderi ancora visibili nel 1954 apparte-nevano alla cavea ricavata nel ianco della collina. Per quanto riguarda la necropoli, Bastianelli si limita a confutare l’opi-nione di Annovazzi, sostenendo che le sepolture da lui de-scritte siano assimilabili senz’altro, per tipologia di costru-zione e dei materiali ritrovati, a quelle esistenti nei dintorni della Castellina, che sono indubbiamente etrusche. La vera necropoli di Castrum Novum, che doveva essere posta nelle immediate vicinanze dell’abitato e probabilmente lungo la via Aurelia, secondo Bastianelli è ancora da esplorare. Proprio negli anni in cui Bastianelli scriveva, Benvenuto Frau si dedicava allo studio delle strutture sommerse, facil-mente indagabili anche senza autorespiratore. Sebbene la sua ipotesi che esse si basassero sui resti di un porto etrusco non abbia retto ad uno studio più approfondito sul livello del mare in quel punto in epoca arcaica,31 a lui va il meri-to di avere riconosciuto per primo la natura marittima di tali strutture in quanto pertinenti ad un grande stabilimen-to per l’allevamento del pesce. La sua monograia, ricca di tavole pregevoli, fu pubblicata nel 1979, dopo il lavoro di Gianfrotta, ma si basano su dati rilevati in immersioni ese-guite nel 1956. Sia che conoscesse il lavoro di Frau, o che si basasse su altre informazioni, Piero Alfredo Gianfrotta dette per assodata la natura marittima delle opere sommerse.32 Una volta rot-to l’obbligo di collocare la parte sepolta della città di fronte a quella sommersa, il problema della localizzazione di Ca-strum Novum poteva essere afrontato sulla base di una serie di elementi che nel 1972, anno della fondamentale mono-graia di Gianfrotta, cominciavano ad essere abbondanti. Gianfrotta si esprime così: “Castrum Novum si estendeva sulla riva del mare dove ancora sono visibili resti di costru-zioni, per circa 400 metri e si sviluppava all’interno per circa 300 metri nella zona chiamata “Bufolareccia” con il limite meridionale posto poco più a sud del casale Alibrandi, pres-so cui furono appunto individuati resti delle mura urbane”.33 E, più avanti: “Altre strutture, tra cui muri in opera incerta e pavimenti in opus spicatum, sono state individuate recen-temente durante i lavori per la costruzione di una fognatura che corre parallela all’Aurelia, appena all’interno del terreno Alibrandi. Questi lavori hanno interessato anche la punta del Capo Linaro e la zona immediatamente vicina alla Torre del-la Chiaruccia dove non si è trovato alcun resto antico e ciò con-ferma l’ubicazione di Castrum Novum nel terreno circostante il casale Alibrandi”.34 Dal 2010, i resti di costruzioni visibili sulla riva del mare sono oggetto di nuovi accurati rilievi (Cfr. p. 39). In base a questi, lo schizzo planimetrico pubblicato da Gianfrotta35 è stato rielaborato mettendo in evidenza l’allineamento
31 vedi S. Giorgi in Castrum Novum. Storia ed archeologia di una colonia romana nel territorio di Santa Marinella, quaderno n. 1, Santa Marinella, 201132 “Non c’è alcun dubbio sulla natura marittima di queste costru-zioni che non devono essere considerate, come a volte è stato fatto, cr Bastianelli, pp. 103 sg., ediici di terraferma sommersi per bradisi-smo”. Gianfrotta, 1972, p. 98, nota 2:33 Gianfrotta, 1972, p. 8734 Gianfrotta, 1972, p. 9335 Gianfrotta 1972, pag. 88, ig. 182
delle strutture murarie superstiti che è riconducibile ad un tessuto urbano regolare.36 Come le colonie di Cosa e Pyrgi, dedotte negli stessi anni nello stesso territorio, infatti, è pro-babile che anche la colonia di Castrum Novum abbia avuto impianto urbano di tipo regolare a reticolato.Per quanto riguarda l’interno, sono le risultanze delle pro-spezioni magnetometriche efettuate sul terreno circostante il Casale Alibrandi nel 201237 che confermano le aferma-zioni di Gianfrotta basate sui lavori di urbanizzazione del 1970. Allora, l’area di Castrum Novum cominciava ad esse-re interessata dall’espansione edilizia di Santa Marinella, a supporto del rango turistico che la “Perla del Tirreno” aveva raggiunto in quegli anni. Tra via Volterra e via Tuscania, all’altezza del Km 64,700 dell’Aurelia che in quel punto corre sulla linea di costa, durante i lavori di preparazione del plateatico per la costruzione di una schiera di villini dispo-sti a semicerchio intorno ad una piscina, aiorarono resti di strutture murarie e pavimenti a mosaico su suspensurae. Intervenuta la Soprintendenza, nella persona dell’ispettore Giovanni Colonna, i lavori furono sospesi e, a seguito delle risultanze di una rapida campagna di scavo d’emergenza, il progetto insediativo fu modiicato per risparmiare l’area in cui oggi sono visibili i resti del piccolo complesso termale e dell’ediicio a pianta quadrata e di un tratto di una via larga e regolare tra di essi (Cfr. pp. 2, 14). Gianfrotta, che coadiu-vò Colonna nell’indagine, praticò un saggio in profondità a ianco della strada e concluse che doveva trattarsi dell’Au-relia vetus, sopravvissuta come percorso alternativo a quello della “direttissima” che collegava Centumcellae a Roma pas-sando più a monte. Nonostante l’intervento della Soprintendenza, il lato nord est dell’ediicio a pianta quadrata scomparve sotto la recin-zione del complesso edilizio mentre la necessità di garantire un passaggio pedonale verso l’Aurelia ha portato al seppelli-mento del lato nord ovest, la parte con pavimento musivo a suspensurae meglio indagata negli scavi del 1970. Il resto è storia di oggi: il Museo Civico di Santa Marinella e i volontari del Gruppo Archeologico del Territorio Cerite, con un progetto pluriennale che coinvolge alcune Univer-sità d’oltralpe, hanno garantito in questi ultimi anni la ma-nutenzione del sito archeologico e l’apparato didattico per consentirne la fruizione da parte del pubblico, documen-tando scrupolosamente i resti e conservando e restaurando i reperti. Ora, con il ruolo di concessionario della Soprin-tendenza all’Etruria Meridionale, il Museo Civico di Santa Marinella ed i suoi partner potranno cominciare a risponde-re alla numerose domande su Castrum Novum che sorgono scorrendo la folta documentazione qui passata in rassegna.
Guido Girolami
36 F. Enei “I resti siti sulla spiaggia tra Torre Chiaruccia e la foce del fosso delle Guardiole“, in: Castrum Novum. Storia ed arche-ologia di una colonia romana nel territorio di Santa Marinella, quaderno n. 1, Santa Marinella 2011, p. 14, ig. 28. 37 Pubblicate in questo stesso Quaderno n. 2 a pag. 46
56
2.4 Les inscriptions de Castrum Novum
Les inscriptions de Castrum Novum sont au nombre d’une soixantaine et fournissent une multitude de renseigne-ments tant sur la vie quotidienne que sur les institutions de la colonie de Castrum Novum1. Les inscriptions livrent bien sûr les noms des habitants de l’antique Castrum No-vum, et, avec leurs noms, des informations d’ordre juridi-que et économique sur le statut de ces habitants. Il est donc possible d’identiier grâce l’épigraphie non seulement des individus, mais aussi la hiérarchie sociale des habitants ou des résidents de Castrum Novum. Au bas de l’échelle sociale, on trouve les esclaves et les af-franchis. Les esclaves de Castrum Novum ne sont pas bien connus, faute d’attestations, ce qui ne signiie pas qu’ils n’étaient pas nombreux sur le territoire de la colonie. Une plaque moulurée du 2ème ou 3ème siècle après J.-C. nous fait connaître [T]ryphae[na], elle-même esclave et compagne d’un esclave (AE, 1973 229) :
[Dis Ma]nib(us) / [..T]ryphae / [nae ? con]tuber(nali) / [... bene] meren(ti) / [ fe]cit.
Le nom de Tryphaena est si courant à Rome dans les ins-criptions d’esclaves et d’afranchis qu’il est impossible de reconstituer des liens familiaux ou de servitude. Un afranchi du 1er siècle avant J.-C., appelé Sex(tus) Lar-tius Phileros, consacre un cippe funéraire en travertin dé-couvert à Campo dell’Oro à son épouse, aux siens et à lui, et fournit le prénom de son maître, Sextus (AE 1973 234) :
Sex(tus) Lartius / Sex(ti) l(ibertus) Phileros / sibi et Caeci-liae / Eutychini coniugi / amantissum(a)e / et suis fecit.
Tiberius Julius Heraclida, un afranchi impérial peut-être, qui tient peut-être son nom de Tibère, a consacré une sta-tuette de Silvain découverte dans ce qui a été identiié com-me la villa d’Ulpien (AE 1973 228) :
Ti(berius) Iulius Heraclida / signum Silvano / l(ibens) d(onum) posuit.
Deux afranchis2, Telephus et Priscus, dédient une statue à Juno Historia3.
Iunoni Historiae / Telephus et Priscus l(iberti) p(osuerunt), d(edicaverunt).
La «bourgeoisie» de la colonie est pour l’instant peu at-testée. Les «couches dirigeantes» de la colonie de Castrum Novum sont en efet mal connues, car peu d’inscriptions de la colonie se réfèrent directement au fonctionnement des institutions. A la in de la République, un seul dirigeant de la colonie est connu nommément: L. Ateius Capito attesté par deux inscriptions de Castrum Novum (CIL, XI 3583-3584) comme duovir quinquennalis4.
1 Sur ces inscriptions, cf. S. Bastianelli, Centumcellae (Civitavec-chia) Castrum novum (Torre Chiaruccia) Regio VII – Etruria, Rome, 1954, p. 121-123. 2 Nous suivons ici la lecture du CIL. 3 Sur l’interprétation de Juno historia, cf. M. Renard, Juno His-toria, Latomus, 12, 1953, p. 137-154.4 Cf. REE, 2, 1896, Ateius, n° 10, P. von Rohden.
Les informations fournies par ces deux inscriptions sont minces et cet Ateius duumvir quinquennalis est diicile à identiier, alors que les individus nommés Ateius Capito sont nombreux. Il a existé un consul sufect de 5 ap. J.-C., curator aquarum à partir de 13 après J.-C., C. Ateius Ca-pito5. Le consul est aussi connu par une copie en fragments des Fastes capitolins trouvée à Préneste en 1778 (CIL, XIV 1, 2963) et dans une inscription de Gaule Narbonnaise avec une datation consulaire (CIL, XII 2574) et peut-être dans une inscription funéraire de Rome (CIL, VI 2, 9537). Le consul C. Ateius Capito est peut-être aussi à identiier avec C. Ateius, juriste et conseiller d’Auguste, homo novus, dont le père, L. Ateius L. f. An. Capito, descendant d’un cen-turion syllanien, avait obtenu la préture en 51 av. J.-C. Ce juriste, élève d’Aulus Oilius, se révéla partisan d’Auguste et du Principat. En tant que jurisconsulte, il jouissait de son vivant de la même considération que Labeo et fonda l’école des Sabiniens. Il est l’auteur de livres sur le droit pontiical et de Coniectanea où il discute des problèmes posés par le droit public lié au Principat et par le droit privé résultant des lois d’Auguste6.Les Ateii Capitones étaient sans doute liés entre eux par des liens familiaux, mais il est impossible de les reconstituer en détail. On ne peut procéder que par exclusion. On hésite à faire d’Ateius Capito de Castrum Novum L. Ateius, le centurion de Sylla7. On ignore les liens de L. Ateius Capito de Castrum Novum avec L. Ateius Capito, oicier des triu-mvirs de 37-36 inconnu8, avec C. Ateius Capito, tribun de la plèbe en 55 av. J.-C. et légat de César en 44 pour l’assi-gnation de terres9, avec M. Ateius, préteur envoyé en Asie en 17 après J.-C. pour inspecter les cités détruites par un tremblement de terre10. On ignore aussi le lien d’Ateius Capito de Castrum Novum avec le céramiste Cn. Ateius, le céramiste arétin. Il paraît diicile à croire que la gens des Ateii Capito ait été originaire de Castrum Novum11. L. Ateius Capito, oicier
5 Cf. Tac., ann., 3, 75. Sur lui, cf. A. Degrassi, I fasti consolari dell’impero romano dal 30 a.C. al 613 d.C., Rome, 1952, 6 ; REE, 2, 2, 1904, n° 8, A. Jors ; PIR, A, 1279 ; W. Kunkel, Herkunt und soziale Stellung der römischen Juristen, Graz-Vienne-Cologne, 1967, p. 114-115, n° 2. 6 Cf. REE, 2, 1896, Ateius, n° 8, Jörs. 7 Cf. Tac., ann., 3, 75. Voir REE, 2, 1896, col. 1903-1904, Ateius, n° 4, Klebs. C’est pourtant la position de L. Sensi, Praescriptio del s.c. lari-nate, in EOS, I, p. 516, n° I et de M. Torelli, Ascesa al senato e rapporti con i territori d’origine, Italia : regio VII (Etruria), in EOS, II, p. 295. 8 Cf. REE, II, 2, 1896, col. 1903-1904, E. Klebs, Ateius n° 9 ; MRR, III, p. 26. 9 Cf. REE, II, 2, 1896, col. 1903-1904, E. Klebs, Ateius n° 7, ; MRR, II, p. 216 ; 332 ; T.P. Wiseman, New Men in the Roman Senate 139 B.C.-A.D. 14, Oxford, 1971, p. 215, n° 52; MRR, III, p. 26. 10 Cf. Tac., Ann., 2, 47. Voir REE, 2, 1896, col. 1903-1904, Ateius, n° 6, P. von Rohden ; PIR A 1278. 11 Mais c’est la position soutenue par Wiseman, New Men in the Senate, p. 215-216; L. Sensi, Praescriptio del s.c. larinate,
in EOS, I, p. 516, n° I; M. Torelli, Ascesa al senato e rapporti
con i territori d’origine, Italia : regio VII (Etruria), in EOS, II,
57
des triumvirs, et C. Ateius Capito, tribun de la plèbe, sont rattachés à la tribu Aniensis, alors que la tribu du territoire de Cerveteri est la Voltinia. Pour E. Papi12, la famille des Ateii Capitones s’implanta sur la côte étrusque et acquit des biens fonciers à l’époque des proscriptions syllaniennes ou bien alors quand le territoire de la colonie fut objet d’as-signations de terres aux vétérans de César. Pour P. Sangri-so13, la famille était peut-être originaire de la Valdichiana. Les Ateii Capitones de Castrum Novum constituent pro-bablement une branche collatérale des Ateii Capitones qui ont fait carrière à Rome. Pour avoir rempli les fonctions de duumvir quinquenna-lis, L. Ateius Capito possédait nécessairement une fortune foncière dont nous ignorons l’étendue. Il signale dans l’ins-cription CIL, XI 3583 qu’il s’est servi de son propre argent pour inancer une curie, des archives (tabularium) et des parties du théâtre, une estrade (scaenarium) et des places d’honneur (subseliarium), ainsi que salles de banquet, ainsi qu’un portique et des salles à manger (Fig. 1) :
L(ucius) Ateius M(arci) f(ilius) Capito / duomvir quinq(uennalis), / curiam, tabularium, / scaenarium, subse-liarium loco / privato de sua pecunia c(olonis) C(astri) N(ovi) f(aciunda) coeravit, / porticus, cenacula ex decurionum decre-to de / sua pecunia c(olonis) C(astri) N(ovi) faciunda coeravit ide<m>q(ue) probavit.
En faisant proiter ses concitoyens de sa fortune, L. Ateius Capito se montrait idèle à son rang. Nous ignorons les liens entre L. Ateius M. f. Capito et M. Liguius f. Ser. Rufus, qui dédie à celui-là une inscription (CIL, XI 3584) :
L(ucio) Ateio M(arci) f(ilio) Capitoni duom/vir(o) quinq(uennali) / M(arcus) Ligvius [- - -] f(ilius) Ser(gia) Rufus.
Peut-être M. Liguius f. Ser. Rufus s’étaient-ils côtoyés en siégeant comme duumvirs de Castrum Novum. A l’époque d’Auguste ou un peu avant, L. Statilius Pollio a restauré à ses frais un autel en marbre, découvert à la Chia-ruccia et conservé dans la Sala della Biga du musée du Vati-can, qui un membre de sa famille, probablement l’un de ses
p. 295; W. Kunkel, Herkunt und soziale Stellung der römischen Juristen, Graz-Vienne-Cologne, 1967, p. 115. Contra, cf. pour
A.M. Andermahr, Totus in praediis. Senatorischer Grundbesitz in Italien in der Frühen und hohen Kaiserzeit, Bonn, 1998, p.
170-171, n° 67. 12 Cf. E. Papi, L’Etruria dei Romani. Opere pubbliche e donazioni private in età imperiale, Rome, 2000, p. 37.13 Cf. P. Sangriso, Terra sigillata e politica augustea : alcune note su Cn. Ateius, SCO, 46, 3, 1998, p. 919-932.
ancêtres, L. Statilius Primus avait fait ériger à ses frais (CIL, XI 3572) : Apollini / sacrum / L(ucius) Statilius / Primus de sua p(ecunia) p(osuit) / hanc aram vetustate / labefactatam / L(ucius) Statilius / Pollio de sua pec(unia) et / renovavit et restituit.
La mention deux fois répétée que les frais ont été assurés à titre privé fait penser que l’autel se dressait dans un lieu pu-blic, sans doute dans un temple (Fig. 2). Il est probable que les Statilii faisaient partie d’une famille aisée de Castrum Novum, car un autre Statilius, ils de Marcus, fait ériger un autre monument à ses frais à la Chiaruccia également (CIL, XI 3574):
[- - - Stat]ilius M(arci) [ f(ilius) - - -] / [- - -]s s(ua) p(ecunia) [- - -] .
Il est possible que les Statilii de Castrum Novum fussent liés à des T. Statilius Taurus connus par ailleurs en abondance : T. Statilius Taurus, consul en 37 avant J.-C., T. Statilius Taurus, père de Messaline et beau-père de Néron. Avant eux, on relève l’existence de L. Statilius impliqué dans la conjuration de Catilina et condamné en 67 avant J.-C.14. Il est possible que les Statilii de Castrum Novum aient pos-sédé une vaste villa à Castrum Novum, peut-être celle dont les restes d’époque républicaine ont été englobés dans la villa dite d’Ulpien. On peut aussi compter parmi les mem-bres de la bourgeoisie de la colonie de Castrum Novum un quinquennalis et curator annonae anonyme du 2ème ou 3ème siècle après J.-C., auquel des décurions et des Augustales quinquennalici de Castrum Novum ofrent un monument (CIL, XI 7591) : [- - -quin]q(uennali) / [curatori] anno/[nae praesta ?]ntissimo / [decurio]nes, Au/[g(ustales), quin-que]nnalici / [- - -]to / [- - -]runt / [- - -]iem / [ // ] Val[- - - ] / NOF[- - -] / CAS [ Le territoire de Castrum Novum a--- ]
14 Cf. Cic., Catil., 2, 26.
Fig. 1
Fig. 2
58
abrité de nombreuses villas d’aristocrates résidant à Rome, intéressés par la beauté du site et par la proximité de Rome. L’un des plus célèbres de ces aristocrates est probablement Ulpien, le célèbre juriste (170-228 après J.-C.). Lors de fouilles ordonnées par la duchesse Sermoneta en 1838, le Castello Odescalchi a livré les restes d’une luxueuse villa ro-maine, comprenant de grandes pièces en opus reticulatum à l’Ouest des murs du château et disposées sur deux étages donnant sur la mer. Ces pièces comprenaient un hall avec un sol en opus sectile et des plaques de marbre blanc. On y trouva aussi une statue de Méléagre, puis en 1895, lors de nouvelles fouilles à l’Est du Castello, une piscine au centre d’une pièce rectangulaire en opus reticulatum contenant de nombreux fragments de statues en marbre, dont un autre Méléagre de Scopas, une Athéna Parthenos de Phidias, un Apollon, un groupe Dionysios et Pan. La villa contenait aussi des lampes, des amphores, de grands dolia, une meule. En 1839, furent découverts trois fragments de istules avec l’inscription CN DOMITIAN NIVLMIANI (lecture de Bormann). Le savant Bormann dans CIL, XI 3587 a pensé qu’il s’agissait du juriste Domitius Ulpianus, qui fut l’un des plus grands juristes de l’Antiquité, préfet de l’annone, puis préfet du prétoire en 222 et principal conseiller de l’empereur Alexandre Sévère et fut tué sous les yeux de cet empereur au cours d’une émeute. L’hypothèse de Bor-mann, reprise par Dessau15 semble vraisemblable, car nous ne connaissons pas d’autre Domitius Ulpianus connu qui puisse avoir bénéicié du standard de vie que trahit cette ri-che villa romaine. En outre, Méléagre, poète et philosophe cynique du 1er siècle avant J.-C., était originaire de Gadara et a vécu à Tyr, ville d’origine d’Ulpien dont celui-ci était très ier16. La villa ayant été occupée entre le 1er et le 3ème siècle après J.-C., Ulpien est sûrement l’un des derniers pro-priétaires de cette villa.
Les empereurs sont aussi très présents à Castrum Novum, soit qu’ils aient disposé d’une villa dans la colonie, soit qu’ils aient fait bénéicié les habitants de la colonie de leur générosité, ce qui leur vaut en retour des manifestations de reconnaissance de la part des habitants de la colonie. Il est fort probable que la villa occupée par Ulpien au 3ème siècle après J.-C. ait fait fonction de résidence impériale pour Caracalla ou l’un de ses successeurs immédiats, qui l’a donnée cédée en usufruit à Ulpien. On a supposé que les habitants de Castrum Novum aient proité de thermes que l’empereur Hadrien aurait oferts. En efet, lors des fouilles de 1776 à 1778, ont été mises au jour des pièces avec une mosaïque et du marbre, dont une vasque, revêtue elle aussi de marbre, au fond de laquelle se trouvait l’inscription : Hadriano / Aug(usto) / ex d(ecreto) d(ecurionum) (CIL, XI 3575) (Fig. 3). Mais on ne connaît ni la localisation ni le plan de ces pièces. On a donc pensé qu’il s’agissait de thermes qu’aurait fait construire Hadrien.
15 Cf. PIR, II, 1, 19, n° 113 et 25 ; A. Stein, REE, 5, 1346, Domi-tius n° 31 ; PIR, III², 39, n° 132 ; A. Passerini, Le coorti pretorie, Rome, 1939, p. 324 sq. 16 Cf. De censibus, I = D. 50, 15, 1 pr : splendidissima Tyriorum colonia, unde mihi origo est, nobilis regionibus, serie saeculorum antiquissima, armipotens, foederis quod cum Romanis percussit tenacissima.
Il est toutefois également envisageable qu’Hadrien ait disposé de son ius aquae ducendae et ait fait mettre en place une déri-vation d’un aqueduc proitant aux habitants de Castrum No-vum aux frais de l’Etat. D’après un édit de Vénafrum (CIL, X 4842, l. 37 sq), l’acte de donation d’un aqueduc comportait le droit de procéder à la distribution de l’eau pour des usa-ges publics et à sa vente à des particuliers. On trouve ainsi de nombreuses inscriptions à propos de dérivations de quelque aqua Augusta (CIL, II 1614 et 2343) ou Iulia (CIL, X 4833), données par des particuliers à la commune, sans que le nom de l’empereur n’apparaisse. Mais il peut s’agir aussi tout sim-plement d’une marque de reconnaissance à l’empereur sans rapport avec les thermes, ou alors d’un simple hasard. Pour G. Colonna17, la formule de l’inscription de Castrum No-vum est inhabituelle en dehors de Rome: aussi, à Castrum Novum, peut-être faut-il donc privilégier la thèse d’une déri-vation d’une propriété ou d’une villa personnelle de l’empe-reur et la mettre en rapport avec cette inscription de Pyrgi : Imp(erator) Hadrianus Aug(ustus) Pyrgensibus (NS, 1960, p. 363) et songer qu’il existait une villa d’Hadrien à Pyrgi. Au moins une conduite d’eau témoigne de la générosité d’Antonin (cf. CIL, XI 3586 b : ]Antonini Imp[ et l’inscrip-tion ex liber(alitate) Antonini (CIL, XI 3586 a). On dispose en plus d’au moins une istule avec le nom de la cité : col(onia) cast(ronouanorum) (CIL, XI 3586b). On ne sait si les tuyaux proviennent du même ensemble, mais il est possible qu’après le inancement par Antonin de conduites d’eau, la colonie ait entretenu le réseau et l’ait complété. Que l’empereur Antonin dispense l’eau à Santa Marinella gratuitement (ex liberalitate) - comme il l’a fait d’ailleurs à Préneste -, est un privilège accordé à Castrum Novum dont nous ignorons les motivations. Existait-il des relations privilégiées entre An-tonin et Castrum Novum ? La colonie de Castrum Novum
17 Cf. G. Colonna, Santa Severa (Roma). Fistula iscritta da Pyrgi, NS, 1960, p. 363-365.
Fig. 3
59
était-elle trop appauvrie pour faire ces dépenses elle-même ? Probablement y avait-il à Castrum Novum un aqueduc - Antonin a fait construire un aqueduc à Anzio18- ou des ther-mes - Antonin a fait construire des thermes à Tarquinia et les thermes de Neptune à Ostie19 - à moins que ce fût tout simplement un raccordement à une propriété d’Antonin20.Un pont dit d’Apollon (pons Apollinis), très endommagé, est restauré par Septime Sévère et Caracalla, empereurs régnants en 205. Une grande inscription en deux morceaux (AE, 1973 226) encore en place au kilomètre 59, 700 de la Via Aurelia commémore la restauration du pont aux lignes 15 et 16 : Imp(erator) Caesar / L(ucius) Septimius Severus / Pius Pertinax Aug(ustus) / Arabicus Adiabenic(us) / Parthicus max(imus) / pontifex maximus / trib(uniciae) potestatis XIV / imp(erator) XI co(n)s(ul) III / pater patriae et / [Im]p(erator) Caesar / M(arcus) Aurelius / Antoninus / Pius Fe-lix Aug(ustus) / trib(uniciae) potestatis IX / consul II p(ater) p(atriae) / Parthicus maximus / Brittan(n)icus / maximus / pontem Apollinis / maris et luminum / violentia eversum / a fundamentis pecunia / sua fecerunt. Le pont pourrait avoir été doté de trois arcades et d’un tracé curviligne et enjambait à 100 m au Nord-Ouest de l’empla-cement actuel de l’inscription deux bras du Castelsecco21, entre la Via Aurelia et la mer. Il est possible qu’aux lignes 15 et 16 ait iguré aussi le nom de Géta, efacé en 210 lors d’un ajout à l’inscription. La famille de l’empereur Gallien reçoit des marques de culte impérial. Une statue ou un groupe statuaire est consacré par la colonie de Castrum Novum à Salonine, l’épouse de Gallien (CIL, XI 3577), au beau-père de cette dernière, P. Cornelius Licinius Valerianus (PIR, L 184), et à Gallien lui-même (CIL, XI, 3578). On note que les trois inscriptions sont gravées sur un même piédestal, avec un formulaire trois fois identique, à l’exception d’une erreur dans l’inscription CIL, XI 3578 :
Publio Corne/lio Licinio / Valeriano / nobilissimo / Caes(ari) col(onia) / Iulia Castro/novo devo/ta numini {a}eiu(s).
Une base de statue est dédiée à l’empereur Aurélien (CIL, XI 3579) et une autre à Numérien (CIL, XI 3580). Peut-être faut-il mettre la reconnaissance portée à Aurélien en rapport avec la volonté d’Aurélien de relancer la viticulture dans les territoires traversés par la Via Aurelia22, mais les manifes-tations du culte impérial sont adressées à tant d’empereurs qu’une seule explication ne saurait suire. Enin, une inscription est dédiée à Sévère II, en qualité de César (CIL, XI 3581), durant son court règne de 306-307 :
] / Imp(eratore) [Caes(are)] / Fl(avio) Valerio / Severo / no-bilissi/mo Caesare / Castrono/vanorum.
Marie-Laurence Haack
18 Cf. HA, Pii, 8, 3. 19 Cf. HA, Pii, 8, 3. 20 Cf. E. Papi, op. cit., p. 35. 21 Fluminum est en efet un pluriel. 22 C’est l’hypothèse de F. Cambi, Paesaggi d’Etruria e di Puglia, in A. Giardina, A. Schiavone (éd.), Storia di Roma, vol. 3.2, Turin, 1993, p. 229-254, spéc. p. 234.
2.5 Le statue di Castrum Novum e i Musei Vaticani
Il palazzetto del Belvedere, ediicato nel 1484 in un luogo elevato del colle vaticano per giovare alla salute di Innocenzo VIII, era stato adibito a luogo di esposizione della collezione pontiicia di arte antica già nei primi del ‘500, con Giulio II. Seguì un perio-do di quasi due secoli durante i quali le statue rimasero invisibili: chiuso il cortile nel 1523 per ordine di Adriano VI, che consi-derava sconveniente l’interesse per quelli che deiniva “idoli an-tichi”, le nicchie che le ospitavano furono chiuse con imposte di legno. Con Clemente XI Albani (1700-1721) il Belvedere tornò a destare l’interesse dei Papi per le opere d’arte che conteneva; si intervenne con restauri, sistemazione di nuove accessioni ma si trattava pur sempre di una raccolta esclusiva, quasi privata, di capolavori di scultura antica. E’ solo a partire dal 1771 che la collezione di scultura, cui si anda-vano aiancando la pinacoteca, il medagliere ed altre raccolte te-matiche, ricevette una sistemazione funzionale alla nuova conce-zione di “grande raccolta pubblica creata a vantaggio della cultura”.1 I lavori si svolsero per quasi 25 anni anni, sotto il pontiicato di Clemente XIV e quello di Pio VI. La supericie espositiva, che ino ad allora era rimasta limitata al palazzetto innocenziano, ne risultò triplicata: fu adibito a museo anche uno dei due corridoi del Bramante che dai tempi di Giulio II collegavano i palazzi va-ticani al Belvedere e la costruzione di un’ala grandiosa, opera di Michelangelo Simonetti ispirata all’architettura delle terme ro-mane, assicurò il raccordo tra le strutture preesistenti (Fig. 1).L’impegno organizzativo e inanziario della Camera Apostolica nella fondazione di quello che oggi è il quarto museo del mondo non poteva limitarsi al contenitore: per riempire le sale appena costruite, il cardinale Gianangelo Braschi, poi Papa Pio VI, dette il via ad una febbrile attività di acquisizione di opere d’arte antica, mediante acquisto sul mercato antiquario, conisca dei ritrova-menti fortuiti - allora piuttosto frequenti in città e nei dintorni - e organizzazione di scavi nei siti archeologici più promettenti.Castrum Novum aveva il pregio di essere collocato in una te-nuta agricola di proprietà della Reverenda Camera Apostolica, la tenuta di Torre della Chiaruccia, e di essere ben collegato con Roma: nonostante la sua scarsa presenza nelle fonti antiche, vi si svolsero quattro campagne di scavo, tra le prime e più fortunate organizzate nell’ultimo quarto del secolo. Sei sono le statue pro-venienti da Castrum Novum esposte nel Museo Pio Clementi-no, accompagnate da nove iscrizioni (due su basi o are riutiliz-zate come supporto di opere di provenienza diversa, sempre nel Pio Clementino, sette conservate nella Galleria Lapidaria) (Cfr. p. 56) e da due massicci tavoli ricavati da un blocco di marmo verde antico recuperato negli stessi scavi. I pezzi di scultura sono stati tutti identiicati nelle due liste di reperti compilate dall’allo-ra Commissario delle antichità presso il Museo pontiicio, abate Giambattista Visconti, al momento dell’ingresso di tali opere nei locali del Museo.2
1 Pietrangeli 1985, premessa, pag. 1 2 La prima lista fu redatta il 9 maggio 1777 e censisce i reperti giunti in Vaticano da Castrum Novum entro il 30 aprile: vi igu-rano 21 pezzi, di cui 10 statue o frammenti di statua. L’originale è riprodotto nella ig. 2 a pag. 51 La seconda elenca i pezzi inca-merati dal Museo entro il 30 settembre 1778 e praticamente ri-guarda i reperti della seconda campagna di scavo, che si era chiusa il 31 maggio dello stesso anno: una sola statua, un’iscrizione e frammenti architettonici.
60
L’identiicazione ha comportato diversi problemi, dovuti in par-te ad equivoci ingenerati da disattenzione dello stesso Visconti, come Carlo Pietrangeli, direttore dei Musei vaticani dal 1978 al 1996, ha fatto rilevare in più occasioni.Seguendo il percorso obbligato di visita del museo Pio Clemen-tino, che oggi si snoda in senso inverso a quello per il quale le sale furono progettate, il primo pezzo castronovano in cui ci si imbatte è la statua che rappresenta un giovane studente vestito di toga (l’età giovanile è attestata dalla bulla che gli pende dal collo, lo stato di studente dalla capsa di rotoli di papiro ai suoi piedi) con testa non pertinente (ed anche un po’ troppo piccola) di isionomia vagamente giulio-claudia (Fig. 2). I papaveri che il fanciullo tiene in mano indicano la natura funeraria del monu-mento, tra i primi ritrovati negli scavi di Castrum Novum. Anche non considerando l’attuale testa-ritratto, sembra probabile che
la statua raigurasse un membro di una famiglia imperiale morto in giovane età e che fosse stata innalzata in suo ricordo nell’Augusteum, ediicio che doveva avere un rilievo centrale in una città dalle ori-gini militari come la colonia di Castrum Novum. Essa fu ritrovata nel corso degli scavi del 1777 ed oggi sorge nel vestibolo che raccorda il corridoio del Bramante con l’ala costruita da Simonetti, e che bi-sogna attraversare per raggiungere il Mu-seo Chiaramonti e salire al c.d. Cortile Ottagono nel palazzetto del Belvedere. In una nicchia ricavata in un pilastro del portico del cortile, precisamente quello a sinistra della nicchia dell’Hermes, è espo-sto in alto il simulacro di Priapo, statua ritrovata quasi intatta all’apertura della seconda campagna di scavo, nel febbra-
io del 1778. Per i suoi aspetti storici e stilistici si veda Viviana Sia, in questo stesso quaderno, pag. 62. Poco avanti, a sinistra del passaggio tra il cortile e la prima delle sale dell’ala di raccordo, la Sala degli Animali, vigila il “Molosso della Chiaruccia”, splendido esemplare di dimensioni maggiori del naturale, ritratto nel mo-
mento in cui, chiamato o atti-rato da un qualche improvviso interesse, si rizza sulle zampe anteriori dalla posizione sdra-iata sul ianco in cui si trovava (Fig. 3). Si tratta di una copia di età imperiale di un origina-le ellenistico, forse di bronzo, attribuito alternativamente a Mirone, Lisippo e - da W. Amelung - alla prima scuola pergamena.3 Questo esempla-re fu ritrovato nel marzo del 1777 e dapprima scambiato per un leone.4 All’altro lato della porta un secondo cane, delle stesse dimensioni ma molto più restaurato, acquista-to sul mercato antiquario nel 1770.
Questo gusto per la simmetria ha forse contribuito ad ingenera-re uno di quegli errori di attribuzione che hanno caratterizzato i reperti di Castrum Novum ino al lavoro chiariicatore di Carlo Pietrangeli. Nella Galleria delle statue sono esposte due statue imperiali loricate, di dimensioni maggiori del vero, il cui grande interesse sta nei bassorilievi inissimi che igurano come deco-razioni della corazza metallica. Ritrovate negli stessi anni, fra il 1777 e il 1778, furono completate l’una con una testa di Lucio Vero (Fig. 4) e l’altra con un probabile ritratto di Clodio Albino, sebbene lo stile dei rilievi non vada oltre l’età adrianea in un caso e quella domizianea nell’altro. Poiché il restauro aveva messo in evidenza l’orientamento convergente degli assi delle statue, a de-stra e a sinistra, ne fu giudicata ottimale la collocazione l’una a ianco dell’altra, a guardia dell’entrata dalla Sala degli Animali. In tutte le guide del Museo Pio Clementino, a partire da quella di Gianbattista Visconti passando per il Catalogo Amelung, queste statue sono indicate come provenienti ambedue da Castrum No-
3 Amelung, 1908, pag. 1624 Torraca 1777 b
Fig. 2: Statua di ragazzo togato con testa (di Tiberio gemello?) non pertinente (Musei vaticani, Pio Clementino, Vestibolo della Scala Simonetti)
Fig. 3: Molosso seduto (Musei va-ticani, Pio Clementino, Cortile Ottagono, Portico Ovest)
61
vum e solo nel 1978 la seconda fu riscontrata con certezza in una lista di reperti degli scavi di Otricoli, vicino Narni, in Umbria, che la Camera Apostolica conduceva contemporaneamente a quelli di Castrum Novum.Nella Sala delle Muse lo schema simmetrico si ripete: sullo sfondo della parete color rosso pompeiano una grande igura femminile siede in mezzo a due erme raiguranti Pericle, a sinistra, ed Aspa-sia, a destra. Quest’ultima è l’erma che fu ritrovata a Castrum No-vum nel marzo del 1777 (Cfr. p. 64). La collocazione vicina dei due pezzi era quasi obbligata dato che, secondo Visconti: “Assai fortunato e singolare accidente è stato quello, che da’ cavamenti fatti in siti molto lontani e diversi l’uno dall’altro, per arricchire di mo-numenti il Museo Pio-Clementino, sieno usciti per la prima volta i due ritratti sino a quel punto ignoti d’Aspasia e di Pericle”.5 Mediante una scala costruita apposta da M. Simonetti nel 1780, la Sala delle Muse e l’ala di cui fa parte si raccordano con la loggia che costituisce il piano superiore del corridoio di Bramante, dove continua l’esposizione dei pezzi del Museo Pio Clementino. In occasione dei lavori, le arcate della loggia furono chiuse alterna-tivamente da vetrate e da tamponature in muratura, che costitu-iscono le pareti alle quali sono addossate ittamente le sculture allora giudicate “minori” rispetto ai capolavori collocati nelle sale precedenti. In una di queste, situata su una mensola a mezz’al-tezza, la statuetta di Dioniso raigurato giovane, imberbe, rico-noscibile dai suoi inequivocabili attributi: il tirso ed il kantharos, con il quale abbevera una piccola pantera ai suoi piedi. Fu ritrova-ta a Castrum Novum nell’aprile del 1777, verso la chiusura della prima campagna di scavo, con poche parti mancanti. Il modello iconograico è noto ed attribuibile all’arte greca di età classica, mentre la datazione della copia romana oscilla tra il II e il IV se-colo (Fig. 5).Delle statue a tutt’oggi esposte nel Museo Pio Clementino, cinque igurano nella prima lista di Visconti che ne comprende dieci ed una, quella di Priapo, nella seconda: fatti i conti, mancano all’ap-pello cinque statue o frammenti, che indichiamo di seguito:1) “Altro torzo simile [a quello poi integrato con la testa di Lucio Vero], ma molto più mutilato” (n. 3 della prima lista Visconti).
5 Visconti 1782 - 1807, tomo VI, scheda XXX, pag. 154
E’ il pezzo che a lungo fu confuso con quello integrato con la testa di Clodio Albino. Date le sue condizioni (Visconti ne dà una stima molto bassa quanto a valore in scudi) è da ritenere che sia rimasto inutilizzato nei magazzini;2) “Figura togata con sua testa di buona espressione di grandezza quasi colos-sale” (n. 5 nella stessa li-sta). Secondo Pietrange-li6 è da identiicarsi con la statua “in abito consolare pur di buona scoltura, sen-za testa” di cui parla Gae-tano Torraca nel primo dei suoi reportages dagli scavi di Castrum Novum.7 Nonostante il grande ri-lievo che ha nella stima di Visconti (assieme al torso loricato “Lucio Vero”, ha il valore più alto dopo l’erma di Aspasia) se ne sono perse le tracce. Delle sta-tue che potrebbero rispondere alla descrizione, oggi esposte nei Musei Vaticani, nessuna reca l’indicazione di provenienza da Ca-strum Novum. La ricerca è ancora aperta, e in tale sede dovrebbe essere chiarita anche l’evidente incongruenza delle due citazioni riguardo l’esistenza della testa al momento del ritrovamento;3) “Togato senza testa” (n. 6 della lista);4) “Togato assai minore del naturale e molto mancante” (n. 8);5) “Testa incognita” (n. 10).Il valore stimato degli ultimi tre pezzi è di gran lunga inferiore a quello degli altri. Anche per questi si può ipotizzare un destino circoscritto ai magazzini o, nel caso della testa, l’innesto su una statua d’altra provenienza. Inine, dalle fonti che conosciamo, altre due sculture risultereb-bero ritrovate a Castrum Novum: una statua di “Vestale”, di cui parla Torraca nelle sue corrispondenze,8 e un’ “Erma di ilosofo” venduta dal custode della Torre della Chiaruccia al referente del-la Reverenda Camera Apostolica a Civitavecchia.9 Poiché questi due pezzi non igurano nelle liste di Visconti, è da ritenere che siano sfuggiti per qualche motivo all’inventario del Museo Pio Clementino10 o che non siano mai giunti in Vaticano.
Guido Girolami
6 C. Pietrangeli,1943, pag. 126, nota 17 Torraca 17778 Torraca 17779 La vendita è citata nel carteggio tra il Cardinal Pallotta, tesorie-re della Reverenda Camera Apostolica e Clemente Pucitta, suo referente a Civitavecchia in: Archivio di Stato di Roma, archi-vio Camerale, titolo II, epistolario, busta 186, 19-23 luglio 1777. Dobbiamo ritenere che l’erma sia stata ritrovata dal custode nei pressi della torre, cioè sul sito dell’antica Castrum Novum. 10 L’ipotesi potrebbe essere non inverosimile per l’erma di ilosofo, la cui anomalia nell’acquisizione potrebbe spiegare l’assenza di docu-mentazione; quanto alla Vestale, invece, Torraca dovrebbe aver com-messo uno strano errore di identiicazione, gratiicando di tale quali-ica una delle due statue togate di cui ai nn. 6 o 8 della lista Visconti.
Fig. 4: Statua loricata con ritratto non pertinente di Lucio Vero (Musei Vaticani, Pio Clementino, Galleria delle Statue)
Fig. 5: Statuetta di Dioniso (Musei Vaticani, Pio Clementino, Galleria dei Candelabri, sezione II)
62
2.6 Un approfondimento sulle statue rinvenute nell’antico sito
di Castrum Novum: la statua di Priapo e l’erma di Aspasia
L’allestimento del Museo Pio Clementino - uno dei com-plessi più grandi dei Musei Vaticani - avvenuto tra il 1770 e il 1791 circa, per volere di Clemente XIV e Pio VI, ebbe un valore paradigmatico per i successivi allestimenti museali in Europa e nel deinire il campo stesso della ricezione dell’an-tico. Fu allestito con l’intenzione di far fronte alle inces-santi esportazioni che, anche con l’approvazione di Win-ckelmann, stavano disperdendo buona parte delle preziose raccolte della capitale pontiicia. Gli oggetti bramati erano per lo più opere scultoree procacciate o attraverso l’acqui-sto o attraverso le campagne archeologiche, numerosissime queste ultime, in particolare, durante il pontiicato di Pio VI (1775 - 1799): si può dire che non ci sia stato luogo della città di Roma o del territorio che non abbia contribuito al suo progetto di promozione delle arti. Nonostante questi scavi siano stati svolti senza alcun me-todo, anzi con grave danno per gli strati archeologici, non dobbiamo dimenticare che fornirono un sostanziale contri-buto per la costituzione della collezione dei musei vaticani.Fonti preziose al ine di comprendere l’attività archeolo-gica svoltasi in questo periodo a Roma e dintorni, sono il “Diario di Pio VI” meglio conosciuto come il “Diario di Roma” e le “Giustiicazioni del Museo Pio Clementino”1. Grazie a questi dati, Carlo Pietrangeli riuscì a ricostruire, in particolare, la storia della formazione dei Musei Vaticani e a identiicare la provenienza di molte sculture, la cui origine era dubbia, ignota o addirittura errata. Conluirono in questo nucleo anche i tesori rinvenuti du-rante gli scavi efettuati tra il 1776 e il 1779 a Torre Chia-ruccia (Santa Marinella)2 - sotto la direzione di Giovanni
1 Si coglie l’occasione per ringraziare il Dott. Prof. Giandomeni-co Spinola, Responsabile del Dipartimento di Archeologia pres-so i Musei Vaticani, per la disponibilità dimostrataci nel fornire chiarimenti utili e preziose informazioni utili alla redazione di quest’articolo, oltre che la possibilità di fotografare le sculture castronovane conservate presso i suddetti Musei. Il Diario di Roma è conservato nell’archivio Campello a Spoleto. È un manoscritto costituito da tre volumi, in cui sono riportati periodicamente gli avvenimenti politici, artistici, mondani e fatti di cronaca avvenuti a Roma e nello Stato Pontiicio tra il 1775 e il 1780. Le Giustiicazioni invece, sono conservate nell’Archivio di Stato di Roma e contengono i numerosi documenti amministra-tivi degli acquisti, scavi e restauri fatti dalla Camera Apostolica nell’interesse dei Musei Pontiici. Vedi Pietrangeli 1958, pp. 6-82 Torre Chiaruccia è una torre in muratura alta circa 20 metri sul lito-rale marittimo del comune di Santa Marinella, in località Capo Lina-ro. Costruita nel XVI secolo per l’avvistamento delle navi dei saraceni in una zona adiacente le antiche rovine dell’insediamento romano di Castrum Novum. In seguito, tra il 1930 e il 1937, la zona divenne sede del centro sperimentale radioelettrico di Guglielmo Marconi sotto il controllo del CNR. Il 1 febbraio 1944, la Torre fu fatta saltare dai tede-schi. I ruderi tutt’ora visibili sono oggi sotto l’aeronautica militare che vi ha installato una stazione meteorologica. Vedi Nibby 1837, p.442;
Corradi ispettore degli scavi pontiici3 - che a detta del Pie-trangeli “furono tra i più fortunati di quelli fatti nei dintor-ni di Roma in quel periodo”4.Grazie al carteggio intercorso tra Gaetano Torraca e Mon-signor Stefano Borgia, pubblicato nella “Antologia Roma-na” del 1777-785, è possibile comprendere le dinamiche di queste ricerche. Si rinvennero reperti di vario tipo, pavi-menti musivi, are, monete e una quantità di frammenti di statue e iscrizioni. Tra le sculture rinvenute, tutte di notevole pregio, si segna-lano in particolare, la statua di Priapo, l’erma di Aspasia, un torso di statua loricata, completata in seguito con una testa di Lucio Vero, un statua di cane molosso e una piccola statua di Bacco6. In questo contesto, si volgerà l’attenzio-ne, in particolare, alla statua di Priapo e all’erma di Aspasia. Attraverso la ricerca d’archivio e bibliograica si tenterà di sviluppare una serie di congetture e ipotesi al ine di poter comprendere la cronologia, lo stile, l’iconograia e il signi-icato mitologico e simbolico di queste opere per poterle meglio inquadrare nel panorama culturale del territorio in cui sono state ritrovate.
Statua di Priapo
Museo Pio Clementino. Cortile Ottagono del Belevedere- Gabinetto dell’Hermes.Statua di divinità virile in marmo giallino a grana ine, di età adrianea.
Dal Diario di Roma, 25 Febbraio 1778.“Nell’utilissima cava della Chiaretta, che si fa per conto della R. nda Camera nel Territorio di Civitavecchia, si è rinvenuta un’antica statua intiera di marmo già trasportata al Museo Clementino al Vaticano, rappresentante il Nume Priapo deità degli Orti, e Giardini quale si per la scoltura, che per l’espressione nel vestimento di bellissimi pampani intrecciati con altri prodotti della terra, si rende meritevole di pregevole stima”7.
La igura gravita sulla gamba sinistra, appoggiata ad un so-stegno laterale a forma di tronco, mentre la destra è legger-mente lessa e portata in avanti. Le braccia sono entrambe piegate e poggiate sui ianchi, ma in particolare il sinistro propone un movimento atto a realizzare un’apertura della veste, lasciando intravedere il membro di notevoli dimen-sioni - in modo da suggerirne l’identità - successivamente nascosto da inserti vegetali. Con il braccio destro invece doveva reggere un attributo, probabilmente una falce, un tirso o un piccolo recipiente.La testa, coronata di pampini e grappoli, è volta verso la gamba lessa. La fronte, triangolare, bassa e liscia, è in-quadrata dalla capigliatura, formata da ciocche ondulate che presentano una scriminatura al centro e si raccolgono
http://www.santamarinella.rm.gov.it/pagina/guglielmo-marconi.3 Giustiicazioni, 1776-1778 (iniziarono il 26 novembre 1776).4 Pietrangeli 1958, p.1035 Torraca 1777 , p. 257 sgg.; Enei 2011, p.166 Pietrangeli 1982, p. 73 7 Pietrangeli 1958, p. 108
63
in una crocchia sull’occipite, non riinita. Caratterizzano questo volto un ovale sinato dalle guance delicatamente modellate, occhi rigoni e leggermente obliqui con arcata sopraccigliare netta e lineare alla radice del naso, ben mo-dellato quest’ultimo e tendente ad allargarsi per poi appiat-tirsi progressivamente verso l’angolo esterno dell’occhio. I bai a ciocche lunghe, lisce, disposte ad arco ai lati della bocca, nascondono il labbro superiore mentre quello infe-riore, carnoso, è incorniciato da una lunga barba di riccioli dall’andamento sinuoso, che lascia scoperto parte del men-to. L’abbigliamento, dai richiami femminili, consiste in un peplo, provvisto di maniche, con apoptygma lungo, stretto sotto il seno da una cintura serrata con un piccolo nodo e aibbiato sulle spalle. Calza stivali alti, in morbida pelle (Figg.1, 2).La scultura rivela un’esecuzione piuttosto scadente, sotto-lineata dalla igura troppo allungata, forse in previsione di una sua ipotetica collocazione in alto. La statua è da consi-derarsi, probabilmente, una replica romana di età adrianea, atona e piuttosto fredda, di un originale greco di scuola li-sippea (il Sileno con Dioniso fanciullo in braccio, ascrivibile al 300 -280 a.C.), ma in questo caso si tratterebbe di una rilettura comica e caricaturale. Tale collocazione cronologi-ca si giustiicherebbe in virtù dei caratteri che deiniscono artisticamente questo periodo, ovvero, il ritorno ad una for-ma idealizzata e ad un atteggiamento eroico in cui è quasi completamente assente il vero carattere isico e psicologico del soggetto8. L’anno stesso del ritrovamento, la statua venne sottoposta al restauro di Ferdinando Lisandroni, che realizzò delle inte-grazioni ben visibili: la punta del naso, la foglia sull’occhio sinistro e parte dei capelli, l’avambraccio e la mano destra, alcuni dei frutti della cornucopia posta nella mano sinistra, in particolare quelli più sporgenti, collocati appositamen-te al ine di celare le pudenda, alcune toppe nel chitone e inine alcune fratture sotto il ginocchio sinistro e sopra il piede destro.Il gesto di sollevarsi la veste all’altezza del pube, sottolineato anche dal movimento della testa, la decorazione che cinge il capo, sono tutti elementi che riconducono alle rappresenta-zioni di Priapo. Divinità delle forze generatrici della natura e della vita vegetativa e fruttiicante. Secondo una tradi-zione sarebbe iglio di Afrodite e Dioniso, e in efetti gran parte della sua personalità rientra in ambiente dionisiaco9. Presumibilmente Priapo è una divinità minore di origini re-lativamente tarde e popolaresche, originario di Lampsaco, nell’odierna Turchia. Di qui si difuse per tutta la Grecia e poi per il mondo romano, sostituendosi indubbiamente a oscure divinità falliche regionali. Lo sviluppo iconograi-co e cultuale di questa divinità ha inizio nell’ellenismo, in un momento artistico il cui linguaggio è espressione della passione per il verismo più grottesco ed espressivo, unito al gusto per certi aspetti di sensualità violenta e tortuosa. Come giustiicare questa statua, il suo ritrovamento e la sua funzione? Nella sua “Analisi storico-topograica della carta dei dintor-ni di Roma” il Nibby riporta una tradizione, da considerare con estrema cautela, circa la fondazione di Castrum Novum,
8 Amelung 1908, pp. 145-1469 Paus. 9, 31,2; Strabo. 13, 587
Fig.1. Statua di Priapo. Dagli scavi del 1778 a Torre Chiaruccia (Castrum Novum). Età adrianea. Museo Pio Clementino. Cortile Ottagono del Belvedere. Gabinetto dell’Hermes.
Fig. 2. Particolare del volto di Priapo.
64
che potrebbe spiegare la presenza di questa statua. Ovvero, gli abitanti di Castrum Inui - sito fondato da Latino Sil-vio, successore di Ascanio, collocabile tra Ardea e Anzio - a causa dell’insalubrità dei luoghi si mossero alla ricerca di una nuova terra e la trovarono tra Pyrgi (S. Severa) e Cen-tumcellae (Civitavecchia). Qui, diedero vita ad una nuova colonia che per tale motivo fu chiamata Castrum Novum. Secondo i grammatici il nome Inuus si riferirebbe ad un nume del Lazio primitivo, corrispondente a Pan o Priapo, quindi con tale trasferimento questo popolo avrebbe anche portato il culto di questa divinità10. È importante però tenere presente che generalmente i ro-mani erano soliti adornare le loro abitazioni con statue e opere d’arte per puro scopo decorativo o simbolico e questo potrebbe essere anche il caso della nostra scultura. Statue di Priapo, infatti, spesso dalla resa per lo più approssimativa e rozza, erano collocate a decorazione di orti, giardini, se-polcri e porti, con funzione apotropaica oltre che di buon auspicio, di fertilità e benessere11.
Erma di Aspasia
Museo Pio Clementino. Sala delle Muse.Erma femminile in marmo pentelico (con striature grigie sulla guancia sinistra), patina giallastra, con iscrizione in greco. Prima metà II sec. d.C.
Da Cracas, 29 marzo 1777.“Si è scoperto nel sito della Chiaruccia, già Castronovo, un Erma bellissimo della famosa Aspasia colla sua iscrizione Greca e un Leone giacente in grandezza naturale di buona scultura”12. Una solida struttura caratterizza la testa di questo busto, lievemente inclinata a destra e coperta da un velo. Il volto mostra un ovale pieno, fronte bassa è incorniciata da cioc-che morbide, gonie e ricurve che si dipartono a raggiera sulla sommità del capo, proponendo la nota acconciatura “a melone”; occhi stretti, dalle palpebre superiori grosse e pe-santi e inferiori a cordoncino rigonio; naso ampio; bocca piccola dal labbro superiore stretto mentre quello inferiore più carnoso. Indossa un chitone. Non particolarmente bello, da un punto di vista estetico - probabilmente, per via di una scarsa maestranza esecutiva ma anche per la cattiva conservazione - questo ritratto, ato-no e privo di tratti somatici caratteristici, è contraddistinto da un’espressione crucciata.Il pilastrino è rastremato verso il basso, dove riporta un’iscrizione ACΠACIA, incisa in modo piuttosto trascu-rato: probabilmente serviva a suggerire l’identità del perso-naggio eigiato, ovvero Aspasia (Figg.3, 4 e 5).Una delle igure femminili più celebri del panorama gre-co del V secolo a. C., Aspasia non corrisponde al modello tradizionale di femminilità classica ma, provenendo da Mi-leto, ha una formazione più cosmopolita, quindi più col-ta, saggia e aperta agli inlussi orientali. Giunge ad Atene intorno al 450 a.C., quando Pericle ha appena promulgato
10 Nibby 1837, pp.440- 44411 Paribeni 1965, pp. 466-46712 Pietrangeli 1958, p. 107
Fig. 3. Erma di Aspasia. Da Castrum Novum. Dagli scavi presso Torre Chiaruccia nel 1777. Prima metà II sec .d C. Museo Pio Cle-mentino – Sala delle Muse
una nuova legge che attribuisce la cittadinanza ateniese solo a chi è iglio di due cittadini; tutti gli altri saranno conside-rati stranieri, senza diritto di voto e di partecipazione attiva alla vita della città. Ciò signiica per Aspasia non poter più diventare la sposa di un cittadino ateniese e, quindi, non poter generare prole legittima ma accontentarsi di essere una concubina.
65
Grazie a Plutarco, uno dei principali storiograi dell’anti-chità, sappiamo che Pericle si innamorò perdutamente di questa donna, carismatica e intelligente, tanto da lasciare moglie e igli13. Se da un lato Socrate e Senofonte ne esal-tano la saggezza, l’intuito politico e la scaltrezza, dall’altra i poeti comici a lei contemporanei, ne fanno oggetto di scherno nelle loro opere arrivando a deinirla come una cortigiana14. Nell’anno in cui fu ritrovata l’erma venne sottoposta ai re-stauri di Gaspare Sibilla il quale apportò diverse integrazio-ni, in particolare gran parte della testa, al centro e in alto a sinistra, la punta del naso, parte della base del pilastrino e operò una stuccatura di una frattura diagonale. Sottopose a levigatura l’intero pezzo asportando così parte della pa-tina originale. Nella letteratura antica non sembrano es-sere attestati ritratti relativi a questa donna, ma la nostra erma potrebbe essere considerata una testimonianza, tanto che Lippold, nel descriverla, congettura la possibilità che
13 Plut. Per., 24, 3- 514 http://www.enciclopediadelledonne.it/index.php?azione=pagina&id=64
si tratti di una copia riproducente il rilievo posto sulla sua tomba15. Quindi questo farebbe del pezzo in questione l’unico ritratto certo di Aspasia, anche se la resa non ecce-zionale ha indotto a pensare che il nome fosse stato apposto successivamente; ipotesi respinta in virtù dei dati del 1777 e del 1869 che confermano il ritrovamento dell’erma com-prensiva di iscrizione16.Dal punto di vista cronologico, possiamo dire di trovarci di fronte ad una copia attribuibile alla prima metà del II seco-lo d.C., riferibile ad un modello che, per il rendimento degli occhi e lo stile alquanto approssimativo, potrebbe ascriversi alla seconda metà del V secolo a.C.; questo modello è nel nostro caso probabilmente iltrato attraverso una sua rilet-tura nella seconda metà del IV sec. a. C., in virtù dell’ac-conciatura tipica del periodo ellenistico perdurante ino in età romana.Tale tipologia iconograica evidenzia caratteristiche co-muni alla statua bronzea dell’Afrodite Sosandra (che salva gli uomini), realizzata nel 470/460 a.C. da Calamide, uno dei più grandi bronzisti dello stile detto “severo”. L’origi-nale bronzeo, collocato all’ingresso dell’ Acropoli di Ate-ne, aveva un sorriso «puro e venerando» ed era avvolta in un mantello «semplice e dignitoso», che le copriva anche la testa17; pur presentando ancora quel residuo di rigidez-za tipico delle opere di stile severo, come tutte le opere di Calamide, quest’Afrodite era sofusa di dolcezza, grazia e raccolto pudore.In età romana furono realizzate numerose repliche di que-sto pezzo, di cui si conserva un esempio integro al Museo Nazionale di Napoli e l’analisi stilistico - iconograica ha indotto gli studiosi dell’Ottocento ad individuarvi il ritrat-to di Aspasia. Inoltre grazie alla testimonianza di Luciano sappiamo che nel II secolo d.C., questo modello era molto in voga e difuso18. La tendenza a realizzare erme nasce e si sviluppa nell’antica Grecia con l’intento di raigurare il dio Ermes e con lo scopo di invocare la sua protezione nei luoghi dove questi pilastrini venivano posti, ovvero, strade, conini di proprietà e ingressi delle case. A partire dall’età ellenistica, l’erma continuò ad essere utilizzata come rap-presentazione di divinità ma anche di persone, forse in virtù dell’assimilazione del defunto con il messaggero degli dei, considerato psychopompòs, cioè accompagnatore delle anime, ino a quando in età romana cominciò a confondersi con il busto-ritratto, incontrando così la tendenza italica di dare, nel ritratto funerario, prevalente importanza alla testa a scapito del corpo. In questo periodo l’erma avrà grandissi-ma difusione sia per le sue applicazioni decorative ma an-che per via della forte predilezione dell’epoca per tutto ciò che era o sembrava arcaico19.Per quanto concerne la nostra erma, quindi, si può pensare che sia stata realizzata con intento decorativo e dal momen-to che mostra la parte posteriore appena sbozzata, proba-bilmente doveva essere collocata entro una nicchia o in un luogo che non ne prevedeva una visione circolare.
Viviana Sia
15 Lippold 1936 , p.8216 Helbig 1869, p. 6917 Paus. I, 23, 2; Luc. Im., 6 18 Orlandini 1961, v. Kalamis19 Johns 1992, p.60
Fig. 5. Iscrizione alla base dell’erma di Aspasia.
Fig. 4. Particolare del volto di Aspasia.
66
2.7 Una possibile raigurazione del “Buon Pastore” dal territorio castronovano
con quella che appare come una capigliatura folta sulla testa o meno probabilmente un’aureola o una sorta di copricapo non meglio identiicabile. La testa, senza indicazione del collo, è attaccata direttamente al corpo, rappresentato in forma schematica triangolare dal quale si staccano sui lati le braccia disegnate come due brevi rettangoli allungati, prive di mani. La forma del corpo indica che il personaggio in-dossa una lunga tunica che arriva quasi all’altezza dei piedi. Nel mezzo del petto, all’altezza del cuore, si notano due profonde incisioni intenzionali di forma circolare scavate con una punta. Dall’orlo inferiore della veste fuoriescono parte delle gambe e i piedi, rappresentati con un semplice tratto orizzontale. L’uomo tiene in mano sulla sua destra un lungo bastone con sommità ricurva tenuto in posizione verticale con appoggio a terra. Sui rispettivi lati del personaggio centrale si riconoscono le forme di due animali, disegnati con dimensioni legger-mente diverse. Le caratteristiche della rappresentazione consentono di identiicarli come due suini. In particolare la igura visibile sulla destra presenta il caratteristico corpo con breve coda ripiegata verso il basso e il muso porcino ben evidente.La scena graita sul laterizio è probabile che sia da iden-tiicare con quella del “Buon Pastore”, la rappresentazione evangelica di Gesù come “Pastore di anime2”, con origini iconograiche nel mondo classico e particolarmente difusa dall’epoca paleocristiana come unica immagine allegorica di Gesù uicialmente autorizzata ino al IV secolo d.C. Il pezzo, proveniente dal sito di una villa rustica, così inter-pretato, può risultare di notevole importanza in quanto
2 Vangelo, Giovanni 10, 1-21.
Si illustra in questa sede il rinvenimento occasionale di un interessante laterizio con scena graita, avvenuto in loca-lità “Macchia della Fornacetta”, nel territorio del Comune di Santa Marinella, nell’ambito di un’area interessata dalla presenza dei resti di una villa rustica romana1 (Figg. 1, 2). Si tratta di un frammento di una probabile tegola, di cm 25x16,5 h, spesso 2,5 cm in argilla rosata, ben cotta, ricca di inclusi micacei, di forma pentagonale irregolare con parte di un lato originario ancora conservato. Sulla supericie lisciata compare una scena graita raigu-rante un uomo vestito di una lunga tunica con un bastone a sommità ricurva nella mano destra e due igure di animali sui lati. Le igure risultano ben incise nella terracotta con un graito rozzo ed impreciso, realizzato quasi certamente con una punta metallica, larga non più di 2 mm. La patina pre-sente all’interno dell’incisione sembra indicare l’antichità della fattura, sebbene l’epoca della realizzazione del grai-to sia di per sé indeterminabile. Nel centro della supericie disponibile, in asse con il vertice del frammento laterizio che con la sua forma crea due spioventi laterali sui lati del-la igura, si trova l’immagine dell’uomo, visto in posizione frontale, con il volto largo, occhi, naso e bocca ben segnati e
1 Il ritrovamento risale al 2003 quando il frammento fu raccolto in occasione di ricognizioni di schedatura dei siti del territorio curate per conto della Regione Lazio dalla Dott.ssa Bice Pisani coadiuvata dal Cav. Luigi Selis, M.llo della Polizia Municipale presso il Comune di Santa Marinella.Il pezzo, a suo tempo segnalato alla Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale, è rimasto per anni presso il Comando della Polizia Municipale ed ora in deposito temporaneo nel Mu-seo Civico.
Fig. 1. Il laterizio graito con probabile igura del “Buon Pastore”
67
potrebbe costituire la prima traccia diretta della presenza di una comunità cristiana nel territorio di Castrum Novum, nei primi secoli dell’impero3 e di fatto anche una delle più antiche rappresentazioni del “Buon Pastore” ad oggi note, che l’estrema semplicità e immediatezza del disegno indica di fattura locale ed estemporanea. Alcuni residui di malta presenti sui bordi del frammento di laterizio potrebbero se-gnalare la sua originaria pertinenza ad una lastra di chiusura di un loculo sepolcrale e, quindi, la provenienza del pezzo da un cimitero paleocristiano. Tuttavia, alcuni elementi della raigurazione e le due incisioni rilevabili sul corpo del personaggio all’altezza del cuore lasciano aperta anche una diversa possibilità di lettura del documento. Molto strana ri-sulta, infatti, la presenza di due suini disegnati al posto delle pecore che normalmente si trovano in tutte le rappresenta-zioni del “Buon Pastore”, così come colpi non accidentali, dovuti alla lunga permanenza nel terreno, sembrerebbero le incisioni rilevabili sul petto dell’uomo. La raigurazione di maiali al posto delle pecore e i colpi sul cuore potrebbero far pensare ad una sorta di deixio, un graito blasfemo, ir-risorio del culto cristiano, realizzato da un pagano a sfregio delle credenze della nuova setta religiosa insediatasi sul ter-ritorio di Castrum Novum4. In attesa degli sviluppi della ricerca e dei dovuti approfon-dimenti, da parte degli specialisti del settore, abbiamo rite-nuto utile segnalare in via del tutto preliminare la scoperta dell’interessante documento, ponendola a disposizione de-gli studiosi e del pubblico.
Flavio Enei
3 La fattura rozza del graito, eseguito su un frammento di late-rizio di buona qualità, rinvenuto nell’area di una villa rustica con tracce di frequentazione tra il I e il III secolo d.C., lascia presume-re che il pezzo possa datarsi in epoca romana imperiale. 4 Vedi ad esempio il famoso Graito blasfemo di Alexamenos dal paedagogium del Palatino a Roma: Coarelli 1984, p. 158.
Fig. 2. In verde il luogo del ritrovamento del graito, nell’entroterra di Punicum, nel territorio della colonia di Castrum Novum (posi-zionamento su carta archeologica di P.A. Gianrotta 1972).
2.8 Una moneta bizantina dall’ager di Castrum Novum
La presente scheda verte sul ritrovamento fortuito di una moneta raigurante l’imperatore bizantino Giustiniano I (527-565), efettuato dallo scrivente, nel settembre 2013, nell’ambito di un’inedita villa rustica romana in località Prato Cipolloso (Santa Marinella), documentata da una ristretta area di frammenti ittili oltre ai resti di alcuni basa-menti in pietra locale e dell’impianto produttivo. In sostan-za, i dati acquisiti vanno attribuiti ad una fattoria con tracce di frequentazione cronologicamente inquadrabili dalla ine del periodo repubblicano alla tarda età imperiale1.
Tornando al ritrovamento in questione, si tratta di un de-canummo in bronzo coniato dalla Zecca di Roma, recante nel dritto il busto frontale di Giustiniano con elmo piuma-to, corazza, scudo e globo crucigero nella destra, nonché la legenda in parte decifrabile nell’intorno: [..] IUSTINIA-NUS [---]2; mentre nel rovescio appare la lettera I3 tra due stelle a sei punte entro corona d’alloro (peso 4,9 gr.; diame-tro 17 mm)4. Questa testimonianza monetale, inora unica nel compren-
sorio, fermo restando ovviamente il contesto di rinveni-mento, potrebbe essere messa in relazione con le vicende della guerra greco-gotica (535-553) che interessarono la città e il porto di Centumcellae, ampiamente note grazie a diversi passi della narrazione di Procopio di Cesarea5.
Massimiliano Galletti
1 I risultati della ricerca topograica di supericie svolta da chi scrive in questo sito, sono in corso di stampa nella collana dei MEFRA.2 Sulla base del confronto con esemplari monetali analoghi è ve-rosimile ipotizzare la seguente integrazione: [DN] IUSTINIA-NUS [PPAVC], cfr. DOC I, pp. 178-179. 331.1-331.13; MIB I, 228; MORRISON 1970, 4/Ro/AE/27-35.3 La riforma monetaria bizantina introdotta dall’imperatore Anastasio I nel 498 d.C., prevedeva che nella maggior parte delle monete in bronzo vi fosse indicato il valore con la numerazione greca. Pertanto I = 10 (decanummo = 10 nummi).4 Per quanto attiene la datazione la moneta potrebbe essere as-segnata alle emissioni del 547-549 (MIB I, 228), e del 547-565 (DOC I, pp. 178-179. 331.1-331.13).5 Procopio di Cesarea, Bellum Gothicum, II,7; III, 13, 37, 39; IV, 34.
68
2.9 I Santi perduti di Castrum Novum
La questione agiograica riguardante i santi Secondiano, Veriano e Marcelliano, presunti martiri di Castrum Novum, appare non priva di complessità. La storia degli studi si basa su due testi cardine e precisa-mente il Martirologio Geronimiano, che riporta i nomi dei tre martiri al 9 agosto e una Passio composta tra il V e il VI secolo.I dati topograici riportati dai diversi codici del Geronimia-no risultano alquanto imprecisi. Il luogo del martirio nel Codex Epternacense è indicato semplicemente in Tuscia; il Wissemburgense indica in Colonia mentre il Bernense speci-ica In Colo(n)ni Tusciae via Aurelia miliario XV 1.La passio, attribuibile al VI secolo2, giunta sino a noi attra-verso tre redazioni manoscritte non anteriori all’XI seco-lo3, non prive di incoerenze di dati 4, presenta i tre martiri come romani dottissimi che si convertono al cristianesimo dopo aver letto e commentato la IV ecloga di Virgilio. Bat-tezzati da Timoteo (presbitero del Titulus Pastoris), vengo-no arrestati dal prefetto Valeriano su ordine dell’imperato-re Decio. Inviati a Centumcellae, vengono condannati alla decapitazione da Quarto Promoto il 9 agosto. I loro corpi, gettati in mare, vengono recuperati dal servus Dei Deodatus e sepolti nello stesso luogo dove erano stati decapitati.La seconda redazione della Passio colloca il luogo del mar-tirio al LXII miglio da Roma, mentre la terza redazione fornisce un’ulteriore precisazione topograica indicando Coloniacum qui dicitur Colonia e localizzando il culto dei tre martiri a Tuscania nella basilica di San Pietro5.Il confronto dei dati forniti dal martirologio con quelli de-sunti dalla Passio portò ad identiicare il luogo del martirio con Castrum Novum 6 o Colonia Iulia Castrumnovum lun-go la Via Aurelia, a quattro miglia da Centumcellae 7. Nel formulare e riproporre tale ipotesi né il Lanzoni né Amore valutarono un elemento di fondamentale importanza, ossia la distanza in miglia espressa dalla Passio e non coincidente con la collocazione topograica della colonia castronovana8. In seguito Fiocchi Nicolai tentò di risolvere tale incon-gruenza9, avanzando l’ipotesi di un errore di trascrizione
1 LANZONI 1927, pp. 519-520; AMORE 1968, coll. 808-809.2 AA.SS 1695, pp. 35-37; AA.SS 1735, pp. 401-407: Cfr. LAN-ZONI 1927, pp. 519-520; AMORE 1968, coll. 808-809;DEL LUNGO 1999, p. 33; SUSI, 2007, pp. 207-209; TIZI 2011, pp. 63-69, p. 84, nota 8.3 DEL LUNGO 1999, p. 33, in part. nota 50; TIZI 2011, pp. 63-64.4 AMORE 1968, col. 808.5 AMORE 1968, col. 808; LANZONI 1927, p. 520. 6 LANZONI 1927, p. 520; AMORE, 1968, col. 808; FIOC-CHI NICOLAI, 1988, p. 33, nota 240.7 Per le indicazioni topograiche aferenti Castrum Novum conte-nute nella Tabula Peutingeriana cfr: ENEI, 2011, p. 9.8 DEL LUNGO 1999, p. 34, nota 52 in cui lo studioso considera una forzatura l’ipotesi lanzoniana.9 Tra le incongruenze nei testi documentari presi in esame merita un accenno l’indicazione delle miglia nel Geronimiano esplicita-te con il numerale XV. Già Lanzoni aveva espresso il suo disaccor-
da parte del redattore della Passio. In tal caso il numerale LXII potrebbe rappresentare una svista da parte della tra-dizione manoscritta che avrebbe invertito le prime due cifre indicanti le miglia alterando così il computo esatto che per riferirsi alla Colonia Iulia Castrumnovum doveva necessa-riamente essere indicato dalla cifra XLII10.Di contro a questa interpretazione che considera Secondia-no e soci martiri autentici di Castrum Novum11, nuovi studi hanno proposto una nuova ipotesi che porta a localizzare l’epicentro del culto presso Graviscae, l’antico porto roma-no dell’odierna città di Tarquinia. L’indicazione topograi-ca del luogo del martirio contenuta nella terza redazione del testo così come è espressa dall’autore non darebbe adito a dubbi. Secondo Del Lungo il luogo qui appellatur Colonia-cum qui dicitur Colonia sexagesimo secundo miliario Urbis Romae corrisponderebbe al territorio di Graviscae o meglio Colonia Graviscos secondo la denominazione imperiale12, la
do a riguardo speciicando che ...secondo la passione (i tre martiri) sarebbero stati decapitati a LXII miglia da Roma (da preferirsi al XV miglio del Gerolimiano (LANZONI 1927, p.520). Secondo Amore ...bisogna correggere le XV miglia del Geronimiano con le LXII indicate dalla passio: ma un tale errore di trascrizione di nu-meri nel Geronimiano non sarebbe insolito (AMORE 1968, col. 808). Dello stesso parere FIOCCHI NICOLAI 1988, p.33, nota 240 con bibliograia precedente.10 FIOCCHI NICOLAI 1988, p.33 nota 240.11 Cosi si esprime Amore: Secondiano, Veriano e Marcelliano, martiri autentici di Castrum Novum dei quali però niente si co-nosce di sicuro contro l’ipotesi di Delahaye che riteneva Veriano e Secondiano due martiri di Albano venerati l’8 agosto:AMORE 1968,coll.808-809.12 DEL LUNGO 1999, pp.33-36; SUSI 2007, pp.216-219. La forma Coloniaco, molto rara in Italia centrale e corrispondente ad un toponimo prediale con terminazione in –anus derivante dal termine colonia, potrebbe essere stata aggiunta dal redattore della passio, forse di origine settentrionale, in un momento in cui l’ori-ginario nome della località, di cui probabilmente si era perduta l’identità, venne sostituito da un termine che ne indicava sempli-cemente lo stato giuridico: DEL LUNGO 1999, pp. 34-35.
Fig. 1. Cappella lungo la via Madonna dell’Olivo. Afresco con i martiri Secondiano, Veriano e Marcelliano (Foto E. Valentini).
69
cui distanza in miglia da Roma corrisponde perfettamente all’antico porto di Tarquinia13.Nell’ambito dello studio agiograico le indicazioni topo-graiche necessarie per localizzare i luoghi della tradizio-ne necessitano anche di un sostrato monumentale in cui riconoscere l’attendibilità storica di un culto. Mentre per Castrum Novum si era sottolineata l’assoluta mancanza di dati monumentali cristiani che potessero sufragare l’ipote-si scaturita dall’interpretazione della passio14, per Graviscae ci troviamo di fronte ad una situazione non priva di interes-santi “puntelli” storico-archeologici. In particolare l’anali-si della igura di Deodatus, servus Dei, identiicato con un vescovo o un alto prelato legato alla diocesi di Tarquinii, appartenenza sottolineata dall’interesse di seppellire i corpi ritrovati nello stesso luogo del martirio, potrebbe rivelare la presenza di un quinto vescovo di Tarquinia agli inizi del VI secolo, momento in cui la fuga dei cristiani dall’Africa verso la Sardegna e la penisola italiana in seguito alle perse-cuzioni vandaliche è fonte di nuovi apporti culturali che si rilettono anche nei metodi costruttivi15.Deodatus, che rivela nel nome la sua origine africana16, po-trebbe in questo caso avallare il contenuto della passio che a sua volta testimonierebbe l’importanza di Graviscae in quanto sede vescovile17, e all’inventio delle reliquie da lui
13 Già Padre Alberto Daga, frate missionario e appassionato stu-dioso tarquiniese, nella sua opera redatta alcuni anni prima della sua morte avvenuta a Tarquinia nel 1974 e pubblicata postuma, in riferimento alla traslatio dei corpi santi da Corneto a Tusca-nia, localizzò il luogo della sepoltura nel luogo della colonia ro-mana di Graviscae: Pensiamo che il braccio di S. Secondiano sia stato donato alla città di Tuscania, allorquando Corneto era sceso in potenza ed estensione, e quale tangibile riconoscimento che quei corpi sarebbero appartenuti a Corneto, in ragione del territorio da cui furono prelevati, nella Colonia Tuscia a 68 miglia sull’Aurelia dove era il porto della Colonia romana di Gravisca, quindi l’attuale Porto Clementino (DAGA 1999, p. 237). I dati riportati rivelano uno studio molto accurato delle fonti agiograiche e l’inesattez-za dell’indicazione delle miglia potrebbe essere imputabile alla diicoltà di lettura e trascrizione dei dattiloscritti deteriorati dal tempo, come scrive nella prefazione il nipote Luigi: Alcune parti anche per il tempo trascorso erano diicilmente decirabili, altre, in fogli dattiloscritti, erano il rutto delle proprie idee, altre probabil-mente facevano riferimento a scritti altrui (DAGA 1999, p. 17).14 Cfr FIOCCHI NICOLAI 1988, p. 33 nota 240.15 DEL LUNGO 1999, pp. 35-37. L’opera a telaio, o opus ari-canum è largamente documentata a Tarquinia: DEL LUNGO 1999, pp. 56-57. 16 Il nome Deodatus e la sua variante Adeodatus è un nome teofo-rico molto difuso nell’onomastica cristiana di derivazione africa-na: DEL LUNGO 1999, p. 35; CORDA 2007, p. 105.17 L’importanza di Graviscae in epoca tardo antica e conseguen-temente l’eicienza del porto, inserito con ogni probabilità nel-le rotte commerciali provenienti dall’Africa e dal Mediterraneo orientale, è testimoniata anche da numerosi interventi edilizi, alcuni dei quali potrebbero indicare un riadattamento di strut-ture preesistenti a ini rituali in concomitanza con la presenza di un vescovo tarquiniese (DEL LUNGO 1999, pp. 30-33). A questo proposito ricordiamo che nel 504 al Sinodo tenuto a S. Pietro in Vaticano partecipò Adonius, il quale di irma come epi-scopus ecclesiae Graviscae: DEL LUNGO 1999, p. 30. Secondo
compiuta potrebbe essere legata l’ediicazione di un luogo di culto inteso come chiesa martiriale.18 L’esistenza di una chiesa intitolata a S. Secondiano sulla strada per il Lido di Tarquinia, in rovina dal XIV secolo, potrebbe essere la pro-va archeologica a supporto della passio e l’unica struttura visibile attualmente nell’area suddetta, la cosiddetta Torre degli Appestati, potrebbe costituire l’unico elemento su-perstite dell’antico martyrium19, ediicato presumibilmen-te nell’ambito degli horrea dell’antica Graviscae 20. Questa interpretazione chiarirebbe l’origine del culto di S. Secondiano e la grande devozione popolare a lui tributata nella città di Tarquinia dal XIII al XV secolo21. Secondia-no divenne così il catalizzatore di un culto oscurando i suoi compagni di fede Veriano e Marcelliano.22
Ma la complessità della vicenda agiograica è destinata ad acuirsi: oltre Corneto, un’altra città della Tuscia rivendica i martiri: Tuscania.Già il Lanzoni riportava che secondo la Passio però i resti dei tre martiri riposavano nella chiesa di S. Pietro della “civitas Tuscana” (Toscanella). Il nome Verianus ricorre spesso nelle iscrizioni della Tuscia. 23
La notizia riferita dalla Passio24 e una lamina di piombo
SUSI una rilettura della Passio permetterebbe una precisazione nella cronologia individuando il terminus post quem verso la metà del VI secolo epoca in cui soppressa l’antica diocesi di Tarquinia, non più documentata dal 504, il territorio passò sotto il controllo amministrativo e ecclesiastico di Centumcellae: SUSI 2007, pp. 218-219.18 DEL LUNGO 1999, p. 35.19 DEL LUNGO 1999, p.35. DEL LUNGO 1999b, p. 135. Lo storico locale Muzio Polidori, autore nella seconda metà del XVII secolo dei “Discorsi, Annali e Privilegi di Corneto”, descri-ve che alla sua epoca dell’antica chiesa di S. Secondiano, che era vicino al mare, si vedeva soltanto la torre, forse l’antico campani-le (di epoca medievale come si può desumere da un documento del 1178): SUSI 2007, p. 217 in part. nota 60 con bibliograia precedente. Inoltre nella narrazione dell’episodio della matrona cornetana nel Commentarius Praevius è detto chiaramente che il dito sottratto alla mano di Secondiano venne esposto nella chiesa intitolata con il nome del martire e che si vede tutt’ora: TONIC-CHI 2011, p. 9220 DEL LUNGO 1999b, p. 135; SUSI 2007, pp. 216-217.21 SUSI 2007, pp. 207-225. Come risulta dalla Margarita Corne-tana e da altri numerosi atti di sottomissione al Comune di Cor-neto, S. Secondiano nel corso dei sec. XIII e XIV è considerato il simbolo della città (SUSI 2000, p. 207). Sul culto di Secondiano a Corneto nel Quattrocento: GUFI 2007, pp. 310-314. 22 Il culto del martire è ancora documentato nella città di Tarqui-nia negli anni Settanta del Novecento. Successivamente sembra essere stato dimenticato. A riguardo Padre Alberto Daga riporta: di S. Secondiano in cattedrale si conservano le ossa di un braccio che tutti possono venerare il giorno 8 agosto. Intorno a questa reliquia è iorita una leggenda che potrebbe rivestirsi di qualche validità unica-mente in certi elementi essenziali. Difatti era necessario dare a questa reliquia autentica un alone di prodigio: DAGA 1999, pp. 235-236.23 LANZONI 1927, p. 520; AMORE 1968, col. 808: il culto dei tre santi era localizzato a Tuscania. Cfr. supra nota 5.24 FIOCCHI NICOLAI, 1988, p. 90; TIZI, 2011, p. 64, p. 84 con riferimenti bibliograici.
70
conservata nella basilica riportano all’anno 648, epoca in cui i corpi dei tre martiri sarebbero stati traslati da Centum-cellae a Tuscania25.La lamina di piombo, considerata garanzia di autenticità delle reliquie e di antichità della traslazione dai Bollandisti nel Commentarius Praevius26 e dagli storici locali27non sem-brerebbe avere altro valore documentario se non quello di avallo ad una tradizione altrimenti priva di fondamento28.La pratica di incidere iscrizioni su lamine plumbee, retaggio dell’uso delle deixiones di tradizione romana, era molto dif-fusa nel Medioevo sia per commemorare la consacrazione di chiese sia per certiicare le reliquie che venivano poste in esse e a tal ine erano riposte all’interno dell’urna marmorea o della capsella lignea collocata presso gli altari29.Un’analisi paleograica potrebbe stabilire la cronologia del-la lamina, attualmente conservata nella chiesa di S. Giaco-mo a Tuscania dentro l’urna con le reliquie di Secondiano, Veriano e Marcelliano30. Di essa si intravede lo spessore ma è praticamente impossibile esaminare il testo,31 noto soltan-to attraverso le trascrizioni degli agiograi32.Il formulario caratterizzato dall’indicazione dell’Annus Domini e dell’indictione trova confronti con iscrizioni ri-salenti all’inizio del XII secolo33 e il fatto che ai nomi dei tre martiri venga aggiunto anche quello di Deodatus rivela una diretta dipendenza del testo epigraico dalla passio. In questo caso Deodatus è però considerato martire forse in seguito ad un’interpolazione o confusione nell’interpreta-zione dei dati da parte dei Tuscanesi nell’intento di acqui-sire un tradizione agiograica e conseguentemente un culto devozionale a loro estraneo.Infatti le tradizioni agiograiche sia cornetane sia tuscanesi
25 Per il testo della lamina si riporta la trascrizione bollandista contenuta nel Commentarius Praevius: Anno D(omi)ni CCCCC-CXLVIIII Indict(ione) VI corpora s(an)ctorum Se(cundiani). Vi(riani) Mar(celliani) et D(e)od(ati). a domo S(an)ctorum tra-slata sunt in civitate Toscana: PALLOTTINI 2011, pp. 117-118 nota 7; TIZI 2010, p. 3; TIZI 2011, p. 67. Da sottolineare che i tre martiri sono tuttora i patroni della città e come sottolinea Tizi l’assunzione contemporanea di tre patroni è l’unico caso che si veriica nella Tuscia: Tizi, 2011, p. 63.26 TONICCHI 2007, p. 98.27 TIZI 2010, p. 3 in part. nota 1 con bibliograia precedente; TIZI, 2011, p. 66.28 Si deve considerare inoltre che la notizia della traslazione com-pare a partire dal XVI secolo negli scritti di Francesco Giannotti e di Paciico Pellegrini: SUSI 2007, pp. 210-212.29 www.comune.pisa.it/museo/moplug-in/Iba-090/paragrafo2.html30 PALLOTTINI 2011, pp.117-118 nota 7. Le sacre spoglie dei martiri rimasero nella chiesa di S. Pietro ino al 1618, anno in cui vennero trasportate nella Chiesa di S. Lorenzo; inine nel 1983 l’urna venne riposta nella cappella della Cattedrale di S. Giacomo: LEONARDI 2003 p. 28.31 IBIDEM32 FIOCCHI-NICOLAI 1988, p. 90 con bibliograia preceden-te; TONICCHI 2011, p. 98.33 Cfr. le placchette plumbee nella Chiesa di S. Pietro in Vincoli a Pisa per la reposizione delle reliquie nei due altari ad opera dell’arcivescovo Pietro nel 1118: www.comune.pisa.it/museo/moplug-in/Iba-090/paragrafo2.html
collocano a diversi secoli dalla morte di Secondiano e com-pagni l’origine del patronato sulle loro città34 e per questo si assiste a creazioni ad hoc tali da giustiicarne il culto ri-vendicandone il primato. Il processo, iniziato già dal me-dioevo, tende ad identiicare il santo con la città secondo un’ottica di religione civica35.Resta da capire come mai questo culto il cui epicentro è sta-to localizzato a Graviscae e che nei secoli successivi assume un’importanza tale da identiicare S. Secondiano nel Co-mune stesso sia passato a Tuscania che ne rivendica l’origi-ne in base alla presunta autenticità delle reliquie collocate anticamente nella chiesa di S. Pietro. L’episodio della traslazione a Tuscania non è menzionato nella Passio ma è narrato da scritti successivi. Il testo più antico a riguardo fu redatto dal tuscanese Francesco Gian-notti tra il 1560 e il 159036. Il manoscritto, ora perduto, del domenicano viterbese Paciico Pellegrini risalente anch’es-so alla metà del XVI secolo, a cui attinsero tutti gli scritti successivi del XVII e XVIII secolo, tra cui il Commentarius Praevius degli Acta Sanctorum37, aggiunge ex novo all’epi-sodio della traslazione la notizia della matrona cornetana che trafugò una parte delle reliquie38. Da ciò si deduce che l’intromissione della igura evergetica della matrona, che provvide alla costruzione di una chiesa intitolata a S. Se-condiano dove conservare la santa reliquia39, costituì un’ag-giunta intenzionale di “matrice cornetana” alla preesistente tradizione tuscanese40.
34 Da sottolineare che la contesa delle reliquie e del primato del culto di Secondiano e compagni compare con il testo sulla trasla-zione riportato nel Commentarius Praevius. In esso Susi ha rico-nosciuto la costruzione di una memoria agiograica condivisa da Corneto e Tuscania: SUSI 2007, pp. 209-216.35 GUFI 2007, pp. 307-308.36 SUSI 2007, p. 212.37 TONICCHI 2011, pp. 89-100. Il testo del Commentarius narra che... i corpi dei martiri, inizialmente sepolti da Deodatus in un luogo oscuro, furono trasportati a Centumcellae e conservati sotto un insigne altare dove riposarono 70 anni. In seguito alla distruzio-ne della città, gli stessi martiri apparvero in sogno ad un prelato di Norchia che riferì il prodigio al vescovo di Tuscania. Per redimere la contesa sulle reliquie tra Centumcellae e Tuscania, il vescovo de-cise di aidare i corpi a due giovenchi indomiti e stabilì che i santi avrebbero trovato la loro deinitiva dimora nel luogo in cui i gio-venchi si fossero fermati. Giunti a Corneto si fermarono a Fontana Nova, dove una matrona prese un dito dalle mani di S. Secondiano esponendolo in una chiesa da lei costruita in onore del martire e che esiste tutt’ora...La narrazione prosegue con la traslatio alla chiesa di S. Pietro in Tuscania. Il racconto della traslazione anche in Polidori, storico tarquiniese del XVII secolo, il quale narra del particolare del braccio: SUSI 2007, pp. 209-210.38 SUSI 2007, pp. 210-215.39 Secondo Polidori, la reliquia sottratta venne posta invece nella chiesa di S. Giovanni Crisostomo. Queste discrepanze potrebbe-ro rivelare che, perduto il testo originario del Pellegrini, il raccon-to della traslazione possa essere giunto agli agiograi già interpo-lato: SUSI 2007, pp. 211-212.40 SUSI 2007, pp. 214-215. A questo proposito da ricordare che la Congregazione dei Riti uicializzò l’episodio della matrona in
71
L’episodio ebbe così il compito di ribadire una devozione graviscana che afondava le sue radici già nella Passio di Se-condiano e compagni, cronologicamente lontana, in quan-to composta come abbiamo visto fra la metà e la ine del VI secolo,41 mentre il passaggio del culto a Tuscania sarebbe avvenuto verso la ine dell’ XI secolo in seguito all’atteggia-mento ostile al culto da parte dei monaci di Farfa42. Insedia-tisi a Corneto con l’intenzione di esercitare il monopolio e controllo su Graviscae e il suo porto, tentarono di cancella-re la devozione verso S. Secondiano il quale oramai, dive-nuto protettore dei naviganti, costituiva il simbolo sacrale dell’ attività commerciale e marittima della città43. Questa situazione risultava in contrasto con gli interessi e le strate-gie economiche del monastero farfense che a quel tempo esercitava, attraverso il possesso dei porti di Santa Severa, di Columnae e di Civitavecchia, un capillare controllo sulla navigazione costiera dell’Etruria Meridionale44. Il trasferimento delle reliquie a Tuscania45 avvenne proba-bilmente in questa temperie storico-economica sotto l’egi-da del sacro, con l’intento di consegnare alla città, assieme alle spoglie, anche un culto martiriale di cui era priva46.In questo periodo potrebbe quindi collocarsi anche la reda-zione del testo epigraico su lamina plumbea, una sorta di “autentica” delle spoglie martiriali, retrodatata al 64847.
quanto nel 1609 venne reso noto il ritrovamento del braccio di S. Secondiano nella Chiesa di S. Giovanni Crisostomo: SUSI 2007, pp. 214-215. In questo modo si compì deinitivamente l’artiicio cultuale da parte della Chiesa di Corneto.41 SUSI 2007, pp. 219-225.42 SUSI 2007, pp. 220-225. 43 IBIDEM: secondo lo studioso la Passio costituì un mezzo per uicializzare il forte legame devozionale che univa Graviscae a Se-condiano e nello stesso tempo per raforzare sul piano cultuale la linea difensiva bizantina, una sorta di sacralizzazione territoriale in previsione di un futuro conronto con gli ariani Longobardi rite-nuto ormai imminente: SUSI 2007, p. 219.44 SUSI 2007, pp. 221-223. 45 Ovviamente “l’esportazione” del culto a Tuscania non cancel-lò la pratica devozionale nei confronti di S. Secondiano da parte della città di Corneto a sostegno della quale annotiamo, per mag-giore chiarezza, l’inserimento da parte dei cornetani del furto della reliquia nella versione tuscanese della traslazione passata ai Bollandisti (vedi supra note 36, 37) . 46 SUSI 2007, p. 223, in part. nota 95. Da ricordare a questo pro-posito l’iscrizione collocata all’interno della chiesa di S. Maria Maggiore menzionante la traslazione dei corpi di 23 martiri av-venuta sotto il pontiicato di Lucio III (1181-1185) a testimo-nianza della grande difusione del culto dei santi a Tuscania in epoca medievale: PALLOTTINI 2011, pp. 102-103. Ma con-trariamente a questa schiera numerosa di martiri dalle origini oscure ed incerte (vedi LANZONI 1927, p. 527) Secondiano e socii probabilmente erano gli unici ad avere un sostrato storico – devozionale su cui fondare l’identità civile e religiosa della città.47 Anche l’epigrafe mutila conservata nell’Archivio Ecclesiastico del Duomo di S. Giacomo Maggiore a Tuscania deve essere consi-derata al pari della placchetta di piombo un altro “falso d’autore” dell’XI-XII secolo: l’iscrizione commemorativa ricorda la sepol-tura dei corpi di Secondiano e compagni dal primitivo luogo del martirio a Centumcellae, anno domini 332. In base alla paleogra-
Questa ipotesi sarebbe avvalorata al fatto che mentre alcuni documenti risalenti alla metà dell’XI secolo 48 nel ripren-dere la Passio di S. Secondiano non fanno minimamente riferimento alla traslazione a Tuscania, quest’ultima ap-pare invece come un dato di fatto nelle narrazioni succes-sive, come nel duecentesco passionario di Orvieto, da cui si evince che “le spoglie dei martiri un tempo sepolte iuxta locum ubi decollati sunt erano venerate in ecclesia beati Petri apostoli in civitate Tuscana”49.L’ipotesi della rifondazione cristiana di Tuscania nel VII secolo e della nuova sacralizzazione del colle di S. Pietro che aveva visto iorire il culto delle divinità pagane 50 andrebbe quindi ridimensionata nel tempo, nell’ottica di una dedi-cazione a S. Secondiano della chiesa di Tuscania alla ricerca di una apostolicità atta ad ampliicare il proprio ruolo reli-gioso e politico51. In ultima analisi il culto dei santi, sorto in età tardo antica e altomedievale, a partire dall’XI-XII secolo assume i carat-teri di un vero e proprio patrocinio religioso nei confronti dei centri cittadini e le memorie agiograiche, ricomposte o create ex-novo, vengono utilizzate in vista di un consolida-mento del potere diocesano e vescovile delle chiese locali la cui eccellenza e antichità nell’organizzazione ecclesiastica del territorio è garantita dalla presenza dei corpi venerati 52.Alla luce di quanto scritto l’ipotesi che vede Secondiano, Veriano e Marcelliano martiri castronovani è destinata a scomparire. Pur ammettendo un errore di trascrizione delle miglia e issando il luogo del martirio nel sito dell’odierna S. Marinella al quarantaduesimo miglio da Roma, ci trove-remmo davanti ad un grosso punto interrogativo: come mai non è rimasta nessuna memoria dei tre martiri nella storia del luogo? Il silenzio delle fonti, l’assenza di una tradizione locale aferente al culto si aggiungono alla mancanza di dati monumentali cristiani, gli unici forse che potrebbero resti-tuire a Castrum Novum i suoi santi perduti.
Alessandra Squaglia
ia e al formulario potrebbe datarsi al XII secolo: PALLOTTINI 2011, p. 118, nota 8. L’iscrizione doveva costituire probabilmen-te l’antefatto storico “certiicato”, preludio alla traslazione a Tu-scania issata in epoca altomedievale.48 Così per esempio nel Codice Amiatino II in cui conluì la Passio di S. Secondiano che i monaci di San Salvatore del Monte Amiata, presenti a Tarquinia già dal IX secolo, trascrissero nei loro Passionari: SUSI 2007, p. 220, spec. nota 70, 71.49 SUSI 2007, pp. 223-224.50 TIZI 2010, pp. 3-7.51 A questo proposito è bene sottolineare l’esistenza di una tradi-zione tuscanese secondo la quale un certo vescovo Paolino venne inviato dall’apostolo Pietro a Tuscania dove, come testimone di fede, subì il martirio: SUSI 2007, p. 223 nota 95. La data del 648 forse venne scelta per sottolineare il ruolo di caposaldo cristiano di Tuscania, divenuta sede vescovile a partire dalla ine del VI se-colo, tra il tardo antico e il medioevo: cfr FIOCCHI NICOLAI 1988, pp. 90-93; DEL LUNGO 1999, p. 43; TIZI, 2011, p. 66.52 GUFI 2007, p. 307-310, in part. nota 1 p. 307.
72
3.1 La frequentazione dell’area portuale dell’antica Castrum Novum:
nuove testimonianze dal fondale
Nel corso degli anni 2011-2013 le ricognizioni subacquee efettuate dal Centro Studi Marittimi nello specchio di mare antistante l’antica città di Castrum Novum, tra il Capo Linaro e la grande peschiera, hanno portato alla scoperta di numerosi materiali archeologici sparsi sul fondale, ino alla
Fig. 1. a) Foto e disegno della spada dell’età del bronzo rinvenuta a Capo Linaro b) Frammento di ansa in impasto non tornito prove-niente dal fondale.
profondità di circa 7 metri1. L’area interessata dalla ricerca coincide con lo specchio di mare sito subito a ridosso del capo roccioso che scherma verso Scirocco e in parte anche da Libeccio quella che dovette essere la rada portuale della città antica. Nonostante il saccheggio in atto da decenni ad opera di bagnanti e subacquei, il patrimonio archeologico sommerso di Castrum Novum si rivela ancora cospicuo ed interessante ai ini della ricostruzione storica della fre-quentazione del sito marittimo. La forte erosione in corso da parte delle correnti sta demolendo lo strato di “matta” che per secoli ha inglobato e protetto i materiali giacenti sul fondale. Tale attività erosiva, dopo ogni mareggiata, sta portando in luce sempre nuovi reperti che in assenza di un controllo sistematico rischiano di essere distrutti dal moto ondoso o asportati in maniera illecita.Tra i materiali recuperati si segnalano alcuni frammenti di ceramica in impasto non tornito riferibili a frequentazioni di epoca pre-protostorica alle quali è attribuibile anche il rinvenimento dell’importante spada in bronzo segnalata nel 2011, databile nell’età del bronzo recente con confronti dal lago di Mezzano: di fatto la più antica spada rinvenuta ino ad oggi nel mare Tirreno2 (Fig. 1). Molto interessante si rivela anche la presenza etrusca di epoca arcaica e tardo arcaica, documentata da numerosi frammenti di anfore in impasto, attribuibili alle forme Py 3 e Py 4 (Fig. 2), da ceramiche di tipo attico, da un’inte-ressante ansa con igura di sirena in bronzo di produzione etrusca (Cfr. p. 79), da un bacino con orlo a fascia e da un frammento architettonico in impasto chiaro sabbioso de-corato con kymation ionico (Fig. 3).
1 Negli anni 2012-2013 hanno partecipato alle ricerche del Cen-tro Studi Marittimi, coordinato dal Dott. Stefano Giorgi, i soci GATC Mauro Giorgi, Marco Fatucci, Alberto Borruso, Paolo Marini, Alessandro Dondolini, Mauro Montagnoli, Gabriella Petrauolo, Franco Rosati, Fabio Papi, Giuliana Fenicoli, Giorgio Brocato, Valentina Asta2 Per la spada dell’età del bronzo Enei 2011, p. 28; Enei 2013 a c.s.
3. La ricerca nelle acque di Castrum Novum: studi e rinvenimenti
ba
73
0 5 10 cm
Signiicativa anche l’attestazione di anfore di tipo punico (Fig. 4) e forse di un esemplare di anfora ionio-massaliota (Fig. 5). All’approdo di Castrum Novum può essere ben collegato anche il ritrovamento di una statuetta votiva di divinità femminile in trono, avvenuto ad opera di pesca-tori subacquei sul fondale immediatamente a sud di Capo Linaro, circa mezzo miglio al largo dell’attuale porticciolo denominato “La Gatta” (Fig. 6). Della igura femminile, se-duta frontalmente su un trono con larga spalliera ad estre-mità sporgenti e arrotondate, si conserva soltanto la parte superiore del corpo, tra la testa e l’addome. La donna in-dossa un peplo con un basso polos con lungo velo ricadente sulle spalle. Il volto si presenta ovale allungato con occhi in evidenza e piccola bocca chiusa; acconciatura a ciocche sul-la fronte e trecce ricadenti sulle spalle al lato del viso, seni ben accennati e braccia distese lungo il corpo. Si tratta di un ex voto realizzato a matrice, di probabile fab-bricazione magnogreca (Sicilia) di epoca tardo arcaica (ine VI inizi V secolo a.C.). La dea potrebbe essere identiicabile con Hera o con Demetra-Kore. Il frammento attesta il tran-sito di navi con a bordo prodotti dell’Italia meridionale e il possibile naufragio di una di esse nelle acque antistanti Capo Linaro.
In fase con la deduzione della colonia romana di Castrum Novum, intorno al 264 a.C., possono essere datati i nume-rosi frammenti di ceramiche a vernice nera pertinenti a coppe e piatti di varie forme (Cfr. p. 82) alcuni con stam-pigli a rosetta e palmetta. Diversi pescatori locali ricordano negli anni Sessanta del Novecento l’esistenza di una forte concentrazione di anfore e ceramiche a vernice nera in un punto del fondale prossimo alla scogliera del porticciolo moderno, a nord della grande peschiera. Potrebbe trattarsi dei resti del naufragio di una nave di epoca romana repub-blicana. Tra il III e il I secolo a.C. il punto di approdo risulta ben frequentato come testimonia la presenza di anfore del tipo greco-italico attribuibili alle forme MGS V e VI (Fig. 7 nn. 1 - 3) e del tipo Dressel 1. Eccezionale per questa fase il rinvenimento di un paraguance in bronzo pertinente ad un elmo del tipo Montefortino, databile con buona certezza in epoca repubblicana (Cfr. p. 81). A frequentazioni di epoca augustea e primo imperiale sono, invece, attribuibili diversi frammenti di ceramiche comuni da mensa, sigillate italiche lisce e sud galliche decorate (Fig. 9; Cfr. p. 83) e anfore del tipo Dressel 2/4 (Fig. 8 nn. 1, 2). La presenza sul fondo di alcune lastre di rivestimento in piombo, con ancora in situ chiodi in bronzo e ferro, ceppi di ancora e contromarre in piombo segnalano anche in questo caso i resti di altri possi-bili naufragi avvenuti in prossimità della costa nell’ambito della rada portuale (Fig. 10). Per la fase pienamente impe-riale, tra il II e il III secolo d.C., sono attestate coppe in si-gillata africana e ceramica africana da cucina con le tipiche patine cenerognole ed orli anneriti.
Fig. 2. Frammenti di anfore etrusche tipo Py 3 e Py 4 dal fondale di Castrum Novum (nn. 1-5).
1 2
3
4 5
Fig. 3. Frammento di terracotta architettonica etrusca di probabile epoca tardo arcaica.
74
Ben presenti i resti di anfore di produzione spagnola con le forme Haltern 70 e Dressel 20, gallica (Pelichet 47) e afri-cana con le forme “Africana piccola” e “Africana grande” (Fig. 11). Tra i reperti più interessanti attribuibili alla fre-quentazione del porto tra il I e il II secolo d.C., si segnala il rinvenimento di un balsamario ovoide in bronzo, probabile suppellettile da bagno, giacente isolato sul fondale a breve distanza dalla costa (Cfr. p. 80), la parte superiore di un’an-fora con iscrizione graita POTITI su un lato della spalla e la sigla AM sull’altro (Fig. 11 nn. 1-3). La presenza di epoca tardo imperiale è ben documentata da una moneta caduta sulla spiaggia dalla sezione del terreno esposta dall’erosione marina, ad oggi la più tarda moneta rinvenuta a Castrum Novum. Si tratta di un Nummo o frazione di Follis che, nonostante la cattiva conservazione del dritto, è possibile attribuire all’imperatore Costanzo II e datare tra il 355 e il 361 d.C., grazie al rafronto fra le tipologie del rovescio ben leggibile e gli stili del ritratto (Fig. 12 n. 7).
Inine, le prospezioni subacquee hanno documentato la presenza di attività anche nella tarda epoca imperiale, ino ad almeno tutto il V secolo d.C. Frammenti di anfore cilin-driche africane tipo Keay XXV, Spatia, un’egiziana bitron-coconica (Fig. 11 n. 8) e anfore di grandi dimensioni at-testano ancora la frequentazione tardo antica dell’approdo (Fig. 12, nn. 1-3), confermata dal ritrovamento di un gran-de piatto in sigillata africana di produzione D1 con decora-zione a stampo, attribuibile alla forma Hayes 59 databile tra il 320 e il 420 d.C. (Fig. 12 nn. 4, 5) e da una lucerna tardo romana anch’essa di produzione africana (Fig. 12 n. 6).I dati raccolti testimoniano una lunghissima frequenta-zione dello specchio di mare protetto dal Capo Linaro, dall’epoca preistorica a quella tardo antica, senza soluzione di continuità. Molto interessante appare la presenza etrusca che confer-ma, nel VI e V secolo a.C., l’utilizzo dell’area portuale per le navi impegnate nei traici facenti capo alla metropoli di Caere. In questo caso i numerosi rinvenimenti sottomarini, dovuti all’ancoraggio temporaneo e a probabili naufragi di imbarcazioni di epoca arcaica, consentono di poter ra-gionevolmente ipotizzare l’esistenza di un insediamento costiero sito subito a ridosso della rada portuale, necessa-rio per ovvi motivi di controllo, di assistenza e di gestione delle attività marittime. Purtroppo allo stato attuale delle ricerche soltanto labili tracce sono aiorate sulla terrafer-ma: alcuni frammenti di bucchero e di ceramica in impasto rosso bruno, nonché qualche frammento di tegole di I fase sono stati rinvenuti nelle aree in corso di scavo lungo la via Aurelia (Cfr. p. 23). Tuttavia, nonostante l’attuale scarsità di documentazione disponibile sulla costa, sono proprio le notevoli scoperte avvenute sul fondale che consentono di avanzare l’ipotesi che anche nel caso di Castrum Novum, così come in quelli di Pyrgi e di Alsium, la colonia marit-tima romana sia stata dedotta esattamente sul luogo di un preesistente sito portuale ceretano. Si ritiene molto pro-babile che il castrum del III secolo a.C. possa essere stato costruito sul rilievo che domina la spiaggia, presso l’attuale Casale Alibrandi, occupando con l’insediamento militare il luogo del precedente abitato etrusco. Soltanto futuri scavi ed indagini scientiiche sistematiche sul terreno potranno confermare o meno tale ipotesi che
Fig. 4. Frammenti di anfore di tipo punico dal fondale (nn. 1-4)
1 2 3 4
Fig. 5. Puntale di probabile anfora ionio-massaliota.
75
vedrebbe la colonia romana sovrapporsi in modo diretto all’antichissimo Castrum Inui, così come indirettamente ricordato dai versi di Rutilio Namaziano: “Stringimus...Castrum...Multa licet priscum nomen deleverit aetas, hoc Inui Castrum fama fuisse putant” (Rut. Nam. I, 231 - 232).Di particolare interesse si rivela anche la successiva lunga frequentazione di epoca romana che, dal III secolo a.C. si protrae per circa 800 anni, almeno ino al V secolo d.C. Le anfore e la sigillata africana rinvenute sul fondale atte-stano la presenza di imbarcazioni che ancora tra il IV e il V secolo d.C. transitano e ormeggiano nello specchio d’acqua riparato, subito prospiciente la città. Si tratta di una fase in cui l’abitato castronovano doveva apparire in forte deca-denza e in parte abbandonato, così come lo descrive Ruti-lio Namaziano che intorno al 416 d.C., passando via mare dinanzi alla città, la ricorda semidistrutta dal mare e dagli anni, con un’antica porta ancora in piedi, presidiata da una statua del dio Pan3. Nonostante la situazione di degrado e spopolamento del centro urbano segnalata da Rutilio, i re-perti rinvenuti sul fondale attestano ancora per tutto il V e forse anche nel VI secolo la presenza nel porto di navi e di attività. Sulla base dei dati resi disponibili dalle ricerche subacquee, è lecito ipotizzare che la rovina deinitiva della città di Ca-strum Novum e del suo approdo sia da collocare nell’ambi-to del VI secolo d.C., forse come conseguenza diretta delle distruzioni e delle pestilenze causate dalla grande tragedia delle Guerre Greco-Gotiche che vide il porto di Centum-cellae e il suo litorale al centro di aspri scontri militari4.
3 Rutilio Namaziano I, versi nn. 227-2364 Da ultimo Enei 2013, pp. 348-350
Fig. 6. Statuetta votiva di divinità femminile di fattura magnogreca dal fondale di Capo Linaro
Fig. 7. Anfore di tipo greco-italico (MGS V e VI) dal fondale di Castrum Novum (nn. 1-3)
1
2
3
76
In conclusione, le nostre nuove prospezioni hanno permes-so, per la prima volta, di documentare l’intensa frequenta-zione della rada, senza dubbio protrattasi per millenni, tra
l’età del bronzo e l’epoca moderna, con particolare in-tensità in epoca etrusca e romana.Alla luce delle indagini svolte, il promontorio di Capo Linaro si rivela un elemento geograico di par-ticolare rilevanza per le coste dell’antica Etruria aven-
do costituito senza dubbio un importante punto di riferimento topograico per i naviganti di tutte le epoche, a partire dalla lontana preistoria ino quasi ai giorni nostri. La sua forma, oggi molto ridimensionata dall’erosione conse-guente all’innalzamento del mare, ancora in epoca etrusca e romana doveva protendersi verso il largo per altre diverse centinaia di metri rispetto all’attuale battigia. L’originaria conformazione “a falce di luna” deve aver oferto per secoli un sicuro riparo per i naviganti ma anche un serio pericolo a causa degli insidiosi bassi fondali che si trovano dinanzi alla sua estremità afacciata sul mare. Da ultimo, a proposito del nome del promontorio, detto Linaro già in documenti del XIII secolo (Cfr. p. 90), vale la pena considerare anche l’ipotesi che il toponimo abbia un’origine risalente all’epo-ca romana. Sul promontorio, anticamente curvato a forma di mezzaluna (lunatus), potrebbe essere esistito un luogo di culto dedicato alla dea Luna, dalla quale il nome Luna-rius. Potrebbe essere all’origine del nome anche il semplice termine linarius, riferibile alla presenza in loco di attività specializzate nella produzione e lavorazione del lino, per le vele e per il cordame navale. Esistono anche diverse altre possibilità: molto suggestiva anche l’ipotesi che il nome possa derivare da quello del proprietario della villa afacciata sulla rada portuale, alla quale appartiene il balneum in corso di scavo (la villa delle Guardiole, Zona A settore I): un personaggio il cui cogno-me Lunensis è conservato sulla istula aquaria rinvenuta quest’anno durante lo scavo dell’impianto termale. Tra le varie possibilità di identiicazione spicca quella del senatore Marco Clodio Lunense, console sufecto nel 105 d.C., un eminente e ricco dominus al quale potrebbe essere apparte-nuta la villa marittima con la relativa terma, tra la ine del I e gli inizi del II secolo d.C. (Cfr. p. 5). Da ultima, e non meno suggestiva, anche l’ipotesi che il nome Linaro possa derivare dalla corruzione del toponimo Inuarius (Linarius - Linaro), possibile denominazione originaria del promon-torio (Caput Inuarius) dove, prima delle deduzione della colonia di Castrum Novum, era situato l’antichissimo inse-diamento di Castrum Inui, il cui nome già in epoca romana era stato “cancellato dal tempo” come ben ricordano i versi di Rutilio (Rut Nam I, 231-235).
Flavio Enei
Fig. 8. Colli di anfore tipo Dressel 2/4 (nn. 1-2).
1 2
Fig. 9. Frammento di coppa in sigillata sud gallica decorata dal fondale. Rimane parte di una scena con un personaggio che brandisce un pugnale verso la schiena di un uomo con le mani legate dietro. Probabile scena di sacriicio di un prigioniero. Sulla sinistra parte del cartiglio rettangolare con irma non leggibile.
Fig. 10. Parti di lastre plumbee di rivestimento di scai navali. Ben visibili i fori dei chiodi di issaggio, alcuni in bronzo e ferro ancora in posto (nn. 1, 2)
77
1
2 3
4
5
6
7
8
Fig. 11. Frammenti di anfore romane provenienti dal fondale di Ca-strum Novum: parte superiore di anfora priva di orlo, probabile for-ma Dressel 7/11, con iscrizioni graite sulla spalla (AM – POTITI) (nn. 1-3); parte superiore di anfora gallica tipo Pelichet 47 (n. 4); collo di anfora spagnola tipo Haltern 70 (n. 5); rammento di orlo di anfora spagnola tipo Dressel 7/11 (n. 6); collo di anfora spagnola tipo Keay XIX (n. 7); collo di anfora egiziana bitroncoconica forma Eglof 172 (n. 8).
78
Fig. 12. Materiali di epoca tardo antica dal fondale di Castrum Novum: 1) parte superiore di spateion di produzione aricana forma tipo Keay XXV, 2; 2) anfora cilindrica aricana, tipo Keay XXV; 3) anfora aricana cilindrica di grandi dimensioni tipo Keay LV, b; 4, 5) scodella in sigillata aricana di produzione D1, forma Hayes 59 (Atlante Tav. XXXIII n.4) con decorazione a stampo a rami di palma con rosetta centrale e bacche all’intorno (Atlante Tav. LVIIb n. 64; Tav. LVIIIb n. 63); 6) fondo di lucerna in sigillata aricana (Atlante Tav. CLX, forma X); 7) moneta ( razione di Follis) dell’imperatore Costanzo II con al dritto busto dell’imperatore diademato a destra e scritta illeggibile; al rovescio l’imperatore in abiti militari a sinistra con globo e lancia; nell’intorno “Spes Reipublicae”, segno di zecca illeggibile. Peso g. 1,7. diametro 14,50 mm. Probabile zecca di Costantinopoli. Data 355- 361 d.C. (Inventario n. 24). Bibl.: RIC vol. VIII Costanzo II London 1981.
1
2
3
4
5
6
7
79
3.2 Un’ansa in bronzo etrusca con igura di sirena
Ritrovata nel settembre 2011, nel mare davanti a Castrum Novum. nell’ambito del territorio controllato in epoca etrusca dall’abitato della Castellina del Marangone1.
Misure: alt. 22 cm; attacco: alt. 6,4 cm; largh. 4,2 cmPatina: dal verde chiaro al verde nerastro, molto ruvida; con le bolle di corrosioni si stacca immediatamente l’epi-dermide originale com’è già successo in gran parte.Resti della lamina della brocca stessa a tergo dell’attacco in-feriore il quale è congiunto tramite saldatura.
L’ansa, nella sezione ret-tangolare sino a quadrata, è faccettata e mostra come attacco inferiore la igura di una sirena a quattro ali falcate vista dal basso - che signiica probabilmente il volo - con i piedi di uccello e le braccia umane piegati davanti alla coda rispettiva-mente al petto. La sua testa è incoronata da un diadema e dalle itte ciocche cadenti sulle spalle. La sirena porta un vestito con scollatura a V e probabilmente con mani-che che iniscono ai gomiti. Le mani sono incurvate ad artiglio come segno della ferocità dell’essere2. Il motivo della sirena come attacco di ansa è uno dei più popolari per brocche come le “Schnabelkannen” di tipo Jacobsthal-Langsdorf3 o quelle del tipo Krauskopf
1 Per gli scavi sulla Castellina del Marangone e sulle sue necropoli v. Prayon – Gran-Aymerich, Castellina del Marangone (Co-mune di S. Marinella, Prov. Roma). Vorbericht über die deutsch-französischen Ausgrabungen in der etruskischen Küstensiedlung (1995-1998), RM 106, 1999, pp. 343-364; J. Gran-Aymerich – A. Dominguez-Arranz (ed.), La Castellina a sud di Civitavec-chia: origini ed eredità (Roma 2011). www.uni-tuebingen.de/CASTELLINA/nekropolen.htm Per Castrum Novum v. Enei et ali, Castrum Novum. Quader-no 1, 2011.2 Cfr. i coperchi di urne a pietra fetida: Cristofani, Statue-cinerario chiusine di età classica, Roma 1975, cat. n. 12 tav. 29 e cat. n. 25 tav. 6. 3 P. es. brocca a Firenze Cristofani, Etruschi. Cultura e società, Novara 1978, ig. a p. 55. In generale D. Vorlauf, Die etruski-schen Bronzeschnabelkannen. Eine Untersuchung anhand der technologisch-typologischen Methode, Espelkamp 1997, pp. 103-105: dall’ultimo terzo del VI a tutto il V sec. a.C.
(Beazley tipo VI)4, databile nel V sec. a.C. Il confronto con altri prodotti etruschi come le anse di brocche a orlo rotondo (for-ma IX) porta alla stessa datazione5. L’attribuzione a un tipo speciico di brocca non è equivoca: la forma generale dell’ansa, molto sollevata ri-spetto all’imboc-catura e rincurva-ta, fa pensare alla forma IX a bocca rotonda la quale però ha un attacco superiore fucinato in forma appiatti-ta, issato con due perni6. Il issaggio che segue la forma dell’orlo con una zona di contatto per la saldatura molto limitata collega l’ansa ai kyathoi a rocchet-to. I kyathoi a rocchetto, normalmente di misura limitata - pure a imboccatura rotonda - mostrano manici issati a saldatura o a getto, però senza attacco igurativo7. Così si potrebbe pensare ai kyathoi tipo Montefortino di una certa grandezza8. Forse la forma più probabile è questa delle olpai raccolte da Weber.9 Probabile è anche un’attribuzione a brocche a imboccatura trilobata di un tipo con tre lobi analoghi orientati in un pia-no unico10. V secolo a.C. Etruria meridionale.
Fritzi Blank
4 Jurgeit, Die etruskischen und italischen Bronzen sowie Ge-genstände aus Eisen, Blei und Leder im Badischen Landesmu-seum Karlsruhe (Pisa – Roma 1999) n. 624: brocche di questo tipo ibid. pp. 379 sg.5 Forma IX secondo Beazley che però normalmente hanno un attacco superiore issato con due perni (esemplari Karlsruhe nn. 646-656).6 Ultimamente Bellelli, Artigianato del bronzo e contesti produttivi. Bilancio etrusco-campano, in Orizzonti 3, 2002, pp. 29-52; Sannibale, La raccolta Giacinto Guglielmi II Bronzi e materiali vari, Roma 2008, pp. 118 sgg. n. 68. 7 Jurgeit cit. pp. 421 sgg. nn. 693-728.8 Husty, TrZ 53, 1990, pp. 20 sgg.; Jurgeit cit. n. 516. La data-zione di questi vasi scende ino al IV sec. a.C.9 Weber, p. 390 III. B. Etr. Da chiarire è il caso del manico nel Vaticano, attribuito normalmente a una oinochoe della forma VI.10 Magi, La raccolta Benedetto Guglielmi nel Museo Gregoriano Etrusco II Bronzi e oggetti vari, Città del Vaticano 1941, nn. 35-36; Castoldi, Recipienti di bronzo greci, magnogreci ed etru-sco-italici nelle Civiche Raccolte Archeologiche di Milano. Not Milano Suppl. XV, 1995, cat. n. 47; Jurgeit cit. nn. 642 e 643.
80
3.3 Un unguentario in bronzo di epoca romana
Ritrovato nel 2011, nel mare davanti al Castrum Novumnell’ambito delle ricerche curate dal Centro Studi Ma-rittimi del Museo del Mare e della Navigazione Antica (GATC).Misure: alt. 12,0 cm; diam. spalle 6,5 cm; diam. imboccatu-ra 3,3 cm; alt. imboccatura 1,1 cm; diam. piede 4,2 cm. Pa-tina: dal verde chiarissimo al verde scuro con diverse incro-stazioni di origine marina; sulla parte inferiore e superiore dell’imboccatura sassolini e una lumaca marina; nel giugno del 2012 conservato ancora in acqua dolce (Fig. 1).Balsamario a forma ovoidale con la massima espansione sulla spalla, di un collo corto concavo, di un’imboccatura modanata e di una pancia che si restringe verso il piccolo piede ad anello; sulla spalla tracce di un attacco cuorifor-me con foro (diam. 0,2 cm); due centimetri sotto questo foro sporge, nel lato interno, un perno (diam. 0,2 cm; lungh. 0,3 cm). Questo ha avuto la funzione di tappare un’incrinatura formatasi durante la martellatura; dopo la riinitura al tornio, la riparazione non è stata più visi-bile. L’altra incrinatura, già preparata per l’inserimento di un perno, poteva essere coperta dall’attacco di uno dei due manichetti, saldati sul labbro e sulla spalla.Manca circa un terzo della lamina che costituì il corpo. Un fatto grazie al quale si ha la possibilità di vedere l’interno del vaso che con uno spessore di meno di un millimetro sicuramente fu tirato a martello e non fuso. Tutta la super-icie risulta levigata al tornio e inoltre elaborata: la parte esterna dell’imboccatura con due costolature accentuate ai bordi che ne rinchiudono due più sottili; un margine alla ine del collo; al lato esterno del piede un solco ino; sulla parte inferiore del piede intorno ad un punto centrale tre modanature spiccate.Somiglianze strette esistono con un esemplare a Toronto1 proveniente dalla costiera centrale israeliana (plain of Sha-ron), fuso (?) e elaborato al tornio con tre modanature sul piede. Il collo e il labbro presentano delle leggere modana-ture, inoltre anche la spalla. Sul suo punto più alto sono presenti due zone lanceolate, una con un piccolo perno, come tracce di due piccole anse verticali - solo incurvate2 o in forma di delino - per il issaggio di una catenella per il trasporto e di un’altra per collegare un piccolo tappo fu-so3. I due esemplari a Parigi sono originari della collezione Durand con probabile provenienza italiana4. Con una pro-venienza microasiatica (Madytos?) esistono due esemplari, tutti e due i balsamari senza tappi, nel museo di Kassel5.
1 Haynes, Greek, Roman, and Related Metalware in the Royal Ontario Museum. A Catalogue, Toronto 1984, p. 93 no. 146. 2 Tassinari, Il vasellame bronzeo di Pompei, Roma 1993, vol. II p. 91, 12199 e 3106.3 Cfr. l’esemplare al Musée du Louvre: De Ridder, Les bronzes antiques du Louvre. Vol. II Les instruments, Paris 1915, pp. 126 sg. no. 2912 tav. 102. n. 2913 (senza anse e tappo).4 De Ridder, Les bronzes antiques du Louvre. Vol. I Les igu-rines, Paris 1913, pp. 1sg. 5 Höckmann, Antike Bronzen. Eine Auswahl. Staatliche Kunstsammlungen Kassel, Kassel 1972, p. 39 tav. 28.
Dieci esemplari di aryballoi a ventre ovoidale provengono dagli scavi di Pompei, da varie insulae, altrettanto sette bal-samari a corpo sferico o aryballoi a ventre globulare6, un fatto che indica un uso contemporaneo di questi due tipi e, sulla base delle somiglianze tecniche, probabilmente una provenienza da oicine artigianali molto vicine che si colle-gano a forme greche. Per la forma sferica i legami con opere greche sono evidenti sia in bronzo7 che in vetro. Uno svi-luppo degli aryballoi a ventre ovoidale “from stoud to slen-der” inora non si può constatare8. Tutti e due i tipi, insieme a strigili e patere termali, facevano parte della suppellettile del bagno9. La datazione per tutti i confronti comprende il I e II secolo d.C., probabilmente iniziando già nel I secolo a.C.10
Fritzi Blank
6 Tassinari cit. vol. I pp. 48 sg. e pp. 209 sg. “brocche di piccole dimensioni: aryballoi”; vol. II, p. 90 tipo F 1100 “aryballoi a ven-tre globulare” e p. 91 tipo F 2110 “aryballoi a ventre ovoidale”.7 Comstock, Vermeule, Greek, Etruscan and Roman Bron-zes in the Museum of Fine Arts, Boston, Boston / Mass. 1971, n. 449 (da Beozia) e n. 480 (da Milo?). Colivicchi, Materiali del Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia XVI, Materiali in alabastro, vetro, avorio, osso, uova di struzzo, Roma 2007, n. 282.8 Brommer, Aryballoi aus Bronze in P. Zazof (ed.), Opus no-bile. Festschrit zum 60. Geburtstag von Ulf Jantzen, Wiesbaden 1969, pp. 17-23 tav. 4. Per le diicoltà dell’applicazione di questo teorema Cfr. Stibbe, C.M., he sons of Hephaistos. Aspects of the Greek Bronze Industry, Roma 2000, pp. 24 sg. 9 Dalle terme del Foro di Pompei: Pirzio Biroli Stefanelli (a cura di), Il bronzo dei Romani. Arredo e suppellettile, Roma 1990, p. 67 ig. 68. Tassinari cit. vol. II, pp. 142-146 tipo I 1000 – I 2000 “attingitoi da bagno”10 Per questa problematica Cfr. Tassinari cit. vol. I cit. pp. 213 sg.
81
3.4 Un paraguance di elmo romano
A circa 50 m a nord del relitto di Capo Linaro (Cfr. p. 83), a un centinaio di metri dalla costa su un fondale di -4,00 m costituito da sabbia e detriti, è stato rinvenuto fuori conte-sto un paraguance anatomico mobile in bronzo (paragnati-de, buccula), spesso 1 mm, alto 14 cm e largo 12 cm, perti-nente ad un elmo (Fig. 1). La forma anatomica è costituita da due sagomature a mezzaluna poste nella parte anteriore che permettevano di proteggere guance, zigomi e mento.
Fig. 2. Elmo tipo Montefortino, Museo Civico Archeologico di Bologna
Fig. 1a e b. I due lati del paraguance in lamina di bronzo
a
b
Quella posteriore, alquanto deteriorata, presenta una for-ma a curva addolcita e parte superiore in corrispondenza del casco terminante a punta. Nella parte bassa è presente un foro del diametro di 5 mm dove poteva essere inserito un bottone per il issaggio di una correggia di cuoio in funzione di sottogola, ed alme-no uno in alto per incernierarlo al casco vero e proprio del diametro di 3 mm, per mezzo di un anello o di un ribattino con striscia di cuoio. La classiicazione di questa parte di elmo, ad un primo esa-me, fa propendere per il tipo cosiddetto “Montefortino” (Fig. 2), di probabile tradizione etrusco-italica attribuibile al tipo C del Coarelli1, l’elmo più comune in uso nelle le-gioni romane tra il IV secolo a.C. ed il I secolo d.C. con la sua forma emisfero-conica (forse chiamato conum). Lo scarso spessore della lamina bronzea fa pensare o ad una fattura tarda dovuta all’elevata produzione dell’elmo, poi-ché i tipi più antichi sono costituiti da lamine più spesse, o ad un uso rituale o da parata o comunque non funzionale ad un evento bellico. Diicile, inine, per mancanza di un contesto, delineare la provenienza del reperto, se da un naufragio (del vicino re-litto di Capo Linaro?) o da un contesto terrestre, vista la sua giacitura in prossimità della riva, raggiunto dal mare in seguito all’innalzamento e al conseguente arretramento costiero.
Stefano Giorgi
1 Coarelli 1976, pp. 157-179
82
3.5 La ceramica dal fondale
L’attività di ricerca subacquea svolta negli ultimi anni dal Centro Studi Marittimi nella baia di Castrum Novum che da Capo Linaro doveva giungere sino al Fosso delle Guardiole1, ha portato all’individuazione e al rinvenimento di materiale archeologico di notevole qualità e fattura (Cfr. p.).I rinvenimenti sono avvenuti sia lungo il tratto di spiaggia corrispondente alla baia, sia in mare dove sono state avvi-state diverse “matte” (costituite da zolle dure di sabbia e limo compattati dallo sviluppo delle radici dell’alga della poseidonia) o cumuli di materiale archeologico a profondi-tà che raggiungono anche i dieci metri.Le principali classi ceramiche appaiono qui ben rappresen-tate da reperti che, concrezioni a parte, appaiono in buono stato di conservazione.A conferma di quanto rinvenuto nei settori I e II della zona A, anche in questa occasione la ceramica a vernice nera ap-pare ben attestata, in questo caso, da almeno due reperti molto ben conservati.Si tratta di una coppa con anse a doppio bastoncello della forma Morel 3131 b12, conservata per quasi la metà e data-
1 FRAU 1979; ENEI et alii 2011.2 MOREL 1981, pl. 87, p. 249
bile al II secolo a.C. (Fig. 1) e di una coppa rinvenuta quasi integra della forma Morel 2323 databile alla prima metà del II secolo a.C.3 (Fig. 2).Un terzo frammento di ceramica a vernice nera, non così ben conservato, è rappresentato da un fondo di coppa con piede ad anello assimilabile ad una forma genericamente ascrivibile al III secolo a.C.La ceramica sigillata è rappresentata da tre reperti, di cui due in buono stato di conservazione, rinvenuti per circa la metà della loro forma: i tre elementi rappresentano, al mo-mento, l’aspetto forse più interessante nel panorama cera-mico di questo sito per la loro provenienza e tipologia.I primi due, meglio conservati, corrispondono a due fram-menti di coppe: la prima, in terra sigillata sud-gallica, as-similabile alla forma Dragendorf 36 ed appare databile al I-II secolo d.C.;4 la seconda, una forma tarda di terra sigilla-ta nord-italica vicina alla forma Dragendorf 24/25 tipo A, risulta inquadrabile cronologicamente nella prima metà del I secolo d.C.5 (Fig. 3).Il reperto meno conservato è rappresentato da un fondo in sigillata aretina con piede ad anello, con bollo all’interno purtroppo non leggibile ed identiicabile solamente per la forma del cartiglio, un bollo in planta pedis, in uso a partire dalla ine dell’età augustea ino alla ine del I secolo d.C. Il restante materiale recuperato è costituito prevalentemente da reperti appartenenti alla classe della ceramica comune.Tra questi una parete di olla con ansa a nastro assimilabile al tipo 2 da Ponte di Nona e databile alla seconda metà del II secolo a.C.6, un’ansa con parte dell’orlo impostato alla sommità di essa riferibile ad una brocca-bottiglia del I seco-lo a.C. ed un orlo di olla sempre del I secolo a.C.Di notevole interesse, ma al di fuori del contesto ceramico, appare poi un elemento decorativo in marmo (una piccola anteissa?) del tipo a palmetta, rinvenuta lungo la costa per-tinente alla baia portuale (Fig. 6).Durante la redazione del presente Quaderno, le attività di ricognizione subacquee efettuate durante la stagione estiva hanno portato all’individuazione di ulteriori reperti appartenenti, genericamente, alla classe ceramica della terra sigillata.Il gruppo di reperti, dei quali in questo volume vengono presentate alcune immagini (Figg. 4, 5) mentre per la loro analisi si rimanda al prossimo Quaderno, appaiono da subi-to di notevole interesse ed in buono stato di conservazione; inoltre la presenza di bolli di diversa tipologia su alcuni di essi rappresenta un punto di partenza molto importante per un futuro studio sulle relazioni commerciali dell’antica Castrum Novum.
Luca Desibio, Paolo Marini
3 MOREL 1981, pl. 47, pp. 164-1654 OSWALD-PRICE 1920, tav. X5 CARANDINI 1981, tav. LIX, p. 1996 BERTOLDI 2011, p. 85
Fig. 1 Coppa in ceramica a vernice nera
Fig. 2 Coppa in ceramica a vernice nera con anse a doppio bastoncello
83
3.6 Il relitto della nave romana di Capo Linaro
Nel corso delle ricognizioni subacquee condotte dal Cen-tro Studi Marittimi del GATC nel tratto di mare antistante Castrum Novum e Capo Linaro nel 2013, è stato possibile rintracciare i resti del relitto di una nave romana, giacen-te a breve distanza dalla costa, in parte indagato dalla So-printendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale nel 1996-971 (Fig. 1). Lo scavo, condotto dal Dott. Roberto Petriaggi, fu realizzato dal Nucleo Sommozzatori dei Ca-rabinieri e da quello dei Vigili del Fuoco con l’ausilio dei tecnici dell’Istituto Centrale per il Restauro. Nella relazio-ne preliminare veniva sottolineato che solo la parte centrale del relitto (circa 10x5 m.) era stato oggetto dello scavo che aveva messo in evidenza un paramezzale largo ben 28 cm e 22 madieri larghi 12 cm e alti 20 cm, posti ad intervalli di 11 cm, uniti al sottostante fasciame con caviglie di legno e chiodi/perni in bronzo. Le tavole del fasciame, larghe ino a 40 cm e spesse 5 cm, erano unite con la tecnica a mortasa e tenone e spinotti (caviglie). Risultavano presenti, inoltre, due correnti di rinforzo, spessi 7 cm, larghi 20 cm e lunghi 3,15 e 2,00 m. Nel corso dello scavo furono rinvenuti alcuni materiali ceramici risalenti alla metà del I secolo d.C. tra i quali si segnala ceramica comune, sigillata sud-gallica e anse di anfore tipo Dressel 2/4, e poco lontano frammenti di do-lia. La struttura massiccia dello scafo ha fatto pensare ad una lunghezza dell’imbarcazione di circa 25 m (Figg. 2 - 6).Dopo circa 17 anni dalla scoperta, il relitto è stato ora ri-trovato nella sua posizione di fronte alle caratteristiche pa-laitte, a poche centinaia di metri dalla costa, a circa 2,40 m di profondità, molto deteriorato rispetto alle condizioni di conservazione all’epoca dello scavo. Le attuali emergenze consistono nei resti dello scafo che aiorano dal fondale sabbioso e ghiaioso sotto uno strato di “matta” spesso alcu-ne decine di centimetri.
Fig. 5
Fig. 6 Frammento architettonico in marmo con motivo a palmetta Fig. 1 Posizione del relitto romano di Capo Linaro
Fig. 3 Coppa in sigillata nord-italica decorata
Fig. 4
84
Figg. 3 -5 Immagini dei resti delle strutture lignee del relitto (da Anelli 2012)
Fig. 3
Fig. 4
Fig. 5
Fig. 2 Pianta delle strutture del relitto (da Anelli 2012)
85
Al paramezzale è aiancata una tavola del fasciame (torel-lo?) larga 35 cm, sono presenti 4 corsi di fasciame larghi 18 cm e spessi ben 5 cm; sopra questi compare una parte di madiere con foro di biscia quadrato da 5 cm di lato, arcua-to nella parte superiore certamente non molto lontano dal pozzetto di raccolta delle acque di sentina e dall’impian-to della pompa di espulsione (Fig. 8). A circa 8,50 m da questi resti emerge un altro tratto del paramezzale largo 28 cm e altre tavole pertinenti al fasciame dove sono ancora presenti alcuni spinotti di connessione per tenone e mor-tasa del diametro di 1,5 cm. E’ stato inoltre qui rinvenuto un perno di bronzo ancora inserito nel legno, lungo 11 cm, spesso 3 cm con testa tonda a forma biconica schiacciata del diametro di 5,5 cm (Fig. 9). Altri elementi dello sca-fo ritrovato consistono in alcuni madieri (almeno quattro) di dimensioni variabili (largh. 9-14 cm. e alt. 15/22 cm), distanti mediamente 11 cm l’uno dall’altro, sotto ai quali aiorano corsi del fasciame. Ulteriori resti lignei dello scafo giacciono certamente in situ sotto lo strato di sabbia e de-triti, mentre non risultano presenti forme ceramiche di ap-prezzabile importanza che possano ulteriormente datare il relitto. L’orientamento dei resti è all’incirca NO/SE (per-pendicolare alla costa) e allo stato attuale delle conoscenze non è ancora possibile riconoscere in quale direzione sia-no collocate la prua e la poppa. La struttura molto forte dello scafo e il ritrovamento di diversi frammenti di dolia a breve distanza dal sito potrebbero anche deporre a favore di un’ipotesi di identiicazione del relitto come pertinente ad una nave cisterna. Inine, la posizione dei resti, giacen-ti su un basso fondale, risulta di grande importanza per la deinizione dei limiti dell’antica area portuale di Castrum Novum e delle sue originarie caratteristiche topograiche. La nave sembra essere afondata a breve distanza dalla terra-ferma molto vicina all’antica linea di costa oggi sommersa, considerando l’innalzamento del mare di oltre un metro, veriicatosi tra l’epoca romana e i giorni nostri 2.
Flavio Enei, Stefano Giorgi
1 Una prima notizia della scoperta e delle operazioni di scavo in Petriaggi 1997, p. 5; un’ulteriore dettagliata descrizione del relitto in Anelli 2012, pp. 65-67.2 Per gli studi sulle variazioni del livello marino Lambeck et al. 2004a, pp. 1567-1598; Lambeck et al. 2004b pp. 563-575. Da ultimo per l’antico litorale ceretano Rovere et al. 2010 pp. 82-91; Lambeck et al. 2010, pp. 1-8.
Fig. 6 Frammenti di ceramica sud gallica dal relitto (da Petriaggi 1997)
Fig. 7 Chiodi in bronzo dal relitto (da Anelli 2012)
Fig. 8 Resti di un madiere con foro di biscia.
Fig. 9 Chiodo in bronzo dal relitto con resti del legno in cui era inserito.
86
3.7 Novità sugli impianti ittici di Castrum Novum: la peschiera absidata
La peschiera absidata è stata già descritta sommariamente nel Quaderno I di Castrum Novum 1. Il notevole cambia-mento del fondale, dovuto alla scomparsa di spessi strati di matta formata da sabbia, fango, detriti e posidonia nel suo interno, ha totalmente rivoluzionato la conoscenza dell’in-terno della struttura rivelando elementi che ino ad alcuni
anni orsono non erano visibili, tanto che G. Schmiedt nel suo Livello Antico del Mar Tirreno la deinisce composta di una sola vasca, con un’immersione media di 0,37 m sul l.m.m.2. La peschiera si sviluppa con un orientamento di 30° rispetto al nord verso est per una lunghezza di 43 m, una larghezza di 25 m sviluppando una supericie di ca 1100 mc (Fig.1). I moles di notevoli dimensioni raggiungono il massimo spessore in corrispondenza del vertice dell’abside con 4,70 m ed il minimo sul lato sud-orientale di 3,20 m e sono costituiti da un conglomerato cementizio composto da lacerti di pietre appena sbozzate di media pezzatura lega-
Fig. 1 Pianta della peschiera absidata. In rosso i resti delle cataractae in piombo.
A
Z
M
L
H
BY
C
X
DI
F E
0 1 2 3 4 5 mt
Masso con foro
G
W1
87
ti con malta non idraulica, mentre il lato a terra è costituito da un muro in calcestruzzo di cui rimangono oltre 19,00 m di lunghezza, per una larghezza di 0,60 m e 0,90 m di altezza (Fig. 2). L’intera struttura poggia su una fondazione artiiciale di massi (euthynteria) come risulta evidente dal rapido aumento della profondità sul lato NO, deinendola così in litore constructae. Come l’altro vivaria situato più a nord, anch’essa risulta difesa da una massicciata di mas-si irregolari larga ca 5,00 m che attualmente emerge sino a -0,80/-0,90 m dal l.m.m. ad una distanza di 20,00 m dalla struttura che risulta divisa in tre parti distinte: a) la parte absidata, b) la parte centrale con i muri che delimitano al-meno 10 vasche, c) la parte a riva dove non era presente il quarto molo ma due muri paralleli di diversa grandezza che delimitano probabilmente un ediicio che era posto a terra,
per la presenza di alcune lastre pavimentali in pietra ancora in situ. La prima come detto è de-limitata da un molo ampio sino a 4,70 m che presenta tre canali di adduzione con diverse incli-nazioni per favorire comunque l’ingresso dell’acqua al variare della traversia di provenienza. Tali canali risultano essere larghi 0,70 m e parzialmente coperti con una piccola volta nella mu-ratura il cui intradosso è spes-so 0,30 m, tale accorgimento rendeva i moli comodamente utilizzabili per il lavoro delle maestranze rendendo possibile il passaggio lungo il perimetro. Esternamente in corrisponden-za degli stessi, sono ricavati degli incavi rettangolari (2,00 x 1,30 m) dove sono posti due conci di arenaria probabilmente uti-
lizzati come iltro per l’ingresso dell’acqua. Una ulteriore barriera contro la forza del mare è costituita da conci sem-pre in arenaria posti davanti ai canali onde evitare l’ingresso impetuoso del lusso di marea fastidioso per la fauna ittica presente.Nell’area dell’abside non risultano presenti muri divisori, per cui se ne deduce che si è in presenza di una vasca unica ad uso probabile di stabulatio (A), ovvero di vasca di de-posito e cernita del pescato o di attrazione del pesce me-diante immissione di acqua dolce sicuramente proveniente dall’adiacente Fosso delle Guardiole. Tale riserva d’acqua veniva anche utilizzata in estate in presenza di una forte eva-porazione dell’acqua salmastra onde mantenere una giusta salinità nelle vasche3. Lungo la maggior parte del perimetro interno sono ancora presenti le crepidini costituite quasi esclusivamente da una ila di mattoni quadrati sesquipedali
o bipedali (con lato rispettivamente di 0,45 m. e 0,60 m) addossati ai moli o ai muri divisori posti a 0,30/0,35 m sotto il livello della cresta dei moli, ovvero - 0,67/ 0,72 m rispetto al l.m.m. odierno, sagomati a mezzalu-na nel lato interno presentando tra loro giunzioni irregolari. Il tutto pog-gia su uno strato di coccio pesto (opus signinum) che rende la struttura mol-to resistente. Solo in corrispondenza del lato absidato siamo in presenza di una crepidine ampia ino a 1,20 m Tali camminamenti, presenti anche nella vicina peschiera di Punta della Vipera, permettevano alle maestran-ze di operare comodamente stando più vicini al pelo dell’acqua (Fig. 3). In alcuni punti sotto le crepidini ri-sultano tracce di precedenti livelli pavimentali che provano l’intervento di restauro subito nonché il probabile
Fig. 2 Muro in cementizio attualmente posto sul bagnasciuga.
Fig. 3 Crepidini sul lato interno sud est della peschiera.
88
intervento a causa dell’in-nalzamento del livello del mare avvenuto nell’arco di tempo d’uso della peschie-ra. La parte centrale, come detto, consta di almeno 10 vasche delimitate da muri in cementizio spes-si 0,60/0,80 m con tratti la cui fodera in cubilia di opera reticolata risulta an-cora evidente in vari punti, mentre un gran numero di essi si possono rinvenire negli strati di crollo gia-centi sul fondale. Le va-sche ancora integralmente delimitate sono però solo due, ovvero quelle del lato di NO (B, C), mentre di tutte le altre rimangono brevi tratti molto interrati
la cui cresta oltre a rimanere sempre sotto il pelo dell’acqua, risulta appena emergere dal fondale. Nel muro divisorio verso l’abside, i due tratti di muro risultano avere su entrambi i lati le crepidi-ni, già emerse sul lato interno SE della peschiera, sempre costituite da mattoni sesquipedali e/o bi-pedali posti alla stessa profondità degli altri. Le aperture per il collegamento tra le vasche vanno da 0,80 a 1,00 m (X, Y, Z) e sono complete di gargami per lo scorrimento delle grate con un ine corsa posto a ca 0,10 m sotto la cresta del muro. In particolare tra le vasche C e D , è pre-sente ancora in situ una grata in piombo quasi in-tegra (cataracta) larga 1,00 m X, che emerge dal fondale per 0,15/0,20 m avente uno spessore di 0,025 m e alcuni fori del diametro di 0,02 m di-stanti mediamente 0,07 m (Figg. 4, 5). I gargami in cui è inserita hanno dimensioni di 0,05 m di larghezza e 0,08 m di profondità, per un’altezza visibile di 0,40/0,60 m La parte superiore risulta essere posta alla profondità di – 0,70 m sotto il l.m.m. Da sondaggi efettuati con strumenti manuali, risulta che la soglia della stessa è posta a -1,65 m dal l.m.m. , deinendo così una grata quadrata da 1,00 x 1,00 m Anche nell’apertura del muro di-visorio tra la vasca absidata A e la L è presente un piccolo frammento di cataracta in piombo inserito ancora nel gargame più meridionale, Z. In questo caso la soglia è posta a -1,85 m Inine l’apertura tra le vasche L e B risulta avere la soglia sempre alla stessa profondità, ma non presenta resti di grate, Y. Secondo i dettami degli autori antichi le chiuse (cataractae) dovevano emergere costantemente sopra il livello dell’acqua anche durante il lusso dell’alta marea 4. Tale assunto ripropone decisamente la tesi dell’innalzamento del livello del mare in epoca romano imperiale (anno 0 ) a 1,20/1,30 m5 La vasca B è collegata
Fig. 4a e b Grata plumbea (Cataracta) in situ e sua ricostruzione in base ai dati disponibili.
89
alcuni conci pavimentali di arenaria emergenti dal fondale aventi dimensioni quasi regolari di 1,10x0,70 m W, allineati di testa a formare una lunga soglia discontinua (Fig.7)6.Il perimetro compreso tra i due muri formava così una struttura ampia ca 100/120 mq che doveva essere posta a terra ed utilizzata per scopi ineren-ti l’attività di allevamento (locali di servizio) o, nel caso del collegamento ad una villa marittima, probabilmente usata dal dominus come sala de-stinata ai banchetti per gli ospiti che allo stesso tempo potevano godere della frescura dovuta alla vicinanza del mare, la cui presenza è nota in molte altre peschiere e citata dagli autori antichi
7. Per quanto riguarda la specializzazione nella tipologia di allevamento, oltre a quella normale di spigole, orate, dentici etc., il rinvenimento di molte valve di ostriche anche stratiicate (confer-mata anche dai ritrovamenti di molti sub della zona) e la presenza del probabile foro per palo pertinente ad un ostriaria, fanno propendere per l’esercizio anche di questa attività che spesso ve-niva abbinata, in presenza di fondali limacciosi e acqua dolce, all’allevamento di murici da porpo-ra, pettini e mitili 8. Si ritiene inine probabile relazionare questa pe-schiera alle opere presenti a terra tra la riva e la scarpata costiera descritte alcuni anni orsono ed ora quasi o del tutto scomparse, come strutture di una villa marittima. Esse consistevano in muri in opus incertum di pietre e di blocchi di scaglia e pietra locale, pavimenti in signinum, mosaici in tessere bianche e nere e pavimenti in mattoni sesquipedali e bessali 9. Sia per le strutture a terra che per quelle in mare del vivarium si propone una datazione compresa tra la ine del I secolo a.C. e la metà del I d.C., confermata anche dal livello del mare funzionale all’uso delle soglie e della grata rinvenute nella peschiera che, preve-devano un livello del mare inferiore di 1,20/1,30 m rispetto a quello attuale.
Stefano Giorgi, Mauro Giorgial mare aperto da un canale molto irregolare sul molo di NO che doveva forse avere la funzione di emissione dell’ac-qua durante le basse maree. In coincidenza del suo sbocco verso ovest è presente un grosso concio di arenaria forma-to da almeno tre lastre sovrapposte con foro laterale da 0,17/0,18 m, al cui interno sono stati rinvenuti due gusci di ostriche (Fig. 6). La funzione di questo manufatto rimane al momento incerta, ma la presenza delle valve potrebbe far pensare all’impianto di un ostriaria dove i pali lignei era-no utilizzati per sostenere un sistema di pergolati e cestelli dove attecchiva il novellame. L’ultimo settore da prendere in considerazione è quello a ridosso della battigia dove sono presenti almeno due muri paralleli distanti 5,55 m tra loro che costituiscono due vani di forma rettangolare a formare un ediicio adiacente alla peschiera di cui parleremo in se-guito (vano 1). Del muro posto sul bagnasciuga come detto rimangono resti dell’alzato in calcestruzzo. Tra questi due muri, parallelamente ad entrambi, sono presenti in acqua
Fig. 5 Foro di alloggiamento di un palo ligneo su una blocco di arenaria.
Fig. 6 Lastra pavimentale in situ all’interno della struttura 1.
1 ENEI et alii 2011, pp. 18, 29, 302 SCHMIEDT 1972, p. 88, ma anche FRAU 1979, p. 15 3 COLUMELLA, De Re Rustica VIII, 1,3 (Libb. VIII-IX, ed. A. Josephson, Upsaliae 1955) 4 COLUMELLA, VIII, XVII, 10 5 LAMBECK et al., 2004a, p. 1567-1598 e LAMBECK, 2004b, p. 563-575.6 Una soglia simile ancora in situ è presente all’ingresso dell’edii-cio tardo-repubblicano che sorge a terra sul tratto della via Aure-lia (Cfr. p. 16). GIANFROTTA 1972, p. 115 . 7 Esempio su tutti la grande peschiera di Torre Astura, quella di Ponza detta “Grotte di Pilato” e l’antro della villa di Tiberio a Sperlonga . 8 COLUMELLA, VIII, XVI, 89 GIANFROTTA 1972, p. 100
90
3.8 Capo Linaro e Santa Marinella nei portolani di epoca medievale
e moderna
Nel corso dell’anno 2011-2012 è stato condotto un primo studio sulla documentazione medievale e rinascimentale relativa a quest’area dalla quale si è potuto ricavare una serie d’informazioni relative all’approdo di Capo Linaro e alla nascita del centro di Santa Marinella.Fra i testi analizzati, di particolare interesse si sono rivela-ti i portolani i quali, trattando di rotte parallele alla terra ferma, costituiscono una fonte preziosa per gli studi di to-pograia storica delle aree costiere, dei loro porti e dei loro approdi minori1.Da un punto di vista geograico, Capo Linaro è inserito nella cosiddetta piana costiera rocciosa, che presenta grossi speroni di panchina, d’arenaria tipo pietraforte e di pie-traforte come le punte di San Paolo, del Pecoraro, la Torre Marangone, il Castello Odescalchi e i Grottini, ai quali si alternano delle insenature.Nel corso del Medioevo alcuni di questi speroni di roccia dovevano costituire punti di riferimento piuttosto im-portanti per la navigazione, come vedremo per la punta di Santa Marinella che un portolano del 1709 deiniva ancora come celle qui s’avance le plus en mer et par consequent la plus reconnaissable de cette côte2.Dal punto di vista della portualità, questa fascia di territo-rio non presenta grandi diferenze con il resto del litorale laziale: si tratta di una costa bassa e piatta, soggetta a feno-meni d’insabbiamento che non ofre molte alternative alla reti di scali ancora esistente3.Il porto artiiciale di Civitavecchia, che ricalca quello roma-no di Centumcellae, è situato nella sola zona adatta a questi tipo d’installazione: l’area è difatti protetta da fenomeni d’alluvionamento del Tevere dal Capo Linaro e ben ricono-scibile per chi viene dal mare grazie alla presenza dei Monti della Tolfa, più volte menzionati negli itinerari4.
1 Cfr. a questo proposito Castelnovi 2004, pp. 343-361 e Gautier Dalché 2009, p. 10. Alcuni preliminari di questa ricerca che interessa tutto il tratto costiero da Santa Severa a Tar-quinia saranno presto disponibili in Nardi Combescure cs.2 Michelot 1709, p. 108.3 Si rimanda a Denis-Delacour 2010, p. 118 che riporta un passo del testamento redatto nel 1733 da Lione Pascoli a pro-posito del litorale romano : Vi sono molti porti, alcuni de’ qualità tuttoché non capaci di grossi bastimenti e non sicuri si dovreb-bero per maggiore capacità, e comodo de’ sottili e de’ piccoli, e per beneizio maggiore del commercio votare, ingrandire et ampliare. Già in epoca romana lo stesso Plinio giudicava questa zona poco favorevole agli scali, prima della costruzione del porto di Centu-mcellae (Epist. VI, 31, 15, 17).4 Cfr. quanto già esposto in Tchernia 2003, pp. 45-60. Negli anni precedenti la costruzione di Centumcellae, le principali aree d’approdo erano situate alla foce dei iumi principali. Stando agli studiosi che si sono occupati dell’argomento, si trattava di porticcioli piuttosto aperti ed esposti come nel caso delle punte della Vipera, della Mattonara, di Torre Valdaliga e di Castrum Novum o di porticcioli più interni e protetti ma adatti a piccole imbarcazioni, come quelli situati alla foce del iume Marangone
Per quello che riguarda il Capo Linaro e Santa Marinella, i testi nautici che c’interessano sono essenzialmente 8 :- il Liber de existencia rivierarum et forma maris Medi-terranei della metà del secolo XII, considerato dall’editore come una prima raccolta di istruzioni nautiche5; - il Compasso de navegare, un testo anonimo di cui s’igno-ra l’origine e l’autore e di cui si conosce una versione datata dall’incipit al 1296 6;- il portolano di Grazia Pauli (seconda metà del secolo XIV - metà del secolo XV), del quale si dispone dell’edi-zione di A. Terrosu Asole, basata sulla trascrizione di B. R. Motzo 7;
o sul sito della Frasca (Gran Aymerich-Velde 2011, p. 39, che rimandano a Bastianelli 1981, Gianfrotta 1988 e Pirani 1996). 5 Gauthier Dalché 1995.6 In nomine d(omi)ni n(ost)ri Ih(es)u Christi amen. In/cipit li-ber compassuu(m). M. CC. LXXXXVI de / mense januarii fuit inceptu(m) opus istud (Debanne 2011, p. 35). Si tratta del Co-dice Hamilton 396 conservato nella Staatsbibliothek di Berlino, del quale si dispone attualmente di due edizioni, quella pubbli-cata da Bacchisio R. Motzo nel 1947 (Motzo 1947) e la più re-cente a cura di Alessandra Debanne.7 Terrosu Asole 1987.
Fig. 1 Santa Severa, Capo Linaro, Civitavecchia e Corneto nella Carta Pisana (da L’âge d’or des cartes marines. Quand l’Europe découvrait le monde, a cura di C. Hofmann, H. Richard, E. Va-gnon, Parigi 2012).
91
- il portolano di Parma-Magliabecchi degli inizi del secolo XV, che costituisce una delle prime descrizioni signiicative delle coste pontiicie8; - il portolano di Bernardino Rizo che costituisce il primo portolano stampato e del quale si conoscono due versioni9;- il portolano di Piri Reis (Kitab-i Bahriyye), un ex pira-ta divenuto poi ammiraglio turco, al quale è associata una mappa e che si data negli anni 1521-152710; - il portolano di Bartolomeo Crescenzi (inizi del secolo XVII) il cui testo fa riferimento a un portolano siciliano del 157311;
8 Palermo 2007, p. 104.9 La prima è un manoscritto della Biblioteca Apostolica Vatica-na (BAV, Borgiani Lat., 846, f. 350-353v., cfr anche Palermo 2007, p. 105), mentre la seconda è l’edizione veneziana il cui de-stinatario era uno zentiluomo veniciano e pubblicata da Kretsch-mer (2009, pp. 148-149).10 Per la descrizione della costa tirrenica d’Italia centro-meridio-nale si rimanda a Bausani 1983.11 B. Crescenzio 1607, Baldacci 1949 e Castelnovi 1995. Crescenzio, architetto e cartografo, conosceva bene queste
- il portolano Zaccaria Rispolo, un docu-mento ancora inedito redatto tra il 1625 e il 1675 e conservato nella Biblioteca de Cata-lunya di Barcellona12;- il portolano di Giacomo Galetti di Savo-na che descrive in modo dettagliato il tratto compreso fra la Foce del Tevere e Corneto13;- il Portulan de la mer di Henry Michelot (1709), pilota delle galere del Re a partire del 1670, interessante testo di cui si conserva una copia presso la Bibliothèque Nationale de France14. La rassegna si conclude con il portolano di Angelo Costaguti, pubblicato a Roma nel 1798, un testo di estrema importanza accom-pagnato da un corpus d’illustrazioni estrema-mente ricco15. Da questi documenti si evince che già dal secolo XII il Capo Linaro è men-zionato come Caput Nari nel Trattato di pace e alleanza tra i Romani e Genovesi del 1165-116616 e nel Liber de existencia rivierarum et forma maris Mediterranei17 mentre dal successivo comincia ad essere rappresentato nella cartograia marittima (per es. la Carta Pisana del 1275, Fig. 1)18. Nel Compasso de navegare, si segnala come arrivarci dal porto di Civitavecchia: [De] Civeta Vellia a capo Linar V mil(lara) p(er) sirocco/ ver mecço dì. Capo Linaro è capo soctile (et) è capo / de placça romana de ver lo maestro, (et) è secco en /mare V mil(lara).E’ molto probabile che in prossimità del Capo Linaro si trovasse l’approdo di Santa Marinella. Quest’ultimo è menzionato in un contratto genovese del 122519 e stando alla ricostruzione di D. Abulaia, doveva essere
zone in quanto compare fra i restauratori del porto di Civitavec-chia (Curcio-Zampa 1995). 12 Ms. 1364, disponibile su internet all’indirizzo http://cataleg.bnc.cat/record=b1571785~S13*cat. Da qui in poi Portolano di Zaccaria Rispolo.13 BAV, Borgiani Lat., 373, riportato in Palermo 2007, p. 107.14 Michelot 1709. Una versione digitale è accessibile all’indi-rizzo http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k106829d15 Dainotto 2005.16 Giorgi 1902, pp. 463-465 : Si, quod Deus avertat, aliquod lig-num Ianuensiu[m] vel de eorum dist[rictu] nauragium] pacietur a ca[pite Anse usque caput Nari, personas et res] salvari faciemus per bonam idem nec eis quicquam auferri paciemur. Et si extra a capite Anse usque Terracinam et a capite Nari usque Cornetum illud con[tigerit, adiuvabimus Ianuenses bona ide] que evaserint rehabere.17 Gautier-Dalché 1995, p. 160 : a Capite Linaris in riveria usque ad Civitatem Veterm ML..X., habentem portum manibus antiquitus fabricatum ante se in arico, et in aquilone iuxta Civi-tatem sinum angustum iacentem portum optimum quod dicitur feminile.18 Bibliothèque Nationale de France, Département cartes et plans, CPL GE B-1118.19 Lanfranco, II, n. 1502.
Fig. 2 Capo Linaro nel portolano di Costaguti (da S. Dainotto, Il portolano della spiaggia romana nel Mare Mediterraneo di Angelo Costaguti, Roma 2005).
92
detto Qau-Olonare è una punta che si allunga per 5 miglia sul mare)25.La presenza di una secca a cinque chilometri dal capo co-stituisce l’elemento comune di questi testi, come anche di quelli successivi.A partire del secolo XVII, al capo è associata Santa Ma-rinella come si deduce dal testo di Bartolomeo Crescenzi (1607: A miglia quattro si trova Capo Linaro, et bisogna passare largo miglia due per i bassi fondi: nel voltar del capo vi è Santa Marinella, ove è un poco di stanza ad un bisogno)26 da quello di Portolano di Zaccaria Rispolo (1625-1675 : A miglia tre v’è una chiesa, che è chiamata Santa Marinella, nel qual luogo il Sommo Ponteice Urbano Ottavo havea fatto principare un molo con lanterna. Dentro di detto luogo v’è bon riparo per nave e galere, la traversia è sirocco e levante)27 e dal portolano di Giacomo Galetti del 1667 (A miglia 5 capo Linaro, bisogna passar largo, vi sono bassi fondi. A miglia 2, andando dentro il capo vi è una torre Santa Marinella, dove ad un bisogno si salverebbero 2 o 3 galere)28.Agli albori del secolo XVIII, H. Michelot indica ancora la punta di Santa Marinella come riferimento principale per riconoscere il porto di Civitavecchia: On ne peur recon-noître Civita-Vechia venant du côté de l’Ouest ou de l’Est,
25 Bausani 1983, pp. 58.26 B. Crescenzio 1607.27 Portolano di Zaccaria Rispolo, f 35v e f 36r. 28 Riportato in Palermo 2007, pp. 107-108.
utilizzato in estate per ormeggiare le navi dirette a Corneto, in alternativa all’approdo situato sulla foce del Marta20.Nei secoli successivi il capo è rappresentato nell’Atlas Cata-lan d’Abraham Cresques del 137521 e descritto nel porto-lano di Grazia Pauli: E da Civita vecchia a chapo Linaro à miglia V per iscelocho di ver mezodì. Chapo Linaro è chapo sottile, è chapo di Piagia romana da maestro e i mare, miglia V, à sécha una. E di chapo Linaro a la focie di Roma à miglia LX per iscelocho di ver Levante22. La forma sottile e le secche di Capo Linaro sono ricordati successivamente nel portolano di Bernardino Rizzo (1490: de civita vecchia a chauo olinar sono mia 5. Chauo olinar si e un chauo sotil ed e uno chauo de la spiaza romana la qual tien per longheza mia 120 quarta de levante ver sirocho. Le seche del chauo olinar e largo in mar mia 5…)23, nel porto-lano di Parma (secolo XV : De civita vechia a cavo linari milia V tra ½ di e scilocho. Cavo linari e cavo basso che insul cavo un miglio in mare per libeccio) 24 e nel Portolano di Piri Reis (1521-1527 : Qau-Olonare è una punta sottile che chia-mano anche Plase Romane. La sua lunghezza è di 12 miglia verso est-sud-est. Queste 12 miglia sono tutte di spiaggia e il
20 Abufalia 1974, pp. 224-234.21 Bibliothèque Nationale de France, Département des manuscrits, Espagnol 30.22 Terrosu Asole 1987, p. 23.23 Kretschmer 2009, p. 198.24 Kretschmer 2009, pp. 148-149.
Fig. 2 Il castello Odescalchi nel portolano di Costaguti (da S. Dainotto, Il portolano della spiaggia romana nel Mare Mediterraneo di Angelo Costaguti, Roma 2005).
93
que par la pointe de Sainte Marinelle, qui est environ 5. A 6. Milles vers le Sud-Sud est; venant de l’Ouest la ville de Cornete en facilite la reconnoissance, aussi bien que la pointe de Sainte Marinelle, qu’on voit d’asses loin; c’est la plus haute et vient en abaissant vers la mer, et celle qui s’avance le plus de cette côte, ensuite on decouvre la Tour du Fanal et la ville de Civita-vechia en même temps29.Anche se molto tardo, il portolano di Costaguti ci fornisce una serie d’informazioni relative a questo tratto di costa ed ai luoghi ove essa può permettere l’ancoraggio di navi (Fig. 1 e ig. 2)30. Innanzitutto ci segnala che a due miglia a largo di Capo Linaro vi è una Corallera, dove i marinai di Tor-re del Greco vanno a cercare il corallo (si trova mettendo li Cappuccini di Civitavecchia fora assai del Marangone, e S. Marinella per dritto a una montagna sopra li Grottini, che à come una cupoletta). Nei pressi del Fosso del Gaetano (attua-le fosso delle Guardiole) si trova un approdo al quale pos-sono accedere delle piccole imbarcazioni come barchette e paranzelle, mentre il fontanile di Santa Marinella, che tro-
29 Michelot 1709, pp. 10730 Dainotto 2005, pp. 91-92.
Fig. 4 Atlante d’Italia manoscritto, anonimo e senza data, del seminario vescovile di Padova (sec. XV-XVI); da L. Lago, Imago italiae: la fabbrica dell’Italia nella storia della cartograia tra Medioevo ed età moderna: realtà ed immaginazione dai codici di Claudio Tolomeo all’Atlante di Antonio Magini, Trieste 2002, p. 526.
viamo rappresentato nel Catasto Alessandrino e nel Catasto rustico della Provincia di Roma, è frequentato da corsari al-gerini e tunisini che vengono a rifornirsi d’acqua31. Costaguti vi segnala un fondale di scogli e invita i naviganti ad accostarsi con diligenza a quest’area verosimilmente si-tuata nei pressi del Castello Odescalchi.
Sara Nardi Combescure
31 ASR, Presidenza delle Strade, Catasto Alessandrino, 428/15, 15 marzo 1660 e Catasto rustico della Provincia di Roma, Civitavec-chia LXXVI, tenute: Santa Marinella.
94
Bibliograia(a cura di Alessandra Squaglia e Guido Girolami)
AbbreviazioniAE, L’Année épigraphiqueAA.SS, Acta SanctorumCIL, Corpus Inscriptionum LatinarumEOS, Epigraia e ordine senatorioMRR, T.R.S. Broughton, he Magistrates of the Roman Republic, New York, 1951-1952. NOTIZIE, Notizie degli Scavi di Antichità comunicate alla R. Ac-cademia dei Lincei per ordine di S. E. il Ministro della pubb. istru-zione periodico mensile, Roma, 1876 - 1903RIC, he Roman Imperial Coniage, a cura di H. Mattingly e A. Sydenham, I - IX - London 1923 - 1984RRC = M. H. Crawford, Roman Republican Coinage, London 1974 (ristampa del 1983)PIR, Prosopographia Imperii Romani. REE, Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschat SCO, Studi classici e orientali
Aa.ss 1695 = Acta Sanctorum Iunii, I, Antverpiae, 1695Aa.ss 1735 =Acta Sanctorum Augusti, II, Antverpiae, 1735Abufalia 1974 = D. Abufalia, Corneto-Tarquinia and the Italian Mercantile Republics: he Earliest Evidence in Papers of the British School at Rome, 42, 1974, pp. 224-234Amelung 1908 =W. Amelung, Die Skulpturen des Vatikanischen Museums, II, Berlin 1908, Amore 1968 = A. Amore, Secondiano, Marcelliano e Veriano, in Bibliotheca Sanctorum, XI, Roma, 1968, coll. 808-809Andermahr 1998 = A.M. Andermahr, Totus in praediis. Senato-rischer Grundbesitz in Italien in der Frühen und hohen Kaiserzeit, Bonn, 1998 Anelli 2012 = S. Anelli, Il relitto di Capo Linaro, in Rinveni-menti sottomarini nel comprensorio di Civitavecchia (a cura di M. Sonno e S. Anelli), Vol. II, Grotte di Castro 2012.Arslan 1965 = E. A. Arslan, Osservazioni sull’impiego e la difu-sione delle volte sottili in tubi ittili, in Bollettino d’Arte, I-II, 1965, pp. 45-52Barbaranelli 1956 = F. Barbaranelli, Villaggi villanoviani dell’Etruria meridionale marittima, in Bullettino di Paletnologia italiana, 65, 1956, pp. 455-489Belardelli, Pascucci 1996 = C. Belardelli, P. Pascucci, I siti costieri del territorio di Civitavecchia e Santa Marinella nella prima età del Ferro. Risultati preliminari di una revisione critica dei dati, in Bollettino della Società Tarquiniense di Arte e Storia, 25, 1996, pp. 343-398Bastianelli 1954 = S. Bastianelli, Centumcellae - Castrum No-vum: Regio VII, Etruria : Italia romana, municipi e colonie, Serie 1, XIV, Roma 1954Bastianelli 1981 = S. Bastianelli, L’abitato etrusco sul poggio detto “la Castellina”. Castrum Vetus (?) e la sua necropoli, in Bollet-tino di Informazioni dell’Associazione Archeologica Centumcellae di Civitavecchia, 15, 6, Civitavecchia 1981, pp. 96-123Bausani 1983 = A. Bausani, La costa italiana del Tirreno da Civi-tavecchia a Ischia nel Portolano di Piri Reis, in Rasa’al: in memoria di Umberto Rizzitano, Palermo 1983, pp. 55-63Bertoldi 2011= T. Bertoldi, Ceramiche comuni dal suburbio di Roma, Roma 2011 Bonomi 1996 = S. Bonomi, Vetri antichi del Museo Archeologico Nazionale di Adria, Venezia 1996 Buonopane 2011 = A. Buonopane, Un medico in un’iscrizione inedita della Cisalpina, in Sylloge Epigraphica Barcinonensis (SE-Barc), IX, 2011, pp. 123-129Calvi 1968 = M. Calvi, I vetri romani del Museo Archeologico di Aquileia, Aquileia 1968Cambi 1993 = F. Cambi, Paesaggi d’Etruria e di Puglia, in, Storia di Roma (a cura di A. Giardina, A. Schiavone),III, 2, Turin 1993, pp. 229-254
Carandini 1981 = A. Carandini (a cura di), Atlante delle forme ceramiche, ceramica ine romana nel bacino Mediterraneo, vol. II, suppl. EAA, Roma 1981.Carandini, Cambi, Celuzza 2002 = A. Carandini, F. Cambi, M. Celuzza (a cura di), Paesaggi d’Etruria: Valle d’Albegna, Valle d’Oro, Valle del Chiarone, Valle del Tafone. Progetto di ricerca italo- britannico seguito allo scavo di Setteinestre, Roma 2002 Cipriani 1972 = I. Cipriani, Scavi archeologici a Castrum No-vum alla ine del XVIII secolo in Rendiconti della Pontiicia Acca-demia Romana di Archeologia, Serie III, XLIV, (a. a. 1971-1972), Roma 1972, pp. 305-327Castelnovi 2004 = M. Castelnovi, Il portolano : una fonte sto-rica medievale trascurata, in Rotte e porti del Mediterraneo dopo la caduta dell’impero romano d’Occidente. Continuità e innovazioni tecnologiche e funzionali (a cura di L. De Maria, R. Turchet-ti), Soveria Manneli 2004, pp. 343-361Coarelli 1976 = F. Coarelli, Un elmo con iscrizione latina ar-caica al Museo di Cremona, in Mèlanges oferts à Jacques Heur-gon: l’Italie preromaine et la Rome republicaine, I, Roma 1976, pp. 157-179 Colonna 1960 = G. Colonna, Santa Severa (Roma). Fistula iscritta da Pyrgi, in Notizie degli Scavi di Antichità, Roma 1960, pp. 363-365 Colonna 1986 = G. Colonna, Il Tevere e gli Etruschi in Archeo-logia Laziale, VII, 2, Quaderni del centro di studio per l’archeolo-gia etrusco-italica, 12, Roma 1986, pp. 90-97Corda 2007= A.M. Corda, Breve introduzione allo studio delle antichità cristiane della Sardegna, Ortacesus (Cagliari), 2007Crema 1959 = L. Crema, L’Architettura Romana, in Enciclopedia Classica, sezione III, Archeologia e Storia dell’Arte Classica, XII, I, Torino 1959Crescenzio 1602 = B. Crescenzio, Portolano nel Mediterraneo, Roma 1602Daga 1999 = P. Alberto Daga, Tarquinia, la città degli Etruschi, delle torri e delle chiese. Una storia lunga tremila anni (a cura di Luigi Daga), Roma 1999Dainotto 2005 = S. Dainotto, Il portolano della spiaggia roma-na nel Mare Mediterraneo di Angelo Costaguti, Roma 2005Debanne 2011 = A. Debanne, Lo compasso de navegare, Berne 2011Degrassi 1952 = A. Degrassi, I fasti consolari dell’impero roma-no dal 30 a.C. al 613 d.C., Rome 1952 Del Lungo 1996 = S. Del Lungo, La toponomastica archeologica della Provincia di Roma, I, Roma 1996Del Lungo 1999 = S. Del Lungo, Insediamenti della bassa Valle del Marta nella tarda antichità e nell’altomedioevo (secoli V-IX), in Bollettino della Società Tarquiniense d’Arte e Storia, XXVIII, 1999, pp. 23-73Del Lungo 1999b = S. Del Lungo, Leopoli – Cencelle, III, La toponomastica della bassa Valle del Mignone, Roma 1999Denis – Delacour 2010 = Ch. Denis-Delacour, Petits ports et escales de la côte romaine dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, in Rives méditerranéennes, 35, 2010, pp. 117-132Dennis 1848 = G. Dennis, Cities and Cemetery of Etruria, I, London 1848De Rossi 1971= G.M. De Rossi, Le torri costiere del Lazio, Roma 1971De Tommaso 1990 = G. De Tommaso, Ampullae vitrea: Conte-nitori in vetro di unguenti e sostanze aromatiche dell’Italia Romana (I sec. a. C. - III sec. d.C.), Roma 1990 Disantarosa 2009 = G. Disantarosa, Le anfore: indicatori ar-cheologici di produzione, delle rotte commerciali e del reimpiego nel mondo antico, in Classica et Christiana, 4/1, 2009, pp. 119-232Dressel 1899 = H. Dressel, Corpus Inscriptionum Latinarum, XV, “, Instrumentum Domesticum, 1, Berlin 1899.Enei et alii 2011= F. Enei, M. L. Haack, S. Nardi Combescure, G. Poccardi, Castrum Novum. Storia e archeologia di una colonia romana nel territorio di Santa Marinella, Quaderno I, Santa Ma-rinella 2011
95
Enei 2013 = F. Enei (a cura di), Santa Severa tra leggenda e realtà storica. Pyrgi e il castello di Santa Severa alla luce delle recenti scoper-te (Scavi 2003-2009), Pyrgi-Santa Severa 2013Enei 2013a = F. Enei Una spada dell’età del bronzo dal fondale di Capo Linaro a Santa Marinella (Roma - Italia), in Archaeologia Maritima Mediterranea, An International Journal on Underwater Archaeology, Vol. 10 20143 c. s.Facchini 1988= G. M. Facchini, Vetri romani della prima e me-dia età imperiale in Archeologia in Piemonte. L’età romana (a cura di L. Mercando), Torino 1988, pp. 256-270Faudet 1999= I. Faudet, Fibules préromaines, romaines et mé-rovingiennes du Musée du Louvre, Département des Antiquités Grecques, Etrusques et Romaines, Paris 1999Ferrari et alii 1998 = D. Ferrari, A. Larese, G. Meconcelli Nota-rianni, M. Verità, Glossario del vetro archeologico, Venezia 1998Fiocchi Nicolai 1998 = V. Fiocchi Nicolai, I cimiteri paleocris-tiani del Lazio, I, Etruria Meridionale, Città del Vaticano 1988Frau 1979 = B. Frau, Il ritrovamento di un porto etrusco del V sec. a. C. ed una piscina romana del I sec. a. C nell’area marittima di Castrum Novum (Santa Marinella), Roma 1979Gabucci 2000 = A. Gabucci, Alcune considerazioni sui balsa-mari e il vasellame in vetro in Alle origini di Biella. La necropoli romana (a cura di L. Brecciaroli Taborelli), Torino 2000, pp. 93-104Gautier Dalché 1995 = P. Gautier Dalché, Carte marine et portulan au XIIe siècle. Le Liber de existencia riveriarum et forma maris nostri Mediterranei, Roma 1995Gautier Dalché 2009 = P. Gautier Dalché, Qu’est-ce qu’un port? Les données des portulans, in Les ports et la navigation en Mé-diterranée au Moyen Âge (a cura di G. Fabre, D. Le Blévec, D. Menjot) Paris 2009, pp. 237-243 Gatc 2013 = Gruppo archeologico del territorio Cerite, Compi-lazione di fonti antiche e moderne sugli scavi archeologici a Castrum Novum, Roma 2013Gianfrotta 1972 = P. A. Gianfrotta, Castrum Novum, Forma Italiae, regio VII – volumen tertium, Roma 1972Gianfrotta 1988 = P. A. Gianfrotta, Le coste, i porti la pesca, in Etruria meridionale. Conoscenza, conservazione, ruizione (a cura di G. Colonna, C. Pettini, R. A. Staccioli), Roma 1988, pp. 11-15Gianfrotta 2011 = P. A. Gianfrotta, Una gemma dalla villa de «le Guardiole», in Enei et alii 2011, p. 33.Gran Aymerich, Velde 2011 = J. Gran Aymerich, B. Velde, Civitavecchia-Tolfa: contesto geograico e risorse naturali, in La Ca-stellina di Civitavecchia. Origini e eredità. Origines protohistoriques et évolution d’un habitat étrusque (a cura di J. Gran Aymerich, A. Dominguez-Arranz), Roma 2011, pp. 37-50Gufi 2007= L. Gui, Culto dei santi e santuari a Corneto nei secc. XIV–XV, in Atti del Convegno di Studio Corneto Medievale: terri-torio, società,economia e istituzioni religiose (a cura di Alfio Cor-tonesi, Anna Esposito, Letizia Pani Ermini e con la colla-borazione di Luca Gufi),in Bollettino Società Tarquiniense d’Arte e Storia, XXXVI, 2007, pp. 307-335Haack et alii 2012 = M. L. Haack, S. Nardi Combescure, G. Poc-cardi, F. Enei, Castrum Novum. Chronique des campagnes de sep-tembre 2010 et septembre 2011, Chronique des activités archéologi-ques de l’École rançaise de Rome 2012; http://cefr.revues.org/616Haack et alii 2013 = M. L. Haack, S. Nardi Combescure, G. Poc-cardi, F. Enei, N. André, V. Picard, Castrum Novum. Chronique de la campagne de septembre 2012, Chronique des activités archéologi-ques de l’École rançaise de Rome 2013; http://cefr.revues.org/862Harden 1981 = D. B. Harden, Catalogue of Greek and Roman Glass in the British Museum, I, London 1981Helbig 1895 = W. Helbig, Guide to the public collections of clas-sical antiquites in Rome, (trad. di James F. e Findlay Muirhead), I, Leipsic 1895 Isings 1957 = C. Isings, Roman Glass rom Dated Finds, Gronin-gen- Djakarta 1957Johns 1992 = C. Johns, Eros dans l’art antique, Roma 1992
Keay 1984 = S. J. Keay, Late Roman Amphorae in the western Mediterranean, Oxford 1984.Kretschmer 2009 = K. Kretschmer, Els portolans de l’edad Mitjana. Una contribuciò a la historia de la cartograia i la nau-tica, Barcellona 2009Krueger, Reynolds 1951-1953 = H. Krueger, R. Reynolds (a cura di), Lanranco, (Notai liguri del secolo XII e del XIII), VI, Genova 1951- 1953Kunkel 1967 = W. Kunkel, Herkunt und soziale Stellung der römischen Juristen, Graz-Vienne-Cologne 1967Lambeck 2004a = K. Lambeck, F.Antonioli, A Purcell, S. Silen-zi, Sea level change along the Italian coast for the past 10.000 yr., “Quaternary Science Reviews”, 23, 2004, pp. 1567-1598; Lambeck 2004b =K. Lambeck, A. Anzidei, F. Antonioli, A. Benini, A. Esposito, Sea level in roman time in the Central Medi-terranean and implications for recent change, “Earth and Planetary Science Letters” 224 (3-4) 2004, pp. 563-575. Lambeck 2010 = K. Lambeck, F. Antonioli, M. Anzidei, L. Fer-ranti, G. Leoni, G. Schicchitano, S. Silenzi, Sea level change along the Italian coast during the Holocene and projections for the future, Quaternary International 2010, pp. 1-8.Lanzoni 1927 = F. Lanzoni, Le Diocesi d’Italia dalle origini al principio del secolo VII (an.604), (Studi e testi 35), I, Faenza 1927Leonardi 2003= C. Leonardi, Nicola Bonvicini: pittore in Roma e opere tuscanesi in www.bibliotecaviterbo.it/Rivista/2003 _1-2/Leonardi.pdf, pp. 28-32Lippold 1936 = G. Lippold, Die Skulpturen des Vaticanischen Museums, III1, Berlin und Leipzig 1936 Lissia, Zanda 1994 = D. Lissia, E. Zanda, Museo Archeologico di Asti. La collezione dei vetri, Torino 1994Maccabruni 1983 = C. Maccabruni, I vetri romani dei musei civici di Pavia: lettura di una collezione, Pavia 1983 Massi 1792 = P. Massi, Indicazione antiquaria del pontiicio mu-seo Pio-Clementino in Vaticano stesa da Pasquale Massi cesenate custode del museo stesso, Roma 1792Michelot 1709 = H. Michelot, Le portulan de la mer Méditer-ranée, ou le Vray guide des pilots costiers, dans la quelle on verra la véritable manière de naviguer le long des côtes d’Espagne, Catalo-gne, Provence, Italie, les isles d’Yvice, Mayorque, Minorque, Corse et autres, Amsterdam 1709Mollo, Framarin 2002 = R. Mollo, P. Framarin, Vetri e aree di produzione nel mondo antico, in Glassway: il vetro, ragilità attra-verso il tempo (a cura di B. Basile), Ragusa 2002, pp. 15-23Morel 1981= J. P. Morel, Céramique campanienne: les formes, I-II, Roma 1981Motzo 1947 = B. R. Motzo, Il compasso de navigare. Opera ita-liana della metà del secolo XIII, Annali della Facoltà di lettere e ilosoia dell’Università di Cagliari, 8, 1947Nardi Combescure 2002 = S. Nardi Combescure, Paesag-gi d’Etruria Meridionale. L’entroterra di Civitavecchia dal II al XV secolo d.C., Firenze 2002Nardi Combescure c. s. = S. Nardi Combescure, La terra vi-sta dal mare. I porti e gli scali minori tra Santa Severa e Corneto nei portolani medievali e moderni, in Temporis Signa. Rivista di archeologia della tarda antichità e del medioevo, c. s. Newby, Painter 1991 = M. Newby, K. Painter, Roman glass: two centuries of art and invention, Londra 1991Nibby 1837 = A. Nibby, Analisi storico-topograica-antiquaria della carta de’ Dintorni di Roma, Roma 1837Nissen 1883 = H. Nissen, Italische Landeskunde, Berlin 1883-1902Olcese 2003 = G. Olcese, Ceramiche comuni a Roma e in area romana: produzione, circolazione e tecnologia : tarda età repubbli-cana-prima età imperiale, Mantova 2003Orlandini 1965 = P. Orlandini, s.v. Kalamis in Enciclopedia dell’Arte antica, classica e orientale, Roma 1965Oswald-Price 1920 = F. Oswald, J. D. Price, An introduction to the study of Terra sigillata, London 1920.
96
Oxè 2000 = A. Oxè et H. Comfort, Corpus Vasorum Arretinorum. A catalogue of the signatures, shapes and chronology of Italian Sigil-lata, 2° ediz., Bonn 2000Pacciarelli 1991 = M. Pacciarelli, Territorio, insediamento, co-munità in Etruria meridionale agli esordi del processo di urbanizza-zione, in Scienza dell’Antichità, storia, archeologia, antropologia, 5, 1991, pp.163-208Pacciarelli 2000 = M. Pacciarelli, Dal villaggio alla città. La svolta proto urbana dal 1000 a.C. nell’Italia tirrenica, Firenze 2000Palermo 2007 = L. Palermo, Il porto di Corneto tra Medioevo e Rinascimento, in Corneto medievale: territorio, società, economia e istituzioni religiose (a cura di A. Cortonesi, A. Esposito, L. Pani Ermini), Tarquinia 2007, pp. 99-126Pallottini 2011 = E. Pallottini, La produzione epigraica di Tus-cania in età medievale (secc. VI-XIII): cronologia, tipologia, contesto, in Da Salumbrona a Tuscania. Trenta secoli di storia. Atti del II Convegno di Studi sulla Storia di Tuscania (Sala Parrocchiale San Marco – Tuscania 14 maggio 2011), Tuscania 2011, pp. 101-122Papi 2000 = E. Papi, L’Etruria dei Romani. Opere pubbliche e do-nazioni private in età imperiale, Roma 2000Paribeni 1965 = E. Paribeni, s.v. Priapo in Enciclopedia dell’Arte antica, classica e orientale, Roma 1965Passerini 1939 = A. Passerini, Le coorti pretorie, Roma 1939Pavolini 1980 = C. Pavolini, Appunti sui vasetti ovoidi e pirifor-mi di Ostia, in Melanges de l’Ecole rançaise de Rome. Antiquitè, T. 92, n.2, 1980, pp. 993-1020; doi: 10.3406/mefr.1980.1260; http://persee.fr/web/revues/home/prescript/article/mefr_0223-5102_1980_num_92_2_1260Pavolini 2000 = C. Pavolini, Scavi di Ostia. La ceramica comune. Le forme in argilla depurata dell’Antiquarium, XIII, Roma 2000Petriaggi 1997 = R. Petriaggi, Il relitto di Capo Linaro a Santa Marinella, in L’Archeologo Subacqueo, III, 3, Bari 1997Pietrangeli 1943 = C. Pietrangeli, Scavi e scoperte di antichità sotto il pontiicato di Pio VI, Roma 1943 Pietrangeli 1958 = C. Pietrangeli, Scavi e scoperte di antichità sotto il pontiicato di Pio VI, 2° ediz., Roma 1958Pietrangeli 1978 = C. Pietrangeli, Otricoli - un lembo dell’Um-bria alle porte di Roma, Roma 1978Pietrangeli 1982 = C. Pietrangeli, Il Contributo del Lazio anti-co ai Musei Vaticani di scultura, Roma 1982Pietrangeli 1985 = C. Pietrangeli, I Musei Vaticani - cinque secoli di storia, Roma, 1985Pietrangeli 1987 = C. Pietrangeli, La provenienza delle scultu-re dei Musei Vaticani in Bollettino dei monumenti, musei e gallerie pontiicie, VII, 1987, p.128, n. 523 Pirani 1996 = F. Pirani, L’abitato etrusco-romano sul poggio detto “La Castellina”. Impressioni, Civitavecchia 1996Py 1974= F. Py, M. Py, Les amphoras étrusques de Vaunage et de Villevielle (Gard), in Melanges de l’Ecole Française de Rome. An-tiquitè, 86, 1974, pp. 141-254.Ravagnan 1994 = G. L. Ravagnan, Vetri antichi del Museo vetrario di Murano. Collezioni dello Stato, Murano - Venezia 1994 Renard 1953 = M. Renard, Juno Historia, in Latomus, 12, 1953, pp. 137-154Rodriguez-Almeida 1974 = E. Rodriguez Almeida, Sobre el uso del anforisco Cucurbitula, in Melanges de l’Ecole rançaise de Rome. Antiqui-tè ,T. 86, n.2, 1974, pp. 813-818; doi:103406/mefr.1974.990 http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/mefr_0223-5102_1974_num_86_2_990Rovere et al 2010 = A. Rovere, F. Antonioli, F. Enei, S. Giorgi, Relative sea level change of the archaeological site of Pyrgi (Santa Se-vera, Roma) during the last seven millennia, “Quaternary Interna-tional”, 2010 pp. 82-91; Sangriso 1998 = P. Sangriso, Terra sigillata e politica augustea:alcune note su Cn. Ateius, SCO, 46, 3, 1998, pp. 919-932 Scapaticci Perfetti 2000 = G. Scapaticci Perfetti, Le origini di Monte Romano. Indagine di scavo sul «Poggio della Rotonda»,in Archeologia Medievale, 27, 2000, pp. 219-227
Sensi 1982 = L. Sensi, Praescriptio del s.c. larinate, in EOS, I, 1982, pp. 515-520Spinola 1996 = G. Spinola, Il Museo Pio Clementino - Guide Cataloghi dei Musei Vaticani 3-I, Città del Vaticano 1996 Spinola 1999 = G. Spinola, Il Museo Pio Clementino - Guide Cataloghi dei Musei Vaticani 4-II, Città del Vaticano, 1999Spinola 2004 = G. Spinola, Il Museo Pio Clementino - Guide Cataloghi dei Musei Vaticani 5-III, Città del Vaticano, 2004Steinby 1978 = M. Steinby, Lateres signati ostienses, Rome 1978Susi 2007 = E. Susi, San Secondiano e Corneto, in Atti del Conve-gno di Studio Corneto Medievale: territorio, società,economia e istituzioni religiose (a cura di Alfio Cortonesi, Anna Es-posito, Letizia Pani Ermini e con la collaborazione di Luca Gufi),in Bollettino Società Tarquiniense d’ Arte e Storia, XXXVI, 2007, pp.207-225Taborelli 1985 = L.Taborelli, Vasi di vetro con rilievi di ludi cir-censes e gladiatori. Nuovi contributi in Studi di Antichità in onore di Guglielmo Maetzke, Roma 1985, pp.561-576 Tchernia 2003 = A. Tchernia, Le ravitaillement de Rome : les réponses aux contraintes de la géographie, in Nourrir les cités de la Méditerranée (a cura di B. Marin, C. Virlouvet) Paris 2003, pp. 45-59Terrosu Asule 1987 = A. Terrosu Asule, Il portolano di Gra-zia Pauli. Opera italiana del secolo XV trascritta a cura di Bacchisio R. Motzo, Cagliari 1987Tizi 2010 = M. Tizi, Le spoglie contese. Note di culto di S. Secon-diano e compagni, Patroni di Tuscania in www.bibliotecaviterbo.it/rivista/2010_3/001_tizi.pdf, pp. 3-7Tizi 2011 = M. Tizi, Secondiano, Veriano, Marcelliano: la rifon-dazione cristiana in Da Salumbrona a Tuscania. Trenta secoli di storia. Atti del II Convegno di Studi sulla Storia di Tuscania (Sala Parrocchiale San Marco – Tuscania 14 maggio 2011), Tuscania 2011, pp.63-88Tonicchi 2011 = R. Tonicchi, De SS. Secundiano, Marcelliano et Veriano, martyribus in Tuscia. Traduzione dal latino del Com-mentarius Praevius degli Acta Sanctorum, in Da Salumbrona a Tuscania. Trenta secoli di storia. Atti del II Convegno di Studi sulla Storia di Tuscania (Sala Parrocchiale San Marco – Tuscania 14 maggio 2011), Tuscania 2011, pp. 89-100Toniolo 2000 = A. Toniolo, Vetri antichi del Museo Archeologi-co Nazionale di Este, Venezia 2000 Torelli 1982 = M. Torelli, Ascesa al senato e rapporti con i terri-tori d’origine, Italia: regio VII (Etruria), EOS, II, 1982, pp. 275-299 Torraca 1777 = Articolo di Lettera scritta dal Sig. Dott. Gaeta-no Torraca in data di Civitavecchia li 3 Febbraro 1777 a Monsig. Stefano Borgia Segretario di Propaganda in Antologia Romana, s. v. Antichità, III, n. 33, febbraio 1777, p. 258 Torraca 1777b = Articolo di Lettera scritta dal Sig. Dottor Gae-tano Torraca a Monsignor Borgia Segretario di Propaganda in data di Civitavecchia 31 marzo 1777 in Antologia Romana, s. v. Anti-chità, III, n. 41, aprile 1777, p. 325 Torraca 1778 = Articolo di lettera scritta a Monsig. Stefano Borgia Segretario di Propaganda dal Sig. Dott. Gaetano Torraca in data di Civitavecchia 20 aprile 1778 in Antologia Romana, s. v. Antichità, IV, n. 44, maggio 1778, p. 345Tortorella 1981= S. Tortorella, Ceramica Aricana, Ceramica da cucina, in Enciclopedia dell’Arte Antica, Atlante delle forme Ce-ramiche, I, Roma 1981, pp. 208-224Uggeri 1968 = G. Uggeri, La terminologia portuale romana e la documentazione dell’Itinerario Antonino,in Studi italiani di ilolo-gia classica, 40, 1968, pp. 225-254Visconti 1782 - 1807 = E. Q. Visconti, Museo Pio Clementino in Le opere di Ennio Quirino Visconti, Milano 1818 - 1822Will 1982= E. L. Will, Greco-italic amphoras, in Hesperia 51, 3, 1982.Wiseman 1971 = T.P. Wiseman, New Men in the Roman Senate 139 B.C.-A.D. 14, Oxford 1971