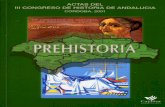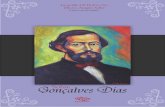Cantando l’esilio, da Gonçalves Dias a Chico Buarque e oltre…
Transcript of Cantando l’esilio, da Gonçalves Dias a Chico Buarque e oltre…
Cantando l’esilio, da Gonçalves Dias a Chico Buarque e oltre…
163
Cantando l’esilio, da Gonçalves Dias a Chico Buarque e oltre…
Enrico Martines
In un convegno che ha nell’esilio uno dei punti tematici fondamenta-li, è quasi scontato per chi, come me, si occupa di letteratura lusofona, rivolgere l’attenzione verso il Brasile e verso uno dei testi principali di quella letteratura, vero e proprio certificato di nascita delle lettere na-zionali, la Canção do Exílio di Gonçalves Dias. Oggetto di numerose riprese intertestuali nel corso dei quasi due secoli di storia della nazio-ne brasiliana, la canzone romantica ha avuto il merito di costituire un patrimonio iniziale di simboli che fanno riferimento a un problema centrale in tutto questo periodo.
La cultura del Brasile è infatti contrassegnata da un universo simbo-lico comune legato a una ideologia nazionalista. Il problema dell’affer-mazione di una identità nazionale è sempre stato centrale nel paese (libe-
Parte seconda. I luoghi: identità e linguaggio
164
ratosi da una posizione coloniale nel XIX secolo), prima come necessità assoluta corroborata in pieno dall’estetica romantica, poi come esigenza di affermare una autonomia culturale, cavalcata nel secolo successivo dai modernisti, quindi come bisogno di ritrovare una patria in cui potersi riconoscere, nel doloroso passaggio della dittatura militare e più in gene-rale nelle contraddizioni della società brasiliana contemporanea.
Questo universo simbolico è dominato dal tema dell’esilio, un to-pos condiviso e alimentato nella letteratura brasiliana, in particolare dalla poesia, sin dall’inizio della storia politica e culturale di quel pae-se. Un tema, lanciato dalla Canção do Exílio di Gonçalves Dias, ripreso da molti autori, da diverse prospettive ideologiche e culturali e secon-do diverse riorganizzazioni formali e tematiche. Un esilio spaziale, un esilio temporale, un esilio individuale, un esilio collettivo: la patria è il terreno fertile comune, creatore di sentimenti e idee messe in poesia da vari scrittori, che hanno sentito la necessità di riprendere non solo la questione della nazione, ma le stesse immagini utilizzate per primo da Gonçalves Dias. Un processo intertestuale che ha assunto forme differenti, dalla parafrasi alla parodia, ora critica ora amaramente po-lemica, come vedremo, limitandoci doverosamente a una selezione delle riprese testuali più significative, tra le Canções do Exílio esistenti. L’esilio, comunque, è in Brasile uno spazio letterario nel quale si in-crociano e si confrontano differenti visioni del mondo1.
Gonçalves Dias scrisse la sua poesia nel 1843 a Coimbra, in Porto-gallo, dove il poeta studiava Diritto. La Canção – che apre la sua rac-colta d’esordio, Primeiros Cantos, pubblicata nel 1846 – rappresenta innanzitutto un sentimento universale ed eterno, la nostalgia e l’ide-alizzazione del proprio paese (il Brasile nasce come nazione nel 1822, in piena voga del Romanticismo, ed è questa estetica che ha creato la maggioranza dei valori essenziali della sua cultura). C’era la necessità
1 Vedi S. H. Cyntrão, Nossos Bosques Têm mais Vida, canções de exílio e evasão: a poética de identidade nacional, disponibile on-line <http://www.germinaliteratura.com.br/sabiasee-xilios/nossosbosquestemmaisvida.htm> (ultimo accesso 11/02/2011).
Cantando l’esilio, da Gonçalves Dias a Chico Buarque e oltre…
165
di esaltare la patria e di opporla alla antica potenza coloniale, cosa che Gonçalves Dias afferma nel suo componimento, che ha il merito di associare l’ufanismo – ovvero l’affermazione esaltata della propria patria2 – a una grande efficacia verbale.
Canção do Exílio
Kennst du das Land, wo die Zitronen [blühen,
Im dunklen Laub die Gold-Orangen [glühen?
Kennst du es wohl? – Dahin, dahin!Möcht ich… ziehn.
[Conheces o país onde florescem as[laranjeiras?
Ardem na escura fronde os frutos [de ouro…
Conhecê-lo? Para lá, [para lá quisera eu ir!]
Goethe (tradução de Manuel [Bandeira)
Minha terra tem palmeiras,Onde canta o Sabiá; As aves, que aqui gorjeiam,Não gorjeiam como lá.
Nosso céu tem mais estrelas,Nossas várzeas têm mais flores,Nossos bosques têm mais vida,Nossa vida mais amores.
Em cismar, sozinho, à noite,Mais prazer encontro eu lá;Minha terra tem palmeiras,Onde canta o Sabiá.
Minha terra tem primores,Que tais não encontro eu cá;Em cismar – sozinho, à noite –Mais prazer encontro eu lá;Minha terra tem palmeiras,Onde canta o Sabiá.
Não permita Deus que eu morra,Sem que eu volte para lá;Sem que desfrute os primoresQue não encontro por cá;Sem qu’inda aviste as palmeiras,Onde canta o Sabiá.
2 Il termine “ufanismo” è utilizzato in Brasile in riferimento all’opuscolo scritto nel 1900 da Afonso Celso, intitolato Porque me Ufano do Meu País.
Parte seconda. I luoghi: identità e linguaggio
166
In questa, come nelle seguenti trascrizioni delle poesie, abbiamo sot-tolineato gli elementi verbali degni di commento, in quanto topoi og-getto di ripresa intertestuale.
Si osserva come il poeta cerchi di rappresentare l’eccellenza della patria attraverso le figure delle “palmeiras” e del “sabiá” che, insieme all’“io” lirico, sono gli elementi fondamentali ripetuti nei due versi ini-ziali che funzionano da refrão o estribilho in tutto il componimento. La palma, per la sua imponenza, era già considerata un simbolo dagli indios Tupi, che chiamavano il Brasile Pindorama, ossia “terra delle pal-me”. Il sabiá si caratterizza, oltre che per la bellezza delle sue penne, per il suo canto, un canto relativamente triste che configura la tristezza del poeta nostalgico. Non a caso, Gonçalves Dias scrive “Sabiá” con la lette-ra maiuscola: il volatile transita dallo spazio fisico a quello simbolico, in modo da rappresentare la superiorità della natura brasiliana, immagine dell’identità nazionale, e la stessa voce del poeta3. Si noti inoltre che la combinazione palmeiras-sabiá è un’invenzione poetica, non una realtà ecologica: l’accostamento di questi due elementi rappresenta più che altro l’unione della zona litorale (le palme) e dell’interno del paese, ter-ritorio preferenziale, anche se non esclusivo, del sabiá.
Un elemento paratestuale che spicca è sicuramente la scelta dell’epigrafe tratta dal romanzo di formazione Gli anni di apprendi-stato di Wilhelm Meister, di Goethe. Questo frammento della Ballata di Mignon, liberamente adattato da Gonçalves Dias, esprime proprio il desiderio di ritorno alla patria e costituisce un autorevole punto di riferimento per uno dei motivi portanti del Romanticismo.
Il poeta brasiliano sceglie per la sua poesia un metro semplice e po-polare, il verso settenario della redondilha maior, una struttura legata alla metrica medievale e trobadorica, coltivata da Dias e dai poeti romantici e profondamente radicata nella cultura popolare. L’efficacia espressiva è
3 Vedi W. J. Marques, O Poema e a Metáfora, in “Revista Letras”, 60 (jul./dez. 2003), pp. 79-93, disponibile on-line <http://www.scribd.com/doc/37638158/Artigo-O-poema-e-a-metafora> (ultimo accesso 11/02/2011).
Cantando l’esilio, da Gonçalves Dias a Chico Buarque e oltre…
167
ottenuta senza l’utilizzo di alcuna aggettivazione diretta. Gli elementi linguistici che danno maggiore espressività poetica sono avverbi e pro-nomi, possessivi e dimostrativi; soprattutto si osserva uno schema com-parativo tutto giocato sull’opposizione tra un “cá” disdegnato e un “lá” esaltato. Dopo la presentazione degli attributi esclusivi della patria lon-tana nella prima strofa (“palmeiras” e “sabià”), la seconda strofa introdu-ce il confronto tra attributi comuni in cui l’avverbio “mais” scandisce ri-petutamente la superiorità della realtà naturale brasiliana. La lontananza da quella realtà provoca l’isolamento fisico e psicologico del poeta, che si sente “sozinho”, e il conseguente sentimento di saudade, motore del componimento, che sfocia nell’accorata invocazione finale.
La Canção di Gonçalves Dias ha contribuito decisivamente alla elevazione della natura tropicale a metafora della nazione, una com-ponente fondamentale nel processo di costituzione dell’immagine del paese, intrapreso dalla élite colta brasiliana nel XIX secolo. Nell’in-tento di costruire una visione idealizzata del Brasile, la poesia recu-pera e concretizza il tradizionale progetto di edenizzazione della na-tura tropicale, riprendendo e affermando il mito che aveva avvolto il Brasile sin dai primordi della sua colonizzazione, quello del Paradiso Terrestre. La lontananza dalla terra natale è la condizione necessaria a questa trasfigurazione, perché pone il poeta nella condizione migliore per lanciare, dal di fuori, uno sguardo idealizzante sulla patria e per scegliere gli elementi naturali cui attribuire un valore simbolico.
Il componimento di Gonçalves Dias ottenne un immediato succes-so. Una prima ripresa, più tematica che intertestuale in senso stretto, si ebbe nel 1847, con la poesia A Noite da Minha Terra inserita nel romanzo A Divina Pastora di Caldre e Fião, considerato il padre della letteratura del Rio Grande do Sul. Ritroviamo l’io lirico che, di notte, in solitudine, esalta i meriti di un “lá” – che corrisponde alla città natale, Porto Alegre – contrapponendoli a un “Aqui” indesiderato, Rio de Ja-neiro. Una dialettica che si svolge tutta all’interno del Brasile, dunque4.
4 Vedi A. E. Alarcón Vaz, Canção do exílio e seus intertextos portugueses no século XIX, in
Parte seconda. I luoghi: identità e linguaggio
168
Una prova della repentina e crescente popolarità della poesia di Gonçal-ves Dias è riscontrabile anche nella pubblicazione di una sua versione parodiata già nel 1848, sul giornale Correio da Tarde5.
“Cadernos Literários” (FURG), 7 (2002), pp. 19-24, disponibile on-line <http://www.dla.furg.br/ecodosul/abralic.pdf> (ultimo accesso 11/02/2011). La poesia in questione, A Noite da Minha Terra, recita: “Fugiu do dia a brancura, / Chega a noite em sombra en-volta, / Traz no aspecto a feiúra, / Traz a negra trança solta; / Não vem garbosa e toucada / Das estrelas rutilantes / Espalhar pelos amantes / Prazeres de enamorada // O janeiro se entristece / Sem luz para refletir / No jardim a flor fenece / Não vê-se o campo sorrir; / Aqui é tudo tristeza / Quando vem da noite a face / Não goza do amor enlace / A tristonha natureza. // Mas lá no meu Porto Alegre / Como és, noite graciosa! / Lá tu não tens quem te regre / Com matina ruidosa / A hora do alevantar: / Podes com doce alegria / O poder do curto dia / Sobre a terra disputar. // Em teus braços a natura / La gosta bem de brincar, / E na tua formosura / Sua face retratar. / Como corre ameno o rio / Copiando o arvoredo / Quando tu por um brinquedo / Tens com Vênus desafio! // Como aqui es poeirosa, / Abafada e sem primor / Não sabes da amante ansiosa / Favorecer doce amor? / Lá quando frios ventilam / Desabridos Minuanos / Fere amor sem fazer danos / Os corações que vaci-lam. // Teu véu de graça deixaste / Nos morros da minha terra, / Lá onde,amiga brincaste, / Com os pinheiros da serra? / Teus raios de luz sutil / O Guaiba os recolheu? / Aqui tens a cor do breu / E lá tens a cor do anil. // Lá deixaste as baforagens / Da rosa e dos alecrins / Do Caí nas doces margens / Perfumadas de jasmins? / La deixaste as cantorias, / E tocatas primorosas / Que em horas silenciosas / Nos enchiam de harmonias? // Oh deixaste!… E indo há pouco / Lá no céu do meu país / Da palmeira amaste o coco, / Foste soberba e feliz! / Viste as fontes de cristal, / Sussurro dos pessegueiros, / Os mal-me-queres rasteiros / Co’a cor do rico metal. // Viste elegante a Matriz / Da minha linda cidade / Viste o alto que se diz / Da Bronze e a Caridade; / Tu Viste o ‘Caminho Novo’ / De sarandins todo orlado, / ‘De Belas Caminho’ amado / Pelo bom gosto do povo. // Quanto és boa oh doce amiga! / Lá no tempo do verão! / Minorar n’água a fadiga / P’ra o Riacho todos vão. / A tua luz que ali cai / Em ondas toda se espraia, / Não há divisa nem raia / Para a gente que lá vai. // Aqui de nuvens coberta / Não dás o menor prazer, / Não há uma flor aberta / Que perfume o teu viver. / Na Niterói decantada / Sempre triste te encontrei! / Que não amas eu bem sei / A terra do sol queimada! // Como é que nestes ardores / Podes viçosa existir! / Para os meus e teus amores / Vamos sozinhos fugir? / Oh, que vamos! Eu bem sei / Que vais lá graças ganhar, / E eu alegre saudar / A terra que tanto amei // Aqui estás triste em degredo, / E lá tens a cor do céu! / Daqui me leva em segredo / Embrulhado no teu veu, / Que o não saibam estas gentes / Senão quando eu lá me achar, / Pois nem eu nem tu estar / Podemos aqui contentes”.5 Marques, O Poema e a Metáfora, cit., p. 90, che riporta un frammento della parodia: “Minha terra tem silvados / Onde canta o rouxinol, / Onde canta a toutinegra / E o cuco no pôr do sol. // Qu´estrelas que por lá vão! / Que flores de cor subida! / Que vida na-
Cantando l’esilio, da Gonçalves Dias a Chico Buarque e oltre…
169
Un altro importante poeta romantico, Casimiro de Abreu, vissuto a Lisbona tra il 1854 e il 1857, è autore di due esplicite parafrasi del-la Canção che, peraltro, sono di livello inferiore rispetto all’originale. La prima è l’omonima Canção do Exílio, del 1855, in cui Casimiro utilizza gli stessi elementi e segue la stessa linea ideologico-estetica: le “palmeiras”, il “sabiá”, l’esagerata esaltazione della patria e la nostalgia causata dalla lontananza, il riferimento alla morte.
Canção do Exílio
Eu nasci além dos mares:Os meus lares,Meus amores ficam lá!– Onde canta nos retirosSeus suspiros,Suspiros o sabiá!
Oh! Que céu, que terra aquela,Rica e belaComo o céu de claro anil!Que seiva, que luz, que galas,Não exalas,Não exalas, meu Brasil!
Oh! Que saudades tamanhasDas montanhas,Daqueles campos natais!Que se mira,Que se mira nos cristais!
Não amo a terra do exílioSou bom filho,Quero a pátria, o meu país,Quero a terra das mangueirasE as palmeirasE as palmeiras tão gentis!- - - - - - - - - - - - - - - - - -Distante do solo amado– Desterrado –a vida não é feliz.Nessa eterna primaveraQuem me dera,Quem me dera o meu país!
queles bosques! / Que amores naquela vida! // Em cismar sozinho à noite / Que prazer eu tinha lá! / Minha terra é um paraíso, / Que não encontro por cá! /”; e aggiunge, in nota 18: “Segundo Lúcia Miguel Pereira, ‘Publicada no Correio da Tarde de 5/01/1848, essa versalhada, que continua no mesmo tom, com uma dedicatória visivelmente destinada
Parte seconda. I luoghi: identità e linguaggio
170
Nella seconda, intitolata Canção do Exílio Meu Lar (1857), non si di-scosta di molto, anche se aggiunge un riferimento nostalgico all’infan-zia e sostituisce le palmeiras con le laranjeiras (aranci), il che ristabilisce la corretta associazione tra albero e uccello.
Canção do Exílio Meu Lar
Se eu tenho de morrer na flor dos [anos,
Meu Deus! não seja já;Eu quero ouvir na laranjeira, à
[tarde,Cantar o sabiá!
Meu Deus, eu sinto e tu bem vês [que eu morro
Respirando este ar;Faz que eu viva, Senhor! dá-me de
[novoOs gozos do meu lar!
O país estrangeiro mais belezasDo que a pátria, não tem;
E este mundo não vale um só dos [beijos
Tão doces duma mãe!
Dá-me os sítios gentis onde eu [brincava
Lá na quadra infantil;Dá que eu veja uma vez o céu da
[pátria,O céu do meu Brasil!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - E sozinho cismando no
[crepúsculoOs sonhos do porvir!
Se eu tenho de morrer na flor [dos anos,
Meu Deus! não seja já;Eu quero ouvir na laranjeira, à
[tarde,Cantar o sabiá!
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Entrambe le canzoni di Casimiro de Abreu furono pubblicate nel 1859 nella raccolta delle sue poesie, intitolata As Primaveras.
Ma la stessa letteratura portoghese presenta esempi di influenza della Canção do Exílio gonçalvina. Poeti di scuola ultraromantica come
a bulir com algum figurão – coisa tão do gosto dos jornais do tempo – só tem o valor de mostrar a repercussão dos versos de Gonçalves Dias.’ Cfr. Pereira, op. cit., p. 99, sem grifos no original”. L’indicazione bibliografica completa dell’opera cui si fa riferimento in nota è L. M. Pereira, A vida de Gonçalves Dias, J. Olympio, Rio de Janeiro, 1943.
Cantando l’esilio, da Gonçalves Dias a Chico Buarque e oltre…
171
João de Lemos, José Antônio da Rocha Galo e Francisco Guilherme Pinto Monteiro, durante il loro esilio in terra straniera – l’Inghilterra per il primo, il Brasile per gli altri due – sono autori di risposte alla celebre poesia brasiliana, in cui traspare la necessità di affermare un orgoglio nazionalistico risentito, con il locale rouxinol (usignolo) chia-mato a prendere il posto del sabiá come simbolo delle bellezze naturali della patria lontana6.
Lo stesso si osserva in ulteriori riprese – a volte povere parafrasi del testo originale – destinate ad accompagnare partiture musicali, che testimoniano comunque la popolarità della Canção brasiliana in Portogallo7.
Tornando in ambito brasiliano, un’altra importantissima ripresa della poesia di Gonçalves Dias si ha nel 1909, quando Osório Duque Estrada scrive il testo dell’inno brasiliano, in cui, all’inizio della secon-da strofa, cita due versi della Canção do Exílio, decretandone ufficial-mente il valore di simbolo nazionale:
Do que a terra mais garridaTeus risonhos, lindos campos têm mais flores;“Nossos bosques têm mais vida”,“Nossa vida” no teu seio “mais amores”.
6 Vedi Alarcón Vaz, Canção do exílio, cit. e Portugal no Sul do Brasil: Intertextos da “Can-ção do Exílio”, in “Revista Letras”, 59 (jan./jun. 2003), pp. 225-237, disponibile on-line <http://www.letras.ufpr.br/documentos/pdf_revistas/vaz59.pdf> (ultimo accesso 11/02/2011). La poesia di João de Lemos si intitola A Lua de Londres e venne implicita-mente messa in ridicolo da Eça de Queirós che, nel III capitolo de Os Maias, la fa decla-mare da Eusebiozinho (questo episodio s’inserisce nell’ambito della generale critica che il romanziere porta avanti nei confronti della cultura ultraromantica). Sia il componimento di Rocha Galo sia quello di Pinto Monteiro scelgono come titolo le prime due parole della Canção gonçalvina, ossia Minha Terra.7 Cfr. B. Berrini, Utopia, utopias, visitando poemas de Gonçalves Dias e Manuel Bandeira, EDUC, São Paulo 1997, pp. 181-199.
Parte seconda. I luoghi: identità e linguaggio
172
Se – come dicevamo – il Brasile come nazione indipendente nasce nel 1822, si può dire che una cultura genuinamente nazionale si af-fermi solo cento anni più tardi, quando il modernismo avvia e forse realizza il suo processo di piena indipendenza. Il movimento moder-nista modifica il modo di guardare la realtà brasiliana, mettendo in discussione il ritratto ottimista del paesaggio tropicale e prendendo coscienza dei problemi economici e culturali derivanti dall’eredità coloniale. I simboli dell’identità nazionale, presenti nella Canção do Exílio di Gonçalves Dias, vengono ripresi e riutilizzati in una prospettiva critica. Le riletture del poema gonçalvino parlano della tematica dell’assenza e della distanza non più in termini esclusiva-mente geografici, non più lamentando la nostalgia romantica della patria, ma soprattutto nel senso di una inadeguatezza della persona al contesto sociale, culturale e politico. Il Brasile emerge in questi componimenti come uno spazio che circoscrive fisicamente il poeta ma non lo rappresenta, non lo contiene più simbolicamente. Il paese non è concepito più come patria natale e l’individuo si sente esiliato nella propria terra8.
Uno dei principali esponenti della prima generazione modernista, Oswald de Andrade, promotore della Semana de Arte Moderna del 1922 e autore del Manifesto Antropófago, ha scritto un Canto de Regres-so à Pátria, pubblicato nel 1925 nella raccolta Pau-Brasil. L’evidente ripresa intertestuale ha un carattere parodico e rientra pienamente nel-la tendenza modernista di criticare visioni tradizionaliste della lettera-tura, com’era considerata anche la poesia romantica. Oswald, precur-sore dell’antropofagia culturale, fagocita i versi di Gonçalves Dias, ne riproduce il metro tradizionale, ma in realtà costruisce una poesia che ha un senso ben diverso. La letteratura modernista era ancora nazio-nalista, ma di un nazionalismo differente, e Canto de Regresso à Pátria
8 Vedi B. Moraes Vieira, Onde Canta o Sabiá, in “Nossa História”, 5 (2004), disponibile on-line <http://bancodetextos.blogspot.com/2006/06/canes-do-exlio.html> (ultimo ac-cesso 11/02/2011).
Cantando l’esilio, da Gonçalves Dias a Chico Buarque e oltre…
173
critica non tanto l’elemento nazionale in sé, quanto l’idealizzazione ufanista del Romanticismo, richiamando l’attenzione sull’alienazione sociale esistente nel Brasile contemporaneo9.
Canto de Regresso à Pátria
Minha terra tem palmaresonde gorjeia o marOs passarinhos daquiNão cantam como os de lá
Minha terra tem mais rosasE quase que mais amoresMinha terra tem mais ouroMinha terra tem mais terra
Ouro terra amor e rosasEu quero tudo de láNão permita Deus que eu morraSem que volte para lá
Não permita Deus que eu morraSem que volte pra São PauloSem que veja a Rua 15E o progresso de São Paulo
Dando un rapido sguardo all’ipertesto oswaldiano, notiamo innanzi-tutto la sostituzione di “palmeiras” con “palmares”. Apparentemente un semplice sinonimo, che però rimanda a Zumbi dos Palmares, il capo di una rivolta di schiavi, catturato e decapitato nel 1695, una probabile sottolineatura del fatto che la poesia era scritta a soli trentasette anni dall’abolizione della schiavitù in Brasile. Un altro particolare che si evidenzia è che a cantare non è il sabiá ma il mare. D’altronde, Oswald è uomo urbano e del litorale (São Paulo), dun-que si perde il riferimento all’interno del Brasile, la faccia moderna del paese è tutta rivolta verso il mare, i centri del commercio e della produzione sono sulla costa. Il sostantivo “aves” viene trasformato
9 Cfr. A. Rocha Dantas, Relação intertextual: a paródia entre Canção do Exílio de Gonçalves Dias e Canto de Regresso à Pátria de Oswald de Andrade, pubblicato il 9/07/2010 nel sito <http://www.webartigos.com>, disponibile on-line <http://www.webartigos.com/articles /42327/1/Relacao-intertextual-A-parodia-entre-Cancao-do-Exilio-de-Goncalves-Dias-e-Canto-de-Regresso-a-Patria-de-Oswald-de-Andrade/pagina1.html#ixzz1DfY9Cf3Z> (ul-timo accesso 11/02/2011).
Parte seconda. I luoghi: identità e linguaggio
174
nel diminutivo “passarinhos”, evidente manifestazione dell’intento di introdurre un tono più colloquiale, in contrasto con la tradizione. Questo è confermato – oltre che dalla soppressione della punteg-giatura, che dà alla poesia un ritmo più vicino al parlato – anche dall’espressione “quase que mais amores”, il che vuole anche indicare che il Brasile moderno ha più elementi fisici che sentimentali, che la nazione sta vivendo un periodo di particolare materialismo. A con-ferma di ciò verifichiamo che il “lá” cui il poeta vuole tornare non è il Brasile in generale ma la città di São Paulo e, in particolare, la Rua 15 (de Novembro), centro del progresso paulista.
Nonostante vengano utilizzate parole e frasi identiche o esistano relazioni iperonimiche (come tra “flores” e “rosas”), le due poesie ri-flettono diverse concezioni del mondo. L’ipertesto rovescia la visione delle cose presente nel prototesto. Nel testo originale, l’uomo ha il tempo di contemplare la natura in quanto creazione divina e ne trae motivo per esaltare la propria patria. Nel testo di Oswald, prevale la velocità, la dinamicità, il progresso e una visione materialista delle cose. L’affermazione dell’identità brasiliana nel poema di Gonçalves Dias è un discorso che ruota intorno all’“essere”, la ripresa moder-nista sottolinea l’ansiosa ricerca dell’“avere” (“Eu quero tudo de lá”). La parola “regresso”, il “ritorno” alla patria che caratterizza il titolo, fa intenzionalmente rima con “progresso”10. Dunque Oswald, nel momento in cui l’espressione letteraria brasiliana aveva più bisogno di affermazione, nell’ambito della rivoluzione modernista, riprende e ricontestualizza la poesia che per quasi un secolo era stata l’inno del sentimento nazionale.
Murilo Mendes, poeta della generazione degli anni Trenta, nella sua Canção do Exílio (pubblicata in Poemas, nel 1930) va ancora più in là, rispetto ad Oswald de Andrade, nell’utilizzo della parodia: la sua ri-
10 Si veda E. Fernandes de Souza, Canção do Exílio e Canto de Regresso à Pátria: um Diálogo, uma Paródia pubblicati in <http://www.portrasdasletras.com.br> (ultimo acces-so 7/11/2010).
Cantando l’esilio, da Gonçalves Dias a Chico Buarque e oltre…
175
lettura è una denuncia esplicita dell’invasione culturale ed economica che il Brasile sta subendo. Il suo è un esilio simbolico, giacché il poeta canta all’interno della sua patria.
Canção do Exílio
Minha terra tem macieiras da [Califórnia
onde cantam gaturamos de Veneza.Os poetas da minha terrasão pretos que vivem em torres de
[ametista,os sargentos do exército são
[monistas, cubistas,
os filósofos são polacos vendendo a [prestações.
A gente não pode dormircom os oradores e os pernilongos.
Os sururus em família têm por[testemunha a Gioconda.
Eu morro sufocadoem terra estrangeira.Nossas flores são mais bonitasnossas frutas mais gostosasmas custam cem mil réis a dúzia.
Ai quem me dera chupar uma [carambola de verdade
e ouvir um sabiá com certidão de [idade!
La denuncia è evidente nelle prime due strofe, in cui si succedono una serie di elementi insoliti, che dissacrano l’esaltazione romantica della flora e della fauna patrie: meli della California sui cui rami can-tano uccelli tropicali di Venezia! C’è una carnevalizzazione dei ruoli evidenziata nei versi seguenti, un mondo sottosopra in cui il sapere ha avuto la peggio rispetto alla logica della forza e del guadagno. Per-sino le liti in famiglia “hanno per testimone la Gioconda”, ossia un elemento straniero. In questa situazione, il poeta “muore soffocato in terra straniera”, nel senso che non si riconosce più – e non riesce più a vivere – in un paese che è pieno di ricchezze naturali (fiori, frutta) ma che la logica del commercio internazionale rende estre-mamente costose e inaccessibili al brasiliano medio. Il nazionalismo di questa poesia si basa su una profonda critica della realtà sociocul-turale brasiliana. Al poeta non resta che invocare un “sabiá” (torna il
Parte seconda. I luoghi: identità e linguaggio
176
simbolo di Gonçalves Dias) che abbia un certificato di nascita e di cittadinanza brasiliane11.
Durante la seconda guerra mondiale Guilherme de Almeida aveva composto una Canção do Expedicionário, musicata da Spartaco Rossi e dedicata ai soldati brasiliani. Un inno militare che riecheggia le mo-dinhas della musica popolare e il cui testo canta la natura brasiliana, esalta una serie di simboli nazionali e, non a caso, riprende per ben quattro volte, all’interno del ritornello, il distico di Gonçalves Dias “Não permita Deus que eu morra / Sem que eu volte para lá”12.
11 Vedi Cyntrão, Nossos Bosques Têm mais Vida, cit.12 Ecco il testo completo della Canção do Expedicionário: “Você sabe de onde eu venho? / Venho do morro, do Engenho, / Das selvas, dos cafezais, / Da boa terra do coco, / Da choupana onde um é pouco, / Dois é bom, três é demais, // Venho das praias sedosas, / Das montanhas alterosas, / Do pampa, do seringal, / Das margens crespas dos rios, / Dos verdes mares bravios / Da minha terra natal. // Por mais terras que eu percorra, / Não permita Deus que eu morra / Sem que volte para lá; / Sem que leve por divisa / Esse “V” que simboliza / A vitória que virá: // Nossa vitória final, / Que é a mira do meu fuzil, / A ração do meu bornal, / A água do meu cantil, / As asas do meu ideal, / A glória do meu Brasil. // Eu venho da minha terra, / Da casa branca da serra / E do luar do sertão; / Venho da minha Maria / Cujo nome principia / Na palma da minha mão, // Braços mornos de Moema, / Lábios de mel de Iracema / Estendidos para mim. / Ó minha terra querida / Da Senhora Aparecida / E do Senhor do Bonfim! // Por mais terras que eu percorra, / Não permita Deus que eu morra / Sem que volte para lá; / Sem que leve por divisa / Esse “V” que simboliza / A vitória que virá: // Nossa vitória final, / Que é a mira do meu fuzil, / A ração do meu bornal, / A água do meu cantil, / As asas do meu ideal, / A glória do meu Brasil. // Você sabe de onde eu venho? / E de uma Pátria que eu tenho / No bôjo do meu violão; / Que de viver em meu peito / Foi até tomando jeito / De um enorme coração. // Deixei lá atrás meu terreno, / Meu limão, meu limoeiro, / Meu pé de jacaranda, / Minha casa pequenina / Lá no alto da colina, / Onde canta o sabiá. // Por mais terras que eu percorra, / Não permita Deus que eu morra / Sem que volte para lá; / Sem que leve por divisa / Esse “V” que simboliza / A vitória que virá: // Nossa vitória final, / Que é a mira do meu fuzil, / A ração do meu bornal, / A água do meu cantil, / As asas do meu ideal, / A glória do meu Brasil. // Venho de além desse monte / Que ainda azula no horizonte, / Onde o nosso amor nasceu; / Do rancho que tinha ao lado / Um coqueiro que, coitado, / De saudade já morreu. // Venho do verde mais belo, / Do mais dourado amarelo, / Do azul mais cheio de luz, / Cheio de estrelas prateadas / Que se ajoelham deslumbradas, / Fazendo o sinal da cruz ! // Por mais terras que eu percorra, / Não permita Deus que eu morra / Sem que volte para lá; / Sem que leve por divisa / Esse “V” que simboliza / A vitória que virá: // Nossa vitória final, / Que é a mira do meu fuzil, / A ração do meu bornal, / A água do meu cantil, / As asas do meu ideal, / A glória do meu Brasil”.
Cantando l’esilio, da Gonçalves Dias a Chico Buarque e oltre…
177
Subito dopo la guerra, il grande poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade pubblica la sua Nova Canção do Exílio nella raccolta A Rosa do Povo (1945).
Nova Canção do Exílio
Um sabiá napalmeira, longe.
Estas aves cantamum outro canto.
O céu cintilasobre flores úmidas.Vozes na mata,e o maior amor.
Só, na noite,seria feliz:um sabiá,na palmeira, longe.
Onde tudo é beloe fantástico,só, na noite,seria feliz.(Um sabiá,na palmeira, longe.)
Ainda um grito de vida evoltarpara onde tudo é beloe fantástico:a palmeira, o sabiá,o longe.
È il Drummond poeta pubblico e politico che, in un lavoro interte-stuale in cui – come si può vedere – sono numerosi gli elementi ripresi dalla poesia di Gonçalves Dias, mette in evidenza la condizione penosa dell’uomo, allontanato dalla sua terra natale. Cronologicamente distanti un secolo, i due poeti si avvicinano attraverso i simboli che compongo-no i due testi: gli elementi “sabiá”, “palmeira” e l’“io” lirico riappaiono come simboli del poeta creatore e dello spazio della terra natale. Ma nel-la sua poesia Drummond va oltre il nazionalismo e la nostalgia della pa-tria, parlando piuttosto di uno spazio idealizzato, dei luoghi immaginari associati alla terra d’origine, uno spazio “onde tudo é belo / e fantástico”. Importante è notare come l’avverbio “longe” sostituisca il “lá”, non solo ampliando il concetto spaziale ma rimandando anche a un aspetto tem-
Parte seconda. I luoghi: identità e linguaggio
178
porale, il tempo lontano dei ricordi. Il “longe”, è il luogo da cui il poeta proviene, lontano non solo geograficamente ma anche cronologicamen-te. Questa distanza, questo allontanamento, costituiscono il suo esilio. Carlos Drummond de Andrade mantiene i riferimenti concreti alla bel-lezza del suo “longe”: “céu”, “flores”, “mata”, “amor”, ma senza il tono ufanista di Gonçalves Dias. Drummond si limita a constatarli, con una descrizione sobria, ma non meno lirica di quella del poeta romantico. Si può dire che il registro della poesia drummondiana sia impressionista, soprattutto se osserviamo i due versi iniziali: “Um sabiá na / palmeira, longe”. Il poeta si serve di due simboli (il “sabiá” e la “palmeira”) che sono già radicati nell’immaginario del lettore. Dunque, si limita a enun-ciarli. Drummond conclude la sua poesia con l’idea della speranza di un ritorno: “Ainda um grito de vida e / voltar”, proprio come aveva fatto Gonçalves Dias: “Nao permita Deus que eu morra / Sem que eu volte para lá”. La rilettura di Drummond della Canção romantica, ancora una volta, non distrugge i simboli utilizzati dall’illustre predecessore ma li impiega aggiungendogli nuove sfumature, esprimendo l’idea che a un esilio fisico possa unirsi un esilio temporale13.
Mário Quintana, nella sua personale rilettura, intitolata Uma Can-ção (in Poesias, 1962), non presenta un esilio geografico, ma l’incapa-cità del poeta di adattarsi alla situazione che lo circonda: l’“onde” e l’“agora” dell’ultimo verso della seconda strofa.
13 Cfr. S. H. Cyntrão, A Ideologia nas Canções de Exílio: Ufanismo e Crítica, Dissertação apresentada ao Departamento de Teoria Literária e Literaturas da Universidade de Bra-sília como requisito para obtenção do título de Mestre em Literatura Brasileira, 1988, pp. 56-60, disponibile on-line <http://repositorio.bce.unb.br/bitstream/10482/3969/1 /1988_SylviaHelenaCynt%C3%A3o.pdf> (ultimo accesso 14/02/2011); C. Macha-do, Canções do Exílio, in “poesia.net”, 174 (2 de Agosto de 2006), disponibile on-line <http://www.algumapoesia.com.br/poesia2/poesianet174.htm> (ultimo accesso 14/02/2011).
Cantando l’esilio, da Gonçalves Dias a Chico Buarque e oltre…
179
Uma Canção
Minha terra não tem palmeiras…E em vez de um mero sabiá,Cantam aves invisíveisNas palmeiras que não há.
Minha terra tem relógios,Cada qual com sua hora
Nos mais diversos instantes…Mas onde o instante de agora?
Mas onde a palavra “onde”?Terra ingrata, ingrato filho,Sob os céus da minha terraEu canto a Canção do Exílio!
Ci troviamo di fronte a una prospettiva differente, a un altro tipo di esilio: lo spazio non è quello fisico-geografico ma quello dell’in-teriorità del poeta. Il dilemma esistenziale lo porta a negare i due valori fondamentali del prototesto, come si vede nella prima strofa. Il poeta non riesce ad aderire alla realtà circostante e si chiede di quale tempo e di quale spazio si parli quando si afferma “minha terra”. È il tempo il fattore fondamentale, come si vede nella seconda strofa, è il momento presente che il poeta non riesce a capire e la sua è una terra ingrata, che non può dare felicità ai suoi figli. Come Murilo Mendes, anche Quintana è un esule nella sua terra. Eppure, nell’ultimo ver-so, pare riaffermarsi, nonostante tutto, il valore dell’azione del poeta e c’è l’esplicito riferimento al poema romantico di Gonçalves Dias, simbolo di quella nazione da cui, nel momento presente, si sente intimamente esiliato.
La musica popolare brasiliana (o MPB) è stato un altro terreno in cui la Canção do Exílio ha prolungato la sua sfera di influenza. La let-teratura, intesa come movimenti collettivi, perde in Brasile, negli anni Sessanta, il contatto con il momento storico caratterizzato dal colpo di stato militare del 1964. Era soprattutto nella musica che si stabiliva-no i comportamenti estetici che orientavano l’espressione artistica: la Bossa Nova era considerata il movimento che apriva nuovi orizzonti, non solo dal punto di vista musicale. Un settore della Bossa Nova era politicizzato e si faceva portavoce delle inquietudini del periodo. E visto che le avanguardie poetiche avevano intrapreso percorsi elitari, il
Parte seconda. I luoghi: identità e linguaggio
180
pubblico cominciò a cercare in altre forme di espressione paralettera-ria la poeticità che prima leggeva nei libri. Così esponenti illuminati della MPB, come Caetano Veloso e Chico Buarque da Hollanda veni-vano visti, ascoltati, ma anche letti come poeti14.
Ed è di Chico Buarque – in collaborazione con Antônio Carlos Jobim, che compone la musica e scrive i versi dell’ultima strofa – la canzone Sabiá, del 1968. I versi di colui che oggi è noto non solo come l’autore della celeberrima Banda, ma anche come apprezzato romanziere, richiamano il tono nostalgico della poesia di Drummond e costruiscono un discorso sulla realtà brasiliana contrassegnato dalla denuncia sottile e amara della sua carenza. Ironicamente, la canzone fu all’epoca considerata eccessivamente disimpegnata da parte di un settore del pubblico di sinistra: Sabiá aveva partecipato a un festival musicale e aveva vinto a scapito della canzone Caminhando di Geraldo Vandré, esplicitamente e appassionatamente schierata contro lo sta-tus quo. Il tono nostalgico delle parole di Sabiá esasperava i militanti dell’epoca, i quali, in un momento di forzato manicheismo politico, non capirono che Chico stava reinterpretando la Canção do Exílio di Gonçalves Dias alla luce della dittatura militare, usando l’ironia per esprimere un discorso critico altamente negativo. L’esilio interiore cantato nei versi di Sabiá, diventò ben presto per Chico Buarque un esilio vero e proprio, visto che il cantante decise di fermarsi in Italia, e il 1968 fu effettivamente il momento della grande diaspora degli intellettuali costretti a fuggire per evitare prigione e tortura. Sabiá finì per affermarsi come un inno di questo esilio politico, legato alla re-pressione della dittatura militare15.
14 Vedi Cyntrão, Nossos Bosques Têm mais Vida, cit.15 Ibidem e Machado, Canções do Exílio, cit.
Cantando l’esilio, da Gonçalves Dias a Chico Buarque e oltre…
181
Sabiá
Vou voltarSei que ainda vou voltarPara o meu lugarFoi lá e é ainda láQue eu hei de ouvir cantarUma sabiá
Vou voltarSei que ainda vou voltarVou deitar à sombraDe uma palmeiraQue já não háColher a florQue já não dáE algum amor Talvez possa espantarAs noites que eu não queriaE anunciar o dia
Vou voltarSei que ainda vou voltarNão vai ser em vãoQue fiz tantos planosDe me enganarComo fiz enganosDe me encontrarComo fiz estradasDe me perderFiz de tudo e nadaDe te esquecer
Vou voltarSei que ainda vou voltarE é pra ficarSei que o amor existeNão sou mais tristeE a nova vida já vai chegarE a solidão vai se acabarE a solidão vai se acabar
Travestito da nostalgia per la terra natale e in aperto dialogo con la poesia di Gonçalves Dias – peraltro, uno dei simboli del nazionali-smo dittatoriale – il tema della libertà politica è finemente trattato nel testo che, al di fuori del suo contesto sociopolitico, potrebbe sem-brare un mero canto di ritorno alla patria. I versi di Chico Buarque si caratterizzano per la ripetizione del sintagma verbale “Vou voltar” (“Tornerò”): oltre a ricordare che, mentre scrive queste parole, il poeta si trova in Brasile, dunque si tratta di un ritorno simbolico a una con-dizione perduta; è necessario sottolineare la scelta del tempo verbale, il futuro perifrastico che indica il fermo proposito di realizzare una azione, o la certezza che essa sarà realizzata in un futuro prossimo.
Parte seconda. I luoghi: identità e linguaggio
182
Dunque, a differenza di Gonçalves Dias che affidava la sua speranza di ritorno (fisico) ai disegni divini, Chico dimostra una ferma e decisa volontà personale di ritornare a un Brasile che non c’è più. Il discorso del poeta compositore è contrassegnato infatti dalla denuncia della inadeguatezza del Brasile attuale, i cui attributi principali – esalta-ti nel Romanticismo – sono negati, ma che un giorno torneranno a poter essere fruiti dal brasiliano, momentaneamente esiliato dalla sua libertà: tornerà a stendersi sotto la palma che non c’è più, a cogliere il fiore che non sboccia più e qualche amore ‘forse’ – qui il poeta è più cauto – tornerà a sorprendere le notti solitarie e indesiderate. L’avver-bio “talvez”, che ironicamente modifica l’asserzione di Gonçalves Dias (“Nossa vida mais amores”), ricorda l’analoga espressione (“Quase que mais amores”) usata da Oswald nel suo Canto de Regresso à Pátria. Chiaramente, notte e giorno sono rispettivamente il simbolo dell’op-pressione vigente e della nuova libertà annunciata da Chico, grazie alla quale la sofferenza e i sacrifici fatti – vedi la terza strofa – non saranno stati inutili16.
Nei decenni successivi altre importanti rivisitazioni della poesia romantica hanno prolungato l’operazione di costante rinnovamento e adeguamento dei suoi simboli alla realtà brasiliana e alle nuove mo-dalità espressive.
João Paulo Paes, poeta contemporaneo, propone nel 1973 (nella raccolta Meia-Palavra) una Canção de Exílio Facilitada. “Facilitata” re-cita il titolo, in realtà la canzone di Paes è un testo per iniziati, il cui linguaggio non assolve a una funzione esplicativa: poesia estremamen-te sintetica, il suo significato può essere interpretato solo alla luce della conoscenza del prototesto di Gonçalves Dias.
16 Cfr. A. Bezerra de Menezes, As Canções de Exílio, in V. Bosi, O Poema: Leitores e Leituras, Ateliê Editorial, Cotia 2001, pp. 105-138.
Cantando l’esilio, da Gonçalves Dias a Chico Buarque e oltre…
183
Canção de Exílio Facilitadalá?ah!
sabiá…papá…maná…sofá…sinhá…
cá?bah!
Questa poesia presenta un totale sgretolamento della sintassi discor-siva e può essere vista come uno dei migliori esempi della poesia bra-siliana postmoderna. Il poeta sfrutta il valore fonico del significante e l’espressività di segnali grafici come il punto interrogativo, l’esclama-tivo, i puntini di sospensione. Riprende la rima ossitona del poema di Gonçalves Dias, concentrando l’espressione del significato nell’oppo-sizione degli avverbi “cá” e “lá” e delle interiezioni “ah!” e “bah!”.
L’inizio della poesia mostra la soddisfazione del poeta che ricorda ele-menti di uno spazio e di un tempo lontani. Gli ultimi due versi esprimo-no l’amarezza e la rabbia per la situazione in cui si trova il Brasile in quel 1973. Paes riprende il contenuto simbolico della canzone di Gonçalves Dias e ne dà una rielaborazione formale assolutamente rivoluzionaria, ridotta all’osso. Il poeta non può più cantare liberamente, pena la prigio-ne o l’esilio, dunque scrive una parodia della celebre canzone romantica utilizzando solo nove parole e qualche segno grafico di punteggiatura17.
Poeta e cronista che ha sempre caratterizzato la sua opera per la vis polemica, Dalton Trevisan incentra la sua letteratura, particolarmente acida e contundente, sui temi e i personaggi della città di Curitiba e
17 Vedi Cyntrão, A Ideologia nas Canções de Exílio, cit., pp. 79-82.
Parte seconda. I luoghi: identità e linguaggio
184
dello Stato del Paraná. La sua Canção de Exílio (pubblicata la prima volta nel 1984, nel supplemento Cultura del giornale “Estado de São Paulo”), ennesimo rifacimento in chiave parodica del testo gonçalvi-no, sposta la tematica nazionalista su un piano regionale. I versi si rife-riscono ripetutamente a elementi, passati e presenti, che compongono l’immaginario sociale paranaense e che sono oggetto di satira. Ciò ha suscitato diverse interpretazioni e reazioni da parte dei personaggi citati nel componimento.
Canção de Exílio
Não permita Deus que eu morrasem que daqui me vásem que diga adeus ao pinheiroonde já não canta o sabiámorrer ó supremo desfruteem Curitiba é que não dácom o poetinha bem viu o que
[fizeramo Fafau e o Xaxufa gorjeando os
[versinhosna missa das seis na igreja da Ordemo trêfego Jaime batia palminhasem Curitiba a morte não é séria[…]castigo bastante é viver em Curitibamorrer em Curitiba é que não dánão permita Deussó bem longe daquimais prazeres encontro eu lá[…]O Vinholes e o Mazza gorjeando os
[primoresque tais não encontro eu cá
não permita Deussem que daqui me vá minha terra já não tem pinheiroo sabiá não canta maisperdeu as penas enterrou no peito o
[bico afiadode sangue tingiu a água sulfurosa do
[rio Belémao último pinheiritofoi demais o dentinho de ouro do
[ex-padre Emircom raízes e tudo arrancou-se das
[pedrasmontou numa nuvem ligeirae voou sim sobre as asas do
[bem-te-vi[…]ó supremo desfruteem Curitiba que não dánão permita Deus que eu morrasem que daqui me vánunca mais aviste os pinheirosonde já não canta o sabiá
Cantando l’esilio, da Gonçalves Dias a Chico Buarque e oltre…
185
I tratti caricaturali della scrittura di Dalton Trevisan hanno determi-nato lo svuotamento ideologico del mito creato dal prototesto. La sua poesia-cronaca si apre con la citazione del primo verso dell’ultima strofa della canzone di Gonçalves Dias, il cui significato viene comple-tamente rovesciato: il poeta non è lontano dalla sua terra, dunque non aspira a tornarvi, anzi si augura, come ultimo desiderio, di riuscire a lasciarla. Sul “pinheiro” tipico del sud del Brasile, che significamente sostituisce la palmeira della tradizione nazionalista, non canta più il “sabiá”, perché l’uomo ha contaminato la natura. La società della sua città, nella quale vivere è un castigo, è ritratta come mediocre, superfi-ciale e ipocrita. Trevisan la critica, ora citando determinati personaggi, ora facendo riferimento a tradizioni locali. Si tratta, dunque, di un altro poeta che si sente esiliato nella propria terra. Ma se, nei casi os-servati in precedenza (Oswald e Murilo Mendes), la rivisitazione del prototesto evidenziava una componente parodica, nel caso del com-ponimento di Trevisan c’è la completa dissacrazione del significato romantico dei simboli, la perdita di qualsiasi componente nazionalista e la rottura definitiva tra il soggetto e la sua terra, qui rappresentata dalla città di Curitiba. E se anche Oswald aveva localizzato nella città di São Paulo lo spazio fisico oggetto della sua Canção, Trevisan, al contrario del poeta modernista, rinnega totalmente il contesto urbano in cui è costretto a vivere18.
Icona della cosiddetta geração mimeógrafo o geração marginal che, negli anni di piombo della dittatura militare, faceva circolare la sua poesia graffiante in edizioni clandestine, Antônio Carlos de Brito, noto come Cacaso, applicò le sue doti di poeta satirico a una enne-sima ripresa intertestuale, in chiave parodica, della Canção do Exílio. Jogos Florais – questo il nome del duplice componimento scritto negli anni Settanta ma pubblicato solo nel 1985 in Beijo na Boca e Outros Poemas – è un tipico esempio di poema-piada, ossia di poesia intesa come scherzo attraverso il quale dire ironicamente alcune verità sco-
18 Ivi, pp. 63-71.
Parte seconda. I luoghi: identità e linguaggio
186
mode, già coltivato dai modernisti e utilizzato dalla geração marginal per esprimere il proprio dissenso19.
Jogos Florais I Jogos Florais II
Minha terra tem palmeirasonde canta o tico-ticoEnquanto isso o sabiávive comendo o meu fubá
Ficou moderno o Brasilficou moderno o milagrea água já não vira vinhovira direto vinagre
Minha terra tem palmaresmemória cala-te jáPeço licença poéticaBelém capital Pará
Bem, meus prezados senhoresdado o avanço da horaerrata e efeitos do vinhoo poeta sai de fininho.
(será mesmo com esses dois essesque se escreve paçarinho?)
L’acida parodia di Cacaso critica il presunto “miracolo economico” degli anni Settanta. Il sabiá della tradizione scambia il suo posto con un altro uccellino il tico-tico, reso celebre dalla composizione musicale (nel gene-re dello choro) Tico-tico no fubá: il sabiá romantico diventa simbolo del Brasile dittatoriale e nazionalista che “vive comendo o meu fubá”, vive “mangiando la mia farina di mais” ossia, alle spese della povera gente. Nella seconda parte, Cacaso riprende il primo verso del Canto do Regresso à Pátria di Oswald ma in qualche modo rifiuta una possibile continuità, imponendo alla memoria di tacere immediatamente e chiedendo “licen-za poetica” per chiudere il componimento in chiave altamente ironica.
19 Vedi D. Santos, Cacaso, um marginal transgressor, Cacaso. A Transgressão na Poesia raccol-ta di testi disponibile on-line <http://www.letraselivros.com.br/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=806>; testo precedentemente pubblicato in www.revistaetcetera.com.br (ultimo accesso 18/02/2011).
Cantando l’esilio, da Gonçalves Dias a Chico Buarque e oltre…
187
Nel 1985 era stato pubblicato anche un altro rifacimento della po-esia di Gonçalves Dias, la Outra Canção do Exílio, di Eduardo Alves da Costa, inclusa nella raccolta No Caminho, com Maiakóvski. L’autore appartiene alla schiera di coloro che si sentono esiliati nella propria terra e si ribella con i suoi versi: l’obiettivo del suo sentimento di rivolta è, ancora una volta, il potere politico e la situazione sociale del Brasile, di cui Alves da Costa comincia con il denunciare una componente particolarmente popolare nel suo paese, il gioco del calcio, criticato nelle sue manifestazioni più distorte.
Outra Canção do Exílio
Minha terra tem Palmeiras,Corínthians e outros timesDe copas exuberantesQue ocultam muitos crimes.As aves que aqui revoamSão corvos que nunca mais,A povoar nossa noiteCom duros olhos de açoiteQue os anos esquecem jamais.
Em cismar, sozinho, ao relento,Sob um céu poluído, sem estrelas,Nenhum prazer tenho eu cá;Porque me lembro do tempoEm que livre na campinaPulsava meu coração, voava,Como livre sabiá; ciscandoNas capoeiras, cantando Nos matagais, onde hoje a morteTem mais flores, nossa vidaMais terrores, noturnos De mil suores fatais.
Minha terra tem encantosde recantos naturais,praias de areias monazíticas,subsolos mineraisque se vão e não voltam mais.
A chorar sozinho, aflito,penso, medito e reflito,sem encontrar solução;a não ser voar para dentro,voltar as costas à miséria,à doença e ao sofrimento,que transcendem o quanto possamo pensamento concebere a consciência suportar. Minha terra tem palmeirasa baloiçar indiferentesaos poetas e dementesque sonham de olhos abertos,a rilhar os dentes.
Parte seconda. I luoghi: identità e linguaggio
188
Minha terra tem primores,requintes de boçalidade,que fazem da mocidadeum delírio amordaçado:acrobacia impossívelde saltimbanco esquizóide,equilibrado no risível sonhode grandeza que se esgarça e rompe,roído pelo matreiro cupim da
[safadeza.
Não permita Deus que eu morrapelo crime de estar atento;e possa chegar à velhicecom os cabelos ao ventode melhor momento.Que eu desfrute os primoresdo canto do sabiá,onde gorjeia a liberdadeque não encontro por cá.
Il poeta gioca con il famoso primo verso della canzone di Gonçalves Dias: la parola “Palmeiras”, non a caso scritta con maiuscola, non rimanda qui a un simbolo della natura brasiliana, ma al nome di una delle squadre più famose di São Paulo (“Corinthians”, che apre il ver-so seguente è il nome di una delle rivali cittadine), e le “copas exube-rantes” non sono qui, chiaramente, le chiome degli alberi ma i trofei accumulati dai club calcistici. Nella prima strofa, Eduardo Alves da Co-sta denuncia il fanatismo dei tifosi, la violenza negli stadi, ma soprattut-to la strumentalizzazione del calcio da parte del regime dittatoriale. Il caso più eclatante si ebbe in occasio-ne della vittoriosa Coppa del Mon-do del 1970, utilizzata dal governo Médici come strumento di propaganda politica e servita per sviare l’attenzione dalla repressione, dalla censura e dalla violenza esercitate contro chi denunciava gli abusi di potere del regime. Successivamen-te il poeta denuncia anche l’inquinamento come conseguenza negati-va del progresso: la dialettica “cá”/“lá” contrappone il presente, in cui
Cantando l’esilio, da Gonçalves Dias a Chico Buarque e oltre…
189
non c’è “nenhum prazer” a un tempo passato in cui era libero, come il “sabiá”, e cantava felice in quei boschi dove oggi regna il crimine. La sua terra possiede enormi ricchezze, materiali e umane, ma la realtà politica del paese non permette di sfruttarle e distrugge le speranze delle nuove generazioni: l’oppressione è sintetizzata nell’espressio-ne “delírio amordaçado” e la repressione politica in “duros olhos de açoite”. L’unica soluzione, dice il poeta, è l’alienazione, il voltare le spalle alla realtà; in effetti, la stessa scrittura della poesia è un atto politico che contraddice questa soluzione. La successiva ripresa del primo verso del prototesto rappresenta l’ennesimo rovesciamento del suo valore originario: le “palmeiras”, simbolo del Brasile, dondolano indifferenti a “poetas e dementes”, ossia ai brasiliani che soffrono e sognano ad occhi aperti. Dunque, l’esilio cantato da Eduardo Alves da Costa deriva dalla mancanza di libertà vigente nel suo paese: il poeta teme che il regime possa chiudergli gli occhi, quegli occhi che hanno commesso il crimine di vedere troppo. Eppure la conclusione del poema è un messaggio di speranza, la speranza in un futuro mi-gliore in cui anche il “sabiá” possa recuperare il suo valore di simbolo di un canto libero.
Più brevemente, citiamo ancora una Canção do Exílio mais recente di Afonso Romano de Sant’Anna (fine anni Ottanta), esteso poema in cui, al di là del titolo, non ci sono altre riprese intertestuali. Dedi-cato a Fernando Gabeira, un intellettuale effettivamente esiliato negli anni Settanta, il componimento riassume il concetto di esilio politico, dell’esilio nella propria terra e di un esilio interiore:
[…] Não ter um paísa essa altura da vida,a essa altura da história,a essa altura de mim, – é o que pode haver de desolado.[…] E eu aqui, no nenhum-desse-lugar, estrangeiroexilando-me ao revés […]
Parte seconda. I luoghi: identità e linguaggio
190
Infine, si segnala una più recente (2000) Nova Canção do Exílio del poeta maranhaense Ferreira Gullar, che è tuttavia una poesia d’amore: è l’ama-ta del poeta, non la sua terra, ad avere “palmeiras” e “passarinhos”20.
L’insieme delle riprese della Canção do Exílio compone un quadro in cui le stesse immagini sono viste da diverse angolature e riflesse da molteplici specchi che ne modificano l’aspetto e il contenuto, ma che attualizzano uno stesso problema fondamentale. Il prototesto di Gonçalves Dias ha avuto il merito di identificare e combinare in modo originale i simboli della nazionalità, aprendo così la strada percorsa posteriormente da altri poeti per parlare, ognuno utilizzando la propria estetica e la propria prospettiva ideologica, della terra natale, in partico-lari momenti di crisi nazionale: nel 1922, quando i modernisti procla-marono l’indipendenza culturale, poi durante l’Estado Novo di Vargas, negli anni Trenta, e ancora nel lungo periodo della dittatura militare negli anni Sessanta e Settanta, i cui echi si ripercuotono nei decenni successivi. Una Canção do Exílio che è così riuscita a funzionare come un ipertesto capace di mantenersi in sintonia con il suo tempo.
20 Pubblicata nel giornale “O Globo”, Caderno “Prosa & Verso”, del 2 settembre 2000, la poesia recita: “Minha amada tem palmeiras / Onde cantam passarinhos / e as aves que ali gorjeiam / em seus seios fazem ninhos // Ao brincarmos sós à noite / nem me dou conta de mim: / seu corpo branco na noite / luze mais do que o jasmim // Minha amada tem palmeiras / tem regatos tem cascata / e as aves que ali gorjeiam / são como flautas de prata // Não permita Deus que eu viva / perdido noutros caminhos / sem gozar das alegrias / que se escondem em seus carinhos / sem me perder nas palmeiras / onde cantam os passarinhos”.