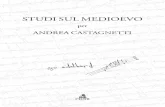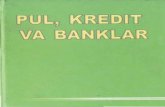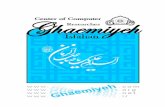2011. “L'anima va alla guerra.”
Transcript of 2011. “L'anima va alla guerra.”
1 Rhode 1898 è sempre fondamentale sull’idea di psyche nella cultura greca di età arcaicae classica.
2 La migliore discussione della caratterizzazione di psyche in Omero resta Bremmer 1983,pp. 14 ss., 74 ss.
CLEMENTE MARCONI
L’ANIMA VA ALLA GUERRA
Psyche, il termine greco che più di ogni altro si avvicina all’italiano‘anima’, deve con ogni probabilità la sua origine etimologica al verbo psy-chein, che significa ‘soffiare’, ‘respirare’1. Tale legame etimologico rendefortemente probabile che all’origine psyche avesse un’accezione puramentefisica, significando semplicemente soffio, o respiro. Tale significato origi-nario trova talvolta ancora riflesso in Omero, in quelle situazioni in cui lapsyche è detta ‘esalare’, come quando Andromaca sviene alla vista del ca-davere di Ettore (Iliade XXII, 467).
In Omero, tuttavia, psyche è già realtà assai più complessa, rappresen-tando la forza vitale dell’essere vivente2. Collocata in una parte imprecisatadel corpo, la psyche resta inattiva, o almeno non è menzionata, quando ilcorpo è attivo. Essa entra invece in azione quando una persona è in una si-tuazione di crisi. È da questi passi che si evince che la psyche è intesa comeforza vitale, essenziale per la sopravvivenza dell’individuo, fino a identifi-carsi tout court con la vita. Come quando Achille insegue Ettore attorno aTroia, e Omero commenta che i due corridori non competono per un anima-le da sacrificare o una pelle di bue, ma per la psyche di Ettore domatore dicavalli (XXII, 161). Sovente, la psyche lascia il corpo quando un uomosviene: quando Pelagonte estrae la lancia dalla coscia di Sarpedone, l’eroesviene e sui suoi occhi scende la nebbia (V, 696).
È però al momento della morte che viene spesso impiegata l’immaginedella psyche che lascia il corpo, come nei casi di Ettore (XXII, 362) e Pa-troclo (XVI, 856). Questa volta la psyche lascia il corpo e questo mondoper sempre, per dirigersi verso l’Ade: meta che sarà raggiunta solo a condi-
64 CLEMENTE MARCONI
3 Come nel fr. 131b Snell/Maehler: cfr. Bremmer 1983, p 7, pp. 79 s.4 Gundert 2000.5 Le principali discussioni di questa iconografia sono: Johansen 1967; Stähler 1967;
Kossatz-Deissmann 1981, pp. 138 ss.; Peifer 1989, pp. 73 ss. Cfr. anche Shapiro 1994b e 1994c.
zione che il cadavere abbia ricevuto sepoltura, come nel caso esemplaredella psyche di Patroclo (Iliade XXIII, 71 ss.). Una volta entrata nell’Ade,la psyche consisterà nell’immagine senza sostanza del defunto, priva di vitae condannata a un’esistenza eterna e infelice, stando alle celebri parole diAchille a Odisseo (Odissea XI, 488 ss.).
In ambito letterario l’immagine omerica della psyche attraversa incon-trastata gran parte dell’età arcaica. A partire dal quinto secolo però, a quan-to pare sotto l’influsso di nuove dottrine religiose, specie l’Orfismo, si fastrada un’idea della psyche intesa come essenza dell’individuo, capace disopravvivere al corpo, e magari perfino di trasmigrare. La testimonianzaprincipale al riguardo viene da Pindaro (Olimpica II, 56 ss.), che dimostraanche come questa nuova concezione non sostituisse necessariamente quel-la omerica, ma potesse anzi esserle associata3. Ben più sintomatici circa latrasformazione semantica del termine psyche al passaggio dall’età arcaica aquella classica, però, sono i testi medici, dato che qui psyche si incontraspesso usata in contrasto con soma, ‘corpo’, rasentando una polarità nonmolto lontana dalla nostra, tra anima e corpo4.
La trasformazione dell’idea omerica di psyche al passaggio dal sesto alquinto secolo è documentata, oltre che dai testi, anche dalle immagini, inparticolare dai vasi dipinti ateniesi. Documenti tanto più preziosi in quantoci introducono in una sfera, quella delle credenze popolari, che è difficileda cogliere tramite i testi letterari.
È precisamente alle immagini che è dedicato questo studio, in particola-re a due iconografie della ceramografia ateniese che coinvolgono l’eroeomerico per eccellenza, Achille: il trascinamento del cadavere di Ettore at-torno alla tomba di Patroclo, e la psicostasia, ovvero la pesatura delle animedi Achille e Memnone nell’occasione del loro duello.
Nella ceramica attica, le rappresentazioni di Achille che trascina il ca-davere di Ettore attorno alla tomba di Patroclo si distribuiscono nell’arcodei due ultimi decenni del sesto secolo a.C.
Due sono gli schemi adottati: il primo presenta il carro ancora fermo,con il cadavere di Ettore già legato; il secondo presenta il carro in pienomovimento, con i cavalli lanciati al galoppo5.
65L’ANIMA VA ALLA GUERRA
6 Londra, British Museum 1899.7-21.3: Corpus Vasorum Antiquorum British Museum 3,III.He.7, tav. 36.1A-D.; Beazley 1931, p. 301; Beazley 1956, p. 330 num. 2; Johansen 1967, pp.139 ss., fig. 49, 264 B 18 a; Beazley 1971, p. 146; Kossatz-Deissmann 1981, tav. 117 Achilleus592; Carpenter 1989, p. 89; Peifer 1989, p. 81, p. 330 num. 39.
7 Cfr. Spieß 1992.
La più antica rappresentazione è su un’anfora a figure nere di tipo A alBritish Museum, proveniente da Vulci, e attribuita da Beazley al Pittore diPriamo (520 a.C.) (Fig. 1)6. Il pannello sul retro mostra amazzoni a cavalloe cani, mentre il lato principale è dedicato alla nostra storia, costruita se-condo il primo dei due schemi. Nel vaso quasi tutti i protagonisti sono ac-compagnati da iscrizioni: Ettore, anzitutto, rappresentato supino all’estremadestra del pannello, nudo e con le gambe, non visibili, già legate al carro,come si deduce dalle cosce sollevate; Achille, che volgendo le spalle al car-ro accenna a piegarsi verso il cadavere del rivale; l’eidolon di Patroclo, chesovrasta il tumulo, dipinto di bianco e decorato da un serpente di profilo, eche muove sospeso in aria verso il basso, lo scudo beotico sollevato, in at-teggiamento di combattimento. L’auriga, dall’enigmatico, non completa-mente leggibile nome di Koni[.]os, iscritto sopra i cavalli (questa almenol’interpretazione di Beazley); e infine il guerriero con scudo beotico cheprecede carro e cavalli, dal nome Olyteu(s), ovvero Odisseo. Completano lascena una figura alata dietro il carro, rivolta verso il tumulo di Patroclo, ap-parentemente senza nome (ma tracce di un sigma sono state in passato os-servate sotto il kappa del nome dell’auriga), identificata da Beazley eJohansen con Iride (quest’ultimo ha spiegato la sua presenza già in questascena come un’anticipazione del ruolo svolto dalla messaggera nell’invitareAchille a desistere dallo strazio del cadavere di Ettore: Iliade, XXIV, 77ss.,104ss.); e un cane, rappresentato in secondo piano dietro i cavalli, e con ilnome inscritto, al pari degli altri eroi (Pha[id]ros). Come sostenuto partico-larmente da Johansen, non c’è dubbio che la scena di questo vaso faccia ri-ferimento al principio del libro XXIV dell’Iliade, quando Achille si appre-sta a trascinare il cadavere di Ettore attorno alla tomba di Patroclo.
In Omero, è Achille ad avere personalmente aggiogato i cavalli e a gui-dare il carro, mentre sul vaso, il carro è guidato da un auriga. È questa la pri-ma libertà del Pittore rispetto al testo di Omero, alla quale si affianca la nonmeno significativa aggiunta di Odisseo, per sé estraneo all’episodio. È evi-dente, come già notava Johansen, che il Pittore aveva in mente, nel rappre-sentare la scena, l’iconografia della partenza del guerriero, dove di frequen-te si osservano guerrieri e cani che affiancano o precedono il carro7. E cheil riferimento a quello schema iconografico lo abbia indotto a introdurre
66 CLEMENTE MARCONI
8 Munich, Antikensammlungen 1719 (J. 407): Beazley 1956, p. 361 num. 13; Johansen1967, pp. 139 ss. fig. 48, 264 B 18 b; Beazley 1971, p. 161; Kossatz-Deissmann 1981, p. 140num. 595; Carpenter 1989, p. 95; Peifer 1989, p. 80, p. 330 num. 38; Shapiro 1994b, p. 31,fig. 17.
9 Lekythos, Delos 546: Beazley 1956, p. 378 num. 257 (Gruppo di Leagros); Johansen1967, pp. 139 ss., 264 B 18 c; Beazley 1971, p. 163; Schefold 1978, p. 234 fig. 313; Carpenter1989, p. 100; Kossatz-Deissmann 1981, tav. 117 Achilleus 588; Peifer 1989, p. 80, p. 330num. 37.
due elementi, il guerriero e il cane, per sé estranei al racconto omerico. Percompensare l’intrusione, alla figura del guerriero è stato dato un nome epi-co altisonante.
Lo schema dell’anfora del Pittore di Priamo, con il carro ancora fermo,si ritrova in altri due vasi ateniesi, entrambi attribuiti da Beazley al Gruppodi Leagros, e databili a un decennio più tardi (510 a.C.).
La prima è una idria a figure nere di Monaco, da Vulci8. Sul corpo delvaso è il combattimento tra Eracle e Gerione, mentre sulla spalla è la scenadel trascinamento del cadavere di Ettore, ridotta quanto a numero diprotagonisti rispetto all’anfora del Pittore di Priamo. L’iconografia, però, èmolto simile, con il carro guidato da un auriga fermo al centro, Ettore supi-no e legato al carro per le gambe (particolare qui messo in evidenza), e iltumulo dipinto di bianco, decorato da un serpente, e sovrastato dall’eidolondi Patroclo. Ci sono però anche tre differenze significative rispetto al primovaso. La prima è la presenza di Iride, riconoscibile dalle ali e dal caduceo,davanti al carro, in rapido movimento verso Achille. La seconda è la posi-zione dell’eidolon di Patroclo; anche qui rappresentato in movimento di at-tacco, ma aderente alla sommità del tumulo, e apparentemente non a mezz’a-ria. L’ultima, infine, riguarda la posizione di Achille, che appoggiandosi allalancia muove verso destra, e non si piega più verso il cadavere di Ettore.
Si apprezza meglio l’implicazione di quest’ultimo leggero cambiamen-to di posa rivolgendosi al secondo vaso del Gruppo di Leagros che adotta ilprimo schema. Si tratta di una lekythos da Delo, dove la scena di svolgetutta attorno al corpo (Fig. 2)9. Di nuovo, Achille non si piega verso il cada-vere di Ettore, ma muove in avanti verso la tomba di Patroclo tenendo duelance in una mano, lo scudo nell’altra. La scena è oramai trasformata in unasorta di incontro tra Achille e l’eidolon di Patroclo. Quest’ultimo è infattirappresentato in corsa a mezz’aria, a sinistra del tumulo, la testa elmata inlinea con la testa elmata di Achille, quasi in uno sguardo reciproco, mentreil piede avanzato sinistro è simbolicamente collocato in corrispondenza del-la testa di Ettore, anche se considerevolmente più in alto. Un secondo eido-lon, dipinto sul retro, ha pura funzione di riempitivo, tra la tomba di Patro-
67L’ANIMA VA ALLA GUERRA
10 Boston, Museum of Fine Arts 63.473: Corpus Vasorum Antiquorum Boston 2, tav. 82.1-3; Johansen 1967, pp. 150 s. fig. 55, 265 B 18 h; Beazley 1971, p. 164 num. 31bis; Boardman1974, fig. 203; Kossatz-Deissmann 1981, tav. 116 Achilleus 586; Carpenter 1989, p. 96; Peifer1989, p. 78 s., p. 330 num. 34; Carpenter 1991, fig. 316; Shapiro 1994b, p. 30, fig. 16.
clo e i cavalli; cionnondimeno, volge la testa indietro, come per assisterealla scena. Che questo vaso sia sulla stessa linea del precedente, è confer-mato dalla figura di Iride, che è ora rappresentata davanti all’auriga, comenell’atto di fermare il carro.
Rispetto ai vasi che adottano il primo schema, i vasi che adottano il se-condo, con il carro di Achille in corsa, hanno una caratterizzazione decisa-mente più drammatica, anche nelle pose dei vari protagonisti.
È questo il caso, anzitutto, di una celebre idria di Boston, attribuita daBeazley al Gruppo di Leagros (510 a.C.) (Fig. 3)10. In questo vaso, la scenadel trascinamento del cadavere di Ettore occupa il corpo del vaso, mentre laspalla mostra il movimentato episodio dello scontro tra Eracle e Cicno. Ciòche caratterizza questo vaso non è solo il fatto che il carro è rappresentatocon i cavalli al galoppo verso destra, nell’atto di passare al fianco dellatomba di Patroclo (solo il treno posteriore visibile). Ma anche il generaledinamismo dei protagonisti, che consuona, certo non per caso, con quellodella scena rappresentata sulla spalla. Così, l’auriga è piegato nell’atto distringere le briglie e guidare i cavalli; Achille è rappresentato nell’atto dibalzare sul carro; l’eidolon di Patroclo è di nuovo in corsa a mezz’aria asinistra della tomba (recante il nome dell’eroe), caratterizzata dalla presen-za alla base di un serpente di profilo. Compaiono nella scena, ad aumentarela drammaticità dell’immagine, i genitori di Ettore (non individuati da iscri-zione), stanti davanti a un edifico colonnato e con trabeazione dorica (spes-so identificato con la porta dardania menzionata in Iliade XXII, 412 s.):Priamo protende la mano destra verso Achille, come per supplicarlo (Achil-le, di rimando, gli rivolge lo sguardo); mentre Ecuba porta una mano allafronte, in un gesto di dolore frequentemente rappresentato in scene di fune-rale della pittura coeva. Oggetto della disperazione dei genitori, il cadaveredi Ettore è rappresentato nell’atto di essere trascinato, il corpo parzialmentesollevato dal terreno. L’apice della drammaticità, in questo vaso, si rag-giunge con la figura alata davanti all’auriga, da identificare con Iride, checorre a braccia levate in direzione di Achille, e con la posizione delle gam-be invertita rispetto all’eroe. È da notare che presso la tomba di Patroclo,all’estremità destra, è il ramo di un albero, chiaro riferimento alla pianapresso Troia. La scena del trascinamento del cadavere di Ettore, dunque, è
68 CLEMENTE MARCONI
11 Napoli, Museo Archeologico Nazionale H2746: Beazley 1956, p. 378 num. 258;Johansen 1967, p. 144, p. 265 B 18 k; Beazley 1971, p. 163; Kossatz-Deissmann 1981, p. 140num. 597; Carpenter 1989, p. 100; Peifer 1989, pp. 74 s., 329 num. 27.
12 Münster, Archäologisches Museum der Universität 565: Beazley 1971, p. 164 num. 31ter; Kossatz-Deissmann 1981, p. 140 num. 596; Korzus 1984, pp. 186 ss. num. 71; Peifer 1989,pp. 76 ss.
come se avesse luogo tra le due coordinate spaziali delle porte di Troia, edella pianura antistante: da un lato l’edificio con trabeazione dorica, dall’al-tro l’albero.
Al Gruppo di Leagros è attribuita da Beazely anche una lekythos diNapoli, che introduce, nell’ambito dello stesso schema del carro in corsa,una variante caratteristica dei monumenti successivi (510 a.C.)11. Gran par-te della scena è occupata dal carro in corsa verso destra che trascina il cada-vere di Ettore. Il carro è guidato da un apposito auriga, che però non èaccompagnato da Achille, come nell’idria di Boston: al contrario, Achille èrappresentato nell’atto di correre a gambe levate al fianco dei cavalli, e alcentro della scena, mentre rivolge la testa all’indietro, verso l’eidolon diPatroclo. Quest’ultimo è rappresentato a sinistra, mentre scende di corsadalla tomba verso il carro e il cadavere di Ettore. Alla base della tomba,sopra il cadavere di Ettore, è un serpente di profilo verso sinistra.
Sempre al Gruppo di Leagros è attribuita da Beazley un’idria frammen-taria di Münster, con lo stesso schema dei cavalli al galoppo e di Achilleche corre al loro fianco12. Proprio incontro ad Achille sembra slanciarsil’eidolon di Patroclo, sospeso a mezz’aria davanti alla tomba, alla cui base,al posto del consueto serpente, è un leone in posa alquanto aggressiva. È unpeccato che troppo poco si conservi di questo vaso: tanto più che a destradella tomba di Patroclo è una figura stante di non chiara identificazione, as-solutamente inusuale per questo genere di iconografia.
Questo vaso è per noi di enorme importanza, in quanto la parola psycheè stata dipinta a chiare lettere presso l’eidolon di Patroclo, nello spaziocompreso tra la piccola immagine di guerriero e la tomba. Si tratta di unaiscrizione tanto più sorprendente, dal momento che tali iscrizioni appostedai pittori, di solito, ci danno il nome dei protagonisti. Al quale qui si è ri-nunciato, preferendo, piuttosto, quello di un concetto astratto.
L’idria di Münster è fondamentale, in quanto dimostra come per i nostripittori la piccola figura di Patroclo presso la tomba non era intesa comesemplice eidolon dell’eroe – termine usato convenzionalmente, che signifi-ca ‘simulacro’ e che in Omero viene utilizzato in riferimento alle ombre deimorti –, ma come la sua psyche.
69L’ANIMA VA ALLA GUERRA
13 New York, Metropolitan Museum of Art 25.70.2: Haspels 1936, p. 233 num. 15;Johansen 1967, p. 144 fig. 51, p. 265 B 18 n; Kossatz-Deissmann 1981, p. 140 num. 598.
14 Parigi, Musée du Louvre CA 601: Perrot e Chipiez 1914, p. 688 fig. 374; Haspels 1936,p. 233 num. 31; Johansen 1967, p. 147, p. 265 B 18 o; Kossatz-Deissmann 1981, p. 140 num.599; Peifer 1989, p. 75 s., p. 329 num. 29.
15 Non sempre la rappresentazione del trascinamento del cadavere di Ettore include la tom-ba di Patroclo e l’eidolon. In due casi mancano sia la tomba che l’eidolon: a) Idria, San Pietro-burgo, Hermitage inv. 173 (510 a.C.): Beazley 1956, p. 362 num. 31 (Gruppo di Leagros);Johansen 1967, pp. 139 ss. fig. 50, 264 B 18 d; Beazley 1971, p. 161; Kossatz-Deissmann 1981,tav. 117 Achilleus 591; Carpenter 1989, p. 96. b) Cratere a volute, Già Darmstadt, CollezioneHeyl (510-500 a.C.): Johansen 1967, pp. 143 ss.; p. 264 B 18 e; Kossatz-Deissmann 1981, p.139 num. 589. In due casi, la tomba è rappresentata, ma l’eidolon è assente: a) Anfora, Londra,British Museum B 239, da Vulci (510 a.C.): Beazley 1956, p. 371 num. 147 (Gruppo di Lea-gros); Johansen 1967, p. 144, p. 264 B 18 f; Kossatz-Deissmann 1981, p. 140 num. 593;Carpenter 1989, p. 98. b) Lekythos, Cracovia, Museo Czartoryski 1245 (510 a.C.): Beazley1956, p. 380 num. 291 (Gruppo di Leagros); Johansen 1967, p. 147 ss., fig. 54, 265 B 18 l;Beazley 1971, p. 163; Kossatz-Deissmann 1981, p. 140 num. 590; Carpenter 1989, p. 100.
Due lekythoi databili al decennio successivo (500 a.C.), ed entrambeattribuite al Pittore di Diosphos, seguono la stessa iconografia, ma con inte-ressanti variazioni.
La prima, a New York, presenta qualche similarità con la lekythos diNapoli13. Di nuovo, la composizione è incentrata sul carro guidato da unauriga che trascina il cadavere di Ettore, con i cavalli affiancati da unguerriero in corsa nella stessa direzione ma con la testa rivolta all’indietro,e da identificare con Achille. All’estremità destra è la tomba di Patroclo,con l’eidolon che ne discende verso destra; e all’estremità sinistra è un al-bero spoglio, che allude alla pianura di Troia. Sotto i cavalli è un serpentein profilo verso destra.
La seconda, al Louvre (Fig. 4), presenta rispetto all’iconografia delleprime due alcune divergenze significative14. Al centro della composizione èsempre il carro che trascina il cadavere di Ettore, questa volta guidato da unguerriero. Sotto i cavalli torna di nuovo il serpente, ma a terra, al guerrieroaffiancato ai cavalli, in corsa e con la testa rivolta all’indietro, se ne aggiun-ge un secondo che precede il carro stesso, in corsa nella medesima direzio-ne. Infine, l’aspetto più significativo di questo vaso è la mancata indicazio-ne della tomba di Patroclo. Il cui eidolon, ora di proporzioni doppie rispettoall’usuale, discende di corsa verso il carro e lo stesso cadavere di Ettore15.
Quest’ultima lekythos costituisce l’ultimo documento figurativo che sipossa con certezza ricollegare al nostro mito; o meglio, l’ultimo vaso per ilquale si possa parlare di una iconografia trattata con competenza dal Pittore.
Già al Gruppo di Leagros, infatti, appartiene una rappresentazione delmito alquanto confusa: su un’anfora a Berlino, dall’Etruria (sul retro è la
70 CLEMENTE MARCONI
16 Berlino F1867: Beazley 1956, p. 371 num. 148; Johansen 1967, p. 147, p. 152, p. 265B 18 g; Beazley 1971, p. 162; Kossatz-Deissmann 1981, p. 139 num. 585; Carpenter 1989, p.99; Peifer 1989, p. 76, p. 329 num. 30, tav. 2.3.
17 Londra, British Museum B543: Haspels 1936, p. 208 num. 60; Johansen 1967, p. 147,p. 152, p. 265 B 18 m; Kossatz-Deissmann 1981, p. 140 num. 594; Peifer 1989, p. 76, p. 329num. 31.
18 Parigi, Bibliothèque Nationale, Cabinet des Médailles senza numero: Haspels 1936, p.226 num. 13; Johansen 1967, p. 147, p. 265 B 18 p; Kossatz-Deissmann 1981, p. 140 num. 600;Peifer 1989, p. 79 s., p. 330 num. 36.
19 Lekythos, Cambridge, Fitzwilliam Museum GR2.1955: Beazley 1956, p. 378 num. 259;Johansen 1967, p. 146 ss., p. 265 B 18 i; Kossatz-Deissmann 1981, p. 139 num. 587; Carpenter1989, p. 100.
20 Shapiro 1994a.21 Johansen 1967 resta lo studio di riferimento fondamentale.
triade delia, con Apollo che suona la cetra), è addirittura omesso il corpo diEttore, e Achille è rappresentato davanti al carro, nell’atto singolare dicorrergli incontro16. Non meno confusa è la scena su di una lekythos daGela, attribuita da Haspels al Pittore di Gela (510 a.C.)17: la scena è limitataall’auriga sul carro (compare un cane sotto i cavalli) e alla tomba di Patro-clo con il relativo eidolon, ma mancano sia Achille che Ettore.
Ci si chiede se in scene come questa sia rappresentato il nostro episo-dio. Un problema che si fa ancora più calzante nel caso di una lekythos diParigi, da Agrigento, attribuita da Haspels al Pittore di Saffo (500 a.C.)18.Qui si tratta di nuovo del trascinamento di un cadavere, di un tumulo, e diun eidolon: ma gli aurighi sul carro sono ora due guerrieri, mentre due altriguerrieri sono a terra, con movimento opposto a quello del carro (uno èdavanti al carro; l’altro, generalmente identificato con Achille, è dietro aicavalli). In una lekythos a Cambridge, poi, il pittore è arrivato al punto dimostrare un guerriero calpestato dai cavalli lanciati al galoppo, uno schematipico delle scene di battaglia (specie di Gigantomachia), ma che nulla ha avedere con il nostro mito19.
Le scene del trascinamento del cadavere di Ettore passate in rassegnaappartengono a un più largo gruppo di rappresentazioni di soggetti omericiche caratterizzano la ceramografia ateniese nell’ultimo quarto del VI seco-lo, e che toccano il culmine nel decennio a cavallo tra VI e V secolo. Datempo si è posta in relazione tale produzione con la riforma delle Panateneeoperata dai Pisistratidi, ai quali spettava, tra l’altro, l’introduzione di recita-zioni da Omero ad opera dei rapsodi20. C’è sufficiente evidenza, nei vasistessi, del fatto che le scene omeriche in essi rappresentate furono in molticasi dipinte proprio sotto l’effetto di tali recitazioni, presumibilmente ascol-tate direttamente dai pittori, o riportate loro da qualche conoscente21.
71L’ANIMA VA ALLA GUERRA
22 Cfr. più di recente Giuliani 2003 e 2004.23 Cfr. soprattutto Detienne 1983 e Calame 1988.
Naturalmente, non è da attendersi che tali rappresentazioni vascolarifossero intese dai pittori e dal pubblico come “illustrazioni” del testo (un’a-spettativa che ha invece caratterizzato la ricerca sul rapporto tra testi eimmagini degli ultimi decenni, portando a grossolane interpretazioni delfenomeno complessivo).
In una cultura orale – o meglio: aurale – come quella greca dell’etàarcaica e della prima età classica, tale possibilità è esclusa a priori22. Tantopiù che in tale cultura il mito è caratterizzato nella sua essenza da unasostanziale plasticità, essendo pronto a subire tante metamorfosi quantesono le sue enunciazioni23.
Ciò vale anche per le scene sui vasi, che in questo periodo sonochiaramente ispirate da un Omero ormai pressoché identico al nostro testo,ma che pure ne divergono continuamente, in particolari anche significativi.Ciò per il fatto che il pittore reinterpreta Omero, rappresentando come taleuna fonte eccezionale, che però non è stata come tale ancora sfruttata, perla ricezione dell’Iliade e dell’Odissea nella cultura popolare dell’epoca (al-la quale appartenevano certamente i pittori dei vasi, generalmente di bassolivello sociale).
Il caso delle scene in esame, dell’oltraggio al cadavere di Ettore, è em-blematico di questa situazione. Non c’è dubbio che le scene esaminate inprincipio si riferiscano a Omero, e al libro XXIV dell’Iliade, del resto l’uni-ca fonte disponibile per questo particolare episodio. Ma non c’è nemmenodubbio che i pittori dei vasi, pur riferendosi a Omero, lo reinterpretano, e sisentono liberi di modificare elementi del testo dell’Iliade in vario modo.Anche essenziali, come il fatto che nei vasi non è Achille a guidarepersonalmente i cavalli, ma un auriga, trasformato nel tempo in un guerrie-ro. O come il fatto che Achille, lungi dallo stare sul carro, è rappresentatonell’atto di correre accanto al carro stesso.
Prima di concludere, come farebbero studiosi recenti, che i pittori dipen-devano da una versione orale alternativa all’Iliade, data la discrepanza traimmagine e testo (una tesi assurda, dato che dovremmo concludere per l’esi-stenza di tante versioni orali di un mito quante le sue rappresentazioni nelmondo antico), è opportuno riflettere sul fatto che in altre scene relative allaguerra troiana Achille appare rappresentato allo stesso modo, in corsa. Cosìè nel caso dell’episodio di Troilo, dove il principe troiano è spesso rappre-
72 CLEMENTE MARCONI
24 Cfr. Kozzatz-Deissmann 1981, pp. 80 ss.; Knittlmayer 1997, pp. 80 ss.25 Cfr. soprattutto Vickers e Gill 1994 per la Grecia e Reusser 2002 per l’Etruria.
sentato su un cavallo lanciato al galoppo, mentre cerca di sfuggire ad Achil-le, che però correndo a gambe levate lo raggiunge e lo ghermisce da dietro24.
Ora, non c’è dubbio che questa propensione a rappresentare Achille agambe levate fosse funzionale a rendere visivamente l’epiteto più frequentedell’eroe in Omero, pié veloce. E quale occasione migliore della presenzadi cavalli per enfatizzare questa qualità? Per questa ragione, anche l’Achilleche dovrebbe guidare i cavalli per fare strazio del corpo di Ettore finiscespesso in questa iconografia col correre a fianco del carro stesso.
Può sembrare singolare che un pittore abbia deciso di stravolgere iltesto di Omero per mantenersi fedele ed enfatizzare un epiteto di Omero,ma così è.
Per spiegare questo fenomeno, giova accennare al problema della diffu-sione, del valore sociale, e della funzione della ceramica dipinta di produ-zione ateniese.
Oggi non vediamo più i vasi ateniesi con gli stessi occhi con cui li ve-devano le generazioni che ci hanno preceduto. In passato, si assumeva che ivasi dipinti ad Atene avessero un alto valore economico, e che fossero benidi lusso, destinati alle èlites della Grecia, dell’Italia, e di altri paesi del Me-diterraneo. Nel dare questo giudizio, non si faceva altro che riflettere l’altovalore monetario di questi vasi nella società moderna e contemporanea; manel contempo, si creava una grossa mistificazione. Un riesame delle fontiletterarie e delle iscrizioni ha dimostrato infatti che le èlites utilizzavanovasi di metallo prezioso, mentre un riesame dei prezzi indicati sui vasi diterracotta, e più ancora un riesame dei contesti di provenienza, ha dimostra-to che questi oggetti, seppur dipinti, rappresentavano un bene non moltocostoso25. Parlare di “classe media” per il mondo greco arcaico e classicopuò forse essere una grossa banalizzazione; ma, più o meno, oggi si può di-re che i vasi dipinti fossero appunto un bene mirato a quel livello sociale:per intenderci, né l’èlite, né i poveri. Con le debite eccezioni, s’intende.
Tutto questo non è senza importanza per la nostra interpretazione delleimmagini rappresentate sui vasi stessi.
La tendenza degli studi degli ultimi decenni, da quando l’iconologia hamesso piede nello studio della ceramica greca (con svariati decenni di ritar-do rispetto alla diffusione del metodo iconologico nello studio dell’arte delRinascimento), è stata quella di porre i vasi sullo stesso livello dei monu-menti pubblici della polis di età arcaica e classica. Secondo questa prospet-
73L’ANIMA VA ALLA GUERRA
26 Cfr. ad es. più di recente Knittlmayer 1997.27 Questo ho cercato di dimostrare in Marconi 2004b.
tiva, le rappresentazioni vascolari sarebbero un riflesso dei valori specificidella società ateniese, e avrebbero avuto un ruolo sostanziale nel ritrasmet-tere tali valori all’interno della stessa Atene26.
Contro tale interpretazione, però, sta il fatto che i vasi ateniesi, per lamaggior parte, non provengono da Atene; e che, nella stragrande maggio-ranza dei vasi ateniesi, manca Atene. Lungi dall’essere prodotti specificiper la società che li ha creati, i vasi ateniesi sono piuttosto prodotti di con-sumo per un vasto mercato, il cui immaginario non vale per la sola Atenema per qualsiasi città greca o hellenisant del Mediterraneo tra sesto e quin-to secolo a.C.27.
Questa genericità, o meglio apertura di significato dei vasi ateniesi, laloro funzione di bene di consumo per una “classe media” greca e non grecasi riflette, tra l’altro, nel fatto che tali vasi molto spesso sono zeppi di cre-denze “popolari” e di luoghi comuni. Come Achille pié veloce che correpiù veloce del carro che trascina il corpo di Ettore.
Ciò però non è senza importanza per un discorso sulle trasformazionidell’idea di psyche tra sesto e quinto secolo.
Ci sono infatti due divergenze rispetto al testo omerico nell’iconografiain esame che meritano la massima attenzione in questa sede. La primariguarda le dimensioni e la conformazione della psyche. Quando al princi-pio del libro XXIII dell’Iliade la psyche di Patroclo appare ad Achille, stesosulla spiaggia, essa è alquanto diversa da ciò che osserviamo nei vasi: «Edecco a lui venne l’anima del misero Patroclo, gli somigliava in tutto,grandezza, occhi belli, voce, e vesti uguali vestiva sul corpo» (Iliade XXIII,65-67). Ora, è vero che la psyche di Patroclo in questo episodio è solo unombra, come conferma il tentativo fallito di abbracciarla da parte di Achil-le, ma almeno le apparenze sono salve. Diversamente nei vasi, dove la psy-che di Patroclo è parecchio ridotta rispetto all’originale, apparendo comeuna vera e propria versione in miniatura dell’eroe.
Più grave è una seconda divergenza rispetto a Omero. Stando al poeta,la psyche, una volta cremato il corpo, non può più ritornare in questo mon-do, restando confinata nell’Ade. È appunto per essere cremata e sepolta chela psyche di Patroclo si rivolge ad Achille, per potere passare le porte del-l’Ade e non ritornare mai più.
Eppure qui, nei vasi, la psyche è rappresentata fuori della tomba, e inpiena azione. Più precisamente, la psyche sembra volare, dato che è posta in
74 CLEMENTE MARCONI
posizione elevata, non è generalmente in contatto con la tomba, corre, ed èspesso alata.
C’è però un particolare che colpisce: malgrado la psyche stia volando, erappresenti Patroclo in armi presso Achille e il cadavere del suo uccisoreEttore, essa in generale non dimostra di prendere parte attiva alla scena incorso, né di avere alcun contatto o rapporto diretto con le figure viventi(una regola dimostrata da eccezioni come la lekythos del Gruppo di Lea-gros da Delo e la lekythos del Pittore di Diosphos al Louvre). L’impressio-ne è che queste particolari soluzioni iconografiche rispecchino due ideemolto diffuse relative all’anima, di parziale derivazione omerica. Il movi-mento frenetico dell’eidolon, paradossalmente enfatizzato a livello visivodalle proporzioni ridotte della figura, dice che l’anima è principio vitale.Mentre il fatto che pur agitandosi tanto l’eidolon non ha parte attiva nellascena rappresentata, dice che dopo la morte l’anima è solo un ombra, e chenon può avere che un rapporto solo parziale con il mondo dei vivi.
Che l’anima sia immortale, invece, i vasi non lo dicono: è vero infattiche l’eidolon ha varcato le porte dell’Ade, apparendo sopra il sepolcro, maè anche vero che l’anima è rappresentata in armi e in stretto collegamentocon la tomba. Nulla di più lontano dal credo di un’anima immortale e beatadegli Orfici, dei Pitagorici, o di Pindaro.
Piuttosto, nel suo essere in armi come l’eroe, l’anima di Patroclo as-somiglia molto a uno spettro, allo spirito del morto. Al riguardo, la sua col-locazione in collegamento con la tomba, in un contesto di rituali funebri peril defunto, non può che ricordare l’apparizione dell’ombra di Dario nei Per-siani di Eschilo (681 ss.). Là, nel mentre la regina compie le offerte sullatomba del re, l’ombra di Dario riesce a emergere dall’Ade e appare maesto-sa al di sopra del tumulo, scioccando il coro.
Vi sono chiaramente due elementi in comune tra l’iconografia in esame equesta scena grandiosa: il primo è la credenza che l’eidolon può varcare le so-glie dell’Ade, e tornare sulla terra. Il secondo è che proprio l’esecuzione del ri-tuale funebre permette di creare un collegamento tra i defunti e i vivi. I defun-ti, infatti, sono presenti presso la tomba durante le cerimonie in loro onore.Non si può però certo confondere la maestosità di Dario nei Persiani diEschilo con l’anima di Patroclo nei nostri vasi. Ce lo impongono infatti dueelementi che caratterizzano la seconda: le dimensioni in miniatura e il fattodi volare. Ora, se le prime servono ad esprimere l’idea che l’anima è soloun’ombra della realtà, che appartiene a un altro mondo, pur essendo visibilein questo mondo, le ali hanno chiaramente una connotazione demoniaca ectonia: l’anima viene trasformata in una sorta di gorgone o di sfinge.
75L’ANIMA VA ALLA GUERRA
28 L’edizione dell’iscrizione si deve a Jameson, Jordan, e Kotansky 1993; i principali studisi devono a Dubois 1995; Clinton 1996; Burkert 1999, pp. 28 ss.; Burkert 2000, pp. 207 ss. L’i-scrizione è datata da Jameson, Jordan, e Kotansky 1993, p. 48 al 475-450, e da Burkert (Burkert1999, p. 29; Burkert 2000, p. 207) al 460. Per una più corretta datazione tra la fine del sesto ela metà del quinto secolo cfr. Cordano 1996, pp. 137 s.
29 Sugli elasteroi cfr. Jameson, Jordan, e Kotansky 1993, pp. 40 ss., pp. 116 ss.; Dubois1995, pp. 138 s.; Clinton 1996, pp. 174 ss.; Neue Pauly 1 (1996) s. v. Alastor pp. 434 s. (F.Graf); Burkert 1999, pp. 30 ss.; Burkert 2000, pp. 208 s.
Ho scritto di rappresentazioni nei vasi come espressioni di credenzepopolari.
Che l’anima di Patroclo rifletta credenze diffuse, nel mondo greco, ne-gli spettri, e negli spiriti dei morti è stato ipotizzato da tempo, e più direcente da Peifer, nel suo libro dedicato all’iconografia degli eidola nell’ar-te greca arcaica e classica. Su questi spettri, da qualche anno, disponiamodi un documento epigrafico di prim’ordine, ovvero la lex sacra di Selinun-te, pubblicata per la prima volta nel 199328.
L’epigrafe, su piombo, data alla transizione dal VI al V secolo, e pro-viene con ogni probabilità dal Santuario periurbano di Zeus Meilichio, cheha una chiara connotazione ctonia. L’iscrizione è un vero e proprio regola-mento cultuale destinato a un gruppo gentilizio, e contiene due testi. Il pri-mo, riguarda una serie di prescrizioni di sacrifici a varie divinità, Zeus Eu-menes, le Eumenidi, e i Tritopatori. Il secondo, che ci interessa più da vici-no, riguarda la purificazione di una persona che sia stata affetta daglielasteroi, ovvero gli spettri dei morti29.
Questo testo è senza dubbio una delle testimonianze più interessanti dietà classica relative agli spettri. L’elasteros è una creatura soprannaturalealla quale si sacrifica, e appartiene all’aldilà, all’Ade, come indicato dal fat-to che il sangue della vittima sacrificale deve colare al suolo. Più precisa-mente, l’elasteros è lo spirito vendicativo del morto, il demone che ne e-sprime la rabbia accanendosi, letteralmente come un’Erinni, sull’autore delcrimine. Ciò che sorprende in particolare di quest’iscrizione, è l’idea chel’aria, letteralmente, possa essere infestata da spiriti: ci sono infatti elaste-roi stranieri, ancestrali, che si sono uditi, che si sono visti, insomma di ognigenere, conclude l’iscrizione. Non si può non mettere in collegamento que-st’idea del demone del defunto che si agita vendicativo per ogni dove inquesto mondo in cerca dell’assassino con l’anima di Patroclo nei nostri va-si, che incombe piena di movimento sopra il cadavere di Ettore.
È con questa immagine in mente che ci dobbiamo rivolgere ora a un’al-tra iconografia di età arcaica e classica, quella del duello tra Achille e
76 CLEMENTE MARCONI
30 Per questa iconografia cfr. in generale Vermeule 1979, pp. 76 s., p. 160 s.; Kossatz-Deissmann 1981, pp. 172 ss.; Peifer 1989, pp. 33 ss.; Vollkommer 1992, pp. 19 ss.; Knittlmayer1997, pp. 100 ss.
31 Le fonti letterarie sono elencate e discusse da Peifer 1989, pp. 48 ss. e Vollkommer 1992,pp. 14 ss.
32 Le analogie / differenze tra pesatura delle anime nel Vicino Oriente e in Grecia sono si-stematicamente discusse da Vermeule 1979, pp. 160 ss. e Vollkommer 1992, pp. 14 s.
Memnone. Nel corso della guerra di Troia Achille si scontra con Memnone,e durante il duello Zeus decide di vedere chi dei due eroi prevarrà, pesando-ne le keres sotto gli occhi terrorizzati di Eos e Teti, le due madri30.
In letteratura la più antica occorrenza di questo episodio sembra fossecontenuta nella Etiopide di Arktinos di Mileto, che faceva pesare a Zeus lekeres di Achille e Memnone (Davies, EGF 47-48). Sarebbe stata propriol’influenza dell’Etiopide, secondo alcuni, a dettare l’inserzione di due epi-sodi analoghi nell’Iliade: nel libro XXII, dove sono pesate le keres diAchille e di Ettore (208-213), e nel libro VIII, dove vengono pesate le keresdei Greci e dei Troiani (68-74)31.
Da dove sia potuta giungere ad Arktinos l’ispirazione per questosoggetto resta tutt’altro che chiaro. In Egitto la psicostasia è documentatafin dalla metà del terzo millennio; presso gli Ittiti, invece, essa è documen-tata nella seconda metà del secondo millennio. Dato che Arktinos viveva aMileto, città che aveva parte considerevole nell’attività dell’emporio grecodi Naucrati, è possibile che l’ispirazione gli sia giunta dall’Egitto e per queltramite.
Questa derivazione dall’Egitto, e il fatto che l’idea di base di pesareuna realtà incorporea legata a un corpo sia analoga, non deve però fardimenticare che vi sono differenze sostanziali tra cultura egizia, ittita e gre-ca. Se in Egitto e presso gli Ittiti pesare l’anima ha una chiara implicazionedi natura etica, trattandosi di giudicare della rettitudine o meno del defunto,in Grecia ogni connotazione etica è assente. Le keres di due persone o diinteri gruppi vengono pesate solo per accertare quale vivrà e quale morirà.Ovvero, la pesatura è come una profezia senza appello. Malgrado questadifferenza di base, però, lo strumento è lo stesso: il giudizio più importantedi un essere (nell’aldilà per gli Egizi, nell’aldiqua e nell’aldilà per gli Ittiti,e solo nell’aldiqua per i Greci), si esegue tramite una bilancia32.
E ora veniamo alle rappresentazioni della scena nella ceramica atenie-se, che fanno la loro apparizione nell’ultimo quarto del VI secolo.
Comune ad esse è la presenza di un dio che tiene la bilancia in mano,con sui piatti gli eidola dei combattenti. La scena può essere estesa al punto
77L’ANIMA VA ALLA GUERRA
33 Vienna, Kunsthistorisches Museum, 3619: Beazley 1956, p. 140 num. 3 (vicino alGruppo E); Kossatz-Deissmann 1981, tav. 135 Achilleus 799; Carpenter 1989, p. 38; Peifer1989, p. 35 s.; Knittlmayer 1997, tav. 23; Vollkommer 1992, num. 57; Shapiro 1994b, p. 213,fig. 176.
34 Roma, Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia 57912: Beazley 1963, p. 72 num. 24;Kossatz-Deissmann 1981, tav. 136 Achilleus 804; Burn e Glynn 1982, p. 82; Carpenter 1989,p. 167; Peifer 1989, p. 36 s.; Vollkommer 1992, tav. 11 Ker 60; Knittlmayer 1997, tav. 24.1.
di includere i duellanti e le loro madri, o altre divinità, o ridotta al punto dilimitarsi al nucleo principale della pesatura.
La serie è aperta da un dinos a figure nere di Vienna (530-520 a.C.),dove la storia è rappresentata lungo l’imboccatura del vaso (Fig. 5)33. Alcentro della scena sono Zeus, seduto, e Ermes, in movimento verso destrama nell’atto di tenere la bilancia. Sui piatti sono i due eidola, alati, nudi,senz’armi, e nell’atto di volgersi la schiena. Questo gruppo centrale è inqua-drato da due figure femminili, che logica vorrebbe fossero Eos e Teti, mal-grado la sostanziale assenza di gesti di concitazione. Seguono altre figuremaschili e quadrighe, e quindi la scena di duello tra Achille e Memnone.
Se nel dinos di Vienna la scena è particolarmente statica, e manca uncoordinamento tra le parti, tutt’altro è il tenore di una coppa di Epitteto(recante la firma del pittore) a Villa Giulia (520-510 a.C.) (Fig. 6), dove latensione è al massimo, e il coordinamento delle figure è considerevole: co-me sempre, del resto, in vasi di questo pittore34. La scena, dipinta su un latodell’esterno della coppa, è divisa in due parti. A sinistra è Ermes che tienela bilancia con gli eidola in forma di guerrieri, nell’atto di combattersi conla lancia. Ermes è raffigurato in corsa, singolarmente collocato con la bilan-cia proprio al centro, tra i duellanti. Nella metà destra, Eos e Teti lascianoterrorizzate la scena del duello, dirigendosi di corsa da Zeus, la folgore nel-la mano destra, seduto assieme a Era su un trono, al limite destro della com-posizione.
La coppa di Epitteto costituisce il documento più significativo circa larappresentazione degli eidola in questa iconografia: come di consueto, essisono ridotti di dimensioni, salvo che ora non hanno più ali e sono armati.Più precisamente, questi eidola sono vere e proprie riproduzioni in miniatu-ra dei duellanti, e ne replicano non solo la posa, ma perfino la tenuta. Così,Achille usa lo scudo beotico e Memnone lo scudo rotondo, e analogamente,l’eidolon di Achille usa lo scudo beotico e l’eidolon di Memnone usa loscudo rotondo. Si dovrebbe aggiungere che i due piatti della bilancia sonoancora sostanzialmente appaiati: ovvero, l’esito del giudizio è ancora incer-to, e infatti il duello è ancora in corso. Ciò non sorprende: la collocazione
78 CLEMENTE MARCONI
35 Londra, British Museum B639: Haspels 1936, p. 227 num. 28, tav. 36.1 (P. di Saffo);Boardman 1974, fig. 261; Vermeule 1979, p. 161, fig. 14; Kossatz-Deissmann 1981, num. 798;Peifer 1989, p. 39; Vollkommer 1992, tav. 11 Ker 58.
36 Parigi, Musée du Louvre G399: Carpenter 1991, fig. 325; Kossatz-Deissmann 1981, tav.135 Achilleus 801; Peifer 1989, pp. 42 s.; Vollkommer 1992, tav. 12 Ker 64.
dei piatti della bilancia allo stesso livello, è tipica dell’iconografia del mito.Così, su una lekythos a figure nere di Londra (500-480 a.C.) (Fig. 7), doveErmes è rappresentato nell’atto di pesare gli eidola tra Achille a sinistra eMemnone a destra35.
Se nella coppa di Epitteto gli eidola sono armati, e nell’atto di duellare,in questa lekythos gli eidola sono raffigurati senza armi, nudi e alati. Il datopiù rimarchevole, però, è che questi due eidola si volgono le spalle, comefossero diretti verso i duellanti: solo che mentre quello di sinistra è quasifermo, quello di destra sembra correre a gambe levate verso Memnone. Èinteressante notare al riguardo la posizione di Ermes: di solito il dio tiene labilancia piuttosto in alto, lontano da terra; ma qui la lascia quasi arrivare alsuolo, guardando come con curiosità all’eidolon di Memnone che si preci-pita verso il suo alter ego. Non c’è dubbio che ad essere rappresentato è ilmomento subito prima del volo, che segnerà inesorabilmente il destino diMemnone.
L’ultima rappresentazione del mito nella ceramica ateniese è su unacoppa di Parigi (450 a.C.) (Fig. 8)36. Di nuovo, Ermes è al centro della com-posizione, e di nuovo tiene la bilancia. Ciò che sorprende, però, è che il dioagita il caduceo in direzione di Teti, e ancora più sorprendente è il fatto chequesta dea, come la stessa Eos dall’altro lato, riconoscibile dalle due ali,sembra fuggire terrorizzata dalla scena. Forse il motivo va ricercato neglieidola sulle bilance, raffigurati come guerrieri: quello di sinistra, infatti, in-segue, letteralmente, quello di destra, che gli volge le spalle e fugge a gam-be levate. Ora, è chiaro che la scena rappresenta il momento della profezia,con Ermes che proclama a Teti il successo di suo figlio, mentre Eos lasciala scena sollevando il velo sul volto in segno di dolore. Ma è alquanto si-gnificativo che a tale momento corrisponda, sulla bilancia, la figura diAchille che insegue Memnone.
La coppa di Parigi illustra meglio di ogni altra rappresentazione il nodoermeneutico di questa iconografia del mito di Achille. Nell’Iliade, nellescene di kerostasia, le keres dei duellanti non attirano più di tanto l’atten-zione del poeta, che non le descrive nemmeno. Ciò che conta, nel testo, è ilfatto che appena poste le keres sulla bilancia, una delle due va giù, indican-do il destino fatale di uno dei contendenti. Nei vasi, al contrario, questo
79L’ANIMA VA ALLA GUERRA
momento di profezia è a tal punto irrilevante, che non solo i piatti della bi-lancia sono fermi e praticamente allo stesso livello, ma gli eidola, lungi dal-l’essere semplicemente pesati, e lungi dall’andare su e giù, corrono perfinoa gambe levate muovendosi in orizzontale. Ovvero, gli eidola, piuttosto checome destino di morte dei duellanti, appaiono piuttosto connotati come laloro essenza.
Ciò è meglio dimostrato da uno sguardo diacronico all’iconografia delmito, e all’evoluzione nella rappresentazione degli eidola. Al principio, neldeinos di Vienna, tali esseri hanno ali, sono nudi e senz’armi, e si volgonole spalle (una soluzione che ricorre anche nella lekythos di Londra). Questieidola sono quanto di più vicino ci si possa immaginare alle keres descritteda Omero: demoni pronti a essere pesati e a rivelare il destino degli indivi-dui ai quali si riferiscono.
A partire dalla coppa di Epitteto, però, tali eidola hanno decisamentecambiato il loro aspetto: privi ormai delle ali, non sono più nudi ma armatidi tutto punto, e lungi dal volgersi le spalle sono ora impegnati a combatter-si, riproducendo in miniatura i duellanti ai quali si riferiscono.
Ora, non mi pare vi possa essere alcun dubbio circa il fatto che questatrasformazione iconografica rifletta il fatto che per i pittori ad essere suipiatti della bilancia non fosse più semplicemente la ker, il destino di morte,ma la psyche, l’anima dei duellanti, la loro vera essenza.
A confermare questa impressione, è la stretta analogia tra gli eidola suipiatti della bilancia e l’eidolon di Patroclo nell’iconografia esaminata inprecedenza. In entrambi i casi, ci troviamo di fronte a guerrieri in miniatu-ra, ed in entrambi i casi ci troviamo di fronte a figure in movimento, ancheestremo, e sospese.
Questo passaggio da ker a psyche può essere solo spiegato con il venirmeno dell’idea omerica dell’anima che si libera dal corpo solo al momentodella morte, e con l’insorgere di una idea dell’anima come essenza dell’in-dividuo, e distinta dal corpo. Tanto distinta, si direbbe, che nei nostri vasi lasi vede agire parallelamente al corpo.
Questo passaggio da ker a psyche non era però limitato all’ambito deivasi. Sappiamo infatti che al principio del V secolo, in una trilogia diEschilo, a una tragedia intitolata Memnone ne seguiva un’altra intitolataPsychostasia, in cui andava in scena il giudizio degli dei nel corso del duel-lo tra Achille e Memnone, e in cui le keres dell’epos erano sostituite, suipiatti della bilancia, da psychai (TrGF III F 279-280 a). Questo cambia-mento non è sfuggito alle fonti antiche, che vi fanno riferimento come aduna invenzione di Eschilo. Una invenzione in letteratura – dovremmo ag-
80 CLEMENTE MARCONI
giungere noi – sulla scorta dei vasi, dato che questi dimostrano come Eschi-lo non faceva che portare in scena idee maturate qualche decennio prima, eormai di ampia circolazione.
Assieme, Eschilo e i vasi ateniesi documentano inequivocabilmente unmutamento sostanziale dell’idea di psyche alla transizione dal VI e V seco-lo: l’anima, lungi dal restare imprigionata nel corpo fino al momento dellamorte, e lungi dal rimanere confinata nell’Ade dopo la morte, è finalmentelibera di muoversi. E, come si è visto sui vasi, di andare alla guerra.
Clemente MarconiInstitute of Fine Arts, New York University
81L’ANIMA VA ALLA GUERRA
BIBLIOGRAFIA
Beazley J. D. (1931), Recensione a K. Bulas, Les illustrations antiques de l’Iliade,Paris, 1929, in «Journal of Hellenic Studies» 51, pp. 301-302.
Beazley J. D. (1956), Attic Black-figure Vase-painters, Oxford.Beazley J. D. (1963), Attic Red-figure Vase-painters, 2nd ed., Oxford.Beazley J. D. (1971), Paralipomena: Additions to Attic Black-figure Vase-painters
and to Attic Red-figure Vase-painters, Oxford.Boardman J. (1974), Athenian Black Figure Vases, London.Bremmer J. (1983), The Early Greek Concept of the Soul, Princeton.Burkert W. (1999), Von Selinus zu Aischylos. ‘Reinigung’ im Ritual und im Theater,
in «Berlin-Brandeburgische Akademie der Wissenschaften. Berichte und Ab-handlungen» 7, pp. 23-38.
Burkert W. (2000), Private Need and Polis Acceptance. Purification at Selinous.”in P. Flensted-Jensen – T. Heine Nielsen – L. Rubinstein (eds.), Polis & Poli-tics, Copenhagen, pp. 207-216.
Burn L. – Glynn R. (1982), Beazley Addenda, Oxford.Calame C. (1988) (ed.), Métamorphoses du mythe en Grèce antique, Genève.Carpenter T. H. (1989), Beazley Addenda. Additional References to ABV, ARV2 and
Paralipomena, 2nd ed., Oxford – New York.Carpenter T. H. (1991), Art and Myth in Ancient Greece, London.Clinton K. (1996), A New Lex Sacra from Selinus: Kindly Zeuses, Eumenides, Im-
pure and Pure Tritopatores, and Elasteroi, in «Classical Philology» 91, pp.159-179.
Cordano F. (1996), Recensione a Jameson, Jordan, e Kotansky 1993, in «Aevum»70, pp. 137-141.
Detienne M. (1983), L’invenzione della mitologia, trad. it., Torino.Dubois L. (1995), Une nouvelle inscription archaïque de Sélinonte, in «Revue de
Philologie» 69, pp. 127-144.Giuliani L. (2003), Bild und Mythos. Geschichte der Bilderzählung in der griechi-
schen Kunst, München.Giuliani L. (2004), Odysseus and Kirke. Iconography in a Pre-literate Culture, in
Marconi 2004a, pp. 85-96.Gundert B. (2000), Soma and Psyche in Hippocratic Medicine, in J. P. Wright – P.
Potter (eds.), Psyche and Soma. Physicians and metaphysicians on the mind-body problem from Antiquity to Enlightenment, Oxford – New York, pp. 13-35.
Haspels C. H. E. (1936), Attic Black-figured Lekythoi, Paris.Jameson M. H. – Jordan D. R. – Kotansky R. D. (1993), A Lex Sacra from Selinous,
Durham.Johansen K. F. (1967), The Iliad in Early Greek Art, Copenhagen.Knittlmayer B. (1997), Die attische Aristokratie und ihre Helden. Untersuchungen
zu Darstellungen des trojanischen Sagenkreises im 6. und frühen 5. Jahrhund-ert v. Chr., «Archäologie und Geschichte» 7, Heidelberg.
Korzus B. (1984) (ed.), Griechische Vasen aus westfälischen Sammlungen, Münster.Kossatz-Deissmann A. (1981), Achilleus, in Lexicon Iconographicum Mythologiae
Classicae vol. I, pp. 37-200.
82 CLEMENTE MARCONI
Marconi C. (2004a) (ed.), Greek Vases: Images, Contexts, and Controversies,«Columbia Studies in the Classical Tradition 25», New York – Leiden
Marconi C. (2004b), Images for a Warrior. On a Group of Athenian Vases andTheir Public, in Marconi 2004a, pp. 27-40.
Oakley J. H. (2004), Picturing Death in Classical Athens: the evidence of the whitelekythoi, Cambridge – New York.
Perrot G. – Chipiez C. (1914), Histoire de l’art dans l’antiquité, X, Paris.Peifer E (1989), Eidola und andere mit dem Sterben verbundene Flügelwesen in der
attischen Vasenmalerei in spätarchaischer und klassischer Zeit, Frankfurt –Bern – New York – Paris.
Reusser C. (2002), Vasen für Etrurien. Verbreitung und Funktionen attischer Kera-mik im Etrurien des 6. und 5. Jahrhunderts v. Chr, Zürich.
Rohde E. (1898), Psyche: Seelencult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen, 2vols., 2nd ed., Freiburg – Leipzig – Tübingen.
Schefold K. (1978), Götter- und Heldensagen der Griechen in der spätarchaischenKunst, München.
Shapiro H. A. (1994a), Hipparchus and the Rhapsodes, in Dougherty C. – Kurke L.(eds.), Cultural Poetics in Archaic Greece, Cambridge, pp. 92-107.
Shapiro H. A. (1994b), Myth into Art: Poet and Painter in Classical Greece, Lon-don – New York.
Shapiro H. A. (1994c), Poet and Painter. Iliad 24 and the Greek Art of Narrative,in «Numismatica e antichità classiche: quaderni ticinesi» 23, pp. 23-48.
Spieß A. B. (1992), Der Kriegerabschied auf attischen Vasen der archaischen Zeit,Frankfurt.
Stähler K. (1967), Grab und Psyche des Patroklos, Münster.Vermeule E. (1979), Aspects of Death in Early Greek Art and Poetry, «Sather Clas-
sical Lectures» 46, Berkeley.Vickers M. – Gill D. (1994), Artful Crafts. Ancient Greek Silverware and Pottery,
Oxford.Vollkommer R. (1992), Ker, in Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae
vol. VI, pp. 14-23.
83L’ANIMA VA ALLA GUERRA
LISTA DELLE IMMAGINI
Fig. 1 – Londra, British Museum 1899.7-21.3: Anfora da Vulci, attribuita al Pitto-re di Priamo (520 a.C.).
Fig. 2 – Delos 546: Lekythos attribuita al Gruppo di Leagros.Fig. 3 – Boston, Museum of Fine Arts 63.473: Idria attribuita al Gruppo di Lea-
gros (510 a.C.).Fig. 4 – Parigi, Musée du Louvre CA 601: Lekythos attribuita al Pittore di Dios-
phos (500 a.C.).Fig. 5 – Vienna, Kunsthistorisches Museum, 3619: Dinos a figure nere (530-520
a.C.).Fig. 6 – Roma, Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia 57912: Coppa di Epitteto
(520-510 a.C.).Fig. 7 – Londra, British Museum B639: Lekythos a figure nere (500-480 a.C.).Fig. 8 – Parigi, Musée du Louvre G399: Coppa a figure rosse (450 a.C.).