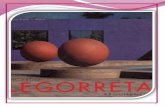(2003) Gadda e Lampedusa - La memoria letteraria
Transcript of (2003) Gadda e Lampedusa - La memoria letteraria
Carla RiccardiRaffaella Callegari - Marinella Ceretti - Luigi Cervi - Paola Italia
l am e m o r i a
l e t t e r a r i aStoria testi e temi della letteratura italiana
7. Il secondo Novecento
l am e m o r i a
l e t t e r a r i a
7. Il secondo Novecento
Le Monnier
C. Riccardi - R. Callegari - M. Ceretti - L. Cervi - P. Italia
la m
em
oria
lette
raria
7. Il secondo Novecento
1 Duecento, Trecento La fondazione della letteratura italiana
2 Quattrocento, Cinquecento Umanesimo e Rinascimento
3 Seicento, SettecentoBarocco e Illuminismo
4 Il primo OttocentoL’età napoleonica e il Risorgimento
5 Il secondo OttocentoLa letteratura della modernità
6 Il primo NovecentoLa crisi delle certezze.Dagli anni Venti alla guerra
7 Il secondo NovecentoDal dopoguerra a oggi
La strutturaQuadro introduttivoModuli tematiciMovimenti AutoriGeneriLetterature straniere
Gli apparatiLa critica e il testoApprofondimentiStrumentiProposte operativeDizionarietto della letteratura italiana(nel primo volume)
Le Monnier
Riccardi, La memoria letteraria 6. Il primo Novecento+7. Il secondo Novecento.Prezzo dei due volumi indivisibili Euro 36,30
88-0
0-41
274-
2
Riccar
di e
altri
Mem
oria
lette
raria
6+7
Le M
onnie
r QUESTO VOLUME, QUALORA SIA SPROVVISTO DEL TALLONCINO A FRONTE, O COMUNQUE OPPORTUNAMENTE CONTRASSEGNATO,È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO FUORI COMMERCIO, E PERTANTO NON PUO ESSEREVENDUTO O CEDUTO AD ALCUN ALTRO TITOLO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17, C. 2, LEGGE
633/1941). ESENTE DA I.V.A. (D.P.R. 26-10-1972, N. 633, ART. 2, LETT. D).
Letteratura7 25-10-2012 9:40 Pagina 1
205
Autori
Carlo Emilio Gadda
La vita e la personalità
Carlo Emilio Gadda nasce a Milano il 14 novembredel 1893 da una famiglia di estrazione borghese edi tradizioni risorgimentali. Le figure familiari e iluoghi dell’infanzia ricopriranno un’importanzafondamentale nella vita dello scrittore.
Gli studi liceali e l’università. Morto ancora giovaneil padre, nel 1909 la madre si trova a dover far fron-te, contemporaneamente, alle pesanti conseguenzedi errati investimenti del marito e alle spese di man-tenimento della casa di Longone; per sostenere lafamiglia si dedica così all’insegnamento di lettere efrancese nelle scuole magistrali. Con lei Gadda svi-lupperà un rapporto intensissimo e difficile, che se-gnerà tutta la sua vita. Dopo il tradizionale ginnasioe liceo, Carlo Emilio – più per compiacere ai desi-deri materni che per vocazione – si iscrive alla fa-coltà di ingegneria al Politecnico di Milano. La scel-ta tuttavia non è definitiva: la scissione tra mentalitàingegneresca e vocazione letteraria innesta sin d’o-ra un dissidio profondo tra il fortissimo principiodel dovere (aggravato dai problemi familiari che vi-vrà sempre con responsabilità da capofamiglia) equello altrettanto forte del piacere o dovere spiri-tuale che lo porterebbe a dedicarsi esclusivamenteai prediletti studi letterari e filosofici.
La guerra e le prime prove letterarie. Allo scoppiodella prima guerra mondiale, parte con il fratelloEnrico come volontario al fronte. Fatto prigionieronella disfatta di Caporetto, viene tradotto in Germa-nia, dove stringe amicizia con i letterati Ugo Betti
(1892-1953) e Bonaventura Tecchi (1896-1968),chelo introdurranno successivamente nell’ambientefiorentino di «Solaria» La drammatica esperienza del-la guerra e della prigionia e la riflessione sulle con-dizioni dell’esercito italiano si riverberano – in pre-sa diretta – nel Giornale di guerra e di prigionia enel Taccuino di Caporetto, un documento eccezio-nale per lucidità di analisi e profondità di giudizio,che traccia un quadro dolorosamente impietoso diuno dei periodi più travagliati della storia italiana.
Il ritorno in Italia e la laurea in ingegneria. Il ritornoin Italia, alla vita civile, seguito dalla notizia dellamorte del fratello, precipitato con l’aereo negli ulti-mi mesi di guerra, è traumatico: il ricordo di Enricoritornerà ossessivo negli anni seguenti, in tutta l’o-pera di Gadda, a segnare il suo approfondimentodella cognizione dolorosa della vita.Dopo la laurea in ingegneria, conseguita nel 1920,inizia a lavorare presso società elettriche in Lom-bardia e in Sardegna, pressato dalle precarie condi-zioni economiche della famiglia. L’affermazionedel fascismo gli si presenta come una concreta pos-sibilità di rinnovamento e di organizzazione offertaa un Paese stremato dalla guerra e sconvolto dai di-sordini sociali; la sua adesione è immediata e puòessere letta come la naturale conseguenza del suointerventismo e nazionalismo.
L’Argentina, la filosofia e il lavoro «ingegneresco».Nel 1922 Gadda parte per l’Argentina, dove rimanefino al 1924, lavorando come ingegnere presso unasocietà termoelettrica. L’esperienza sudamericana losollecita alla scrittura, con alcune note con ritratti dipersone (depositate nelle future pagine della Cogni-zione del dolore) e collaborazioni giornalistiche.
206
Tornato in Italia, continua a esercitare la professio-ne di ingegnere prima a Roma, poi in Lorena e nel-la Ruhr (1925-31) e di questo decennio sono anchele prime prove narrative e le riflessioni filosofiche.Nel 1924, sollecitato da un concorso letterario ban-dito dalla casa editrice Mondadori per un romanzoinedito, inizia il Racconto italiano di ignoto del No-vecento che lascerà tuttavia incompiuto (sarà pub-blicato solo nel 1983 a cura di Dante Isella), mentredel ’28 sono la Meditazione milanese – un’opera fi-losofica (rimasta inedita fino al 1974), in cui vienesistematizzata la sua personale concezione filosofi-ca – e le prime prove narrative della Meccanica edi Novella seconda.L’iscrizione all’Accademia di lettere e scienze (l’at-tuale Facoltà di lettere e filosofia) certifica la vo-lontà di riscattare nella riflessione filosofica e nellaletteratura la dimensione più profonda di un’esi-stenza psicologica già fortemente provata dalla dif-ficile infanzia e dalla guerra, irriducibile alla nor-malità e costantemente in bilico tra doveri materia-li e spirituali. Non stupisce quindi che dopo aversostenuto e brillantemente superato tutti gli esamidel corso di filosofia, e concordato la tesi con PieroMartinetti (filosofo neokantiano spiritualista, poi ri-mosso dall’insegnamento per antifascismo), Gaddanon pervenga alla laurea.Le collaborazioni che intrattiene con le riviste «Am-brosiano» e «Solaria» non sono continuative e nonpossono garantirgli la tanto necessaria stabilità eco-nomica, costringendolo alla perpetua oscillazionetra periodi «ingegnereschi» e letterari. Dal 1932 al1934 lavora a Roma ai servizi elettrotecnici dellaCittà del Vaticano; negli stessi anni, e precisamentenel triennio 1931-34, maturano i racconti di am-bientazione milanese L’incendio di via Keplero eSan Giorgio in casa Brocchi, che Gadda progetta dipubblicare insieme al romanzo Un fulmine sul 220,iniziato nel 1932 e lasciato incompiuto fino all’ini-zio degli anni Quaranta, quando brani isolati saran-no pubblicati come disegni milanesi nella raccoltadi racconti L’Adalgisa.
Firenze, «Solaria» e le prime pubblicazioni. La fre-quentazione dell’ambiente fiorentino che ruota at-torno a «Solaria» e al celebre caffè delle Giubbe Ros-se è condizione necessaria per emergere nell’aristo-cratico ed elitario mondo della cultura italiana diquegli anni, mondo rispetto al quale Gadda oscillatra interessamenti e timori.Nel 1931 pubblica, per i tipi di «Solaria», la raccolta dinovelle La Madonna dei Filosofi, alla quale segue,
nel ’34, Il castello di Udine, che suscita l’interesse dellinguista Giacomo Devoto e quello di GianfrancoContini. Gadda entra di diritto nella schiera degliscrittori solariani e continua le collaborazioni a quoti-diani e riviste, che confluiranno nelle raccolte di sag-gi Le meraviglie d’Italia (1939) e Gli anni (1943). Nel1936 la morte della madre e la conseguente venditadella casa di Longone segnano l’inizio della Cogni-zione del dolore, il romanzo più sofferto e tormenta-to di Gadda, edito prima a tratti su «Letteratura», e piùtardi in volume nel 1963. Allo scoppio della guerra,Gadda è a Firenze e nell’agosto del ’44 a Roma, dovecomincia la stesura del giallo Quer pasticciacciobrutto de via Merulana (uscito in rivista dal 1946). Aquesto periodo risale anche il pamphlet grottesco eviolentemente antifascista Eros e Priapo, che, per lacrudezza dei contenuti – sia pure mascherati da unfiorentino simil-cinquecentesco – potrà essere pub-blicato solo nel 1967.
Roma, la RAI e il successo. Con l’assunzione, nel1950, al settore cultura del Terzo programma dellaRAI, Gadda può rinunciare definitivamente al lavo-ro ingegneresco e trasferirsi a Roma, dove resterà fi-no alla morte, avvenuta nel 1973. La sua collabora-zione alla RAI, oltre a rappresentare un momento diineguagliato livello qualitativo raggiunto dall’azien-da radiotelevisiva (Gadda, forte delle amicizie lette-rarie degli anni fiorentini, affida i programmi cultu-
IL SECONDO NOVECENTODal dopoguerra a oggi
Autori
Carlo Emilio Gadda • Un ‘ingegnere’ della letteratura
207
rali a collaboratori del calibro di Roberto Longhi),costituirà anche l’occasione della nascita di alcunefortunate pièces radiofoniche; ne sono esempi ilpamphlet antifoscoliano Il guerriero, l’amazzone elo spirito della poesia nel verso immortale del Fosco-lo (scritto nel 1958, ma pubblicato nel 1967), in cuibersaglio della feroce ironia gaddiana è l’esibizioni-smo del poeta ottocentesco – una sorta di controfi-gura retorico-priapesca di Mussolini –, e l’interes-sante rilettura storica della dinastia francese primadella Rivoluzione, I Luigi di Francia (1952), che ce-la, tra le pieghe caricaturali della rappresentazione,un significato politico attuale, di critica al fascismo eal modello dittatoriale mussoliniano.Intanto, mentre escono Le novelle dal Ducato infiamme, che nel 1953 vincono il Premio Viareggio,Gadda continua a lavorare al Pasticciaccio, pubbli-cato nel 1957, con uno straordinario successo edi-toriale. Gadda, a quasi settant’anni, vive così un pe-riodo di inaspettato favore della critica e di popola-rità presso il pubblico, che accoglie con sorpresa erassegnata autoironia: sono diventato una specie diLollobrigido, di Sofìo Loren, senza avere i doni del-le due impareggiabili campionesse, commenta tri-stemente ironico agli amici milanesi.Licenziatosi dalla RAI per sopraggiunti limiti d’età,trascorre gli ultimi anni in quasi completo isolamen-to, circondato da pochissimi amici. In una delle ulti-me interviste, mentre i suoi libri vengono tradotti al-
l’estero e confermano la dimensione europea dellasua opera, alla richiesta di una definizione che possaracchiudere il senso della sua vita, dichiara di rite-nersi una infelice creatura, sfortunata e infelice.
Un ‘ingegnere’della letteratura
Il paradosso gaddiano. Nel panorama della letteratu-ra italiana del Novecento, Gadda, ha contribuito adefinire uno stile e si è collocato come punto d’ar-rivo di una tradizione – quella espressionistica –che vede in lui uno dei suoi principali esponenti(insieme ai grandi scrittori europei del secolo, daJames Joyce – a Robert Musil).Il paradosso di Gadda sta nel fatto che proprio lui,estraneo, per cultura e formazione, al mondo lette-rario, è divenuto il principale promotore del rinno-vamento del romanzo nel Novecento e che, purnon avendo partecipato a nessuna avanguardia, è ilrappresentante della più ardita sperimentazionelinguistica del nostro secolo.
Le ragioni della sua originalità. La sua straordinariaoriginalità, inoltre, consiste nell’essere riuscito a co-niugare una forte innovazione narrativa (tutti i suoiromanzi, ad esempio, mancano di una conclusio-ne, e la lingua in cui scrive si discosta non solo daquella del passato, ma anche da quella dei narrato-ri a lui contemporanei) con un uso originale dellatradizione letteraria (uno dei suoi modelli forti, adesempio, è Manzoni, dal quale Gadda deriva la for-te tensione morale della scrittura). La tradizione let-teraria, infatti, non è rifiutata a priori, ma attraver-sata, consapevolmente e in estrema libertà, tantoda poter produrre – accanto a quelli di grande spe-rimentalismo tecnicistico e dall’alto grado di defor-mazione linguistica – brani di straordinaria inten-sità lirica e di acceso simbolismo.
Biografia e letteratura. Grandissima importanza hala sua biografia, che si rifrange costantemente sul-l’opera; l’autore, uno dei primi a usare la psicoana-lisi come strumento di interpretazione del reale edella propria coscienza, ci presenta un ritratto di sé
Mark Tobey, Le forme seguono l’uomo, 1943, olio e tempera su tela, Seattle, Art Museum.
208
IL SECONDO NOVECENTODal dopoguerra a oggi
Autori
crudo, bizzarro, a volte impietoso, ma di rara pro-fondità e verità, nonostante lo schermo della fin-zione romanzesca. Un ritratto che scava così pro-fondamente – e con tale ossessività – nelle proprieidiosincrasie e nelle proprie nevrosi, da dare l’im-pressione di riflettere in un’opera vastissima (i suoiscritti ammontano a più di cinquemila pagine) unsolo libro, un solo personaggio, una sola storia. Pa-rallelamente, con la stessa evidenza e rilevanzagrottesca, Gadda rappresenta la realtà sociale e cul-turale, dalla quale ricava la materia della sua operae che costituisce spesso il bersaglio dei suoi furori edella sua satira. Per Gadda, infatti, è la stessa cono-scenza della realtà a causare la sua deformazione, el’assunzione di uno stile composito e barocco nonè altro che una dichiarazione di fedeltà alla com-plessità dell’oggetto rappresentato: per questa ra-gione, la categoria critica che meglio vale a inqua-drare la prosa di Gadda è ancora quella, creata daContini, dell’«espressionismo naturalistico».L’opera gaddiana si presenta quindi non solo comeuna tappa imprescindibile nella storia della letteratu-ra del nostro secolo – di cui ha interpretato le inquie-tudini e i drammi con altissima tensione morale –, maanche come un’esperienza di straordinario arricchi-mento per il lettore, che vi trova una delle più fortie disincantate denunce dei pregiudizi, dell’ignoran-za e della superficialità della cultura e della società,espresse in una delle prose più ricche, originali e di-vertenti del secolo. Tutti elementi, questi, che spie-gano la statura di questo autore e lo consacrano avero e proprio ‘classico’ del Novecento.
Le opereUn’intricata storia editoriale. Prima di analizzare la
produzione gaddiana è necessario sottolineare lavicenda che ha visto l’autore protagonista di unadelle più complicate storie editoriali del Novecen-to, solo da un decennio compiutamente illuminatadalla critica. La relativa estraneità di Gadda all’am-biente letterario degli anni Trenta e Quaranta, lasua formazione eclettica, insieme classica e scienti-fica, e l’assoluta originalità della sua scrittura spie-gano in parte il fatto che le sue opere maggiori ab-biano dovuto attendere quasi mezzo secolo primadi essere conosciute dal grande pubblico e che so-lo il successo ‘popolare’ del Pasticciaccio abbiapermesso la stampa di testi scritti in decenni prece-denti (e ad essi appartenenti per ispirazione e sti-
le). Anzi, tale successo scatena una vera e propriacorsa all’inedito da parte degli editori, costringendol’autore a recuperare dal suo privato cuofeno («bau-le», alla napoletana) racconti, appunti e abbozzi diromanzi: materiali disparati e spesso eterogenei, chein più di un caso vengono assemblati redazional-mente per soddisfare le pressanti richieste editoriali.Si potrebbe dire, semplificando, che tutto quantoGadda ha scritto negli anni più fecondi della suaproduzione rimane inedito o parzialmente edito finoall’edizione completa delle Opere, conclusasi solonel 1993; le opere che riesce a pubblicare in tiraturelimitatissime e spesso a sue spese (e che hanno sem-pre costituito l’oggetto primario di ogni discorso cri-tico sullo scrittore) più che riflettere il reale percorsoletterario dell’autore, risentono piuttosto del gustodell’epoca o dell’ambiente, nella fattispecie di quelloletterario fiorentino degli anni Trenta, in cui Gadda –per poter assecondare la propria, prepotente voca-zione letteraria – ha dovuto di necessità inserirsi.Opere eccentriche e a volte scarsamente rappresen-tative della sua produzione, che rimaneva invece to-talmente sconosciuta. Per fare due soli esempi: men-tre Gadda pubblica su «Solaria» le brevi prose de-scrittive di gusto rondesco di Studi imperfetti (1926),che potrebbero assimilarlo ai tanti scrittori di prosad’arte di quegli anni, matura nel suo privato labora-torio un romanzo storico, d’impianto manzoniano,sul lavoro italiano e sulla situazione politico-socialeitaliana tra le due guerre, ricco di suggestioni daStendhal, Balzac, Zola, Dostoevskij e D’Annunzio:una parte del quale, il Racconto italiano di ignotodel Novecento, potrà essere conosciuto solo diecianni dopo la morte dell’autore (grazie all’edizioneapprontata da Dante Isella nel 1983).Lo stesso destino è toccato alla Meditazione milane-se, scritta nel 1928 – cioè coeva a un romanzo comeLa meccanica, pubblicato anch’esso mezzo secolodopo la stesura – ma edita solo nel 1974; l’opera risul-ta peraltro indispensabile per comprendere il solidoimpianto filosofico che presiede, in Gadda, al rinno-vamento delle strutture romanzesche e alla deforma-zione della lingua letteraria. Ripercorrere l’evoluzione di tutta la sua produzione, te-nendo sempre costantemente distinti il versante dellascrittura ‘pubblica’ da quello della scrittura ‘privata’ èperciò condizione necessaria per affrontare uno dei piùgrandi autori del Novecento. Un autore che proprio acausa di questa sfasatura è stato spesso interpretato se-guendo schemi critici che possono spiegare solo in par-te la straordinaria ricchezza e profondità raggiunte dal-la sua scrittura nell’interpretazione della realtà.
Carlo Emilio Gadda • Le opere
Un romanzo «psicopatico e caravaggesco»: il Rac-conto italiano di ignoto del Novecento. Il 24 marzodel 1924, in uno dei Cahiers cui affida nel corso de-gli anni spunti narrativi e osservazioni critico-teori-che, secondo quell’alternanza tra momento creati-vo e riflessivo poi tipica di tutta la sua futura pro-duzione, Gadda dà inizio al Racconto italiano diignoto del Novecento, noto anche come Cahier d’é-tudes, in cui si propone di rappresentare la trage-dia di una persona forte che si perverte per l’insuf-ficienza dell’ambiente sociale. Insieme agli studi (i brani narrativi) convivono sullapagina gaddiana note critiche e compositive, ovve-ro riflessioni teoriche sulla narrazione e sulla strut-tura particolare del racconto; note che, per la lorooriginalità e modernità, si configurano come ununicum nella storia del romanzo del Novecento.Non meno interessante è quanto l’autore sostiene aproposito delle maniere espressive da utilizzarenella narrazione. Con grandissima consapevolezzastilistica, identifica i cinque stili o maniere che glisono più congeniali. Nella serie, che è utile consi-derare analiticamente, è possibile riconoscere alcu-ni dei tratti espressivi della futura scrittura gaddia-na. Vengono identificate una maniera logico-razio-nalistica, seria cerebrale, una umoristico-ironicaapparentemente seria (Dickens e Panzini sono gliautori di riferimento), una umoristico seria manzo-niana, che lascia il gioco umoristico ai soli fatti,non al modo di esprimerli, una maniera enfatica,tragica, «meravigliosa 600», simbolistica, utile a«épater le bourgeois» [«far colpo sulla gente»], moltovicina alla poesia e di difficile fusione con l’insiemee infine una maniera cretina, fresca, puerile, miticae omerica, lo stile di un bambino che vede il mon-do (e sapesse già scrivere).Gadda, non ancora legittimato al pastiche (che sa-rebbe poi diventato la sua ‘cifra stilistica’ e la mi-gliore risorsa delle sue potenzialità espressive), difronte alla necessità di eleggere uno di questi stili odi fonderli insieme, sceglie la prima ipotesi, senzaper questo evitare di assecondare l’ispirazione, uni-ca garanzia alla buona riuscita della prova lettera-ria. È interessante notare come l’esordio narrativogaddiano si ponga sotto le insegne di Manzoni, au-tore cui lo legano la comune matrice lombarda,l’interesse per la storia e l’attenzione costante almezzo espressivo. Alle sue difese Gadda, nel 1927,dedica un corposo articolo emblematicamente inti-tolato Apologia manzoniana (tratto dal corpus delCahièr) in cui, attraverso una rilettura in chiave ba-rocca e secentesca, esalta l’eticità, la sensibilità ver-
so il rispetto della storia, lo sforzo di parlare da uo-mo agli uomini e di fissare le rappresentazioni del-la trama complessa della realtà – ingarbugliato in-treccio – con il genio del narratore e più dell’esege-ta e dell’analista e infine la compattezza e omoge-neità dello stile.
La meccanica e Dejanira Classis. Il primo vero ro-manzo gaddiano, La meccanica – iniziato nel 1928– traccia una storia milanese di pasticci e garbugli,sullo sfondo della prima guerra mondiale. La pas-sione per la meccanica, esercitata nei locali dell’U-manitaria (benefica e filantropica società nata a Mi-lano alla fine del XIX secolo ed emblema della soli-darietà sociale e socialista verso il mondo popola-re), unisce i due personaggi principali, Luigi Pessi-na e Franco Velaschi, che condividono anche l’at-trazione per Zoraide (moglie di Luigi e amante diFranco), una delle prime straordinarie figure fem-minili del mondo gaddiano. La procace contadinaveneta, vera indiscussa protagonista, si trova co-stretta tra i doveri di fedeltà al marito – che non re-sisterà alle durezze della guerra finendo i suoi gior-ni ammalato di tisi – e l’attrazione verso il giovaneVelaschi, ‘campione’ di salute e di forza, figlio ac-cudito e coccolato della buona borghesia milanese.Se nel Racconto italiano la guerra era un fatto delpassato che causava il pervertimento di un indivi-duo eccezionale, qui è una realtà vissuta in presadiretta, che agisce sugli uomini e sulla società. Il ro-manzo diviene il primo dei vari luoghi di denunciadell’autore contro il male, anche se è Gadda stessoa dichiarare: Non è nel mio modo la denuncia di-retta del mio dolore. Talvolta esso va travestito discherno.Dello stesso anno della Meccanica è il raccontolungo e incompiuto Dejanira Classis, che Gaddachiama anche Novella seconda. Il testo, narrativa-mente incerto e frammentario, è tuttavia molto in-teressante in quanto viene ispirato da un reale fattodi cronaca: un processo di matricidio svoltosi inquell’anno a Milano. Sono presenti, in embrione, idue temi portanti dei grandi romanzi gaddiani: ilmatricidio, che concluderà la Cognizione del dolo-re, e l’inchiesta poliziesca, che sarà al centro del ce-lebre Pasticciaccio. L’impianto narrativo risentetuttavia di un’impostazione fortemente positivisticae lombrosiana, che tende a fare del romanzo unarequisitoria contro le tare sociali ed ereditarie.Questi primi esperimenti lasciano già intravederealcune caratteristiche della scrittura gaddiana piùmatura, come l’uso di registri linguistici diversi e in
209
frizione fra loro (dal linguaggio basso a quello auli-co, agli sporadici inserti dialettali) e la tendenza al-la digressione, che dissolve la centralità del sogget-to e disgrega la trama narrativa. L’impianto dellanarrazione è tuttavia ancora tradizionale, ottocen-tesco; se la storia diventa progressivamente margi-nale, secondaria, ciò accade più per allentamentodei fili di una trama troppo complessa per essereseguita dal narratore, che per una decisa volontà di‘decostruzione’.
La Madonna dei Filosofi. Uscito nel 1931 per i tipi di«Solaria», La Madonna dei Filosofi, il primo libropubblicato da Gadda, riunisce alcuni testi usciti su«Solaria» e su altre riviste tra il 1926 e il 1928. Esso siapre con il racconto Teatro – cronaca di uno spetta-colo d’opera –, a cui corrisponde simmetricamenteil penultimo racconto, Cinema, suo pendant popo-laresco; seguono le brevi prose descrittive intitolateStudi imperfetti, e le Manovre di artiglieria da cam-pagna, un ricordo della guerra. A conclusione è po-sto il racconto eponimo, di maggior respiro e com-piutezza narrativa, ambientato a Milano nel 1922.
Il castello di Udine. Maggior interesse di critica rispet-to a quello suscitato da La Madonna dei Filosofi ri-scuote – anche se entro la limitata cerchia dei fio-rentini – Il castello di Udine, il secondo libro gad-diano, uscito anch’esso per le edizioni di «Solaria»,che raccoglie molta della produzione giornalisticadel biennio 1931-33, ma non di quella narrativa,che rimane un cantiere ricchissimo e ancora ine-splorato. Le prose del Castello di Udine ripercorro-no i temi – cari all’autore – della guerra e del diariodi viaggio. Altissima e mirabolante introduzione alvolume è la prosa Tendo al mio fine, in cui l’autorerivendica le ragioni della propria deformazione lin-guistica in uno specimen di plurilinguismo che èanche una straordinaria dichiarazione di poetica. Ilcastello di Udine introduce una novità consistente efeconda nella scrittura gaddiana: lo sdoppiamentodell’autore nel commentatore Feo Averrois (che ri-prende il dantesco Averoìs che ’l gran comento feodi Inferno, IV 144), legato da antica dimestichezzaal convoluto Eraclito di via S. Simpliciano, ovverolo stesso Gadda. L’origine di tale decisione è rintrac-ciabile in un suggerimento del critico Giuseppe DeRobertis, che recensendo La Madonna dei Filosofi,di fronte a tanta erudizione ingegneresca e alle in-numerevoli digressioni storiche, aveva suggerito aGadda «un commento allegro e altra mormorazionedi riso», in note da inserire nella successiva ristam-
pa; soluzione che l’autore (che a De Robertis dedi-cherà l’Adalgisa) adotta puntualmente nel Castello. Prende così forma un originalissimo modello narra-tivo – più tardi esperito compiutamente nell’Adal-gisa – che mescola al registro del ‘narrato’ una sor-ta di controcanto, un luogo di frontiera e spesso dideformazione linguistica, nel quale l’autore può in-tervenire con maggiore libertà.
Gadda «milanese»: da Un fulmine sul 220 all’Adalgi-sa. Con Il castello di Udine si chiude il capitolo bio-grafico della guerra e se ne apre un altro, da Continidefinito felicemente dell’«antivittorianesimo ambro-siano». Il risentimento di Gadda – già maturato neitesti degli anni Venti – contro la borghesia milanese,colpevole di aver rinnegato e tradito i suoi stessi va-lori di razionalità, precisione e onestà, si trasformanel Castello in una vera e propria requisitoria controuna classe che, dopo esser stata una realtà delle piùattive e più salde, nella vita economica e morale del-la patria, vive ora solo delle sue squallide imposi-zioni formalistiche, delle sue ossession[i] conserva-tric[i] e moralistich[e]. Siamo già nel clima risentito epolemico, preludio al grande processo inquisitoriodegli anni Trenta, che porterà ai disegni milanesidell’Adalgisa. La storia compositiva che lega i testi diquesti anni è stata ricostruita solo di recente.
210
IL SECONDO NOVECENTODal dopoguerra a oggi
Autori
Carlo Emilio Gadda a Firenze nel 1957, «L’illustrazioneitaliana».
Carlo Emilio Gadda • Le opere
211
Alcuni materiali autografi emersi dall’archivio diGadda provano che egli sta lavorando, all’iniziodegli anni Trenta, a un progetto di vasta portata; sitratta di un volume destinato a riunire i due raccon-ti San Giorgio in casa Brocchi e L’incendio di viaKeplero (alla cui stesura Gadda attende fin dal1930) con il progettato e incompiuto romanzo Unfulmine sul 220, al quale lavora nel biennio 1932-34, nell’intervallo tra La Madonna dei Filosofi e Ilcastello di Udine. Proprio il Fulmine costituisce lascoperta più interessante; si tratta di un testo digrandi ambizioni, un affresco della società milane-se degli anni Venti, che lo scrittore vuole radical-mente e definitivamente stigmatizzare. La satiradell’ambiente milanese è anche il tema dominantedel San Giorgio in casa Brocchi, uscito su «Solaria»nel giugno 1931, che riscuote un certo successo dipubblico e sembra anticipare modi e temi del Ful-mine. Il progettato trittico, che avrebbe dato a Mila-no una delle sue rappresentazioni più incisive ememorabili, non viene però realizzato; i due rac-conti confluiranno, nel 1953, nelle Novelle dal Du-cato in fiamme, mentre alcuni frammenti del ro-manzo lasciato incompiuto (ma provvisto di un’i-potesi conclusiva) verranno utilizzati solo dieci an-ni più tardi nel volume di racconti l’Adalgisa (LeMonnier, Firenze 1944), significativamente sottoti-tolato disegni milanesi.
I «disegni milanesi» dell’Adalgisa. L’Adalgisa è unlibro composto di materiali eterogenei, provenientida diversi progetti narrativi, ma costruiti secondouno schema organicamente definito. Al brano diapertura, Notte di luna, di tono lirico-estetizzante(significativamente ispirato al D’Annunzio delTrionfo della morte), che Gadda riprende dal Rac-conto italiano di ignoto del Novecento di vent’anniprima, seguono, simmetricamente disposti, tre rac-conti legati al disegno milanese: Quando il Girola-mo ha smesso …, Claudio disimpara a vivere eQuattro figlie ebbe e ciascuna regina. La cornicemilanese fa da sfondo anche a un altro racconto,che funge da centro di simmetria, I ritagli di tempo,e poi, ancora, in chiusura, ai tre racconti derivantidal Fulmine, compreso quello eponimo della rac-colta (Un «concerto» di centoventi professori; AlParco, in una sera di maggio; L’Adalgisa).Spicca su tutti il personaggio di Adalgisa, una don-na di origine popolare che ha riscattato la sua posi-zione sociale sposando il ragionier Carlo Biandron-ni, ed entrando così di diritto nel chiuso mondodella borghesia milanese, mondo che, peraltro,
non l’ha mai completamente accettata. L’incontrocon la cognata Elsa, entrata anch’essa nel soma del-la somaresca tribù, ma ai margini della società bor-ghese perchè accusata di avere una relazione con ilnipote Valerio, scatena il desiderio di rivalsa diAdalgisa nei confronti della stessa società che pri-ma ha rifiutato e calunniato lei, poi la cognata. Ilracconto della propria storia, che si snoda lungo gliultimi tre racconti, delinea una sorta di moraleesemplare in base alla quale l’Adalgisa si proponedi riscattare, con quella di Elsa, anche la propriaesistenza.L’attraversamento dei generi letterari raggiunge,nell’Adalgisa, risultati di grande felicità stilistica,forte anche della familiarità dell’autore con unmondo in cui ha vissuto direttamente e di cui co-nosce i riti, il linguaggio, la cultura e le meschinità.Il dialetto milanese, abilmente mescolato, in tutte lesue ‘gradazioni’, all’italiano, contribuisce alla rap-presentazione-deformazione di questa realtà, e siinserisce sia nel dialogo, a scopo mimetico, sia nel-la narrazione.
La cognizione del dolore: un romanzo alla ricercadell’essere. Nel luglio-settembre del 1938 esce sul-la rivista «Letteratura» la prima parte di un nuovo ro-manzo, considerato da molti critici il vertice dellaproduzione narrativa di Gadda: La cognizione deldolore. Le vicissitudini biografiche dell’autore in-trattengono con quest’opera un rapporto strettissi-mo: in una Brianza travestita da Sudamerica si sno-dano le vicende di Gonzalo Pirobutirro – un chiaroalter ego dell’autore –, proprietario di una villa incampagna dove vive con la vecchia madre. Pochigli eventi esterni di rilievo, stante anche la forte an-tinarratività dell’intreccio e l’inserzione di numero-se digressioni che diventano vere e proprie narra-zioni autonome. Il romanzo ha una trama moltosemplice, che si risolve nel dramma finale: l’ucci-sione della madre una notte in cui il figlio è partitoper lavoro. Il dramma resterà irrisolto, a precludereogni effetto catartico. Più che un romanzo, la Co-gnizione si potrebbe considerare un trattato filoso-fico – tale è la «subordinazione dell’invenzione nar-rativa a un dibattito d’idee» (Manzotti) — e insiemeun viaggio di autoanalisi nelle profondità dell’io,nelle sue pulsioni inconfessate, nei suoi travagli im-medicabili. Radicale è quindi la frattura con la pro-duzione precedente: se nell’Adalgisa il Robespierredella borghesia milanese (come Gadda stesso si de-finiva) sembrava riconoscere solo nemici esterni,responsabili del suo stato di irriducibile diversità
IL SECONDO NOVECENTODal dopoguerra a oggi
Autori
esistenziale, e compensava il male subito attraversol’irrisione caustica, la deformazione grottesca deirappresentanti di quella classe sociale in cui si erasvolta la sua inesistita giovinezza, ora il suo viaggioalle radici dell’essere non riconosce altri nemici chel’io stesso. I toni della narrazione, anche quandos’improntano alla satira, celano quindi, sempre, unfondo drammatico.
Dalle note dell’Adalgisa a Eros e Priapo. Il periodovissuto a Firenze lascia un’evidente traccia lingui-stica nelle opere gaddiane, e prima ancora che neitesti, nelle note che accompagnano i racconti del-l’Adalgisa, scritti un decennio prima, pubblicati inrivista, e riuniti in volume solo tra il 1943 e il ’44. Lavera novità del testo in volume, rispetto all’edizio-ne in rivista, è costituita proprio dal corredo di no-te, che vengono inserite nel tessuto del racconto.Una vistosa caratteristica delle note – scritte presu-mibilmente nel 1943 – è costituita dall’uso a tratti diuna lingua arcaica, ispirata al fiorentino simil-cin-quecentesco, nella sintassi e nel lessico. All’originedi questa scelta linguistica non ci sono soltanto mo-tivazioni di ordine stilistico, ma anche e soprattuttoragioni dettate da una più sottile urgenza espressi-va. Le note infatti assolvono a un duplice compito:da un lato costituiscono una chiosa lessicale ederudita di termini del testo, dall’altro innestano unadigressione storica che spesso si dilata fino alle ab-normi dimensioni di un testo alternativo e paralleloa quello principale. Protagonista delle note e deicontinui innesti in praeteritum tempus ( 214) èNapoleone, colto negli aspetti più narcisistici e iro-nici del suo culto della personalità. È proprio nelladialettica tra testo reale e testo annotato che possia-mo rintracciare i temi di denuncia sociale e politicache il racconto dissimula nelle forme della satiraantiborghese e che nella nota vengono mascheratidal travestimento storico e linguistico. Come nonriconoscere dietro la satira antinapoleonica una piùurgente polemica contro la figura che ancora nel1944 incarnava vistosamente le manie di grandezzadel nano di Ajaccio? È proprio in questi anni, infat-ti, che si istituisce l’equazione Napoleone-Mussoli-ni, da cui scaturirà uno dei testi più violenti e com-plessi di Gadda: Eros e Priapo. Da furore a cenere.Scritto nel biennio 1943-45, Eros e Priapo sarà pub-blicato in forma assai diversa solo nel 1967 sull’on-da della riscoperta editoriale che seguirà il succes-so del Pasticciaccio.Il rapporto di Gadda con il fascismo, infatti, era sta-to tormentato e complesso, e potrebbe essere defi-
nito come un aspetto del suo nazionalismo, di queldesiderio di ritorno all’ordine che egli aveva condi-viso con molti reduci della Grande Guerra. Il mo-mento di maggiore adesione risale infatti agli anniTrenta, quando il fascismo gli appare come un tu-tore di quei valori borghesi, nazionali e tradizionaliche la guerra aveva rischiato di distruggere. Ma giàalla fine degli anni Venti (in alcune lettere agli ami-ci, ad esempio) Gadda si dissocia sarcasticamentedalla retorica di regime, e più avanti si opporrà al-l’alleanza con la Germania, Paese che lui, prigio-niero dei tedeschi a Rastatt nel 1919, non potevacerto sentire vicino. Lo scoppio della guerra è vistoquindi come un tradimento rispetto ai propositi ini-ziali di ragione e razionalità, e provoca tutto il furo-re e la violenza gaddiana. La psicanalisi fornisceuna chiave di interpretazione del ventennio, perio-do funesto in cui sulle istanze del Logos hanno pre-valso quelle irrazionali dell’Eros, di una moltitudineirretita nell’adorazione cieca del capo. Mussolini,che Gadda descrive come un Priapo esibizionista efallocrate, incarna il campione del narcisismo, del-l’esaltazione della potenza fisica, del tradimento deivalori, e diventa perciò oggetto di una satira violen-tissima, appena mitigata dalle forme ‘raffreddanti’del trattato scientifico e di un linguaggio straniantee storicizzato. Ma se Mussolini ha tradito e irretitoun’intera popolazione, questa stessa popolazione siè fatta governare per un ventennio ed è quindi essastessa colpevole di ignoranza, di insipienza e di an-nullamento delle proprie facoltà razionali. La folla èfemmina e nella sua ninfomania politica è rintrac-ciata la causa della dittatura fascista.Il paradosso e l’iperbole sono caratteristiche co-stanti di questo testo, al quale non si deve chiedereun’analisi obiettiva e scientifica del fascismo, mauna sua interpretazione in chiave letteraria. E la let-tura psicanalitica datane da Gadda, per quanto nonortodossa, può essere annoverata fra le più origina-li interpretazioni di quel periodo storico conosciutealla nostra letteratura.
La dissoluzione del «pasticcio». La parola-chiave del-l’ultimo e più celebre romanzo gaddiano è nel suostesso titolo: Quer pasticciaccio brutto de via Merula-na. Il pasticcio, infatti, inteso come lo scomporsi e losfaccettarsi della realtà, che viene ad essere priva diuna sua, unica chiave di interpretazione, è al centrodella riflessione gaddiana sin dai tempi della Medita-zione milanese. Il protagonista del Pasticciaccio, ilcommissario Ingravallo – chiamato a indagare sull’as-sassinio, avvenuto in via Merulana 219, di una signo-
212
Carlo Emilio Gadda • Gadda e la critica
ra della buona borghesia – dichiara sin dall’aperturadel romanzo la sostanza ‘filosofica’ della sua inchie-sta. Nella sua verifica dell’inesistenza di una causa alsingolare che possa dare compiuta spiegazione deglieventi, egli non fa altro che mettere in praticaquell’‘emendazione del principio di causalità’ cherappresenta uno dei primi nuclei della riflessione fi-losofica gaddiana ( 214).Sul piano stilistico, nel Pasticciaccio il plurilingui-smo ‘esplode’ nelle sue forme più alte, contami-nando i vari registri precedentemente sperimentaticon il dialetto romanesco della voce popolare, conquello molisano di Ingravallo e quello napoletano,con il linguaggio burocratico, e con straordinari in-serti lirici dai toni gravi e solenni.
La produzione saggistica. La prima raccolta di saggipubblicata da Gadda, Le meraviglie d’Italia (uscitanel 1939 e poi ristampata insieme a Gli anni nel1964), raccoglie articoli pubblicati in varie sedi, dal-la metà degli anni Trenta agli anni Sessanta. Si pas-sa dalla rappresentazione del mercatino dell’usato(Carabattole a Porta Ludovica) o del macello mila-nese (Una mattinata ai macelli) alla descrizione diun’operazione chirurgica di appendicite resa conuna precisione scientifica che potremmo definireiperrealista, ma che è in realtà simbolica, dal mo-mento che attraverso le viscere del paziente si offreallo scrittore il nefando pasticcio della vita ‘esterio-rizzata’, stanata fuori dalla sua caverna come pre-da nell’orrore (Anastomòsi).Nel 1958, con la collaborazione di Pietro Citati, Gad-da raccoglie i saggi scritti dal 1927 al 1957 nel volu-me I viaggi la morte. Vi entrano testi di grande im-portanza come Lingua letteraria e lingua dell’uso (227), Le belle lettere e i contributi espressivi delle tec-niche ( 214), Psicanalisi e letteratura, che fissanole linee di una personale poetica e questione dellalingua; ma anche acute recensioni a spettacoli tea-trali o volumi, in poche parole: Il laboratorio diGadda, i suoi eroici furori: dal metodo di lavoro agliautori amati, dalle polemiche alle impennate.Ma non meno importanti sono i saggi di caratterepiù strettamente ingegneresco, raccolti nel 1986 inAzoto. Non sono semplicemente articoli di divulga-zione tecnico-scientifica – come quelli sulle nuoveleghe metalliche, o sulle opere di canalizzazionedei fiumi – ma luoghi dove risuona, con vere e pro-prie movenze narrative, il valore esemplare del la-voro dell’uomo, la sua paziente e consapevole rior-ganizzazione della realtà naturale verso un’altrarealtà più piena e vera.
Gadda e la critica
Non è difficile comprendere, in conclusione, comemai Gadda sia stato sostanzialmente ignorato dallacritica fino alla seconda metà degli anni Cinquanta;estraneo a tutte le mode letterarie, refrattario allevarie correnti di pensiero, aristocraticamente isola-to in una prosa dura, ostica e difficile, in contesta-zione permanente con un sistema che prima anco-ra di essere letterario, sociale o politico, era un si-stema di conoscenza.Un’ignoranza che, tuttavia, annoverava illustri ec-cezioni come Contini che, nel fare dell’ingegnere-scrittore un nuovo canone letterario (la cosiddet-ta «funzione Gadda»), se da un lato lo relegava inun solitario riserbo, dall’altro lo sottraeva a faciliinquadramenti (come quello del Neorealismo, acui l’autore stesso reagì prontamente). O comeGian Carlo Roscioni, a cui si deve l’intervento cri-tico di maggior peso negli anni Sessanta (oltre al-l’edizione di testi fondamentali come la Medita-zione milanese).Dopo il successo editoriale del Pasticciaccio, la cri-tica gaddiana ha vissuto un momento di grandecrescita, che si è tradotto in un incremento consi-stente di monografie, pubblicazioni e traduzioni,che contribuiscono ad ampliare la fama dell’inge-gnere all’estero (nel 1963 la Cognizione vince ilPrix international de littèrature).Un vero e proprio boom interpretativo si è peròverificato in concomitanza con le esperienze del-l’avanguardia legata al Gruppo 63 ( 126). In unmomento fortemente ‘eversivo’ per la letteraturaitaliana, in cui la morte del romanzo sigla la con-danna della cultura borghese, le soluzioni gaddia-ne sembrano l’unica via a una nuova narrativa. Lalettura di Gadda procurata dalla Neoavanguardia,se ha conferito a quest’ultima un nume tutelare eun’auctoritas d’indiscusso rilievo, ha tuttavia im-pedito per anni una corretta interpretazione dellanarrativa gaddiana.La complicata vicenda editoriale che vede protago-nisti i testi dello scrittore ha contribuito ad aumen-tare le difficoltà della critica: opere come punta diun iceberg che solo di recente ha iniziato a delinea-re le sue terre sommerse. Un contributo fondamen-tale nella delineazione di questa nuova geografiagaddiana e alla ricostruzione ‘filologica’ delle ope-re è venuto da Dante Isella, che ha diretto l’edizio-ne del corpus di Gadda per Garzanti.
213
214
IL SECONDO NOVECENTODal dopoguerra a oggi
Autori
Strumenti
La poetica filosofica di Gadda
Come si è più volte osservato, in Gadda, sin dall’inizio della sua attività letteraria, la scrittura narrati-va procede di pari passo alla speculazione filosofica, e il momento riflessivo convive con quello crea-tivo fino a surclassarlo, come accade, per esempio, nel Racconto italiano di ignoto del Novecento.Fondamentali per comprendere l’interrelazione tra analisi teorica e risultati ‘pratici’, soluzioni espres-sive della prosa gaddiana sono, come si è già osservato, gli studi di Gian Carlo Roscioni.
Conoscenza e deformazioneNell’estate del 1928 Gadda si propone di completare la sua tesi di laurea, intitolata La teoria della co-noscenza nei «Nuovi saggi» di Leibniz. I quaderni che ci sono rimasti contengono però solo alcuniabbozzi, schemi e riassunti che non vanno oltre lo stadio di materiale preparatorio; la tesi, infatti, nonsarà mai discussa. Dal 2 maggio al 28 giugno, però, Gadda stende un’opera particolarissima, una lun-ga riflessione filosofica in cui dà forma ai propri principi gnoseologici elaborati sulla base delle lettu-re di Leibniz, Spinoza, Bergson, e soprattutto dell’insegnamento del maestro, il filosofo Piero Marti-netti (1872-1943). La Meditazione milanese, che resterà inedita fino al 1974, non ha però la forma deltrattato filosofico; le dimostrazioni cedono infatti il posto a digressioni che acquistano progressiva-mente una loro piena autonomia narrativa, mentre la lingua tende a spostarsi dal piano argomentati-vo e denotativo a quello espressivo e connotativo (numerose sono le metafore, le analogie, le simili-tudini). L’analisi schematica dei principi sostenuti nella Meditazione è fondamentale ai fini di com-prendere il quadro di riferimento del percorso narrativo e, più ancora, linguistico dello scrittore; il‘problema’ della lingua, in Gadda, è infatti strettamente dipendente da quello della conoscenza.La teoria gnoseologica gaddiana si basa sulla visione della realtà in senso sistemico. Il reale risultacomposto da dato e sostanza; nel primo Gadda identifica un divenire e un persistere, ovvero un per-manere quasi privo di alterazioni, d’alcuni elementi d’un sistema, mentre altri si deformano più in-tensamente. Son essi questi elementi apparentemente provvisoriamente inalterati, son essi che ci per-mettono di travedere una continuità del sistema, un’unità e consecuzione del tempo, un essere, unnucleo sostanziale. L’esempio che meglio illustra questo concetto è offerto dal gioco degli scacchi: lamossa di un singolo pezzo non muta la configurazione del solo pezzo (non lo deforma), ma quelladi tutto il sistema-gioco, perché invalida la mossa che l’avversario avrebbe potuto fare e quelle po-tenziali future. Tutti i sistemi di cui si compone la realtà (e anche l’io, che è esso pure un sistema) in-teragiscono fra loro in mutua interdipendenza; non esiste quindi un sistema fisso e isolato dagli altri,ma tutti i sistemi sono in continua evoluzione e, a causa dei rapporti che intrattengono fra loro, incontinua ‘deformazione’. Ne deriva che anche la conoscenza, mettendo in relazione il sistema-io coni sistemi-dato, è soggetta a questo processo: procedere, conoscere è inserire alcunché nel reale èquindi deformare il reale.
Filosofia e linguaggioIn un saggio del 1929, Le belle lettere e i contributi espressivi delle tecniche, Gadda istituisce una con-nessione tra questa concezione della realtà e della conoscenza e il problema linguistico: lo stessorapporto che l’io intrattiene con la realtà è infatti istituito tra lo scrittore e la lingua.La lingua è concepita non come una realtà fissa e immutabile, ma come una realtà (un dato) in dive-nire: Lo scrittore – sostiene Gadda – ha davanti a sé delle realtà storiche esterne, come il cavatore hadei cubi di granito da rimuovere […] Lo scrittore a sua posta rimuove e coordina queste realtà date(storiche esterne) o le ricrea, o meglio conferisce ad esse quel supersignificato che è il suo modo diespedirsi. Tali realtà costituiscono il linguaggio. Esiste quindi un dato linguistico preesistente (linguad’uso, lingua letteraria, linguaggi tecnici, dialetti) rispetto al quale ogni operazione linguistica è in séuna deformazione, necessaria allo scrittore perché in questo consiste la sua arte. Nessuna innovazio-ne in campo linguistico dovrà però prescindere dalla funzione comunicativa del linguaggio (Gaddaè molto lontano, in questo, dalle avanguardie futuriste o dadaiste, nonostante ne condivida l’atteg-
Carlo Emilio Gadda • Gadda e la critica
215
Strumenti
giamento rivoluzionario in campo linguistico); il processo di disgregazione e ricostruzione del datolinguistico è sempre animato, in Gadda, da una forte tensione etica. Per tornare all’esempio del ca-vatore, egli può tritare il mattone offertogli e poi rimpastarlo e rifarlo a suo modo mattone, e poi se-guitare alla fabbrica del ‘suo muro’, che è la ‘sua opera’, ma questo processo non può e non deve es-sere gratuito, non può prescindere da un dovere di rappresentazione del reale per come esso si con-figura (realtà sistemica). Se quindi conoscenza e deformazione coincidono, dovere dello scrittore èarricchire la lingua degli apporti più disparati, in un plurilinguismo o pastiche linguistico che è mol-to più di un espediente stilistico, e si configura come l’adeguamento delle forme espressive a unanuova e moderna concezione della realtà.
Le «causali convergenti»Altro caposaldo della visione filosofica gaddiana, fondamentale a comprendere l’impianto narrativodei suoi romanzi, è la cosiddetta ‘emendazione del principio di causalità’ (di quella teoria filosofica,cioè – il cui esponente, nella filosofia antica, è Aristotele e in quella moderna Kant – che individuauna correlazione necessaria, di causa ed effetto, tra i fatti dell’esperienza); se gli elementi della realtàsono organizzati in sistemi costituiti da infinite relazioni, infatti, non esiste più un’univoca relazionedi causa-effetto, non esiste, come sosterrà il commissario Ingravallo nel Pasticciaccio, un unico mo-tivo, una causa al singolare: ma [le inopinate catastrofi] sono come un vortice, un punto di depres-sione ciclonica nella coscienza del mondo, verso cui hanno cospirato tutta una serie di causali con-vergenti. L’immagine che meglio esemplifica il concetto è rappresentata, nella Meditazione milane-se, dal garbuglio: La deformazione della figura comporta deformazione interna degli elementi col-piti […] i quali non ci è dato di concepire se non pensando a grovigli o nuclei o gomitoli di rapporti,privi affatto d’un contorno polito. In modo non diverso, Ingravallo parlerà di nodo o groviglio, ogarbuglio, o gnommero, che alla romana vuol dire gomitolo. Ne deriva l’impossibilità di dipanaregli ingarbugliati intrecci della realtà e della finzione letteraria che la rispecchia secondo un unicopunto di vista, di chiudere la narrazione su una verità pacificante; di qui l’incompiuto e la fram-mentazione narrativa.
La digressione e l’innesto del presente in praeteritum tempusSi ricollega al quadro gnoseologico sopra tracciato la caratteristica tecnica digressiva del narrare gad-diano. La scrittura dell’ingegnere è – come osserva acutamente Emilio Manzotti, che qui seguiamonella caratterizzazione del fenomeno – «in equilibrio dinamico tra forze contrastanti: forze accentra-trici e organizzatrici da una parte, e dall’altra forze disgregatrici», sempre in bilico tra l’intreccio e lesue infinite implicazioni-digressioni, tra la disgregazione e la riorganizzazione del reale. La digressio-ne si configura spesso come aggancio della vicenda presente a vicende passate (con un’operazionegià del Racconto italiano di ignoto del Novecento), secondo il modello manzoniano di innesto delpresente (nei Promessi sposi, l’Ottocento) in un praeteritum tempus (nei Promessi sposi, il Seicento).L’operazione narrativa ha in Gadda un suo significato ‘ontologico’ e tragico, e si presenta come co-rollario e naturale conseguenza della concezione universale del male: l’aggancio al passato deve ser-vire da collegamento tra dramma presente e dramma universale: il continuo riferimento del male an-tico al nuovo aumenta la risonanza tragica di ogni pensiero – scrive Gadda nell’articolo Apologiamanzoniana (1927), tratto dal corpus del Racconto italiano.Il testo, rifiutando la tradizionale chiusura di ogni opera narrativa, soggiace a forze centrifughe, e in-trattiene legami con tutti gli altri testi dell’autore; spesso conosce un prolungamento nelle note, luo-go nel quale si deposita quanto esorbita dalla struttura portante del racconto. Costante è poi la ten-denza a inquadrare l’entità singola nella collettività (classe sociale, situazione storica e politica), o avederla come effetto, risultato della sua storia. Ogni oggetto, infatti, in quanto ragnatelo di riferi-menti infiniti, rimanda a quanto l’ha preceduto: La realtà sembra una città e la città è fatta di case; ela casa fatta di muri: e il muro è fatto di mattoni; e il mattone è fatto di granuli. E il granulo è in sé, ènel mattone, è nel muro, è nella casa.
216
La Madonna dei Filosofi
Il ‘dittico’ Teatro-Cinema. Primo libro pubblicato daGadda, La Madonna dei Filosofi può a ragione esse-re considerato «un’opera di transizione» (Ferretti), seconsiderato all’interno dell’officina dello scrittore.Uscito nel 1931 per le edizioni di «Solaria», esso rac-coglie alcuni testi pubblicati tra il 1926 e il 1928 su«Solaria» e altre riviste. La giustapposizione cela tut-tavia un progetto compositivo: la raccolta è apertadal racconto Teatro, cronaca di uno spettacolo d’o-pera, al quale corrisponde simmetricamente Cine-ma, penultimo racconto della raccolta e polo posi-tivo, pars costruens di un dittico di cui Teatro è lapars destruens, il polo negativo. Al roboante melo-dramma viene infatti contrapposto il cinema, eva-sione popolare dalla realtà concessa a chi lottaquotidianamente contro lo stato d’animo di stan-chezza e di tedio della vita. L’arte popolare del ci-nema è preferita non solo perchè reca un oblio mo-mentaneo dal male, ma perchè costituisce un co-mune termine di riferimento per lo scrittore e unmodo di inserire sè nell’universale umano (comeGadda aveva teorizzato nel Racconto italiano diignoto del Novecento).Nella dialettica tra i due poli, il primo offre alloscrittore un banco di prova della sua capacità dimanipolazione linguistica, di corrosione critica del-la realtà attraverso l’arma dell’ironia e della defor-mazione grottesca. La realtà diventa mirabile cari-catura: Gadda ha un illustre precedente in CarloPorta, che nelle Olter desgrazi de Giovannin Bon-gee (1812-13), raccontando le avventure di Gio-vanni e della sua Barborin alla Scala, alBallo Prometeo, aveva offerto unaprima straordinaria caricatura delmelodramma ottocentesco.
Le altre prose della raccolta.A Teatro seguono le breviprose descrittive degli Stu-di imperfetti e il ricordo diguerra delle Manovre di ar-tiglieria da campagna. La raccolta è conclusa dallaMadonna dei Filosofi, che ledà il titolo ed è racconto di mag-gior respiro e compiutezza narrati-va, ambientato a Milano nel 1922. Itre protagonisti hanno tutti qualche rap-
porto con la biografia di Gadda: Maria Ripamonti(il cognome della nonna di Gadda), una ragazza dicampagna che ha perso il fidanzato Emilio in guer-ra (come Enrico Gadda, morto nel 1918), ama, cor-risposta, l’ingegner Baronfo, uomo colto, appassio-nato bibliofilo e dalle curiose idiosincrasie (eviden-te proiezione dell’autore). Allo svolgimento argo-mentativo del racconto fa da contrasto il finale ro-manzesco da feuilleton a effetto: la relazione tra idue innamorati (due sconfitti dalla vita che si con-solano a vicenda) viene interrotta dalla brusca irru-zione, nella vita di Baronfo – a scopo di vendetta –di una sua ex amante, tradita, delusa e con un figlioa carico. Il finale non conclude, ma riflette sul maleche la vita procura al figlio innocente.
Lingua e stile. Per comprendere lo stile del volume,si deve pensare all’ambiente fiorentino degli anniTrenta e al gusto della prosa d’arte che una rivistacome «Solaria» aveva certo contribuito a diffondere.Il racconto Manovre di artiglieria da campagna,infatti, inviato da Gadda alla rivista fiorentina avevaricevuto un fermo rifiuto da parte del suo direttore,Alessandro Bonsanti (poi uno fra i più affezionatiamici fiorentini). Si può quindi immaginare comeGadda, per garantirsi quell’ingresso nel mondo deiletterati di mestiere che gli avrebbe permesso di svi-luppare in seguito una vena più personale e risenti-ta, avesse operato una radicale selezione rispetto almateriale presente nel suo cantiere, scegliendo so-lo quanto era più affine al gusto imperante nell’am-biente del caffè fiorentino delle «Giubbe rosse», inparticolare la sezione degli Studi imperfetti, i piùlegati alla poetica del frammento e della prosa d’ar-te. Il gustoso campione di plurilinguismo sperimen-
tato in Teatro, ampiamente apprezzato dal-la critica, aveva sollecitato l’ingegnere a
continuare sulla medesima linea conil coevo Cinema.
Nonostante la promozione degliamici e dello stesso ingegnere,La Madonna dei Filosofi ven-derà poco più di duecento co-pie, e rara e poco entusiasticasarà l’accoglienza della critica:Gadda, anomalo ingegnere pas-sato alle lettere, resta un diverso,
uno «stravagante minore», e tutt’alpiù un umorista.
IL SECONDO NOVECENTODal dopoguerra a oggi
Autori
Ottone Rosai, Uomini al tavolo, particolare,1942, olio su tela, Milano, Galleria Sacerdoti.
Carlo Emilio Gadda • La Madonna dei Filosofi
217
La critica e il testo
Più che un’analisi… un invito
P. Cudini
Come districarsi nel labirinto gaddiano
Per un’opera come quella di Gadda, notoriamente com-plessa, dai molteplici e intricati piani di comprensione,ci è sembrato opportuno venire meno alla consuetudinedi offrire in questa sezione un’analisi puntuale del testo.Per questa rimandiamo all’Analisi del testo ( 225).Il brano che proponiamo è piuttosto un invito ragionatoalla lettura dell’‘ingegnere’ lombardo, un percorso gui-dato attraverso le indubbie difficoltà della sua opera. Adaccompagnarci nei meandri gaddiani è Piero Cudini,docente della Normale di Pisa, recentemente scomparso,che, dopo essersi occupato a lungo di questioni ‘serissi-me’, bibliografiche e filologiche, ha scritto negli anni No-vanta opere dichiaratamente divulgative, utilizzandouno stile e un linguaggio capaci di trasmettere la passio-ne per la nostra letteratura al maggior numero possibiledi giovani. Sulla raccolta di racconti La Madonna dei fi-losofi, Cudini parla di componimenti «in apparenza fa-cili, di fatto già ricchissimi, spesso densi di una satiragaddiana feroce». Il testo antologizzato ci fornisce l’oc-casione per capire quanto l’opera più ‘facile’ di Gaddasia in realtà (soprattutto linguisticamente) più ‘difficile’di tante opere contemporanee. Gadda è una sfida conti-nua alla banalità. Chi supera le difficoltà iniziali puògodersi però una delle prose più affascinanti e coinvol-genti dell’intero Novecento (non solo italiano).
Su Carlo Emilio Gadda, lo so, ci sono forti, fortidiffidenze popolari. Non voglio imporvelo. Pe-rò si perde molto, a non leggere Gadda. Si per-
de un processo conoscitivo del mondo, processo diconoscenza che è profondamente tragico e che sa es-sere anche, in superficie, carico d’ironia, di diverti-mento aspro, tocca il grottesco. Gadda non è, comebanalmente si afferma da molte parti e da sempre, ilgiocoliere di parole, compiaciuto di questa sua abi-lità. Nessun altro scrittore ha come Gadda, nel Nove-cento, una tanto alta sostanza tragica. Nessun altro sausare come Gadda, con la sua determinazione e con-sapevolezza uno strumento linguistico arduo e dutti-le, consapevolmente adeguato alla ricchezza e molte-
plicità – a volte tragicomica – del reale. La comples-sità del reale (che è un «nodo o groviglio, o garbuglio,o gnommero, che alla romana vuol dire gomitolo»:così quasi all’inizio di Quer pasticciaccio brutto devia Merulana, in volume nel 1957) diventa comples-sità della rappresentazione, mediatissima del reale.Nel linguaggio straordinariamente compatto e com-posito di Gadda trovano pari dignità forme dialettali,gerarchia, tecnicismi, arcaismi: tutto in funzione diuna rappresentazione del caos tragico e grottesco delreale. Due romanzi soprattutto, indimenticabili e soli-tari - via, consentitemi una bella espressione pacchia-namente retorica - sulle vette più alte del Novecento:il Pasticciaccio e La cognizione del dolore (in volumenel 1936; da vedere poi, con due capitoli inediti, nel-l’edizione del ’70). Accettate un consiglio: andate pergradi. Gadda non lo si può, non lo si deve ignorare.Non lo si può riassumere, e io non posso ora sensa-tamente mettermi a raccontarvelo. Incominciate dun-que per vostro conto con la lettura del Gadda degli ini-zi, proprio il suo primo, La Madonna dei Filosofi, 1931,racconti in apparenza facili, di fatto già ricchissimi,spesso densi di una satira feroce. Poi le prose de Le me-raviglie d’Italia: ovvero, anche, come Gadda sia scritto-re «d’occasione» assolutamente eccezionale (come,cioè, costituisca comunque eccezione). Poi almenoL’Adalgisa, dieci racconti che escono in volume nel1944, una angoscia profonda quasi sotto ogni riga, atentare di recuperare una realtà frantumata, sostanzial-mente inconoscibile, un senso di odio violento, di di-sprezzo per quella borghesia milanese che Gadda ridi-colizza, rispetto alla quale ostenta distacco, per la qua-le sembra tenere rabbiosamente nascosti fervori d’amo-re. Di Gadda vanno poi le lettere, soprattutto quelle aun altro prosatore grandissimo, critico sommo del no-stro secolo, Gianfranco Contini; quando le avrete lette,penserete che il telefono l’hanno inventato perchè tan-to nessun altro saprebbe più scrivere lettere come Gad-da – che infatti detestava il telefono. E va letto l’ango-sciato e dignitosissimo Giornale di guerra e di prigio-nia. Avrete così progressivamente e profondamentecominciato a nutrirvi di Gadda. Ora sicuramente loamate. Ora potete cominciare a lottare col Pasticciac-cio e con la Cognizione. A lottare, come si fa con Dan-te, che ti spiazza sempre, che è sempre troppo troppo
218
IL SECONDO NOVECENTODal dopoguerra a oggi
Autori
più grande di te – e proprio qui sta il gusto della lotta,non essere del tutto sopraffatti, riuscire quanto meno acapire qualcosa del sistema, a entrare nelle assi ardue,ma sicuramente geometriche e perciò individuabili e ar-duamente ripercorribili, regole del gioco, della scrittura,delle sue profondità. Si deve farlo con Dante. Lo si devefare anche con Gadda. Succede solo coi grandissimi.Chiudo – e capirete subito perché, di fronte a talegrandezza – con un Gadda delizioso, solo in appa-
renza «minore», Il primo libro delle favole, anno 1952(per la cronaca, ultimo nella cinquina dello Strega diquell’anno, dopo scrittoroni del rango di un Bontem-pelli, di una Gianna Manzini, di Tobino, Bernari...).Favola 146: «Il Viale Giulio Cesare mette capo al lar-go Ermenegildo Fregnetti. E tal è di noi. Amen»
(da Che fai tu luna in ciel: il romanzo della letteratura italiana,Rizzoli, Milano 1995)
Teatroda La Madonna dei Filosofi
Il racconto è la cronaca straniata e grottesca di uno spettacolo d’opera lirica. L’autore iro-nizza sulle forme artistiche del melodramma ottocentesco, tanto vuote quanto magnilo-quenti, e si diverte a deformarne i tratti: dalle esibizioni dei cantanti e dell’orchestra allereazioni del pubblico.
Rimasi al buio.Non vidi più Giuseppina, né i Biassonni, né i Pizzigoni, né il grand’ufficiale Pesciatelli.In preda a un leggero batticuore, mi chiedevo che stesse accadendo, allorché apparverodelle rocce, percorse da un fremito: si gonfiavano come la vela toccata dal marezzo1: comeper bonaccia poi si abbiosciavano2. Qualche metro più in là il cielo dell’alba, con lo zaffì-ro richiesto dal caso: da un lato aveva assunto un aspetto lievemente verdastro in seguitoa una riparazione.Da dietro le rocce sbucarono, suscitando la curiosità generale, un uomo corpulento e una don-na assai pingue, stretta per altro nella ritenutezza d’un robusto fasciame3 cosparso di vetruzzi.C’era per aria un vecchio dispiacere.Presero difatti a rinfacciarsi l’un l’altra i loro diportamenti4: ella con lodoleschi5 trilli e occhidi ex-vipera. Egli bofonchiò truce le più spropositate assurdità. Parevano dapprima un po’timidi, oh! ma si rinfrancarono tosto.Inorgogliti dalle luci color indaco, violetto e giallo canarino che gli aiuti-elettricisti proiet-tavano sopra di loro, eccitati dall’invidia e dall’ammirazione che venivan suscitando in tut-ti gli altri, rimasti così miseramente al buio, essi tranghiottivano6 a tratti, nelle pause, la te-nue saliva del loro magnifico «io».Egli, poi, andava giustamente superbo d’un elmo dorato e d’una scimitarra argentata daltintinnìo metallico come di posateria presso l’acquaio.Vestiva lo smagliante costume dell’ammiraglio persiano, con calzari di cuoio al cromo ricca-mente adorni di gemme di vetro: aveva vinto Sardanapalo7 e i suoi temibili congiunti Aga-
1. marezzo: luccichio, riverbero della luce.2. si abbiosciavano: «si accasciavano»; il
termine è di uso dannunziano.3. fasciame: il termine, che indica, pro-
priamente, l’insieme delle tavole che rivesto-no l’ossatura di una nave, ha qui un signifi-cato chiaramente ironico e caricaturale, desi-gnando il busto rigido, ma con pretese dieleganza (cosparso di vetruzzi), in cui le ab-bondanti forme della donna sono costrette.
4. diportamenti: «comportamenti», termi-ne raro e di uso letterario.5. lodoleschi: «da allodola», neologismo
gaddiano.6. tranghiottivano: «inghiottivano avida-
mente», è termine arcaico.7. Sardanapalo: ultimo grande re dell’As-
siria, noto anche con il nome di Assurbani-pal, vissuto tra il 669 e il 627 a.C.; si distinseper le imprese belliche che lo videro vitto-
rioso (campagna d’Egitto, repressione dellarivolta di Babilonia), ma anche per il lussosfrenato di cui si circondava, tanto da passa-re alla storia come esempio di dissolutezza evizio. La parentela con Agamennone (miticocomandante dell’esercito greco durante l’as-sedio di Troia) e Pigmalione (mitico re di Ci-pro) è, naturalmente, fittizia, e bene esem-plifica l’astoricità di certe improbabili tramedei libretti d’opera ottocenteschi.
Carlo Emilio Gadda • La Madonna dei Filosofi
219
mennone e Pigmalione: si esprimeva concitatamente, mediante settenari sdruccioli e tronchi.I più significativi provocavano dei violenti starnuti in ottanta uomini ordegni8 che un si-gnore in frack9 teneva a disposizione dell’ammiraglio.La donna, una faraònide10, vestiva a sua volta in modo superiore a ogni previsione.Dodici lunghi pennacchi, rigidi ed aperti a ventaglio, corroboravano di un’aureola tacchi-nesca il santuario della pettinatura.Per diademi e collane fascinanti barbagli, come ai bastioni Genova, con altri timpani, quel-la che il serpente carezza11.Diademi, collane; occhiaie bleu. L’abito rosa trapunto di stupende pagliuzze metalliche; lostrascico una scopatrice stradale.Raccontò del suo crin e ci fornì elementi circostanziati sulle principali peripezie del suo sen;non trascurò l’alma; illustrò le forme più tipiche del verbo gire, coniugandolo al participio, al-l’imperfetto, al passato remoto e al trapassato imperfetto; propose alcuni esempi di quellaparte del discorso detta dai grammatici interiezione, scegliendoli con gusto e opportunità frai più rari della nostra letteratura, quali «orsù» e «ahi! lassa12».Tutto questo con gutturazioni impeccabili; le ultime, le più acute erano addirittura l’ì, ì, ì d’u-na porta malvagiamente irrugginita13, che si chiuda a scatti, nella beffa d’un ragazzo malvagio.Quando l’ultima vibrazione dell’ultimo ghirigoro si spense nel sepolcro notturno, un rag-gio di speranza arrideva ai nostri cuori fascinati: ma l’ammiraglio, che non aspettava altro(avendo nel frattempo ripreso fiato) scoppiò nelle più truculente vociferazioni.Rimasi esterrefatto. Mi spiegai per altro la gravità del caso, di fronte al quale le mie mode-ste preoccupazioni di ingegnere elettrotecnico dovevano necessariamente passare in se-conda linea: la pericolante successione al trono d’Egitto, cui portavano inciampo gli amo-razzi della ben nota regina Semiramide, veniva a complicarsi ulteriormente per effetto del-le mire ambiziose di Giocasta e di Maria Teresa14.Esse andavano sobillando (l’una però all’insaputa dell’altra) la celebre etàira Anassàgora15,affinchè, attratto l’ammiraglio in una notte di piaceri durante il plenilunio imminente, vo-lesse condividere secolui il pomo di Cafìr16, per buona parte avvelenato, lasciando quelgrande nelle peggiori difficoltà.Uomo e donna finirono per litigare: usarono, è vero, modi assai sconvenienti, ma nessunamaiolica fu portata in scena, come nel dozzinale cinematografo. Accorsero diverse persone.Intanto l’ala aquilonare, vaga sempre nelle alte regioni atmosferiche, andava molestandouna roccia, fra le maggiori costituenti quell’importante gruppo orografico.Apparve un pompiere. Credevo intervenisse per sedare il battibecco, per ricondurre il vin-citore di Agamennone a più miti propositi, avvalendosi assai opportunamente di disposi-zioni regolamentari. Ma, riflettendo meglio, capii che si era sporto per errore, forse attratto
8. uomini ordegni: «professori d’orche-stra»; sintagma d’ispirazione quasi futurista:ordegno è variante arcaica di ordigno, chesta, genericamente, per «strumento mecca-nico di natura complessa».9. signore in frack: ci si riferisce al diret-
tore d’orchestra.10. faraònide: «regina dell’antico Egitto»;il termine ‘strizza l’occhio’, ironicamente, alparonomastico faraona (il «gallinaceo do-mestico di origine africana»), come confer-ma l’aureola tacchinesca di qualche rigapiù avanti.11. Per diademi … carezza: il luccichio [ibarbagli] che mandano i finti gioielli della fa-raònide-soprano ricorda lo sfarzo degli orec-chini [timpani è metonimia per orecchi] por-tati dalla prostituta [carezzata dal serpente,
simbolo del peccato] dei bastioni di PortaGenova [una delle porte di Milano].12. Raccontò … lassa: è compendiata, inqueste righe, la maggior parte del reperto-rio lessicale – d’impronta poetica – della li-brettistica ottocentesca (crin, sen, alma,gire), già irriso nell’accenno, poco sopra, aisettenari sdruccioli e tronchi.13. irrugginita: «arrugginita», forma aulicapresente, non a caso, nelle Grazie foscolia-ne (Inno I, Venere, 110-111: il pio stromen-to irruginìa su’ brevi / solchi sdegnato), iltesto in cui viene teorizzato il connubiodelle arti da Gadda preso di mira.14. Semiramide … Maria Teresa: fanno dapendant femminile al precedente terzetto(Sardanapalo, Agamennone, Pigmalione) lalussuriosa regina degli Assiri ricordata, tra gli
altri, da Dante (Inferno, V 52-60), Giocasta,madre e sposa di Edipo, e Maria Teresad’Austria, l’imperatrice dagli impeccabili gio-chi politici in materia di successione al trono.15. etàira Anassagora: la grafia etimologi-ca (etàira in luogo del più comune «etera»),sottolineando la pretenziosità del riferimen-to, finisce per smascherare lo strafalcionestorico, assai frequente, peraltro, nelle com-plicatissime trame dei libretti d’opera: il filo-sofo greco Anassagora (499-428 a.C.) è infat-ti scambiato (per via della terminazione in -adel suo nome) con una cortigiana, che rice-ve dalle donne l’incarico di uccidere con l’in-ganno l’ammiraglio (il tenore).16. pomo di Cafìr: allusione alla mela diEva, tentazione e perdizione (Cafìr in ara-bo significa «infedele»).
220
IL SECONDO NOVECENTODal dopoguerra a oggi
Autori
dal campo magnetico rotante di alcune danzatrici17, i cui piedi sembravano volersi disfare,ora al nostro indirizzo ora al suo, di una molesta ciabatta.Egli non faceva parte del capolavoro: è un pompiere, per spegnere «il fuoco», se avviene«l’incendio», poichè tutto è previsto nei moderni teatri. Qualche arrosto metropolitano nonè che un’eccezione a confermare la regola; si tratta d’altronde della disciplinata solerzia deivigili nel trattenere la folla dei salvatori troppo dilettanteschi.Nel frattempo gli elettricisti avevano tramutate le loro luci in giallo limone ed arancionedacché, secondo notizie raccolte e coordinate in appresso, all’alba era succeduto il giorno.Inseguirono con i riflettori l’ammiraglio e la faraònide che si aggiravano sbraitando sull’im-piantito: se miravano male, in quella specie di tiro al piccione, davano aureole e barbaglial pompiere.Gli accorsi erano divenuti folla: si distinguevano agevolmente, ai varî e tipici costumi di te-la stampata, pescatori, arcieri, peltasti18, prefetti del popolo, mugnai assiro-babilonesi, in-dovini, legionari romani, navarchi19, fabbricanti di vasi di Samo, chiromanti di Cirene, pilo-ti mauri, il pretore d’Oriente con tre persone del seguito, pubblicani, farisei, dentisti, torni-tori di gambe di seggiola, ex-ministri di Sardanapalo ed altre persone di moralità indiscus-sa, dotate comunque di buona volontà mesopotamica o di solida cultura classica, come te-stimoniavano le varie fogge del loro abbigliamento.Eppure presero a delirare tutti in una volta, inseguendo con laceranti unìssoni i fonismi20 diquei due: urlavano a perdifiato le più roboanti stravaganze, le più imprevedibili assurdità,senza muoversi, senza guardarsi, rossi, gonfi, turgidi le vene del collo21, il mastoide indafa-rato come un ascensore22, le mani in mano: e come rivolti al nulla e a nessuno; e come as-solti23 da ogni riferimento alla realtà delle cose. Ogni faccia, maschera della follìa, defeca-va la sua voce totale nella cisterna vuota dell’insensatezza.«Meraviglioso, meraviglioso…» mormoravano nel palco vicino i signori Biassonni. Anche ilgrande ufficiale Pesciatelli, che non si meraviglia mai di nulla perchè ci tiene a farsi pren-dere per un inglese, fu coinvolto nella stupefazione generale.Il signore che, in frack, è sul podio, avrebbe potuto interporre i suoi buoni uffici e la sua au-torità per sedare tanto tumulto: e invece si sbracciava ad esacerbarlo, incurante degli insegna-menti del Vangelo e del progressivo rammollimento cui le parti inamidate della persona veni-van soffrendo24.Si ebbe così un ben meritato castigo, dacchè le ridusse impresentabili, macerandole di aci-di della serie aromatica e della serie grassa, di ammino-acidi, di composti albuminoidi varîe di altre sostanze azotate.Perchè si prestasse a ciò, la direzione del Teatro gli aveva conferito un lauto onorario.A un tratto, il buio cessò anche per me.Lo sfolgorìo dei lampadari avvolse di luce le più giovani dame della città, dicendo alto l’e-logio di dolcissime curve o della «maigreur élégante de l’épaule, au contour heurté25». Al-cune, come una goccia di sangue, avevano un rubino sulla bianchissima gola.Le attendono i cuscini dal disegno ignorato; ora il genio del melodramma disseta le loroanime con la linfa della eterna bellezza.
17. campo … danzatrici: iperbole ‘inge-gneresca’ dall’efficace effetto comico, deri-vata dal principio dell’elettrocalamita (unnucleo di ferro circondato da una bobina –cioè da filo conduttore avvolto in uno o piùstrati – al passaggio della corrente elettricasi magnetizza, si comporta come una cala-mita).18. peltasti: «soldati armati di pelta» (nellaGrecia antica, uno scudo piccolo e leggero).19. navarchi: si chiamavano così, nel-
l’antica Grecia, i comandanti di una flottao di una nave.20. fonismi: «suoni inarticolati, rumori»,neologismo gaddiano.21. turgidi … collo: accusativo di relazio-ne, o «alla greca», equivalente a: «con le venedel collo turgide, gonfie».22. mastoide … indafarato come un ascen-sore: «la mandibola [ma più precisamente etecnicamente: «la protuberanza dell’osso tem-porale, posteriore al padiglione dell’orecchio»]
che saliva e scendeva continuamente»; la for-ma scempia indafarato è un dialettalismo.23. assolti: «sciolti, astratti»; forma derivatadal latino absolvo («sciolgo»).24. incurante … soffrendo: «senza curarsiné di rappacificare gli animi (come insegna ilVangelo) né del fatto che così facendo suda-va terribilmente»; si noti l’escursione estremadal registro sublime a quello prosaico, basso.25. maigreur … heurté: «elegante magrezzadella spalla, dal netto profilo», in francese.
Carlo Emilio Gadda • La Madonna dei Filosofi
221
Ero sprovveduto di occhiale madreperlaceo: così le guardai a occhio nudo, dato che ci ve-do abbastanza bene anche così.Lo spettacolo fu indescrivibile: quella sera la più colta società babilonese26 s’era data conve-gno al Ponchielli. Il fondo del ferro di cavallo era percorso da signori serissimi. Nei palchipiù costosi, gli sparati perfetti27, le attillate bande dei frack28, i polsi immacolati, un distrattosussiego dicevano: «Noi conosciamo i retroscena della vita! Le spole secrete del mondo noisiamo a passarle per mezzo l’ordito della grossezza plebea29. La nostra scienza, il nostro in-gegno, il nostro potere, i nostri denari permettono al genio che ci divaghi30, come un giul-lare. Poiché questo è genio autentico». Difatti i buongustai, i cultori, i critici si congratulava-no gli uni con gli altri. In alto si sentiva gridare aranciata. Bacche di perle sui seni burrosidella seconda giovinezza: stille di brillanti. Non s’era mai vista una cosa simile. Un diffusoprofumo di paste e di farine da tavoletta31 mi faceva pensare a un favoloso gineceo, dovepurtroppo è proibito entrare, se non a speciali personaggi un po’ grassocci32.
Si udirono tuoni lontani: Sardanapalo era diretto verso le porte del Tartaro.L’impiantito fu zoccolato33 da un nùgolo di diavoli, con code di cartone e tridenti di legno rin-volto nella stagnola; le anche, come quelle degli antichi fauni34, erano avvolte di pelli caprine,le gambe protette da calze rosse. Erano le tempie provvedute di conetti di panno rosso im-bottiti, a raffigurare le emergenze cornee proprie di questi temibilissimi spiriti.Mentre li ritenevo assai vivaci e sprizzanti dagli occhi una perversa malizia, con la quale econ cenni della coda inducono le ragazze alle più rischiose disubbidienze, furono quellasera oltremodo melensi e sbugiardarano altresì quel turista fiorentino, che li fotografò in at-titudini poco contegnose e li dice facili alle peggiori scurrilità35.«Fatti più là, lasciami un po’ di posto», pareva dire ciascuno al suo simile, quando apparve-ro alquanto rattrappiti attardandosi e urtandosi, come dei collegiali dal fotografo.Un’aria fredda doveva tirare da qualche porticina di servizio del Tartaro con disagio del-l’ambiente plutonico36: perchè, con la coda dell’occhio, guardavan tutti da una parte quasiper dire: «Chiudila!».C’era poi, bisogna riconoscerlo, quel sordo mormoramento, come di grattugia, che l’uomoin frack andava ora suadendo ai suoi complici; l’ex-frenetico37 sembrava istupidito dalla va-leriana. Con le brache lente, con un sorriso imbelle, con la mimica del lestofante che av-verta sopra di sé i due occhi implacabili del sospetto, andava implorando da tutti il più pru-dente contegno. Abbadava ora agli ottoni e ai contrabbassi: e con un rattrappire la spallasinistra e con un richiamar la mano a casa e un distenderla, pareva dire: «Andiamo, via!»;poi con la destra infrenava38 i temuti scarti dei fagotti e le impennate de’ violini, de’ clari-netti e dell’oboe. Con le ginocchia faceva della ginnastica da camera.Seppi di poi che tutto quel lavorìo era inteso a procurarci la sensazione della correnteacherontea39.
26. babilonese: il riferimento è alla confu-sione di razze, lingue e stili che «contamina»la società milanese (ma in seguito, e poi co-stantemente nel Pasticciaccio, Babylon saràRoma; 244); l’aggettivo introduce il pa-rallelismo, implicito, tra la vacuità dei ro-boanti personaggi sulla scena e quella deivociferanti spettatori del teatro Ponchielli.27. sparati perfetti: le parti anteriori dellecamicie, perfettamente inamidate.28. bande dei frack: le falde – a coda dirondine – del frack, che si appoggiano, ade-rendovi perfettamente, ai pantaloni.29. Le spole … plebea: «noi attraversiamo letrame segrete del mondo, passando oltre lastupidità plebea»; le spole sono propriamen-
te le «spolette» o «navette» del telaio; qui iltermine è metonimia per trame.30. ci divaghi: ci distragga.31. farine da tavoletta: ciprie.32. personaggi … grassocci: perifrasi per«eunuchi», laddove l’aggettivo (grassocci) de-signa una ‘flaccidezza’ femminea, non virile.33. zoccolato: «calpestato con gli zoccoli».Il verbo zoccolare («far rumore con gli zoc-coli») da intransitivo è fatto qui transitivo(compare, infatti, nella diatesi passiva).34. fauni: divinità protettrici dei campi,con un aspetto per metà umano per metàcaprino (erano raffigurati con orecchie ap-puntite, corna e piedi di capra). 35. turista … scurrilità: Gadda si riferisce
qui al ritratto dei diavoli tratteggiato daDante (turista dell’oltremondo infernale) ealle scurrilità descritte in Inferno, XVIII 64-66 e XXI 48-57, 67-139.36. plutonico: «infernale»; da Plutone, diogreco dell’oltretomba (il Tartaro).37. ex-frenetico: «lui, che prima si era agi-tato come un pazzo»; l’aggettivo freneticoha qui un’accezione tecnica, clinico-medi-ca, suggerita anche dal seguente valeriana.38. infrenava: «frenava, metteva a freno»;il verbo appartiene, con ogni probabilità, alcampo semantico dell’ippica, come sugge-riscono i successivi scarti e impennate.39. corrente acherontea: l’Acheronte è ilmitico fiume infernale.
222
IL SECONDO NOVECENTODal dopoguerra a oggi
Autori
Le lampade ad arco40 aiutarono la bisogna, poiché, sottoposte all’accurato controllo deglielettricisti, presero a fare dei friggimenti e dei gargarismi carbureggianti41: volevano sputa-re una resca, ma non gli veniva. La grattugia fece su tutti la più favorevole impressione:«Meraviglioso, meraviglioso…» andavano dicendo i Biassonni.È il connubio delle arti42. Nove muse intrecciate fra di loro.Perché un piacere alla volta?Qui l’occhio vede, l’orecchio sente, il muscolo freme, preso nell’émpito della mimesi ter-psicorea43. Oh! ma l’olfatto e il gusto e il tatto e il resto, perchè assisteranno negletti al tri-pudio dei favoriti?In un ulteriore stadio evolutivo del glorioso melodramma a questo vizio sarà fatto riparo.Per il tatto un bagno tepido ai piedi, con rubinetto di regolazione; a richiesta, un apparec-chio cinesiterapico44, giovevolissimo alla salute. Per l’olfatto, un odorino iniziale di cetriolisott’aceto darà la stura a una successione fantasmagorica di altri odorini. Essi verranno dalbasso: una batteria di potenti aspiratori li tirerà di cucina, un gioco di valvole li immetterànella sala secondo schemi sinfonici: esaleranno poi dall’alto, a lor comodo, in virtù dellanota legge fisica del tiraggio45.L’importante è che Melpomene ed Euterpe46 si sposino, l’importante è il connubio: anchese un po’ audace. Né rimangano inoperose Clio, Erato e Talìa47 e le altre della portentosa«équipe»: diano opera anzi ad un sùn48 formidabile e definitivo.Quanto allo scorticatore di Marsia49, l’attività di tutte le polizie letterarie europee lo ha co-stretto a rendersi irreperibile.Eppure il suo divino coltello potrebbe rendere ancora dei preziosi servigi.Ai diavoli melensi si mescolarono ben presto delle perfide, vermiglie creature, con ali di li-bellule assiro-babilonesi: esse diedero espressione geometrica a un vortice di piroette, le-vando altissime le gambe nervose, calzate da maglie rosa stinto.A quell’ora alcuni fra i maggiorenti de’ palchi, detti dai franceschi gagà50, dovevano sicura-mente impallidire. Il ritmo del balletto era tutto un ottonario tronco: ralla lilla trilla rì – ron-dinella pellegrin.I tuoni raddoppiarono di violenza: fumi sulfurei promanò la terra, mediante bòtole: e si le-vavano fino alle sandaline del cielo51.«Ecco Sardanapalo», mi disse Giuseppina, in preda a uno spiegabile orgasmo.Ma questo re corrottissimo stentava a giungere: e se ne intuì la ragione. Arrivava a cavallo:disfatto dall’angoscia e dal rimorso, perseguito dalla maledizione divina, madido di un su-dore diaccio52; ma il cavallo procedeva piano piano, come se avesse i piedi di cioccolato,tenuto da un bel valletto alla briglia. Di quest’ultimo si avevano ottime referenze: credulo-
40. lampade ad arco: particolari tipi dilampade, dette per esteso «ad arco voltai-co», nelle quali la luce scaturisce dall’arcoelettrico che scocca fra due elettrodi.41. gargarismi carbureggianti: l’espres-sione, di conio gaddiano, equivale a «scop-piettii come di un carburatore».42. il connubio delle arti: esplicito riferi-mento alla teoria estetica foscoliana svilup-pata nelle Grazie, che presuppone un’ar-monica cooperazione di tutte le arti (poesia,pittura, scultura, musica) al compito civiliz-zatore assolto nei confronti dell’umanità. Ilpendant musicale al connubio delle arti fo-scoliano è la teoria wagneriana del Wort-Ton-Drama («parola, suono, dramma», in te-desco), ossia di un’opera in musica ‘totale’,in grado di riunire tutte le forme d’arte (cele-
bre esempio ne è il Tristano e Isotta, 1859).43. émpito … terpsicorea: «impeto della mi-mesi artistica»; Tersicore (da cui deriva l’ag-gettivo terpsicorea) è la musa della danza.44. apparecchio cinesiterapico: apparec-chio per massaggi ed esercizi di ginnasticarieducativa; la cinesiterapia è una terapiache consiste nel far compiere a parti delcorpo movimenti specifici e ‘mirati’.45. legge … del tiraggio: noto principio fi-sico in base al quale l’aria calda tende ver-so l’alto (riscaldata, in questo caso, dallafolla scalmanata di spettatori e attori).46. Melpomene ed Euterpe: muse, rispetti-vamente, della tragedia e della lirica.47. Clio, Erato e Talìa: muse, rispettiva-mente, della storia, della poesia amorosa edella commedia.
48. sùn: traslitterazione dal greco sun,«con».49. scorticatore di Marsia: si tratta di Apollo,dio e patrono della poesia; secondo il mito, ilsileno Marsia osò sfidare il dio in una garamusicale, ma, sconfitto, fu legato a un alberoe scorticato (sul mito, oltre le fonti classiche, siveda anche Dante, Paradiso, I 19-21).50. detti … gagà: chiamati dai francesigagà, «elegantoni»; l’aggettivo franceschi,dal tardo latino francescus, è termine lette-rario e arcaico.51. fino … cielo: «fino alle nuvole»; la san-dalina è un’«imbarcazione leggera a formadi gondola, usata nelle regate»; qui il termi-ne è metafora che designa le nuvole cheviaggiano per il cielo.52. diaccio: «ghiacciato», arcaismo.
Carlo Emilio Gadda • La Madonna dei Filosofi
223
ne, fu però coinglutito53 nel vortice Sardanapalesco ed appariva angustiato non soltantodalla dannazione eterna, ma anche dalla piega che quel cavallo avrebbe potuto prendere.Il re, accasciato sulla sella come un fagotto, volontà spenta, levava a intervalli un’occhiataimplorante verso l’uomo in frack: «Adagio con le trombe, in nome de’ tuoi poveri morti!».Com’è vero che la sventura rende umili anche i più superbi e crudeli potentati!Ma chi tiene l’uomo in frack? Egli è valletto alla rèdina dell’alato ippogrifo.Tutto, per altro, andò nel migliore dei modi: quel quadrupede, dovevamo capirlo prima,non era pericoloso.Stavo pensando come il nostro spirito potrebbe evadere quel laberinto54 di cartone, di re me-sopotamici, di scudi di latta, di proterve lussureggianti regine, di maglie stinte, di notizie ten-denziose, di guerrieri antichi e valorosissimi, che accennava a distendersi nell’eternità.Provvide a ciò un angelo, inviato dall’Onnipotente. «L’angelo, l’angelo… eccolo, eccolo…»,mi fece Giuseppina.Il messo celeste arrivava, com’è logico, dal soffitto, ma lo ravvisai subito. Era Carlo, proprioCarlo, il garzone del nostro fornitore di latte, a cui feci jer l’altro una solenne lavata di ca-po, perchè va frescando e incidendo a graffito i muri della scala di servizio, con immaginiche turbano la modestia del personale.Il gancio al quale era appeso lo depositò al suolo fra il sollievo degli astanti. È un bel ra-gazzo. Come angelo è muto (mentre con Silvia parla diverse lingue): così non ci fu dato co-noscere nemmeno in questa rara e favorevolissima congiuntura le inflessioni della voce ce-lestiale, riflesso de’ mondi superni55.Le ali del cherubino hanno il difetto di rimaner prese costantemente in una strana rigidez-za, sia che egli fenda i diafani ed apertissimi cieli, sia che cammini le vie peccaminose edanguste di nostra terra: mentre è notorio che tutti i più provetti volatili le dispiegano du-rante il volo, per raccoglierle non oltre si pòsino56. Sono ali, queste di questo cherubinoCarlo, fisse: se le porta con sé come una valigia, anche quando vola appeso al gancio. Nonle sparnazza57 mai.Il vispo agnolotto58 ha comunque la virtù di far ricadere il telone sugli avvenimenti del se-condo episodio, cui, scoccando la mezzanotte, seguita il terzo.Non ne ho afferrato compiutamente lo spirito informatore poiché, durante la prima parte,mi accadde ciò che non mai altra volta, al conspetto di un capolavoro del genio umano: miappisolai!Tentarono le bombarde orchestrali di strapparmi al sopore in cui ero incorso. Gli ottantasono malvagi.Non gli riuscì a riscotermi se non verso l’una, col rinnovare tali scoppi concomitanti de’ lo-ro utènsili, che sembrava ne meditassero l’esplosione, presi in un’orgia di annientamento.Bisogna far calcolo che si tratta di diverse decine di diplomati, tutti nel vigore dell’età.Mi destai allucinato. L’ammiraglio agonizzava, disteso sur59 un tappeto, nel folto della sel-va paradisiaca: era quello di quel primo battibecco con la donna obesa. Si abbandonò perl’ennesima volta a delle gravissime affermazioni sul conto di costei, nel mentre una coster-nazione profonda si dipingeva nel volto di tutti gli astanti.La sua agonia si protrasse quarantaquattro minuti, ricordo come fosse stamane, durante iquali gli venne fatto di declamare altri centododici endecasillabi e trentatre quinarî, di cui
53. coinglutito: «inghiottito», neologismogaddiano.54. evadere … laberinto: «fuggire da quel-l’intrico»; il verbo compare qui usato transiti-vamente su influsso del linguaggio burocra-tico (per esempio, evadere una pratica).55. superni: latinismo per «superiori, deicieli».
56. non oltre si pòsino: «non appena toc-cano il suolo»; si osservi la struttura latineg-giante dell’intero periodo, bipartito dallascansione sia … sia … (su modello del lati-no sive … sive …).57. sparnazza: «dispiega»; il verbo è in li-nea con il ritratto caricaturale e marcatamen-te ironico del cherubino e con l’abbassarsi
del registro stilistico che lo caratterizza; spar-nazzare è detto, propriamente, dei polli cherazzolano sparpagliando il becchime.58. agnolotto: «angioletto», con deforma-zione caricaturale e parodica.59. sur: «su» (la -r eufonica veniva antica-mente usata davanti a parole che iniziava-no per vocale).
224
IL SECONDO NOVECENTODal dopoguerra a oggi
Autori
altri ripetuti due volte, altri fugati, altri sillabati in ripresa, altri mormorati a recitativo. L’in-digesto pomo di Cafìr aveva sortito evidentemente l’effetto previsto e consegnava il tragi-co spirito dell’ammiraglio a quella baritonale agonìa.La sua fibra eccezionalmente robusta ci consentì tuttavia di venire a integrale conoscenzadelle di lui disposizioni testamentarie, avanti che il sudario della notte avesse a distendersisulle pupille ancor fervide del lampo di tante battaglie, e avesse a privarci di un solo emi-stichio.Nessuno era preparato a una simile sciagura. La morte di tanto Uomo è una perdita irrepa-rabile per l’umanità tutta. Un’angoscia ci prende al pensiero che domattina il commercio deipneumatici, dei medicinali, dei latticini, dei tessuti, dei materiali da costruzione riprenderàpuntualmente alle otto e mezza: alle dieci nuovamente avran quotazione i saccariferi, i mi-nerarî, i meccanici, i metallurgici, gli immobiliari, gli elettrici, i tessili: ed Egli ora si spegnefra inenarrabili difficoltà! Dissapori coniugali, imbarazzi finanziari, complicazioni dinasti-che, infedeltà di luogotenenti, trono vacillante, Giocasta e Maria Teresa alle soglie deltrionfo; tormentosi dubbî della grande anima, cambiali false, ingratitudine del capo conta-bile!O virtù! non sei che un vano nome60!C’è poi da aggiungere, cosa non improbabile, che l’astio di Sardanapalo gli avrà arrecatosciagura, perchè corre voce che costui, specie da defunto, induca gramo.Con la dipartita dell’anima eletta ebbero fine tutti i suoni le luci ed i suffumigi di quella not-te memoranda61.I signori e gli psicopompi62, un cartoncino alla mano, si accalcarono e gomitarono63 comeplebei per riavere la pelliccia al più presto.Il generale dei pompieri (che ha un elmo con un pennacchio speciale) ragunò64 i suoi ottoe, arringàtili, tutti insieme si avviarono per andare a nanna; in ciò imitati da un inappunta-bile drappello di carabinieri bergamaschi. Fortunatamente non si era avvertito, in tutta lameravigliosa serata, il benchè minimo odore di bruciaticcio.
60. O virtù … nome: l’esclamazione è untopos diffuso, che si ritrova, nella letteratu-ra italiana, in più luoghi e in più autori, daVincenzo Monti (Ahi nome vano, virtù;Caio Gracco, III 3) a Leopardi (Stolta virtù;Bruto minore, v.16). La formulazione rie-cheggia certe apostrofi dantesche, come,per esempio: Purgatorio, XI 91-100: O vana
gloria de l’umane posse! […] Non è il mon-dan romore altro che un fiato / di vento,ch’or vien quinci e or vien quindi, / e mutanome perchè muta lato…61. memoranda: «memorabile, da ricor-dare», latinismo (si tratta propriamente delgerundivo latino).62. psicopompi: nell’antica Grecia erano
le divinità deputate ad accompagnare leanime dei morti nell’oltretomba (psico-pompo per eccellenza è il dio Ermes, oMercurio).63. gomitarono: «si sgomitarono, si diede-ro gomitate»; il verbo compare in CarloDossi.64. ragunò: «radunò, riunì», arcaismo.
Carlo Emilio Gadda • La Madonna dei Filosofi
225
Analisi del testo
UNA NARRAZIONE ‘STRANIATA’
La prima prova narrativa gaddiana non è una nar-razione, ma una descrizione, condotta – secondo laterminologia istituita da Gadda nel Racconto italia-no – ab interiore. Il narratore, che è anche spettato-re, racconta in prima persona uno spettacolo dimelodramma a cui ha assistito al Teatro Ponchielli.L’effetto straniante del racconto è dovuto al parti-colare punto di vista adottato: il narratore, infatti,sembra non scindere tra realtà e finzione, descrivegli eventi come se fossero reali e non appartenes-sero invece a una rappresentazione teatrale. Inoltreegli non ha maggiori informazioni del lettore (co-me di regola accade per un evento a cui chi rac-conta ha assistito direttamente), ma ne sa quantolui, e gli comunica via via maggiori informazioni.L’effetto prodotto da tale straniamento è di straordi-naria comicità e di diretta partecipazione del letto-re, partecipazione accresciuta dalla coincidenzatra tempo del racconto e tempo dell’evento rac-contato. L’unico salto temporale è infatti costituitodal momento in cui egli si addormenta.
LA STRUTTURA DEL RACCONTO
Il racconto può essere agevolmente suddiviso neitre atti del melodramma: tra il primo e il secondo viè un breve intervallo, che istituisce una pausa de-bole, mentre tra il terzo e il quarto si trova una ce-sura forte costituita dal sonno del narratore. Analiz-zeremo pertanto tale tripartizione.
IL PRIMO ‘ATTO’
La situazione del narratore-spettatore rimanda aun’implicita posizione di inferiorità gnoseologicarispetto alla vicenda narrata (Rimasi al buio), checomunica pertanto una comprensibile insicurezzainiziale (Non vidi più Giuseppina, né i Biassonni, néi Pizzigoni, né il grand’ufficiale Pesciatelli). Il pubbli-co, infatti, è portatore di una visione del mondo di-storta, non conosce che la finzione della realtà,mentre la vera conoscenza è di colui che la sma-schera (lo svelamento della macchina scenica
sarà una costante del brano che si conclude, non acaso, sull’immagine dei pompieri). Il tono delladescrizione è iperbolico e perciò dissacrante:Gadda mette in campo tutti i suoi artifici lessicali eretorici per smascherare le vane parvenze delmelodramma, e le sue contraddizioni (improbabi-lità storica, dissennatezza rappresentativa, ecces-so di sentimentalismo…). Non a caso, alla repenti-na interruzione della finzione teatrale (A un tratto,il buio cessò anche per me) corrisponde un rapidomutamento di registro, dal grottesco ironico al su-blime, assolutamente serio, ben esemplificato dal-l’iperbato che introduce, con la citazione francese,un’immagine fortemente rilevata (dicendo alto l’e-logio di dolcissime curve o della «maigreur élégan-te de l’épaule, au contour heurté». Alcune, comeuna goccia di sangue, avevano un rubino sulla bian-chissima gola). Ma la finzione dura poco e cedeimmediatamente a un tono aulico dalla funzionedecisamente antifrastica (ora il genio del melo-dramma disseta le loro anime con la linfa dellaeterna bellezza).
IL SECONDO ‘ATTO’
La descrizione del secondo atto è caratterizzata daun effetto di climax ascendente che culmina nel con-nubio delle arti di Foscolo (uno degli obiettivi pole-mici del brano, secondo la lettera di Gadda a Caroc-ci) e nell’apparizione dell’angelo. La dissacrazione èperò garantita dallo smascheramento dell’artificioscenico (l’Angelo è il garzone del lattaio).
IL TERZO ‘ATTO’
Il passaggio tra il secondo atto e il terzo è risoltovelocemente (Il vispo agnolotto ha comunque lavirtù di far ricadere il telone sugli avvenimenti delsecondo episodio, cui, scoccando la mezzanotte, se-guita il terzo) e un forte salto temporale è costituitodal sonno del narratore che annulla la corrispon-denza tra eventi accaduti ed eventi narrati. Il bru-sco risveglio (Mi destai allucinato) introduce gli ul-timi eventi descritti nelle forme dell’allucinazione econ i toni tragici che le sono propri (agonizzava,
226
IL SECONDO NOVECENTODal dopoguerra a oggi
Autori
gravissime affermazioni, costernazione profonda,agonia, simile sciagura, perdita irreparabile). L’ef-fetto ironico è ottenuto dilatando eccezionalmentela figura retorica dell’antifrasi fino alla catarsi finalecostituita dall’esclamazione di ricordo dantesco(anch’essa, naturalmente, antifrastica): O virtù! nonsei che un vano nome!
LINGUA E STILE
Se consideriamo il racconto alla luce dei cinque stiliche Gadda nel Racconto italiano di Ignoto del Nove-cento ( 209) dichiara di avere a disposizione, vi ri-troviamo la maniera «logico-razionalistica» che sipropone di lasciare l’ironia ai fatti e quella «cretina»,falsamente ingenua, come di uno spettatore sprov-veduto che, capitato per caso nel loggione di un tea-tro d’opera, non capisce (o finge di non capire) cosasta accadendo. Si noti però come possano rintrac-ciarvisi anche brevi saggi della maniera enfatica,tragica, «meravigliosa 600», simbolistica, utile a «épa-ter le bourgeois» [«far colpo sulla gente»]» (si veda-no ad esempio due splendidi casi di costruzionemetonimica: avanti che il sudario della notte avesse adistendersi sulle pupille ancor fervide del lampo ditante battaglie), utilizzata però sempre a contrastocon un brusco abbassamento stilistico (e avesse aprivarci di un solo emistichio).
Agli stilemi tipici della prosa gaddiana ( 227) sene aggiunge qui un altro, che si rivela particolar-mente attivo e che chiameremo di «divaricazionestilistica».Esso consiste nell’uso di un lessico aulico(spesso prelevato dalla tradizione dannunziana ecarducciana) per descrivere una realtà bassa eumile e viceversa di un lessico basso e popolareper un oggetto nobile, con effetto di demistificazio-ne e dissacrazione. Si consideri ad esempio: Dodi-ci lunghi pennacchi, rigidi ed aperti a ventaglio,cor-roboravano di un’aureola tacchinesca il santuariodella pettinatura. Tale procedimento si verifica fre-quentemente in concomitanza con l’uso antifrasti-co della similitudine (scimitarra argentata dal tintin-no metallico come di posateria presso l’acquaio).Particolare attenzione, inoltre, merita la sintassigaddiana, spesso più ritmica che grammaticale,qui chiaramente esemplificata nell’uso asintatticodell’interpunzione, che ha invece la funzione diistituire una pausa nel discorso (Vestiva lo sma-gliante costume dell’ammiraglio persiano […]: ave-va vinto Sardanapalo e i suoi temibili congiunti, ca-so in cui, ad esempio, i due punti non hanno scopodi esemplificazione, ma di interruzione del ritmonarrativo). La pausa può anche essere iterata, co-me in I tuoni raddoppiarono di violenza: fumi sulfu-rei promanò la terra, mediante bòtole: e si levavanofino alle sandaline del cielo.
Proposte operative
Analizza nel racconto le diverse componenti liguistiche e stilistiche, individuando e catalogando aulicismi,dialettalismi, forestierismi, neologismi e tecnicismi. Quale componente ti sembra prevalere sulle altre? E a quale ti sembra che Gadda affidi la propria ‘dissacrante’ parodia?
Secondo una lettera di Gadda al direttore di «Solaria» Carocci, uno degli obiettivi polemici del brano è UgoFoscolo. Sapresti rintracciare i luoghi dove più evidente appare questa volontà dissacratoria?
Prova a identificare nel racconto i luoghi della cosiddetta «divaricazione stilistica», di quel procedimento,cioè, basato sul comico accostamento di contesti e registri linguistico-stilistici dissonanti, in contrasto tra loro.Commentali analizzando, di volta in volta, lessico, sintassi e stile.
Lo stato psicologico con il quale l’autore affronta l’opera rappresentata è velato dall’uso costante dell’ironia,del sarcasmo, di mezzi che distraggono l’attenzione del lettore. Prova, superando questi ostacoli gaddiani,a delineare un ritratto interiore dello ‘spettatore’ Gadda.
4
3
2
1
Carlo Emilio Gadda • La Madonna dei Filosofi
227
Strumenti
Lingua e stile: gli ingredienti del pastiche gaddiano
La matrice filosofica che, in Gadda, ha il problema linguistico, conferisce uno spessore di ne-cessità etica al suo plurilinguismo e al suo espressionismo. Esiste infatti una correlazione strettatra espressione e azione:
Si potrebbe scrivere, di molti casi dei secoli, una storia sui generis, riferendo i fatti alle modalità espressivedell’epoca dove occorsero: e si vedrebbe come la stortura, cioè la inutilità prava, del fatto, accompagna as-sai volte la stortura dell’espressione: o almeno è aggravata, dilatata, prolungata, catastrofizzata da quella.
Per Gadda il vaniloquio genera errore, e adottare la lingua comune per la rappresentazione del-la realtà è un atto immorale. Le motivazioni alla base delle scelte linguistiche gaddiane sono rias-sunte in un saggio, pubblicato nel 1942 su «La Ruota», dal titolo Lingua letteraria e lingua del-l’uso. Ne riportiamo alcuni estratti:
la lingua dell’uso piccolo-borghese, puntuale, miseramente apodittica, stenta, scolorata, tetra, eguale, come pic-cioletto grembiule casalingo da rigovernare le stoviglie, va bene, concedo, è lei pure una lingua: un «modo» del-l’essere. Ma non può diventare la legge, l’unica legge. La mia penna è al servizio della mia anima, e non è fan-te o domestica alla signora Cesira e al signor Zebedia, che vogliono suggere dal loro breviario «la lingua dell’u-so», del loro uso di pitta-unghie o di fabbricanti di bretelle.
Si tratta ora di vedere quali ‘tasselli’, quali apporti linguistici lo scrittore può introdurre nella suaprosa. Ascoltiamo ancora Gadda:
il diritto di alcuni modi più ricchi o più vigorosi de’ dialetti stessi […] a entrare nell’elenco dei padri e co-scritti. Dò palla bianca ai meteci [«gli stranieri»] e inserisco in una mia prosa il ligure galuppare (per scirop-pare, francese bouffer) e il romanesco gargarozzo. Giungo perfino a fare qualche scandalosa concessionealle due grandi lingue sorelle, francese e spagnolo.
Tra gli ingredienti del lessico, avranno un posto prioritario i dialettalismi e i forestierismi, ma an-che i termini della lingua letteraria, soprattutto poetica, usati però in modo spastico (sottoposti,cioè, a ‘torsioni’ e forzature espressive; ad esempio, con valore parodico). È inoltre auspicato l’u-so delle varie gradazioni di colore, toni specifici, toni preferenziali nella scelta istintiva del vo-cabolo, nella pratica del linguaggio: termini popolari, quindi, termini gergali e tutti i linguaggispeciali, in primo luogo quelli tecnici, come è naturale che sia per uno scrittore-ingegnere; le lin-gue tecniche, infatti,
avvezzano lo scrivente a una particolare disciplina della notazione (giure, scienze fisiche, scienze mediche,storiografia ecc.) e immettono nel gran fiume della lingua da un lato il frasario gergale de’ pratici […] dal-l’altro il frasario di lontana o rinnovata discendenza illustre.
Speculare, rispetto alla varietà degli ingredienti del pastiche, è la gamma degli stilemi della pro-sa gaddiana. Gian Carlo Roscioni li ha analizzati in uno studio su Gadda per molti aspetti anco-ra insuperato (La disarmonia prestabilita, Torino 1969, 19953); ne riassumiamo qui i punti prin-cipali (riportando tra virgolette le citazioni puntuali). Alla base delle scelte stilistiche ed espressive gaddiane Roscioni individua una motivazione diordine filosofico: se il reale ha innumerevoli significati, nominare gli oggetti di cui esso si com-pone significa collegarli e riferirli ad altri oggetti; di qui il ricorso alla figura della metonimia,che risponde a un’esigenza di approfondimento conoscitivo. Nominare un oggetto, quindi,equivale a evocare una o più sue modalità; al di fuori di esse, l’oggetto stesso non ha alcunarealtà. «Quanto più informe e aggrovigliata si presenta, poi, la materia che costituisce l’oggetto
228
IL SECONDO NOVECENTODal dopoguerra a oggi
Autori
Strumenti
della rappresentazione, tanto più è necessario individuarne il principio organizzativo, esprimer-la in grandezze misurabili»: di qui la geometrizzazione del reale (i cubi delle case e delle ville pa-revano bianchi e chiari (L’Adalgisa); dirò la sua [del porco] cupida e sensual fame con le vènto-le balbe degli orecchi e immane gaudio di tutto il cilindro del corpo (Il castello di Udine).Più numerose e complesse sono le relazioni tra le cose, più è necessario il ricorso a figure gram-maticali e retoriche che fungano da principi organizzativi. Molto frequente è l’uso dello stilemaastratto, cioè di un sostantivo astratto seguito da un complemento di specificazione, in luogo delcorrispondente aggettivo qualificativo: La chiarità dell’estate [al posto di La chiara estate] si in-farinava di bianche miglia (Gli anni); l’orrore giallo e feroce delle cose furibonde (Il castello diUdine); oppure l’uso di un verbo sostantivato: il serpere e il poligonare degli ori (Quer pastic-ciaccio brutto de via Merulana), talora con un surplus d’invenzione linguistica: la panciatica eorologiatica autorità del tutore di codesto seno [per: «il consorte di un’avvenente signora, fornitodi panciotto e di orologio da taschino] (Quer pasticciaccio brutto de via Merulana). La costruzione astratta ha la funzione di portare in primo piano le proprietà intrinseche e le qua-lità delle cose e di sottolineare che è proprio grazie a queste proprietà che le cose stesse vengo-no percepite: «È solo trasferendo alla modalità, che per sua natura è temporanea e mutevole, lacarica semantica sostanziale dei nomi, che si può catturare l’attimo della rivelazione e rappre-sentarlo nell’espressione».Altro stilema prediletto da Gadda è il catalogo; il desiderio di dare ordine al mondo ha come na-turale conseguenza la sua catalogazione, la riduzione del caos e dell’informe alla forma. Tale de-siderio si svuota e si vanifica, però, nell’impossibilità di una catalogazione esaustiva, e per il fat-to che il nuovo ordine è soggetto esso stesso a confusione e sovrapposizione di nuovi criteri or-dinatori. Costante, ad esempio, è la tendenza a organizzare i dati dell’esperienza in serie causa-li (ma di cause al plurale, beninteso, non di causa!), per evitare la giustapposizione asindetica enon ‘gerarchizzata’, priva di motivazione intrinseca. La decostruzione del reale, e l’elencazionedi tutte le sue componenti, è funzionale a una riorganizzazione del reale stesso in una nuova emotivata storia interna. E sarà proprio la constatazione del fallimento di questa riorganizzazionea portare Gadda ad accettare il pasticcio, il non finito. Un mirabile esempio di catalogo è costi-tuito dalla descrizione dei gioielli ritrovati nel laboratorio della Zamira (Quer pasticciaccio brut-to de via Merulana):
dal disciolto sàcculo, rovesciato a sua volta con ogni garbo […] smottaron giù quasi confortandosi a vicen-da nella inaspettata uscita e caduta pallette verdi, medagliette, spille e corniole, gingilli d’oro, catenine, cro-cine, collanine a filigrana impigliate le une nelle altre, e anelli e coralli: anelli insigniti di perle rare, o splen-denti d’una gemma, o talora di due di color distinto avanti alla bocca aperta del Cocullo, al batticuore delbrigadiere […].
Morris Graves, Volo di uccelli, particolare, 1955, olio su tela, New York, Whitney Museum.
Carlo Emilio Gadda • La cognizione del dolore
229
La cognizione del dolore
La storia editoriale. La cognizione del dolore esce insette puntate sulla rivista «Letteratura» (fondata daAlessandro Bonsanti dopo la chiusura di «Solaria»),dal luglio-settembre 1938 al gennaio-marzo 1941,interrompendosi al settimo tratto (‘capitolo’, secon-do la dizione gaddiana). Nel 1943 due tratti vengo-no inclusi nell’Adalgisa e corredati di note, mentrenel 1953 un altro (La madre) entra nelle Novelle dalDucato in fiamme. L’edizione in volume vienepubblicata nel 1963, con la collaborazione di GianCarlo Roscioni. Anche quest’edizione lascia la con-clusione aperta a diverse soluzioni (e così sarà an-che per la ristampa del 1971, che pure aggiunge al-tri due tratti inediti). Introduce il volume un fonda-mentale saggio di Gianfranco Contini, e lo accom-pagna una nota d’autore – dal titolo L’Editore chie-de venia del recupero chiamando in causa l’Auto-re – che costituisce la più compiuta autoesegesidella Cognizione.Con la Cognizione Gadda dà risonanze universali auna materia esplicitamente autobiografica e realiz-za quell’operazione di sceverazione del bene dalmale in cui ritiene debba consistere il principio mo-rale. Se l’effetto di tale cernita è l’irrisione, la defor-mazione barocca della realtà, la colpa non è ascri-vibile all’autore, ma al mondo stesso: il barocco e ilgrottesco albergano già nelle cose, nelle singole tro-vate di una fenomenologia a noi esterna; essi sonoquindi legati alla natura e alla storia.
Brianza e Sudamerica: la trama. L’ambientazione,tuttavia, non persegue il canone naturalistico chela nota gaddiana sembrerebbe tendenziosamentesuggerire. La storia è infatti ambientata negli annitra il 1925 e il 1933 in un Paese sudamericano – sulquale si riverberano molte caratteristiche dellaBrianza, familiare a Gadda – dal nome fantastico:Maradagàl, appena uscito dalla guerra con il vicinoParapagàl e governato dal Regime del dio-vulcanoAkatapulqui (trasparente allusione a Mussolini).Manifestazione tangibile del nuovo ordine politicosono i Nistitúos de vigilancia para la noche, uncorpo di vigilanza che – con atti di intimidazione edi violenza – garantisce protezione alle ville dellacampagna brianzola-maradagalese. Fra queste vil-le c’è quella di proprietà del protagonista, donGonzalo Pirobutirro d’Eltino, e dell’anziana madre,emblematicamente chiamata la Signora. La fanta-
stica geografia locale, di suggestione manzoniana(si pensi al Serruchon/Resegone: una lunga ertamontana tutta triangoli e punte, quasi la groppa-minaccia del dinosauro: «lunga erta montana» èespressione manzoniana), contempla nomi curiosie «trasparenti» come Lukones (Longone al Segrino),il paese più vicino alla villa, Novokomi (Como), ElPrado (Erba) e la città di Pastrufazio (Milano).Il protagonista è un chiaro alter ego dell’autore; lesue vicende biografiche si modellano infatti sullevicissitudini professionali e umane di Gadda, dallaguerra agli studi ‘ingegnereschi’, dalle idiosincra-sie e i furibondi accessi d’ira al rapporto esclusivoe complesso con la madre. La Signora è rappre-sentata nel romanzo in tutta la sua fragilità (mentrela madre di Gadda – scomparsa nel 1936 – era unadonna energica, dai tratti forti e duri), oppressa dalterrore del mondo, protesa filantropicamente ver-so i contadini che ruotano intorno alla villa e chebeneficiano senza misura della sua generosità, ecompresa ossessivamente nella custodia del pro-prio dolore: anche lei, come Adele Lehr, ha persoun figlio in guerra e non se ne dà pace.La narrazione ha un centro di forza nella chiamatadel medico del villaggio a villa Pirobutirro, per unavisita di controllo, durante la quale compaionodue personaggi minori: il figlio del colonnello me-dico cui la Signora dà lezioni di francese e il Man-ganones (un nome parlante che evoca lo strumen-to principale della violenza delle squadre fasciste),uno degli esponenti del Nistitúo, deciso a conclu-dere il contratto precedentemente stipulato con lamadre. Il deciso rifiuto di Gonzalo viene accoltocome un atto di sfida e anticipa future ipotesi divendetta da parte dei «tutori dell’ordine».La seconda parte del romanzo è interamente occu-pata dal rapporto, difficile e complesso, tra Gonza-lo e la madre e crea i presupposti della tragedia fi-nale. Quando, un giorno, Gonzalo lascia la villaper recarsi a Pastrufazio, la madre, rimasta sola epriva di protezione (Gonzalo ha infatti licenziato ilfattore), viene aggredita e uccisa.L’aggressione non avrà testimoni e il romanzo sichiude su una serie di indizi che muovono in dire-zione degli esponenti del Nistitúo, ma che tuttavianon riescono a scagionare completamente il figliodalla terribile accusa di matricidio. Un tema che,affiorato negli anni giovanili di Dejanira Classis,sembra accompagnare Gadda fino alle prove dellamaturità (il delitto di via Merulana, come vedremo,potrà essere anch’esso spiegato come un indirettomatricidio).
Amletismo e donchisciottismo. A proposito della fi-gura del protagonista, la critica ha spesso parlato diamletismo e di donchisciottismo. Il personaggiodella Cognizione incarnerebbe infatti il dramma diAmleto – anche se il suo «non essere» è piuttosto un«essere come tutti», un agire seguendo i bisogni del-la massa e non quelli dell’individuo – e l’idealismodell’eroe di Cervantes, proteso com’è alla ricerca diuna verità ideale che si contrapponga alla realtà,gretta e meschina (al mondo com’è, governato dafalsi obiettivi di salute fisica e di pace fisica). Daquesta contrapposizione, netta e disillusa, tra mon-do ideale e mondo reale, deriva una posizione ra-dicale, lontana da ogni forma di compromesso, eche si traduce nelle forme della satira; una satira in-diretta, che ha come obiettivo ‘nascosto’ e primarioil fascismo, inteso come versione aggiornata e di-rettamente vissuta dello svuotamento e corrompi-mento degli antichi valori. Molti sono i simboli‘mascherati’ della retorica fascista, primo tra tutti ilNistitúo di vigilancia para la noche, emblema dellesoperchierie di un regime che cela dietro garanziedi ordine sociale un reale intento liberticida.Se, nei testi precedenti, la diversità dell’autore ri-spetto al mondo circostante trovava un parziale ri-scatto (la guerra come momento supremo di provaindividuale, la fattività della vecchia classe borghe-se portatrice di buoni valori traditi dalla nuova clas-se), nella Cognizione si assiste a una radicalizzazio-ne delle posizioni di isolamento dell’individuo, chefinisce per rinchiudersi in un’asocialità e misantro-pia totalizzanti. Solitudine e silenzio dominano lavita del protagonista, senza possibilità di riscattoche non sia la remunerazione della scrittura, an-ch’essa tuttavia in bilico tra autobiografia e travesti-mento letterario (lo stesso scenario sudamericanovale come mascheramento protettivo dell’autore).
La lettura di Contini:nasce la «funzione Gadda».Ta-le precario equilibio verrà riconosciuto dalla criticapiù attenta, e precisamente scoppierà come unabomba contro lo schivo ingegnere, nell’Introdu-zione scritta da Gianfranco Contini per l’edizione involume della Cognizione, pubblicata da Einaudinel 1963. Contini riconosce subito la sostanza psi-canalitica del romanzo gaddiano e lo accosta op-portunamente alla Recherche proustiana, offrendoal testo inedite risonanze. Lo ‘svelamento’ provo-cherà l’immediata reazione di Gadda (Il tuo saggio[…] per ‘gli altri’ specie miei familiari viventi, e abi-tanti di Lukones, riescirebbe esplosivo, e tragica-mente atto a spezzare il cuore), che chiede all’ami-
co di eliminare qualche vocabolo troppo esplicito echiarificatore. L’accorata preghiera ci dà la misuradi come la Cognizione avesse rappresentato per loscrittore un tentativo di chiusura dei conti con il nu-cleo oscuro della propria «disarmonia prestabilita»con il mondo e anche con se stesso.L’Introduzione di Contini sviluppa inoltre una fe-conda intuizione già delineata nella recensione alCastello di Udine, e sancisce definitivamente la na-scita della «funzione Gadda». La prosa gaddianadella Cognizione viene vista infatti come il puntod’arrivo di un percorso letterario che attraversa i se-coli accomunando diversi atteggiamenti linguisticiche tradiscono tutti una stessa visione, ‘deformata’,del mondo, un atteggiamento ‘non pacifico’ neiconfronti della realtà e che si è caratterizzato per laforzatura delle forme di espressione. Questo ‘filorosso’ – che si connota per un acceso plurilingui-smo che mescola la lingua letteraria a quella quoti-diana, il latino ai dialetti, le forme dotte alle popo-lari – va dai «macaronici» del Cinquecento – comeTeofilo Folengo e il francese François Rabelais – aCarlo Porta, alla Scapigliatura piemontese e a CarloDossi, per approdare infine a Gadda, accomunatoda Contini a Joyce e al francese Cèline.
Nuovi ingredienti del pastiche gaddiano. L’ambien-tazione sudamericano-brianzola (nella quale river-bera l’esperienza del soggiorno in Argentina del1924-26) aggiunge al pastiche gaddiano una patinalinguistica di «spolveratura creola» (Contini) e dia-lettale, non solo nella divertente (e trasparente)geografia locale, ma anche in numerose espressio-ni e locuzioni. Il plurilinguismo gaddiano giungequi a una maturità piena e ricca di nuovi succhi,dallo spagnolo (locupletò di pesos papel tutti i nego-zianti di vetri dell’arrondimiento) al dialetto duro eimpietoso dei calibani gutturaloidi (La cadenza diquel discorso era ossìtona, dacché distaccato e ap-peso, nel dialetto del Serruchón, suonano destaca-giò e takasü); non mancano poi i già sperimentatiaulicismi con funzione parodica (Talora avevanodiademi di gemme sopra i capegli, le femmine: e imariti dei collari con un pendaglio di latta; Dallaparete di fronte […] da una cornice di noce, laguardata corusca del generale Pastrufacio, in da-gherrotipo), i tecnicismi (ma il tentennamentoostacolato dal gozzo, le riuscì con elongazione ri-dotta), i termini derivati da linguaggi settoriali, co-me quelli filosofici o medici (il crepitìo della terrapareva consustanziale alla luce; quella esibizioneolfìmica di valerianati, formiati e capriliti).
230
IL SECONDO NOVECENTODal dopoguerra a oggi
Autori
Carlo Emilio Gadda • La cognizione del dolore
231
Fulmini e parafulminida La cognizione del dolore, I I
Il brano è incentrato sulla deformazione satirico-grottesca dell’ambien-te che circonda il protagonista, un ambiente che ricorda da vicino quel-lo meneghino, già colpito dagli strali del Robespierre della borghesia mi-lanese. Qui, in particolare, oggetto del risentimento gaddiano sono l’ir-razionalismo ornamentale delle ville brianzole e gli scempi prodotti dal«funzionalismo» (lo stile architettonico, anche altrove preso di mira, re-cepito da Gadda come una vera e propria violenza naturale. Violenzatanto più grave, in quanto snatura un paesaggio che reca memoria del-l’illustre – e carissima a Gadda – ambientazione manzoniana).Dalla divertente invettiva iniziale contro le ville in Brianza – tutta co-struita secondo l’artificio retorico del catalogo e in chiave parodica(dallo stile delle agenzie immobiliari a quello degli architetti pastrufa-ziani) – l’autore passa a descrivere tre di queste ville: Maria Giuseppina,Enrichetta e Antonietta. I nomi evocano una cornice ottocentesca, chevede mescolarsi echi manzoniani (Enrichetta Blondel) e napoleonici(Giuseppina Beauharnais). Nell’ultima parte del brano la deformazio-ne caricaturale spetta a un altro monumento letterario molto amato emolto odiato da Gadda. Dietro il vate Carlos Caçoncellos, il grande epi-co maragadalese, aedo della Reconquista e della battaglia di Santa Rosa,si cela infatti una diretta parodia dannunziana; e la villa Giuseppina,divenuta sacrario del poeta, altro non è che la villa del Vittoriale di Gar-done: la principesca dimora dell’ immaginifico dal 1920 fino alla morte(1938), poi divenuta monumento nazionale.Al testo del racconto si aggiungono qui – in corsivo – le note d’autore chefiguravano nella prima edizione del brano in volume (L’Adalgisa,1944), poi eliminate nell’edizione del 1963; esse danno conto, infatti, diuna caratteristica fondamentale della prosa gaddiana, l’autoglossa;una pratica metanarrativa che lo avvicina ai grandi «macaronici» delpassato, come Teofilo Folengo. Le note gaddiane spaziano dall’osserva-zione erudita all’informazione storica o di costume; il loro stile è benlungi dall’essere quello piano e referenziale che compete alle note, matalora si complica in preziosismi lessicali e stilistici che necessitano, a lo-ro volta, di glosse esplicative.
Di ville, di ville!; di villette otto locali doppi servissi1; di principesche vil-le locali quaranta ampio terrazzo sui laghi veduta panoramica del Serru-chón2 – orto, frutteto, garage, portineria, tennis, acqua potabile, vascapozzonero oltre settecento ettolitri: – esposte mezzogiorno, o ponente,o levante, o levante-mezzogiorno, o mezzogiorno-ponente, protetted’olmi o d’antique ombre dei faggi avverso il tramontano e il pampero3,ma non dai monsoni delle ipoteche4, che spirano a tutt’andare anchesull’anfiteatro morenico5 del Serruchón e lungo le pioppaie del Prado6;di ville! di villule!, di villoni ripieni, di villette isolate, di ville doppie, dicase villerecce, di ville rustiche, di rustici delle ville7, gli architetti pa-strufaziani8 avevano ingioiellato, poco a poco un po’ tutti, i vaghissimi eplacidi colli9 delle pendici preandine, che, manco a dirlo, «digradanodolcemente10»: alle miti bacinelle dei loro laghi. Quale per commissioned’un fabbricante di selle di motociclette arricchito, quale d’un bozzolie-
1. «Villette otto locali doppi servissi; ecc.»:È uno standard della grafia pubblicitaria,ne’ cosiddetti «annunci economici» de’giornali. Servissi è pronuncia lomb. perservizi: (1943 et ultra). «Esposte mezzogior-no, ecc.»: Catullo, Carmina, 26: «… villulanostra non ad Austri flatus oppositast ne-que ad Favoni, ecc… verum ad milia quin-decim et ducentos»: (di ipoteche). «O ven-tum horribilem atque pestilentem!». [N.d.A.]Riportiamo il passo nella traduzione diGuido Ceronetti: Sulla nostra casina dicampagna / Non soffia l’Austro, Furio, nè ilFavonio, / Né il Boreale né l’Orientale: / Daquindicimila sesterzi d’ipoteca / è soffiata.Questo è un vento che non perdona.2. Serruchón: il Resegone di manzoniana
memoria (monte delle Prealpi lombarde, anord-est di Milano).3. pampero: «vento delle Pampas» (nota
gaddiana a un altro passo del romanzo).4. monsoni delle ipoteche: al riferimento
catulliano citato alla nota 1, va ad aggiun-gersi una precisa circostanza autobiografi-ca: dopo la morte della madre di Gadda, lasorella Emilia aveva proposto di ipotecarela casa di Longone; nel 1937 la casa vennedefinitivamente ceduta.5. anfiteatro morenico: standard della ti-
pologia corografica e orodescrittiva. [N.d.A.]Le «morene» sono accumuli di materiali de-positati dai ghiacciai; negli «anfiteatri more-nici» questi materiali si dispongono davantialla fronte del ghiacciaio.6. Prado: la località corrisponde al piano
di Erba (in provincia di Como), dove sorge-vano diverse ville.7. di ville … delle ville: nello sfrenato gioco
combinatorio del catalogo (con struttura bi-naria: villette isolate/doppie, o a chiasmo:ville rustiche/rustici delle ville) viene ripetu-to più volte il complemento di strumentodell’attacco del brano (Di ville, di ville!).8. pastrufaziani: «abitanti di Pastrufazio»
(o alla spagnola Pastrufacio), cioè – nellacorrispondenza Sudamerica-Brianza – diMilano; l’aggettivo deriva da una comicacommistione tra latino e dialetto: pastrügnfacere, «fare pasticci». Si costruisca così ilsuccessivo periodo così: «Gli architetti pa-strufaziani avevano ingioiellato i vaghissi-mi e placidi colli delle pendici preandine diville, di ville…».9. vaghissimi … colli: eco pariniana da
La vita rustica, vv.33-36: Colli beati e placi-di / che il vago Eupili mio / cingete con dol-cissimo / insensibil pendio.10. «digradano dolcemente»: l’espressione,in sé scontata (manco a dirlo), ricorda ilquadro iniziale dei Promessi Sposi: in luci-do serpeggiamento pur tra’ monti che l’ac-compagnano, degradando via via, e per-dendosi quasi anch’essi nell’orizzonte.
11. bozzoliere fallito: «allevatore di bachida seta»; evidente allusione al padre diGadda, che aveva infruttuosamente tentatodi impiantare in Brianza un allevamento –su scala industriale – del baco da seta.12. nella terra … per aria: nella Brianza,dove la vecchia attività serica è in crisi (inalto mare) e le nuove industrie hanno basiassai poco solide (campate per aria).13. banzavóis: Gadda definisce il ban-zavóis con queste parole: una specie digranoturco dolciastro proprio di quel cli-ma; si tratta di un cereale immaginario,principale fonte di sostentamento dei ma-radagalesi, che ricorda il granturco di cuiabbondano le campagne brianzole. E pro-prio nel dialetto della Brianza il banzavóisha le sue radici, come conferma Gaddastesso: da panz vöj, «pance vuote».14. «Verze»: (dial. lombardi): cavoli. «Oc-chieggiare» e «verzicare» sono le due pen-nellate maestre de’ grandi paesisti, speciedonne, tra il 1900 e il 1930. Aggiungi an-che «svettare» in un intorno di tempo sul1925. [N.d.A.]15. qualmente: «parimenti, allo stesso mo-do»; toscanismo arcaico.16. politecnicali prodotti: «opere d’inge-gneria», metonimia per «le ville medesime».17. tetto … punte: si osservi il chiasmo atre elementi, con forte allitterazione delledentali.18. il legno … serruchonese: le case sono aintonaco bianco dipinto color legno, nellapretesa imitazione degli chalet svizzeri;scialbatura è termine tecnico delle bellearti, ed equivale a «intonacatura». L’Ober-land (letteralmente, «terre alte», in tedesco)è la Svizzera.19. dacquate: «acquazzoni, scrosciate d’ac-qua», voce lombarda.20. in fuora: «in fuori», fiorentinismo cin-quecentesco.21. in coppa: «in cima», dialettalismo napo-letano.22. come … capovolti: Il modello fisico diquesto Kremlino-Alhambra-filanda-pagodaesiste nella reale realtà, in riva, quasi, d’unbel lago della provincia di Novara: e quasiappiè il monte, «la cui neve è rosa». [N.d.A.] Sinoti l’uso parodico della similitudine.23. embricata: «a embrici»; l’embrice è unlaterizio a forma trapezoidale e con i latirialzati alle estremità.24. tenevano della: avevano un che di.25. Alhambra: la fortezza-palazzo costrui-ta a Granada tra il XIII e il XIV sec. dagliemiri arabi, uno dei più noti esempi di arteispano-moresca.26. l’umberto … guglielmo: il lungo catalo-go degli stili si ispira al saggio del criticod’arte Roberto Longhi, Officina ferrarese
(1934), conosciuto e citato dall’autore. Quila prima parte è sobriamente verosimile,con una piccola concessione al neo-neo-classico.27. pompeiano … angioino: il primo è lostile falso-antico, sorto sull’onda delle sco-perte archeologiche di Ercolano e Pompei,il secondo è un’invenzione gaddiana. 28. l’egizio-sommaruga e il coppedè-ales-sio: Sommaruga e Coppedè sono architetti«straricchi» del primo ventennio del secolo.Di Galeazzo Alessi le città di Milano e diGenova dicono la fastosa grandezza, ilperduto e patetico sognare. Per il Somma-ruga si usarono anche gli aggettivi: pesan-te, funerario. [N.d.A.]29. Biarritz … Ostenda: la prima è una cittàbalneare della Francia, situata sul golfo diGuascogna, la seconda è una città del Bel-gio che si affaccia sul mare del Nord.30. Indianàpolis: capitale dello Stato del-l’Indiana, negli Stati Uniti.
31. Filippo Maria … bocca: Filippo MariaVisconti (1392-1447), l’ultimo esponentedella famiglia Visconti; dopo di lui, il duca-to di Milano passò agli Sforza. Filippo Ma-ria Visconti viene ricordato qui per la suaimperizia (di buona bocca).32. stravaccata: «sdraiata, seduta in modoscomposto», italianizzazione del lombardostravacàa.33. ottomana turca: divano, detto anchealla turca, con materasso e cuscini per laspalliera, trasformabile in letto. Il commen-to tra parentesi (sic) scherza sullo ‘stridore’formale della giustapposizione tra i due ag-gettivi (che sono sinonimi).34. funzionale novecento: Gadda alludequi all’architettura «funzionale», o «funzio-nalismo», sorta, in realtà, tra la fine delXVIII e l’inizio del XIX secolo, che – perreazione al barocco e al rococò – mirava asubordinare la decorazione e l’ornamentoalla funzionalità architettonica.
232
re fallito11, e quale d’un qualche ridipinto conte o marchese sbiadito,che non erano riusciti né l’uno a farsi affusolare le dita, né l’altro, non-chè ad arricchire, ma purtroppo nemmeno a fallire, tanto aveva potutosoccorrergli la sua nobiltà d’animo, nella terra dei bozzoli in alto mare edelle motociclette per aria12. Della gran parte di quelle ville, quando ve-nivan fuori più «civettuole» che mai dalle robinie, o dal ridondante fo-gliame del banzavóis13 come da un bananeto delle Canarie, si sarebbeproprio potuto affermare, in caso di bisogno, e ad essere uno scrittore ingamba, che «occhieggiavano di tra il verzicare dei colli». Noi ci contente-remo, dato che le verze14 non sono il nostro forte, di segnalare comequalmente15 taluno de’ più in vista fra quei politecnicali prodotti16, coltetto tutto gronde, e le gronde tutte punte17, a triangolacci settentrionalie glaciali, inalberasse pretese di chalet svizzero, pur seguitando a cuo-cere nella vastità del ferragosto americano: ma il legno dell’Oberlandera però soltanto dipinto (sulla scialbatura serruchonese18) e un po’troppo stinto, anche, dalle dacquate19 e dai monsoni. Altre villule, dov’èlo spigoluccio più in fuora20, si drizzavano su, belle belle, in una torri-cella pseudo-senese o pastrufazianamente normanna, con una lunga enera stanga in coppa21, per il parafulmine e la bandiera. Altre ancora siinsignivano di cupolette e pinnacoli vari, di tipo russo o quasi, un po’come dei rapanelli o cipolle capovolti22, a copertura embricata23 e benespesso policroma, e cioè squamme d’un carnevalesco rettile, metà gial-le e metà celesti. Cosicchè tenevano della24 pagoda e della filanda, ederano anche una via di mezzo fra l’Alhambra25 e il Kremlino.Poichè tutto, tutto! era passato pel capo degli architetti pastrufaziani,salvo forse i connotati del Buon Gusto. Era passato l’umberto e il gu-glielmo26 e il neo-classico e il neo-neoclassico e l’impero e il secondoimpero; il liberty, il floreale, il corinzio, il pompeiano, l’angioino27, l’egi-zio-sommaruga e il coppedè-alessio28; e i casinos di gesso caramellatodi Biarritz e d’Ostenda29, il P.L.M. e Fagnano Olona, Montecarlo, In-dianàpolis30, il Medioevo, cioè un Filippo Maria di buona bocca31 a brac-cetto col Califfo: e anche la Regina Vittoria (d’Inghilterra), per quantostravaccata32 su di un’ottomana turca33: (sic). E ora vi stava lavorando ilfunzionale novecento34, con le sue funzionalissime scale a rompigam-
IL SECONDO NOVECENTODal dopoguerra a oggi
Autori
35. a rompigamba: comico neologismo co-struito sul modello di «a rompicollo».36. oblò del càssero: «piccole finestre similiagli oblò nelle cabine delle navi»; il càssero èpropriamente una sovrastruttura delle navimercantili adibita a cabina e destinata all’al-loggio del personale di bordo.37. novelli … di Terepàttola: Jacopo Barozzi
detto il Vignola (1507-73), fu architetto e teo-rico (Regola delli cinque ordini di architettu-ra, 1562). Terepàttola, nel distretto del Serru-chón, è da identificarsi, forse, con Albavilla(tra Como ed Erba).38. Coi … capire: Occorse all’autore inge-gnere di aver a discutere con un «collega suo»circa le dimensioni di alcuni luoghi di como-
do. [N.d.A.]; capire è termine aulico (derivatodal latino capi, «essere contenuto»), per «trovarposto».39. dimandano: «richiedono», arcaismo.40. bronzatura … delle meningi: La moda oanzi manìa dei bagni di sole (1920-1940) hatalora ecceduto i limiti del buon senso. E dalbagno di sole esci stupido. [N.d.A.]41. da ova sode: Esempi innumeri di caseinabitabili per troppo ampie vetrate: luce evento e calore non sono sempre amici dell’uo-mo. Il clima e la luce del Prado non sonoquelli di Oslo. [N.d.A.]42. San Juan: «la costa di fronte a Longone,sulla destra della provinciale da Erba (lo «stra-done del Prado»)»; San Juan è «Galliano o Ca-polongo» (Manzotti).43. fronte: la linea che separa due masse d’a-ria che hanno caratteristiche fisiche diverse.44. malestro: «marachella», ma anche «dannomateriale di una certa entità, provocato damaldestrezza o sbadataggine».45. pittate: «dipinte», è una voce di area meri-dionale.46. linfatica: «debole, malaticcia»; propria-mente l’aggettivo designa chi è affetto da «lin-fatismo» (condizione di debolezza costituzio-nale, conseguente a un eccessivo sviluppodel sistema linfatico).47. locupletò: «arricchì», voce aulica derivatadall’aggettivo latino locuples, «ricco».48. pesos papel: pezzi (pesi) carta, distintidai pezzi (pesi) oro nella monetazione delMaradagàl. [N.d.A.]49. arrondimiento: distretto (del Serruchón).50. Descrivere … pensabile: secondo l’artifi-cio retorico della preterizione, la dichiarazio-ne di impossibilità narrativa è smentita subitodopo dall’elaborata e minuziosa descrizionedell’evento; inopinata equivale a «inattesa»,«imprevista»; è voce d’uso letterario derivatadal latino.51. diportamento scaricabarilistico: «l’atteg-giamento di rifiuto di assunzione delle re-sponsabilità» (il comportamento di chi fa «ascaricabarile»). Si osservi la stridente – e ironi-ca – giustapposizione tra il termine aulico di-portamenti e l’aggettivo – di conio gaddiano –scaricabarilistico, di matrice proverbiale epopolareggiante.
Carlo Emilio Gadda • La cognizione del dolore
233
ba35, di marmo rosa: e occhi di bue da non dire, veri oblò del càssero36,per la stireria e la cucina; col tinello detto office: (la qual parola eserci-tava un fascino inimmaginabile sui novelli Vignola di Terepàttola37). Coicessi da non poterci capire38 se non incastrati, tanto razionali erano, dicinquantacinque per quarantacinque; o, una volta dentro, da non arri-var nemmeno al sospetto del come potervisi abbandonare: cioè a mani-festazione alcuna del proprio libero arbitrio. Ché, per quanto libere, so-no però talvolta impellenti e dimandano39, comunque, un certo volumedi manovra. Con palestra per i ragazzi, se mai volessero cavarsi lo sfizio;non parendogli essere abbastanza flessuosi e snodati tra una bocciaturae l’altra, tra il luglio e l’ottobre. Con tetto a terrazzo per i bagni di soledella signora, e del signore, che aspiravano già da tanto tempo, perquanto invano, sia lei che lui, alla bronzatura permanente (delle menin-gi40), oggi così di moda. Con le vetrate a ghigliottina uno e sessanta lar-ghe nel telaio dei cementi, da chiamar dentro la montagna ed il lago, os-sia nella hall, alla quale inoltre conferiscono una temperatura deliziosa:da ova sode41.Ma basti, con l’elenco delle escogitazioni funzionali.Fra le ville della costa di San Juan42, lungo lo stradone del Prado, (saet-tavano i rimandi rossi dei loro vetri avverso il taciturno crepuscolo), c’e-ra anche, piuttosto sciatta, e ad un tempo stranamente allampanata, Vil-la Maria Giuseppina; di proprietà Bertoloni. Il crepuscolo, e il suo fron-te43 malinconioso e lontano, appariva striato, ad ora ad ora, da lungherughe orizzontali, di cenere e di sanguigno. La villa aveva due torri, edue parafulmini, alle due estremità d’un corpo centrale basso e lungo;tanto da far pensare a due giraffe sorelle-siamesi, o incorporàtesi l’unanell’altra dopo un incontro a culo indietro seguito da unificazione deideretani. Dei due parafulmini, l’uno pareva stesse meditando un suospeciale malestro44 verso nord-ovest, oh! una trovata: ma diabolicamen-te funzionale: e l’altro la stessa precisa cosa a sud-est; e cioè d’infilare ilfulmine, non appena gli venisse a tiro, sul «confinante» di destra: e l’altroinvece su quello di sinistra: rispettivamente Villa Enrichetta e Villa Anto-nietta. Accoccolate lì sotto, in positura assai vereconda, e un po’ subal-terna rispetto alle due pròtesi di Villa Giuseppina, e pittate45 di chiaro,avevano quell’aria mite e linfatica46 che vieppiù eccita, o ne sembra, ilcrudele sadismo dell’elemento.Questo sospetto della nostra immaginosa tensione era divenuto scaricadella realtà il 21 luglio 1931, durante l’imperversare d’una grandinatasenza precedenti nel secolo, che locupletò47 di pesos papel48 tutti i ne-gozianti di vetri dell’arrondimiento49.Descrivere lo spavento e i cocci di quella fulgurazione così inopinatanon è nemmeno pensabile50. Ma il diportamento scaricabarilistico51 deidue parafulmini ebbe strascichi giudiziari, – subito istradati verso l’eter-nità – tanto in sede civile, con rivendica di danni-interessi, perizie tecni-che, contro-perizie di parte, e perizie arbitrali, mai però accettate con-
234
52. Che ce ne impodo io: «Cosa posso farci?»,espressione del dialetto lombardo.53. ludro: «birbante, manigoldo», terminedialettale (dal lombardo luder).54. riccio … dorato: è la parte più alta delparafulmine, costituita da una palla a formadi riccio, che finirà poi fusa dalla forza sca-tenata del fulmine e, in un’immagine grot-tesca, sciolta come cera di candela lungola stanga del parafulmine.55. il terrore dei castani: tipico esempiodella costruzione astratta «che oggettiva quila reazione (il terrore) indotta, disgiungen-dola dalle cause» (Manzotti); in luogo di «icastani terrorizzati» si trova il sostantivoastratto seguito dal complemento di speci-ficazione. 56. bilicare: «tenersi in bilico», arcaismo(derivato dal latino volgare).57. smoccolàtili: «fattili colare», con valorecausativo.58. quasi ch’e’ fussero: si osservi il registrostilistico arcaizzante.59. sparnazzò: «si sparse»; sparnazzare èdetto, propriamente, dei polli che razzola-no sparpagliando il becchime. La voce bas-sa, popolare, è comicamente giustappostaal registro alto di poco sopra (si veda la no-ta precedente).60. acròbato: «acrobata»; il maschile acro-bato è invenzione gaddiana.61. «Colmigno» è il colmo del tetto. [N.d.A.]62. intrefolàtosi: «avvoltosi», neologismogaddiano (derivato da «trefolo», l’elementocostitutivo delle corde, vale a dire l’insiemedei fili elementari avvolti tra loro).63. issofatto: «subito, immediatamente», arcai-smo (dal latino ipso facto, «nell’atto stesso»).64. bagnarola: «vasca da bagno, tinozza».Il termine è di matrice dialettale e appartie-ne a un registro stilistico basso, quotidiano.65. nullità … di terra: l’espressione, costrui-ta nella consueta forma astratta, è di ambitotecnico, scientifico. Per convenzione alla ter-ra è assegnato un potenziale elettrico a valo-re zero (da qui la misteriosa nullità).66. itinèraire: «itinerario, percorso», infrancese. Si veda, più sotto, la variante si-nonimica configurazione di percorrenza.67. giallone: «il fulmine» così chiamato per-chè di colore giallo; definito in un altropasso della Cognizione, il giallone troja azig-zag.68. equazioni … integrare: equazioni delcalcolo differenziale, delle quali calcolaro-no l’integrale.69. carrucolar: «trasportare con carrucola»,neologismo gaddiano.
temporaneamente dalle due parti; – quanto in sede penale, per incuriacolposa e danneggiamento a proprietà di terzi. E ciò perchè la causa ap-parì, fin dal suo principio, delle più controverse. «Che ce ne impodoio52», protestava il vecchio Bertoloni, un immigrato lombardo, «se quelludro53 non sapeva neanche lui dove andare?». Il fulmine infatti, quandocapì di non poter più resistere al suo bisogno, si precipitò sul paraful-mine piccolo; ma non parendogli, quella verga, abbastanza insigne perlui, rimbalzò subito indietro come una palla demoniaca e schiantò suquell’altro, un po’ più lungo, della torre più alta, e cioè in definitiva al-lontanandosi da terra, cosa da nemmen crederci. Lì, sul riccio platinatoe dorato54, aveva accecato un attimo il terrore dei castani55, sotto la nuo-va veste d’una palla ovale, – fuoco pazzo a bilicare56 sulla punta, – comefosse preso da un bieco furore, nell’impotenza: ma in realtà sdipanandoe addipanando un gomitolo e controgomitolo di orbite ellittiche in sen-so alternativo un paio di milioni di volte al secondo: tutt’attorno l’orofalso del riccio, che difatti avea fuso, insieme col platino, e anche col fer-ro: e smoccolàtili57 anche, giù per la stanga, quasi ch’e’ fussero58 di ceradi candela.Poi sparnazzò59 un po’ dappertutto sul tetto, sto farfallone della malora,e aveva poi fatto l’acròbato60 e la sonnambula lungo il colmigno61 e lagrondaia, da cui traboccò in cantina, per i buoni uffici d’un tubo di sca-rico della grondaia medesima, resuscitandone indi come un serpente,intrefolàtosi62 alla corda di rame del parafulmine piccolo, che aveva vi-ceversa l’incarico di liquidarlo in profondo, sta stupida. E in quel nuovofarnetico della resurrezione si diede tutto alle rete metallica del pollaioretrostante il casamento della Maria Giuseppina (figurarsi i polli!), allaquale metallica non gli era parso vero di istradarlo issofatto63 sulla can-cellata a punte, divisoria delle due proprietà confinanti, cioè Giuseppi-na e Antonietta: che lo introdusse a sua volta senza por tempo in mezzonella latrina in riparazione, perchè intasata, del garage dell’Antonietta,donde, non si capì bene come, traslocò immantinente addosso alla En-richetta, saltata a piè pari la Giuseppina, che sta in mezzo. Ivi, con unosparo formidabile, e previo annientamento d’un pianoforte a coda, situffò nella bagnarola64 asciutta della donna di servizio. Stavolta s’era ap-piattito per sempre nella misteriosa nullità del potenziale di terra65. – Fu-rono le diverse perizie che via via permisero di delineare, per successi-vi aggiustamenti, in un atlante di carta bollata, questo catastrofico «itinè-raire66». Ciò in un primo tempo. In un secondo tempo, furono le periziestesse a intorbidar le acque, ossia a mescolar le carte, a un tal segno darendere impensabile ogni configurazione di percorrenza. Il muratore divilla Enrichetta, con il buon senso proprio de’ paesani, affacciò una suaipotesi, d’altronde plausibilissima: che l’ultimo indietreggiamento delgiallone67, così lo chiamò, fosse dovuto al fatto d’aver trovata intasata lacanna della latrina, per cui non potè usufruire del passaggio necessarioa un tanto fulmine. Ma gli elettròlogi non ne vollero sapere d’una simileipotesi, e sfoderarono delle equazioni differenziali: che pervennero an-che a integrare68, con quale gioia del cav. Bertoloni si può presumere.Parallelamente a ciò, nel mito e nel folklore del Serruchón si fece strada l’i-dea che il pianoforte sia strumento pericolosissimo, da carrucolar69 fuori ingiardino senza perdere un istante, non appena si vede venire il temporale.La disgrazia, per il cav. Bertoloni, sarebbe stata ancora sopportabile, sedurante l’elaborazione delle perizie di parte e la celebrazione d’un pri-
IL SECONDO NOVECENTODal dopoguerra a oggi
Autori
Carlo Emilio Gadda • La cognizione del dolore
235
mo tentativo di procedura arbitrale, a complicare maggiormente le cose,e a stroncar netta ogni speranza di composizione, un secondo fulminenon fosse caduto sulle tre ville, omai affratellate dalla «lubido70» celeste;e cioè due anni dopo la scarica della bagnarola, nel giugno del ’33.Chiamati ad ennesima perizia i più occhialuti ingegneri elettrotecnici diPastrufazio, essi arrivarono in locum71 una stupenda mattina di mezzoagosto, con ogni sorta di strumenti in scatola, delicatissimi, e ohmetri eponti di Wheatstone72 portatili, d’una fragilità estrema: ma in quel gior-no si celebravano a Terepáttola le esequie di Carlos Caçoncellos73, ilgrande epico maradagalese che era venuto a mancare due giorni prima,piombando74 nella costernazione il mondo letterario, e i poeti epici inparticolare misura. Sicché gli ingegneri, nella villa deserta, e privata an-che del custode, non avevano potuto combinar nulla. Da alcuni anni ilVegliardo aveva in affitto la villa, dove soleva trascorrere la maggior par-te dell’estate assistito dalla fedele Giuseppina75, educando rose e ama-ranti, e pomidoro76, nel «parterre» a occidente del terrazzo, ma rifiutan-dosi di adibir cure al pollaio: che giudicava, quella, banalità indegna delcantore di Santa Rosa: e i cui coccodé lo avrebbero sicuramente inco-modato nella elimazione77 de’ suoi dodecasillabi eroici e di alcuni tetra-metri giambici, ancora più difficili dei primi. Solo la serva, dentro quelrugginoso e fulgurato recinto, gli allevava di scondone78 un qualche pol-lo immalinconito e pieno di pidocchi, che risultava poi, all’atto pratico,assolutamente immangiabile.Carlos Caçoncellos, come tutti sanno, fu l’aedo della Reconquista edella battaglia di Santa Rosa79 (14 maggio 1817 – in giorno di domeni-ca), il cantore di gesta del ciclo maradagalese del libertador. Tutta l’e-pica maradagalese dell’ottocento è avvivata dalla figura e dal nome dellibertador, il generale Juan Muceno Pastrufacio80, il vittorioso di SantaRosa, terrore dei «gringos», disperditore degli Indios, ricostruttore del-la città omonima; esaltato in versi stupendi come il Belgrano e insiemeil Moreno81 del Maradagàl, per quanto in altre occasioni poetiche loabbiano anche paragonato a Giorgio Washington, Tamerlano, Garibal-di e Mazeppa82.
Sobre ese mismo – caballo hasta el Domingo¡Vuelva Usted! dando – nos el grito de guerra:Como allá cuando – despavorido esta tierraDejó, en la sangre, – y volvió espalda el gringo83.
Cioè quando si venne a giornata84, la domenica del 14 maggio 1817, nel-la piana di Santa Rosa: dove Nepomuceno Pastrufazio battè gli «antichi»conquistadores e subito prima le torme degli Indios in piena rivolta, nonsi sa bene se contro lui o contro quegli altri.Imbarazzatissimi, dopo la dipartita del Vate, i Bertoloni non sapevanopiù che pesci pigliare per tirare avanti. Il bisogno era sempre istante, dicavare un qualche quattrinuccio dalle costole dell’allampanata e pollu-ta85 Giuseppina, giusto da poter pagare le tasse, i periti, gli avvocati, gliinteressi delle ipoteche…: e adibirvi le riparazioni di maggiore urgenza.Imbarazzatissimi e costernati, poveracci, tante e tali erano le grane chegli avevano piantato intorno, e tali e tanti i nembi, che s’erano venuti cu-mulando su quel loro tesoro serruchonese.
70. lubido: «forte desiderio», in latino (congrafia arcaizzante rispetto a libido). Il ter-mine è anche tecnicismo della psicanalisi.71. in locum: «sul posto», in latino.72. ohmetri … Wheatstone: strumenti tec-nici – il secondo dei quali (il ponte diWheatstone) dal nome del suo inventore, ilfisico inglese Charles Wheatstone (1802-75) – usati per la misurazione di resistenzeelettriche.73. Caçoncellos: il cognome di questo per-sonaggio deriva dai macaronici casoncellis,«grossi ravioli ripieni di formaggio».74. piombando: «facendo precipitare», rarouso causativo del verbo. 75. assistito dalla fedele Giuseppina: È unostandard idiomatico vagotonico relato adEros idillico. Rapporti idillici tra fàmuli epadroni nel notiziario de’ giornali: e nellaletteratura educativa.76. educando … pomidoro: parodica e ir-riverente deformazione di un passo dei Se-polcri foscoliani, vv.124-126: Le fontaneversando acque lustrali / amaranti educa-vano e vïole / su la funebre zolla.77. elimazione: il termine, coniato da Gad-da, allude al latino labor limae («il lavoro dilima»), il lungo processo di affinamento sti-listico a cui ogni poeta – e D’Annunzio inparticolare – sottopone i suoi testi.78. di scondone: di nascosto: (dial. lom-bardi). [N.d.A.]79. aedo … Santa Rosa: il poeta che cantòla riconquista della città di Buenos Aires du-rante la guerra tra Spagna e Inghilterra (inArgentina è festa nazionale), nella quale fudeterminante la battaglia di Santa Rosa.80. generale … Pastrufacio: questo gene-rale immaginario appare modellato sulla fi-gura di Garibaldi.81. Belgrano … Moreno: Manuel Belgranoe Mariano Moreno furono protagonisti del-la rivoluzione di maggio del 1810, che de-cretò l’indipendenza dell’Argentina.82. Tamerlano. … Mazeppa: Tamerlano èl’eroe letterario del dramma del poeta edrammaturgo inglese Christopher Marlowe(1564-93), Tamburlaine the Great (Tamer-lano il Grande, 1587-88); Mazeppa è il pro-tagonista dell’omonimo poema di GeorgeByron (1819) e del poema Poltàva diPuskin.83. Sobre … gringo: «Sopra lo stesso caval-lo, (a tempo) per quella domenica, / possatu tornare! lanciandoci il grido di guerra: /Come quando, atterrito, questa terra / La-sciò, nel sangue, e volse il tergo lo stranie-ro» (trad. E. Manzotti).84. quando … a giornata: quando venneil giorno della battaglia.85. polluta: «contaminata»; aggettivo d’usoletterario coniato sul latino.
236
86. dugento mila dodecasillabi: si osservil’iperbole, che allude, stigmatizzandola, al-la sterminata produzione poetica dannun-ziana.87. izquierda: «sinistra», in spagnolo.88. cinquantina di volumi: il corpus delleopere di D’Annunzio consta di quarantano-ve volumi.89. la gran parte giacevano: sintassi popo-lare, con concordanza a senso tra soggettosingolare e verbo al plurale.90. monumento nazionale: dopo la mortedi D’Annunzio (1938) il Vittoriale fu dichia-rato monumento nazionale e, mutato no-me, divenne il «Vittoriale degli Italiani».91. pristino: «anteriore, originario», voceletteraria derivata dal latino (come mostra ilseguente pristinam); si osservi l’ironico bi-sticcio con il precedente riprìstino.92. con lapide … gregoriana: GregorioPontefice XVI, (1831-1846), «amante dellearti e delle scienze», fu costruttore, e orna-mentatore di Roma con lapidi in buon lati-no: «fondò» il Museo Etrusco che da lui sidenomina. Lasciamo del rimanente.[N.d.A.]93. in dignitatem … domini: «riportato alsuo stato originario nell’anno del Signore»;la frase ripete, in latino, quanto detto im-mediatamente sopra.
Poiché da un lato l’idolatria del pubblico per l’Estinto (di cui si dicevaavesse scritto da dugento mila dodecasillabi86, e ventitre mila tetrametrigiambici) vietava loro nel modo più perentorio di «rimuovere anche sol-tanto uno spillo», nei diversi locali della Giuseppina: dal come lui stessol’Estinto li aveva lasciati prima di venir trasferito alla clinica di San José,a Terepàttola: ed ecco però che nel frattempo erano venuti a mancaremisteriosamente le ciabatte, una pera di gomma, e lo spazzolino da den-ti, e cioè prima ancora del trigesimo: di certo involati da un qualche am-miratore e fanatico raccoglitore di cimeli, così almeno si suppose. Il che,dalla stampa de izquierda87, fu subito recato a colpa della «ignavia bor-ghese dei proprietari» e della loro «ottusità mercantile nel confronto deipiù alti valori dello spirito».D’altro lato i giornali repubblicani menavano già una campagna di quel-le, perché la Giuseppina avesse a divenire il sacrario del Poeta, e dellesue memorie; e vi fossero adunati tutti i suoi cimeli, fra cui la lenza, e,quel che più conta, i suoi manoscritti, di cui s’erano pubblicati una cin-quantina di volumi88; ma la gran parte giacevano89 inediti presso le variecase editoriali del Maradagàl, che stentavano, dicono (e stentano ancoroggi), a trovar loro uno sbocco sul mercato librario, nonostante l’eleva-to grado culturale della società maradagalese. Secondo alcuni Villa Giu-seppina doveva addirittura, e senza por tempo in mezzo, venir dichiara-ta monumento nazionale90, previo esproprio a termini di legge e a spe-se dello stato: e passare a manutenzione statale. Ma lo stato era già so-vraccarico di monumenti, antichi e moderni, e la società archeologicaper gli studi pre-colombiani non gli dava pace, arrivando a procurarglifino a dodici e quindici monoliti alla settimana, e tombe di re incas, chevenivano accolti, dai baffi del Ministro della Istruzione, con la stessagioia che i trovatelli in un brefotrofio senza fondi.Sicchè la legge per il riprìstino dello spazzolino da denti nel pristino91
splendore, con lapide e incisione gregoriana92 – in dignitatem pristinamredactus, anno domini93, eccetera – minacciava di rimaner progetto. L’e-sattore intanto, una bravissima persona del resto, e uomo di penna dav-vero incisiva, quello, non scherzava.
IL SECONDO NOVECENTODal dopoguerra a oggi
Autori
Proposte operative
Analisi
Quali sono i valori della società rappresentata nell’inizio del romanzo? Ricavali dai canoni estetici che presiedono alla costruzione delle ville del Maradagàl.
Analizza nella descrizione dell’ambiente il tema della natura.Individua nel passo gli elementi tipici del pastiche gaddiano e spiegane la funzione.Rintraccia nel testo i nuovi ‘ingredienti’ del pastiche legati all’ambientazione del romanzo.Evidenzia nel passo la ‘presenza’ del Manzoni e di D’Annunzio.5
4
3
2
1
Carlo Emilio Gadda • La cognizione del dolore
237
1. Ingambarono: «scavalcarono»; il verbocompare già in Carlo Dossi e in RiccardoBacchelli (ma in quest’ultimo nell’accezio-ne, intransitiva, di «darsela a gambe»).2. Drupe tumide: «frutti carnosi con un
unico seme centrale»; in questo caso, le su-sine.3. polloni: si definisce pollone il ramo che
si forma sul fusto o alla base di una piantaarborea adulta, generato per lo più da gem-ma avventizia.4. scrimolo: «bordo» (del muretto).5. sassonia: «strada sassosa», neologismo
gaddiano.6. e si ricorda … notte: come ha osserva-
to Emilio Manzotti, la frase è un endecasil-labo a minore (con accento principale,cioè, sulla quarta sillaba).7. zimarre: il termine zimarra designa,
in origine, una lunga sopravveste maschile;qui equivale a «vestaglie da notte, vesti dacamera».8. alcade: variante arcaica della voce spa-
gnola alcalde, che designa il sindaco dellecittà spagnole.9. Peppa … Beppina: la Peppa è la lavan-
daia di Lukones, definita da Gadda unadonna-uomo più dura e salda che non siastato mai un facchino […] tenace e povera,e gialla nel viso; la Beppina, invece, è la pe-scivendola, sommariamente vestita perchèsempre scalza e vestita in modo sciatto etrasandato.10. peone: termine spagnolo che designa,propriamente, il «lavoratore a giornata».11. il figlio … stessa: don Gonzalo era in-fatti partito dopo aver licenziato il fattoreGiuseppe e aveva lasciato così sola, nellavilla, l’anziana madre.
La morte della Signorada La cognizione del dolore, II IX
È il finale del romanzo, che si conclude con l’assassinio della madre diGonzalo e con il rinvenimento del cadavere. La scoperta dell’omicidioavviene ad opera di due cugini assoldati come guardie private dal vici-no di casa dei Pirobutirro, il cavalier Trabatta (già in precedenza og-getto delle minacce del Nistitúo). I due ragazzi, Bruno Olocati e GomezErmenegildo, insospettiti dai rumori provenienti dalla villa di don Gon-zalo, scavalcano il cancello ed entrano nell’edificio, dove trovano, ago-nizzante, la Signora.Come accadrà nel Pasticciaccio, anche in questo caso il mistero dell’uc-cisione resta irrisolto.
Ma adesso era buio, tutto buio: e notte. E nessuno che li poteva spiare.Ma il terrore d’esser colti li prese. Il cancello era chiuso. Erano chiusidentro. «Andiamo! Andiamo», si dissero. Ingambarono1 il muro, uno do-po l’altro. Drupe tumide2, dai polloni3 dei susini, percossero loro la fac-cia, si spiccarono, caddero sullo scrimolo4, rimbalzarono e rotolaronodavanti a loro nella sassonia5 e nel buio. Essi erano balzati sulla strada,oh! se Dio volle, liberi di esservi. Non si slogarono nessun piede, suiciottoli.Fu solo allora che si dissero «cosa facciamo» e decisero di dare l’allarmea Lukones o alle vicine ville: e si ricorda ancora quella notte6. Che dopoun’ora o due vi erano zimarre7 e ciabatte, come di spettri spettinati, intutte le ville, con la luce accesa dappertutto.Con l’esplicita autorizzazione dell’alcade8, un’ora dopo, o più forse, en-trarono nel giardino della casa in diversi, e anche la Peppa, che richia-mata di strada s’era abbigliata in fretta e furia e molto sommariamente,come fosse invece la Beppina9, la pescivendola. Entrarono nel giardinodal basso, dal cancello grande di legno che non aveva serratura, ma ungrosso chiodo internamente, infilato in due ganci ad anello, di cui laPeppa sapeva. Girarono la casa, salirono la scala esterna; chiamaronoancora «Giuseppe, Giuseppe» e anzi passandoci davanti bussarono fortee ripetute volte all’usciòlo particolare della sua abitazione. Chiuso. Ten-tarono anche il portoncino dei signori. Chiuso anche questo. Allora ven-nero al terrazzo. Esitavano, dal timore del ridicolo, non volevano distur-bare. Ma insomma c’era la porta-finestra aperta, sul terrazzo: e nessunorispondeva. Dove diavolo s’era cacciato il peone10, il Giuseppe? Nessu-no rispondeva. Il vento, una breve folata, agitò i rami dei susini, l’olea, ibracci dei mandorli, scheletriti, che appena si travedevano nella notte.Un uscio battè, nella casa. Il vento si allontanò, come un ladro. Avevanodiverse lampade da campagna, di quelle a scatola di vetri, quadre, condentro il moccolo, che pendono dondolando da un gancio di fil di fer-ro: le sollevavano ad ogni tratto, triangoli fiochi di una luce gialla si agi-tavano sui muri, sul terrazzo: avevano armi, uno aveva addirittura il fu-cile, il cugino dell’alcade una pistola, come i due giovani.Chiamarono per nome la madre, il figlio, gridando, verso le finestre del Ipiano, premettendo ai nomi l’appellativo senora, senor… Ma la Peppa as-sicurò che il figlio era partito quella sera stessa11, non poteva esserci… As-sicurò anzi di averlo veduto partire… con una piccola valigia… la madre
238
12. mezza … coulisse: anta di persiana asoffietto.13. una fotografia … velivolo: il dettagliodella fotografia del giovane fratello di Gon-zalo immortalato dietro la mitragliatrice edavanti all’aereo ha una precisa corrispon-denza nella biografia gaddiana: una foto-grafia di famiglia ritrae infatti il fratello del-l’autore (morto anch’egli in volo) nella stes-sa posizione e nello stesso atteggiamento.14. Ma …devono: si tratta molto probabil-mente – come ha osservato Manzotti – diuna citazione a memoria delle Leggi di Pla-tone, il dialogo nel quale il filosofo grecoespone la propria teoria politica e discutedel sistema governativo e legislativo ideale. 15. Cabeza … Prado: Cabeza, che in spa-gnolo significa «capo, testa», corrisponde,nella geografia brianzola, ad Asso, capoli-nea delle ferrovie del Nord Italia. Pradocorrisponde invece, come si è visto (nota 6
231), a Erba.16. agilulfo-celtico: «longobardo-celtico».Agilulfo fu re dei Longobardi dal 591 al616. Il celtico è il sostrato linguistico – pre-cedente alla romanizzazione – delle zoneabitate dai contadini brianzoli.17. schidioni: «punte»; lo schidione è, pro-priamente, uno spiedo lungo e sottile.18. intorcolarsi: «attorcersi», neologismogaddiano derivato dal latino torculum, «tor-chio».19. büsekka … büsekk: «pancia, visceri», indialetto lombardo.20. antri illuni: «caverne [cioè stanze] nonilluminate dalla luce lunare»; illune è agget-tivo caro a D’Annunzio.21. epigastriche: «che provengono dallostomaco», più propriamente dall’epigastrio,ovvero dalla parte alta dello stomaco.22. ossitone «con accento sull’ultima silla-ba» (nel greco antico).
lo aveva salutato dal terrazzo dicendogli «Addio!… non essere inquieto».Poi si introdussero risolutamente nel ripiano della scala, ma incespicaro-no in qualche cosa, dalla porta-finestra socchiusa. Spinsero la mezza ge-losia a coulisse12 nel suo vano. Entrarono tutti, con le lanterne, Brunocon la lampadina: Gildo era intorno alle ville con uno di Lukones. Ince-spicarono in alcune scope, sgabelli, e anche un anaffiatoio che la Peppariconobbe subito, (e lo spiegò agli altri egutturando concitata, ma a vocebassa), come gli elementi della vespertina barricata con cui la Signoracredeva di confermare l’idea-chiusura espressa dai serramenti; che un la-dro aveva fabbricati. Dietro le due porte-finestre sprangate la signora ac-cumulava tavolini, sgabelli, scope, per fermare i passi furtivi della notte.La casa appariva deserta. La Peppa, il Bruno ed altri furono subito in cu-cina, poi in sala da pranzo; e la Peppa, ad un esame sommario, trovò lasala come l’aveva lasciata, nel tardo pomeriggio.Allora accesero le luci elettriche, salirono al piano superiore, gli uominidavanti, bussarono alla camera del figlio, lo chiamarono « senor…,senor…», non ebbero risposta, entrarono: la Peppa accese la luce elettri-ca: nessuno. Il letto intatto. Il grande tavolo liscio. Sul tavolo un libroaperto, una fotografia del fratello di lui, ragazzo dal volto sorridente, do-po tant’anni!: con una mano sul manubrio della mitragliatrice: era visibi-le, in parte, la struttura del velivolo13. Uno degli intrusi indugiò a guar-dare la fotografia, e lesse poi alcune righe nel libro aperto. «…Ma le leg-gi della perfetta città devono14…».Alcuni deposero le lanterne. Tennero, nel corridoio al piano superiore,un breve concilio, inquieti. Decisero di veder prima tutte le altre came-re. Due scesero ancora a chiamare il peone e arrivarono fino alla porti-cina del suo alloggio: e picchiarono e gridarono ancora. Gli altri erano lìtra il corridoio e la scala, perplessi, non ardivano bussare alla cameradella signora. Allora qualcuno ricordò che il peone, alla tabaccheria, eanche all’osteria, aveva detto di volersi trovare un nuovo posto, poichèquel cane di un figlio lo aveva licenziato… o minacciava di licenziar-lo…E sarebbe dovuto andare a Cabeza, dopo el Prado15, sì, no, passatoCabeza, dove c’era, forse, una proposta possibile.Ma altri sostennero che aveva rimandato la gita, che alle sei e mezzo eraancora per casa, che la Signora gli aveva preparato la cena: ella infattiusava cuocere e servire personalmente la cena ai suoi dipendenti…Al cancelletto di ferro, frattanto, arrivarono altri due o tre o più da Luko-nes, altre lanterne e voci e anzi uno con una torcia a vento: e presero achiamare dal cancello chiuso e mescevano le loro urla celtiche ai richia-mi longobardi dei due che bussavano all’usciòlo del peone. E si rico-nobbero alle voci, come animali nel buio, sicchè ne nacquero rinnova-to clamore, grida, spiegazioni; incitamenti rivolti da quei due dentro,agli altri, di farsi animo e scavalcare il cancello, e, nel baccano agilulfo-celtico16, per quanto fasciato dalla notte, avvertimenti che potevano in-filzarsi come polli sulle punte di quelli schidioni17 del cancello, bucarsila pancia, intorcolarsi18 la trippa sulle punte, stessero attenti!, e allora ap-punto i nomi trippa, büsekka, plurale tripp, büsekk19. E poi lazzi e me-raviglie ironiche per la torcia, che cosa è successo, e proteste e nuoveegutturazioni dei cavernicoli, stanati per quell’allarme dagli antri illuni20
del sonno. Un va e vieni di voci, per lo più monosillabiche, epigastriche,a urti21, a urli, o tutt’al più bisillabe, ma in tal caso ossitone22, a spari, ascopp»… Una folla dalla gola ossitona latrava e ingigantiva nella notte,
IL SECONDO NOVECENTODal dopoguerra a oggi
Autori
Carlo Emilio Gadda • La cognizione del dolore
239
con pantaloni pericolanti, quadrupedanti zoccoli, sui ciottoli, cro, cro,zoccoli… zoccoli, zòkur23, triangoli di luce, fumo e smoccolature di lan-terne e giornali al suolo, buttativi dall’irrompere di una ventata. Dal par-co conchiuso del cavr Trabatta, invece, si animavano a quando a quan-do i pini, i tigli, all’unisono, del loro signorile susurro. A ogni passaggiodel vento aveva preluso il lontano stormire della notte: a ogni respirodel vento, che i mandorli, qui, presso casa, cercavano invano di carez-zare, quasi ad attenuarne, a riavviarne la stolida chioma, come pettini,con rada fronda.Oranghi zoccolavano24 per casa, o dietro casa, o nel vialetto de’ susini:altri sul terrazzo, nell’esitazione della timidezza e nella libidine della cu-riosità, chiedevano notizie: «che cosa è, che cos’è». In casa, dove s’eraaccesa la luce elettrica, tra le seggiole e gli sgabelli che venivano conti-nuamente tra i piedi, le scope, l’anaffiatoio, all’altezza dei ginocchi lelanterne seguitavano a dar fumo, con odore di vernice arrostita, i moc-coli gocciolavano goccioloni di cera liquefatta sulla cartaccia comepiombo fuso, sui giornali che s’erano sparsi al suolo, dal tavolo del cor-ridoio, e tutti ci camminavano su. La testa del serpente collettivo era rap-presentata da quei sei o sette, fra cui il Bruno, la Peppa, il cugino del-l’alcade, che avevano fatto il giro della casa, di sopra, fino ai lavabi e sta-vano ora confabulando nel corridoio davanti l’uscio della camera da let-to in cui la Signora dormiva. Si fecero animo, visto che nessuno rispon-deva. Bussarono alla camera della Signora, dapprima dolcemente, poipiù forte e chiamandola, un po’ per uno. Nessuna risposta. Ma la signo-ra forse era sorda, con l’età. Il battente cedette: poi anche quello del se-condo uscio. Uno degli uomini avanzò il capo, disse »compermesso«,poi introdusse la lanterna; allora entrarono. Le lampade dimezzarono,tagliarono le ombre della grande camera, che soprastava alla sala dapranzo. Accesero la luce, dissero, già sgomenti, «Senora, Senora!», rivoltiverso il letto.Nel grande letto nuziale un posto appariva occupato, sotto le coltri. Unacoperta di lana assai buona, e frangiata, colorata a scacchi color sale epepe, di quelle che gli inglesi chiamano «plaids» e usavano ne’ loro viag-gi, al tempo di Dickens25, nascondeva quasi completamente il guancialee il capo della dormente. Ella, pensò la Peppa, era alquanto freddolosa:e forse si era riparata il capo a quel modo. Ma quel drappo parve a tuttiche nascondesse la morte.Il trapestio26 delle sei o sette persone sul pavimento di legno della ca-mera ebbe finalmente un arresto. Quelli che più s’erano avvicinati al let-to dalla parte occupata, tra cui la donna, chiamarono ancora, quasi sot-tovoce, per un riguardo, «senora, senora», chinandosi. E il vecchio Olo-cati la scoperse. Gli occhi della signora, aperti, non lo guardarono, guar-davano il nulla. Un orribile coagulo di sangue si era aggrumato, ancorvivo, sui capelli grigi, dissolti, due fili di sangue le colavano dalle narici,le scendevano sulla bocca semiaperta. Gli occhi erano dischiusi, laguancia destra tumefatta, la pelle lacerata, e anche sotto l’orbita, orribi-le. Le due povere mani levate, scheletrite, parevano protese verso «gli al-tri» come in una difesa o in una implorazione estrema. Esse poi appari-vano graffiate: macchie e sbavature di sangue erano sul guanciale e sullembo del lenzuolo27.Si accorsero che respirava, che solo le mani erano così, quasi fredde:tardo, debolissimo, il polso batteva ancora. Allora fu subito mandato per
23. zòkur: traduzione in dialetto lombardodel precedente zoccoli.24. Oranghi zoccolavano: si tratta di altricontadini (muniti di zoccoli) che accorronoper sapere cosa è successo.25. Dickens: Charles Dickens (1812-70), ilfamoso romanziere inglese autore, tra glialtri, dei romanzi Il circolo Pickwick (1836-37) e David Copperfield (1849-50).26. trapestio: scalpiccio, rumore di passi.27. Un orribile … lenzuolo: la rassegna deimacabri dettagli trova una quasi perfettacorrispondenza nella descrizione del cada-vere dell’altro figlio (sempre nella Cogni-zione), e in quella del cadavere della vitti-ma del Pasticciaccio, Liliana Balducci.
240
medico, fu Bruno che corse. In paese già lo avevano svegliato, quasi aun presagio.Egli finalmente arrivò, passando dal cancello grande di legno e dallascaletta esterna: una trentina di persone erano state messe fuori dellaporta dal cugino dell’alcade, poi dall’alcade, sopravvenuto lui pure, esostavano sul terrazzo, confabulando, rabbrividendo. Nessuno trovavala chiave del cancelletto di ferro. In casa erano rimaste la Peppa, la Bep-pina, la donna del cimitero, autorizzate a rendersi utili come potevano:e alcuni uomini, degli «aventi diritto».Il vecchio medico di Lukones in quelle tristissime contingenze si resemolto utile. Aveva una barba di quattro giorni sulle guance cascanti,non bianca ancora del tutto, ed era senza cravatta, con un colletto d’a-mido sfilacciato e un po’ «foedra de salamm28», con occhî arrossati comeper una blefarite29, stanchi, gonfî e piccoli dalla fatica e dal sonno: sottoai due piccoli bulbi le occhiaie gonfie, a lùnula, parevano due amache odue ghirbe30. Aveva portato con sè il prevedibile nella sua borsa nera ebisunta che tutti conoscevano, rifornita ad istinto, come da lunghi annila praticaccia omnibus31 gli aveva suggerito, e poi a mano a mano cor-retto i suggerimenti con le novità sempre più perfette del pronto soc-corso. La depose sul tavolino in un angolo. Altri impicci e bende avevaaffidato al Bruno, che pure ve li depose. Il dottore si accostò al letto,guardò quell’essere immobile e così orrendamente offeso: «così l’avetetrovata?», disse, prese la mano e distese quasi con una certa fatica il brac-cio scheletrito che i pizzi della camicia da notte ricadendo avevano la-sciato emergere nell’implorazione e nella difesa, l’una e l’altra vane. Ta-stò il polso destro mentre con l’altra mano ricompose distendendolol’altro braccio della povera indifesa. Si chinò ad ascoltare il cuore, poinuovamente con lo stetoscopio.Allora, senza dir nulla, estrasse il necessario da quella borsa e deposeogni cosa sul tavolino: i contadini tacevano guardando: la Peppa si face-va ripetutamente, energicamente, il segno della Croce: egli la invitò a sa-lire sul letto dalla parte del posto libero, in ginocchio, e a sollevare dol-cemente la padrona. Poi, chinatosi, praticò alla coscia una dopo l’altra treiniezioni, di olio canforato, di strofantina32, la terza di un altro cardioci-netico ancora, adrenalina, che infatti ravvivarono il polso. La signoraperò non die’ segno di dover riprendere i moti facciali, le palpebre del-l’occhio destro, tumefatte, non avrebbero neppure potuto dischiudersi:nè, dolcemente interrogata dagli astanti, dal medico, rispondeva alcun-chè. Tutta la guancia destra era ora orrendamente tumefatta. Respiravaora con pena, la lingua pareva essersi affossata nel palato, un rantolo, colrespiro, ne usciva. Le labbra insanguinate e semiaperte la lasciavanoscorgere al medico, giù, afflosciata nel retrobocca, che veniva a intasare.Il dottore, con due dita, cercò allora di estrarnela e di ricondurla alla suapostura normale. Le palpebre dell’occhio sinistro, con una leggera pres-sione delle dita, vennero da lui richiuse. Gli uomini lamentavano: «pove-ra signora, povera signora!», le donne piangevano e pregavano sommes-samente, poi sommessamente si soffiavano il naso, salvo la viriloide33
Peppa, che faceva solo, di quando in quando, il segno della Croce.Poi il capo, tutto sangue, fu dolcemente deterso, senza rimuoverlo, sen-za strapparne un capello, con ovatta imbibita d’alcool e poi, come nonbastava, di essenza e d’acqua di colonia, trovata in una fialetta sul tavo-lino: e ciò con estreme cautele: tutta la sala fu subito odorosa di alcool,
IL SECONDO NOVECENTODal dopoguerra a oggi
Autori
28. foedra de salamm: «buccia di salame»;il colletto della camicia, un po’ consunto,assomiglia alla pelle del salame. L’immagi-ne è già in Carlo Porta, La nomina del cap-pellan, vv.151-152 (l’accostamento si devea Manzotti).29. blefarite: «infiammazione del marginedella palpebra», termine medico.30. ghirbe: otri di pelle per il trasportod’acqua.31. praticaccia omnibus: «esperienza versa-tile»; si osservi la giustapposizione del termi-ne popolaresco praticaccia e del latino om-nibus (letteralmente, «in tutte le cose»).32. strofantina: si tratta di un cardiocineti-co che aumenta le contrazioni del muscolocardiaco.33. viriloide: «mascolina», neologismo gad-diano.
Carlo Emilio Gadda • La cognizione del dolore
241
di benzina, d’acqua di colonia, che vinsero i panni cristiani34 degli astan-ti. Ma, per detergere, ci vollero pazienza e tempo, al dottore, mentre ipresenti inorridivano. Il capo, allora, palesò due ferite, apparentementenon gravi, al parietale destro e alla tempia destra, e altre lacerazioni eabrasioni minori: e quella orrenda ecchimosi alla guancia destra, ch’eracosì spaventosamente tumefatta, fin sotto l’occhio. L’emorragia avevaimbrattato il capo, il viso, le labbra, il coagulo si era aggrumato e sta-gnato ne’ capelli, nell’orecchio destro, sulla faccia, sotto il naso: anchedal naso era venuto molto sangue: il lembo del lenzuolo, il cuscino, neerano atrocemente arrossati.Si comprese da tutti, al riscontrare delle tracce di sangue sullo spigolodel tavolino da notte, verso il letto, che il capo così ferito doveva avervibattuto violentemente; forse qualcuno doveva averla afferrata a duemani, pel collo, e averle sbattuto il capo contro lo spigolo del tavolinoda notte, per terrorizzarla, o deliberato ad ucciderla. Terribile fu e per-maneva a tutti l’aspetto di quel volto ingiuriato, ch’essi conoscevano co-sì nobile e buono pur nel disfacimento della vecchiezza.Ora tumefatto, ferito. Inturpito da una cagione malvagia operante nellaassurdità della notte; e complice la fiducia o la bontà stessa della signo-ra. Questa catena di cause riconduceva il sistema dolce e alto della vitaall’orrore dei sistemi subordinati, natura, sangue, materia: solitudine divisceri e di volti senza pensiero. Abbandono.«Lasciamola tranquilla», disse il dottore, «andate, uscite».Nella stanchezza senza soccorso in cui il povero volto si dovette racco-gliere tumefatto, come in un estremo ricupero della sua dignità, parve atutti di leggere la parola terribile della morte e la sovrana coscienza del-la impossibilità di dire: Io.L’ausilio dell’arte medica, lenimento, pezzuole, dissimulò in parte l’or-rore. Si udiva il residuo d’acqua e alcool dalle pezzuole strizzate ricade-re gocciolando in una bacinella. E alle stecche delle persiane già l’alba.Il gallo, improvvisamente, la suscitò dai monti lontani, perentorio edignaro, come ogni volta. La invitava ad accedere e ad elencare i gelsi35,nella solitudine della campagna apparita.
34. panni cristiani: l’espressione allude,eufemisticamente, al cattivo odore prodot-to dai vestiti, madidi di sudore, dei contadi-ni presenti.35. elencare i gelsi: l’immagine finale ricol-lega la morte della Signora alle sventurepassate della villa, sulla quale si riverberanole vicissitudini della casa di Longone, acqui-stata dal padre di Gadda per impiantarviuna coltivazione di gelsi per bachi da seta.
Analisi del testo
LA MESCOLANZA DI STILI E REGISTRI
Il racconto della macabra scoperta costituisce un in-teressante esempio di alternanza – che accompa-gna le variazioni del punto di vista – tra narrazione interza persona e discorso indiretto libero. Alle opinio-ni dei cugini si sommano poi voci sempre più indi-stinte (Alcuni deposero le lanterne; Due scesero; Glialtri erano lì; qualcuno ricordò; altri sostennero), che a
poco a poco si confondono – non senza evidente iro-nia – in un’unica ‘radice’ longobardo-celtica (mesce-vano le loro urla celtiche ai richiami longobardi deidue che bussavano all’usciòlo del peone.E si riconob-bero alle voci, come animali nel buio). Il brano offreanche alcuni esempi del registro lirico, speculare aquello comico-satirico (Dal parco conchiuso del cavr
Trabatta, invece, si animavano a quando a quando ipini, i tigli, all’unisono, del loro signorile susurro).
Quer pasticciaccio bruttode via Merulana
La scelta del genere «giallo». Nel decennio 1946-57,Gadda, dopo aver chiuso con la Cognizione il capi-tolo più delicato della propria dolorosa autoanalisi,si volge a una narrativa più oggettivata, rivolta al-l’esterno, che si faccia strumento d’analisi di un ma-le identificato ora nelle forme storiche della folledittatura fascista. In questa fase della vita e dellaproduzione gaddiana, fondamentale è infatti rista-bilire quell’ordine che con il ventennio fascista e iltrauma della guerra è andato perduto, denunciarequesto furto di valori e trovare una forma narrativache sappia rappresentare tale urgenza. Urgenzache, se risulta mitigata rispetto ai toni di Eros ePriapo, permette tuttavia di concretizzarsi in unadelle più decise (e divertenti) requisitorie antifasci-ste contemplate dalla letteratura italiana.Il genere giallo sembra offrire tutto questo, sia per lacapacità ad esso intrinseca di ricostruire una ratio al
disordine del mondo, sia perchè affida tale ricostru-zione al Logos, laddove invece il disordine del predo-minio del Predappiofesso era dovuto alla prevarica-zione dell’Eros. Ma il romanzo non si conclude; il gial-lo smentisce se stesso e il colpevole dell’atroce delittodi via Merulana non viene identificato. La tensione trai due principi di ordine e disordine, partita con moti-vazioni razionali e volta alla chiusura dell’indagine, fi-nisce invece per risolversi nella registrazione del caose del fallimento dell’indagine stessa. Per usare ancorale parole di Roscioni, restano «due fatti indiscutibili. Ilprimo è che per Gadda il libro esige una chiusa e ilpasticcio deve essere sbrogliato; il secondo è che lachiusa non c’è, e che il pasticcio rimane tale».
La storia editoriale
La grande opera della maturità, il romanzo in cuiconvergono tutte le linee che hanno guidato l’ispi-razione gaddiana, esce inizialmente a puntate sucinque numeri di «Letteratura» da gennaio-febbraioa novembre-dicembre 1946.
242
IL SECONDO NOVECENTODal dopoguerra a oggi
Autori
IL MISTERO IRRISOLTO
Nel risvolto di copertina dell’edizione del 1963, siipotizza che la Signora sia stata aggredita dalle stesseguardie del Nistitúo de vigilancia para la noche cheerano state incaricate di proteggerla, mentre atrocele si insinuava nell’anima il sospetto che ad organiz-zare l’aggressione fosse stato proprio il ‘tristo’ figlio
Gonzalo. Nell’edizione del 1970 (che pure si annun-ciava risolutrice del giallo), la causa si stempera nel-l’indeterminatezza delle cause,si confonde in una ca-gione malvagia operante nell’assurdità della notte.L’indecisione di Gadda permane fino all’ultimo e nonsi scioglie il garbuglio: il figlio, scagionato da alibiesterni,non risulterà colpevole,ma,creduto tale dallamadre morente, vivrà nel dolore del sospetto di lei.
Proposte operative
Analisi
Evidenzia nel passo il diverso ritmo narrativo e i differenti registri linguistici nelle sequenze che lo compongono.
Come è rappresentata la Signora? Rintraccia e analizza nel testo il problema della ‘soluzione’ del delitto.Evidenzia nel brano il tema della morte.4
3
2
1
Carlo Emilio Gadda • Quer pasticciaccio brutto de via Merulana
243
L’edizione del ’57. Per l’edizione in volume del 1957,Gadda rivede accuratamente e integralmente il te-sto; ne risulta un romanzo strutturalmente e lingui-sticamente diverso: ai primi sei capitoli, che ripren-dono quattro delle cinque puntate di «Letteratura»,vengono aggiunti altri quattro capitoli, che nonconcludono però la narrazione e non sciolgono ilgiallo. Sono inoltre espunte le note che accompa-gnavano l’edizione in rivista, e viene sensibilmente‘caricata’ la patina linguistica. L’intero quarto capi-tolo, infine, viene eliminato perchè, secondo Gad-da, avrebbe tolto suspence all’azione (ma anchegettato una luce ambigua sulle tendenze sessualidella vittima).
Un lungo lavoro di revisione. Il lavoro di revisionedel testo (e in particolare del romanesco) occupaGadda dal 1955 al 1957. Per questa revisione, infat-ti, lavorerà con il supporto di un consulente in mo-do da regolarizzare forme che spesso tradivano lanon familiarità dell’autore con il nuovo dialetto.Del resto, Gadda stesso, nel 1951 (prima, quindi,del lavoro di revisione), aveva dichiarato: Quantoal romanesco, non intendevo scodellare il vero eproprio dialetto; ma l’italiano misto a dialetto, quelmodo vigoroso di parlare che hanno quelli che pro-vengono per famiglia da un ambiente dialettale.
Una trama di «pasticci» e «garbugli»
Il protagonista e la trama. Don Ciccio Ingravallo,commissario alla squadra mobile di Roma nei primimesi del 1927, si trova coinvolto in uno dei casi piùcomplessi della sua carriera. Al numero 219 di ViaMerulana, un palazzo di loschi trafficanti, pesceca-ni arricchitisi nel dopoguerra con traffici illeciti, ebattezzato perciò dalla fantasia popolare il palazzodell’oro, abitano Liliana Balducci e suo marito Re-mo, amici di Ingravallo. Il commissario, platonica-mente innamorato della bellissima Liliana, invitatouna sera da loro a cena, ha modo di intuire il maleoscuro che tormenta la donna: l’ossessione per unamaternità mancata che viene compensata con l’a-dozione di ragazze-nipoti e l’assunzione di giovanidomestiche provenienti dalla zona dei Castelli Ro-mani; e traccia un inquietante quadro clinico chegetta subito una luce ambigua sulla strana coppia.Poche settimane dopo, nello stesso palazzo di viaMerulana, vengono rubati i gioielli di una condo-mina, la contessa Menegazzi, matura vedova di ori-gine veneta. Il commissario ha appena iniziato le
indagini (e i primi interrogatori spalancano le portesulle miserie e le divertenti caratteristiche degli in-quilini del palazzo dell’oro), quando gli viene co-municata la notizia che Liliana Balducci è stata uc-cisa nel suo appartamento (MT 61). Ingravallo,sconvolto, assume la direzione del duplice caso. Ilcaso Menegazzi sembra essere la chiave del miste-ro: le indagini portano Ingravallo verso i colli Alba-ni dove una vecchia megera, la Zamira, nascondedietro un laboratorio di tintoria, sporche attività diricettatrice e lenona. Al mondo della città, arricchi-tosi illecitamente, ma sterile, incapace di trasmette-re naturalmente questa ricchezza, si contrapponequello della campagna romana, rozzo e violento,egualmente illecito (la Zamira è infatti legata al fur-to dei gioielli) portatore di una fecondità naturaleche ha attratto fatalmente Liliana e ne ha provocatola morte. Nel laboratorio della Zamira, infatti, preci-pitano e si annodano tutti i fili del delitto. Ingraval-lo segue questa pista e sembra vicino allo sciogli-mento dell’ingarbugliato caso: il cerchio intorno al-la vita di Liliana si stringe sempre più. Viene inter-rogata l’ultima domestica di casa Balducci, l’Assun-tina, che nega con forza l’infamante accusa. Ma ilromanzo si interrompe bruscamente.
La struttura. La struttura del libro è bipartita: a unaprima parte decisamente realistica e canonicamen-te saldata su una trama gialla che si potrebbe defi-nire «da manuale», segue una seconda parte – diquattro capitoli – che innalza il grado di deforma-zione della trama e della scrittura, come se il mec-canismo romanzesco si fosse inceppato e non con-tenesse più la forza narrativa dentro i solidi binaridel genere prescelto e finisse così per esplodere,perdendosi in una miriade di rivoli e digressioni.
Le digressioni ‘antinarrative’. È proprio questa laparte più innovativa del romanzo e che non soffreaffatto, quanto a un giudizio di valore, dell’essereancora inevitabilmente inconclusa. Le digressioni‘antinarrative’ aumentano le risonanze, anche tragi-che, del racconto, ma si offrono al lettore comestraordinari «disfrenamenti» della fantasia gaddiana,piccoli capolavori del suo maturo plurilinguismo.Così si hanno, ad esempio, brani celebri come ladivagazione sugli alluci dei Santi Pietro e Paolo,oppure il sogno del brigadiere che insegue, in unamirabolante catena di associazioni mentali, il topa-zio-refurtiva divenuto topo-topaccio-giallazio ecc.Nella tensione continua tra l’ordine e il disordine diuna trama che sembra perdere progressivamente il
244
suo centro, Gadda finirà per accettare il disordine,prova di una «disarmonia prestabilita» (secondo laformula di Gian Carlo Roscioni) che può solo esse-re registrata.
Il finale incompiuto. L’incompiutezza del romanzoappare tanto più significativa e ‘programmatica’ seconsideriamo che Gadda sapeva bene come avreb-be potuto terminare l’indagine di Ingravallo, inquanto la versione cinematografica da lui stessoprogettata tra il 1947 e il 1948 (Il palazzo degli ori),prevedeva la cattura della colpevole dell’omicidio:Virginia, penultima nipote di Liliana, a lei legata daun affetto morboso sconfinante nella follia.
La lingua di «Babylon»
Nel Pasticciaccio Gadda mette in moto la sua mac-china linguistica, ormai perfettamente oliata. Laquantità dei linguaggi aumenta sensibilmente ag-giungendo, alle commistioni già sperimentate, il ro-manesco della folla dei personaggi di contorno, ilmolisano di Ingravallo (ma contaminato con napo-letano e romanesco), il napoletano del dottor Fumi,il veneziano della contessa Menegazzi; tutti ingre-dienti volti a rappresentare, deformandola, la com-posita realtà di Roma-Babylon. Ma il pastiche è tan-to più interessante in quanto è messo in azione sianel dialogo che nella narrazione, con un incremen-to del discorso indiretto libero quale non è possibi-le riscontrare in altre opere gaddiane. Il romanzo,perciò, assume i toni corali delle tragedie greche, ela voce anonima del popolo tende sempre più a sfu-marsi in quella di un commentatore indistinto.
Il dialetto. Se nei testi degli anni Trenta (e poi, piùtardi, nei neorealisti; 84) l’uso del dialetto tendea essere più mimetico che espressionistico, data lavolontà di rappresentare un ambiente storicamen-te e socialmente definito, in Gadda esso diventaespressione autonoma, indipendente dalla classesociale che rappresenta, e si configura sempre piùcome una deformazione artistica fine a se stessa.Non bisogna tuttavia dimenticare che per l’autore ilromanesco è lingua di adozione tardiva, ‘assunta’con una mediazione letteraria (tanto che nel ro-manzo troviamo numerosi termini non più in usoalla fine degli anni Venti), mentre il lombardodell’Adalgisa e della Cognizione è un dialetto checonosce bene e che sente profondamente legato aun uso diretto.
Significato etico dell’operazione linguistica. Un si-gnificato etico si nasconde però – sia pure in formemolto diverse da quelle della denuncia sociale neo-realista – anche nell’operazione di deformazionelinguistica gaddiana. È lo stesso Gadda a svelarlo,nel saggio Fatto personale o quasi (incluso nel 1958in I viaggi la morte), una sorta di dichiarazione dipoetica per il Pasticciaccio: la maccheronea polve-rizza e dissolve nel nulla ogni abuso che d’ogni mo-do e forma e del ragionare e del dire venga fatto,per entro le parole della frode. Tanto, dunque, l’a-borrono i gran lucumoni [comandanti delle cittàetrusche] del nulla: i zelatori d’ogni simulato entu-siasmo. È questa una funzione etica e gnoseologi-ca. Gadda insorge quindi – come postuma vendet-ta – contro il conformismo della politica culturale elinguistica del ventennio, che aveva fatto dell’autar-chia culturale e del mito dell’italianità (consideratoda Gadda sterile monolinguismo, che tradiva anchequei valori nazionali che avevano ispirato la suagiovinezza) una legge inderogabile. Facendo final-mente convivere tutti i registri, gli stili e le maniereche gli erano già proprie, ma che qui sono mirabil-mente fuse tra loro, Gadda dà una delle prove piùalte della sua narrativa.
IL SECONDO NOVECENTODal dopoguerra a oggi
Autori
Ennio Morlotti, Donna che si lava, 1946, olio su tela, Milano, collezione privata.
Carlo Emilio Gadda • Quer pasticciaccio brutto de via Merulana
245
«S’è trovato la signora… la signoraBalducci…»da Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, II
Nell’indagine sul furto in casa Menegazzi, i primi indizi portano a Ma-rino, alle pendici dei colli Albani. Il commissario Ingravallo si preparaad andare sul posto, ma viene bloccato da un carabiniere che lo richia-ma urgentemente in caserma: Liliana Balducci è stata trovata assassi-nata a via Merulana.Ingravallo ci appare in un momento di relativa pausa che precede la ca-tastrofe e tutta la prima parte del brano è costituita dal suo monologo in-teriore. Attraverso di lui ci appare la Roma umbertina del primo dopo-guerra, l’immagine di Mussolini si deforma in un quadro grottesco chesi avvicina ai toni di Eros e Priapo.
Quella mattina, giovedì finarmente! Ingravallo si potè concedere unascappata a Marino. S’era portato appresso Gaudenzio1: poi però mutòidea e al Viminale lo licenziò, raccomandandogli alcuni altri affarucci.Era una giornata meravigliosa: di quelle così splendidamente romaneche perfino uno statale di ottavo grado, ma vicino a zompà ner settimo,be’, puro quello se sente aricicciasse ar core2 un nun socché, un quar-che cosa che rissomija a la felicità. Gli pareva davvero di inalare ambro-sia cor naso, de bevela giù ne li pormoni: un sole dorato sur travertinoo sur peperino3 d’ogni facciata de chiesa, sul colmo d’ogni colonnetta,che già je volaveno intorno le mosche. E poi, lui, s’era già messo in te-sta tutto un programma. A Marino, artro che quel’ambrosia ce sta! a lagrotta der sor Pippo ce steva un bianco4 malvagio: un vigliacchetto dequattr’anni, in certe bottije, che cinque anni prima avrebbe elettrizzato ilministero Facta, se il Facta factorum5 fosse stato in grado de sospettannel’esistenza. Faceva l’effetto del caffè, sui suoi nervi molisani6: e gli por-geva d’altronde tutta la vena, con tutte le sfumature, d’un vino di classe:le testimonianze e i modulati accertamenti linguatico-palatali-faringo-esofagici d’una introduzione dionisiaca7. Con uno o un paro de quelibicchieri in canna, chissà.Nei due giorni precedenti, oltre a tutto il resto – non c’è solo via Meru-lana a sto monno – era stato due volte alla direzione delle tranvie deiCastelli: gli piaceva di trottare un po’ lui, verso le undici, piuttosto cheingarbugliarsi l’anima8 e gli orecchi dei confusi o tentennanti referti diqualche subalterno. Gaudenzio e Pompeo erano indaffarati altrove. «Chivuole vada, chi non vuole mandi». Il numero progressivo e la serie delbiglietto9, il foro alla data, 13, e lo strappo a la fermata, il Torraccio, ave-vano felicemente consentito di stabilire giorno ora vettura d’emissionedel biglietto: nonchè d’interrogare il bigliettaio emittente, convocato al-la direzione col manovratore per la mattina del secondo convegno. AiDue Santi, al Torraccio, a le Frattocchie10, la domenica di primo pome-riggio, era salita una quantità di persone: una folla. Non era loro possi-bile ricordar tutti: qualcuno sì, e indicarono alcuni clienti più ravvisabi-li: non senza contestazioni tra manovratore e bigliettaio e confusioni colgiorno avanti o col dopo. Il bigliettaio, Merlani Alfredo fu Giuseppe,escluse d’aver visto un giovanotto in tuta, nè celeste, nè grigia. «Cor ber-retto sull’occhi?». Nemmeno. «Con una sciarpa ar collo?… Una sciarpa? ».
1. Gaudenzio: è l’agente noto alla mala-vita come er Biondone; insieme a Pompeo,nominato più avanti e detto invece loSgranfia, è un sottoposto di Ingravallo.2. aricicciasse ar core: «rigermogliare il
cuore (prendere nuova vita) »; è termineusato da Belli (Sonetto 2107).3. travertino … peperino: sono i due ma-
teriali impiegati nell’edilizia romana; il tra-vertino è una pietra calcarea, leggera e po-rosa; il peperino è un cemento naturale for-mato di cenere vulcanica ripiena di mica equarzo.4. bianco: «vino bianco»; la zona dei Ca-
stelli Romani è giustamente famosa per isuoi ottimi vini.5. Facta factorum: Luigi Facta (1861-
1930) fu ministro delle Finanze sotto i go-verni Giolitti e divenne presidente del Con-siglio nell’ottobre 1922; le sue incertezzedinanzi allo squadrismo fascista della «mar-cia su Roma» portarono alle dimissioni delGoverno; Facta factorum gioca, ironica-mente, su Sancta sanctorum (letteralmen-te, «le cose santissime»; il penetrale del tem-pio, luogo più vicino all’altare e di accessoriservato), e allude alla perfetta integrazio-ne di Facta nello stato fascista (nel 1924Mussolini lo nominò senatore a vita).6. nervi molisani: Francesco Ingravallo è
di origine molisana, come attestano le bat-tute pronunciate poco oltre (succedenno;mo me ne jevo a spasso).7. le testimonianze … dionisiaca: le pro-
ve dell’eccellenza del vino fornite da lin-gua, palato, faringe, esofago (con un co-strutto aggettivale giustappositivo, tipolo-gia cara a Gadda). Dioniso (o Bacco) è,nella mitologia classica, il dio del vino.8. ingarbugliarsi l’anima: «tormentarsi»; il
verbo ha valore ‘programmatico’ (così comeil sostantivo da cui deriva, garbuglio).9. Il numero … del biglietto: una delle pi-
ste seguite da Ingravallo per il furto in casaMenegazzi – quella che lo porta verso Ma-rino – è un biglietto dell’autobus timbratoin data 13 marzo.10. Due Santi … Frattocchie: sono tuttefermate dell’autobus lungo la linea cheporta verso i colli Albani.
11. j’inturcinava: gli avvolgeva, gli copriva.12. barbozzo: «bazza, mento», termine ro-manesco usato anche da Belli (Sonetti 446,931, 2056).13. septimonzio: «i sette colli di Roma», ita-lianizzazione del latino septimontium, cheindicava la cinta dei sette colli di Roma el’omonima festa, che si celebrava l’11 di-cembre.14. dell’era dell’egira: espressione ironicache designa gli esponenti dell’era fascista;egira, letteralmente «fuga», indica l’abban-dono della Mecca da parte di Maometto,diretto verso Medina, nel settembre 622,data d’inizio della cronologia islamica.15. l’arti … fezzeria: gli «alti esponentidella gerarchia fascista» che indossavano ilfez, il tipico copricapo a tronco di cono dicolore rosso (da cui papaveri) con unanappa nera. Gadda gioca a incrociare traloro più riferimenti; il fez è infatti, origina-riamente, un copricabo arabo (e, in quantotale, appartiene allo stesso ambito dellaprecedente egira). In fezzeria, peraltro, èevidente il gioco parafonico e paronoma-stico con fesseria, ‘attributo’ in Gadda ca-ratteristico del fascismo (lo stesso Mussoli-ni è chiamato Predappiofesso).16. o se faceveno … piazza: «o stavano ariposo, come tanti accattoni di piazza, alCollegio Romano», di fronte a Santo Stefa-no del Cacco (dove si trova il commissaria-to); strucchioni è termine romanesco usatoda Belli (Sonetti 11 e 2212).17. riversati … piroscafo: i politici irakeni evenezuelani fatti sbarcare (lo scalandrone èla passerella mobile che si dispone tra il mo-lo e la nave per l’imbarco e sbarco dei pas-seggeri) sul molo del porto di Napoli. L’ag-gettivo roco, riferito al piroscafo, allude forseal rumore della sirena all’ingresso nel porto.18. dopo … de novizzio: siamo nel marzodel 1927, a un anno e mezzo dall’emana-zione delle leggi «fascistissime» del novem-bre 1926 (dette «norme per la difesa delloStato») che, con l’abolizione della libertà distampa e la soppressione di ogni plurali-smo, decretarono l’instaurazione della dit-tatura.19. Testa … tight: Mussolini (in uno degliepiteti gaddiani meno violenti) in giaccalunga fino al ginocchio e aperta dietro(stiffelius o redingote), oppure in abito dacerimonia (tight).20. rampazzi: «grappoli», termine romane-sco usato da Belli (Sonetti 185, 335).21. radiosi destini: Gadda allude, antifra-sticamente, alle future sconfitte, usandoun’espressione canonica della propagandafascista.22. Margherita … abbandonata: Marghe-rita Sarfatti (1882-1961), attiva sostenitricedi Mussolini (promosse il movimento arti-stico di stampo classicista «Novecento» efondò la rivista culturale fascista «Gerar-
chia») e sua intima amica; nel 1926 avevaappena pubblicato una fortunata biografiadel Duce (Dux). Dopo un periodo di fortu-nato sodalizio con Mussolini, venne allon-tanata e infine costretta, per le sue originiebree, a espatriare in Francia e poi in Ame-rica. La ninfa Egeria è, nella mitologia ro-mana, sposa e consigliera del re NumaPompilio. Didone è la regina cartagineseamata e abbandonata da Enea.23. Vacava: «partecipava, si dedicava»; lati-nismo derivato dal verbo vacare, «averetempo libero per dedicarsi a» (con dativo).24. feluca: il cappello a due punte dell’altauniforme degli ufficiali, degli accademici edei diplomatici.25. eredoluetico … in proprio: «con sifilideereditaria, oltre che contratta direttamente».L’aggettivo luetico designa colui che è af-
fetto da lue (sinonimo di sifilide). Inizia quila pesante requisitoria contro Mussolini,che – forte del precedente di Eros e Priapo– sfrutta immagini a sfondo sessuale e unlinguaggio – antifrasticamente e parodica-mente – elevato, spesso tecnico-medico.26. acromegàlico: «affetto da acromegalia»;si tratta di una malattia endocrina (propria-mente una disfunzione della ghiandola ipo-fisi) che causa ipertrofia (cioè sviluppo ab-norme) della faccia, delle mani e dei piedi.27. invulvarselo: «fagocitarlo, inglobarlo»,con riferimento sessuale. La popolazionefemminile ‘invaghita’ di Mussolini non de-sidera altro – in un’ottica sulla quale Gaddaproietta tutta la propria vena misogina –che ‘fagocitarlo’, usarlo come oggetto ses-suale. Il verbo invulvare compare già inGovoni.
246
Sì… questo sì… «Una specie de sciarpa o de fazzolettone de lana ver-de?…». Sì, sì. «Verde come l’erba nera». S’accalorò nella conferma. Loaveva colpito il fatto, ner daje er bijetto, che la sciarpa j’inturcinava11
mezza faccia, al cliente: «ciaveva er barbozzo12 drento», come facessechissà che freddo, il 13 di marzo, al Torraccio. No, non aveva berretto. Atesta scoperta, sì: però a capo chino senza guardare in faccia: un zazze-rone tutto scarruffato, e niente artro. Non lo conosceva affatto. No, for-se non lo avrebbe nemmeno ravvisato. E fu tutto.Erano dunque le undici. Il dottor Ingravallo stava per salire sul tram, al-l’angolo di via D’Azeglio. Le poche macchine a disposizione della poli-zia vagavano raminghe pel septimonzio13, o impegnate a foro o a ter-razza, o ar Pincio o ar Giannicolo, così: magari pe portacce a spassoqueli signori, dell’era dell’egira14, l’arti papaveri de la fezzeria15: o se fa-ceveno una pennichella, ar Colleggio Romano, come tanti strucchionide piazza16, però pronte pe daje er giro puro a loro, nun se sa mai. C’e-ra di gran visite di plenipotenziari dell’Irak e di capi di stato maggioredel Venezuela, in quei giorni, un andirivieni de gente piena de patac-che: riversati a branchi sul molo Beverello dagli scalandroni d’ogni piùroco piroscafo17.Ereno i primi boati, i primi sussulti, a palazzo, dopo un anno e mezzo denovizzio18, del Testa di Morto in stiffelius, o in tight19: ereno già l’occhia-tacce, er vommito de li gnocchi: l’epoca de la bombetta, de le ghette co-lor tortora stava se po dì pe conclude: co quele braccette corte corte derospo, e queli dieci detoni che je cascaveno su li fianchi come du ram-pazzi20 de banane, come a un negro co li guanti. I radiosi destini21 nonavevano avuto campo a manifestarsi, come di poi accadde, in tutto il lo-ro splendore. La Margherita, di ninfa Egeria scaduta a Didone abbando-nata22, varava ancora il Novecento, el noeufcènt, l’incùbo dei milanesi diallora. Vacava23 alle mostre, ai lanci, agli oli, agli acquerelli, agli schizzi,quanto può vacarci una gentile Margherita. Lui s’era provato in capo lafeluca24, cinque feluche. Gli andavano a pennello. Gli occhi spiritati del-l’eredoluetico oltrechè luetico in proprio25, le mandibole da sterratoreanalfabeta del rachitoide acromegàlico26 riempivano di già l’Italia Illu-strata: già principiavano invaghirsene, appena untate de cresima, tuttele Marie Barbise d’Italia, già principiavano invulvarselo27, appena disce-se d’altare, tutte le Magde, le Milene, le Filomene d’Italia: in vel bianco,
IL SECONDO NOVECENTODal dopoguerra a oggi
Autori
28. redimite di zàgara: «incoronate di fiorid’arancio (o di limone)»; redimite latinismo(dal participio-aggettivo redimitus, «cinto,incoronato»). La zagara è, propriamente, ilfiore degli agrumi.29. nartece: nelle basiliche paleocristiane,il nartece è una zona separata dal resto del-l’edificio religioso (una sorta di vestibolo,antistante l’ingresso), destinata ad acco-gliere catecumeni o penitenti. Qui il termi-ne è sineddoche per «chiesa». 30. manganello: lo strumento della violen-za squadrista ha qui una connotazioneesplicitamente sessuale.31. Maiano … Cernobbio: Maiano è uncentro a nord di Firenze, sotto Fiesole,mentre Cernobbio è sulla riva occidentaledel lago di Como.32. si strangullavano: si ingozzavano.
33. itecaquani: forse «abitanti di Itaqui»che è una piccola città situata al confine traArgentina e Brasile, quindi, per estensione,«sudamericani».34. un sol micolo: «una sola briciola», to-scanismo.35. cable: «cablogramma», telegramma tra-smesso mediante cavi sottomarini.36. desde … pionieri: «dall’Italia, sullastampa degli emigranti», in spagnolo; du-rante il suo soggiorno in Argentina, Gaddaaveva preso contatti con nuclei fascisti del-la comunità italiana, e aveva anche colla-borato ad alcuni giornali locali.37. Quell’uomo … d’Italia: la frase è rical-cata sulla famosa affermazione di Pio XI,che sottoscrisse i Patti Lateranensi conMussolini e parlò di lui come «l’uomo dellaProvvidenza».
38. desde … Italia: «dalla medesima Italia»,in spagnolo.39. Balilli: Balilla è il soprannome del ra-gazzo che si diceva avesse dato l’avvio, nel1746, alla rivolta dei genovesi contro l’Au-stria. In epoca fascista, Balilla divenne sim-bolo dell’‘eroica’ e ‘patriottica’ gioventù fa-scista.40. a ghindarsi: «per salire, issarsi»; ghin-dare è termine marinaresco che significa«issare (le vele)»; non è privo di rilievo, inquesto contesto, il fatto che il verbo derividallo spagnolo (ghindar, «alzare»). 41. Porchettini: è Pompeo, l’altro agentesottoposto a Ingravallo.42. mo … a spasso: adesso me ne stavo an-dando a spasso.43. ipotiposi … interrogativa: l’ipotiposi èquella figura retorica consistente nella descri-zione vivace, fortemente rappresentativa, diun avvenimento o di un oggetto. Gli Apulierano, anticamente, gli abitanti della Puglia.
Carlo Emilio Gadda • Quer pasticciaccio brutto de via Merulana
247
redimite di zàgara28, fotografate dal fotografo all’uscire dal nartece29, so-gnando fasti e roteanti prodezze del manganello30 educatore. Le dame,a Maiano o a Cernobbio31, già si strangullavano32 ne’ su’ singhiozzi ve-nerei all’indirizzo der potenziatore d’Italia. Giornalisti itecaquani33 lo an-davano intervistare a palazzo Chigi, le sue rare opinioni, ghiotti ghiotti,le annotavano in un’agendina presto presto, da non lasciarne addietroun sol micolo34. Le opinioni del mascelluto valicavano l’oceano, la mat-tina a le otto ereno già un cable35, desde Italia, su la prensa dei pionie-ri36, dei venditori di vermut. «La flotta ha occupato Corfù! Quell’uomo èla provvidenza d’Italia37». La mattina dopo er controcazzo: desde la mi-sma Italia38. Pive ner sacco. E le Magdalene, dài: a preparar Balilli39 a lapatria. Le macchine de la questura «stazzionaveno»: ar Collegio Romano.Ereno le undici der dicissette marzo e il dottor Ingravallo, a via D’Aze-glio, aveva già un piede sur predellino e teneva già con la man destra, aghindarsi40 in tramme, il poggiamano di ottone. Quando il Porchettini41
trafelato gli sopravvenne: «Dottor Ingravallo! dottor Ingravallo!».«Che vòi? Che te sta succedenno?».«Dottor Ingravallo, senta. Me manna er commissario capo», abbassò an-cora la voce: «a via Merulana… è successo un orrore… stamattina presto.Hanno telefonato ch’ereno le dieci e mezza. Lei era appena uscito. Il dot-tor Fumi lo cercava. Tratanto m’ha mannato subbito a vede, co due agen-ti. Credevo quasi de trovallo là… Poi ha mannato a casa sua a cercallo».«Be’, che è stato?».«Lei ce lo sa già?».«C’aggia sapé? mo me ne jevo a spasso42…».«Hanno tajato la gola, ma scusi… so che lei è un po’ parente».«Parente ’e chi?… » fece Ingravallo accigliandosi, come a voler respinge-re ogni propinquità con chi si fosse.«Volevo dire, amico».«Amico, che amico! amico ’e chi?». Raccolte a tulipano le cinque dita del-la mano destra, altalenò quel fiore nella ipotiposi digito-interrogativa43
tanto in uso presso gli Apuli.«S’è trovato la signora… la signora Balducci…».«La signora Balducci?». Ingravallo impallidì, afferrò Pompeo per il brac-cio. «Tu sei pazzo!» e glielo strinse forte, che a lo Sgranfia parve glielostritolasse una morsa, d’una qualche macchina.
248
«Sor dottò, l’ha trovata suo cugino, il dottor Vallarena… Valdassena44.Hanno telefonato subbito in questura. Mo è là puro lui, a via Merulana.Ho dato disposizzioni. Mi ha detto che lo conosce. Dice», alzò le spalle,«dice ch’era annato a trovalla. Pe salutalla, perchè ha d’annà a Genova.Salutalla a quell’ora? dico io. Dice che l’ha trovata stesa a terra, in un la-go de sangue, Madonna! dove l’avemo trovata puro noi, sul parquet, incamera da pranzo: stesa de traverso co le sottane tirate su, come chi di-cesse in mutanne. Il capo rigirato un tantino… Co la gola tutta segata,tutta tajata da una parte. Ma vedesse che tajo, dottò!». Congiunse le ma-ni come implorando, si passò la destra sulla fronte: «E che faccia! ch’amomenti svengo! Già fra poco dovrà vedello. Un tajo! che manco er ma-cellaro. Mbè, un orrore: du occhi! che guardaveno fisso fisso la creden-za. Una faccia stirata, stirata, bianca da parè un panno risciacquato…che, era tisica?… come si avesse fatto una gran fatica a morì…».Ingravallo, pallido, emise un mugolo strano, un sospiro o un lamento daferito. Come se sentisse male puro lui. Un cinghiale co una palla in corpo.«La signora Balducci, Liliana… » balbettò, guardando negli occhi loSgranfia. Si tolse il cappello. Sulla fronte, in margine al nero cresputo deicapelli, un allinearsi di gocciole: d’un sudore improvviso. Come un dia-dema di terrore, di dolore. Il volto, per solito olivastro-bianco, lo avevainfarinato l’angoscia. «Andiamo, va’!». Era madido, pareva esausto.Giunti a via Merulana, la folla. Davanti il portone il nero della folla, conla sua corona di rote de bicicletta. «Fate passare, polizia». Ognuno si sco-stò. Er portone era chiuso. Piantonava un agente: con due pizzardoni45
e due carabinieri. Le donne li interrogavano: loro diceveno a le donne:«Fate largo!». Le donne voleveno sapè. Tre o quattro, deggià, se sentì cheparlaveno de nummeri: ereno d’accordo p’er dicissette, ma discutevenosur tredici46.I due salirono in casa Balducci, l’ospitale casa che Ingravallo conosceva,si può dire, col cuore. Su le scale un parlottare di ombre, il susurro del-le casigliane47. Un bimbo piangeva. In anticamera… nulla di particolar-mente notevole (il solito odore di cera, l’ordine abituale) eccettochè dueagenti, muti, attendevano disposizioni. Sopra una seggiola un giovanecol capo tra le mani. Si alzò. Era il dottor Valdarena. Apparve poi la por-tiera, emerse, cupa e cicciosa, dall’ombra del corridoio. Nulla di notevo-le si sarebbe detto: entrati appena in camera da pranzo, sul parquet, trala tavola e la credenza piccola, a terra… quella cosa orribile. […]
IL SECONDO NOVECENTODal dopoguerra a oggi
Autori
44. suo cugino … Valdassena: è GiulianoValdarena, il principale indiziato nella pri-ma fase delle indagini.45. pizzardoni: «vigili urbani», termine dia-lettale del centro Italia.46. ereno … tredici: sono i numeri da gio-care al lotto il giorno dopo. La scena quidescritta ricalca quella che aveva fatto dacornice ai primi accertamenti seguiti al fur-to in casa della contessa Menegazzi.47. casigliane: «inquiline», toscanismo.
Analisi del testo
LA STRUTTURA DI UN «GIALLO»
L’inizio del secondo capitolo presenta le caratteri-stiche tipiche del genere «giallo»: una lunga pre-messa incentrata su Ingravallo e scissa dalla narra-zione vera e propria, in cui tutto il racconto è costi-tuito dalle riflessioni del protagonista (espresse in
discorso indiretto libero). Essa crea una sospensio-ne degli eventi che contrasta violentemente conl’accelerazione successiva, dall’incontro con Pom-peo in poi. Seguono altre due sezioni: la ricapitola-zione dello Sgranfia al commissario – che anticipagli eventi al lettore, ma li distanzia nel referto stra-niante dell’agente – e il racconto vero e proprio. La
Carlo Emilio Gadda • Quer pasticciaccio brutto de via Merulana
249
costruzione del capitolo è calibratissima e sapien-te, tutta volta a graduare emozioni e informazioniperché maggiore sia l’effetto-sorpresa dell’omici-dio (il lettore lo vive insieme al protagonista, con unprocesso di identificazione totale).
LA SOSPENSIONE DEGLI EVENTI
La sospensione temporale della prima parte creaun effetto di straniamento che consente alla notiziadell’omicidio di risaltare con il massimo impattoemotivo. Tutti i periodi sono introdotti o contengo-no determinazioni di tempo. A un inizio di tipo ca-nonico (Quella mattina, giovedì) seguono una ge-nerica notazione meteorologica (Era una giornatameravigliosa), subito deformata dall’iperbole (cheperfino uno statale…), una ricapitolazione dell’in-dagine già svolta da Ingravallo per aggiornare illettore (Nei due giorni precedenti) e una digres-sione sulla confusione cittadina (Erano dunque leundici) amplificata nella tirata antimussoliniana(Ereno i primi boati […] dopo un anno e mezzo denovizzio). La riflessione di Ingravallo ha l’effetto disospendere il tempo stesso, tanto che l’autore, do-po quasi una pagina può affermare nuovamente:Ereno le undici der dicissette marzo, come se il mo-nologo del commissario si fosse svolto in una di-mensione atemporale.
L’ACCELERAZIONE DEL RITMO NARRATIVO
La seconda parte del brano ribalta la situazione edaccelera i tempi narrativi. Il pathos è altissimo, an-che perché il lettore che ha seguito Ingravallo pertutta la prima parte, è completamente all’oscuro,come lui, di ciò che accadrà e la notizia giunge ina-spettata. Inoltre conosce i sentimenti del commissa-rio per Liliana, cosa che aumenta il coinvolgimento.Il racconto di Pompeo è prolettico, la descrizionedel cadavere solo accennata, con un ulteriore effet-to di suspense, perché si capisce che Ingravallo do-vrà recarsi di persona sul luogo del delitto e si co-nosce la sua angoscia.
IL ‘PRECIPITARE’ FINALE
Nella terza parte il racconto procede con cautela ecircospezione, con frasi brevi e pausate, con unaprogressiva acquisizione di porzioni di realtà: lescale con le inquiline, il pianto del bimbo, l’immagi-ne del cugino disperato in anticamera, e infine lacamera da pranzo, con la scena raccapriccianteche meriterà poi una lunga e tremenda descrizio-ne. Il narratore condivide con Ingravallo lo stato didolore, come se sentisse male puro lui. Il corpo del-la donna, ora, non può nemmeno essere nominato:diventa infatti quella cosa orribile.
Proposte operative
Analisi
Evidenzia la struttura del passo: quale tecnica individui? Quali ‘fasi’ nella narrazione?Quale significato hanno i riferimenti al contesto storico?Da chi viene raccontato il delitto? Come giustifichi questa scelta?Individua nel passo i luoghi di ‘divaricazione stilistica’.4
3
2
1
250
IL SECONDO NOVECENTODal dopoguerra a oggi
Autori
Testi: l’edizione completa delle Opere di Carlo Emilio Gad-da, diretta e curata da D. Isella, coadiuvato da diversi colla-boratori, è stata pubblicata da Garzanti in cinque volumi. Iprimi due, usciti rispettivamente nel 1988 (a cura di G. Luc-chini, E. Manzotti e R. Rodondi), e nel 1989 (a cura di D. Isel-la, G. Pinotti e R. Rodondi) raccolgono tutti i Romanzi e rac-conti (La Madonna dei Filosofi, Il castello di Udine, L’Adalgisa,La cognizione del dolore nel primo volume; Quer pasticciac-cio brutto de via Merulana edizione del 1957 e redazione di«Letteratura», 1946-47; La meccanica, Accoppiamenti giudi-ziosi, Racconti dispersi, Racconti incompiuti nel secondo); ilterzo e il quarto – usciti rispettivamente nel 1991 (a cura diD. Isella, C. Martignoni, L. Orlando) e nel 1992 (a cura di G.Gaspari, G. Gavazzeni, D. Isella, G. Pinotti, M.A. Terzoli, C.Vela) – riuniscono Saggi giornali favole e altri scritti, ovvero laproduzione saggistica, i diari di guerra e di prigionia e le fa-vole del periodo fiorentino (Le meraviglie d’Italia, Gli anni,Verso la Certosa, I viaggi la morte e gli Scritti dispersi nel ter-zo volume; Giornale di guerra e di prigionia, Il primo librodelle Favole, I Luigi di Francia, Eros e Priapo, Il guerriero, l’a-mazzone e lo spirito della poesia nel verso immortale del Fo-scolo nel quarto). L’ultimo volume – uscito nel 1993 (a cura diD. Isella, P. Italia, G. Pinotti, A. Silvestri, C.Vela) – offre gli Scrit-ti vari e postumi e precisamente le Pagine di divulgazionetecnica, il Racconto italiano di ignoto del Novecento, la Medi-tazione milanese, I miti del somaro, Il palazzo degli ori, Gon-nella buffone e le traduzioni.Di grandissima utilità sono la bibliografia gaddiana curatada D. Isella e preposta al primo volume e gli Indici dei nomie analitico (a cura di G. Lucchini e L. Orlando) allegati alquinto, che permettono di orientarsi nella selva delle edizio-ni e riedizioni gaddiane e di utilizzare agevolmente i cinquevolumi predetti.Della Cognizione del dolore esiste anche un’eccellente edi-zione critica e commentata a cura di E. Manzotti, Einaudi,To-rino 1987. Ricca di note è anche l’edizione Mondadori(«Oscar oro», Milano 1990) del Primo libro delle Favole, cu-rata da C.Vela.Tra le raccolte più interessanti dell’epistolario ricordiamo Let-tere agli amici milanesi (Il Saggiatore, Milano 1983); L’ingegnerfantasia.Lettere a Ugo Betti,1919-1930 (Rizzoli,Milano 1984); leLettere alla sorella,1912-1924 (Archinto, Milano 1987); le Lette-re a Gianfranco Contini a cura del destinatario,1934-1967 (Gar-zanti, Milano 1988) e le Confessioni di Carlo Emilio Gadda, incui sono raccolte dal cugino scrittore Piero Gadda Conti alcu-ne lettere a lui indirizzate (Pan Libri, Milano 1974).I testi antologizzati sono tratti rispettivamente da La Madon-na dei Filosofi, Garzanti, Milano 1989, da La cognizione deldolore, edizione critica a cura di E. Manzotti e da Quer pa-
sticciaccio brutto de via Merulana, edizione curata da G. Pi-notti, pubblicata nelle Opere, II, cit.
Critica: una biografia degli anni giovanili di Gadda è statapubblicata da Mondadori nel 1997, a cura di G.C. Roscioni;si tratta della documentazione più completa che possedia-mo finora sulla tormentata vita dell’ingegnere.Nella sterminata letteratura critica su Gadda segnaliamo soloalcuni testi particolarmente utili all’inquadramento generaledell’opera. Le prose critiche di G. Contini sono state raccolteda Einaudi nel 1989 in Quarant’anni di amicizia.Scritti su CarloEmilio Gadda (1934-1988), mentre lo studio a tutt’oggi ancorainsuperato per acutezza d’analisi e originalità di interpretazio-ne è La disarmonia prestabilita di G.C. Roscioni pubblicato daEinaudi nel 1969 e riedito nel 1975 e nel 1995 con interessantigiunte, che fornisce una chiave di lettura dell’opera gaddianaattraverso il quadro gnoseologico emergente dagli scritti edalle pagine della Meditazione milanese. Un quadro esaurien-te della formazione filosofica gaddiana è presente anche nelvolume di G. Lucchini, L’istinto della combinazione. Le originidel romanzo in Carlo Emilio Gadda, La Nuova Italia, Firenze1986 e, in chiave genettiana,nel recente Gadda filosofo milane-se di Giulio de Jorio Frisari, Palomar, Bari 1996.Un’originale lettura del Pasticciaccio viene fornita da C. Bene-detti in Una trappola di parole.Lettura del «Pasticciaccio»,ETS,Pi-sa 1980; si segnala anche l’interpretazione di V.Amoruso, Lettu-ra psicoanalitica del «Pasticciaccio», il Mulino,Bologna 1995.Tra le monografie ricordiamo G. Baldi, Carlo Emilio Gadda(Mursia, Milano 19822) e gli utili Per leggere Carlo EmilioGadda di E. Melfi (Bonacci, Roma 1986), Ritratto di Gadda diG.C. Ferretti (Laterza, Roma-Bari 1987), gli Studi e testi gad-diani di A. Andreini, Sellerio, Palermo 1988 e l’utile capitoloin Lombardia, a cura di A. Stella, C. Repossi e F. Pusterla(«Letteratura delle Regioni d’Italia. Storia e Testi»), EditriceLa Scuola, Brescia 1990.Un profilo complessivo è quello di E. Manzotti, Carlo EmilioGadda, in Storia della letteratura italiana, diretta da E. Malato,IX, Il Novecento, Salerno editrice, Roma 2000.Dal 2001 esce, curata da D. Isella, per la casa editrice Ric-ciardi, la rivista annuale «I quaderni dell’ingegnere: testi estudi gaddiani».Sul ‘barocco’: R.S. Dombroski, Gadda e il barocco, trad. di A.Dicuonzo, Bollati Boringhieri, Torino 2002.Grande attenzione alla prosa gaddiana è stata riservata an-che da acuti interpreti stranieri, fra cui H.M. Enzesberger, In-troduzione alla traduzione tedesca della Cognizione del do-lore, München 1963, e R.S. Dombrowski, Introduzione allostudio di Carlo Emilio Gadda,Vallecchi, Firenze 1975, a con-ferma della statura ‘europea’ dello scrittore.
Bibliografia
407
Autori
Giuseppe Tomasi di Lampedusa
La vita e le opere
I primi anni. Giuseppe Tomasi di Lampedusa nascea Palermo nel 1896, figlio unico di una famiglia diantica nobiltà (al titolo di Principe di Lampedusaunisce anche quello di Duca di Palma) e trascorregran parte dell’infanzia nella città natale. Dopo lapartecipazione alla prima guerra mondiale intra-prende la carriera militare (si dimetterà però nel1925, in seguito all’instaurarsi del regime fascista);si iscrive all’università, prima a Torino, poi a Geno-va, dove si laurea in giurisprudenza. Libero dapreoccupazioni economiche grazie al cospicuo pa-trimonio familiare, si divide poi tra la passione peri viaggi e la letteratura, rimanendo comunque sem-pre isolato rispetto alla cultura ufficiale.
Le collaborazioni editoriali e la guerra.Tra il 1926 eil ’27 pubblica alcuni articoli di argomento storico eletterario; allo stesso periodo risale il matrimoniocon Alessandra Wolff-Stomersee. Con lo scoppiodella guerra è richiamato alle armi. Nel 1943 in se-guito ai bombardamenti americani il palazzo deiLampedusa viene completamente distrutto: né l’e-sperienza bellica, né quella drammatica della pri-gionia sono così profondamente sentite dallo scrit-tore come la scomparsa della casa di famiglia, ri-cordata due volte nella sua produzione letteraria(nel Gattopardo e nel racconto Lighea) e protago-nista, insieme alla residenza estiva nelle campagnedi Santa Margherita Belice, del frammento autobio-grafico Luoghi della mia prima infanzia.Gli anni del dopoguerra sono infatti dedicati a unprimo tentativo di ricostruzione, rivelatosi impossi-
bile, e all’acquisto di un palazzo un tempo pro-prietà del bisnonno Giulio (a cui è ispirato il pro-tagonista del Gattopardo), ove l’autore trascorreràpoi tutta la vita.
Le lezioni palermitane e il contatto con il mondoletterario. Nel 1954 Tomasi tiene a Palermo unaserie di lezioni di letteratura francese e inglese auna ristretta cerchia di giovani palermitani, fra cuiGioacchino Lanza (Tomasi), che più tardi diverràsuo figlio adottivo. In tali corsi, pubblicati solo direcente, si rivela critico acuto e originale, in gradodi padroneggiare i più vasti settori della letteratu-ra straniera che ha sempre coltivato. L’attività culturale palermitana, per quanto im-portante, si svolge nel più assoluto anonimato, al-meno nei confronti degli ambienti letterari, ri-spetto ai quali lo scrittore si mantiene sempre inuna posizione appartata, tra l’isolamento e l’indif-ferenza. Il primo vero contatto con il mondo cul-turale ha luogo solo nel 1954, quando, in veste diaccompagnatore del cugino Lucio Piccolo, vinci-tore di un premio letterario, Tomasi si reca a SanPellegrino dove sono convenuti i principali scrit-tori italiani.
Il Gattopardo e i racconti. Secondo le testimonianzedegli allievi ammessi alle sue lezioni, proprio dopoil 1955 Tomasi comincia a scrivere Il Gattopardo,sviluppando un progetto narrativo (la giornata diun principe siciliano all’epoca dell’impresa dei Mil-le) ideato quasi vent’anni prima. Nel giugno dellostesso anno la sua vena scrittoria (pur senza velleitàartistiche) si è concretizzata nei Ricordi d’infanzia,trovando un ideale contenitore nel genere memo-rialistico-autobiografico.
408
IL SECONDO NOVECENTODal dopoguerra a oggi
Autori
La destinazione esclusivamente privata dello scrittone caratterizza l’impianto strutturale e lo stile: i ri-cordi sollecitati dai luoghi ove ha trascorso l’infan-zia, confluiscono l’uno nell’altro senza soluzione dicontinuità, obbedendo più al desiderio di fissaresulla carta ciò che è ancora ben vivo nella memoria,che a una precisa esigenza narrativa, che prenderàpoi corpo e più salda struttura nel Gattopardo.Il secondo racconto, intitolato redazionalmente Ilmattino di un mezzadro, fa invece parte, almenoinizialmente, di un progetto di più vasta portata:dovrebbe essere il capitolo iniziale dei Gattini cie-chi, continuazione del romanzo, vero centro pro-pulsore della sua attività narrativa. Se Il Gattopardoha celebrato la caduta della vecchia aristocrazia si-ciliana, il nuovo libro dovrebbe delineare l’ascesadella nuova classe, la borghesia terriera, rappresen-tata dalla famiglia Ibba. La commossa partecipazio-ne con cui Tomasi ha narrato le vicende di Don Fa-brizio, principe di Salina, viene qui ribaltata in luci-da e a volte ironica osservazione di una realtà chenon gli appartiene, semplice testimone dell’affer-mazione di una nuova mentalità, rozza e materiali-stica, quanto quella di Don Fabrizio aveva teso adessere nobile e raffinata.Per quanto costretto nella limitante categoria degli«incompiuti», il racconto svolge con abilità e ironiaun tema che avrebbe avuto forse sviluppo autono-mo, se la breve stagione di narratore avesse potutoproseguire. Tomasi di Lampedusa muore infatti aRoma nel 1957.
Un intellettuale anomaloPrima dell’esplosione del «caso Gattopardo», il suoautore, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, morto pochigiorni dopo avere ricevuto il rifiuto di Vittorini allapubblicazione del romanzo presso Mondadori, erasconosciuto al mondo letterario. Il Gattopardo saràinfatti pubblicato postumo, nel 1958, a cura di Gior-gio Bassani nella collana «I contemporanei» di Feltri-nelli, con un enorme successo; la sua fortuna edito-riale e il dibattito ideologico che immediatamente se-gue portano alla ribalta uno dei più acuti e anomaliintellettuali del Novecento italiano, scrittore – già inetà avanzata – di un solo, fondamentale, libro.
La produzione saggistica: una poetica stendhaliana.Le lezioni tenute agli allievi palermitani sono stateanch’esse raccolte e pubblicate postume. La lettera-
tura francese e inglese è esclusiva protagonista diqueste pagine, nelle quali vengono messi a con-fronto Stendhal e Joyce, T.S. Eliot e Virginia Woolf,la poesia di John Donne, William Blake, SamuelTaylor Coleridge e William Butler Yeats. Particolar-mente interessante è il corso dedicato a Stendhal, incui si possono cogliere i fondamenti della poeticatomasiana, teorizzata guardando allo stile del gran-de autore francese come insuperato e insuperabilemodello.Elemento essenziale è costituito dalla distinzioneche Tomasi opera tra scrittori espliciti e impliciti: lapartecipazione emotiva dei primi è condannata afavore del distacco e dell’oggettivazione narrativadei secondi, che non cedono alla tentazione dispiegare tutti i passaggi, anche psicologici, lascian-do al lettore la fatica o il gusto di ricavarli dal testo.In realtà, mentre tende a un linguaggio scarno –corrente – essenziale, limando il testo alla ricercadell’implicito, egli spesso tradisce nella pagina leproprie affermazioni, rivelandosi ben più esplicitodi quanto non voglia sembrare.Sarebbe quindi un grosso errore cercare di leggerela sua opera come un’esemplificazione concretadella poetica contenuta nelle lezioni palermitane,pena lo stravolgimento di una scrittura che costan-temente smentisce le regole enunciate ( 407).
Il GattopardoTra il romanzo storico e il modello joyciano. Secon-
do la testimonianza della moglie di Tomasi, l’ideaoriginaria da cui si sviluppa Il Gattopardo aveva giàpreso corpo diciotto anni prima della sua effettivastesura, e solo problemi materiali (la guerra e la ri-costruzione del palazzo di famiglia) avrebbero trat-tenuto l’autore dal metterla in pratica. Alla fine del1956, però, il romanzo è terminato, affidato a unquadernone manoscritto poi andato distrutto.Forse non tutti i suoi detrattori – condannandolocome tardo epigono del «romanzo storico», mal in-quadrabile nelle nuove tendenze dell’avanguardialetteraria – hanno tenuto sufficientemente contodelle affermazioni di Tomasi sulle proprie velleitàletterarie. A Gioacchino Lanza egli aveva infatti di-chiarato: saranno 24 ore della vita del mio bisnonnoil giorno dello sbarco di Garibaldi, lasciando intrave-dere in filigrana l’ambizioso modello da cui il pro-getto era partito: l’Ulisse di Joyce. Anche se la suc-cessiva stesura coincide con un radicale mutamento
Giuseppe Tomasi di Lampedusa • Il Gattopardo
409
dell’impianto narrativo, suddiviso in tre grandi architemporali (non omogenei) – scanditi dalle tre date:1860, 1885 e 1910 –, non si può trascurare la mo-dernità della scelta iniziale, in linea con i contem-poranei sviluppi della letteratura europea.La prima stesura viene dattiloscritta nel 1956 e con-sta di soli quattro capitoli – o, meglio, parti, comeindicato dall’autore –, in quanto le Parti V e VI (levacanze di Padre Pirrone e il ballo a palazzo Pon-teleone), composte per ultime, per ragioni di tem-po non vengono comprese nel dattiloscritto, ma in-serite solo in un secondo momento, in una copiaapprontata a mano da Tomasi come regalo al figlio.
Un caso editoriale e filologico del Novecento. Il ro-manzo (nella versione in quattro parti del dattilo-scritto) viene inviato alle case editrici Einaudi eMondadori che si avvalgono della consulenza edi-toriale di Elio Vittorini, il quale ne sconsiglia lapubblicazione in quanto ritiene Il Gattopardo estra-neo al carattere sperimentale della collana einau-diana «I Gettoni», da lui diretta, e nient’altro che una«seducente imitazione» in chiave rondesca dei Vi-ceré di De Roberto. Il dattiloscritto viene poi invia-to alla Feltrinelli, ed è Giorgio Bassani a sostenernela pubblicazione, ma il 23 luglio del 1957 lo scritto-re muore.Il Gattopardo pubblicato nel 1958 si basa quindi sultesto dattiloscritto, ad eccezione delle parti finaliche Bassani trae dal manoscritto del 1957, ricevutodallo stesso figlio di Lampedusa.La vicenda editoriale è ricostruita solo dieci annidopo, quando Carlo Muscetta, controllando l’edi-zione del 1958 con il testo autografo dell’anno pre-cedente, vi constata numerose differenze. In realtàgli interventi di Bassani non furono molto numero-si, e non tali, comunque, da alterare profondamen-te la fisionomia del romanzo.
La trama e i protagonisti. Lo sbarco dei Mille a Mar-sala, la loro marcia trionfale fino al Volturno e glieventi che portano alla rapida caduta del regnoborbonico fanno da sfondo alle vicende narratenella più ampia parte del romanzo, completata nel-le ultime due parti da stacchi cronologici di venti-cinque anni che scandiscono la morte del protago-nista e il drammatico epilogo delle vicende dellafamiglia Salina.Su tutto e tutti, incontrastato protagonista, dominaDon Fabrizio, principe di Salina, spettatore consape-vole del lento e inesorabile declino della classe digentiluomini e proprietari terrieri cui appartiene, di
fronte alla rapida scalata al successo dei parvenusdella nuova borghesia in ascesa. Destino (e conces-sione dell’autore all’intreccio sentimentale e roman-zesco) vuole che il nipote prediletto, figlio dell’ama-tissima sorella, Tancredi Falconeri, si innamori di An-gelica, la figlia di uno di questi parvenus: il sindacodi Donnafugata, feudo e residenza estiva dei Salina,Don Calogero Sedàra, gran ‘sostenitore’ dell’Unitàd’Italia, che egli conosce a una cena in casa dello zio,nei giorni del plebiscito per l’annessione. Con il ma-trimonio, il sangue dei Salina si unirebbe a quello diun’oscura famiglia di mezzadri, ma otterrebbe anchecospicui vantaggi economici, non secondari per chi,come Tancredi, non può contare su un grande patri-monio e nutre invece ambizioni politiche. Il cinicoTancredi incarna dunque l’astuto conservatorismodella vecchia classe, pronta a collaborare con l’av-versario storico pur di mantenere il potere e i privile-gi. La frase (poi divenuta emblema del romanzo) Sevogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tuttocambi è lui che la pronuncia all’inizio del romanzosalutando lo zione prima di andare a raggiungere igaribaldini, e non Don Fabrizio come spesso si cre-de, anche se la ‘filosofia’ del principe trova in essaun’efficace sintesi.L’arruolamento nelle fila dell’esercito piemontese ele iniziali perplessità della famiglia (dalla principes-sa, che riconosce nel matrimonio l’inizio della finedella stirpe, alla cugina Concetta, che di Tancredi èda sempre innamorata) non impediscono il matri-monio, frutto tanto di una travolgente passioneamorosa quanto dei sapienti calcoli e del computoreciproco dei vantaggi personali. Tancredi e Ange-lica infatti si assomigliano: avidi della vita e dei suoipiaceri, disposti a molto, ambedue, per ottenerli,saranno una coppia perfetta, come riconosce ilprincipe guardandoli ballare.Gli eventi storici si intrecciano con le vicende pri-vate della famiglia Salina e in particolare di DonFabrizio: incapace di sostenere con il trasformi-smo politico una qualche volontà di cambiamen-to, fedele fino all’ultimo a una lettura immobilisti-ca degli eventi storici dalla quale è del tutto assen-te ogni cinismo, in un certo senso delega a Tan-credi, che ne ha invece le ‘virtù’ necessarie, di ‘tra-ghettare’ la dinastia in un mondo che a lui è e re-sterà estraneo, ma nel quale i suoi discendenti do-vranno vivere. Il suo spirito è quello pessimistico,di distaccata accettazione – di stampo ‘illuministi-co’ –, che sin dal marzo del 1861 gli ha fatto affer-mare che molte cose sarebbero avvenute, ma tuttosarebbe stato una commedia, una rumorosa, ro-
410
IL SECONDO NOVECENTODal dopoguerra a oggi
Autori
mantica commedia con qualche macchiolina disangue sulla veste buffonesca. All’offerta del pie-montese Aimone de Chevalley, segretario dellaprefettura, che gli propone l’ambita carica di Se-natore del Regno (allora di nomina regia), coop-tando così, nella nuova, la vecchia classe borboni-ca, il Principe opporrà un netto rifiuto, suggeren-do invece proprio il nome di Don Calogero Sedà-ra come suo degno sostituto. Il colloquio con ildelegato piemontese è motivo di una riflessionepiù ampia sulla natura della Sicilia e sull’immobi-lità dei suoi abitanti: al fondo dell’animo sicilianosi cela un desiderio di morte, un’ansia di annulla-mento, un desiderio di immobilità voluttuosa, chefa amare il passato solo perché morto e fa apprez-zare le novità solo quando sono defunte incapacidi dar luogo a correnti vitali.La morte, evocata e corteggiata per tutto il roman-zo, la creatura bramata da sempre, giunge infineanche per Don Fabrizio, nella penultima parte, raf-figurata nelle vesti di una giovane donna che giun-ta a faccia a faccia con lui sollevò il velo e così, pu-dica ma pronta ad essere posseduta, gli apparvepiù bella di come mai l’avesse intravista negli spazistellari. Il fragore del mare si placò del tutto.Nell’ultima parte, con un altro stacco temporale, diventicinque anni, che ci porta nel maggio del 1910,l’autore ritrae le figlie del Principe intente a salva-guardare dal severo giudizio della curia vescovile ilpoderoso apparato di reliquie accumulato nel tem-po e posto ad ornamento della cappella di famiglia,gloria e vanto dell’onore e della rispettabilità dellacasa e testimonianza incorruttibile di un’aristocra-zia caparbiamente sopravvissuta al mutare deglieventi. La distruzione del reliquiario, e infine anchedelle spoglie del fido cane Bendicò, correda specu-larmente la scomparsa del Principe e conclude suun registro drammatico e grottesco un affresco sto-rico-familiare, che diventa via via un romanzo psi-cologico-decadente della memoria individuale ecollettiva.
I personaggi minori. Alla rappresentazione dei per-sonaggi maggiori si affianca una schiera di figure diminore rilievo ai fini della narrazione, ma abilmen-te caratterizzate. A Padre Pirrone, ad esempio, cap-pellano di famiglia e meschino rappresentante del-la gerarchia ecclesiastica non aliena dalle seduzionidel potere, è dedicata la Parte VI, che ne tratteggia ilcarattere di novello vaso di coccio messo a duraprova dai mutamenti intervenuti con l’annessionedel Regno delle due Sicilie al recente Stato unitario.
Il dibattito ideologico. La comparsa del Gattopardo,in piena crisi del Neorealismo e del filone tematicoresistenziale, mentre il mito americano alimentatodalla narrativa di Pavese e Vittorini si va esaurendoe incalzano le imminenti sperimentazioni di avan-guardia, non passa inosservata, e immediatamenteseguono le polemiche.Le accuse più rilevanti si concentrano sulla presun-ta storicità del romanzo, inficiato da qualche con-cessione alla prosa d’arte e alla narrativa memoria-le dominanti negli anni Trenta, tornate in auge pri-ma che le correnti letterarie dei Sessanta decretas-sero la morte del romanzo stesso. Da una parte, in-fatti, la stanca e pessimistica visione della realtà dicui è portatore il protagonista viene considerataconservatrice e reazionaria (operando un’indebitaidentificazione tra autore e personaggio), riflesso diun qualunquismo che finisce per dare un’interpre-tazione riduttiva e semplicistica dell’epoca del Ri-sorgimento. Intellettuali impegnati come FrancoFortini e il comunista Mario Alicata, e profondi co-noscitori della Sicilia come Leonardo Sciascia, sonoconcordi nel considerare Il Gattopardo un «raffina-tissimo esercizio letterario dove […] il decadenti-smo cacciato dalla porta rientra dalla finestra» (Ali-cata) e in definitiva un romanzo di «destra» (anchese uno tra i più autorevoli rappresentanti della criti-ca marxista, il francese Louis Aragon, ne dà una let-tura più equilibrata). Altri critici, invece, lo conside-rano unilateralmente un romanzo psicologico, ovela buona caratterizzazione della figura del Principemal si concilia con le ambizioni tolstojane di affre-sco sociale.La maggiore debolezza del libro viene riconosciutanel non avere deciso fino all’ultimo per l’una o perl’altra impostazione, e nell’aver alternato parti «sto-riche» con altre «psicologiche». In particolare, si farilevare la contraddizione fra la parte sulla mortedel Principe e l’epilogo della vicenda, in cui l’auto-re tenta un farraginoso ritorno all’impianto storicoiniziale.
Ambivalenza tematica e strutturale. In realtà le con-traddizioni sono insite nella struttura di tutto il ro-manzo, costruito su una serie di antitesi tematiche ein un continuo alternarsi di sentimenti contrastanti.Alla scarsità di avvenimenti esterni, infatti, si con-trappongono le diverse reazioni che tali eventi pro-ducono sui personaggi, dominati da opposti statid’animo (diretta conseguenza di una visione dellarealtà governata da princìpi in eterno contrasto).Così, per esempio, il procedimento chiaroscurale si
Giuseppe Tomasi di Lampedusa • Il Gattopardo
411
riflette nella descrizione dell’arrivo a Donnafugatadella famiglia Salina, vissuto attraverso le sensazio-ni di Don Fabrizio: il soggiorno a Donnafugata co-stituiva un periodo di riposo […]. Bande, mortaret-ti, campane, «zingarelle» e Te Deum all’arrivo, vabene; ma dopo la rivoluzione borghese che saliva lesue scale nel frack di Don Calogero, la bellezza diAngelica che poneva in ombra la grazia contegno-sa della sua Concetta […]; le mille astuzie alle qua-li doveva piegarsi lui, il Gattopardo, che per tantianni aveva spazzato via le difficoltà con un rove-scio della zampa.I temi presenti nel romanzo rivelano costantemen-te un duplice aspetto: anche la nota più gioiosa ècorredata di un risvolto di segno fatalmente oppo-sto, come la decadenza dei Salina e l’ascesa socialedei Sedàra, o la passione di Tancredi e Angelica el’orgogliosa ritrosia di Concetta di fronte agli im-pacciati approcci del settentrionale tenente Cavria-ghi, compagno d’armi di Tancredi, che di lei si è ti-midamente innamorato.
Un romanzo di difficile inquadramento. Nonostantele vicende si inseriscano in un periodo politicamen-te rilevante, in cui la storia familiare si intreccia conquella del recente Regno d’Italia e ne diventa il luo-go di osservazione privilegiata, Il Gattopardo nonpuò essere definito un romanzo «storico». Le dichia-razioni dell’autore, del resto, autorizzano a ritenerepiù probabile che l’«occasione» tragga origine dal de-siderio di fissare una materia personale ancora vivae presente alla memoria, piuttosto che dalla volontàdi documentazione storica. Ma l’aver ambientato ilromanzo nell’arco di tempo compreso tra il 1860 e ilprimo decennio del Novecento ha permesso a To-masi di prendere le distanze dagli eventi narrati,perseguendo – senza peraltro riuscire a mantenerlacostantemente – un’oggettivazione del punto di vi-sta che lo avvicina a quella sintetica magrezza stili-stica che egli tanto apprezzava in Stendhal.È importante operare quindi una preliminare distin-zione tra autore e protagonista, per non cadere neldiffuso pregiudizio che ha voluto fare del Gattopar-do un romanzo esclusivamente autobiografico. Imeccanismi narrativi di «allontanamento», frequente-mente occorrenti nel testo, ci permettono di soste-nere questa separazione, anche se non mancano si-tuazioni in cui l’autore non può fare a meno di vesti-re i panni del Principe. Si consideri ad esempio lascena dell’uscita dal bagno di Don Fabrizio che co-me «l’Ercole Farnese» si offre alla vista imbarazzata diPadre Pirrone (Parte II), dove l’ironia funge da presa
di distanza dal protagonista, contrapposta a tutta laparte dedicata alla sua morte, in cui l’adesione e lasovrapposizione con circostanze drammaticamenteautobiografiche è totale.Si è più propensi ormai a inquadrare il romanzo inuna zona «neutra», sospesa tra l’affresco storico-fa-miliare e il romanzo psicologico, portatore di un’a-nomalia che lo caratterizza rispetto alla contempo-ranea produzione italiana e ne sostiene la grandez-za letteraria. Tomasi di Lampedusa, del resto, eraperfettamente a conoscenza delle tecniche narrati-ve sviluppate nel Novecento europeo: la narrazio-ne «a sbalzi» temporali, per esempio, è sembrata de-bitrice all’analoga tecnica adottata da VirginiaWoolf; di derivazione proustiana è invece la preli-minare considerazione che i soli eventi degni di es-sere narrati sono quelli della memoria, anche se unvero e proprio modello scrittorio è pur sempre daravvisare in Stendhal.L’originalità del romanzo, quindi, non sta tanto nel-la capacità di rappresentarci attraverso il declino diuna classe sociale i mali profondi del Risorgimento,l’ascesa e la consacrazione nell’Olimpo dell’elettasocietà siciliana dei nuovi ricchi, capaci di consoli-dare con abilità e astuzia il potere economico conun corrispondente prestigio sociale, quanto nellastraordinaria profondità con cui tale affresco vieneteatralizzato a rappresentare simbolicamente il crol-lo di quei «valori» sacri e incorruttibili incarnati dallafamiglia Salina e l’inappagata sete di eternità frustra-ta e sconfessata da tale crollo.Non quindi l’apologia dell’immobilità dell’ordine so-ciale, ma l’attenta analisi dell’incapacità dell’individuodi certificare nell’appartenenza a tale ordine il bisognodi valori e di certezze non corruttibili, costantementedisilluso dalla precarietà e dalla mortalità del reale.
La grande fortuna del romanzo. Da questo punto di vi-sta si può meglio comprendere la grande fortuna delromanzo che, uscito nel 1958, nel maggio dell’annosuccessivo aveva già raggiunto la XVIII edizione e unmilione di copie vendute. Pur non ottemperando aidettami delle moderne avanguardie, e ponendosi an-zi apparentemente in una linea fedele alla tradizione,incapace di inserirsi nel panorama letterario domina-to dagli scrittori della cosiddetta «crisi della moder-nità», esso risulta ai lettori straordinariamente moder-no e in grado di esprimere le inquietudini e le incer-tezze del secolo, pur non rinunciando all’impianto ro-manzesco e a una lingua di immediata e piacevoleleggibilità. D’altro canto, la profonda istanza che sot-tostà agli eventi narrati permette di comprendere an-
412
IL SECONDO NOVECENTODal dopoguerra a oggi
Autori
che quegli aspetti meno legati alla contemporaneità,ma che ad essa simbolicamente si riferiscono, ed è pu-re in grado di rappresentare la crisi di una generazio-ne al pari dei grandi autori europei, indiscutibilmenteritenuti moderni e fra i quali Tomasi di Lampedusanon può non essere incluso.
La lingua e lo stile. Come la struttura del romanzo ècostantemente articolata per antitesi, così nella pa-gina lampedusiana convivono registri linguistici estilistici a volte in contrasto fra loro, o di segno de-cisamente opposto. Vengono infatti messi a con-fronto elementi semanticamente divergenti me-diante l’uso di sintagmi e dittologie oppositive dal-la chiara funzione di ‘messa a fuoco’ dell’antitesi te-matica rappresentata. Si consideri ad esempio ladescrizione della tavola su cui viene offerta la cenaalla villa di Donnafugata con il fasto sbrecciato cheallora era lo stile del Regno delle Due Sicilie. […] Ri-coperta da una rattoppata tovaglia finissima, essasplendeva sotto la luce.A questa tecnica sottostà una più profonda motiva-zione contenutistica, tanto che le figure stilisticheosservate non sono altro che la traduzione a livelloformale di una complessa visione del reale: Essi ri-masero estasiati [racconta il Principe] dal panora-ma, dall’irruenza della luce; confessarono però cheerano stati pietrificati osservando lo squallore, lavetustà, il sudiciume delle strade di accesso. Nonspiegai loro che una cosa era derivata dall’altra. Larealtà più profonda della Sicilia, microcosmo ingrado di riflettere il destino umano, pur nella pecu-liarità della sua condizione, è costituita da un con-tinuo alternarsi di bene e male, principi indissolu-bilmente legati.
A un’indubbia originalità nel trattamento delle figu-re stilistiche si accompagna una lingua non partico-larmente difforme dalla media d’uso e che ha con-centrato su di sé i più appuntiti strali critici, cheoscillano tra l’osservazione di una «maniera, vec-chia e scadente» e quella di una corrività nell’usodel registro medio-basso su cui si innalzano, coneffetto non sempre soddisfacente, punte di baroc-chismo e di grottesco, in un risultato complessivodi grande eterogeneità. Accanto a termini prove-nienti dal lessico colto di chiara marca ottocente-sca, ve ne sono altri tratti dal linguaggio popolare,fino al prestito dal gergo o dal dialetto in una formanaturalmente italianizzata. Spesso l’uso degli aulici-smi permette all’autore di mutare il punto di vistaeffettuando un momentaneo distacco ironico estraniante e un contemporaneo ‘raffreddamento’della materia trattata.Dal punto di vista sintattico, la costante più signifi-cativa sembrerebbe essere la prevalenza di unastruttura paratattica, più idonea a un tipo di narra-zione che è stata definita «cinematografica», che sno-da una serie di membrature di dimensioni presso-ché uguali con funzione di amplificazione e di itera-zione. L’effetto di lentezza e ritmicità del periodo èdeterminato anche dall’uso frequente dell’anafora,che genera spesso lunghi periodi a catena.È stato evidenziato, infine, come tali stilemi (accu-mulo di aggettivi, procedimenti anaforici, ipertrofi-smi del periodo) tendano a concentrarsi proprio inquei passi ove la narrazione coinvolge oggetti opersonaggi verso cui maggiore è l’investimentoemotivo, e quindi minore il distacco del narratore,anche se quest’ultimo resta l’obiettivo perseguitoda Tomasi.
Paul Delvaux, Donna allo specchio, particolare, 1936, olio su tela, Lugano, Collezione Thyssen-Bornemisza.
Giuseppe Tomasi di Lampedusa • Il Gattopardo
413
Il «ciclone amoroso»da Il Gattopardo, IV
È un episodio-chiave della narrazione. Da un lato esemplifica la strut-tura antitetica che è una costante di tutto il libro, dall’altro contraddice,integrandola, la lettura del romanzo all’insegna di un cupo pessimismo,che ne vorrebbe fare un lungo «corteggiamento della morte» dalla primaall’ultima pagina.Il vagabondare trasognato di Tancredi e Angelica nello sconfinato Palaz-zo Salina, a Donnafugata, si inserisce tra l’incontro di Don Fabrizio conDon Calogero per l’ufficializzazione delle nozze (dove l’amarezza e l’u-mor nero del Principe hanno fatto da contrappunto ai toni ironico-grotte-schi del dialogo) – seguito dall’arrivo di Tancredi e Cavriaghi a Donnafu-gata – e la visita del piemontese Chevalley (con il famoso monologo di DonFabrizio sugli eterni mali della Sicilia). L’episodio, definito «una specie diinno alla vita e all’amore nelle sue gioie sensuali e terrene» (Salvestroni),rivela come dietro al pessimismo del Principe si celi una visione ‘edonisti-ca’ della vita, dove la maggiore felicità coincide con la contemplazionedella bellezza e di una sensualità ingenua e naturale, non appesantita dacomplicazioni intellettualistiche, che proprio per questo può sublimare inrinunzia lo stimolo sensuale. Il profondo attaccamento a tale realtà terre-na si rivela tanto più forte quanto più il protagonista (e con lui l’autore) sisente vicino a doverla lasciare. Il senso di malinconico rimpianto con cuiviene descritto l’amore dei due giovani non impedisce però che questaconcezione ‘pagana’ si mostri (mettendo anche in opera i più sontuosi ar-tifici della prosa lampedusiana) in tutta la sua pienezza, come la tardama viva testimonianza di un esplicito ‘corteggiamento della vita’, cui re-sta la consapevolezza della sua precarietà. Le scorribande amorose nellestanze disabitate della villa, ove sopravvivono le vestigia dei settecenteschilibertinaggi dei precedenti proprietari, si costituiscono anche, e simbolica-mente, come un’esplorazione dei possibili registri della passione amorosa.
In seguito all’arrivo degli ospiti benvenuti il ritorno a Palermo fu rinvia-to; e seguirono due settimane d’incanti. L’uragano che aveva accompa-gnato il viaggio dei due ufficiali, era stato l’ultimo di una serie e dopo diesso risplendette l’estate di San Martino che è la vera stagione di voluttàin Sicilia: temperie luminosa e azzurra, oasi di mitezza nell’andamentoaspro delle stagioni, che con la mollezza persuade e travia i sensi men-tre con il tepore invita alle nudità segrete. Di nudità erotiche nel palaz-zo di Donnafugata non era il caso di parlare ma vi era copia di esaltatasensualità tanto più acre quanto maggiormente rattenuta1. Il palazzo deiSalina era stato ottant’anni prima un ritrovo per quegli oscuri piaceri neiquali si era compiaciuto il Settecento agonizzante; ma la reggenza seve-ra della principessa Carolina2, la neoreligiosità della Restaurazione, il ca-rattere soltanto bonariamente carnale dell’attuale Don Fabrizio avevanoperfino fatto dimenticare i suoi bizzarri trascorsi; i diavoletti incipriatierano stati posti in fuga; esistevano ancora, certamente, ma allo stato lar-vale ed ibernavano sotto cumuli di polvere in chissà quale soffitta dellosmisurato edificio. La venuta a palazzo della bella Angelica aveva fattoun po’ rinvenire quelle larve, come forse si ricorderà3; ma fu l’arrivo deigiovanotti innamorati che ridestò davvero gli istinti rimpiattati nella ca-
1. tanto … rattenuta: si anticipa qui untema che verrà sviluppato in un crescendocontinuo durante i vagabondaggi di Tan-credi e Angelica: una sensualità che cresceproporzionalmente agli ostacoli che si in-terpongono al suo appagamento, e di cuisembra essere pervaso tutto il palazzo.2. principessa Carolina: la madre del
principe di Salina, di origine tedesca, e dinobili, rigidi costumi, la cui alterigia avevacongelato, trent’anni prima, la corte sciat-tona delle Due Sicilie (Parte I).3. come … ricorderà: il riferimento è a un
episodio della Parte II, in cui l’indugio diDon Fabrizio nel contemplare la fontanadella villa – dove su di un isolotto al centrodel bacino rotondo […] un Nettuno spiccio esorridente abbrancava un’Anfitrite vogliosa– era stato colto e maliziosamente rimprove-rato da Tancredi (Zione, vieni a guardare lepesche forestiere. Sono venute benissimo. Elascia stare queste indecenze che non sonofatte per uomini della tua età). Il ricordo e ilrimpianto del passato ‘libertino’ del Princi-pe, male ostacolato dai rigidi costumi dellafamiglia, viene ora risvegliato dalla statua edalla presenza di Angelica.
414
IL SECONDO NOVECENTODal dopoguerra a oggi
Autori
sa; essi adesso si mostravano dappertutto, come formiche destate dalsole, disintossicati forse ma oltremodo vivaci. L’architettura, la decora-zione stessa rococò con le loro curve impreviste evocavano anche di-stese e seni eretti; l’aprirsi di ogni portale frusciava come una cortinad’alcova.Cavriaghi4 era innamorato di Concetta; ma, fanciullo com’egli era e nonsoltanto nell’aspetto come Tancredi ma nel proprio intimo, il suo amoresi sfogava nei facili ritmi di Prati e di Aleardi5, nel sognare ratti al chiarodi luna dei quali non si arrischiava a contemplare il logico seguito e chedel resto la sordità di Concetta schiacciava in embrione. Non si sa se nel-la reclusione della sua camera verde egli non si abbandonasse a un piùconcreto vagheggiare; certo è che alla scenografia galante di quell’au-tunno donnafugasco egli contribuiva solo come abbozzatore di nuvolee di orizzonti evanescenti e non come ideatore di masse architettoniche.Le due altre ragazze invece Carolina e Caterina, tenevano assai bene laloro parte nella sinfonia di desideri che in quel Novembre risuonava pertutto il palazzo mescolandosi al mormorio delle fontane, allo scalciaredei cavalli in amore nelle scuderie ed al tenace scavo di nidi nuziali deitarli nei vecchi mobili. Erano giovanissime ed avvenenti e benché prived’innamorati particolari si ritrovavano immerse nella corrente di stimoliche s’incrociavano fra gli altri; e spesso il bacio che Concetta negava aCavriaghi, la stretta di Angelica che non aveva saziato Tancredi si river-beravano sulle loro persone, sfiorava i loro corpi intatti e per esse si so-gnava, esse stesse sognavano ciocche madide di speciosi sudori, gemitibrevi. Financo l’infelice mademoiselle Dombreuil a forza di dover fun-zionare da parafulmine, come gli psichiatri si infettano e soccombono al-le frenesie dei loro ammalati, fu attratta in quel vortice torbido e ridente;quando dopo una giornata d’inseguimenti e agguati moralistici essa sistendeva sul suo letto solingo palpava i propri seni appassiti e mormora-va indiscriminate invocazioni a Tancredi, a Carlo, a Fabrizio6…Centro e motore di questa esaltazione sensuale era naturalmente la cop-pia Tancredi-Angelica. Le nozze sicure benché non vicine stendevano inanticipo le loro ombre rassicuranti sul terriccio arso dei loro mutui desi-deri; la differenza di ceti faceva credere a don Calogero normali nellanobiltà i lunghi colloqui appartati, ed alla principessa Maria Stella abi-tuali nel rango dei Sedàra la frequenza delle visite di Angelica ed unacerta libertà di contegno che essa, certamente, non avrebbe trovata leci-ta nelle proprie figlie; e così le visite di Angelica al palazzo divennerosempre più frequenti sino ad essere quasi perpetue ed essa finì con l’es-sere solo formalmente accompagnata dal padre che si recava subito inAmministrazione per scoprire (o per tessere) nascoste trame o dalla ca-meriera che scompariva nel riposto per bere il caffè ed incupire i dome-stici sventurati.Tancredi voleva che Angelica conoscesse tutto il palazzo nel suo com-plesso inestricabile di foresterie vecchie e foresterie nuove, apparta-menti di rappresentanza, cucine, cappelle, teatri, quadrerie, rimesseodorose di cuoi, scuderie, serre afose, passaggi, anditi, scalette, terrazzi-ne e porticati, e soprattutto di una serie di appartamenti smessi e disabi-tati, abbandonati da decenni e che formavano un intrico labirintico emisterioso7. Tancredi non si rendeva conto (oppure si rendeva contobenissimo) che vi trascinava la ragazza verso il centro nascosto del ci-clone sensuale, ed Angelica, in quel tempo, voleva ciò che Tancredi
4. Cavriaghi: il tenente milanese, compa-gno d’armi di Tancredi nell’esercito pie-montese, innamorato di Concetta, una dellefiglie del Principe di Salina.5. nei facili … Aleardi: vengono prescelti a
rappresentare la quintessenza del sentimen-talismo svenevole i due poeti più in voga al-la fine dell’Ottocento, esponenti della secon-da generazione romantica: Giovanni Prati eAleardo Aleardi. Quest’ultimo è autore predi-letto dal giovane tenente che ne ha donato iCanti alla ritrosa Concetta, accompagnando-li con l’emblematica dedica «sempre sorda»(alle sue suppliche amorose).6. Financo … Fabrizio: alla caratterizzazio-
ne della signorina Dombreuil, la governanteincaricata di ‘sorvegliare’ le fughe dei due gio-vani, concorrono i toni ironico-grotteschi del-l’iperbole (indiscriminate invocazioni), chehanno contribuito alle critiche sull’eteroge-neità anche stilistica dell’episodio.7. foresterie vecchie … misterioso: la classi-
ca figura dell’enumeratio è qui funzionalealla resa della struttura ‘labirintica’ del palaz-zo (caratterizzando stilisticamente tutto ilbrano), cui ben si attaglia la metafora delviaggio sviluppata nei periodi seguenti.
Giuseppe Tomasi di Lampedusa • Il Gattopardo
415
aveva deciso. Le scorribande attraverso il quasi illimitato edificio eranointerminabili; si partiva come verso una terra incognita, ed incognita eradavvero perché in parecchi di quegli appartamenti sperduti neppureDon Fabrizio aveva mai posto piede, il che del resto, gli era cagione dinon piccolo compiacimento perché soleva dire che un palazzo del qua-le si conoscessero tutte le stanze non era degno di essere abitato. I dueinnamorati s’imbarcavano verso Citera8 su una nave fatta di camere cu-pe e di camere solatie, di ambienti sfarzosi o miserabili, vuoti o affollatidi relitti di mobilio eterogeneo. Partivano accompagnati da mademoi-selle Dombreuil o da Cavriaghi (padre Pirrone con la sagacia del suo Or-dine si rifiutò sempre a farlo), talvolta da tutti e due; la decenza esterio-re era salva. Ma nel palazzo non era difficile di fuorviare chi volesse se-guirvi: bastava infilare un corridoio (ve ne erano lunghissimi, stretti etortuosi con finestrine grigliate che non si potevano percorrere senzaangoscia), svoltare per un ballatoio, salire una scaletta complice, e i dueragazzi erano lontano, invisibili, soli come su un’isola deserta. Restava-no a guardarli soltanto un ritratto a pastello sfumato via e che l’inespe-rienza del pittore aveva creato senza sguardo o su un soffitto obliteratouna pastorella subito consenziente. Cavriaghi, del resto, si stancava pre-sto ed appena trovava sulla propria rotta un ambiente conosciuto o unascaletta che scendeva in giardino se la svignava, tanto per far piacere al-l’amico che per andare a sospirare guardando le gelide mani di Concet-ta. La governante resisteva più a lungo, ma non per sempre; per qualchetempo si udivano sempre, più lontani, i suoi appelli, mai corrisposti:«Tancrède, Angelicà, où êtes-vous9?». Poi tutto si richiudeva nel silenzio,striato solo dal galoppo dei topi al di sopra dei soffitti, dallo strisciare diuna lettera centenaria dimenticata che il vento faceva errare sul pavi-mento: pretesti per desiderate paure, per un aderire rassicurante dellemembra. E l’Eros era sempre con loro, malizioso e tenace, il gioco in cuitrascinava i due fidanzati era pieno di azzardi e di malia. Tutti e due vi-cinissimi ancora all’infanzia prendevano piacere al gioco in sé, godeva-no nell’inseguirsi, nel perdersi, nel ritrovarsi; ma quando si erano rag-giunti i loro sensi aguzzati prendevano il sopravvento e le cinque dita dilui che s’incastravano nelle dita di lei, col gesto caro ai sensuali indecisi,il soffregamento soave dei polpastrelli sulle vene pallide del dorso, tur-bava tutto il loro essere, preludeva a più insinuate carezze.Una volta lei si era nascosta dietro un enorme quadro posato per terra;e per un po’ “Arturo Corbera all’assedio di Antiochia10” protesse l’ansiasperanzosa della ragazza; ma quando fu scoperta, col sorriso intriso diragnatele e le mani velate di polvere, venne avvinghiata e stretta, e ri-mase una eternità a dire «No, Tancredi, no», diniego che era un invitoperché di fatto lui non faceva altro che fissare nei verdissimi occhi di leil’azzurro dei propri. Una volta in una mattinata luminosa e fredda essatremava nella veste ancora estiva; su di un divano coperto di stoffa abrandelli lui la strinse a sé per riscaldarla; il fiato odoroso di lei gli agita-va i capelli sulla fronte; e furono momenti estatici e penosi, durante iquali il desiderio diventava tormento, i freni a loro volta, delizia.Negli appartamenti abbandonati le camere non avevano né fisionomiaprecisa né nome; e come gli scopritori del Nuovo Mondo essi battezza-vano gli ambienti attraversati col nome di ciò che in essi era accaduto aloro: una vasta stanza da letto nella cui alcova stava lo spettro di un let-to adorno sul baldacchino da scheletri di penne di struzzo, fu ricordata
8. s’imbarcavano verso Citera: «davanosfogo al loro amore». Citera è l’antico nomedell’isola greca di Cerigo, sede del culto diAfrodite (Venere) che, secondo la leggen-da, era nata dalle sue acque; in poesia ‘ci-terea’ è frequente epiteto della dea: si vedaad esempio Foscolo, i lini odorati / che aCiterea porgeano (A Luigia Pallavicini ca-duta da cavallo, vv.3-4).9. Tancrède … vous: la governante è ridot-
ta a pura macchietta caricaturale anche me-diante il particolare trattamento linguistico. Lesue forme espressive (rigorosamente in fran-cese) si limitano a vane interrogazioni («Tan-credi, Angelica, dove siete?») o a estatici motidi commozione espressi in un monotono re-frain: Angelicà, Angelicà, pensons à la joie deTancrède; Tancrède, Tancrède, pensons à lajoie d’Angelicà («Angelica, Angelica, pensia-mo alla gioia di Tancredi; Tancredi, Tancredi,pensiamo alla gioia di Angelica»).10. Arturo … Antiochia: Arturo Corbera èun antenato del Principe di Salina che ave-va partecipato alla crociata per la riconqui-sta di Antiochia, nel celebre assedio del1098, che portò alla fondazione dell’omo-nimo principato.
416
IL SECONDO NOVECENTODal dopoguerra a oggi
Autori
poi come la “camera delle pene”; una scaletta dai gradini di lavagna li-si e sbrecciati venne chiamata da Tancredi “la scala dello scivolone fe-lice”. Più d’una volta non seppero più dove erano: a furia di giravolte,di ritorni, d’inseguimenti, di lunghe soste riempite di mormorii e con-tatti perdevano l’orientamento e dovevano sporgersi da una finestrasenza vetri per comprendere dall’aspetto di un cortile, dalla prospettivadel giardino in quale ala del palazzo si trovassero. Talvolta però non siraccapezzavano lo stesso perché la finestra guardava non su uno deigrandi cortili ma su di un cortiletto interno, anonimo anch’esso e maiintravisto, contrassegnato soltanto dalla carogna di un gatto o dalla so-lita manciata di pasta al pomidoro non si sa mai se vomitata o buttatavia; e da un’altra finestra li scorgevano gli occhi di una cameriera pen-sionata. Un pomeriggio rinvennero dentro un cassettone con tre gam-be quattro carillons, di quelle scatole per musica delle quali si dilettaval’artificiosa ingenuità del Settecento. Tre di esse, sommerse nella polve-re e nelle ragnatele, rimasero mute; ma la quarta, più recente, megliochiusa nello scrignetto di legno scuro, mise in moto il proprio cilindrodi rame irto di punte e le linguette di acciaio sollevate fecero a un trat-to udire una musichetta gracile, tutta in acuti argentini: il famoso “Car-nevale di Venezia”; ed essi ritmarono i loro baci in accordo con queisuoni di giocondità disillusa; e quando la loro stretta si allentò si sor-presero nell’accorgersi che i suoni erano cessati da tempo e che le lorocarezze non avevano seguito altra traccia che quella del ricordo di quelfantasma di musica.Una volta la sorpresa fu di colore diverso. In una stanza della foresteriavecchia si avvidero di una porta nascosta da un armadio; la serraturacentenaria cedette presto a quelle dita che godevano nell’intrecciarsi esoffregarsi per forzarla: dietro, una lunga scala stretta si svolgeva in sof-fici curve con i suoi scalini di marmo rosa. In cima un’altra porta, aper-ta, e con spesse imbottiture disfatte, e poi un appartamentino vezzosoe strambo11, sei piccole camere raccolte attorno a un salotto di medio-cre grandezza, tutte e il salotto stesso con pavimenti di bianchissimomarmo, un po’ in pendio, declinanti verso una canaletta laterale. Suisoffitti bassi bizzarri stucchi colorati che l’umidità aveva fortunatamen-te resi incomprensibili; sulle pareti grandi specchi attoniti, appesi trop-po in giù, uno fracassato da un colpo quasi nel centro, ciascuno colcontorto reggi-candela del Settecento; le finestre davano su un cortilet-to segregato, una specie di pozzo cieco e sordo che lasciava entrareuna luce grigia e sul quale non spuntava nessun’altra apertura. In ognicamera ed anche nel salotto ampi, troppo ampi, divani che mostravanosulle inchiodature tracce di una seta strappata via; appoggiatoi macula-ti; sui caminetti, delicati, intricati intagli nel marmo, nudi parossistici,martoriati, però, mutilati da martellate rabbiose. L’umidità aveva mac-chiato le pareti in alto e, sembrava almeno, in basso ad altezza d’uomo,dove essa aveva assunto configurazioni strane, tinte cupe, inconsuetirilievi. Tancredi, inquieto, non volle che Angelica toccasse un armadioa muro del salotto; lo schiuse lui stesso. Era profondissimo e contene-va bizzarre cose12: rotolini di corda di seta, sottile; scatolucce di argen-to impudicamente ornate con sul fondo esterno etichettine minuscolerecanti in eleganti grafie indicazioni oscure, come le sigle che si legge-vano sui vasi delle farmacie: “Estr. catch.” “Tirch-stram.” “Part-opp.”;bottigliette dal contenuto evaporato; un rotolo di stoffa sudicia, ritto in
11. vezzoso e strambo: la dittologia opposi-tiva, associando un’attribuzione esteticacon una velata riprovazione morale, intro-duce la descrizione (che diventa vera epropria digressione sulle depravazioni del-la famiglia Salina) della stanza ‘dei sadici’.La visione sembra affidata all’occhio atten-to e impaurito di Tancredi: fortunatamenteresi incomprensibili; troppo in giù; ampi,troppo ampi (e più sotto: indicazioni oscu-re; attrezzini metallici inspiegabili).12. bizzarre cose: il manoscritto del 1957 in-serisce il catalogo degli oggetti contenuti nel-l’oscuro armadio, laddove il testo rivisto daBassani riportava: «Era profondissimo mavuoto, tranne che per un rotolo di stoffa…».
Giuseppe Tomasi di Lampedusa • Il Gattopardo
417
un angolo; dentro vi era un fascio di piccole fruste, di scudisci in nervodi bue, alcuni con manici in argento, altri rivestiti sino a metà da unagraziosa seta molto vecchia, bianca a righine azzurre, sulla quale siscorgevano tre file di macchie nerastre; attrezzini metallici inspiegabili.Tancredi ebbe paura, anche di sé stesso, comprese di aver raggiunto ilnucleo segreto centro d’irradiazione delle irrequietudini carnali del pa-lazzo13. «Andiamo via, cara, qui non c’è niente d’interessante». Richiuse-ro bene la porta, ridiscesero in silenzio la scala, rimisero a posto l’ar-madio; tutto il giorno poi i baci di Tancredi furono lievi, come dati insogno ed in espiazione.Dopo il Gattopardo14, a dire il vero, la frusta sembrava essere l’oggettopiù frequente a Donnafugata. L’indomani della loro scoperta dell’ap-partamentino enigmatico i due innamorati s’imbatterono in un altro fru-stino, di carattere ben diverso. Questo, in verità, non era negli apparta-menti ignorati ma anzi in quello venerato detto del Duca-Santo, il piùremoto del palazzo. Lì, a metà del Seicento un Salina si era ritirato co-me in un convento privato ed aveva fatto penitenza e predisposto ilproprio itinerario verso il Cielo. Erano stanze ristrette, basse di soffitto,con l’ammattonato di umile creta, con le pareti candide a calce, simili aquelle dei contadini più derelitti. L’ultima dava su un poggiuolo dalquale si dominava la distesa gialla dei feudi accavallati ai feudi, tutti im-mersi in una triste luce. Su di una parete un enorme Crocifisso più gran-de del vero: la testa del Dio martoriato toccava il soffitto, i piedi san-guinanti sfioravano il pavimento: la piaga sul costato sembrava unabocca15 cui la brutalità avesse vietato di pronunziare le parole della sal-vezza ultima. Accanto al cadavere divino pendeva giù da un chiodouna frusta col manico corto dal quale si dipartivano sei strisce di cuoioormai indurito, terminanti in sei palle di piombo grosse come nocciole.Era la “disciplina” del Duca-Santo. In quella stanza Giuseppe Corbera,duca di Salina, si fustigava solo, al cospetto del proprio Dio e del pro-prio feudo, e doveva sembrargli che le gocce del sangue suo andasse-ro a piovere sulle terre per redimerle; nella sua pia esaltazione dovevasembrargli che solo mediante questo battesimo espiatorio esse divenis-sero realmente sue, sangue del suo sangue, carne della sua carne, co-me si dice. Invece le zolle erano sfuggite e molte di quelle che da lassùsi vedevano appartenevano ad altri, a don Calogero anche; a don Calo-gero, cioè ad Angelica, quindi al loro futuro figlio. L’evidenza del ri-scatto attraverso la bellezza, parallelo all’altro riscatto attraverso il san-gue diede a Tancredi come una vertigine. Angelica inginocchiata ba-ciava i piedi trafitti di Cristo. «Vedi, tu sei come quell’arnese lì, servi aglistessi scopi». E mostrava la disciplina; e poiché Angelica non capiva edalzato il capo sorrideva, bella ma vacua, lui si chinò e così genuflessacom’era le diede un aspro bacio che la fece gemere perché le ferì il lab-bro e le raschiò il palato.I due passavano così quelle giornate in vagabondaggi trasognati; sco-prirono inferni che l’amore poi redimeva, rinvenivano paradisi trascu-rati che quello stesso amore dopo profanava; il pericolo di far cessare ilgiuoco per incassarne subito la posta si acuiva, urgeva per tutti e due;alla fine non cercavano più, ma se ne andavano assorti nelle stanze piùisolate, quelle dalle quali nessun grido avrebbe potuto giungere a nes-suno; ma grida non vi sarebbero state, solo invocazioni e singulti bassi.Invece se ne stavano lì tutti e due stretti ed innocenti, a compatirsi l’un
13. comprese … palazzo: la notazione psi-cologica (contraria all’oggettivazione narra-tiva), è presente nel solo manoscritto.14. Gattopardo: il riferimento è, natural-mente, allo stemma nobiliare di casa Salina,decorazione di ogni oggetto del palazzo;basta pensare ad esempio alla descrizionedella cena all’inizio del romanzo (Parte I):si slargavano i fianchi argentei dell’enor-me zuppiera col coperchio sormontato dalGattopardo danzante.15. la piaga … una bocca: il livello stilisti-co del brano si conforma al periodo evoca-to, da cui la scena, resa con toni espressiva-mente ‘barocchi’.
418
IL SECONDO NOVECENTODal dopoguerra a oggi
Autori
l’altro. Le più pericolose per loro erano le stanze della foresteria vec-chia: appartate, meglio curate, ciascuna col suo bel letto dalle materas-se arrotolate che un colpo della mano avrebbe bastato a distendere…Un giorno, non il cervello di Tancredi che in questo non aveva nulla dadire, ma tutto il suo sangue aveva deciso di finirla: quella mattina An-gelica, da quella bella canaglia che era, gli aveva detto: «Sono la tua no-vizia», richiamando alla mente di lui con la chiarezza di un invito, il pri-mo incontro di desideri corso fra loro16; e già la donna resa scarmiglia-ta si offriva, già il maschio stava per sopraffare l’uomo, quando il boa-to del campanone della chiesa piombò quasi a picco sui loro corpi gia-centi, aggiunse il proprio fremito agli altri; le bocche compenetrate do-vettero disgiungersi per un sorriso. Si ripresero; e l’indomani Tancredidoveva partire.Quelli furono i giorni migliori della vita di Tancredi e di quella di An-gelica, vite che dovevano poi essere tanto variegate, tanto peccamino-se sull’inevitabile sfondo di dolore. Ma essi allora non lo sapevano edinseguivano un avvenire che stimavano più concreto benché poi risul-tasse formato di fumo e di vento soltanto. Quando furono divenuti vec-chi e inutilmente saggi i loro pensieri ritornavano a quei giorni con rim-pianto insistente: erano stati i giorni del desiderio sempre presenteperché sempre vinto, dei letti, molti, che si erano offerti e che eranostati respinti, dello stimolo sensuale che appunto perché inibito si era,un attimo, sublimato in rinunzia, cioè in vero amore. Quei giorni furo-no la preparazione a quel loro matrimonio che, anche eroticamente, fumal riuscito; una preparazione però che si atteggiò in un insieme a séstante, squisito e breve: come quelle sinfonie che sopravvivono alleopere dimenticate e che contengono, accennati e con la loro giocositàvelata di pudore, tutte quelle arie che poi nell’opera dovevano esseresviluppate senza destrezza, e fallire.
Quando Angelica e Tancredi ritornavano nel mondo dei viventi dal loroesilio nell’universo dei vizi estinti, delle virtù dimenticate e, sopratutto,del desiderio perenne, venivano accolti con bonaria ironia. «Siete proprioscemi, ragazzi, ad andare a impolverarvi così. Ma guarda un po’ come seiridotto, Tancredi» sorrideva Don Fabrizio; e il nipote andava a farsi spaz-zolare. Cavriaghi a cavalcioni di una sedia fumava compunto un “virginia”e guardava l’amico che si lavava la faccia e il collo e che sbuffava per il di-spetto di veder l’acqua diventare nera come il carbone. «Io non dico di no,Falconeri: la signorina Angelica è la più bella “tosa” che abbia mai visto;ma questo non ti giustifica: Santo Dio, un po’ di freni ci vogliono! oggi sie-te stati soli tre ore; se siete tanto innamorati sposatevi subito e non fate ri-dere la gente. Avresti dovuto vedere la faccia che ha fatto il padre oggiquando, uscito dall’amministrazione ha visto che voi stavate ancora navi-gando in quell’oceano di stanze! Freni, caro amico, freni ci vogliono, e voiSiciliani ne avete pochini!».
16. il primo … loro: il riferimento è a un episodio occorso nel primo incontro dei due gio-vani (Parte II). Durante la cena offerta dai Salina al sindaco di Donnafugata, giunto in com-pagnia della figlia, il racconto licenzioso di Tancredi sulle scorribande militari in un con-vento di terrorizzate novizie aveva suscitato la divertita reazione della ragazza (Che bei ti-pi dovevate essere! Come avrei voluto trovarmi con voi!) e l’impertinente risposta del gio-vane (Se ci fosse stata lei, signorina, non avremmo avuto bisogno di aspettare le novizie).
Giuseppe Tomasi di Lampedusa • Il Gattopardo
419
Analisi del testo
I l brano è costruito secondo un crescendo emotivoche, appena accennato nelle prime pagine, si
evolve fino alla climax finale (il boato del campanoneche interrompe il congiungimento fra i due giovani).La sua struttura è tripartita:anticipazione del «cicloneamoroso» (fino a domestici sventurati), viaggi di An-gelica e Tancredi nei labirinti del palazzo (da Tancre-di voleva che Angelica a l’indomani Tancredi dovevapartire), riflessione finale dell’autore (da Quelli furonoi giorni migliori della vita di Tancredi a senza destrez-za,e fallire).Analizziamola partitamente.
ANTICIPAZIONE DEL «CICLONE AMOROSO»
Il «ciclone amoroso» è anticipato dall’ambiente na-turale, cui fanno da cornice la straordinaria mitezzadel clima e la sensualità del paesaggio. Sull’impor-tanza delle forze naturali dichiarerà successiva-mente il Principe al perplesso Chevalley: […] l’am-biente, il clima, il paesaggio siciliano. Queste sono leforze che […] hanno formato l’animo: questo pae-saggio che ignora le vie di mezzo fra la mollezza la-sciva e l’arsura dannata; l’incipit del brano pende di-chiaratamente per il primo di questi due termini.Una delle costanti stilistiche del brano è costituitadall’uso delle immagini simboliche con personifi-cazione della metafora; all’inizio la sensualità delPrincipe di Salina, risvegliata dall’arrivo di Angeli-ca, è rappresentata dai diavoletti incipriati [che]erano stati posti in fuga; esistevano ancora, certa-mente, ma allo stato larvale ed ibernavano sotto cu-muli di polvere in chissà quale soffitta dello smisura-to edificio; lo stesso vale per la seguente rappre-sentazione degli istinti come formiche destate dalsole. Inoltre, anche la descrizione antropomorfizza-ta della villa (L’architettura, la decorazione stessa ro-cocò con le loro curve impreviste evocavano anchedistese e seni eretti; l’aprirsi di ogni portale frusciavacome una cortina d’alcova) funge da introduzione atutto il tono del brano; la particolare atmosfera crea-tasi nel palazzo sembra pervadere tutti i suoi abi-tanti coinvolgendoli, con diverse reazioni, nella pas-sione amorosa, ma è anche funzionale a renderepiù efficacemente il contrasto con il casto e idillicotrasporto di Cavriaghi per Concetta, dagli indubbieffetti ironici. Una spia del forte tasso di simbolismo
del testo è costituita dall’uso della particolare co-struzione astratta nel passo: Le nozze […] stendeva-no in anticipo le loro ombre rassicuranti sul terriccioarso dei loro mutui desideri: in cui la locuzione«stendere un’ombra» passa dal senso figurato aquello proprio e porta in primo piano l’elementoconcreto del sintagma (terriccio arso, che in un co-strutto tradizionale sarebbe semplice attributo) adessa correlato semanticamente, relegando l’ele-mento portante (mutui desideri) a semplice com-plemento di specificazione. Il procedimento è mol-to diffuso nella lingua poetica novecentesca ma an-ticipato già nell’Ottocento; si veda ad esempio Pa-scoli, nero di pece a monte / stracci di nubi chiare(Temporale, vv.4-5).Si noti, infine, il procedimento chiaroscurale per cuiun elemento di registro cupo o ironico-grottesco siinsinua in una descrizione pervasa da un’atmosferaserena e distesa. Qui alla sinfonia di desideri in cuisembra avvolto il palazzo partecipa anche la ripro-duzione tenace dei tarli nei vecchi mobili. Nellascansione paratattica, l’accumulazione predilige ilritmo ternario, con un effetto di lenta scansione rit-mica: al mormorio… allo scalciare… al tenace sca-vo. Tale costrutto è frequentemente impiegato intutto il brano, e può ben definirsi una costante stili-stica lampedusiana (ad esempio nell’inseguirsi, nelperdersi, nel ritrovarsi).
VIAGGI DI ANGELICA E TANCREDI
Il campo metaforico del «viaggio» si sviluppa conuna serie di elementi semanticamente omogenei (sipartiva, terra incognita, s’imbarcavano,nave, relitti, iso-la deserta, rotta, scopritori del Nuovo Mondo); mentrela nave “amorosa” conduce a un universo dove sicontrappongono elementi di segno opposto, qui rap-presentati dalla doppia struttura chiastica:camere cu-pe… camere solatie; ambienti sfarzosi o miserabili,vuoti o affollati di relitti di mobilio eterogeneo. A intro-durre il tono favolistico di questa parte centrale delracconto vale anche la costante determinazione tem-porale:Una volta..;Più d’una volta…;Talvolta…;Un po-meriggio…; Una volta…; Un giorno…; e, come nellefavole, alla storia esterna si sostituisce sempre di piùun’esperienza personale che si presenta come
420
IL SECONDO NOVECENTODal dopoguerra a oggi
Autori
esclusiva (tanto da poter ricreare le cose, nominan-dole) a cui corrisponde simbolicamente la sovrappo-sizione della visione del mondo dei protagonisti aquella libertina rappresentata dai relitti della licenzio-sità settecentesca nelle sale disabitate. D’altro canto,la rappresentazione di una realtà esterna in disfaci-mento fisico sostiene la concezione laica e materiali-stica dell’autore e la scelta ‘edonistica’ che ne conse-gue. Il palazzo assume sempre più i connotati di unmicrocosmo impenetrabile, come nell’immaginedelle finestre che davano su un cortiletto segregato,una specie di pozzo cieco e sordo che lasciava entrareuna luce grigia e sul quale non spuntava nessun’altraapertura.Questa seconda parte è a sua volta bipartita neidue episodi di depravazione moralistica (la «stanzadei sadici») e religiosa (la stanza del Duca-Santo:Giuseppe Corbera), accomunati dall’immaginedella frusta. L’oggetto concentra su di sé i simbolidei due aspetti della perversione rappresentati nel-la parte, cui viene contrapposta la passione istintivae naturale di Tancredi e Angelica; da un lato la vizio-sità e l’immoralità degli oscuri piaceri nei quali si eracompiaciuto il Settecento agonizzante, dall’altro i ri-svolti masochistici di una religiosità non meno tor-bida e perversa, caratteristica dalla seconda metàdel Seicento fino alla Restaurazione, entrambi con-dannati dall’autore.Tancredi ravvisa nella mentalità folle e ottusa deipropri antenati un segno e una giustificazione della
progressiva decadenza della nobiltà terriera, rovi-nata, oltre che dall’incalzare degli eventi storici, datale ottusità. Ma al riscatto espiatorio delle pratichedi mortificazione del passato si sostituisce il nuovoriscatto della bellezza inconsapevole di Angelica,bella ma vacua, perché nulla potrà contro l’avvicen-darsi delle proprietà dei Salina-Sedàra.I toni pesantemente sentimentali prestati alla resadell’ultimo episodio amoroso culminano nella tea-trale irruzione del divieto della morale cattolica,simbolicamente rappresentato dal boato del cam-panone della chiesa.
RIFLESSIONE DEL NARRATORE
Con un forte stacco stilistico si assiste a un repenti-no cambiamento del punto di vista, prima focaliz-zato su Tancredi (con numerosi casi di sovrapposi-zione autoriale). Il narratore stempera l’atmosferasensuale e giocosa del brano nell’anticipazione ditristi eventi futuri che il romanzo non espliciterà, ecostringe l’‘orizzonte di attesa’ del lettore a un bru-sco mutamento in direzione malinconico-meditati-va. Il procedimento, molto frequente nella narrativanovecentesca, corrisponde alle abitudini scrittoriedi Lampedusa e alla sua concezione della preca-rietà e provvisorietà della realtà, quantunque coltain un momento squisito e breve: una sinfonia che re-ca fugaci accenni ad arie che poi dovevano esseresviluppate senza destrezza, e fallire.
Proposte operative
Analisi
Ripercorri, nelle sequenze in cui il passo si articola, le descrizioni del palazzo (dall’esterno verso l’interno)in relazione al tema centrale.
Il viaggio ‘d’amore’ nel palazzo è anche un percorso nella storia: quali epoche vengono ‘attraversate’? Qualiconcezioni dell’amore?
A conclusione dell’episodio interviene il narratore: quale significato attribuisci all’anticipazione della storiasuccessiva dei due personaggi?
3
2
1
Giuseppe Tomasi di Lampedusa • Il Gattopardo
421
Il ballo a palazzo Ponteleoneda Il Gattopardo, VI
La presentazione di Angelica all’alta società avviene durante un ballo of-ferto dalla famiglia Ponteleone, cui partecipa tutto il bel mondo dell’aristo-crazia siciliana che, dopo gli sconvolgimenti procurati dall’impresa gari-baldina, ritorna agli usati festeggiamenti, quasi a voler certificare la pro-pria persistenza, per congratularsi di esistere ancora. Ospite d’onore è quelcolonnello Pallavicino autore della sconfitta di Garibaldi ad Aspromonte(29 agosto 1862), che ha scongiurato l’avanzata dei garibaldini verso Ro-ma. È interessante notare come, con la parte del ballo e anche all’internodella stessa, si dispieghi la tendenza dell’autore ad interporre nella narra-zione delle pause, in modo da dare al lettore ‘alcuni momenti di sosta’. Laparte si inserisce infatti tra l’intermezzo costituito dalle vacanze di PadrePirrone e la morte del Principe, ove trovano drammatico sviluppo i temi –qui appena accennati – che fanno da controcanto all’atmosfera gioiosadella festa. Analogo contrasto si riscontra nelle diverse sezioni in cui è sud-divisa la parte, tutta impostata dal punto di vista di un narratore esterno,spesso coincidente (secondo moduli espressivi vicini al discorso indiretto li-bero) con quello del Principe, combattuto da sensazioni malinconichecontrapposte a momenti di ‘rasserenamento’.L’autocelebrazione collettiva della classe cui appartiene, sopravvissutaagli eventi e a se stessa, diventa per Don Fabrizio l’occasione per ladrammatica riflessione su un problema di ben più vasta portata: la pre-carietà e corruttibilità di tutto ciò che riguarda l’umana esistenza, de-stinata a cedere alle ferree leggi naturali che ne garantiscono l’ordinatosvolgimento (i principi laicamente ‘illuministici’ di Don Fabrizio si so-stanziano nella sua passione per l’astronomia), ma riluttante a rinun-ciare a una superiore giustificazione della propria condanna alla estin-zione, fosse solo nella precaria illusione del senso di eternità contenutonelle tradizioni familiari e nella perpetuazione della discendenza.Alla meritata notorietà dell’episodio ha concorso anche la riduzione ci-nematografica del romanzo (1963) sotto la direzione di un regista qua-le Luchino Visconti. Un’impeccabile ricostruzione storico-ambientale(che raggiunge nella scena del ballo i maggiori risultati artistici), unitaalla magistrale interpretazione del protagonista Burt Lancaster, ha dun-que contribuito alla conoscenza del capolavoro di Lampedusa anchepresso il vasto pubblico.
[Il ballo: ingresso di Pallavicino e dei Sedàra – Malcontento di Don Fa-brizio – La sala da ballo – In biblioteca – Don Fabrizio balla con Angeli-ca – Il ballo appassisce, si ritorna a casa.]
Novembre 1862[…] Lo scalone era di materiale modesto ma di proporzioni nobilissime;sui lati d’ogni scalino primitivi fiori spandevano il loro rozzo profumo;nel pianerottolo che divideva le due fughe, le livree amaranto di dueservi immobili sotto la cipria, ponevano una nota di colore vivace nelgrigio perlaceo dell’ambiente. Da due finestrotti alti e con grate dorategiungevano risa e mormorii infantili: i nipotini dei Ponteleone, esclusidalla festa, si rifacevano beffeggiando gli ospiti. Le signore appianavano
422
IL SECONDO NOVECENTODal dopoguerra a oggi
Autori
le pieghe delle sete, Don Fabrizio col gibus1 sottobraccio le sorpassavadi tutta la testa benché fosse uno scalino indietro. Alla porta del primosalone s’incontrarono i padroni di casa: lui, Don Diego, canuto e pan-ciuto2 che gli occhi arcigni soltanto salvavano dall’apparenza plebea; lei,donna Margherita, che di fra il corruscare del diadema e della triplicecollana di smeraldi mostrava il volto suo adunco di vecchio canonico.«Siete venuti presto! tanto meglio! ma state tranquilli, i vostri invitati nonsono ancora comparsi». Una nuova pagliuzza infastidì le unghiette sen-sibili del Gattopardo. «Anche Tancredi è già qui».Infatti nell’angolo opposto del salone il nipote, nero e sottile come unabiscia, teneva circolo a tre o quattro giovanotti e li faceva sbellicare dal-le risa per certe sue storielle certamente arrischiate, ma teneva gli occhi,inquieti come sempre, fissi alla porta d’ingresso. Le danze erano di giàcominciate e attraverso tre, quattro, cinque, sei saloni giungevano dallasala da ballo le note dell’orchestrina.«Ed aspettiamo anche il colonnello Pallavicino, quello che si è condottotanto bene ad Aspromonte».Questa frase del principe di Ponteleone sembrava semplice ma non loera. In superficie era una costatazione priva di senso politico tendente so-lo ad elogiare il tatto, la delicatezza, la commozione, la tenerezza quasi,con la quale una pallottola era stata cacciata nel piede del Generale3; edanche le scappellate, inginocchiamenti e baciamani che la avevano ac-compagnata, rivolti al ferito Eroe giacente sotto un castagno del monte ca-labrese e che sorrideva anche lui, di commozione e non già per ironia co-me gli sarebbe stato lecito (perché Garibaldi ahimè! era sprovvisto diumorismo). In uno strato intermedio della psiche principesca la frase ave-va un significato tecnico e intendeva elogiare il Colonnello per aver benpreso le proprie disposizioni, schierato opportunamente i suoi battaglionied aver potuto compiere, contro lo stesso avversario ciò che a Calatafimiera tanto incomprensibilmente fallito a Landi4. In fondo al cuore del Prin-cipe, poi, il Colonnello si era «condotto bene» perché era riuscito a ferma-re, sconfiggere, ferire e catturare Garibaldi e ciò facendo aveva salvato ilcompromesso faticosamente raggiunto fra vecchio e nuovo stato di cose.Evocato, creato quasi dalle parole lusinghiere e dalle ancor più lusin-ghiere cogitazioni, il Colonnello comparve alla scala. Procedeva fra untintinnìo di pendagli, catenelle, speroni e decorazioni, nella ben imbot-tita divisa a doppiopetto, cappello piumato sotto il braccio, sciabola ri-curva poggiata sul polso sinistro: era uomo di mondo e di maniere roton-dissime5, specializzato, come tutta l’Europa ormai sapeva, in baciamanidensi di significato; ogni signora sulle cui dita si posarono quella sera i mu-stacchi suoi odorosi fu posta in grado di rievocare con conoscenza di cau-sa, l’attimo storico che le stampe popolari avevano di già esaltato.Dopo aver sostenuto la doccia di lodi riversata su di lui dai Ponteleone,dopo aver stretto le due dita tesegli da Don Fabrizio, Pallavicino fu som-merso nello spumeggiare profumato di un gruppo di signore; i suoi trat-ti coscientemente virili emergevano al disopra delle spalle candide egiungevano sue frasi staccate: «Piangevo, contessa, piangevo come unbimbo» oppure «Lui era bello e sereno come un Arcangelo». La sua sen-timentalità maschia rapiva quelle dame che le schioppettate dei suoibersaglieri avevano di già rassicurato.Angelica e don Calogero tardavano e di già i Salina pensavano a inoltrarsinegli altri saloni, quando Tancredi piantò in asso il proprio gruppo e si di-
1. gibus: «cappello cilindrico di seta«, chemediante un sistema di molle può essereappiattito; la notazione col gibus sottobrac-cio (cioè, a testa nuda) contribuisce alladefinizione dell’imponente statura delPrincipe.2. canuto e panciuto: la predilezione per
le dittologie allitterative sostiene il ritmodella frase, che risulta più esplicita inseren-do (come nell’edizione del ’58) una virgoladopo il secondo aggettivo.3. Generale: ovviamente Garibaldi, grati-
ficato poi dell’appellativo di ferito Eroe.4. Calatafimi … Landi: a Calatafimi, il 15
maggio 1860, si trovava il generale Landicon le truppe borboniche; lo scontro, no-nostante le numerose perdite da parte deigaribaldini, si era concluso con la presadella città e la ritirata dei Borboni; il com-battimento era stato decisivo per la conqui-sta dell’Italia meridionale.5. di maniere rotondissime: «di modi ele-
ganti e grandiosi«, conformi all’eleganza ri-chiesta dal bel mondo; dal latino rotundus(ore rotundo loqui, «parlare con magnilo-quenza»).
Giuseppe Tomasi di Lampedusa • Il Gattopardo
423
resse come un razzo verso l’ingresso: gli attesi erano giunti. Al disopra del-l’ordinato turbinìo della crinolina rosea le bianche spalle di Angelica rica-devano verso le braccia forti e dolci; la testa si ergeva piccola e sdegnosasul collo liscio di gioventù e adorno di perle volutamente modeste. Quan-do dall’apertura del lungo guanto glacé 6 essa fece uscire la mano non pic-cola ma di taglio perfetto, si vide brillare lo zaffiro napoletano. Don Calo-gero era nella di lei scia, sorcetto custode di una fiammeggiante rosa; negliabiti di lui non vi era eleganza ma decenza sì, questa volta; solo suo errorefu quello di portare all’occhiello la croce della Corona d’Italia7 conferitaglidi recente; essa, per altro, scomparve presto in una delle tasche clandesti-ne del «frack» di Tancredi.Il fidanzato aveva di già insegnato ad Angelica l’impassibilità, questofondamento della distinzione («Tu puoi esser espansiva e chiassosa sol-tanto con me, cara; per tutti gli altri devi essere la futura principessa diFalconeri, superiore a molti, pari a chiunque»), e quindi il saluto di lei al-la padrona di casa fu una non spontanea ma riuscitissima mescolanza dimodestia verginale, alterigia neo-aristocratica e grazia giovanile.I palermitani sono dopo tutto degli italiani, sensibili quindi quanti altrimai al fascino della bellezza ed al prestigio del denaro; inoltre Tancrediessendo notoriamente squattrinato era giudicato, per quanto attraente, unpartito non desiderabile (a torto, del resto, come si vide poi quando futroppo tardi); egli era quindi più apprezzato dalle signore sposate chedalle ragazze da marito. Questi meriti e demeriti congiunti fecero sì chel’accoglienza ricevuta da Angelica fosse di un calore imprevisto; a qualchegiovanotto, a dir vero, avrebbe potuto rincrescere di non aver dissepoltoper sé una così bella anfora colma di monete; ma Donnafugata era feudodi Don Fabrizio e se egli aveva rinvenuto lì quel tesoro e lo aveva passa-to all’amato Tancredi non si poteva rammaricarsene più di quanto ci si sa-rebbe amareggiati se avesse scoperto una miniera di zolfo in una sua ter-ra: era roba sua, non c’era da dire.Anche queste labili opposizioni, d’altronde, dileguavano dinanzi al rag-giare di quegli occhi; a un certo momento vi fu una vera calca di giova-notti che volevano farsi presentare e richiedere un ballo: a ciascuno An-gelica dispensava un sorriso della sua bocca di fragola, a ciascuno mo-strava il proprio carnet nel quale a ogni polka, mazurka e valzer segui-va la firma possessiva: Falconeri. Da parte delle signorine le proposte di«darsi del tu» fioccavano e dopo un’ora Angelica si trovava a suo agio frapersone che del selvaggiume della madre e della taccagneria del padrenon avevano la minima idea8.Il contegno di lei non si smentì neppure un minuto: mai la si vide erra-re sola con la testa fra le nuvole, mai le braccia le si scostarono dal bu-sto; mai la sua voce si alzò al disopra del «diapason» (del resto abbastan-za alto) delle altre signore. Poiché Tancredi le aveva detto il giorno pri-ma «Vedi, cara, noi (e quindi anche tu, adesso) teniamo alle nostre caseed al nostro mobilio più che a qualsiasi altra cosa; nulla ci offende piùdella noncuranza rispetto a questo; quindi guarda tutto e loda tutto; delresto palazzo Ponteleone lo merita; ma poiché non sei più una provin-cialotta che si sorprende di ogni cosa, mescolerai sempre una qualcheriserva alla lode; ammira sì ma paragona sempre con qualche archetipovisto prima, e che sia illustre». Le lunghe visite al palazzo di Donnafuga-ta avevano insegnato molto ad Angelica, e così quella sera ammirò ogniarazzo ma disse che quelli di palazzo Pitti avevano le bordure più belle;
6. guanto glacé: «guanto glassato» (infrancese), cioè «lucido, satinato».7. la croce … d’Italia: al vezzo di Don Ca-
logero, che ostenta l’unico grado nobiliaredi recente acquisto, si aggiunge l’inoppor-tuno sfoggio del simbolo del nuovo Statounitario davanti ai rappresentanti della vec-chia monarchia borbonica.8. del selvaggiume … idea: la famiglia
Sedàra ha origini oscure e chiacchierate;lo svela, in particolare, la confessione delguardacaccia e ‘amico’ Don Ciccio Tumèoa Don Fabrizio sulla madre di Angelica:pare che donna Bastiana sia una speciedi animale: non sa leggere, non sa scrive-re, non conosce l’orologio, quasi non saparlare: una bellissima giumenta, volut-tuosa e rozza; […] buona ad andare a let-to e basta.
424
IL SECONDO NOVECENTODal dopoguerra a oggi
Autori
lodò una Madonna del Dolci ma fece ricordare che quella del Granducaaveva una malinconia meglio espressa; e financo della fetta di torta cheun premuroso giovin signore9 le portò disse che era eccellente e buonaquasi come quella di «monsù Gaston», il cuoco dei Salina. E poiché«monsù Gaston» era il Raffaello fra i cuochi e gli arazzi di Pitti i «monsùGaston» fra le tapezzerie, nessuno poté trovarvi da ridire, anzi tutti furo-no lusingati dal paragone ed essa cominciò già da quella sera ad acqui-stare la fama di cortese ma inflessibile intenditrice di arte che doveva,abusivamente, accompagnarla in tutta la sua lunga vita.Mentre Angelica mieteva allori, Maria-Stella spettegolava su di un diva-no con due vecchie amiche e Concetta e Carolina raggelavano con la lo-ro timidità i giovanotti più cortesi, Don Fabrizio lui, errava per i saloni:baciava la mano delle signore che incontrava, indolenziva le spalle de-gli uomini che voleva festeggiare, ma sentiva che il cattivo umore lo in-vadeva lentamente. Anzitutto, la casa non gli piaceva: i Ponteleone dasettanta anni non avevano rinnovato l’arredamento ed esso era ancoraquello del tempo della regina Maria-Carolina, e lui che credeva di averedei gusti moderni s’indignava. “Ma, Santo Dio, con i redditi di Diego civorrebbe poco a metter fuori tutti questi ‘tremò’, questi specchi appan-nati! Si faccia fare un bel mobilio di palissandro e peluche, stia a viverecomodamente lui e non costringa i suoi invitati ad aggirarsi per questecatacombe. Finirò col dirglielo!”. Ma non lo disse mai a Diego perchéqueste sue opinioni nascevano solo dal malumore e dalla sua tendenzaalla contradizione, erano presto dimenticate e lui stesso non mutavanulla né a S. Lorenzo né a Donnafugata. Intanto però bastarono ad au-mentargli il disagio.Le donne che erano al ballo non gli piacevano neppure: due o tre fraquelle anziane erano state sue amanti e vedendole adesso appesantitedagli anni e dalle nuore, faticava a ricreare per sé l’immagine di loroquali erano venti anni fa e s’irritava pensando che aveva sciupato i pro-pri anni migliori a inseguire (ed a raggiungere) simili sciattone. Anche legiovani però non gli dicevano gran che, meno un paio: la giovanissimaduchessa di Palma della quale ammirava gli occhi grigi e la severa soa-vità del portamento, Tutù Làscari anche dalla quale se fosse stato piùgiovane avrebbe saputo trarre accordi singolarissimi. Ma le altre… erabene che dalle tenebre di Donnafugata fosse emersa Angelica per mo-strare alle palermitane cosa fosse una bella donna.Non gli si poteva dar torto: in quegli anni la frequenza dei matrimoni fracugini, dettati da pigrizia sessuale e da calcoli terrieri, la scarsezza diproteine nell’alimentazione aggravata dall’abbondanza di amidacei, lamancanza totale di aria fresca e di movimento, avevano riempito i salot-ti di una turba di ragazzine incredibilmente basse, inverosimilmente oli-vastre, insopportabilmente ciangottanti10; esse passavano il tempo rag-grumate tra loro, lanciando solo corali richiami ai giovanotti impauriti,destinate, sembrava, soltanto a far da sfondo alle tre o quattro bellecreature che come la bionda Maria Palma, la bellissima Eleonora Giardi-nelli passavano scivolando come cigni su uno stagno fitto di ranocchie.Più le vedeva e più s’irritava; la sua mente condizionata dalle lunghe so-litudini e dai pensieri astratti, finì a un dato momento, mentre passavaper una lunga galleria sul pouf centrale della quale si era riunita una nu-merosa colonia di quelle creature, col procurargli una specie di alluci-nazione: gli sembrava di essere il guardiano di un giardino zoologico
9. giovin signore: l’espressione allude evi-dentemente al destinatario del Giorno pari-niano, Sai che compagna / con cui partir dela giornata illustre / i travagli e le glorie ilciel destina / al giovane signore (Il Mattino,vv.252-255).10. ciangottanti: che chiacchieravano con-fusamente e in modo insopportabile.
Giuseppe Tomasi di Lampedusa • Il Gattopardo
425
posto a sorvegliare un centinaio di scimmiette: si aspettava di vederle aun tratto arrampicarsi sui lampadari e da lì, sospese per le code, dondo-larsi esibendo i deretani e lanciando gusci di nocciola, stridori e digri-gnamenti sui pacifici visitatori.Strano a dirsi fu una sensazione religiosa ad estraniarlo da quella visio-ne zoologica: infatti dal gruppo di bertucce crinolinate11 si alzava unamonotona continua invocazione sacra: «Maria! Maria!» esclamavano per-petuamente quelle povere figliole. «Maria! che bella casa!». «Maria! chebell’uomo è il colonnello Pallavicino!». «Maria! mi fanno male i piedi!».«Maria! che fame che ho! quando si apre il ‘bouffet’?». Il nome della Ver-gine, invocato da quel coro virgineo riempiva la galleria e di nuovocambiava le scimmiette in donne, poiché non risultava ancora che iouistiti12 delle foreste brasiliane si fossero convertiti al Cattolicesimo.Leggermente nauseato, il Principe passò nel salotto accanto: lì invecestava accampata la tribù diversa e ostile degli uomini: i giovani ballava-no ed i presenti erano soltanto degli anziani, tutti suoi amici. Sedette unpoco fra loro: lì la Regina dei Cieli non era più nominata invano; ma, incompenso, i luoghi comuni, i discorsi piatti intorbidavano l’aria. Fraquesti signori Don Fabrizio passava per essere uno «stravagante»; il suointeressamento alla matematica era considerato quasi come una pecca-minosa perversione, e se lui non fosse stato proprio il principe di Salinae se non lo si fosse saputo ottimo cavallerizzo, infaticabile cacciatore emedianamente donnaiolo, le sue parallassi13 e i suoi telescopi avrebbe-ro rischiato di farlo mettere al bando; però già gli si parlava poco perchél’azzurro freddo dei suoi occhi, intravisto fra le palpebre pesanti, facevaperdere le staffe agli interlocutori ed egli si trovava spesso isolato nongià per rispetto, come credeva, ma per timore.Si alzò; la malinconia si era mutata in umor nero autentico. Aveva fattomale a venire al ballo: Stella, Angelica, le figliole se la sarebbero cavatabenissimo da sole, e lui in questo momento sarebbe beato nello studio-lo attiguo alla terrazza in via Salina, ad ascoltare il chioccolìo della fon-tana ed a cercar di acchiappare le comete per la coda14. «Tant’è, adessoci sono; andarsene sarebbe scortese. Andiamo a guardare i ballerini».La sala da ballo era tutta oro: liscio sui cornicioni cincischiato15 nelle in-quadrature delle porte, damaschinato chiaro quasi argenteo su menochiaro nelle porte stesse e nelle imposte che chiudevano le finestre e leannullavano conferendo così all’ambiente un significato orgoglioso discrigno escludente qualsiasi riferimento all’esterno non degno. Non erala doratura sfacciata che adesso i decoratori sfoggiano, ma un oro con-sunto, pallido come i capelli di certe bambine del Nord, impegnato anascondere il proprio valore sotto una pudicizia ormai perduta di mate-ria preziosa che voleva mostrare la propria bellezza e far dimenticare ilproprio costo; qua e là sui pannelli nodi di fiori rococò di un colore tan-to svanito da non sembrare altro che un effimero rossore dovuto al ri-flesso dei lampadari.Quella tonalità solare, quel variegare di brillii e di ombre fecero tuttaviadolere il cuore di Don Fabrizio che se ne stava nero e rigido nel vano diuna porta: in quella sala eminentemente patrizia gli venivano in menteimmagini campagnole: il timbro cromatico era quello degli sterminatiseminerî16 attorno a Donnafugata, estatici, imploranti clemenza sotto latirannia del sole: anche in questa sala come nei feudi a metà Agosto, ilraccolto era stato compiuto da tempo, immagazzinato altrove e, come là,
11. bertucce crinolinate: «scimmiette vesti-te di crinolina» (ma nell’edizione del 1958si legge: crinolate); la deformazione visivacoinvolge anche l’espressione linguisticafino a generare un neologismo aggettivalederivato da un sostantivo.12. ouistiti: «uistiti», scimmietta amazzoni-ca di piccole dimensioni.13. parallassi: termine astronomico cheindica «l’angolo sotto il quale si vede da uncorpo celeste una data unità di lunghezza»;la passione per i calcoli astronomici è undato biografico di Giulio Salina, bisnonnodell’autore, a cui la figura di Don Fabrizioè direttamente ispirata.14. acchiappare … coda: «inseguire sogniirrealizzabili», ma anche, ironicamente,«stare con la testa nelle nuvole»; espressio-ne che rivela la presa di distanza del narra-tore e l’amara autoironia del principe.15. cincischiato: «gualcito»; la descrizionedella sala da ballo si comprende meglioleggendo così il testo (come corregge Bas-sani): liscio sui cornicioni, cincischiatonelle inquadrature delle porte, damaschi-nato chiaro quasi argenteo su, meno chia-ro nelle porte stesse.16. seminerî: campi seminati.
426
IL SECONDO NOVECENTODal dopoguerra a oggi
Autori
ne rimaneva soltanto il ricordo nel colore delle stoppie; arse d’altronde einutili. Il valzer le cui note traversavano l’aria calda gli sembrava solo unastilizzazione di quell’incessante passaggio dei venti che arpeggiano il pro-prio lutto sulle superfici assetate, ieri, oggi, domani, sempre, sempre,sempre. La folla dei danzatori fra i quali pur contava tante persone vicinealla sua carne se non al suo cuore, finì col sembrargli irreale, composta diquella materia della quale son tessuti i ricordi perenni che è più labile an-cora di quella che ci turba nei sogni. Nel soffitto gli Dei, reclini su scanni17
dorati, guardavano in giù sorridenti e inesorabili come il cielo d’estate. Sicredevano eterni: una bomba fabbricata a Pittsburgh, Penn. doveva nel1943 provar loro il contrario18.«Bello, principe, bello! Cose così non se ne fanno più adesso, al prezzoattuale dell’oro zecchino!». Sedàra si era posto vicino a lui, i suoi oc-chietti svegli percorrevano l’ambiente, insensibili alla grazia, attenti alvalore monetario.Don Fabrizio, ad un tratto, sentì che lo odiava; era all’affermarsi di lui,di cento altri suoi simili, ai loro oscuri intrighi, alla loro tenace avarizia eavidità che era dovuto il senso di morte che adesso incupiva questi pa-lazzi; si doveva a lui, ai suoi compari, ai loro rancori, al loro senso d’in-feriorità, al loro non esser riusciti a fiorire, se adesso anche a lui, DonFabrizio, gli abiti neri dei ballerini ricordavano le cornacchie che plana-vano, alla ricerca di prede putride, al disopra dei valloncelli sperduti.Ebbe voglia di rispondergli malamente, d’invitarlo ad andarsene fuoridai piedi. Ma non si poteva: era un ospite, era il padre della cara Ange-lica. Era forse un infelice come gli altri.«Bello, don Calogero, bello. Ma ciò che supera tutto sono i nostri due ra-gazzi». Angelica e Tancredi passavano in quel momento davanti a loro, ladestra inguantata di lui posata a taglio sulla vita di lei, le braccia tese e com-penetrate, gli occhi di ciascuno fissi in quelli dell’altro. Il nero del «frack» dilui, il roseo della veste di lei, frammisti, formavano uno strano gioiello. Essioffrivano lo spettacolo più patetico di ogni altro, quello di due giovanissimiinnamorati che ballano insieme, ciechi ai difetti reciproci, sordi agli ammo-nimenti del destino, illusi che tutto il cammino della vita sarà liscio come ilpavimento del salone, attori ignari cui un regista fa recitare la parte di Giu-lietta e quella di Romeo nascondendo la cripta e il veleno, di già previsti nelcopione. Né l’uno né l’altra erano buoni, ciascuno pieno di calcoli, gonfiodi mire segrete; ma entrambi erano cari e commoventi mentre le loro nonlimpide ma ingenue ambizioni erano obliterate dalle parole di giocosa te-nerezza che lui le mormorava all’orecchio, dal profumo dei capelli di lei,dalla reciproca stretta di quei loro corpi destinati a morire.I due giovani si allontanavano, altre coppie passavano, meno belle, al-trettanto commoventi, immerse ciascuna nella propria passeggera cecità.Don Fabrizio sentì spetrarsi19 il cuore: il suo disgusto cedeva il posto allacompassione per questi effimeri esseri che cercavano di godere dell’esi-guo raggio di luce accordato loro fra le due tenebre prima della culla, do-po gli ultimi strattoni. Come era possibile infierire contro chi, se ne è si-curi, dovrà morire? voleva dire esser vili come le pescivendole che ses-sant’anni fa oltraggiavano i condannati nella piazza del Mercato. Anche lescimmiette sui poufs, anche i vecchi babbei suoi amici erano miserevoli,insalvabili e cari come il bestiame che la notte mugola per le vie dellacittà, condotto al macello; all’orecchio di ciascuno di essi sarebbe giuntoun giorno lo scampanellìo che aveva udito tre ore fa dietro S. Domenico.
17. scanni: seggi regali.18. una bomba … contrario: il ricordo èesplicitamente autobiografico in quanto sitratta della bomba che ha distrutto il pa-lazzo di Tomasi di Lampedusa, non quellodei Ponteleone; il romanzo si costituiscequindi, sempre di più, come riparazionepostuma.19. spetrarsi: «intenerirsi», aulicismo diuso poetico; vale anche per «liberarsi, di-staccarsi», si veda ad esempio Petrarca,con quanta faticha oggi mi spetro / del’errore, ov’io stesso m’era involto! (Rerumvulgarium fragmenta, LXXXIX, vv.13-14.
Giuseppe Tomasi di Lampedusa • Il Gattopardo
427
Non era lecito odiare altro che l’eternità.E poi tutta la gente che riempiva i saloni, tutte quelle donne bruttine, tuttiquesti uomini sciocchi, questi due sessi vanagloriosi, erano il sangue delsuo sangue, erano lui stesso; con essi soltanto si comprendeva, soltantocon essi era a suo agio. “Sono forse più intelligente, sono certamente piùcolto di loro, ma sono della medesima risma, con essi debbo solidarizzare”.Si accorse che don Calogero parlava con Giovanni Finale del possibilerialzo del prezzo dei caciocavalli e che, speranzosi di questa beatificaevenienza, i suoi occhi si erano fatti liquidi e mansueti. Poteva svignar-sela senza rimorsi.Fino a questo momento l’irritazione accumulata gli aveva dato energia;adesso con la distensione sopravvenne la stanchezza: erano di già ledue. Cercò un posto dove poter sedere tranquillo, lontano dagli uomini,amati e fratelli, va bene, ma sempre noiosi. Lo trovò presto: la bibliote-ca, piccola, silenziosa, illuminata e vuota. Sedette poi si rialzò per beredell’acqua che si trovava su un tavolinetto. “Non c’è che l’acqua a esserdavvero buona” pensò da autentico siciliano; e non si asciugò le goc-cioline rimaste sulle labbra. Sedette di nuovo. La biblioteca gli piaceva,ci si sentì presto a suo agio; essa non si opponeva alla di lui presa di pos-sesso perché era impersonale come lo sono le stanze poco abitate: Pon-teleone non era tipo da perdere il suo tempo lì dentro. Si mise a guarda-re un quadro che gli stava di fronte: era una buona copia della «Mortedel Giusto» di Greuze. Il vegliardo stava spirando nel suo letto, fra sbuf-fi di biancheria pulitissima, circondato dai nipoti afflitti e da nipotine chelevavano le braccia verso il soffitto. Le ragazze erano carine, procaci, ildisordine delle loro vesti suggeriva più il libertinaggio che il dolore; sicapiva subito che erano loro il vero soggetto del quadro. Nondimeno unmomento Don Fabrizio si sorprese che Diego tenesse ad aver sempredinanzi agli occhi questa scena malinconica; poi si rassicurò pensandoche egli doveva entrare in questa stanza sì e no una volta all’anno.Subito dopo chiese a se stesso se la propria morte sarebbe stata simile aquella: probabilmente sì, a parte che la biancheria sarebbe stata menoimpeccabile (lui lo sapeva, le lenzuola degli agonizzanti sono sempresudice, ci son le bave, le deiezioni, le macchie di medicine…) e che erada sperare che Concetta, Carolina e le altre sarebbero state più decente-mente vestite. Ma, in complesso, lo stesso. Come sempre la considera-zione della propria morte lo rasserenava tanto quanto lo aveva turbatoquella della morte degli altri; forse perché, stringi stringi, la sua morteera in primo luogo quella di tutto il mondo?Da questo passò a pensare che occorreva far fare delle riparazioni allatomba di famiglia, ai Cappuccini. Peccato che non fosse più permessoappendere là i cadaveri per il collo nella cripta e vederli poi mummifi-carsi lentamente: lui ci avrebbe fatto una magnifica figura su quel muro,grande e lungo com’era, a spaventare le ragazze con l’immoto sorrisodel volto incartapecorito, con i lunghissimi calzoni di piqué bianco. Mano, lo avrebbero vestito di gala, forse in questo stesso «frack» che avevaaddosso.La porta si aprì. «Zione, sei una bellezza stasera. La marsina ti sta alla per-fezione. Ma cosa stai guardando? Corteggi la morte?».Tancredi era a braccio di Angelica: tutti e due erano ancora sotto l’in-flusso sensuale del ballo, stanchi. Angelica sedette, chiese a Tancredi unfazzoletto per asciugarsi le tempie; fu Don Fabrizio a darle il suo. I due
428
IL SECONDO NOVECENTODal dopoguerra a oggi
Autori
giovani guardavano il quadro con noncuranza assoluta. Per entrambi laconoscenza della morte era puramente intellettuale, era per così dire undato di coltura e basta, non un’esperienza che avesse loro forato il mi-dollo delle ossa. La morte, sì, esisteva, senza dubbio, ma era roba ad usodegli altri; Don Fabrizio pensava che è per la ignoranza intima di questasuprema consolazione che i giovani sentono i dolori più acerbamentedei vecchi: per questi l’uscita di sicurezza è più vicina.«Principe» diceva Angelica «abbiamo saputo che Lei era qui; siamo venu-ti per riposarci ma anche per chiederle qualche cosa; spero che non mela rifiuterà». I suoi occhi ridevano di malizia, la sua mano si posava sullamanica di Don Fabrizio. «Volevo chiederle di ballare con me la prossima“mazurka”. Dica di sì, non faccia il cattivo: si sa che Lei era un gran bal-lerino». Il Principe fu contentissimo, si sentiva tutto ringalluzzito. Altroche cripta dei Cappuccini! Le sue guance pelose si agitavano per il pia-cere. L’idea della “mazurka” però lo spaventava un poco: questo ballomilitare, tutto battute di piedi e giravolte non era più roba per le suegiunture. Inginocchiarsi davanti ad Angelica sarebbe stato un piacere,ma se dopo avesse fatto fatica a rialzarsi?«Grazie, Angelica, mi ringiovanisci. Sarò felice di ubbidirti, ma la “ma-zurka” no, concedimi il primo valzer».«Lo vedi, Tancredi, com’è buono lo zio? Non fa i capricci come te. Sa,Principe, lui non voleva che glielo chiedessi: è geloso».Tancredi rideva: «Quando si ha uno zio bello ed elegante come lui è giu-sto esser gelosi. Ma, insomma, per questa volta non mi oppongo». Sorri-devano tutti e tre, e Don Fabrizio non capiva se avessero complottatoquesta proposta per fargli piacere o per prenderlo in giro. Non avevaimportanza: erano cari lo stesso.Al momento di uscire Angelica sfiorò con la mano la tapezzeria di una pol-trona. «Sono carine queste; un bel colore; ma quelle di casa sua, Princi-pe…». La nave procedeva nell’abbrivo20 ricevuto. Tancredi intervenne: «Ba-sta, Angelica. Noi due ti vogliamo bene anche al di fuori delle tue cono-scenze in fatto di mobilio. Lascia stare le sedie e vieni a ballare».Mentre andava al salone da ballo Don Fabrizio vide che Sedàra parlavaancora con Giovanni Finale. Si udivano le parole «russella», «primintìo»,«marzolino»: paragonavano i pregi dei grani da semina. Il Principe previ-de imminente un invito a Margarossa, il podere per il quale Finale si sta-va rovinando a forza di innovazioni agricole.
La coppia Angelica-Don Fabrizio fece una magnifica figura. Gli enormipiedi del Principe si muovevano con delicatezza sorprendente e mai lescarpette di raso della sua dama furono in pericolo di esser sfiorate; lazampaccia di lui le stringeva la vita con vigorosa fermezza, il mentopoggiava sull’onda letèa21 dei capelli di lei; dalla scollatura di Angelicasaliva un profumo di bouquet à la Maréchale, soprattutto un aroma dipelle giovane e liscia. Alla memoria di lui risalì una frase di Tumèo: «Lesue lenzuola debbono avere l’odore del paradiso». Frase sconveniente,frase villana; esatta però. Quel Tancredi…Lei parlava. La sua naturale vanità era sodisfatta quanto la sua tenaceambizione. «Sono così felice, zione. Tutti sono stati tanto gentili, tantobuoni. Tancredi, poi, è un amore; e anche Lei è un amore. Tutto questolo devo a Lei, zione, anche Tancredi. Perché se Lei non avesse voluto sisa come sarebbe andato a finire». «Io non c’entro, figlia mia; tutto lo de-
20. abbrivo: «velocità di un mezzo di navi-gazione», ma anche in senso figurato:«spinta iniziale, propulsione».21. onda letèa: «onda di morte»; leteo, «delfiume Lete» è aggettivo letterario che insenso figurato vale «che produce oblio», oanche «apportatore di morte»; si veda in Pa-rini, Imene or porta / non più serti di roseal crine avvolti, / ma stupido papaverogrondante / di crassa onda letea (Il Gior-no, Il Meriggio, vv.410-413).
Giuseppe Tomasi di Lampedusa • Il Gattopardo
429
vi a te sola». Era vero: nessun Tancredi avrebbe mai resistito alla sua bel-lezza unita al suo patrimonio. La avrebbe sposata calpestando tutto. Unafitta gli traversò il cuore: pensava agli occhi alteri e sconfitti di Concetta.Ma fu un dolore breve: ad ogni giro un anno gli cadeva giù dalle spalle;presto si ritrovò come a venti anni quando in questa sala stessa ballavacon Stella, quando ignorava ancora cosa fossero le delusioni, il tedio, ilresto. Per un attimo, quella notte, la morte fu di nuovo ai suoi occhi, «ro-ba per gli altri».Tanto assorto era nei suoi ricordi che combaciavano così bene con la sen-sazione presente che non si accorse che ad un certo punto Angelica e luiballavano soli. Forse istigate da Tancredi le altre coppie avevano smessoe stavano a guardare; anche i due Ponteleone erano lì: sembravano inte-neriti, erano anziani e forse comprendevano. Stella pure era anziana,però, ma da sotto una porta i suoi occhi erano foschi. Quando l’orchestri-na tacque un applauso non scoppiò soltanto perché Don Fabrizio aveval’aspetto troppo leonino perché si arrischiassero simili sconvenienze.Finito il valzer, Angelica propose a Don Fabrizio di cenare alla tavolasua e di Tancredi; lui ne sarebbe stato molto contento ma proprio inquel momento i ricordi della sua gioventù erano troppo vivaci perchénon si rendesse conto di quanto una cena con un vecchio zio gli sareb-be riuscita ostica, allora, mentre Stella era lì a due passi. «Soli voglionostare gli innamorati o magari con estranei; con anziani e, peggio chepeggio, con parenti, mai».«Grazie, Angelica, non ho appetito. Prenderò qualcosa all’impiedi. Vaicon Tancredi, non pensate a me».
[Il Principe entra nella sala dove è stato imbandito il buffet, rifiuta l’of-ferta di Tancredi già seduto ai tavoli vicino ad Angelica e si accomodaaccanto al Pallavicino, intessendo con lui un dialogo che subito diventamonologo del Colonnello sui recenti fatti d’Aspromonte. Il quadro politi-co fatto al Principe sul recente Stato unitario è sconfortante e si conclu-de sulla amareggiata affermazione che mai siamo stati tanto divisi comeda quando siamo uniti. Intanto la festa volge al termine.]
Il ballo continuò a lungo e si fecero le sei del mattino: tutti erano sfinitie avrebbero voluto essere a letto da almeno tre ore: ma andar via prestoera come proclamare che la festa non era riuscita e offendere i padronidi casa che, poveretti, si erano data tanta pena.I volti delle signore erano lividi, gli abiti sgualciti, gli aliti pesanti. «Maria!che stanchezza! Maria! che sonno!». Al disopra delle loro cravatte in di-sordine le facce degli uomini erano gialle e rugose, le bocche intrise disaliva amara. Le loro visite a una cameretta trascurata, a livello della log-gia dell’orchestra, si facevano più frequenti: in essa era disposta in bel-l’ordine una ventina di vasti pitali, a quell’ora quasi tutti colmi, alcunisciabordanti per terra. Sentendo che il ballo stava per finire i servitori as-sonnati non cambiavano più le candele dei lampadari: i mozziconi cortispandevano nei saloni una luce diversa, fumosa, di mal augurio. Nellasala del buffet, vuota, vi erano soltanto piatti smantellati, bicchieri conun dito di vino che i camerieri bevevano in fretta guardandosi attorno.La luce dell’alba si insinuava dai giunti delle imposte, plebea.La riunione andava sgretolandosi e attorno a donna Margherita vi era giàun gruppo di gente che si congedava. «Bellissimo! un sogno! all’antica!».
430
IL SECONDO NOVECENTODal dopoguerra a oggi
Autori
Tancredi dovette faticare per svegliare Don Calogero che con la testa al-l’indietro si era addormentato su una poltrona appartata; i calzoni glierano risaliti sino al ginocchio e al disopra delle calze di seta si vedeva-no le estremità delle sue mutande, davvero molto paesane. Il colonnel-lo Pallavicino aveva le occhiaie anche lui; dichiarava però, a chi voles-se sentirlo, che non sarebbe andato a casa e che sarebbe passato diret-tamente da palazzo Ponteleone alla piazza d’armi; così infatti voleva laferrea tradizione seguita dai militari invitati a un ballo.Quando la famiglia si fu messa in carrozza (la guazza22 aveva reso umi-di i cuscini) Don Fabrizio disse che sarebbe tornato a casa a piedi; unpo’ di fresco gli avrebbe fatto bene, aveva un’ombra di mal di capo. Laverità era che voleva attingere un po’ di conforto guardando le stelle. Ven’era ancora qualcuna proprio su, allo zenith. Come sempre il vederlelo rianimò; erano lontane, onnipotenti e nello stesso tempo tanto dociliai suoi calcoli; proprio il contrario degli uomini, troppo vicini sempre,deboli e pur tanto riottosi.Nelle strade vi era di già un po’ di movimento: qualche carro con cu-muli d’immondizia alti quattro volte l’asinello grigio che li trascinava.Un lungo barroccio23 scoperto portava accatastati i buoi uccisi poco pri-ma al macello, già fatti a quarti e che esibivano i loro meccanismi più in-timi con l’impudicizia della morte. A intervalli una qualche goccia rossae densa cadeva sul selciato.Da una viuzza traversa intravide la parte orientale del cielo, al disopradel mare. Venere stava lì, avvolta nel suo turbante di vapori autunnali.Essa era sempre fedele, aspettava sempre Don Fabrizio alle sue uscitemattutine, a Donnafugata prima della caccia, adesso dopo il ballo.Don Fabrizio sospirò. Quando si sarebbe decisa a dargli un appunta-mento meno effimero, lontano dai torsoli e dal sangue, nella propria re-gione di perenne certezza?
22. guazza: rugiada mattutina.23. barroccio: carrettino (ma la forma atte-stata è «baroccio»).
Analisi del testo
N ell’analisi del testo seguiremo la scansione sug-gerita dai sei sommari dell’indice.
[1. Il ballo: ingresso di Pallavicino e dei Sedàra (Lo sca-lone era di materiale modesto […] in tutta la sua lungavita)] Tancredi è introdotto da una similitudine (nero esottile come una biscia) riferita alla sua astuzia e abi-lità. La similitudine animale occorre però in tutto ilbrano, con iperbolica deformazione caricaturale deipartecipanti alla festa.Segue poi una lunga digressione sulla dichiarazionedel principe di Ponteleone (Pallavicino,quello che si ècondotto tanto bene ad Aspromonte), e in particolaresull’interpretazione di Don Fabrizio.L’analisi di Toma-si seleziona tre livelli di percezione: In superficie […].
In uno strato intermedio della psiche principesca […].In fondo al cuore del Principe. La digressione contra-sta con le dichiarazioni poetiche a favore dellastendhaliana «magrezza», capace di presentare unpersonaggio senza eccedere in dialoghi e pensieri elasciando al lettore la possibilità di dedurre il suocomportamento semplicemente dalla descrizione fi-sica. Nella presentazione di Angelica la dittologia op-positiva forti e dolci ha valore più generale sulle qua-lità della figlia di Don Calogero; l’educazione fiorenti-na ne ha smussato certe rozzezze di comportamen-to, ma non ne ha soffocato la naturale, istintiva forza dicarattere (anche se il personaggio si riscatta della lu-ce ‘primitiva’ in cui era stato presentato nelle parti
Giuseppe Tomasi di Lampedusa • Il Gattopardo
431
precedenti, sfoggiando ora sapiente grazia e affettatamoderazione).[2. Malcontento di Don Fabrizio (Mentre Angelica mie-teva allori […] Andiamo a guardare i ballerini)] Dopo il‘rasserenamento’ seguito all’entrata di Angelica, il to-no e il punto di vista cambiano repentinamente e DonFabrizio diventa l’osservatore privilegiato della festa.Si noti come la descrizione degli ambienti e dei par-tecipanti si sposti via via da un tono realistico-referen-ziale a uno onirico-introspettivo, corrispondente alladeformazione che il reale assume nella mente delPrincipe. Il fitto stuolo di ragazze presenti alla festa,adesempio, subisce nella sua percezione allucinata unalenta deformazione animale, prima solo accennata.[3.La sala da ballo] La visione della sala da ballo stuc-cata ad ori sollecita la seconda ‘visione’ di Don Fabri-zio: la campagna dopo il raccolto, bruciata dal sole edesolata. Anche qui il ricordo genera ambivalenza,tra la bellezza delle decorazioni e il senso di morteche aleggia nella sala funerea.[4. In biblioteca (Fino a questo momento […] a forza diinnovazioni agricole)] La sequenza è tutta giocata sul te-ma della morte, attraverso l’immagine del quadro diGreuze. L’incidentale (lui lo sapeva… medicine…)esplicita il pensiero dell’autore,oscillante tra una visio-ne liberatoria secondo cui la morte è consolazione su-prema al «male di vivere» (ma anche condizione sen-suale di «immobilità voluttuosa»),e una illuministica le-
gata alla corruttibilità della materia. A quest’ultima siispirano i pensieri di Don Fabrizio sulla tomba di fami-glia.L’ingresso di Tancredi ha una funzione di stacco eintermezzo ironico-giocoso dalla tensione emotiva e sicostituisce come momento-pausa nella narrazione.[5. Don Fabrizio balla con Angelica (La coppia Angeli-ca-Don Fabrizio […] Vai con Tancredi, non pensate ame)] Si noti la consueta contrapposizione tra elemen-ti antitetici: qui la rudezza vigorosa del Principe e lagrazia di Angelica. L’uso della morfologia animaleper la descrizione del Principe (la zampaccia di lui lestringeva la vita con vigorosa fermezza) è frequentenel romanzo (si veda,oltre alla nota 5, il gesto affettuo-so di Maria Stella nei confronti di Don Fabrizio nellaparte II: La Principessa tese la mano infantile e carezzòla potente zampaccia che riposava sulla tovaglia).[6. Il ballo appassisce, si ritorna a casa] Lo squallidoquadro offerto dai partecipanti alla festa conclude de-gnamente questa occasione mondana che ha mostra-to al lettore una classe definitivamente decaduta e ca-pace ormai di celebrare soltanto se stessa.Simmetricamente, come l’incontro col prete recanteil Santo Viatico ha aperto la parte con una nota dolo-rosa, un’immagine di morte dai toni macabro-grotte-schi la conclude. L’effetto di contrasto con la descri-zione della fissità imperturbabile di Venere (era sem-pre fedele) appartiene a uno stilema abbondante-mente rilevato nella pagina lampedusiana.
Proposte operative
Analisi
Secondo il critico Bàrberi Squarotti «una grandetragedia funebre, una contemplazione della mortecostituisce il tema supremo del Gattopardo, la ragioneultima della sua poesia. Il ballo dai Ponteleone, forse il culmine del libro, proprio da questo senso funebre del destino umano, dal perire della bellezza, acquista il suo ritmo eccezionale di meditazione ultima e pietosa». Su quali aspetti dell’episodio si fonda,a tuo avviso, questo giudizio? In quali aspetti emergenell’episodio la «contemplazione della morte»?
Evidenzia nel passo gli elementi che riguardano il tema del destino storico della Sicilia.
Individua i momenti della narrazione in cui al puntodi vista del narratore onnisciente subentra quello del protagonista.
3
2
1
Approfondimenti
Procurati il film di Luchino Visconti tratto dal Gattopardoe soffermati sull’episodio del ballo a palazzo Ponteleone.Quali elementi sono stati privilegiati nella trasposizionecinematografica,e quali sono stati invece trascurati? Quali differenze trovi tra la caratterizzazione del personaggio del principe di Salina data nel romanzo e quella offerta dall’interpretazione di Burt Lancaster?
L’ideale narrativo di Tomasi di Lampedusa trae le sue origini da quella che egli chiama stendhalianamagrezza,ovvero la capacità di porre tra il narratore e l’oggetto narrato una distanza oggettivante, in modo da ridurre al minimo il coinvolgimento emotivodell’autore.Rintraccia,nei brani presentati, i luoghi dovequesto ideale ti sembra raggiunto e quelli in cui,Lampedusa non è riuscito a mantenere questo distacco.
2
1
432
IL SECONDO NOVECENTODal dopoguerra a oggi
Autori
BibliografiaBibliografia
Testi: tutta l’opera lampedusiana è stata edita postuma. IlGattopardo esce da Feltrinelli a cura di Bassani nel 1958; lasuccessiva edizione del Gattopardo basata sull’autografodel 1957, a cura e con una premessa di G. Lanza Tomasi, nel1969 sempre da Feltrinelli. Per la stessa casa editrice nel1961 vengono pubblicati i quattro Racconti (disponibili inedizione critica a cura di Lanza Tomasi dal 1988). Ora IlGattopardo si legge in edizione economica Feltrinelli(Milano 1985) e De Agostini (Novara 1997); I racconti inedizione economica Feltrinelli (Milano 1993) e Loescher(Torino 1991).Solo recentemente l’attenzione editoriale si è rivolta allaproduzione saggistica con le Lezioni su Stendhal, già uscitenel 1959 sulla rivista «Paragone» e raccolte nel 1977 per laprima volta in volume (con introduzione di P. Renard, Selle-rio, Palermo 19872); con l’Invito alle lettere francesi del Cin-quecento (Feltrinelli, Milano 1979) e soprattutto con saggi diLetteratura inglese (I, Dalle origini al Settecento, e II, L’Otto-cento e il Novecento), a cura di N. Polo, introduzione e postfa-zione di G. Lanza Tomasi (Mondadori, Milano 1996).Nel 1995 (19973) la Mondadori ha raccolto in un volume del-la collana «I Meridiani», curato da G. Lanza Tomasi e N. Poloe introdotto dallo stesso Lanza Tomasi, gran parte dell’operalampedusiana: Il Gattopardo (con una ricca Appendice difonti, varianti e prime stesure), I racconti, tre saggi da «LeOpere e i Giorni» e i saggi di Letteratura francese e inglese,facendo entrare a tutti gli effetti lo scrittore nel rango di clas-sico del Novecento.I testi antologizzati sono tratti dalla edizione del Gattopardo,a cura di G. Lanza Tomasi, nei «Meridiani», cit.
Critica: nel 1987, presso la casa editrice Sellerio, sono statepubblicate due importanti biografie dello scrittore: GiuseppeTomasi di Lampedusa di A. Vitello (cui si deve anche ilprecedente I Gattopardi di Donnafugata, Sellerio, Palermo1963), e Lettere a Licy-Un matrimonio epistolare di C. Cardona(basata sulle lettere alla moglie Licy Wolff-Stomersee, orapubblicate da S. Caronia, Licy e il Gattopardo, Edizioni
Associate,Roma 1995);mentre nel 1988 è uscita la biografia diD. Gilmour, The last Leopard-A life of Giuseppe Tomasi diLampedusa (tradotta nel 1989 con il titolo L’ultimo gattopardo,Feltrinelli, Milano 1989). Di grande importanza, per laricostruzione della personalità e della figura di Lampedusa, èla memoria di Francesco Orlando,uno degli allievi delle lezionipalermitane: Ricordo di Lampedusa, Scheiwiller, Milano 1963(ora «Ricordo di Lampedusa» seguito da «Da distanze diverse»,Bollati Boringhieri, Torino 1996), ma numerose informazionisulla vita e le opere dell’autore si trovano anche nelleprecedenti monografie di G.P. Samonà, «Il Gattopardo», i«Racconti», Lampedusa, La Nuova Italia, Firenze 1974 (checontiene anche una significativa antologia della critica) e Igattopardi e le iene (Sellerio,Palermo 1983) di N.Zago.Per un primo approccio all’opera lampedusiana si vedano G.Buzzi, Invito alla lettura di Tomasi di Lampedusa, Mursia, Mila-no 1972; la voce Tomasi di Lampedusa, in Dizionario criticodella letteratura italiana, diretto da V. Branca, IV, UTET, Torino19862, redatta da R. Ricorda, e nella collana «Il Castoro» dellaNuova Italia il volume curato da S. Salvestroni (Tomasi di Lam-pedusa, Firenze 19742), che fornisce, insieme a un agile pro-filo dell’autore e dell’opera, una lettura critica del testo.Un’ampia bibliografia sul Gattopardo è stata pubblicata da F.Pavone nei suoi Scritti di critica e di filologia, O.P.I., Roma1968 e da A.Vitello, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, cit.Dopo lo studio di A. Dipace, Questioni delle varianti del «Gatto-pardo»,Di Mambro,Latina 1971 (che fornisce un puntuale con-fronto tra l’edizione «bassaniana» e quella «conforme al mano-scritto del 1957»),sono apparsi, fra gli altri, Il Gattopardo:un ro-manzo storico per negare la storia di E. Ocello, Lo Faro, Roma1987; Come leggere «Il Gattopardo» di Giuseppe Tomasi diLampedusa, di G.Masi,Mursia,Milano 1975 (19962);un saggiodi M. Bertone in La scrittura e l’interpretazione, Palumbo, Paler-mo 1996; F. Orlando, L’intimità e la storia. Lettura del Gattopar-do, Einaudi, Torino 1998. Le analisi sviluppate intorno al rac-conto La sirena sono state infine raccolte dalla CLUEB di Bolo-gna nel 1997, in Le sirene: analisi semiotiche intorno a un rac-conto di Tomasi di Lampedusa, a cura di S. Cavicchioli.
485
Una questionedi vecchia dataLe profonde radici del problema. Tra la prima e la se-
conda guerra mondiale, la «questione meridionale» ela connessa riforma agraria si erano imposte come itemi più urgenti che lo Stato italiano doveva affronta-re. Il problema, tuttavia, aveva radici ancora piùprofonde e lontane. Già all’indomani dell’Unità, laforte arretratezza delle strutture socio-economichedel Sud, la mancata partecipazione delle masse conta-dine al processo di unificazione, unite alle diffuse no-stalgie borboniche delle classi dominanti, avevanocontribuito da un lato ad aumentare il divario tra unNord avviato alla rapida industrializzazione e un Sudsempre più ancorato alla cultura pastorale e contadi-na, dall’altro a consolidare l’immobilismo della so-cietà meridionale. Una società basata ancora larga-mente sul latifondo, ovvero sullo sfruttamento dellapopolazione – composta per lo più da allevatori eplebi rurali – da parte dei proprietari terrieri, e che po-teva conservare il suo precario equilibrio solo mante-nendo a un grado minimo il livello di istruzione e diconsapevolezza sociale delle masse. L’atto di denun-cia formale di questa situazione è costituito da duestudi pubblicati nel 1875 (l’anno precedente all’in-gresso della sinistra di Depretis al governo) e destina-ti a diventare dei capisaldi della storia economica esociale dello Stato unitario: le Lettere meridionali diPasquale Villari e l’inchiesta sulle Condizioni econo-miche e amministrative delle provincie napoletane diLeopoldo Franchetti (cui seguirà nel 1876 un’analogainchiesta svolta in collaborazione con Sidney Sonninosulla situazione della Sicilia). Anche gli studi dello sto-
rico Giustino Fortunato contribuirono ad approfondi-re il problema e a farlo considerare di primaria impor-tanza per lo Stato italiano. La forte arretratezza delSud, il vistoso dislivello economico tra le due parti delPaese – denunciati a chiare lettere dalla grande in-chiesta agraria promossa da Stefano Jacini e condottadal 1877 al 1884 – non potevano più essere conside-rati una manovra propagandistica, ma dovevano es-sere studiati nelle loro implicazioni storiche, econo-miche e sociali in quanto problemi prioritari della na-zione, come avrebbero mostrato, ad esempio, gli stu-di di Gaetano Salvemini e Antonio Gramsci ( 73). Lecontraddizioni del nuovo Stato, un involucro che rac-chiudeva problemi irrisolti di vecchia data, trovavanodunque uno specifico e urgente banco di prova pro-prio nella «questione meridionale».
Il riemergere della questione nel dopoguerra. Il re-gime fascista – ereditando come si è detto il proble-ma – autoproponendosi come catalizzatore del pro-cesso di unificazione del Paese, ovvero autodefinen-dosi come compimento realizzato dello Stato unita-rio, aveva dato ormai per risolta e superata la «que-stione meridionale», che in realtà si era limitato sem-plicemente (come molti altri problemi) a ‘rimuovere’.Essa dunque si ripresenta con forza nel dopoguerra –caricata di un peso antico, ma motivata anche dallenuove istanze emerse dalla lotta di liberazione nazio-nale e con modalità che attingono più spesso alla po-litica – e si lega in un nodo inestricabile all’altra gran-de questione dell’emigrazione.Negli anni della ricostruzione si hanno, così, frequentioccupazioni delle terre da parte di braccianti e conta-dini, e grandi spostamenti di manodopera verso ilNord industriale; a tutto ciò i governi centristi cercano– purtroppo con scarsi risultati – di dare risposta, nel
Generi
La narrativa meridionalistica
486
IL SECONDO NOVECENTODal dopoguerra a oggi
Generi
1950, con la riforma agraria e la creazione della Cassaper il Mezzogiorno (abolita nel 1986), un ente pubbli-co che dovrebbe in vari modi finanziare lo sviluppoeconomico di quelle aree, ma che in realtà contribui-sce probabilmente ad approfondire il solco che divideil Paese e a determinare quell’intreccio tra squilibrio disviluppo e criminalità mafiosa che emergerà poi, condrammatica evidenza, dopo gli anni Settanta.
Una nuova coscienza del problema. Sul piano cultu-rale, tutto ciò induce nella coscienza nazionale diquegli anni – in particolar modo negli intellettuali eartisti di orientamento socialista e comunista – l’aper-tura di un processo di riflessione e confronto chedarà frutti importanti ( 487) e che, per la stessacomplessità dei problemi, rimarrà vivo e vitale permolto e molto tempo.Nasce in questi anni, nell’ambito delle scienze umane,anche un nuovo versante di studi e ricerche (non soloitaliani) sul Sud, motivati da un profondo interesse perle sue strutture sociali, le sue tradizioni, le sue specifi-cità culturali. Capostipite di questo interesse è l’etnolo-go Ernesto De Martino, autore di opere che hanno ‘fat-to scuola’, tra cui Il mondo magico (1948) e Sud e ma-gia (1953). È dunque in seguito a tale nuova consape-volezza che anche la letteratura volge al Sud una nuo-va attenzione. Da un punto di vista intellettuale, la so-cietà e la cultura meridionale si rivelano estremamen-te ricche, composite e stimolanti, anche per la molte-plicità degli apporti culturali dei popoli che nei secolihanno dominato quelle terre: Greci, Normanni, Arabi,Francesi, Spagnoli, un insieme letterariamente moltofecondo. La drammatica crisi di valori vissuta tra le dueguerre viene inoltre riscattata dalla ricchezza e saggez-za del mondo contadino, che offre termini di raffrontosempre più validi e culturalmente riconosciuti, soprat-tutto a confronto della alienazione della vita cittadinadel nuovo proletariato industriale.
Scrittori alla ricercadella terra
Personalità diverse, caratteristiche comuni. Il ter-mine generico di «narrativa meridionalistica» accomu-na narratori assai diversi fra loro, che tuttavia condi-vidono l’aver dedicato gran parte della loro produ-zione a rappresentare le complesse realtà del Sud,cercando di interpretarle. Pur non essendo tutti meri-dionali di nascita (Carlo Levi, ad esempio, è torinese)
essi condividono un fortissimo legame con la ‘pro-pria’ fra quelle terre: ad esempio, la Sicilia, per Bran-cati, Tomasi di Lampedusa ( 407) e Leonardo Scia-scia ( 543); l’Aspromonte calabrese, per CorradoAlvaro; l’Abruzzo, per Silone; il Molise, per FrancescoJovine (1902-50) – autore delle Terre del Sacramento(1950), affresco corale di tutta una terra e commossaepopea ‘verista’ del lavoro contadino e delle sue lot-te negli anni Venti –; la Lucania del confino e dellascoperta antropologica del mondo rurale, per Levi.A unirli è poi soprattutto la volontà di far rivivere –talvolta nelle forme mitiche e favolistiche di una cul-tura ancestrale permeata di forte simbolismo – l’im-magine di un popolo che è rimasto fortemente lega-to alla sua dimensione contadina, ne ha mantenutogli usi, i costumi, la mentalità e ne vive e soffre per-sonalmente le contraddizioni e le sconfitte.
Il rapporto con l’impegno politico. Un altro elemen-to che questi scrittori hanno in comune è l’impegnopolitico, inteso come forma di partecipazione diret-ta alla vita del Paese – dalla quale l’intellettualitàsoffriva di un sempre più radicale distacco –: piùintenso, più direttamente ‘politico’ per Levi – checollabora con i socialisti liberali di «Giustizia e li-bertà» –, per Silone, uno dei fondatori del Partitocomunista (da cui in seguito verrà espulso), perSciascia – che sarà deputato al Parlamento italianoed eurodeputato –, per il comunista Jovine e perAlvaro, che dopo alcuni iniziali entusiasmi per il fa-scismo si schiererà su aperte posizioni antifasciste.Più mediato sui toni ‘civili’ per Brancati.Del tutto diverso è invece il caso di Lampedusa, raffi-nato esponente della antica nobiltà palermitana, cheperò condivide con gli altri scrittori un tenace attac-camento alla propria terra, tanto più vagheggiato nelsuo edenico stato di natura, quanto più i rivolgimen-ti politici ne vanno trasformando l’aspetto in modo, sipuò dire, irreversibile. Da questa partecipazione ap-passionata nasceranno storie bellissime e struggenti,e personaggi indimenticabili, come l’Antonello diGente in Aspromonte, i contadini di Fontamara equelli di Gagliano, o gli indolenti protagonisti dei ro-manzi di Brancati, nei quali si manifesta la crisiprofonda che investe non solo il ceto medio meridio-nale, ma un’intera società. Campeggia sopra tutti lastraordinaria drammaticità del tomasiano Principe diSalina – lucido e triste osservatore di una realtà di cuiintuisce i mali profondi –, un carattere scolpito a tin-te nette e decise, che si iscrive a pieno titolo nella gal-leria di personaggi della letteratura italiana, ma in cuirisuonano note universali, quasi dostoevskiane.
La narrativa meridionalistica • Scrittori alla ricerca della terra
487
Approfondimenti
La cultura italiana davanti alla «questione meridionale»L a «questione meridionale»,il pro-blema più grave emerso dalla
formazione dello Stato unitario, nonaveva trovato soluzione né con i go-verni della monarchia né con il fasci-smo, e la diversità di livelli di sviluppoe di vita tra Nord e Sud resta sensibileanche nel secondo dopoguerra e ne-gli anni del boom economico.Un tentativo di soluzione è la riformaagraria che viene varata dal gover-no De Gasperi (1950) dopo la lungastagione delle lotte contadine ebracciantili al latifondo, con ripetuteoccupazioni delle terre. La violentaopposizione dei proprietari – nelquadro di un’alleanza tra poteri co-stituiti e mafia – arriva a servirsi diun bandito come Salvatore Giuliano,il materiale esecutore della stragedi lavoratori di Portella della Gine-stra (1947). Comunque, una voltarealizzata, la riforma agraria nonavrà sensibili effetti sullo sviluppodel Sud. Si tentano allora interventidi politica economica meridionali-sta che, pur divorando risorse dalloStato, non riescono neppure così agenerare sviluppo, quanto meno aridurre il divario col Nord, che inve-ce cresce: le risorse distribuite si di-sperdono infatti in mille rivoli, capa-ci più di alimentare la corruzione ela malavita che non di creare un rea-le tessuto di infrastrutture e di soste-gno all’economia e all’occupazione.Grandi industrie, di Stato e private,ma finanziate dallo Stato, restanospesso come isole o ‘cattedrali neldeserto’.L’emigrazione sia verso l’estero (so-prattutto Germania, Svizzera, Bel-gio) sia verso il Nord industriale d’I-talia (Torino, Milano) resta quasi l’u-nica speranza di una vita meno sten-tata per migliaia di persone, cheperò devono sradicarsi, affrontando
la difficile e faticosa ricerca di unacollocazione e una identità nuove –non solo in Belgio o in Germania, maperfino a Milano e a Torino, dove i‘terroni’ sono accolti con diffidenzae talvolta aperto disprezzo –: l’Italiaè ‘fatta’ da un secolo e con la guerradi liberazione ha riguadagnato il di-ritto a sedere tra i Paesi democratici,ma gli italiani sono ancora ‘da fare’, acominciare dalla lingua comune, chedi fatto non c’è e dunque non può es-sere elemento di comunicazione ecomprensione tra persone i cui usi ecostumi si assomigliano poco.Accanto alla «questione meridiona-le» si ripresenta inoltre, seppure informe nuove, la ‘questione sociale’:essa attraversa le metropoli, dallebaracche delle borgate romane aiquartieri-dormitorio delle periferie,costruiti dalla speculazione ediliziasenza rispetto né per l’ambiente néper chi dovrà viverci; attraversa lecampagne, sempre più spopolate,abbandonate, desolate; e attraversale stesse culture popolari, segnatedalle grandi differenze nei modi divita di un Sud agricolo e un Nord in-dustriale.In questo dopoguerra – in cui l’im-pegno e la partecipazione divengo-no valore fondante della cultura – lecoscienze degli scrittori e degli in-tellettuali proprio da queste diffe-renze sono spinte a prendere posi-zione, rappresentando la realtà ita-liana – nella letteratura, nel cinema,nelle arti figurative – con dichiaratiintenti di denuncia, di intervento, dicambiamento.Anche il fascismo ha contribuito co-munque – del tutto involontariamen-te – alla presa di coscienza dei pro-
blemi del Sud, inviandovi al confinotanti intellettuali settentrionali: CarloLevi, ad esempio, che con Cristo si èfermato a Eboli rende più forte la de-nuncia proprio per la ‘nudità’ de-scrittiva del suo occhio estraneo einsieme partecipe.Altri intellettuali di punta in questianni sono invece meridionali, e dal-le proprie radici attingono linfa eforza per costruire un nuovo rappor-to tra letteratura e società. Elio Vitto-rini ad esempio, che da anni lavora aMilano come direttore editoriale,chiama la sua rivista col nome diquella di Carlo Cattaneo, «Il Politec-nico»; mentre Brancati – dopo Piran-dello e non senza che di quest’auto-re si percepiscano echi – con DonGiovanni in Sicilia disegna (con l’anti-doto dell’autoironia necessario con-tro i troppi pietismi rovesciati a paro-le sul Sud, mentre nei fatti non si dàcorso a nessun progetto di sviluppo)un ritratto contrapposto della vitasonnolenta e depressiva nella pro-vincia siciliana e di quella milanese,altrettanto vuota e superficiale, e ol-tretutto vissuta con la totale mancan-za di coscienza di chi si nascondedietro al mito del lavoro e della pro-duttività.Francesco Jovine nelle Terre del Sa-cramento narra l’epopea del conflit-to di classe nelle campagne molisa-ne e del lavoro contadino; mentre iracconti di Il mare non bagna Napolidi Anna Maria Ortese sono insiemetradimento e dichiarazione d’amoredell’autrice per questa città con lesue infinite contraddizioni, nodo d’a-more che non si spegne nei suoi ro-manzi di ‘esule’ e soprattutto si scio-glie nella poesia.
488
IL SECONDO NOVECENTODal dopoguerra a oggi
Generi
Approfondimenti
La «questione meridionale» dilagatuttavia ben oltre la letteratura: glianni Cinquanta vedono la pubblica-zione degli studi di due grandi etno-logi, Giuseppe Cocchiara e ErnestoDe Martino il cui Sud e magia portaun contributo che va ben oltre quelMezzogiorno che ne è oggetto, fa-cendo esplodere un dibattito ‘nazio-nale’ sul pensiero mitico e le sue so-pravvivenze nel mondo moderno. Èla «collana viola», curata da Paveseper Einaudi ( 186), a proporre perla prima volta in Italia (e in pienapredominanza, nel mondo intellet-tuale, del razionalismo marxianoche diffida di ogni rivalutazione del-l’irrazionalismo) i nuovi studi antro-pologico-culturali condotti su sog-getti non primitivi né lontani.Accanto alla narrativa meridionale e‘meridionalistica’ si allineano e infit-tiscono in questa stagione le rappre-sentazioni del Sud, che ne denun-ciano lo sfruttamento economico el’incomprensione culturale da partedel resto del Paese e insieme ne af-fermano i valori. E forse il cinema neè il vero protagonista.Luchino Visconti, dopo aver compiu-to un’operazione di enorme impattocon La terra trema (1948) – tratto da IMalavoglia e recitato non da attoriprofessionisti ma dalla gente di AciTrezza,cosa che obbliga il pubblico aconfrontarsi con volti diversi e un dia-letto che suona incomprensibile, co-stringendo a fare i conti, senza edul-coramenti, con l’attualità di un roman-zo scritto oltre sessant’anni prima –,realizza Rocco e i suoi fratelli (1960) –sulla miseria e la crisi morale e diidentità di una famiglia di immigratimeridionali a Milano – e poi Il Gatto-pardo (1963), che porta sullo scher-mo il romanzo di Tomasi di Lampe-dusa, vero ‘caso editoriale’ degli an-ni Cinquanta, che taluni leggono in
chiave reazionaria e antimoderna,altri, all’inverso, come la pacata de-nuncia ‘illuministica’ del fallimentodel processo unitario e risorgimen-tale (e in quegli anni una delle inter-pretazioni della Resistenza è propriodi ‘ultima guerra d’indipendenza’,chechiude il processo risorgimentale).Così,pure,è il cinema che ‘lancia’a li-vello di grande pubblico la denunciadi Sciascia sulla mafia e i suoi legamicon la politica dei governi nazionali –quando ancora in Italia semplice-mente si nega che essa esista – por-tando sullo schermo i suoi romanzipiù famosi (A ciascuno il suo, 1967, diElio Petri; Il giorno della civetta, 1969,di Damiano Damiani). Ed è ancora ilcinema a parlare della speculazioneedilizia ‘malavitosa’ che devasta Pa-lermo e Napoli nella connivenza del-le amministrazioni e dei partiti (Lemani sulla città, 1963, di FrancescoRosi, due anni prima autore anche diSalvatore Giuliano, che ricostruiscetra l’altro la strage di Portella).Ma il Sud dà voci e storie anche algrandissimo teatro di Eduardo DeFilippo, la cui Napoli esce dagli ste-reotipi della città misera e grandiosae dei pulcinella dolenti e pezzentiche piace ai turisti: nel dialetto na-poletano di Eduardo parla l’essereumano, nudo nei sentimenti e neidrammi che tutti attraversano per-ché «ha da passà ’a nuttata».Il cinema, la letteratura e il giornalismocoraggioso (come quello di Mauro DeMauro, fatto ‘sparire’proprio nel pienodi un’inchiesta per il quotidiano «L’O-ra» sui legami tra mafia e potere nellaPalermo degli anni Settanta) indaga-no e ripetono che la mafia non è ‘cor-po estraneo’ né semplice delinquen-za, ma neppure elemento che per-metta quella ‘naturale’ identificazionetra Sud e barbarie, o addirittura traSud e delinquenza, che purtroppo
l’opinione pubblica nazionale (e nonsolo) è portata a fare. Così, piano pia-no certi pregiudizi cominceranno amostrarsi per quello che sono e l’opi-nione pubblica si farà più attenta esensibile, costringendo talvolta loStato a prenderne atto con una politi-ca diversa.Un’epica e una celebrazione le lottedel Sud le trovano comunque, giànell’immediato dopoguerra, anchenella pittura, quella ad esempio diRenato Guttuso; mentre è dagli anniSettanta che le sonorità mediterranedella tradizione si eleveranno a musi-ca colta andando a nutrire la ricercaetnomusicale così come, più tardi,quella di molti cantautori e del rap.Anche da questi pochi esempi, dun-que, una cosa emerge con chiarez-za: la trasformazione che si determi-na in questi decenni nel rapporto traproblemi dello sviluppo del Sud eproduzione culturale, e che consistein un radicale mutamento: dalle rap-presentazioni ottocentesche di undramma quasi ‘naturale’ a quelle diuna situazione contro cui combatte-re per far venire in luce la qualità delSud come risorsa vivissima dellacultura nazionale.
Giuliano Zigaina, Occupazione delle terre, 1950, olio su tela, Milano, collezione privata.
La narrativa meridionalistica • Corrado Alvaro
489
Corrado Alvaro
La vita e le opere
L’Aspromonte e la guerra. Corrado Alvaro nasce nel1895 a San Luca – un piccolo paese in provincia diReggio Calabria, situato sul versante jonico dell’A-spromonte – ma subito dopo le scuole elementariviene mandato in collegio per proseguire gli studi,prima a Frascati e poi in provincia di Perugia. A 16anni pubblica la raccolta di versi Polsi nell’arte, nellaleggenda, nella storia. Lo scoppio della prima guerramondiale lo vede nelle file interventiste, fino allachiamata alle armi nel 1915. Combatte nei pressi diSan Michele del Carso, dove viene ferito e passaquindi al servizio sedentario a Chieti. Durante l’espe-rienza bellica maturano le Poesie grigioverdi, usciteinizialmente sulla «Riviera ligure» di Mario Novaro epoi in volume nel 1918.
L’attività giornalistica. Dopo la guerra inizia perAlvaro un periodo di intense collaborazioni giorna-listiche che lo portano prima a Bologna, poi a Mila-no – redattore senza firma al «Corriere della Sera» diLuigi Albertini – e infine a Roma, dove collabora al«Tempo» e pubblica alcune traduzioni dal russo, tracui L’eterno marito di Dostoevskij, con la collabo-razione della moglie. Nel 1922 si trasferisce a Parigicome corrispondente. Con il delitto Matteotti(1924) la sua posizione antifascista diventa piùesplicita: collabora alla rivista umoristica «Il beccogiallo» e nel ’25 sottoscrive il Manifesto degli intel-lettuali antifascisti promosso da Croce. Il suo pri-mo racconto lungo dall’emblematico titolo L’uomonel labirinto, già uscito a puntate su «Lo Spettatore»nel 1922, viene stampato a Milano nel 1926. Il pro-tagonista, Sebastiano Babe – un meridionale tra-piantato che tenta un impossibile inserimento nellarealtà del Nord –, compendia caratteri autobiografi-ci e suggestioni letterarie. Per la sua posizione dieterno spettatore della vita e la sua incapacità dicomunicare con il mondo, mostra più di un’affinitàcon altri ‘antieroi’ letterari scaturiti dalla prosa diquesti anni, dal borgesiano Rubè al più celebre Ze-no Cosini. Babe, respinto dal nuovo ambiente e in-capace di costruirsi un’identità anche dal punto divista affettivo, ritorna al paese d’origine dove final-mente, nella scoperta delle proprie radici e nelladolorosa solitudine della sua gente, ritrova anchese stesso.
L’anno successivo, sulla «Stampa», escono le primepagine del racconto che darà il titolo all’opera piùfamosa di Alvaro: Gente in Aspromonte.
L’adesione a «900» e i primi successi letterari. Dal1926 Alvaro è segretario della redazione di «900» – larivista di Massimo Bontempelli e Curzio Malaparte,portatrice di una profonda volontà di rinnovamentoe di apertura alle più recenti esperienze europee – eintensifica le collaborazioni con altre riviste straniere,francesi e tedesche. L’aperta ostilità del regime neisuoi confronti si palesa con l’opposizione di Mussoli-ni alla premiazione della raccolta di racconti L’amataalla finestra, pubblicata nel 1929.Il Meridione fa da sfondo ai temi che caratterizzeran-no tutta la successiva produzione: il ritorno alla terrad’origine dopo la fallimentare ricerca della propriaidentità, la riscoperta dei valori familiari, il passaggiodell’uomo dall’adolescenza all’età matura.Il 1930, nonostante le difficoltà imposte da un am-biente culturale sempre più asservito alla propagan-da fascista, sancisce però il suo primo successo dipubblico con il Premio letterario «La Stampa»: esconole raccolte di racconti Gente in Aspromonte (Le Mon-nier) e La signora dell’isola (Carabba), e il romanzoVent’anni (Treves). Alcune sue novelle vengono tra-dotte in Germania con il titolo Facce nascoste.
Corrado Alvaro in una foto della fine degli anni ’40,Milano, Archivio Rizzoli.
490
IL SECONDO NOVECENTODal dopoguerra a oggi
Generi
Il rapporto con il fascismo. Nonostante le aperte di-chiarazioni antifasciste, negli anni Trenta il rapporto diAlvaro con il regime si arricchisce di implicazioni in-tellettuali più complesse: nel 1931 viene duramentecolpito dalla proibizione di collaborare a giornali e ri-viste (attività che tuttavia continuerà a esercitare finoal dopoguerra), ma nel ’34 pubblica per le Edizioni diNovissima dell’Istituto Nazionale Fascista di Cultura ilvolume Terra nuova (Prima cronaca dell’agro ponti-no), considerato poi da molti come un documento in-sopportabilmente apologetico. La crisi personale epolitica, denunciata da queste due opere di segno op-posto, esplode nel romanzo fortemente autobiografi-co pubblicato da Bompiani nel 1938: L’uomo è forte,che l’autore – per imposizione della censura – è co-stretto ad ambientare in Russia anziché, come avevainizialmente previsto, in Italia. I due protagonisti, Dalee Barbara (un ingegnere emigrato, al suo ritorno inpatria, e la donna che aveva amato in gioventù), speri-mentano nel tragico evolversi del loro rapporto la pro-gressiva perdita di umanità prodotta dall’incomberedella cultura del sospetto: la violenza psicologica eser-citata dalle istituzioni sugli uomini li trasforma irrime-diabilmente e ne annichilisce ogni volontà di resisten-za. Il romanzo viene premiato nel 1940 dall’Accade-mia d’Italia e suggella la fama di Alvaro come narrato-re (fino alla vittoria del Premio Strega nel 1951 perQuasi una vita), mentre nel medesimo periodo i suoiinteressi si rivolgono verso il cinema e il teatro (dal ’49al ’51 sarà infatti critico teatrale del «Mondo» di Pan-nunzio, mentre nel ’52 sostituirà Flaiano nella rubricadi critica cinematografica). Nell’autunno del 1944 fon-da con Francesco Jovine il Sindacato nazionale degliscrittori, che seguirà poi fino alla morte.
Un’opera in cantiere. Colpito da malattia nel 1954,nel pieno di una vivacissima attività di giornalista,traduttore, sceneggiatore e da ultimo anche curato-re delle proprie opere, Alvaro muore due anni do-po, sessantenne, lasciando numerosi racconti ine-diti e romanzi incompiuti. Alcuni di essi, come Bel-moro e i due romanzi Mastrangelina e Tutto è ac-caduto – che completano la trilogia autobiograficadelle Memorie del mondo sommerso inaugurata nel1946 con l’Età breve –, saranno pubblicati postumi.
Un «settentrionale del Sud»
Uno stile di dimensione ‘europea’. L’acuta capacità dianalisi esercitata sui problemi del Meridione, vistosempre in una luce di trasfigurazione mitica, e il con-
tinuo inserimento di tale analisi nella problematicaesistenziale dell’uomo moderno, tengono semprel’opera dello scrittore al di qua della rappresentazio-ne bozzettistica e di maniera e la inseriscono in unadimensione che potremmo definire ‘europea’.Anche lo stile risente di questo progressivo supera-mento del realismo; toni di pacata contemplativitàsi innestano infatti sul racconto della sua terra, pursempre ricco di calore e passione, tanto che Euge-nio Montale ha potuto definire Alvaro un vero «set-tentrionale del Sud». A ciò si deve anche aggiunge-re il suo rifiuto di essere annoverato tra gli scrittorimeridionalisti – categoria cui appartiene per la te-matica dominante della sua narrativa, ma dalla qua-le si distacca per l’ampia gamma degli interessi eper il progressivo abbandono delle tematiche so-ciali – evoluzione cui concorre direttamente l’espe-rienza novecentista.
Una posizione del tutto personale. Di qui una posizio-ne ideologica e stilistica assolutamente personale edifficilmente inquadrabile, per la quale valgono an-cora le parole che sempre Montale – con il consuetoacume critico – scrisse alla sua morte: «non agiografi-co, non politico, estraneo ai problemi che interessa-vano la «Ronda», e più tardi non calligrafista né con-tenutista […], Alvaro fu scrittore nuovo e modernoperché seguì fino in fondo la sua inclinazione mora-le, senza scivolare mai nel moralismo o nell’astrattospiritualismo, e senza sacrificare nulla della suaasciuttezza e severità di espressione».
Gente in Aspromonte
Un’opera tra Verga e il Novecento. La raccolta di rac-conti Gente in Aspromonte esce nel 1930, insieme aFontamara di Silone ( 509) e un anno dopo Gliindifferenti moraviani, in uno dei momenti più dif-ficili e cupi per la cultura italiana, costretta al forza-to silenzio imposto dal regime. La contiguità crono-logica con questi due romanzi non è casuale, dalmomento che la narrativa di Alvaro può dirsi collo-cata tra il realismo verghiano – aggiornato da scrit-tori come Silone alla nuova «questione meridionale»sorta dopo la grande guerra – e le esperienze delromanzo italiano più apparentate al Decadentismoeuropeo (bipolarismo implicito anche nella stessavicenda biografica dell’autore, uomo del Sud cui leesperienze giovanili in Germania e Francia hannodato sin dall’inizio dell’attività intellettuale un re-spiro europeo).
La narrativa meridionalistica • Corrado Alvaro
491
La trama. Il racconto lungo, o romanzo breve, che dàil titolo all’opera è considerato dalla critica il prodot-to più rappresentativo della produzione alvariana,per la sua capacità di concentrare in una struttura es-senziale e compatta i temi trattati negli altri racconti eromanzi: il mondo calabrese – universo chiuso nellesue drammatiche contraddizioni, e nel destino di po-vertà e sottomissione dei suoi pastori – e il mondopsicologico dell’adolescente Antonello, entrato diprepotenza nella comunità adulta e precocementecresciuto nella durezza e nelle ingiustizie della suacondizione sociale. Il padre di Antonello – il pastoreArgirò, a servizio dei potenti Mezzatesta, i ricchi pro-prietari che dominano il paese – concentra sull’altrofiglio minore, Benedetto, destinato alla carriera ec-clesiastica, tutte le speranze di riscatto personale ecollettivo, costringendo Antonello a lavorare fuoridal paese per mantenere il fratello agli studi.La situazione familiare peggiora ulteriormentequando un incendio distrugge la stalla di Argirò,con la mula che costituiva l’unica proficua fonte direddito; nel contempo anche Antonello, provato
dalle fatiche del lavoro e pervaso da una nuova vo-lontà di rivalsa, è costretto a lasciare il lavoro e tor-na a casa, sempre più consapevole della necessitàdi farsi strumento di una personale giustizia. AncheBenedetto – che non può dunque essere più man-tenuto agli studi – rappresenta comunque una de-lusione per le aspettative paterne di riscatto sociale:protagonista di un’autentica vocazione, finisce cir-condato da un alone di santità, per dirla con le pa-role della gente diventa cioè «santo sul serio».Quando Antonello scopre che nell’incendio dellastalla sono coinvolti i Mezzatesta, decide di com-piere un gesto estremo, per esternare tutta la sua ri-bellione: contro le proprie sventure, ma anche con-tro la sofferenza e la miseria che vede intorno a sé,contro l’ingiustizia, il sopruso e l’arroganza dei po-tenti. Incendia così il bosco di proprietà dei Mezza-testa, uccidendone gli armenti e distribuendo lacarne ai paesani, e si rifugia nella capanna in Aspro-monte dalla quale, con la mente ormai semiscon-volta, si consegnerà alla Giustizia, per poterle final-mente dire il «fatto suo».
L’incendio al bosco di Mezzatestada Gente in Aspromonte, XIV-XV
Presentiamo i due capitoli conclusivi del racconto. Antonello ha appic-cato il fuoco al bosco di proprietà di Filippo Mezzatesta; l’incendio si pro-paga rapidamente in uno scenario apocalittico, reso ancora più terrifi-cante dall’incalzare delle tenebre e dai muggiti e belati terrorizzati degliarmenti in fuga. Il giorno seguente il paese è in festa, la «festa della mon-tagna» e la notizia della distruzione della proprietà e dell’uccisione dellebestie si diffonde, colorando l’impresa di toni favolosi. Ma la rivolta diAntonello resta racchiusa nei confini di un sacrificio personale, in unasolitudine che vuole riscattare e vendicare una storia di millenarie op-pressioni e soprusi ma che purtroppo è tragicamente confinante con lafollia. L’ultimo quadro ritrae il protagonista con i toni favolosi e iperboli-ci dell’epica popolare: si diceva, nelle leggende che si spargevano sulconto suo […] che stava su un cumulo di carne macellata e che con unfocone davanti alla sua capanna faceva arrostire quarti di bue e bocconibuoni. Alla soddisfazione per il riscatto ottenuto da tutto il paese si uni-sce il timore suscitato da un evento che ha interrotto l’ordine naturaledella realtà, ordine che, nella mentalità contadina, è intoccabile e diffi-cilmente sovvertibile, da cui i toni iperbolici della narrazione.
La mattina seguente un bosco di Filippo Mezzatesta prese fuoco. L’albaaveva sgomberata la montagna dai vapori notturni, ma una bruma bas-sa rimaneva come un velo caduto. Poi si vide un luccicore nel sole, co-me fa il fuoco nella luce, o come quello che con gli occhiali da presbite
492
IL SECONDO NOVECENTODal dopoguerra a oggi
Generi
alcuni accendevano nel tabacco della pipa1. Poi un alito pesante e arsoche si mescolava al calore del solleone. Il Mezzatesta uscì sulla terrazzaa guardare. Gli portarono una sedia, e si mise a osservare come andavail fumo greve, spostato appena da qualche alito di vento, come se fossetroppo denso. Poggiava i pugni grossi sul davanzale e gridava a chiunquepassasse: «Aiuto, non lo vedete che brucia lassù? Quello è il bosco mio, ilbosco di Zefiria. Perché non correte a spegnere?». «La vostra signoria parlacon me?» rispondeva qualcuno e seguitava per la sua strada. «Gente male-detta da Dio, perché nessuno corre ad aiutare? Olà, servi, correte a cercaregente. Io pago, pago molto!». Ma nessuno gli dava retta e i servi più che gi-rare come asini pel paese non potevano fare. Gli sembrava che il paese in-tero gli volgesse le spalle, e avesse piacere a vederlo disperarsi, enormesulla terrazza dove non appariva mai e a predicare come da un pulpito.Una fila di ragazzi e di donne non perdevano uno solo dei suoi atti e dellesue parole, ed egli irritato cominciò a tirare in basso certi calcinacci cheaveva staccato dal parapetto della terrazza. Guardava i progressi del fuoco,come andava sicuro, e con ordine, che pareva ragionasse; come si accen-deva e come sostava, come si alimentava, come superava le barriere dopoessersi raccolto prima del salto, e come gli rispondevano subito gli alberipiù lontani prendendo fuoco subitamente, quasi che si rallegrassero e siincendiassero soltanto al pensiero dell’approssimarsi della fiamma. Alla se-ra il fuoco aveva sbarrato tutto il crinale del monte. Ci volevano non menodi cinquanta persone a tentare di fermare quell’ira di Dio. Lui protestavache avrebbe pagato. Ma gli rispondevano: «Poteva pagare prima». «E checosa faccio io per i pascoli quest’anno? E che do da mangiare alle bestie? Ofuoco che mi brucia, o danno che mi rovina!». I pastori arrivarono dicendoche avevano potuto salvare il bestiame portandolo dall’altro versante, cheinutilmente si erano opposti al fuoco e che la montagna ardeva come unbraciere. Egli, afferrato al parapetto della terrazza, ad ogni lembo di terrache il fuoco invadeva, gridava come se la vedesse sprofondare. Sul crinaledel monte i ragazzi videro crollare la processione d’alberi che si staccava-no nel cielo e intorno a cui avevano fantasticato come di giganti.Il signor Filippo uscì, seguito da pochi servi e pastori, si fece issare su unmulo, prese la via del bosco. «Lo spengo io! E me ne ricorderò di quelliche non mi hanno voluto dare aiuto». Ma a mezza costa il mulo non potépiù proseguire, ed egli, in testa ai suoi uomini, affrontò la salita. Si sen-tiva l’imminenza delle fiamme come un alito stranamente odoroso. Lefoglie degli alberi più lontani si accartocciavano e si mettevano a trema-re come creature. Più lontano, tra la foschia del fumo, splendevano ver-di e abbaglianti alcune querce come in un teatro, ma improvvisamenteavvampavano con uno strepito di fuoco d’artifizio. I pastori, coi piedi ele mani e il viso coperti di stracci, fra cui solo gli occhi si aprivano unvarco, fecero a colpi d’accetta certe grandi scope di rami verdissimi e co-minciarono a battere il fuoco come si batte il grano, cercando di soffo-care le fiamme più vicine. Era notte ma ci si vedeva come davanti a unforno. Si sentivano lontani i muggiti e i belati degli armenti in fuga, e frail crepitio delle fiamme che era come un gran vento impetuoso, le vocidei pastori che gridavano parole incomprensibili. Nuovi rami verdi so-stituivano quelli con cui si picchiava il fuoco e che a loro volta minac-ciavano di incendiarsi, ma i lentischi2 là in mezzo e i pinastri3 sembrava-no segnare punto e daccapo aggiungendo le fiamme loro veloci a tuttele difficoltà del fuoco, come colate d’olio bollente. La notte era lunga, e
1. con gli occhiali … pipa: come il fuocousato per accendere il tabacco della pipa.Si noti la similitudine legata alla quotidia-nità, caratteristica dello stile alvariano.2. lentischi: arbusti sempreverdi caratteri-
stici della macchia mediterranea.3. pinastri: pini selvatici.
La narrativa meridionalistica • Corrado Alvaro
493
il calore accumulato nel giorno faceva correre per l’orizzonte lunghilampi. Una voce si avvicinò distintamente e disse: «Duecento pecore so-no precipitate in un burrone. Qualcuno ci si è parato davanti e le ha spa-ventate». Ora pareva di vedere quell’individuo agitarsi fra le fiamme conun forcone, saltare come una salamandra. Era invece il signor Filippoche gridava aiuto, e si era spinto troppo avanti.La Pirria4 sembrava essersi messa in festa. Aveva cominciata la giornatacicalando con le donne, e invitando le più povere a venirsi a prenderele brode del giorno avanti per i maiali, e le scorze di fichidindia. «Oggi èla festa mia», diceva. Dopo mezzodì alcune persone con un tamburelloe la zampogna si misero a suonare sulla piazza, e ballavano. La Pirria sigodeva lo spettacolo dalla finestra. Da una finestra all’altra le donnic-ciole si domandavano che festa fosse, che non ne avevano mai sentitoparlare. Ma nessuno lo sapeva. Non si sa come, rotolò in mezzo allapiazza un barilotto di vino e correvano i bicchieri da mano a mano. LaPirria verso sera accese il lume a petrolio e lo espose alla finestra, e aquel chiarore la gente si era data convegno, cantando e cicalando. «Nonli vedete i fuochi? È la festa della montagna». Nella casa del signor Filip-po le finestre erano chiuse e senza lume. Solo di quando in quando unatesta si affacciava a spiare e la finestra si chiudeva frettolosamente comedavanti alla tempesta. La voce di quello che succedeva in montagna sipropagava rapidamente, e le donne se lo gridavano a squarciagola. Ca-pre e buoi del signor Filippo non esistevano più, arrivavano perfino imercanti da fuori a chiedere se c’era da comperare bestie morte. Segnoche la fama era andata molto lontano. Poi altri mercanti scesero dallamontagna menando davanti a sé certe bestie, e a chi domandava dovele avessero comperate rispondevano che gliele aveva vendute un gio-vane lassù. «Avete capito che cosa ci aveva?» strillava la Pirria. «Cinque-cento pecore, duecento buoi, e settantacinque porci. Avete capito?».Ad aumentare la gazzarra apparve qualche cosa di soprannaturale, unuomo che pochi riconobbero per l’Antonello. Passando fra quella turbamagna5, su un mulo, buttava di sella certi carichi sanguinolenti: «Ecco,gente, di che sfamarvi. Ecco qui carne di vitella e di pecora fresca ma-cellata. C’è da mangiare per tutti. Riempitevi la pancia per quello cheavete digiunato». Buttò quella roba in mezzo alla folla e sparì. Una vocelà in mezzo gridò: «Anche le bestie del signor Camillo Mezzatesta sonosparite». Alla scena della gazzarra succedette un’apparizione di donnecoi capelli sciolti, mogli di pastori, che si schierarono davanti alla chiesafacendo gran lamento. Si strappavano i capelli, mentre la gente si rinta-nava nelle case, e la Pirria ritirava rapidamente il lume, ma non senzagridare: «Ah, gioia mia!». Ma alcune di quelle si ricomponevano e si stac-cavano da quel quadro, perché un pastore venne a tranquillare le moglidei piccoli mandriani, che non erano stati toccati: «Soltanto i grossi, si sa;il fulmine sceglie sempre le grandi altezze».Immane, al lume di una fiaccola di resina, apparve il signor Filippo. Lapiazza era stata sgombrata, e vi si aggiravano soltanto Andreuccio e ilTitta6 che inforcavano i loro cavalli per raggiungere la montagna e fargiustizia dei malfattori. Si gridò: «Fate attenzione». Uno reggeva la fiac-cola sul capo del signor Filippo, nero, tutto a brandelli, mentre qualcu-no gli strofinava il viso e le mani con una pezza intinta di olio. Avevadue righe di sangue sul viso. «Attenti a non urtarlo, scansatevi. Non lovedete che ha perduto gli occhi?».
4. Pirria: la donna di Camillo Mezzatestache esulta della disgrazia della famiglia del-l’amante (colpevole di non aver riconosciu-to i figli Andreuccio e Titta nati dalla lororelazione) e ravvisa nell’incendio una ven-detta personale contro l’ingiustizia subita.5. turba magna: gran folla in tumulto.6. Andreuccio e il Titta: i figli della Pirria
che, nonostante il mancato riconoscimentoda parte di Camillo Mezzatesta, difendonogli interessi della famiglia.
494
IL SECONDO NOVECENTODal dopoguerra a oggi
Generi
L’Antonello stava nella sua capanna di felci e di canne a mezzacosta del-l’Aspromonte. Col fucile in ispalla girava come un guardiano, all’ertache non arrivasse qualcuno. La capanna era costruita su quattro alberigrossi, su due piani, e al pianterreno aveva un posto per le riserve. Quibelavano chiusi i montoni, e i buoi, che facevano un gran concerto.Qualcuno passava al largo, ma egli lo chiamava con un cenno, e posavail fucile in segno di pace. Voleva che, se andava al paese, portasse qual-che piccolo regalo ai suoi amici; compensava lautamente. Metteva nellabisaccia del passante agnelli vivi e coscie di manzo. Si ricordava dei piùpoveri del paese, con la memoria dell’infanzia. Si ricordava dell’Agatacieca, quella che andava mendicando, e le mandava un agnellino. Si ri-cordava di tutti. Gli davano anche le notizie. Il signor Filippo era rovi-nato, rovinati i tre eredi del signor Camillo Mezzatesta. Erano arrivati lanotte i carabinieri e si sarebbero messi alla ricerca degl’incendiari. Cre-devano che fosse una banda, e l’Andreuccio e il Titta la andavano cer-cando. Egli sorrideva orgogliosamente. Intanto era tornato suo fratello,Benedetto, che non poteva più pagare al seminario, e rimaneva vestitoda prete. Era un santo, predicava la pace, viveva di pane ed acqua, e ledonne lo seguivano e gli baciavano l’orlo della veste. Giovane com’era,dava già buoni consigli alla gente che ne chiedeva, e scriveva le lettereper tutti. «E portate», diceva l’Antonello, «questi pochi denari alla Schia-vina, con questo agnellino. La conoscete la Schiavina? E questo maiali-no che lo allevi per il carnevale, alla mia salute. E questi denari a lui, amio fratello Benedetto, che potrà così tornare a studiare. E che mi per-doni e preghi per me». Ora si diceva, nelle leggende che si spargevanosul conto suo, da quelli stessi che lo avevano veduto, che stava su uncumulo di carne macellata e che con un focone7 davanti alla sua capan-na faceva arrostire quarti di bue e bocconi buoni. Egli emanava decreti,e mandò a dire ai piccoli mandriani che potevano star tranquilli, ché luinon ce l’aveva con loro. Si affacciarono dunque le pecore a brucare leerbe sui precipizi, ed egli le sentiva scampanellare e belare, col cuorpieno, come se le avesse create lui. Aspettava la sua sorte. Quando videi berretti dei carabinieri, e i moschetti puntati su di lui dietro agli alberi,buttò il fucile e andò loro incontro.«Finalmente», disse, «potrò parlare con la Giustizia. Ché ci è voluto perpoterla incontrare e dirle il fatto mio!».7. focone: braciere.
Analisi del testo
L e ultime concitate vicende del racconto sononarrate da un punto di vista collettivo, che parte-
cipa espressamente della mentalità popolare; l’au-tore ne rivela l’intenzione attraverso alcuni espedientinarrativi e stilistici.
L’ITERAZIONE
La struttura iterativa, ad esempio (Poi si vide un lucci-core nel sole […] Poi un alito pesante e arso), concor-re alla rapidità descrittiva dell’incendio, ma è anche
La narrativa meridionalistica • Corrado Alvaro
495
Proposte operative
Analisi
Delinea le caratteristiche dei due personaggi-chiavedell’episodio: cosa rappresenta ciascuno?
Evidenzia nella descrizione dell’incendio del bosco il punto di vista del proprietario.
Individua nel passo il rapporto tra i temi e le sceltestilistiche: quali elementi rivelano il valore mitico-simbolico della vicenda nelle intenzioni dello scrittore?
3
2
1
Approfondimenti
Confronta la rappresentazione del mondocontadino e della sua ‘protesta’ raccontata nel passocon altre opere che conosci.
1
funzionale a una resa stilistica che riprende le stessestrutture mentali che sottostanno all’espressione po-polare.Accanto alla resa corale si intercala il discorsoindiretto libero di Filippo Mezzatesta (che pareva ra-gionasse…; quasi che si rallegrassero…; e più avanti… quell’ira di Dio) che antropomorfizza l’incendio,scorgendovi i tratti di una vendetta collettiva.La ripro-duzione mimetica del linguaggio popolare agiscesulla struttura sintattica, lasciando invariato il lessicocome nell’uso alogico del pronome relativo (le don-nicciole si domandavano che festa fosse, che non neavevano mai sentito parlare).
LA SIMILITUDINE COME FIGURA ‘CHIAVE’
Sin dall’inizio del brano, inoltre, la similitudine si rive-la stilisticamente come figura ‘chiave’ (una brumabassa rimaneva come un velo caduto), e rimanda al-l’esperienza quotidiana di una voce narrante che ap-partiene al mondo contadino (come fa il fuoco nellaluce, o come quello che con gli occhiali da presbite al-cuni accendevano nel tabacco della pipa), come purea quella dell’autore vero e proprio (splendevano verdie abbaglianti alcune querce come in un teatro; i pina-stri sembravano segnare punto e daccapo).La similitudine i servi più che girare come asini par-tecipa invece della forma mentale di Mezzatesta, fi-gura grandiosa e contraltare negativo dell’epos che– nell’ultimo capitolo – sarà rappresentato da Anto-nello. Nei due personaggi si fronteggiano infatti nonsolo due classi sociali, ma due realtà antropologi-che. La montagna ardeva come un braciere è invecesimilitudine che sostanzia la descrizione dell’even-to naturale, messo in relazione ora con il mondo de-gli oggetti quotidiani, ora con una realtà umana (Si
sentiva l’imminenza delle fiamme come un alito stra-namente odoroso; Le foglie degli alberi […] si met-tevano a tremare come creature), che a sua voltaviene paragonata al mondo animale (pareva di ve-dere quell’individuo agitarsi fra le fiamme con unforcone, saltare come una salamandra).
L’IPERBOLE
Conforme allo spirito popolare, anche l’iperbole èfrequentemente usata: Antonello diventa dispensa-tore di cibo e di giustizia in una sorta di trasfigura-zione religiosa della superstizione collettiva (ap-parve qualche cosa di soprannaturale, un uomo chepochi riconobbero per l’Antonello).
IL REALISMO DI ALVARO
La forma narrativa di Alvaro risente indubbiamentedella lezione verghiana, con alcuni puntuali elemen-ti rivelatori, come l’inserimento del proverbio conta-dino a commento e conclusione dell’evento tragico(Soltanto i grossi, si sa; il fulmine sceglie sempre legrandi altezze) e l’allocuzione finale di Antonello aicarabinieri (Finalmente […] potrò parlare con la Giu-stizia. Ché ci è voluto per poterla incontrare e dirle ilfatto mio!), che risente sia ideologicamente che stili-sticamente dei toni del grande scrittore siciliano adesempio in Libertà.Il realismo alvariano,però,non è immune da una cer-ta ricercatezza stilistica che contrasta con l’oggettivavolontà testimoniale dell’evento (all’autore non inte-ressa raccontare una storia particolare, ma sottoli-nearne il valore mitico-simbolico e quindi universa-le) per muovere verso toni simbolistici.
496
IL SECONDO NOVECENTODal dopoguerra a oggi
Generi
Carlo Levi
La vita e le opere
Un intellettuale del Nord. Carlo Levi nasce a Torinonel 1902 e durante l’adolescenza partecipa del climaculturale della città, che vede in quegli anni operarePiero Gobetti e il suo gruppo. Laureatosi in medici-na a 21 anni, abbandona subito la professione perdedicarsi alla pittura (in cui raggiungerà risultati dilivello internazionale) e alla letteratura. Nel 1929partecipa con il suo maestro, Felice Casorati, algruppo dei «Sei pittori di Torino», che – ispirati dallenuove tendenze europee – avversano ogni forma diaccademismo, propugnando un rinnovamento del-le forme espressive, in aperto contrasto con le teo-rie estetiche imposte dal regime. La passione politi-ca di Levi trova nella lezione di Gobetti un fonda-mentale punto di riferimento: dopo l’esperienzadella rivista clandestina «Lotta politica» (diretta insie-me a Nello Rosselli), ancora nel 1929 egli fonda aParigi con Gaetano Salvemini, Carlo Rosselli, EmilioLussu il movimento clandestino «Giustizia e libertà»,che mira a coniugare le istanze del socialismo rivo-luzionario con i principi liberali, e getta le basi delfuturo Partito d’Azione. La sua vivace attività di or-ganizzatore politico viene presto scoperta: nel 1934è arrestato, incarcerato per alcuni mesi a Torino el’anno successivo inviato al confino in Lucania, pri-ma a Grassano poi ad Aliano, in provincia di Mate-ra, dove trascorre il biennio 1935-36.
L’esperienza del confino e dell’esilio. La complessarealtà meridionale, che già durante gli anni torinesiLevi aveva considerato, teoricamente e ideologica-mente, come prova del carattere artificiale dell’Unitàitaliana, gli si mostra ora concretamente in tutta la suacomplessità. Impedito a esercitare la professione dimedico, si dedica alla pittura, rappresentando nellearti figurative, prima ancora che nelle pagine del ro-manzo che scaturirà da questa esperienza – Cristo siè fermato a Eboli –, il mondo rurale lucano. L’opera,che lo consacrerà scrittore in Italia e all’estero, deveinfatti attendere ancora quasi un decennio per venirealla luce.Nel 1936, in seguito alla proclamazione dell’Impero,Levi viene amnistiato e trascorre gli anni successivi inesilio per l’Europa, prima a Parigi, poi in Bretagna, aLa Baule dove nel 1939 stende il saggio Paura dellalibertà (che sarà pubblicato solo nel 1946, sulla scia
del successo del romanzo). È interessante notare co-me gli anni trascorsi in Lucania lo spingano, primaancora che a narrare direttamente l’esperienza delconfino, a riflettere sulla struttura profonda della co-scienza umana, a interrogarsi sulle cause più genera-li della perdita della libertà degli individui. Ispirando-si agli autori della giovinezza (da Vico agli idealisti te-deschi che leggeva durante le riunioni con Gobetti,da Bergson alla psicanalisi freudiana, all’esistenziali-smo di Jaspers), egli giunge a sostenere che è la na-tura profonda dell’uomo a provocare la nascita deitotalitarismi, in quanto questi, incapace di vivereconsapevolmente i rapporti con gli altri, teme la pro-pria libertà, la rifugge, preferendo annullare la pro-pria coscienza nella massa indistinta, nello Stato-ido-lo come nel Partito, in una istituzione cioè che garan-tisca dall’esterno quelle norme dei rapporti interper-sonali che il singolo individuo ha paura di fondare suuna libera scelta. L’interpretazione della storia con-temporanea alla luce di una teoria socio-antropologi-ca del rapporto individuo-Stato costituisce la base delsuo percorso di ricerca, e si esplicita narrativamentenel romanzo che lo porterà al successo.
Cristo si è fermato a Eboli. Nel 1941 Levi rifiuta il vistoper gli Stati Uniti e decide di continuare in Italia lasua attività antifascista. Durante l’occupazione tede-sca partecipa attivamente alla resistenza fiorentina efa parte del Comitato di Liberazione Nazionale per laToscana. Nei drammatici mesi vissuti a Firenze tra ildicembre del 1943 e il luglio del 1944 scrive di gettoCristo si è fermato a Eboli, che uscirà presso Einaudisolo nel 1945, a guerra ormai conclusa, riscuotendofin da subito un clamoroso successo non solo nazio-nale (in trent’anni avrà ben 32 edizioni).
Le prose di viaggio del dopoguerra. Alla difesa delmondo contadino e dei suoi valori Levi dedicherà an-che le opere saggistiche del decennio successivo, tracui ricordiamo gli scritti raccolti nel volume Le parolesono pietre (1955): il racconto di tre viaggi in Sicilia edelle cose di laggiù, come possono cadere sotto l’oc-chio aperto di un viaggiatore senza pregiudizi, cheriporta alla ribalta la centralità del problema meridio-nale per l’organico sviluppo della nazione (centralitàche Levi sente anche a livello personale, tanto dafondare una federazione in difesa dei lavoratori emi-grati e delle loro famiglie).Di taglio più giornalistico sono invece Il futuro ha uncuore antico, resoconto di un viaggio in Russia, pub-blicato nel 1956, e il volume Tutto il miele è finito, incui sono raccolte le impressioni di una breve perma-
La narrativa meridionalistica • Carlo Levi
497
nenza in Sardegna. Costante, in questi testi, è l’inte-resse verso la cultura popolare, unica depositaria diquei valori che possono rinnovare l’individuo e resti-tuirlo a se stesso.
Un romanzo trascurato: L’orologio. Nonostante imolteplici interessi, la fama di Levi è sempre statalegata al romanzo d’esordio, considerato da moltil’unica testimonianza della sua vena narrativa, piùfeconda nella letteratura testimoniale e di denunciache nell’originalità dell’invenzione. Non stupisceperciò il fatto che la novità del suo secondo roman-zo, L’orologio (1950), sia potuta passare quasi inos-servata, al di là delle polemiche che ne accompa-gnarono l’uscita.Nel 1944 Levi era stato nominato direttore di «Italia li-bera», organo del Partito d’Azione. Le vicende del ro-manzo sono per l’appunto ambientate a Roma, nellasede del quotidiano, dove l’autore-protagonista, aseguito della rottura dell’orologio, vive per tre giornicompletamente avulso dal tempo cronometrico, re-golato solo quello della coscienza, in un flusso dimemoria che evoca personaggi ed eventi apparen-temente senza filo logico, ma in realtà obbedienti al-le leggi della coscienza. L’originale espediente nar-rativo (che risente espressamente delle teorie del fi-losofo francese Henri Bergson e fa di questo l’unicoromanzo veramente «bergsoniano» apparso in Italia),permette a Levi di tratteggiare un quadro completo enon pregiudiziale della società dell’immediato do-poguerra, che ha sacrificato gli ideali della Resisten-za ai due nuovi idoli che puntellano l’istituzione sta-tale: il Vaticano e il Comunismo.La lotta per il potere coinvolge tutti i partiti ed esa-spera la divisione tra gli uomini. Levi identifica dauna parte i Contadini, gli eterni sfruttati, tra cuiconsidera anche le categorie in qualche modoproduttive (la piccola borghesia imprenditoriale egli intellettuali non allineati con il potere), dall’al-tra i Luigini (dal nome del podestà di Aliano), inon-produttori, che si confondono con la massaindifferenziata per godere i privilegi garantiti dal-l’istituzione.Ancora una volta risulta evidente lo sforzo di Levidi andare al di là di una mera analisi della realtàstorica per cogliere in essa le strutture più generalidella coscienza dell’uomo, in un percorso intellet-tuale che, pur con qualche ingenuità, ha semprecercato di essere coerente con se stesso.Negli ultimi anni Levi segue con dedizione la FILEF(Federazione italiana lavoratori emigrati e fami-glie). Muore a Roma il 4 gennaio 1975.
Cristo si è fermato a Eboli
L’esperienza di Aliano. Nel biennio 1935-36 CarloLevi è inviato al confino ad Aliano, piccolo e iso-lato paesino in provincia di Matera, che nel ro-manzo diventa Gagliano, rivelando, con la lievemascheratura, l’esplicita volontà dell’autore di da-re riconoscibilità storica alle vicende narrate. AdAliano egli partecipa alla vita dei paesani, contadi-ni con i quali intesse un rapporto di amicizia e re-ciproco rispetto, e sperimenta personalmente l’e-norme distanza che separa lo Stato dalla popola-zione – una distanza che affonda le radici nell’an-tistatalismo borbonico –, fino a riconoscere nell’a-narchica scelta di brigantaggio dei contadini l’uni-ca risorsa di libertà per uomini abituati allo sfrut-tamento e alla sottomissione.Così egli stesso scrive in una lettera all’editore Ei-naudi posta a presentazione della prima edizioneeconomica (1963) del romanzo:
Certo, l’esperienza intera che quel giovane (che forse ero io)andava facendo, gli rivelava nella realtà non soltanto un pae-se ignoto, ignoti linguaggi, lavori, fatiche, dolori, miserie ecostumi, non soltanto animali e magia, e problemi antichinon risolti, e una potenza contro il potere, ma l’alterità pre-sente, l’infinita contemporaneità, l’esistenza come coesisten-za, l’individuo come luogo di tutti i rapporti, e un mondo im-mobile di chiuse possibilità infinite, la nera adolescenza deisecoli pronti ad uscire e muoversi, farfalle dal bozzolo; e l’e-ternità individuale di questa vicenda, la Lucania che è in cia-scuno di noi, forza vitale pronta a diventare forma, vita, isti-tuzioni, in lotta con le istituzioni paterne e padrone, e, nellaloro pretesa di realtà esclusiva, passate e morte.
Un mondo di ‘alterità’. Il romanzo compendia dun-que, in una drammatica testimonianza di vita, lastoria del popolo meridionale colto nella dimensio-ne etnico-antropologica prima ancora che nellacondizione storico-politica. I contadini lucani, in-fatti, appaiono a Levi vittime da sempre dell’op-pressione e dello sfruttamento, in una situazioneche precede cioè la stessa organizzazione dello Sta-to-idolo (quello di cui ha scritto in Paura della li-bertà, al quale gli individui sono asserviti per unaconsapevole rinuncia alla propria libertà). Essi nonhanno – scrive Levi – né possono avere, quella chesi usa chiamare coscienza politica, perché sono, intutti i sensi del termine, pagani, non cittadini: glidèi dello Stato e della città non possono aver cultotra queste argille, dove regna il lupo e l’antico, nerocinghiale.
498
IL SECONDO NOVECENTODal dopoguerra a oggi
Generi
La sostanziale alterità di questo mondo si esplicitaquindi soprattutto nell’essere al di qua di quellapaura della libertà che Levi ha identificato come ti-pica delle società evolute. La realtà lucana è quindila sola capace di accettare la sfida della libertà stes-sa, l’unico mondo in cui si possono coltivare deirapporti veri fra gli uomini; i suoi valori vannoquindi preservati come l’unico luogo in cui è possi-bile la realizzazione della libertà individuale.(Levi giunge anche a teorizzare le forme politicheconcrete in cui tale realtà può organizzarsi: la tra-sformazione dello Stato in una federazione infinitadi autonomie: dal comune rurale, alle scuole, allesingole fabbriche, a tutte le forme della vita socialedove esso eserciti solo una funzione di controllo la-sciando il massimo dell’iniziativa e del potere auto-nomo ai singoli componenti).I contadini piccoli, neri, con le teste rotonde, i gran-di occhi e le labbra sottili, gli appaiono vivere inuna condizione precedente alla storia e alla civiltà:la loro vita, nelle identiche forme di oggi, si svolge-va nei tempi più remoti: – Noi non siamo cristiani,– essi dicono, – Cristo si è fermato a Eboli –.
«Noi… non siamo uomini». Eboli è infatti il paese cam-pano dove la strada e la ferrovia lasciano la costa sa-lernitana per proseguire verso l’interno, e rappresen-ta l’ultimo luogo segnato dalla civiltà prima della de-solazione e dell’abbandono lucani. Cristiano vuol di-re, nel loro linguaggio, uomo […] «Noi non siamo cri-stiani, non siamo uomini, non siamo considerati co-me uomini, ma bestie, bestie da soma, e ancora menoche le bestie, i fruschi, i frusculicchi, che vivono la lo-ro libera vita diabolica o angelica, perché noi dobbia-mo invece subire il mondo dei cristiani, che sono di làdall’orizzonte, e sopportarne il peso e il confronto». Irapporti umano-animaleschi caratterizzano la culturagaglianese, un «mondo ambiguo, magicamente con-fuso e indefinito, in cui coesistono diverse nature pri-ma di acquisire una presenza storica» (Falaschi).Il riconoscimento di questa peculiarità e la necessità dirispettare ‘il diverso’, l’alterità propria della civiltà con-tadina – intesa come sistema alternativo di valori e noncome dimostrazione di arretratezza e di incultura – re-sta l’eredità forse più feconda dell’analisi leviana, al dilà delle polemiche che accompagnarono il libro, spes-so tacciato di «meridionalismo» e di «populismo».
Una famiglia rurale fotografata in Basilicata nel 1929 da Saverio Morra.
La narrativa meridionalistica • Carlo Levi
499
«Tutto è realmente possibile, quaggiù»da Cristo si è fermato a Eboli
Presentiamo un intero capitolo del romanzo. Il protagonista si è stabilito inuna casa un po’ fuori dal paese ed è accudito dalla governante Giulia Ve-nere, fredda, impassibile, animalesca, una donna di appena quaran-tun’anni, ma già antichissima, ritenuta dai paesani una strega contadina,depositaria di una sapienza secolare e di una ambigua natura magica.Dal terrazzo prospiciente la casa, egli passa in rassegna i paesini che cir-condano Gagliano e ne presenta al lettore la natura ruvida, magica e mi-steriosa: la leggenda del drago le cui corna sono conservate in una chiesameta di pellegrinaggi, le varie storie legate alla doppia natura umana eanimale di molti abitanti di Gagliano e una digressione gustosa sulla sto-ria del suo cane, Barone, cui i Gaglianesi tributano speciale rispetto per lasua presunta origine divina. Il capitolo si conclude con la festa della Ma-donna, uno spettacolo grandioso di agitazione frenetica e infocata in cuisi confondono religione, superstizione e tradizioni pagane.
I grandi calori andavano passando, in quel settembre avanzato, e cede-vano al primo fresco precursore dell’autunno. I venti mutavano direzio-ne, non portavano più l’arsura bruciante dei deserti, ma un vago sento-re marino; e i tramonti allungavano per delle ore le loro strisce di rossifuochi, sui monti di Calabria, nell’aria piena dei voli delle cornacchie edei pipistrelli. Sulla mia terrazza il cielo era immenso, pieno di nubi mu-tevoli: mi pareva di essere sul tetto del mondo, o sulla tolda di una na-ve, ancorata su un mare pietrificato. A monte, verso levante, le casupo-le di Gagliano di Sotto nascondevano agli sguardi il resto del paese, che,costruito sulla cresta di un’onda di terra, a saliscendi, non si riesce mai avedere intero da nessuna parte: dietro i loro tetti giallastri spuntava lacosta di un monte, al di sopra del cimitero, e di là, prima del cielo, sisentiva il vuoto della valle. Sulla mia sinistra, a mezzogiorno, c’era lastessa vista che dal palazzo: la distesa sconfinata delle argille, con lemacchie chiare dei paesi, fino ai confini del mare invisibile. Alla mia de-stra, a mezzanotte, scendeva la frana sul burrone rinchiuso fra i monti,che mostravano la loro faccia spelacchiata e brulla: in fondo al burroneil sentiero, dove vedevo muoversi, non più grandi di formiche, i conta-dini che andavano e venivano dai campi. La Giulia si meravigliava cheio sapessi distinguere, a una tale distanza, i gaglianesi dai forestieri, icontadini dai mercanti ambulanti: e, per quanto la mia vista fosse buo-na, non avrei davvero potuto farlo se non per divinazione o per magìa.Ma avevo notato il loro diverso modo di camminare: i contadini avanza-vano rigidi, senza muovere le braccia. Ogni volta che io vedevo uno diquei puntini neri muoversi oscillando con un dondolìo e un’aria quasi didanza, potevo esser certo che era uno di città: presto la tromba del ban-ditore becchino avrebbe annunciato il suo arrivo e chiamate le donneall’acquisto delle sue mercanzie1.Dinanzi a me, verso occidente, dietro le larghe foglie verdi e grige del fi-co dell’orto e i tetti delle ultime catapecchie digradanti in pendìo, sorge-va il Timbone della Madonna degli Angeli, un monticciuolo di terra tut-to incavi e sporgenze, con poca erba rada qua e là nella parte meno di-rupata, come un osso di morto, la testa di un femore gigantesco, che
1. presto … sue mercanzie: l’autore si rife-risce all’abitudine della popolazione di an-nunciare tutti gli eventi che coinvolgono ilpaese (dalle nascite ai decessi, all’arrivo –come in questo caso – di un mercante dallacittà) mediante un pubblico banditore (chequi è anche il becchino del paese); ancheuna sopravvivenza dell’antica arte dei canta-storie e una significativa ignoranza dei mo-derni mezzi di comunicazione (le vicendenarrate si svolgono nel biennio 1935-36).
500
IL SECONDO NOVECENTODal dopoguerra a oggi
Generi
portasse ancora attaccati dei brandelli secchi di carne e di pelle. A sini-stra del Timbone, per un tratto lunghissimo, fino laggiù in fondo, versol’Agri, dove il terreno si spianava in un luogo detto il Pantano, era un se-guirsi digradante di monticelli, di buche, di coni di erosione rigati dal-l’acqua, di grotte naturali, di piagge, fossi e collinette di argilla unifor-memente bianca, come se la terra intera fosse morta, e ne fosse rimastoal sole il solo scheletro imbiancato e lavato dalle acque. Dietro questoossame desolato era nascosto, su una piccola altura sul fiume malarico2,Gaglianello, e più lontano si vedeva il greto dell’Agri. Di là dall’Agri, suuna prima fila di colline grige, sorgeva bianco Sant’Arcangelo, il paesedi Giulia, e dietro, più azzurre, si levavano altre colline ed altre ancora,schierate più indietro, con dei paesi vaghi nella distanza, e più in là an-cora i borghi degli albanesi3, sulle prime pendici del Pollino, e dei mon-ti di Calabria che chiudevano l’orizzonte. Un po’ a sinistra e più in altodi Sant’Arcangelo, appariva, a mezza costa di un’altura, il biancore diuna chiesa. Qui usavano convenire in pellegrinaggio le genti della valle:era un luogo di molta devozione, sede di una madonna miracolosa. Inquesta chiesa erano conservate le corna di un drago che infestava, neitempi antichi, la regione. Tutti, a Gagliano, le avevano vedute. Io pur-troppo non potei mai andarci, come avrei desiderato. Il drago, a quelloche mi raccontarono, abitava in una grotta vicino al fiume, e divorava icontadini, riempiva le terre del suo fiato pestifero, rapiva le fanciulle, di-struggeva i raccolti. Non si poteva più vivere, in quel tempo, a Sant’Ar-cangelo. I contadini avevano cercato di difendersi, ma non potevano farnulla contro quella bestiale potenza mostruosa. Ridotti alla disperazio-ne, costretti a disperdersi come animali su per i monti, pensarono infinedi rivolgersi per soccorso al più potente signore dei luoghi, al principeColonna di Stigliano.Il principe venne, tutto armato, sul suo cavallo, andò alla grotta del dra-go e lo sfidò a battaglia. Ma la forza del mostro, dalla bocca che lancia-va fuoco e dalle enormi ali di pipistrello, era immensa, e la spada delprincipe pareva impotente di fronte a lui. A un certo momento, quel va-loroso si sentì tremare il cuore, e stava quasi per darsi alla fuga o per ca-dere fra gli artigli del drago, quando gli apparve, vestita di azzurro, laMadonna, che gli disse con un sorriso: – Coraggio, principe Colonna! –e rimase da una parte, appoggiata alla parete di terra della caverna, aguardare la lotta. A questa visione, a queste parole, l’ardimento del prin-cipe si centuplicò, e tanto fece che il dragone cadde morto ai suoi piedi.Il principe gli tagliò la testa, ne staccò le corna, e fece edificare la chie-sa perché vi fossero per sempre conservate.Passato il terrore, liberato il paese, i santarcangelesi tornarono alle lorocase, e così fecero quelli di Noepoli e di Senise e degli altri paesi lì at-torno, che, come loro, avevano dovuto fuggire pei monti. Bisognavaora compensare il principe per il servizio reso: in quei tempi antichi, isignori, per quanto cavallereschi e amanti di gloria, e protetti personal-mente dalla Madonna, non usavano muoversi per nulla. Si radunaronoperciò gli abitanti di tutti i paesi fatti sicuri dalla morte del drago, perdeliberare. Quelli di Noepoli e di Senise proposero di dare al principealcune loro terre in signoria feudale: ma quelli di Sant’Arcangelo, cheancora oggi sono reputati avari e astuti4, e che volevano salvare la terra,fecero una diversa proposta. – Il drago, – dissero, – abitava nel fiume,era una bestia dell’acqua. Il principe si prenda dunque il fiume, diventi
2. fiume malarico: fiume malsano, ap-portatore di malaria.3. albanesi: nella zona, come in altre del
Mezzogiorno (in Puglia, Calabria e Sicilia)vi erano, e ancora vi sono, comunità di ori-gine albanese o greca, immigrate in tempiantichi.4. che ancora … astuti: l’espressione è
chiaramente antifrastica, come mostra l’e-pisodio seguente.
La narrativa meridionalistica • Carlo Levi
501
il signore della corrente –. Il loro consiglio prevalse: l’Agri fu offerto alColonna, e quello lo accettò. I contadini di Sant’Arcangelo credevano diaver fatto un buon affare, e di aver ingannato il loro salvatore: ma ave-vano fatto male i loro conti. L’acqua dell’Agri serviva ad irrigare i cam-pi, e da allora bisognò pagarla al principe e ai signori feudali suoi di-scendenti, per tutti i secoli. Così ebbe origine una servitù che si è con-servata fino alla seconda metà del secolo scorso. Non so se esistano an-cora oggi dei discendenti diretti di quell’antico paladino, e se vantinoancora i loro diritti sull’acqua. Un mio amico, il direttore d’orchestra Co-lonna, che discende da un ramo collaterale dei principi di Stigliano epotrebbe portarne il titolo, non sapeva neppure, quando dopo moltianni gliene parlai, dove fosse Stigliano, il suo feudo, e tanto meno sa-peva nulla del drago, gloria della sua famiglia. Ma i contadini, che han-no pagato l’acqua per molti secoli, e che vanno ancora in pellegrinag-gio a contemplare le corna del mostro, si ricordano del drago e dellaMadonna, e del principe.Che ci fossero, da queste parti, dei draghi, nei secoli medioevali (i con-tadini e la Giulia, che me ne parlavano, dicevano: – In tempi lontani, piùdi cent’anni fa, molto prima del tempo dei briganti –) non fa meraviglia:né farebbe meraviglia se ricomparissero ancora, anche oggi, davanti al-l’occhio atterrito del contadino. Tutto è realmente possibile, quaggiù,dove gli antichi iddii dei pastori, il caprone e l’agnello rituale, ripercor-rono, ogni giorno, le note strade, e non vi è alcun limite sicuro a quelloche è umano verso il mondo misterioso degli animali e dei mostri. Ci so-no a Gagliano molti esseri strani, che partecipano di una doppia natura.Una donna, una contadina di mezza età, maritata e con figli, e che nonmostrava, a vederla, nulla di particolare, era figlia di una vacca. Così di-ceva tutto il paese, e lei stessa lo confermava. Tutti i vecchi ricordavanola sua madre vacca, che la seguiva dappertutto quando era bambina, ela chiamava muggendo, e la leccava con la sua lingua ruvida. Questonon impediva che fosse esistita anche una madre donna, che ora eramorta, come da molti anni era morta anche la madre vacca. Nessunotrovava, in questa doppia natura e in questa doppia nascita, nessunacontraddizione: e la contadina, che anch’io conoscevo, viveva, placida etranquilla come le sue madri, con la sua eredità animalesca.Alcuni assumono questa mescolanza di umano e di bestiale soltanto inparticolari occasioni. I sonnambuli diventano lupi, licantropi, dove nonsi distingue più l’uomo dalla belva. Ce n’era qualcuno anche a Gagliano,e uscivano nelle notti d’inverno, per trovarsi con i loro fratelli, i lupi veri.– Escono la notte, – mi raccontava la Giulia, – e sono ancora uomini, mapoi diventano lupi e si radunano tutti insieme, con i veri lupi, attorno allafontana. Bisogna star molto attenti quando ritornano a casa. Quandobattono all’uscio la prima volta, la loro moglie non deve aprire. Se apris-se vedrebbe il marito ancora tutto lupo, e quello la divorerebbe, e fuggi-rebbe per sempre nel bosco. Quando battono per la seconda volta, an-cora la donna non deve aprire: lo vedrebbe con il corpo fatto già di uo-mo, ma con la testa di lupo. Soltanto quando battono all’uscio per la ter-za volta, si aprirà: perché allora si sono del tutto trasformati, ed è scom-parso il lupo e riapparso l’uomo di prima. Non bisogna mai aprire la por-ta prima che abbiano battuto tre volte. Bisogna aspettare che si sianomutati, che abbiano perso anche lo sguardo feroce del lupo, e anche lamemoria di essere stati bestie. Poi, quelli non si ricordano più di nulla.
502
IL SECONDO NOVECENTODal dopoguerra a oggi
Generi
La doppia natura è talvolta spaventosa e orrenda, come per i licantropi;ma porta con sé, sempre, una attrattiva oscura, e genera il rispetto, co-me a qualcosa che partecipa della divinità. Qualcosa di questo genereera riconosciuta da tutti, in paese, per il mio cane, che non era riguar-dato come un cane normale, ma come un essere straordinario, diversoda tutti gli altri cani, e degno di essere particolarmente onorato. Anch’io,del resto, ho sempre pensato che in lui ci fosse un elemento infantil-mente angelico o demoniaco, e che i contadini non avessero torto neltrovargli quella ambiguità che obbliga all’adorazione. Già, la sua origineera misteriosa. Questo cane era stato trovato in treno, sulla linea che daNapoli va a Taranto, con un cartellino appeso al collare che diceva: «Ilmio nome è Barone. Chi mi trova abbia cura di me». Non si seppe dun-que mai di dove venisse: forse dalla grande città, poteva essere il figliodi un re. Lo presero i ferrovieri, e lo tennero qualche tempo alla stazio-ne di Tricarico; quelli di Tricarico lo regalarono ai ferrovieri della stazio-ne di Grassano5. Il podestà di Grassano lo vide, se lo fece dare dai fer-rovieri, e lo tenne nella sua casa con i suoi bambini, ma poiché facevatroppo chiasso, ne fece dono a suo fratello, segretario del sindacato deicontadini di Grassano, che lo portava sempre con sé, nei suoi giri per lacampagna. Tutti conoscevano Barone, e tutti, a Grassano, lo considera-vano un essere straordinario.Un giorno, nei tempi in cui vivevo solo laggiù, mi avvenne di dire percaso a dei miei amici contadini e artigiani che non mi sarebbe dispia-ciuto avere un cane, per la compagnia. La mattina dopo mi portaronosubito un cucciolo, uno dei soliti cani gialli da caccia. Lo tenni qualchetempo, ma non mi piaceva: non mi riusciva di allevarlo, sporcava dap-pertutto, e non mi pareva intelligente: perciò lo restituii a quelli che mel’avevano regalato, e non pensai più a cani. Ma quando arrivò improv-visamente l’ordine di partire per Gagliano, e quella buona gente che misi era affezionata ne fu spiacentissima, come di una disgrazia che li aves-se ingiustamente colpiti, i contadini vollero lasciarmi un regalo, che miseguisse e mi rammentasse che a Grassano c’erano dei buoni cristianiche mi volevano bene. Si ricordarono di quel mio vecchio desiderio,che io mi ero ormai dimenticato, e decisero di regalarmi un cane. Manessun altro cane era degno di me, se non il famoso Barone; e Baronedoveva essere mio. Tanto dissero e tanto fecero, che riuscirono a farse-lo dare dal suo padrone, lo pulirono, lo lavarono, gli cercarono un belcollare, una museruola, e un guinzaglio. Antonino Roselli, il giovanebarbiere e flautista, che sognava di seguirmi in capo al mondo comemio segretario, lo tosò da leoncino, lasciandogli il lungo pelo sul da-vanti, e rasandolo sul dietro, con un grosso ciuffo in cima alla coda; e in-gentilito, bianco, profumato e travestito, Barone, il selvaggio Barone, mifu offerto in dono, a ricordo eterno della buona città di Grassano, il gior-no prima della mia partenza. Così truccato e abbellito, io stesso non ca-pivo che cane fosse: mi pareva uno strano miscuglio di cane barbone edi cane da pastore. In verità era forse un cane da pastore, ma di una raz-za o incrocio non comune: non ne ho mai incontrati altri identici. Era dimedia grandezza, tutto bianco, con una macchia nera sulla punta delleorecchie; che aveva lunghissime e pendenti ai lati del viso. Questo eramolto bello, come quello di un drago cinese, spaventoso nei momentidi furore, o quando mostrava i denti, ma con due occhi rotondi e uma-ni, color nocciola, coi quali mi seguiva senza voltare il capo, pieno vol-
5. Tricarico … Grassano: paesi in provin-cia di Matera; a Grassano Levi aveva tra-scorso qualche settimana all’inizio del con-fino, prima del trasferimento ad Aliano.
La narrativa meridionalistica • Carlo Levi
503
ta a volta di dolcezza, di libertà e di una certa infantile misteriosa argu-zia. Il pelo era lungo quasi fino a terra, ricciuto, morbido e lucente comela seta: la coda, che egli portava arcuata e svolazzante come un pennac-chio di guerriero orientale, era grossa come quella di una volpe. Era unessere allegro, libero e selvaggio: si affezionava, ma senza servilità; ub-bidiva, ma conservava la sua indipendenza; una specie di folletto o dispiritello familiare, bonario, ma, in fondo, irraggiungibile. Più che cam-minare, saltava, a grandi balzi, con un ondeggiare delle orecchie e delpelo; inseguiva le farfalle e gli uccelli, spaventava le capre, lottava con icani e coi gatti, correva da solo pei campi guardando le nuvole, semprepronto, scattante, in un continuo gioco aereo, come seguisse il filo on-dulante di un innocente pensiero inumano, l’elastico incarnarsi di unbizzarro spirito dei boschi.Fin dal nostro primo arrivo a Gagliano, l’attenzione di tutti si posò suquesto mio strano compagno: e i contadini, che vivono immersi nell’in-canto animalesco, si accorsero subito della sua natura misteriosa. Nonavevano mai visto una bestia simile: in paese ci sono soltanto i segugibastardi, buoni cacciatori talvolta, ma miseri, umiliati, plebei; e solo dirado passa, dietro i greggi ed i pastori, qualche maremmano feroce, colcollare irto di punte di ferro, contro il morso dei lupi. E poi, il mio canesi chiamava Barone. In questi paesi, i nomi significano qualcosa: c’è inloro un potere magico: una parola non è mai una convenzione o un fia-to di vento, ma una realtà, una cosa che agisce. Egli era dunque, davve-ro, un barone; un signore, un essere potente, che bisognava rispettare.Se, fin dal primo giorno, io fui guardato dai popolani con simpatia equasi con ammirazione, lo dovetti certo un poco anche al mio cane.Quando egli passava, pazzamente saltando e abbaiando nella sua follelibertà naturale, i contadini se lo additavano, e i ragazzi gridavano: –Guarda, guarda! Mezzo barone e mezzo leone! – Barone per loro era unanimale araldico, il leone rampante sullo scudo di un signore. E tuttaviaera soltanto un cane, un frusco6 come tutti gli altri: ma questa sua dop-pia natura era meravigliosa. Anch’io lo amavo per la sua semplice mol-teplicità. Ora egli è morto, come mio padre a cui l’avevo regalato, ed èsepolto sotto un mandorlo in faccia al mare di Liguria, in quella mia ter-ra dove io non posso mettere il piede, poiché pare che i potenti, nel lo-ro terrore del sacro, abbiano scoperto che anche in me è una doppia na-tura, e che, anch’io, sono mezzo barone e mezzo leone.Tutto, per i contadini, ha un doppio senso. La donna-vacca, l’uomo-lu-po, il Barone-leone, la capra-diavolo non sono che immagini particolar-mente fissate e rilevanti: ma ogni persona, ogni albero, ogni animale,ogni oggetto, ogni parola partecipa di questa ambiguità. La ragione sol-tanto ha un senso univoco, e, come lei, la religione e la storia. Ma il sen-so dell’esistenza, come quello dell’arte e del linguaggio e dell’amore, èmolteplice, all’infinito. Nel mondo dei contadini non c’è posto per la ra-gione, per la religione e per la storia. Non c’è posto per la religione, ap-punto perché tutto partecipa della divinità, perché tutto è, realmente enon simbolicamente, divino, il cielo come gli animali, Cristo come la ca-pra. Tutto è magìa naturale. Anche le cerimonie della chiesa diventanodei riti pagani, celebratori della indifferenziata esistenza delle cose, de-gli infiniti terrestri dèi del villaggio.Eravamo alla metà di settembre, la domenica della Madonna. Fin dalmattino le strade erano piene di contadini vestiti di nero, c’erano dei fo-
6. frusco: «spirito animale». Il termine ap-partiene alla lingua dei paesani, e comparenella espressione che Levi cita in aperturadel romanzo: Noi non siamo cristiani, nonsiamo uomini, non siamo considerati co-me uomini, ma bestie, bestie da soma, eancora meno che le bestie, i fruschi, i fru-sculicchi, che vivono la loro libera vita dia-bolica o angelica…
504
IL SECONDO NOVECENTODal dopoguerra a oggi
Generi
restieri, i musicanti di Stigliano e gli artificieri di Sant’Arcangelo, venuti adisporre le bombe e i mortaretti. Il cielo era chiaro e leggero, e ogni tan-to giungeva, per l’aria, con il suono funebre delle campane, lo sparo diqualche fucilata. I contadini, con i loro schioppi lucidi, inauguravano lafesta. Il pomeriggio, dopo le ore del caldo, cominciò la processione.Uscì dalla chiesa, e percorse tutto il paese. Risalì dapprima fino al cimi-tero, poi ridiscese alla piazza, alla piazzetta, giù fino a Gagliano di Sottoe alla crollata Madonna degli Angeli, per tornare poi, per la stessa stra-da, al punto di partenza, e rientrare in chiesa. Davanti camminavano deigiovanotti con delle pertiche, su cui, a guisa di stendardi, erano attacca-ti dei panni, dei lenzuoli bianchi, e li agitavano e sventolavano; e i suo-natori della banda di Stigliano con le trombe lucenti e fragorose. Poi, suun baldacchino retto da due lunghe stanghe, portato a turno da unadozzina di uomini, veniva la Madonna. Era una povera Madonna di car-tapesta dipinta, una copia modesta della celebre e potentissima Madon-na di Viggiano, e aveva, come quella, il viso nero7: era tutta coperta diabiti di gala, di collane e di braccialetti. Dietro la Madonna camminavadon Trajella, con una stola bianca sulla vecchia sottana bisunta, e il suosolito aspetto stanco, smunto e annoiato; poi il podestà e il brigadiere, epoi i signori, e poi le donne, tutte insieme, con un grande ondeggiare diveli bianchi, i ragazzi e i contadini. Si era levato un gran vento fresco,che alzava nuvole di polvere, e faceva volare le sottane, i veli e le ban-diere: forse sarebbe venuta la pioggia, in tanti mesi di arsura invano in-vocata e desiderata. Al passaggio della processione, scoppiava con fra-gore una doppia fila di mortaretti, disposti lungo tutta la strada. Le mic-ce si accendevano, le strisce di polvere prendevano fuoco, le bombe de-tonavano, i contadini si affacciavano sulle soglie con i fucili, e sparava-no in aria. Il crepitìo, il frastuono erano continui, interrotti soltanto dalrumore improvviso di qualche carica più grossa, che rimbombava e sve-gliava gli echi dei burroni. In questo chiasso di battaglia non si vedeva,negli occhi delle persone, felicità o estasi religiosa, ma una specie di fol-lia, una pagana smoderatezza, e come uno stordimento a cui si lasciava-no andare. Tutti erano eccitati. Gli animali correvano spaventati, le ca-pre saltavano, gli asini ragliavano, i cani abbaiavano, i ragazzi urlavano,le donne cantavano. Sugli usci di tutte le case i contadini aspettavano laprocessione con in mano un cesto di grano, e al suo passaggio ne but-tavano piene manciate sulla Madonna, perché si ricordasse dei raccoltie portasse la buona fortuna. I chicchi volavano per l’aria, cadevano sul-le pietre del selciato e rimbalzavano con un rumore leggero, come digrandine. La Madonna dal viso nero, tra il grano e gli animali, gli spari ele trombe, non era la pietosa Madre di Dio, ma una divinità sotterranea,nera delle ombre del grembo della terra, una Persefone contadina, unadea infernale delle messi.Davanti alla porta di alcune case, qua e là dove la strada si allargava,erano preparati dei tavoli coperti da una tovaglia bianca, come dei pic-coli rustici altari. La processione faceva sosta qui davanti, don Trajellabiascicava qualche benedizione, e i contadini e le donne correvano aportare le offerte. Attaccavano agli abiti della Madonna delle monete,dei biglietti da cinque e da dieci lire, e perfino dei dollari, avanzo gelo-so delle fatiche americane8.Ma i più le appendevano al collo grandi collane di fichi secchi, o posa-vano ai suoi piedi frutta e uova, e correvano con altre offerte quando già
7. il viso nero: le cosiddette «Madonne ne-re», tipiche dell’Europa orientale, sono pre-senti nelle aree del Mezzogiorno fin datempi molto antichi, dove si legano alla tra-dizione delle icone importata dalla domi-nazione bizantina.8. avanzo … americane: «il poco denaro
rimasto dei guadagni realizzati in America,conservato gelosamente»; molti degli abi-tanti di Aliano sono infatti ex emigranti tor-nati in patria o familiari di emigranti rimastiin America a fare fortuna.
La narrativa meridionalistica • Carlo Levi
505
la processione si era rimessa in cammino, e si univano alla folla e allostrepito delle trombe, degli spari e delle grida. Più la processione avan-zava, più si faceva numerosa e tumultuante, finché, ripercorso tutto ilpaese, non rientrò nella chiesa. Cadeva qualche grossa goccia di piog-gia, ma presto il vento spazzò le nubi, il temporale si allontanò e tornòil sereno, con le prime stelle della sera. Così non si sarebbe sciupato lospettacolo dei fuochi. Tutti mangiarono un boccone in fretta: appenabuio tutto il paese si riversò ai bordi del burrone, di dove, qualche me-tro più in basso, dovevano partire le bombe. Fu allora che vidi dei grup-pi di giovanotti salire sul tetto del monumento della piazzetta, per me-glio godere, di là, lo spettacolo. In onore della Madonna anche noi con-finati potevamo restare un’ora di più fuori di casa9. Era la grande gior-nata, la festa dei raccolti, la sera del fuoco. Si erano spese tremila lire peri fuochi artificiali, e questa era un’annata cattiva: altre volte si era arriva-ti anche alle cinque e alle seimila: i paesi più grandi consumano, neigiorni dei loro santi, cifre anche molto più grosse. Tremila lire, per Ga-gliano, sono una somma enorme, il risparmio totale di mezza annata,ma per i fuochi si buttano volentieri, e nessuno le rimpiange. Si eranoconsultati, a gara, gli artificieri più noti della provincia: se si avesse avu-to più denaro si sarebbero scelti quelli di Montemurro o quelli di Fer-randina, ma ci si era dovuti accontentare dei santarcangelesi, che, delresto, erano buonissimi. Ed ecco, fra gli applausi, le grida di spavento edi ammirazione delle donne e dei bambini, la prima candela romana sa-liva diritta verso il cielo pieno di stelle e poi un’altra, e un’altra ancora, epoi le girandole, i bengala, le bombe, le grandi piogge d’oro: uno spet-tacolo meraviglioso.Erano le dieci, e dovevo rientrare. Dalla mia terrazza, con Barone cheguardava eccitato in aria e abbaiava agli spari, rimasi ancora a lungo acontemplare le luci che salivano e ricadevano sfriggendo sull’argilla delTimbone, e ad ascoltare il rimbombo degli scoppi. Poi ci fu il lancio ac-celerato di venti fuochi, e il gran colpo finale; e udii a poco a poco lagente disperdersi, i passi sulle pietre, lo sbattere degli usci. Il giorno del-la festa contadina era finito, con la sua agitazione frenetica e infocata; glianimali dormivano, e sul paese buio era tornato il silenzio e l’oscuritàvuota del cielo.
9. anche noi … casa: la festa determinadunque un clima di ‘trasgressione’ ancheper i confinati che, di norma, dovevano in-fatti osservare un orario preciso per il rien-tro, il cosiddetto ‘coprifuoco’.
Analisi del testo
I l capitolo esemplifica chiaramente molti procedi-menti narrativi e stilistici operanti nel romanzo; li
analizzeremo seguendo le cinque sezioni in cui sistruttura il brano.
LA DESCRIZIONE DELL’AMBIENTE
La prima sezione è occupata dalla descrizione del-l’ambiente naturale, che familiarizza il lettore con la
nuova dimora del protagonista. Le prime righe delcapitolo (come di ogni altro del romanzo) anticipa-no il tema dominante (altrove fungono invece dachiave di lettura per il capitolo precedente). Qui ladescrizione del passaggio dall’estate all’autunno ètutta giocata sulla contrapposizione tra immobilità-mobilità, monotonia-cambiamento, e prelude al te-ma del doppio (uomo/animale) inteso come essen-za della civiltà contadina.
506
IL SECONDO NOVECENTODal dopoguerra a oggi
Generi
La descrizione del paesaggio – osservato dai quat-tro punti cardinali – si avvale di un linguaggio imma-ginoso che,partendo da una semplice analogia (ter-razza / tolda di una nave) sviluppa poi una serie di cate-ne simboliche (paese / mare pietrificato; crosta dellaterra / cresta di un’onda di terra). Il procedimento stili-stico introduce ed esplicita la dimensione magica cheil mondo naturale assume per la cultura contadina, di-mensione ormai parte della forma mentis dell’autore.
IL MONDO DEL SOPRANNATURALE
E DEL ‘MAGICO’
La descrizione di una chiesa in cui sono conservatele corna di un drago, introduce alla seconda sezionedel capitolo.Particolare attenzione merita l’uso dellacostruzione astratta il biancore di una chiesa, che po-ne in primo piano la qualità dell’oggetto e ‘abbassa’questo a complemento di specificazione della stes-sa.Tale stilema, tipico della poesia simbolista, espli-cita il cosiddetto ‘impressionismo’dell’autore – la ca-pacità cioè di fare del colore la principale caratteri-stica del paesaggio – frutto dell’analitica capacità edella ‘qualità’ di osservazione derivanti dalla sua at-tività di pittore.Il mondo del soprannaturale e del ‘magico’, qui em-blematizzato dal drago, è presentato da Levi in ter-mini assolutamente plausibili e senza ostentare in-credulità o sarcasmo; l’autore usa infatti l’imperfetto(In questa chiesa erano conservate le corna di un dra-go che infestava) e non il condizionale eventuale(«che avrebbe infestato, che dicevano avesse infe-stato»), in modo da marcare la realtà dell’evento. Sinoti come la tipologia del racconto dell’impresa delprincipe Colonna contro il drago sia modellata suquella delle fiabe: assoluta indeterminatezza degliindicatori temporali (A un certo momento, A questavisione), iperbolizzazione del valore del protagoni-sta (tutto armato: quel valoroso: l’ardimento del prin-cipe si centuplicò), uso dell’anafora in funzioneespressiva (A questa visione, a queste parole), pre-senza quasi esclusiva della sintassi paratattica (glitagliò la testa, ne staccò le corna, e fece edificare lachiesa). Il racconto presenta inoltre, sul piano delcontenuto,un interessante aggancio ai miti orientali,nei quali il drago rappresenta le forze ctonie, le for-ze del Caos; la sua uccisione segna perciò il ristabi-
limento del cosmo, dell’ordine, e, non ultimo, la fon-dazione della civiltà.
IL TEMA DEL ‘DOPPIO’
Ci sono a Gagliano molti esseri strani, che partecipa-no di una doppia natura: inizia così, con la terza se-zione, il nucleo centrale del capitolo (introdotto giàdalla storia del drago che è morto,ma sempre è pre-sente, conservato), tutto giocato sul tema del ‘dop-pio’, della natura bivalente degli abitanti di Gagliano(la donna-vacca, l’uomo-lupo…). La contiguità delrapporto uomo-animale è tale da investire anche lastruttura linguistica, fitta di parallelismi.
IL CANE BARONE
La quarta sezione è tutta occupata dalla storia del ca-ne Barone. La trasposizione dell’alterità animalesco-divina nel cane, tanto legato allo scrittore da diventa-re una sua proiezione, una sua sorta di ‘doppio’ (an-che in me è una doppia natura), stringe il legame diLevi con questa civiltà, con le sue credenze e la suacultura. Nel racconto dell’episodio si può rilevareuno dei procedimenti narrativi più frequenti nel cor-so del romanzo: la costruzione di una vicenda baseall’interno della quale è possibile effettuare diversedigressioni e stacchi temporali,come un viaggio del-la memoria nella memoria; qui si possono eviden-ziare tre livelli temporali: il presente dell’atto dellanarrazione, il perfetto storico di Grassano e il passa-to remoto di Aliano.La digressione sul nome del cane permette all’auto-re una riflessione linguistico-antropologica (In que-sti paesi, i nomi significano qualcosa:c’è in loro un po-tere magico: una parola non è mai una convenzione oun fiato di vento, ma una realtà, una cosa che agisce).Per Levi, infatti, mondo colto e mondo magico-po-polare si oppongono radicalmente proprio nella pa-rola:non etichetta intellettuale,né flatus vocis,ma do-minio dell’essenza delle cose (la parola agisce sullacosa che nomina). È una esplicita dichiarazione dipoetica, valida alla comprensione delle costanti sti-listiche osservate: semplicità, linearità, misura. Lalingua per Levi non deve essere altro che strumentodi comunicazione, una realtà, quindi, una cosa essastessa che agisce.
La narrativa meridionalistica • Ignazio Silone
507
L’IMPORTANZA DELLA FESTA
L’ultima sezione presenta il racconto della festa del-la Madonna, una sorta di exemplum di festa, paga-na e religiosa insieme, che ha per il paese un signi-ficato assoluto, come momento di coagulazione in-
torno a una identità collettiva e di liberazione dell’i-stintività repressa, che trova normativa e garanzianella tradizione stessa.Si noti nella descrizione del-la festa il già segnalato procedere sintattico per ac-cumulo di brevissime proposizioni principali lega-te per asindeto.
Proposte operative
Analisi
Rintraccia nel testo tutti gli elementi che documentano la dimensione magica della cultura contadina.Come si rapporta lo scrittore a questa dimensione? Quali indizi segnalano la sua posizione?Evidenzia nel passo la poetica dello scrittore: ritieni che i principi esposti siano attuati in quanto hai letto?Spiega l’affermazione: Nel mondo dei contadini non c’è posto per la ragione, per la religione e per la storia.
Analizza il racconto della festa della Madonna alla luce di questa preventiva considerazione.
4
3
2
1
Ignazio Silone
La vita e le opere
L’impegno politico e l’esilio: l’esordio letterario.Ignazio Silone – pseudonimo di Secondo Tranquil-li – nasce a Pescina dei Marsi in provincia dell’A-quila il 10 maggio del 1900. Il terremoto del 1915distrugge la casa di famiglia e lo costringe – orfanodi entrambi i genitori – a lasciare l’Abruzzo e a tra-sferirsi a Roma per proseguire gli studi; nella capi-tale si dedica molto presto all’attività politica. Nel 1921, in qualità di rappresentante della gio-ventù socialista italiana, è a Livorno, con AntonioGramsci, alla fondazione del Partito Comunistad’Italia; sei anni dopo, in delegazione a Mosca conTogliatti, assiste all’espulsione di Trotzkij e Zi-nov’ev dal Komintern, evento che sigla l’ascesa diStalin al potere. Sempre più distante dalle scelteoperate dall’Esecutivo del partito, nel 1930 vienealla definitiva rottura ed entra nell’Internazionalesocialista. Perseguitato per antifascismo dalle au-
torità, è costretto a riparare in Svizzera dove rima-ne fino alla fine della guerra. Durante l’esilio adot-ta lo pseudonimo con cui firmerà le opere, emble-maticamente derivato dal romano Quintus Poppe-dius Silo che guidò le rivolte dei Marsi nella guerrasociale del 90 a.C., cristianizzato con il nome delsanto spagnolo Ignazio.A Davos, in una casa di cura dove era stato ricove-rato per una malattia polmonare, inizia a scrivere ilromanzo che (pubblicato, come gli altri scritti du-rante l’esilio, in prima edizione e in traduzione te-desca a Zurigo) lo renderà famoso in tutto il mon-do prima ancora che in Italia: Fontamara (1933); aquesto seguono presto Pane e vino (1936) e Il se-me sotto la neve (1941). La Svizzera è infatti in que-sti anni non solo il rifugio di tanti oppositori del re-gime, ma un vero e proprio crocevia di culture edesperienze intellettuali eterogenee; qui Silone vie-ne in contatto con scrittori del calibro di ThomasMann, Bertolt Brecht ( 752), Robert Musil. Nel1938 pubblica il saggio sul totalitarismo La scuoladei dittatori, che provoca l’ostracismo delle auto-rità svizzere alla sua nuova attività di dirigente delCentro estero del Partito socialista.
508
IL SECONDO NOVECENTODal dopoguerra a oggi
Generi
Le opere del dopoguerra: una febbrile volontà di te-stimonianza. Il ritorno in patria e i primi anni del do-poguerra coincidono con una nuova stagione di fervi-da attività politica: nel biennio 1945-46 è direttoredell’«Avanti!» e deputato socialista alla Costituente; mail rinnovamento imposto alle strutture del Partito so-cialista (allora PSIUP) si rivela inutile, mentre semprepiù forte gli appare il contrasto tra la spinta etica chesostanzia la sua vocazione politica e le reali condizio-ni in cui, come uomo di partito, è costretto a operare.Dal 1950 alla morte – che avverrà a Ginevra nel 1978 –tutte le sue energie vengono indirizzate verso l’impe-gno sociale e civile: dal 1955 in poi dirige con NicolaChiaromonte (1905-72) il mensile «Tempo presente»,che diviene centro di coordinamento di altre riviste eu-ropee della medesima ispirazione, e stende i romanziUna manciata di more (1952), Il segreto di Luca (1956)e La volpe e le camelie (1959). Negli anni successivipubblica la raccolta di saggi Uscita di sicurezza(1965) e il romanzo L’avventura di un povero cristia-no (1968), che si possono leggere come la condannadi tutti i movimenti, politici e religiosi, nati per la libe-razione dell’uomo e trasformati dalla lotta per il pote-re in istituzioni contro l’uomo. Il secondo, in particola-re, attua una originale rilettura in chiave moderna del-la vicenda dell’eremita Pietro da Morrone, papa per so-li tre mesi con il nome di Celestino V, che, abdicandoin favore del Cardinale Caetani (il futuro BonifacioVIII), oppose alla corruzione della Chiesa quello cheDante avrebbe poi definito il gran rifiuto.
Una produzione letteraria bipartita
Le vicende storiche, così profondamente legate allabiografia dello scrittore, dividono la sua produzione indue periodi ben distinti per ispirazione e contenuti.
L’interesse per la realtà meridionale. Nei romanzidell’esilio la rappresentazione dei conflitti sociali del-la realtà meridionale assorbe tutta l’attenzione di Silo-ne, fino a lasciare in secondo piano ogni istanza di ri-cerca formale, data l’urgenza dei contenuti che la sualetteratura si ritiene destinata ad esprimere. In questafase la sua opera è davvero, profondamente, una‘narrativa meridionalista’.
Il conflitto interiore. Nella seconda fase lo scrittore siconcentra invece sul tema, scopertamente autobiogra-fico, dei conflitti interiori del rivoluzionario, per il qua-le l’adesione alla causa degli «umili» – di ispirazioneschiettamente cristiana – si scontra con le forme di con-
creta attuazione politica nelle quali l’impegno perso-nale è costretto ad esplicitarsi. La parabola siloniana,dalla militanza nella politica a quella nella cultura ‘con-tro’ la politica, si ritrova nei ritratti fervidi e appassionatidei suoi protagonisti, stretti tra l’inconciliabilità degliideali cristiani e socialisti in cui credono con gli istitutistorici in cui tali ideali si sono concretizzati. Un unicodestino lega questi uomini così diversi, tutti fatalmen-te destinati ad abbandonare la Chiesa e i Partiti ufficia-li per rimanere fedeli alla scelta dei compagni, come fanella vita il loro stesso autore.
Le scelte e lo stile di Silone. La forte emblematicitàdelle storie raccontate da Silone, che deliberatamen-te sceglie uno stile piano, semplice e non particolar-mente caratterizzato – naturale e immediato veicolodei contenuti elementari in cui si può sintetizzare ilsuo messaggio: difesa della libertà individuale e lottacontro le disuguaglianze sociali – danno ragione del-lo straordinario successo della sua opera (Fontama-ra è stato tradotto in ventisette Paesi). Una riletturadella produzione siloniana, non gravata dai pregiudi-zi ideologici che ne hanno impedito la giusta com-prensione, si rende oggi sempre più necessaria, a tar-divo risarcimento dell’ostracismo della critica neiconfronti di quello che, almeno tra le due guerre, èstato il nostro scrittore più ‘europeo’.
Il «caso Silone»: notorietà e oblio di uno scrittore
Con Ignazio Silone ci troviamo infatti di fronte a unodegli scrittori italiani più conosciuti e tradotti nelmondo, ma anche a quello per cui la critica, dopo l’e-splosione del cosiddetto «caso Silone», ha nutrito uninteresse sempre meno crescente, fino a una vera epropria archiviazione.La sua fama letteraria è stata cioè progressivamente of-fuscata dalle polemiche derivate dalle sue scelte poli-tiche (partecipazione e poi espulsione dal PCI); egli,dal canto suo, ha spesso definito la letteratura uno stru-mento di denuncia sociale e di impegno morale, unasorta di prolungamento o ‘braccio secolare’ dell’attivitàpolitica. Come ha ben sintetizzato Luce D’Eramo –scrittrice essa stessa e acuta interprete di Silone –, tuttala sua opera riflette l’intreccio costante tra impegno po-litico e «un concetto funzionale della cultura intesa co-me presa di coscienza critica della società». Le circo-stanze tormentate della sua biografia danno la misuradella difficoltà, ma anche della coerenza e solidità diquesta sintesi.
La narrativa meridionalistica • Ignazio Silone
Fontamara
Tra ricordo e denuncia sociale. Le vicende che ve-dono protagonisti gli abitanti di Fontamara – piccolopaese abruzzese, nella conca del Fucino – nel decen-nio 1920-30 sono al centro del primo e più famosoromanzo di Silone. I ricordi autobiografici della gio-vinezza trascorsa nella Marsica si fondono con la do-cumentazione lucida e oggettiva dei soprusi che con-tadini e braccianti (i cafoni) subiscono, oppressi da-gli ex notabili e dalle autorità religiose solidali ormaicon i nuovi padroni imposti dal fascismo (i galan-tuomini).
Tre voci per una storia. L’esposizione della storia èaffidata a una triplice voce narrante, che si alterna:padre, madre e figlio di una famiglia di cafoni, chel’autore immagina esiliata in Svizzera. Non si tratta diun semplice espediente narrativo, ma – a detta di Si-lone stesso – di una vera e propria garanzia di auten-ticità per il lettore, una certificazione di impersonalitàe di oggettività del racconto.
Un’azione corale. Come la narrazione, così anche l’a-zione si svolge coralmente, seguendo un iter di an-gherie e sopraffazioni che prende il via dalla devia-zione – a favore delle proprietà dell’Impresario (ungalantuomo) – del ruscello che rifornisce d’acqua ilpaese e ne consente l’attività agricola. La protestadelle donne fontamaresi ottiene la suddivisione del-l’acqua tra i paesani e l’Impresario amministratorenella misura di tre quarti e tre quarti, ennesima egrottesca beffa all’ignoranza popolare. Intanto, allerimostranze dei fontamaresi contro le nuove imposi-zioni (divieto di emigrare e di parlare di politica inpubblico) le autorità rispondono con una violentissi-ma rappresaglia contro le donne di Fontamara. Il so-litario tentativo di ribellione da parte di Berardo Vio-la – un bracciante libertario e anarchico – viene pre-sto soffocato e Berardo, impossibilitato a fuggire al-l’estero, trova uno sbocco nella lotta clandestina; mo-rirà poi in carcere, per le torture. Venuti a conoscen-za del ‘martirio’ di Berardo, sul suo esempio anche ifontamaresi trovano la forza di ribellarsi: ma il lorogiornale clandestino – dall’emblematico titolo «Chefare?» (che riprende quello di un celebre scritto di Le-nin, del 1903) – è soppresso dalle autorità, mentreun’ulteriore spedizione punitiva fascista colpisce ilpaese con ferocia, disperdendone gli abitanti; traquesti vi sono appunto le tre voci narranti, cui nonresta che il volontario esilio dal quale testimoniare –a futura memoria – la loro storia.
Una lingua «presa in prestito». La volontà di dare carat-tere simbolico e non solo documentaristico alle vi-cende raccontate nel libro si esplicita nel trattamentodei personaggi e della lingua oltre che nella triplicesuddivisione del punto di vista. Da un lato stanno icafoni, tratteggiati come coralità indifferenziata tra cuispicca solo il leader Berardo; dall’altro i possidenti ele autorità locali (i galantuomini), rappresentanti diun potere esercitato in modo dispotico e tirannicodall’autorità politica e da quella ecclesiastica. Nell’in-troduzione al romanzo è l’autore stesso a chiarire lescelte stilistiche operate: il dialetto, se da un latoavrebbe potuto corrispondere a una precisa volontàtestimoniale, dall’altra avrebbe però costituito un og-gettivo impedimento alla diffusione del messaggio didenuncia di cui il libro è portatore. Le ragioni dellaforma vengono quindi subordinate a quelle del con-tenuto. Scrive infatti Silone: A nessuno venga in men-te che i Fontamaresi parlino l’italiano. La lingua ita-liana è per noi una lingua imparata a scuola, comepossono essere il latino, il francese, l’esperanto […].Ma poiché non ho altro mezzo per farmi intendere(ed esprimermi per me adesso è un bisogno assoluto),così voglio sforzarmi di tradurre alla meglio, nellalingua imparata, quello che voglio che tutti sappiano:la verità sui fatti di Fontamara. Tuttavia, se la linguaè presa in prestito, la maniera di raccontare, a mesembra, è nostra. È quella stessa appresa da ragazzo,seduto sulla soglia di casa, o vicino al camino, nellelunghe notti di veglia, o accanto al telaio, seguendo ilritmo del pedale, ascoltando le antiche storie.
Pablo Picasso, Tre donne alla fontana, 1921, olio su tela,New York, The Museum of Modern Art.
509
510
IL SECONDO NOVECENTODal dopoguerra a oggi
Generi
«Di quella terribile sera non ricordo altro»da Fontamara, V
Il brano che abbiamo scelto è tratto dal capitolo V del romanzo. La re-pressione della rivolta dei fontamaresi si è trasformata in una vera epropria spedizione punitiva delle camicie nere che, approfittando dell’as-senza dei contadini, si rivalgono brutalmente sulle donne del paese. Laprima parte del capitolo affida al personaggio femminile la narrazione; ildiretto coinvolgimento della donna nella tragica vicenda impedisce ognipresa di distanza dalla materia e l’evento si carica di una valore assoluto,diventa elemento totalizzante della realtà: delle volte anche mi capita chedi tutta la vita non so e non ricordo altro, all’infuori di quello che in quel-la sera accadde sotto i miei occhi e che adesso ho raccontato.
Attorno al pezzo di tratturo che l’Impresario si era gratuitamente appro-priato1, il comune aveva fatto costruire una staccionata di legno.La staccionata avrebbe dovuto mettere fine alle chiacchiere dei cafoniche non la smettevano di dubitare che qualcuno potesse impossessarsidi quel terreno che da millenni apparteneva a tutti; ma le discussioninon cessarono. Una notte la staccionata andò in fiamme.«Il legno era troppo secco» spiegò Berardo2. «L’ha bruciato il sole».«Di’ piuttosto il chiaro di luna» io corressi. «È bruciato di notte».L’Impresario fece costruire la seconda staccionata a spese del comune evi pose a guardia uno spazzino comunale armato. Uno spazzino potevafar paura al tratturo che dal giorno della creazione ne ha viste di tutti icolori, guerre, invasioni, zuffe di pecorai, di lupi, di briganti?Alla presenza dello spazzino la staccionata andò nuovamente in fiamme.Egli vide distintamente vampate di fuoco uscire dalla terra e incenerire inpochi minuti tutta la staccionata. Com’è obbligo per ogni miracolo, lospazzino raccontò subito il fatto al canonico don Abbacchio e poi a tuttiquelli che volevano ascoltarlo, e don Abbacchio stabilì che l’incendio del-la staccionata era senza dubbio opera soprannaturale, però d’iniziativa dia-bolica. E noi trovammo che dopo tutto, il diavolo non è così brutto comelo si dipinge. L’Impresario però che doveva salvare il prestigio dell’auto-rità, non potendo fare arrestare il diavolo, fece mettere dentro lo spazzino.Chi la vincerà, noi ci domandavamo, il diavolo o l’Impresario? (Tutti noieravamo contro l’Impresario, ma di aperto partigiano del diavolo nonc’era che Berardo.)Di questo discorrevano una sera, sull’imbrunire, alcune donne di Fonta-mara, mentre aspettavamo sulla piazzetta davanti alla chiesa che gli uo-mini tornassero da Fucino. Erano con me Maria Grazia, la Ciammaruga,Filomena Castagna, la Recchiuta e la figlia di Cannarozzo, ed eravamosedute, come al solito, sul muricciolo che fa da spalliera alla piazzetta,verso valle. Noi guardavamo verso il piano, che era già sommerso nel-l’ombra. La valle sottostante a Fontamara, divisa in due dalla striscia dipolvere della strada nazionale, appariva deserta e silenziosa. La via chedal piano saliva su a Fontamara facendo larghi giri sul dorso della colli-na, era anch’essa deserta e silenziosa. I nostri uomini sarebbero tornaticon ritardo, perché all’epoca della mietitura, non esiste orario. Ricordoanche che in un angolo della piazzetta c’era Maria Cristina, vestita a ne-ro per la morte recente del marito, che ventilava il poco grano raccolto
1. che … appropriato: «di cui l’Impresariosi era gratuitamente appropriato»; sintassidel parlato.2. Berardo: Berardo Viola, il capo della ri-
volta dei fontamaresi e personaggio princi-pale del romanzo. La sua volontà di lottaviene dall’aver perduto la terra paterna acausa di una speculazione, e dal non poterchiedere la mano della donna che ama, Elvi-ra, senza poterle garantire un futuro; di quila sua disperata volontà di affermazione e(alla perdita di Elvira) l’impegno rivoluzio-nario con le sue tragiche conseguenze.
La narrativa meridionalistica • Ignazio Silone
511
nel suo campo, facendo cadere il grano dalla còscina3 tenuta in alto, abraccia tese, a ritroso del vento.Nessuno poteva figurarsi quello che stava per accadere e ci dicevamo lecose che si dicono ogni giorno.«Che daremo agli uomini il prossimo inverno» dicevo io «se la mancanzad’acqua ci priverà dei fagioli?».«E cosa semineremo in autunno» diceva Filomena «se in mancanza digranoturco dovremo mangiarci tutto il grano?».«Passeranno questi guai, se Dio vuole, come ne sono passati tanti altri»diceva la Recchiuta fiduciosa. «Quante volte si è detto, così non si puòandare avanti? E si è andati avanti».In un angolo della piazzetta alcuni ragazzi e bambine giocavano allosceriffo: lo sceriffo non può andare a piedi, deve andare a cavallo, e aturno ogni bambina faceva da cavallo. Poi prese il crepuscolo e appar-vero le prime lucciole. Una bambina (credo che fosse una figlia di MariaCristina) venne a chiedermi se fosse vero che le lucciole vanno in cercadi chicchi di grano per il pane delle anime affamate del purgatorio; e te-neva sul palmo della mano aperta alcuni chicchi di grano.Intanto, senza che ce ne accorgessimo subito, nel silenzio cominciò ainsinuarsi un rumore monotono e regolare, dapprima simile a quellodegli alveari, poi a quello delle trebbiatrici. Il rumore saliva dalla valle,ma la causa non era palese. Trebbiatrici non se ne vedevano. Le aie ap-parivano tutte vuote. D’altronde le trebbiatrici non risalivano la valleche verso la fine della mietitura. D’un tratto il rumore si fece più distin-to e nella prima curva della strada che dal piano saliva verso di noi, ap-parve un camion pieno di gente. Subito dopo ne apparve un altro. E poiun altro. Cinque camion che venivano a Fontamara. Ma subito dopo neapparve un altro. Erano dieci? quindici? dodici? La figlia di Cannarozzogridava che erano un centinaio, ma era una ragazza che non sapevacontare. Il primo camion era già all’ultima curva, all’entrata di Fontama-ra, e l’ultimo ancora ai piedi della collina. Tanti camion non si erano maivisti. Nessuno di noi aveva immaginato che esistessero tanti camion.Allarmata dal fragore mai udito di un così grande numero di macchine,tutta la popolazione di Fontamara era accorsa sulla piazzetta davanti al-la chiesa, cioè le donne, i bambini e gli uomini vecchi che non erano an-dati ai campi. Ognuno spiegava in modo diverso l’inattesa e improvvisaapparizione di tante macchine dirette verso Fontamara.«È un pellegrinaggio» gridava Marietta tutta eccitata. «Adesso i pellegriniricchi non vanno a piedi ma in automobile. Sarà un pellegrinaggio per ilnostro San Rocco».«Ma oggi non è il giorno di San Rocco» io dissi.«Sarà una corsa di automobili» ripeteva invece Cipolla che da soldato erastato in città. «È una sfida tra automobilisti a chi corre di più. In città ognigiorno vi sono sfide tra automobilisti».Il rumore dei camion divenne sempre più alto e impressionante. A essosi aggiunsero le grida selvagge degli uomini sui camion. Un crepitio dispari secchi, seguito dalla caduta dei vetri del finestrone della chiesa,finì col mutare in panico la nostra curiosità.«Sparano, sparano contro di noi, sparano contro la chiesa» ci mettemmoa gridare.«Indietro, indietro» gridava Baldissera a noi donne più vicine al parapet-to. «Indietro che sparano».
3. còscina: cesto di forma conica, costi-tuito da un cerchio di legno su un fondo diassi, che veniva usato negli Abruzzi per fa-re la ricotta.
512
IL SECONDO NOVECENTODal dopoguerra a oggi
Generi
«Ma chi sono quelli che sparano? ma perché sparano? ma perché spara-no contro di noi?».«È la guerra, è la guerra» diceva Baldissera tutto esaltato. «È la guerra».«Ma perché la guerra? ma perché contro di noi la guerra?».«È la guerra» ripeteva Baldissera. «Solo Dio sa perché, ma è la guerra».«Se è la guerra bisogna dire le litanie sulla guerra» saltò a dire Teofilo ilsacrestano e si mise a intonare: “Regina pacis ora pro nobis”, quandouna seconda scarica di fucileria crivellò la facciata della chiesa e cospar-se di calcinacci noi ch’eravamo vicino al portale.Le litanie furono interrotte. Tutto quello che succedeva era privo di sen-so. La guerra? ma perché la guerra? Giuditta fu presa dalle convulsioni.Attorno a essa noi eravamo come un branco di capre impazzite.Ognuno gridava parole sconnesse. Solo Baldissera ripeteva grave eimpassibile:«Non c’è nulla da fare, è la guerra, non c’è nulla da dire, è il destino: ogniguerra quando arriva, arriva così».Maria Rosa, la madre di Berardo, ebbe una parola giusta e propose:«Suoniamo le campane. Quando il paese è in pericolo bisogna suonarele campane. Si è fatto sempre così».Ma Teofilo non si reggeva in piedi per l’avvilimento. Diede le chiavi ame. Elvira, accorsa anche lei in quel momento in piazza, mi accompa-gnò sul campanile per suonare a martello. Ma vicino alle campane, Elvi-ra ebbe un’esitazione. Domandò:«Ci sono mai state guerre contro le donne?». «Non ne ho mai sentito par-lare» risposi io.«Ecco» disse «quelli che arrivano non vengono contro di noi ma controgli uomini. È meglio non dare nessun allarme. Se noi suoniamo a mar-tello, gli uomini da lontano crederanno che si tratti d’incendio e torne-ranno in fretta, e si scontreranno con questi».Elvira pensava certamente a Berardo. Io pensai a mio marito e a mio fi-glio. Rimanemmo perciò sul campanile, senza toccare le funi.Dall’alto del campanile vedemmo i camion arrestarsi all’entrata di Fon-tamara e dai camion scendere un gran numero di uomini armati di fuci-le. Un gruppo rimase presso i camion. Gli altri si avviarono nella dire-zione della chiesa.Ai nostri piedi le donne, i bambini e i vecchi di Fontamara avevano fini-to la recita delle litanie e cominciata quella degli scongiuri. Teofilo il sa-crestano con voce tremante diceva l’invocazione e gli altri in coro ri-spondevano: “Libera nos, domine”. Anche Elvira ed io inginocchiate sulcampanile, rispondevamo sottovoce: “Libera nos, domine”. Nessuno sa-peva che cosa stesse per succedere. Teofilo faceva l’elenco di tutti gliscongiuri possibili, e ognuna di noi aggiungeva: “Libera nos, domine.“Ab omni malo, libera nos, Domine,“Ab omni peccato, libera nos, Domine,“Ab ira tua, libera nos, Domine,“A subitanea et improvisa morte, libera nos, Domine,“A spiritu fornicationis, libera nos, Domine”.
Nessuno poteva immaginare che sciagura stesse per succedere. Teofiloera arrivato allo scongiuro contro il colera, la fame e la guerra, quandola colonna degli uomini armati sbucò sulla piazzetta, urlando e agitandole armi in aria. Il loro numero ci sbigottì. Istintivamente Elvira ed io ci ri-
La narrativa meridionalistica • Ignazio Silone
513
traemmo indietro, in un angolo del campanile in modo da continuare avedere senza essere viste.Gli uomini armati potevano essere circa duecento. In più del moschettoognuno traeva un coltellaccio alla cintola. Tutti erano mascherati da morti.Personalmente non riuscimmo a riconoscere che la guardia campestre e ilcantoniere Filippo il Bello; ma anche gli altri non avevano facce nuove enon venivano da lontano. In parte avevano anch’essi l’aspetto dei cafoni,ma di quelli senza terra, che vanno a servizio dei padroni, guadagnano po-co e vivono per lo più di furto e di galera. In parte, come poi si riseppe conpiù precisione, erano tra essi anche sensali, di quelli che si vedono suimercati, e anche lavapiatti delle taverne, e anche barbieri, cocchieri di ca-se private, suonatori ambulanti. Gente fiacca e, di giorno, vile. Gente ser-vizievole verso i proprietari, ma a patto di avere l’immunità nelle cattiveriecontro i poveri. Gente senza scrupoli. Gente che una volta veniva da noi aportarci gli ordini di don Circostanza per le elezioni e ora veniva con i fu-cili per farci la guerra. Gente senza famiglia, senza onore, senza fede, gen-te infida, poveri ma nemici dei poveri.Alla loro testa marciava un piccolo uomo ventruto4, con una fascia tri-colore sul ventre e al fianco di lui si pavoneggiava Filippo il Bello.«Cosa racconti?» domandò l’ometto con la fascia tricolore a Teofilo il sa-crestano.«Invoco la pace» rispose impaurito l’uomo di chiesa.«Adesso te la do io la pace» aggiunse ridendo il panciuto e fece segno aFilippo il Bello.Il cantoniere si avvicinò a Teofilo e dopo una certa esitazione gli diedeuno schiaffo.Teofilo si mise una mano sulla guancia colpita, si guardò attorno e do-mandò timidamente:«Ma perché?».«Vile, vile» cominciò a inveire l’ometto dal ventre tricolore. «Perché nonreagisci? Sei un vile».Ma Teofilo rimase immobile, silenzioso e più che altro sorpreso5. Nellafolla di donne, di bambini, di vecchi e d’invalidi lì presente, il panciutonon trovò il tipo che potesse essere provocato con miglior risultato. Siconsultò un po’ con Filippo e disse con disprezzo:«Mi sembra che non ci sia proprio nulla da fare».Poi rivolto alla folla, comandò con voce stridula: « Andate a casa tutti».Quando sulla piazzetta non rimase più nessun Fontamarese, l’ometto sirivolse agli uomini neri e ordinò:«Cinque per cinque, andate in ogni casa, frugate dappertutto e seque-strate ogni sorta di armi. Presto, prima che tornino gli uomini».In un attimo la piazzetta si vuotò. Si era fatto buio. Ma dal nostro rifugio,potemmo vedere le pattuglie di cinque suddividersi nei vicoletti, sparirenelle case oscure.«Senza luce sarà difficile perquisire tutte le case» io dissi.«Mio padre è a letto e si spaventerà. È meglio che io vada a casa ad ac-cendere il lume» disse Elvira preparandosi a scendere dal campanile.«No, resta qui» io le dissi. «A tuo padre non possono fare nulla di male».«Ma che armi cercano?» domandò Elvira. «Noi non abbiamo fucili. È unafortuna che Berardo sia in campagna».«Porteranno via le roncole e le falci» dissi così per supposizione. «Altrearmi non abbiamo».
4. ventruto: dal ventre molto prominente,panciuto.5. Il cantoniere … sorpreso: l’episodio al-
lude al precetto evangelico del «porgerel’altra guancia» e racchiude la concezionereligiosa di Silone che considera l’umileaccettazione del dolore come elemento in-dissociabile della condizione umana, tantoda ritenere degno solo colui che lo accettaumilmente, per trasformarlo in verità e co-raggio morale.
514
IL SECONDO NOVECENTODal dopoguerra a oggi
Generi
Ma le improvvise grida di Maria Grazia, che aveva la casa proprio a fian-co del campanile, e subito dopo le grida disperate di Filomena Castagnae di Carracina, e le altre grida provenienti da case più lontane, accom-pagnate da rumori e tonfi di mobili rovesciati, di sedie rotte, di vetri rot-ti, ci rivelarono in un attimo quali armi cercasse quella gentaccia.Maria Grazia, sotto di noi, urlava come un animale che sta per esseresgozzato. Attraverso la porta spalancata vedemmo confusamente la zuf-fa canesca di cinque uomini contro la povera donna: varie volte essa riu-scì a divincolarsi e una volta arrivò fino alla porta, ma fu ritratta a tem-po, e afferrata per le gambe e le spalle, fu gettata per terra e, immobiliz-zata, spogliata di tutto quello che aveva indosso e tenuta da quattro uo-mini con le braccia aperte e le gambe divaricate, in modo che il quintopoté insozzarla. Maria Grazia rantolava come un animale scannato.Quando il primo ebbe usato di lei, il suo posto fu preso da un altro e ri-cominciò il martirio. Finché essa cessò ogni resistenza; il rantolo delladonna era diventato già così flebile che a noi non giungeva più.Elvira, accanto a me, aveva assistito a tutta la scena. Come impedirlo?Tutto si era svolto sotto i nostri occhi, a una quindicina di metri da noi.Serrata contro di me, con le braccia attorno al mio collo, io sentivo la ter-rorizzata creatura tremare tutta come presa dalle convulsioni. Fu comese tutto il campanile tremasse, tutta la terra tremasse sotto di noi. Io face-vo forza perché Elvira non cadesse, col pericolo di sprofondare per lascaletta di legno e di richiamare l’attenzione degli uomini armati sul no-stro nascondiglio. Con gli occhi enormi, sbarrati, immobili, Elvira guar-dava sempre la stanza dalla quale erano usciti i cinque uomini e doveera disteso il corpo lacerato di Maria Grazia. Ebbi allora paura che Elvirauscisse di ragione. Le chiusi gli occhi con le mie mani come si fa con imorti. Poi d’un tratto, la resistenza venne meno anche a me, le gambe mivennero meno e ci accasciammo nel buio l’una accanto all’altra.Di quella terribile sera non ricordo altro, all’infuori di quello che adessoho cercato di raccontare. Delle volte anche mi capita che di tutta la vitanon so e non ricordo altro, all’infuori di quello che in quella sera accad-de sotto i miei occhi e che adesso ho raccontato. Il resto, se vuole, puòraccontarvelo mio marito. […]
Analisi del testo
UNA LINGUA‘TRADOTTA’DAL DIALETTO
Sin dall’attacco del brano, l’uso del che alogico (chel’Impresario si era gratuitamente appropriato) rivela iclassici moduli sintattici del parlato. L’espediente vie-ne frequentemente usato da Silone che, erede in que-sto della grande tradizione verghiana,preferisce lavo-rare sulla sintassi più che sul lessico che si mantieneneutro, senza mai scendere al livello dell’espressione
dialettale o italiano-dialettale. Nell’esempio proposto,il punto di vista è ‘orientato’ anche ideologicamente(gratuitamente), rivelando una totale sovrapposizionedell’autore al narratore.Uno stilema è costituito dalla ripetizione (Subito dopone apparve un altro.E poi un altro […]. Ma subito dopone apparve un altro), spesso complicata dalla variatio(Tanti camion non si erano mai visti.Nessuno di noi ave-va immaginato che esistessero tanti camion),o – per una
La narrativa meridionalistica • Ignazio Silone
515
maggiore resa drammatica – da un incremento pro-gressivo dei membri (Ma chi sono quelli che sparano?ma perché sparano? ma perché sparano contro di noi?).Ma è la sintassi nominale che,per dichiarazione stessadell’autore,racchiude la maniera del narrare siloniano.Si veda ad esempio la serie anaforica Gente fiacca […]Gente servizievole […] Gente senza scrupoli […] Gen-te che una volta […] Gente senza famiglia […], il cui ul-timo membro presenta una struttura ternaria:senza fa-miglia,senza onore,senza fede,che racchiude i cardinidell’etica e dell’ideologia del fontamarese.Un’altra costante stilistica della pagina siloniana è lagiustapposizione di aggettivi in serie binaria (La vallesottostante a Fontamara […] appariva deserta e silen-ziosa) o, più raramente, ternaria (senza famiglia, senzaonore, senza fede; immobile, silenzioso e più che altrosorpreso),complicata a volte dall’epifora (era anch’es-sa deserta e silenziosa),con un risultato complessivo diavvicinamento alla monotona e quasi cantilenante ca-denza del parlato popolare ‘tradotto’dall’autore.Ma non è solo linguisticamente e stilisticamente chel’autore si modella sull’anonimo narratore del raccon-to. Nell’espressione cominciò a insinuarsi un rumoremonotono e regolare,dapprima simile a quello degli al-veari,poi a quello delle trebbiatrici, Silone traduce congrande efficacia la forma mentis dei fontamaresi, cheadeguano ogni evento reale all’esperienza personale,proveniente dal mondo naturale e contadino. L’anima-lità è, per Silone, una condizione che accomuna chicompie la bestiale violenza a chi la subisce inerme.
NOMI E SOPRANNOMI
Secondo un procedimento già manzoniano (si pensiad Azzeccagarbugli), molti personaggi del romanzo ein specie i rappresentanti dell’autorità religiosa e poli-tica vengono designati dal narratore ‘corale’ con un
esplicito soprannome,valido a caricaturizzarli iperbo-licamente. Di matrice tutta verghiana (nelle cui operecompaiono ad esempio Comare Piedipapera, la Longae Compare Cinghialenta) è invece l’assegnazione diepiteti ad alcuni dei rappresentanti del popolo fonta-marese (la Recchiuta, l’Amico del Popolo).
STRATEGIE NARRATIVE
La narrazione si avvale di alcuni procedimenti checoncorrono ad aumentare la tensione drammatica.Uno di questi consiste nel ribaltamento del ruolodei personaggi. Nell’episodio del campanile, adesempio, le due donne, la narratrice ed Elvira, chedevono dare l’allarme agli uomini nei campi, deci-dono di non agire proprio per evitare l’unico tipo dicarneficina che riescono a immaginare (lo scontrodei loro uomini con i fascisti armati), trasformando-si da deus ex machina della vicenda in testimoni-vit-time inermi della rappresaglia, il terribile stupro cuiassistono senza poter intervenire o chiedere aiutoall’esterno. Nel medesimo passaggio, la recita dellelitanie crea una climax ascendente che fa da sfondoal dramma. Si noti infine che il gesto della narratricead Elvira (Le chiusi gli occhi con le mie mani come sifa con i morti) diventa prolettico del destino della ra-gazza. Elvira, infatti, dopo lo shock subito, offre lasua vita alla Madonna in cambio di quella del fidan-zato Berardo, e ne ottiene la salvezza. Ma questi, ap-presa a Roma la notizia della morte di lei, si autoac-cusa davanti alla polizia di essere il Solito Scono-sciuto (un militante antifascista ricercato per pos-sesso e diffusione di stampa clandestina), viene in-carcerato e muore per le torture subite. Il commis-sario riuscirà però a convincere il suo compagno dicella – io narrante – che Berardo si è ucciso impic-candosi a un’inferriata.
Proposte operative
Analisi
Quale effetto produce la scelta di un narratore interno alla vicenda?Delinea il ritmo narrativo del racconto.Commenta le scelte stilistiche dello scrittore: a quale risultato sono funzionali?3
2
1
516
IL SECONDO NOVECENTODal dopoguerra a oggi
Generi
Vitaliano Brancati
La vita e le opere
La Sicilia e gli anni perduti. Brancati nasce nel 1907 aPachino – piccolo centro della provincia siracusanasituato sulla punta estrema della Sicilia orientale (do-ve vive fino al 1920, anno in cui la famiglia si trasferi-sce a Catania) – e partecipa dello spirito e dell’ideo-logia di una generazione molto sensibile ai fermentidi rinnovamento del neonato movimento fascista, di-visa tra le suggestioni vitalistiche della nuova culturae la tranquilla realtà di una cittadina di provincia. Leabitudini, le aspirazioni, la sensualità e la noia deigiovani catanesi diventeranno presto i temi portantidelle sue più brillanti invenzioni narrative.Al 1924 risale la sua iscrizione al Partito NazionaleFascista e l’inizio – con quelli che nel primo roman-zo Brancati stesso definirà gli anni perduti – di un’in-tensa attività letteraria tutta protesa inizialmente ver-so il teatro (Fedor, Everest, Piave, L’urto), sensibile al-le suggestioni oratorie del modello culturale dan-nunziano imposto dal fascismo. La collaborazione adiversi giornali e riviste lo mette in contatto con l’am-biente culturale della capitale, dove si trasferisce perlavorare come redattore capo della rivista «Quadri-vio». Qui pubblica la Singolare avventura di viaggio(1934), un romanzo breve subito accusato di immo-ralismo e posto sotto sequestro.
La «conversione» al comico. È lo stesso Brancati afar risalire al 1934 – anno in cui rifiuta la monda-nità romana e fa ritorno a Catania, e a una menoambiziosa attività di insegnante magistrale – la cri-si politica che gli fa maturare il passaggio dalla ma-gniloquenza retorica di una improbabile carriera‘di regime’ alla maturità stilistica di una nuova sta-gione letteraria. Si tratta di una vera e propria ‘con-versione’, testimoniata da un’intensa produzioneletteraria che racchiude gli spunti autobiograficidella cosiddetta «narrativa della memoria» e quellaambivalente vis comica che sarà la cifra stilistica deisuoi romanzi più famosi. Nel decennio successivovedono infatti la luce Gli anni perduti (1941), il So-gno di un valzer (su «Quadrivio» e postumo in vo-lume nel 1982 insieme ad altri racconti), Don Gio-vanni in Sicilia e i racconti poi riuniti nel 1946 nelvolume Il vecchio con gli stivali.Dal 1941 alterna i soggiorni a Roma, impegnatonell’attività editoriale con Longanesi e Bompiani, a
quelli siciliani (sempre a Catania e negli ultimi annia Zafferana Etnea).La nuova dimensione narrativa non sminuisce l’anticointeresse per il teatro: numerose sono le pièce messe inscena in questi anni, nonostante i continui ostacoli del-la censura fascista. Nel 1942 a Roma, durante le provedi uno spettacolo, conosce la giovane attrice Anna Pro-clemer, che sposerà quattro anni dopo.
Il dopoguerra: l’impegno letterario e saggistico(1945-54). Il rinnovato clima del dopoguerra permet-te la pubblicazione di opere in cui la posizione anti-fascista maturata nel decennio precedente si ap-profondisce in una critica serrata al regime e alla cul-tura che se n’era fatta sostenitrice. L’analisi ideologicae sociale della realtà della sua generazione e l’inevi-tabile autocritica che ne deriva sono svolte da Bran-cati nelle forme dell’invenzione narrativa, ma anchein quelle più razionali della produzione saggistica.Nel 1946 vengono raccolte, nel volume I fascisti in-vecchiano, le Cronachette del 1945 e nel 1952 esceil pamphlet Ritorno alla censura, che accompagnala discussa commedia La governante, fortementeosteggiata per il tema omosessuale affrontato.Il terzo momento della stagione brancatiana, dopoil giovanile filofascismo e la conversione comico-realistica, sviluppa temi già anticipati dal Don Gio-vanni in Sicilia negli altrettanto famosi Il bell’Anto-nio (1949, che vincerà l’anno successivo il premioBagutta battendo La bella estate di Cesare Pavese) ePaolo il caldo (pubblicato postumo). La grottescasatira del dongiovannismo provinciale, tutta prece-dentemente giocata su toni ironico-grotteschi, cam-bia però di registro, presentando, dietro un caso ri-spettivamente di impotenza e di esasperazione ses-suale, le tinte cupe di una condizione umana de-viata e irriducibile alla normalità sociale.Brancati sviluppa anche un’intensa attività di sce-neggiatore. Nel 1947, dal Vecchio con gli stivali,trarrà il soggetto per il film Anni difficili, diretto daLuigi Zampa, mentre gli ultimi suoi due romanziraggiungeranno il grande pubblico anche attraversotrasposizioni cinematografiche di successo.Lo scrittore muore a Torino nel 1954.
La «sicilianità» di Brancati. Per Vitaliano Brancati la«sicilianità» è stata dunque un segno di riconosci-mento, un vero e proprio ‘filo rosso’ che ha infor-mato tutta la sua scrittura, tanto da provocare inter-pretazioni riduttive da parte della critica. La suaproduzione narrativa – rigorosamente legata a temie personaggi della Sicilia – è stata infatti letta nel
La narrativa meridionalistica • Vitaliano Brancati
517
quadro di un bozzettismo naturalistico, o al più so-ciologico. Inoltre, l’assoluta estraneità dell’autore aoperazioni sperimentali o d’avanguardia lo haspesso relegato in una dimensione regionalistica dacui attende ancora di essere recuperato.
Dongiovannismo e «gallismo»nell’opera di Brancati
Seguendo la lucida lettura che ne ha proposto unaltro siciliano, Leonardo Sciascia ( 543), si puòdire che il dongiovannismo ‘siculo’ rappresentatoda Brancati «consiste nel pensare e sognare ladonna con tale assiduità e intensità, e talmente as-sottigliandone e sofisticandone il desiderio, danon reggere poi alla presenza di lei, da esserneumiliati e come devastati».
Don Giovanni in Sicilia. Il protagonista di Don Gio-vanni in Sicilia, Giovanni Percolla, commerciantescapolo amorosamente accudito dalle tre sorelle,incarna perfettamente questa tipologia maschile.Ossessionato dall’idea della conquista erotica tra-scorre le sue giornate con gli amici, condividendo-ne i racconti goliardici e le velleità seduttive, tantoassorbito da questa attività immaginaria da trovarsiincapace di reagire quando viene prescelto dallapiù desiderata ragazza di Catania, Ninetta. Il matri-monio e il trasferimento a Milano suggellano la suavolontà di cambiamento. Dimessa l’antica accidia el’indolenza della vita siciliana e assunti i nuovi pan-ni del marito efficiente e dinamico, Giovanni sem-bra finalmente rinnovato. Di fronte alle prime occa-sioni di tradimento amoroso, però, si svela l’artifi-cialità dell’operazione e Giovanni si trova di nuovopreda della noia, incapace di reagire e tormentatoanche da un progressivo affievolirsi del desiderioamoroso, in cui prima si concentrava la sua unicacarica vitale. Il ritorno in Sicilia, progettato dalla mo-glie per mostrare pubblicamente la sua metamorfo-si, lo irretisce nella molle e protettiva atmosfera del-la casa natale dove ritrova le antiche ossessioni; e ilsonno postprandiale cui si abbandona – in uno sta-to di torpore simile alla morte – apre fondati dubbisul suo effettivo ritorno a Milano.A differenza dell’illustre precedente dapontiano-mozartiano – per il quale l’ossessione seduttiva sinutre di un esasperato vitalismo, che nel catalogodelle conquiste amorose esorcizza l’ossessiva pauradella morte – il Don Giovanni di Brancati si rivelavittima non involontaria dell’irriducibilità tra reale e
immaginario e consuma la propria assenza di vo-lontà in una totale accettazione della vita che – perusare ancora le parole di Sciascia – travalica in «con-templazione della morte».
Il bell’Antonio. Il protagonista del Bell’Antonio, ribal-ta completamente la tipologia, celando dietro un’af-fascinante e invidiata avvenenza fisica un’inconfes-sata impotenza sessuale, che si svela solo dopo lenozze. La dimensione collettiva che pian piano vie-ne ad assumere questo evento privato, reso pubbli-co dalle circostanze e dalle convenienze sociali(l’annullamento del matrimonio procurerebbe allamoglie un’unione economicamente più vantaggio-sa), permette al narratore di rappresentare la vario-pinta realtà provinciale siciliana in mirabili e gusto-sissime pagine, affinando quelle doti ironico-de-scrittive che il primo romanzo aveva già rivelato.
Paolo il caldo. Il tema del gallismo (termine coniatoda Brancati e poi invalso nell’uso comune a rappre-sentare un certo modo di rapportarsi all’erotismo ealla donna, tipico del maschio italiano e, in partico-lare, siciliano) si approfondisce nelle sue compo-nenti patologiche nell’ultimo romanzo, Paolo il cal-do, iniziato nel 1952 e pubblicato postumo sebbeneincompiuto. Il primo capitolo contiene una dichia-razione poetica che illumina retrospettivamente an-che i romanzi precedenti: Lo sforzo costante dellamia vita è stato di vedere la luce del mondo (che perme è quella della Sicilia) dalla parte ridente, edespellere dal cervello le influenze della sua ripresabuia, dalla quale derivano l’apprensione e la lussu-ria. Paolo Castorini incarna questo luogo oscurodella mente e sviluppa, in un crescendo di immora-lità ed abiezione in cui l’ironia cede il posto al cupoe tetro cinismo, i tratti deformati di un insanabilecontrasto tra sensualità e ragione, prima precaria-mente bilanciato dalla potente vis comica.
Linguaggio e stile del «realismo comico»
Una costante tensione al realismo. È stato osservatocome l’elemento portante della narrativa brancatia-na si possa sintetizzare in una costante tensione alrealismo (che ricerca costantemente lo ‘spessore’della realtà nella sua dimensione memoriale, per cuilo stesso piacere della scrittura diventa piacere dellamemoria) nutrita da una brillante vena ironica. Il co-mico però non nasce dallo stravolgimento del rea-
518
IL SECONDO NOVECENTODal dopoguerra a oggi
Generi
le tradotto in immaginazione fantastica, ma da unaminuta osservazione dei personaggi e degli am-bienti in cui essi agiscono. È infatti la lucida e ra-zionale analisi della realtà a svelarne le imperfezio-ni e le deformazioni, e a spingere inevitabilmenteverso la rivelazione della sua natura comica.
Lo stile e le tecniche narrative. A uno stile piano escorrevole, immune da sperimentalismi narrativi olinguistici, Brancati aggiunge la consumata periziadi costruttore di dialoghi, prima teatrali e poi cine-matografici. E dal cinema derivano anche alcuneefficaci tecniche narrative, come i rapidi passaggidall’inquadratura soggettiva al campo lungo, chemovimentano la superficie non particolarmenterilevata della patina linguistica.
La noia nel ’937
Si tratta di uno dei racconti più famosi di Brancati,che ben compendia alcuni dei temi trattati nei ro-manzi. Steso nel 1944, apparso per la prima volta
sul n.11 della rivista «Mercurio» nel luglio del 1945(e l’anno successivo nella raccolta Il vecchio congli stivali), è però ambientato – come recita il tito-lo – nel 1937, anno in cui lo scrittore insegna co-me straordinario di ruolo a Caltanissetta, città nel-la quale si svolgono le vicende narrate.Il protagonista, Domenico Vannantò, intellettualesenza un’occupazione fissa, incarna molti elemen-ti peculiari comuni ai personaggi brancatiani: si-mile a loro nella incorreggibile accidia e nel totaledisinteresse per gli eventi politici e sociali che locircondano. Ma racchiude anche dei tratti indub-biamente autobiografici, legando il sentimentodella noia alla condizione di inattività forzata incui anche l’autore – come ogni intellettuale – erastato costretto dal regime fascista. L’esilità dellatrama permette a Brancati di dare al racconto lastruttura di un trattato filosofico, una sorta di ag-giornamento moderno delle Operette morali leo-pardiane; frequenti sono infatti i richiami all’inter-no del testo al poeta della noia; nel 1941, inoltre,egli aveva curato per Bompiani un’antologia delloZibaldone.
La noia nel ’937da Il vecchio con gli stivali
Un telegramma inviato a un amico, in cui Vannantò fa esplicito riferi-mento ai tempi noiosi in cui si trova a vivere, scatena immediatamentela reazione della questura, che trova l’espressione insopportabilmenteprovocatoria. Di fronte al funzionario di polizia inviato per convincer-lo a ritrattare l’affermazione, il protagonista non trova altra soluzioneche il suicidio, più come estremo corollario della noia esistenziale che loopprime, che per un atto di eroica protesta.
Chi non conosce la noia, che si stabilì in Italia nel 1937, manca di unagrave esperienza che forse non potrà avere più mai, nemmeno nei suoidiscendenti, perché è difficile che si ripetano nel mondo quelle singola-ri condizioni.Non che tutti in Italia si annoiassero, o almeno credessero di annoiarsi. Lamaggior parte anzi credeva il contrario, di star bene o addirittura di esse-re felice. I giovani nati dopo il ’15, non ricordavano una società diversadalla propria; i vecchi, avviliti perché vinti, erano creduti soltanto quandonon credevano più ai loro ideali, sicché essi dovevano mentire per acqui-starsi la reputazione di veritieri. Le donne poi, le casalinghe contente chei loro mariti non fossero distratti dalla politica, le corrotte che i loro aman-ti non fossero indeboliti dal pensiero o resi freddi dagl’ideali, aiutavano in
519
La narrativa meridionalistica • Vitaliano Brancati
tutti i modi a tenere in piedi l’inganno. Sì, erano felici! Come, non eranofelici? Chi è quel pazzo che sostiene che non siamo felici? Perdio, che beitempi! Tempi meravigliosi!… I giornali, profittando di tanta ingenuità, sibuttavano a domandare: «Perché siete contenti di vivere nella vostra epo-ca?» E i lettori su a rispondere con un sacco di ragioni.Eppure sarebbe bastato che, dal mezzo di un giardino popolato di per-sone che si ritenevano felici, erompesse una risata dei vecchi tempi, unadi quelle risate squillanti, energiche, di autentica e personale gioia, per-ché tutti trasalissero di stupore, d’invidia e infine di vergogna, comeun’accolta di suonatori stonati alla pura arcata di un Paganini.La noia era grande. Non si poteva sfuggire alla brutalità senz’annoiarsimortalmente. La vita dell’uomo onesto e, naturalmente, appartato e so-litario, mandava di notte e di giorno il sottile stridio di un vecchio legnointarlato.Proprio in quel periodo, capitò a Caltanissetta, e alloggiò nell’unico al-bergo riscaldato della cittadina, un uomo di appena trent’anni, chiama-to Domenico Vannantò. Era alto, magro, il viso affilato e pallido sarebbestato perfino tagliente se una luce ancora più pallida, piovendogli dagliocchi, non ne avesse estenuato gli zigomi e il mento, e sostituito la du-rezza con la stanchezza; quando camminava, teneva sempre una manosul dorso, una mano che si serrava e apriva di continuo, ciascun dito lot-tando con gli altri, specie il pollice che, dopo essersi cacciato fra l’indi-ce e il medio, fra il medio e l’anulare, fra questo e il mignolo, soccom-beva nella stretta dei suoi vicini e nemici.Solo chi gli andava dietro, e osservava attentamente quella mano, pote-va vantarsi di conoscere la qualità più delicata e repressa di Vannantò: inervi e l’inquietudine, perché nel resto della persona egli era ineccepi-bile. Chi gli sedeva accanto o di fronte, s’ingannava profondamente sul-l’indole di lui, al punto che persone colleriche, smaniose o irruenti, main sostanza poco sensibili, si riconobbero spesso il diritto d’invidiarlo:«Beato Lei, beato Lei che non ha nervi!».Nel ’37, come abbiamo detto, Vannantò, tornando da Roma, ove avevaperduto la prova scritta di un concorso, per esservi arrivato con un giornodi ritardo, si fermò a Caltanissetta, all’albergo Mazzoni. Vi si fermò colproposito di passarvi una giornata, ma sulla fine di febbraio erano giàventi giorni ch’egli appariva, al tocco in punto, nella sala da pranzo del-l’albergo, facendo tacere la vasta tavola a cui sedevano i giudici del Tri-bunale, il Presidente e il Pubblico Ministero, questi due ultimi con lo zuc-chetto in testa e lo scialle addosso, la cui frangia andava continuamente apescare nel fondo dei piatti e dei bicchieri. Tacevano, ma per un minuto,e subito riprendevano a tuonare, come se rigettassero tutta l’eloquenzaavvocatesca ch’erano stati costretti a ingoiare la mattina. Assordati dalleproprie parole, accecati dai propri argomenti, essi non prestavano più at-tenzione ad alcuno, e Domenico Vannantò, che, poco prima, sentendosiguardato da tanti occhi, aveva stabilito di lasciare subito Caltanissetta, tor-nava sulla sua risoluzione e stabiliva di rimanere ancora un giorno.Vannantò, se fosse vissuto nel ’700, sarebbe stato un pensatore, eavremmo letto di lui un qualche articolo nella vecchia Enciclopedia1; sefosse vissuto nell’800, sarebbe stato un poeta, e avrebbe combattuto perl’indipendenza greca2; vivendo in Italia nell’epoca in cui gli era toccatodi vivere, e avendo trent’anni nel ’37, faceva l’unica cosa nobile che po-tesse fare un uomo come lui: si annoiava.
1. Enciclopedia: l’«Enciclopedia» (Ency-clopédie) per antonomasia, diretta da DenisDiderot, Jean-Baptiste Le Rond d’Alemberte Louis de Jaucourt e pubblicata dal 1751 al1780, che costituì la più alta realizzazionedel secolo dei lumi. Il riferimento alla cul-tura francese vale a collocare le attitudiniintellettuali del protagonista al verticeestremo di una potenzialità non realizzata,a causa dell’epoca in cui gli era toccato divivere.2. se fosse … greca: l’allusione è al più ce-
lebre poeta romantico, George Gordon By-ron, morto per l’appunto a Missolungi nel1824, combattendo per l’indipendenza del-la Grecia contro i Turchi; esempio estremodi un ruolo sociale e politico dell’uomo dicultura vissuto attivamente (tema già impli-cito nel riferimento all’Encyclopédie).
520
IL SECONDO NOVECENTODal dopoguerra a oggi
Generi
Ma come? si dirà, un rimedio alla noia si trova sempre! Perché non lavo-rava?Il lavoro, a quei tempi, si riduceva a un cómpito da eseguire: Vannantòne aveva ripugnanza.Perché non meditava?Nella fanciullezza e nell’adolescenza, aveva molto meditato, e l’aria delsuo viso era stata quella di un ragazzo a cui dolesse fortemente il capo:il pensiero della morte lo aveva estasiato fino a togliergli il respiro, co-me un vento piacevole, ma che troppo crescesse di rapidità e violenza;i suoi mattini più felici erano stati quando si svegliava dall’aver sognatoche uno sforzo fortissimo, quasi sanguinoso, della memoria gli aveva ri-portato un ricordo dell’al di là, di prima della nascita, ricordo che dinuovo s’era perduto, ma della cui dolcezza gli rimaneva una lacrimafredda all’orlo dell’occhio; una testa di lupo, premendo dall’esterno ilvetro della finestra, non gli avrebbe dato il batticuore che gli dava, inquello stesso vetro, un cielo stellato; rimasto solo in un giardino, dopoessersi guardato attorno come chi si accinge a rovistare i cassetti in casad’altri, s’inginocchiava davanti a un cespuglio, v’immergeva la mano, ilbraccio, e si dava a frugare e tastare in tutta fretta, sperando di premereper caso, in qualche ramo o sassolino, il tasto segreto dell’universo, peril quale si spalancasse la porta del mistero e gli angeli vi apparissero glo-riosamente; poi a scuola, le prime notizie scientifiche sul moto di rota-zione terrestre, le aveva prese tanto sul tragico da guastarsi il piacere diveder sorgere e tramontare il sole come gli altri uomini sogliono veder-lo comunemente; e di un tramonto egli vide, non più l’apparenza, ma larealtà vertiginosa: il lato occidentale della terra si avventava sul sole, locopriva, lo nascondeva, il lato orientale invece precipitava lasciandoscoperto un cielo bruno, poi nero, e tutto l’orizzonte si rovesciava comeun gran piatto dalla parte della tenebra… ma alla fine questi pensieri esogni e sensazioni gli si aggrovigliarono in tal modo ch’egli disse: «Basta!Non sono più un bambino! Sono un uomo!», e pagò caramente l’avermeditato sul mistero dell’universo da bambino, perché gli rimase il so-spetto che il meditare su quell’argomento fosse proprio cosa da bambi-ni, per nulla degna di un adulto. La lettura di alcuni filosofi del suo tem-po lo confermò in questa supposizione. Egli andò oltre, naturalmente, esmise la meditazione non solo di quell’argomento, ma di qualunque al-tro di filosofia e scienza; e se talvolta ne era riassalito, il suo cervello or-mai l’accoglieva come un principio di stanchezza o di sonno, al qualeseguiva o un vago immaginare o il sonno vero e proprio.E le donne? Perché non si dava alle donne, diamine? Donne ce n’erano,donne non ne mancavano!S’era dato alle donne… come no?… e con grande piacere le prime vol-te. Quando “riuscì nel suo intento” con la signora Gallerati, gettò un ur-lo che fu sentito in tutto quanto il caseggiato. Ma se il piacere gli piac-que moltissimo, le donne finirono ad irritarlo. Le ragazze riflettevano,più di ogni altra creatura al mondo, la sinistra luce dei tempi. Frasi spor-tive o sciocche, modi barbari o indifferenti, s’erano impadroniti di queicorpi delicati. Vannantò perdette le staffe: egli non riusciva a sopportareuno sguardo maschile o stupido in due occhi di fattura quasi divina, néuna manata cameratesca da una mano perfetta. La Bellezza, caricacom’era di stupidità, gli divenne odiosa: egli prese una cattiva strada,cominciando a trovare voluttuoso il dare sfogo a uno strano sentimento
La narrativa meridionalistica • Vitaliano Brancati
521
di vendetta e di abbiezione; e fuggendo il più possibile dalla Gioventù edalla Bellezza, andò a nascondere il suo piccolo urlo supplichevole inseno ad alcune donne di cui ci risparmieremo di ritrarre le sembianze ein ogni caso di rivelare l’età. Ma questo non durò che tre anni: la castitàpiù gelida venne a coprirlo dalla testa ai piedi come un sudario. Le don-ne del resto non lo degnavano di alcuna attenzione: la sua persona altae magra, il suo sguardo lento e chiuso, che nell’800, col solo apparire inuna sala, avrebbero fatto steccare3 una fanciulla che cantasse, non pia-cevano nel ’937: bastava che gli sedesse accanto un giovane dalla testarapata, le spalle quadre, macinando un bocchino fra i denti scoperti dal-le labbra sprezzanti, perché una ragazza non rispondesse più ai suoimolti saluti, talmente le diventava invisibile.Se odiava la tirannide, perché non sparava?Contro chi, avrebbe dovuto sparare? Giudicava che la tirannide avessetante teste quante la servitù; che caduta la prima, tutte le altre, che lesonnecchiavano dietro, si sarebbero svegliate e rizzate più cupe chemai. «La tirannide non si uccide!» soleva dire. «Si uccide la servitù! Ma ioincontro, in ogni passeggiata, non meno di mille facce servili: non pos-so uccidere mille persone la volta!».Avrebbe potuto fare un bel gesto, ne conveniamo. Ma le parole “bel ge-sto” con quell’aggettivo tronco bel le reputava adatte piuttosto a unadonna che a lui: un bel gesto era una vanità di cui soltanto una personavanitosa avrebbe trovato gusto ad ornarsi. Se egli lo avesse compiuto, lamoltitudine lo avrebbe biasimato, questo non gl’importava gran che; mane avrebbe anche riso, e questo gl’importava molto, perché quell’infini-to riso di sciocchi e di servi gli pareva il meno atto, fra i rumori del mon-do, a lasciarlo dormire quietamente nel fondo della tomba, in cui di si-curo il bel gesto lo avrebbe gettato.Insomma non gli restava che annoiarsi, annoiarsi nei modi più strani ediversi, ma unicamente annoiarsi. E questo egli faceva, passando da unanoia avida e feroce, che divorasse quanto c’era all’intorno di odioso, auna noia sorda e plumbea, in cui si spegnesse, come grido nella nebbia,quanto c’era di vanitoso e petulante, a una noia lugubre e nera che av-volgesse, nel pensiero castigatore della morte, quanto c’era di stupida-mente giulivo. Gli altri credevano di agire, ed egli si annoiava; gli altricredevano di godere, ed egli si annoiava. Gli si annoiava quasi in faccia,con la cattiveria di chi sbadiglia sul muso dell’oratore per fargli intende-re che dice balordaggini. Ma anche quand’era solo, il che gli accadevaspesso, e nessuno lo vedeva, quel suo annoiarsi tenace, occulto,profondo, gli pareva che lentamente, ma sicuramente andasse consu-mando tutto e tutti, specie la persona (e in questo non s’ingannava) chepiù di ogni altra col tempo gli era venuta in fastidio: se stesso.S’era fermato a Caltanissetta perché aveva subito intuito che qui la noiatoccherebbe un punto che altrove non aveva mai sfiorato. La cittadina dipietra gialla, sospesa su una squallida pianura; l’albergo affacciato sullapiccola stazione da cui trenini affaticati gettavano ogni tanto uno stridu-lo grido; i portoni chiusi di prima sera, ai piedi dei quali i cani roteava-no su se stessi cercando di mordersi la coda; le nuvole che passavano digran corsa, cacciate da un vento che non aveva tregua; la statua del Re-dentore in cima a un colle su cui piovevano gli sguardi dei carcerati dal-le finestrine di un casamento livido; le fabbriche di chitarre ai piedi divecchie chiese; il mantello del federale zoppo nella nebbia del tramon-
3. steccare: «stonare», perché distratta,colpita dal suo aspetto, evidentemente af-fascinante.
522
IL SECONDO NOVECENTODal dopoguerra a oggi
Generi
to; gli avvocati che gesticolavano davanti al portone di casa, mentre sulloro capo, stesa a un filo tra balcone e balcone, la loro camicia gestico-lava anch’essa; le conferenze sull’impero, le paoline4… cosa gli manca-va per portare la noia al grado dell’esultanza?Come un gobbo, a cui venga presentato il più perfetto ed elegante degliabiti da gobbo, Vannantò, nel vedere quella città, ebbe un piccolo sorri-so amaro. «Questa va bene!» si disse, e annunziò al portiere dell’albergoche si sarebbe fermato un poco… Che poco! Gennaio passò via, feb-braio volò, era già la metà di marzo, e Vannantò non si risolveva ancoraa partire. Passava le giornate solo, perché l’unica persona che avesse co-nosciuto, il Pubblico Ministero, s’era molto scandalizzato nel sentirloparlare: «Ma perché vi annoiate? Si può sapere per quale ragione vi an-noiate? Che vuol dire, scusatemi, che vi annoiate?… La sera, venite agiocare a dama con me!».Quel buon vecchio del Pubblico Ministero s’era anche provato ad ac-compagnarlo in una passeggiata serale sul colle del Redentore. Il ventofischiava dentro i loro baveri, e Vannantò pareva ascoltarlo con tanto in-teresse, ora aggrottando le ciglia ora storcendo la bocca chiusa, che ilcompagno non osò disturbarlo con una sola parola. «Siete poco loqua-ce!» gli disse per giunta Vannantò, alla fine della passeggiata. «Io parlodalla mattina alla sera! Sei tu che fai cascare la parola di bocca!».Vannantò era tornato a passeggiare solo. Leggeva poco, non scrivevanulla, osservava con attenzione cupida e vuota l’ultima mosca letargicache gli volava a mezz’aria nella camera, passeggiava… Chi sa qualepoeta o eroe o filosofo moriva in lui piano piano, durante quelle pas-seggiate che lo riportavano diecine di volte davanti al medesimo spec-chio lesionato del corso, ove sempre, malgrado i giuramenti di non far-lo più, apriva le labbra e si guardava i denti?Una mattina, la noia gli parve così insopportabile che ne parlò in un te-legramma scherzoso a un amico.Due giorni dopo, fu bussato alla sua camera.Vannantò, in quel momento, sedeva accavalcioni su una sedia, pog-giando le braccia sulla spalliera, sulle braccia il mento, e guardando tor-pidamente la porta e il muro bianco.«Chi sarà mai?» si domandò, e non aveva ancora terminato di domandar-selo che uno sconosciuto entrò lesto lesto e richiuse la porta dietro di sé.«Siete voi Vannantò Domenico di Pietro?».Vannantò era così annoiato che la novità, invece di scuoterlo, parve ad-dormentarlo maggiormente come un fastidio che gli portasse al culminela stanchezza. «Sono io!» mormorò.L’altro, con un fare sfacciato e confidenziale, s’era seduto sul letto, e alzan-do un ginocchio per appoggiarvi un quaderno sul quale era pronto a scri-vere, e scuotendo in aria la matita, domandò:«Posso darvi un consiglio?».Vannantò non rispose nulla, ma il suo occhio, risalita lentamente la per-sona dello sconosciuto, gli arrivò in faccia così pieno di disgusto, chel’altro cambiò tono.«Dunque», disse, «perciò…». Tossì due o tre volte, cavando dalla rauce-dine una voce sempre più severa. «Dunque, egregio camerata, è vostroil seguente telegramma? Spero rivederti Roma… eccetera… partenza ri-mandata… eccetera… questi tempi noiosi… Ecco, ci siamo! Chi vi ciporta a dire baggianate? Spiegatemi che cosa avete voluto dire con tem-pi noiosi?».
4. le paoline: le Figlie di san Paolo, un or-dine di religiose con sede nella città sicilia-na, attivo nella diffusione della fede permezzo di pubblicazioni e altri mezzi di co-municazione.
La narrativa meridionalistica • Vitaliano Brancati
523
Vannantò gli tenne a lungo gli occhi addosso, sbattendo ogni tanto lepalpebre, come un cane più attento alla faccia di una persona che allesue ingiunzioni. Finalmente parve svegliarsi. «Chi siete, per favore?» do-mandò.«Io? Come? Io?». Lo sconosciuto si mise a ridere, poi rovesciò il baverodella giacca e mostrò un dischetto di metallo: «Questura!». Aspettò che ilsuo gesto avesse un effetto notabile nel viso di Vannantò, ma poiché inquel viso non si disegnava nulla, fece una smorfia e riprese: «Dunque,abbiate la compiacenza di spiegarmi questo tempi noiosi! Cosa c’è, sot-to? Chi si annoierebbe? Non vorrete mica dire che si annoiano tutti?».Ci fu una nuova pausa. Poi Vannantò disse: «Come piace a voi!».«Come mi piace, a me? Come vi piace a voi! E state attento a quello cherispondete perché potrebbero aversi, ehm mi capite? spiacevoli conse-guenze! Dunque», aggiunse, scrivendo a matita con difficoltà, «dunque siannoiano tutti!». Alzò il viso accigliato: «Si annoia anche il popolo?…Certo, anche il popolo… E perché si annoia il popolo?».«Che ne so io?».«Andiamo al sodo: non avete voluto per caso fare lo spiritoso, e dare aintendere che il popolo è scontento, il popolo se la passa male, il popo-lo si annoia perché ha come Capo?…». Il poliziotto si alzò, buttandosienergicamente dietro le spalle la falda della sciarpa che gli pendeva sulpetto, «perché ha come Capo Colui che sapete?».Vannantò lo seguì con gli occhi amareggiati senza staccare il mento dal-le braccia.«Ehi, dico a voi! Devo scrivere la vostra risposta!». Il poliziotto tornò a se-dere sul letto. «E badate che dipendono da questa risposta le spiacevoliconseguenze a cui mi sono riferito… Dunque, perciò, poche chiacchie-re! Perché si annoia il popolo?».«Vi ripeto: non lo so!».«Ma siete pronto a dichiarare che esso non è annoiato perché ha comeCapo Colui che sapete, e che anzi è felice di averlo, ed è invidiato daglialtri popoli?… Ehi, dico a voi!».«Ma che ne so io?» ripeté Vannantò, con lo stento di chi è costretto a par-lare in mezzo al sonno. «Che ne so io, se è invidiato dagli altri popoli?».«Qui non si tratta di saperlo o di non saperlo: si tratta di dichiararlo, scri-vendo a matita le parole che vi detto io e firmandole!».«Scrivendo a matita…» mormorò pesantemente Vannantò.«Scrivendo, per esempio, questo: Io sottoscritto, ovvero meglio: Il sot-toscritto Vannantò Domenico di Pietro dichiara sul suo onore, e con-ferma… ci mettiamo anche conferma, e conferma che nel suo tele-gramma mandato all’amico, eccetera, non vuole dire che il popolo siannoia perché ha come Capo eccetera… ma per altre ragioni… si an-noia perché… anzi: non si annoia…». Il poliziotto era diventato rossofin dentro gli occhi, una vena scura gli si era gonfiata nel mezzo dellafronte e pareva divorargliela piuttosto che alimentarla di sangue. «Lafrase non va… no, non va! Rifacciamola da capo. Il sottoscritto Van-nantò eccetera dichiara che il popolo è felice di avere come Capo Coluiche ha e contentissimo dei tempi presenti… Però resta il fatto che voi(vi fosse cascata la mano, quando l’avete scritto!) che voi nel tele-gramma ci avete messo: Tempi noiosi… Dunque perciò bisogna ritrat-tare questo noiosi e dichiarare che le parole del telegramma vi sonoscappate…».
524
IL SECONDO NOVECENTODal dopoguerra a oggi
Generi
Vannantò, che aveva infilato le mani nelle tasche, le tirò fuori indolente-mente sollevando un arnese che s’appoggiò fra il collo e il mento, e poid’un tratto fece esplodere con un fracasso che mandò a pezzi il vetrodella finestra.«Ehi, dico a voi: che avete fatto?» urlò il questurino, stravolto dalla paura.«Credo di essermi ucciso!» rispose Vannantò, col consueto tono di noia,reso leggermente più roco dalla gola sfracellata.
Analisi del testo
I l racconto è articolato in tre sequenze: un pream-bolo generale sulla noia come condizione esi-
stenziale collettiva, la presentazione del protagoni-sta, la fulminante narrazione dell’evento drammatico.
IL PREAMBOLO
L’affermazione iniziale anticipa il tono ironico-grot-tesco che sarà dominante nel brano. L’anno 1937,infatti, racchiude in sé una serie di eventi-chiave everi e propri sconvolgimenti – come la guerra civi-le spagnola, la dichiarazione dell’Impero da partedi Mussolini, la nascita dell’asse Roma-Berlino,quella del Ministero della Cultura Popolare (Min.Cul. Pop.) che istituzionalizza la censura fascista eil controllo del regime sulla cultura – considerandoi quali la noia può essere solo una condizione diinattività forzata. È interessante notare come l’auto-re provveda a commentare il dato reale appenapresentato con una vera e propria dichiarazione dipoetica (sarebbe bastato che…). L’irreale e artefat-ta condizione di felicità, infatti, non viene interrottada un eroico gesto di ribellione, ma dal prepotentesentimento del comico che corrisponde a unagioia tanto autentica e personale da farsi condannaed esplicita denuncia, e che rivela così la propriafunzione sociale.
IL PROTAGONISTA
La seconda sequenza presenta al lettore il protago-nista; la sua descrizione fisica – seppure a prima vi-
sta quella di un tipico eroe romantico – rompe i ca-noni dello schema ottocentesco. Sotto l’apparentenormalità si celano infatti sottili segni d’inquietudi-ne al limite della patologia, segni che nell’economiadella novella hanno la funzione di anticipare la tra-gedia finale.Domenico Vannantò – come gli altri personaggibrancatiani – ha ripugnanza del lavoro, inteso comeun dovere da eseguire, ed è piuttosto incline alla ri-flessione che all’azione. Ma la meditazione ha su dilui effetti devastanti: il pensiero della morte lo avevaestasiato fino a togliergli il respiro, come un ventopiacevole,ma che troppo crescesse di rapidità e vio-lenza. Nella similitudine si svela l’irresistibile attra-zione esercitata sul protagonista dalla morte, chesembrerebbe sostituire – per sovrapposizione leo-pardiana – quella per l’amore, tradotto in piaceresensuale, fino alla dimensione patologica (che con-divide con Paolo il caldo).Il richiamo a Leopardi si può individuare anche nel-la successiva immagine del giardino in cui Van-nantò spera di premere per caso […] il tasto segre-to dell’universo; in cui sembra esplicito il rimandoalla nota 4176 dello Zibaldone (22 aprile 1826), do-ve il dolore come legge della realtà viene indivi-duato nella souffrance («sofferenza») di tutti gli ele-menti della natura: ogni giardino è quasi un vastoospitale. L’insoddisfazione di Vannantò per l’indagi-ne razionale si traduce invece in immaginazione esogno (si spalancasse la porta del mistero e gli an-geli vi apparissero gloriosamente). Anche nel suc-cessivo smarrimento davanti alle leggi sul moto di
La narrativa meridionalistica • Vitaliano Brancati
525
rotazione terrestre e nella irriducibile separatezzadal buon senso comune (da guastarsi il piacere diveder sorgere e tramontare il sole come gli altri uo-mini sogliono vederlo comunemente) si può ricono-scere una matrice leopardiana: la conseguenza ne-gativa (fino al drammatico epilogo) di una cono-scenza razionale e scientifica della realtà che,comein Leopardi, non fa che accrescere la percezionedella pochezza umana (qui rappresentata dal gro-viglio conoscitivo). La rete dei riferimenti leopar-diani continua nel vago immaginare che rimanda di-rettamente alle Ricordanze, vv.170-173: …fia com-pagna / d’ogni mio vago immaginar,di tutti / i miei te-neri sensi […] la rimembranza acerba.Nella sessualità quasi patologica di Vannantò, si puòriconoscere uno dei caratteri dei personaggi bran-catiani,qui tinto di ambigua misantropia (non riusci-va a sopportare uno sguardo maschile o stupido indue occhi di fattura quasi divina, né una manata ca-meratesca da una mano perfetta); costante è inoltrela tensione verso i poli estremi della castità e dellalussuria.Ma la nota comica sulle donne nasconde lacompleta disarmonia del protagonista rispetto al-l’epoca in cui vive, e svela nella rappresentazionedell’iconografia maschile invalsa durante il regime(un giovane dalla testa rapata, le spalle quadre) i trat-ti di una polemica che potrà farsi esplicita solo nel-le forme dell’autodistruzione. Le immagini che em-blematizzano le diverse forme della noia nella vitaprovinciale di Caltanissetta anticipano l’esplosione
del dramma, lo portano alla sua climax e sono pre-sentate con tecnica cinematografica che sintattica-mente si traduce nella lunga serie di proposizioninominali culminanti nella finale interrogativa (l’esul-tanza sarà da leggere in parallelo a quella che Bran-cati nei Piaceri della disperazione chiama benignadisperazione).
LA NARRAZIONE DELL’EVENTO DRAMMATICO
La vera e propria sequenza narrativa inizia icastica-mente (Una mattina, la noia gli parve così insoppor-tabile che ne parlò in un telegramma scherzoso a unamico). Secondo i canoni della scrittura dramma-turgica e cinematografica, si sviluppa dapprimalentamente – seguendo il ritmo del dialogo – poi piùvelocemente fino al rapidissimo precipitare deglieventi, preparato dall’autore come una sorta di ‘col-po di scena’; l’aggettivo scherzoso suggerisce im-mediatamente al lettore una chiave di lettura grotte-sca di quanto segue.Il dialogo tra Vannantò e il questurino contrapponealla spavalderia e arroganza del secondo l’assolutaremissività e quasi indolenza del primo che, pernulla turbato dalla prevaricazione, sembra assiste-re inerte (come un cane) a un’ennesima dimostra-zione dell’impossibilità di vivere e l’autore – perfet-to regista della sua opera – fa scoppiare il drammadallo stridore fra il registro ironico-grottesco del-l’interrogatorio e il tragico e catartico gesto finale.
Proposte operative
Analisi
Delinea la personalità del protagonista: il narratorestesso ne evidenzia il legame con le figure-tipodella storia letteraria? Quale ti sembra il modellopiù significativo?
Come spieghi la scelta finale del protagonista?Quale significato emblematico assume?
Individua nel testo i riferimenti al contesto storico.3
2
1
Quali aspetti collegano il racconto alla narrativameridionalistica?
Approfondimenti
Individua analogie e differenze con altre operedella narrativa meridionalistica.
1
4
526
IL SECONDO NOVECENTODal dopoguerra a oggi
Generi
CORRADO ALVARO
Testi:nel 1954 Corrado Alvaro iniziò a curare per Bompiani l’edi-zione completa delle sue opere. I più importanti romanzi e rac-conti vennero raccolti vent’anni dopo da L.Bigiaretti;ora – con unascelta antologica lievemente diversa – si possono leggere in unvolume a cura e con introduzione di G.Pampaloni (Romanzi e rac-conti,Bompiani,Milano 1990),provvisto anche di una bibliografiadegli scritti dell’autore (suddivisi in Volumi,Testi teatrali,Tradu-zioni,Edizioni e prefazioni e Racconti,articoli e contributi vari nonriuniti in volume,Epistolario,Opere postume,manoscritti,dattilo-scritti, inediti) e una bibliografia ragionata della critica.Il testo antologizzato è tratto da C.Alvaro, Gente in Aspromonte,Garzanti,Milano 1978.
Critica: ancora fondamentali le due monografie di A. Balduino(Corrado Alvaro,Mursia,Milano 1965;nuova edizione,ivi 1972) edi V. Paladino (L’opera di Corrado Alvaro, Le Monnier, Firenze1968),che forniscono una ricchissima rassegna bibliografica ag-giornata però fino all’anno di pubblicazione.Ulteriori indicazionisi possono ricavare dal contributo di P.Tuscano,La critica alvaria-na negli ultimi dieci anni (1968-1978), in U. Bosco, G. Cingari e G.Pampaloni,Corrado Alvaro.L’Aspromonte e l’Europa,Casa del li-bro,Reggio Calabria-Roma 1981.A Balduino si deve anche l’otti-ma scheda sul Dizionario critico della letteratura italiana,diretto daV.Branca,I,UTET,Torino 19862.Si veda inoltre P.Del Rosso,Comeleggere «Gente in Aspromonte»,Mursia,Milano 1993.Nel 1981 sono stati pubblicati gli Atti di due convegni, tenutisi ri-spettivamente a San Luca, 23-24 giugno 1979 (Corrado Alvaro:cultura,mito,realtà,a cura di G.Gigliozzi e S.Amelio,Lucarini,Ro-ma),e a Reggio Calabria,4 e 10-12 novembre 1978 (Corrado Al-varo.L’Aspromonte e l’Europa,cit.),mentre nel 1987 sono usciti gliAtti del Convegno promosso dal «Centro studi Corrado Alvaro»tenutosi a Roma il 30 novembre 1986,che raccolgono importanticontributi della critica sull’autore (Utopia e realtà nell’opera di Cor-rado Alvaro,a cura di P.Falco,Edizioni Periferia,Cosenza).
CARLO LEVI
Testi: la produzione narrativa e saggistica di Carlo Levi è editasingolarmente da Einaudi, presso lo stesso editore nel 1987 èuscito anche il primo volume della raccolta completa delle Ope-re, con introduzione di C. Cases. Nel 1991 la casa editrice Il Me-langolo di Genova ha pubblicato le lettere dal carcere del biennio1934-35 (È questo il «carcer tetro»?),a cura di D.Ferraro.Il testo antologizzato è tratto da C.Levi,Cristo si è fermato a Eboli,Einaudi,Torino 1990.
Critica: per un primo inquadramento della figura leviana si pos-sono consultare gli agili volumi Carlo Levi,a cura di G.Falaschi,LaNuova Italia,Firenze 1971 e Invito alla lettura di Carlo Levi,a cura diM.Miccinesi,Mursia,Milano 19895;presso la stessa casa editricenel 1986 è uscito anche il volume Per leggere «Cristo si è fermatoa Eboli»,curato da F. Viganò.Un interessante bilancio delle tesi le-viane sulla realtà meridionale è proposto da G.Russo,Carlo Levie la civiltà contadina, in Il paese di Carlo Levi (Aliano,cinquant’annidopo),Laterza,Roma-Bari 1985.Un completo aggiornamento bibliografico si trova nel volumeCarlo Levi nella storia e nella cultura italiana,a cura di G. De Dona-to (cui si deve anche il precedente Saggio su Carlo Levi,De Dona-
to,Bari 1974),Lacaita,Manduria (Taranto) 1993,che raccoglie gliAtti di un seminario tenuto a Roma.
IGNAZIO SILONE
Testi: apparse prima in tedesco che in italiano, le opere di Silonesono poi state tutte pubblicate da Mondadori.Il testo antologizzato è tratto da I. Silone, Fontamara, Mondadori,Milano 1953.
Critica: la critica,dopo un periodo di disinteresse,seguito da unapresa di posizione ideologica spesso sconfinante nell’ostracismo,ha vissuto solo recentemente una fase di rinnovato interesse.Fon-damentale risulta ancora la monografia di L. D’Eramo, L’opera diIgnazio Silone, Mondadori, Milano 1971, che fornisce un profilocompleto ed esaustivo dello scrittore.Una sintetica storia della cri-tica siloniana si trova anche nello studio di F. Virdia, Ignazio Silone,La Nuova Italia,Firenze 1967.Più aggiornati i volumi di V. Arnone,Ignazio Silone,Edizioni dell’Ateneo,Roma 1980,e di V.Esposito,Vi-ta e pensiero di Ignazio Silone,Studio Bibliografico Polla,Cerchio(L’Aquila) 1993. Sui rapporti di Silone con il fascismo: M. Franzi-nelli, I tentacoli dell’Ovra,Bollati Boringhieri,Torino 1999;D.Bioc-ca e M.Canali,L’informatore Silone,i comunisti e la Polizia,Luni Edi-trice,Milano-Trento 2000.
VITALIANO BRANCATI
Testi: le opere di Vitaliano Brancati si possono ora leggere in duevolumi della collana dei «Classici Bompiani»: il primo (Opere1932-1946),uscito nel 1987 per le cure e con una significativa in-troduzione di L. Sciascia, contiene Gli anni perduti, Singolare av-ventura di viaggio,Don Giovanni in Sicilia;il secondo (Opere 1947-1954), corredato della postfazione di D. Perrone (di cui ricordia-mo anche i saggi raccolti in I sensi e le idee, Sellerio, Palermo1985),contiene Il bell’Antonio e Paolo il caldo.I tre romanzi maggiori erano già stati editi in volume dalla stessacasa editrice nel 1974, con introduzione di A. Guglielmi, e sonostati ristampati separatamente agli inizi degli anni Ottanta, ma sipossono trovare agevolmente in edizioni economiche.Il testo antologizzato è tratto da V.Brancati, Il vecchio con gli stivalie altri racconti,Bompiani,Milano 1981.
Critica: l’interesse della critica nei confronti dell’autore sicilia-no,nonostante il successo editoriale avuto a partire dal Don Gio-vanni,data dagli anni Settanta con gli studi di V.Gazzola Stacchi-ni (La narrativa di Vitaliano Brancati, Olschki, Firenze 1970, e Ilteatro di Vitaliano Brancati:poetica,mito e pubblico,Milella,Lec-ce 1972), L. Abrugiati (Il primo tempo di Vitaliano Brancati, Ca-rabba,Lanciano 1977),fino a F.Spera (Vitaliano Brancati,Mursia,Milano 1981), G. Morelli (Vitaliano Brancati tra fascismo e galli-smo, Lacaita,Roma 1989) e S.Zircone (La carne e la noia: la nar-rativa di Vitaliano Brancati,Novecento,Palermo 1991);si segnalainoltre G.C.Ferretti,L’infelicità della ragione nella vita e nell’ope-ra di V.Brancati,Guerini,Milano 1998.Negli anni Ottanta due convegni,nel 1984 a Misterbianco (Vita-liano Brancati, a cura di S. Zappulla Muscarà, Maimone, Catania1986) e nel 1986 a Siracusa-Pachino (Vitaliano Brancati nella cul-tura europea,a cura di P.M.Sipala,Ediprint, Siracusa 1987),han-no ampliato la ricognizione sul territorio – per alcuni aspetti an-cora inesplorato – della narrativa brancatiana.
Bibliografia