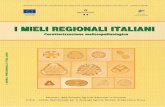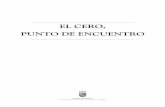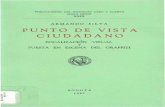Violenza praticata e violenza subita: il punto di vista dei cattolici antifascisti italiani...
Transcript of Violenza praticata e violenza subita: il punto di vista dei cattolici antifascisti italiani...
1
VIOLENZA PRATICATA E VIOLENZA SUBITA: IL PUNTO DI VISTA DEI CATTOLICI
ANITIFASCISTI. SPUNTI INTERPRETATIVI DAL CASO MODENESE (1943-1948)
Alessandro Santagata
Nelle prime pagine del suo grande affresco sul «dopoguerra» europeo, Tony Judt descrive i caratteri
delle violenze sommarie, quando «nell’intervallo tra la ritirata delle armate tedesche e l’instaurazione
di un controllo effettivo da parte degli eserciti alleati, le frustrazioni popolari e le vendette personali
sboccarono in un episodio breve ma sanguinario di regolamento dei conti»1. Al di là delle specificità
nazionali che implicano una problematizzazione della categoria di «collaborazionismo», le grandi
questioni (le violenze contro il nemico “interno”, l’organizzazione dell’epurazione, la celebrazione
dei processi di guerra e l’assegnazione delle responsabilità) toccavano tutti paesi usciti dal conflitto.
Di fondo, – sostiene lo studioso – c’era la necessità da parte dei nuovi poteri democratici di chiudere
rapidamente i conti con la guerra e di procedere verso la fondazione di una nuovo ordine. In questo
scenario si inserisce anche la vicenda italiana, considerata da Judt «un caso difficile» di metamorfosi
controllata verso la democrazia2. Il desiderio di vendetta e di riscatto, particolarmente forte laddove
soffiava il «vento del Nord», conviveva nella mentalità collettiva con la difficoltà a «identificare il
nemico» e a attribuire le cause di tanta sofferenza (dai bombardamenti, alla fame, alla perdita dei
propri cari)3. È dunque l’Italia del De profundis, magistralmente raccontata da Salvatore Satta, il
palcoscenico in cui si è celebrato il rito catartico dell’uscita dalla guerra con quel «di più di violenza»
fotografato a Piazzale Loreto4.
Un rito duplice, istituzionale e spontaneo, sul quale questa breve relazione intende mettere a
fuoco un punto di vista particolare, quello dei militanti cattolici antifascisti dal periodo resistenziale
all’immediato dopoguerra. Più specificamente, sarà oggetto di studio la riflessione sulla
legittimazione della violenza, «agita» nella guerra partigiana e successivamente la violenza
dopoguerra, di cui gli stessi militanti cattolici sono stati talvolta vittime. Pur adottando una prospettiva
ampia, un certo spazio verrà dedicato alle vicende del gruppo democristiano modenese comandato da
Ermanno Gorrieri. La selezione di questo case study, peraltro già oggetto di diverse ricerche
storiografiche, si spiega alla luce della riconosciuta rilevanza del modenese come laboratorio della
1 T. Judt, Postwar. A History of Europe since 1945, London, William Heinamm, 2005, (trad. ita. Mondadori 2007) p. 33.
Più specifico è lo studio di K. Lowe, Savage Continent. Europe in the Aftermath of World War II, London, Penguin, 2012,
pp. 75-179. 2 Ibidem, p. 33. 3 Cfr. anche G. Crainz, L’ombra della guerra. Il 1945 in Italia, Roma, Donzelli, 2007; E. Di Nolfo, Le paure e le speranze
degli italiani (1943-1953), Milano, Mondadori, 1996. 4 S. Satta, De profundis, Roma, Adelphi, 2003 [prima edizione Padova, Cedam 1948].
2
violenza del dopoguerra e risponde efficacemente alla tesi qui sostenuta: il rapporto di continuità tra
la legittimazione della violenza partigiana da parte dei combattenti cattolici e l’atteggiamento assunto
di fronte alla «prosecuzione» della guerra civile. Anche se non ne costituiscono il centro, rientreranno
nella riflessione anche le principali istituzioni del mondo cattolico tenendo sullo sfondo la Santa Sede
e la Democrazia cristiana. Infine, per quanto riguarda la cronologia, se il punto di partenza è
individuato nelle tensioni e nelle contraddizioni generate dall’ingresso dell’Italia in guerra, un
passaggio ineludibile per comprendere il momento della «scelta» (settembre ’43-gennaio 44‘), il
terminus ad quem è identificato nel 1948, l’anno delle prime elezioni politiche quando il rischio di
una nuova guerra civile, e di un ritorno dei cattolici alla lotta armata, raggiungerà il climax
nell’immaginario collettivo. Il fine ultimo è suggerire alcune linee di ricerca su un aspetto, questo dei
cattolici e la violenza tra guerra e immediato dopoguerra, che attende ancora di essere problematizzato
in maniera adeguata nei suoi diversi aspetti.
L’eredità del ventennio
I cattolici italiani non rappresentavano negli anni Quaranta un insieme omogeneo. Esistevano modi e
forme diverse di vivere la fede e le sue implicazioni sociali. Tuttavia, si è ormai concordi nel
considerare il ventennio fascista il periodo in cui si è completata la «nazionalizzazione delle masse»
cattoliche con il compattamento del mondo religioso attorno al regime (considerato uno strumento
per realizzare la «nazione cattolica»), e al «papa re» (enciclica Quas primas), a cui spettava il compito
di indirizzare la nuova «religione della politica»5. Concretamente, dopo la stipulazione del
Concordato, Chiesa e fascismo avevano sviluppato un modus vivendi fondato sullo scambio del
consenso in favore di leggi e privilegi. Non erano mancati momenti di frizione, ma sarebbe stato
necessario attendere il biennio 1939-1940 perché la fiducia della Santa Sede nelle potenzialità del
regime venisse messa in discussione. Se l’impresa di Etiopia e la “crociata” in Spagna avevano
rappresentato il punto più alto degli «anni del consenso», l’entrata in guerra a fianco delle potenze
dell’Asse, a un anno dell’emanazioni delle leggi razziali, ha segnato l’apice di cui crisi che Pio XII
gestirà all’insegna di una lenta transizione verso la democrazia6. È questo il contesto in cui va
inquadrato il rapporto dei cattolici italiani con la violenza politica nella sua forma più estrema, quella
della guerra. I giovani chiamati a combattere contro Francia e Gran Bretagna, cresciuti nelle
5 Sui rapporti tra Chiesa e fascismo sono ancora di grande utilità la raccolta di fonti, corredata di introduzione critica, di
P. Scoppola, La Chiesa e il fascismo: documenti e interpretazioni, Roma-Bari, Laterza, 1967, così come l’interpretazione
fornita da G. Miccoli, La chiesa e il fascismo, in Idem, Fra mito della cristianità e secolarizzazione. Studi sul rapporto
chiesa-società nell'età contemporanea, Marietti, Casale Monferrato (AL), 1985, pp. 112-130. Per una sintesi documentata
e di più lungo periodo L. Ceci, L’interesse superiore. Il Vaticano e l’Italia di Mussolini, Roma-Bari, Laterza, 2013. 6 Cfr. E. Fattorini, Pio XI, Hitler e Mussolini. La solitudine di un papa, Torino, Einaudi, 2007.
3
organizzazioni del regime, dovranno fare i conti con un nuovo conflitto mondiale e dopo l’8
settembre, con l’onere di una difficile scelta di campo.
Francesco Malgeri ha sottolineato come nel 1940, di fronte a un conflitto non voluto né dalla
Santa Sede né da moltissimi italiani, l’atteggiamento prevalente nel clero e tra i militanti dell’Azione
cattolica sia stato il «rifugio nel campo spirituale», nell’assistenza, nell’organizzazione e nella
spontaneità di riti e processioni interpretati dai prefetti come un odioso cedimento al pacifismo7. Non
che in queste manifestazioni si possa riscontrare del dissenso, ma «la chiesa italiana sembrava
rinchiudersi in una sorta di autoisolamento, quasi impotente e incapace di individuare istanze e
prospettive politiche alternative»8. Come ha mostrato l’importante ricerca di Giovanni Miccoli, se
dopo vent’anni di regime l’adesione dei credenti alla patria in guerra era un fatto scontato, la linea
scelta di fronte alla guerra era la medesima del 1915-1918: attestazione della Santa Sede su una
posizione super partes di condanna (generica) delle violenze e obbedienza dei cattolici ai rispettivi
governi nazionali9. Non stupisce quindi che «disciplina», «dovere» e «sacrificio» fossero le parole
più ricorrenti nelle omelie episcopali e nella pubblicistica (emblematica l’iniziativa da parte di padre
Gemelli di procedere nel 1940 con la consacrazione dei soldati al Sacro Cuore). A ciò si aggiunga
che, dal punto di vista di una certa tradizione intransigente, fatta propria dal Magistero, la guerra era
un «castigo divino» (Summi pontificatus, 1939), il prodotto di quella genealogia dei mali moderni
iniziata con la Riforma e proseguita con la Rivoluzione (De Maistre), ma ciò non poteva comportare
una giustificazione per sottrarsi alla guerra e al dovere della Chiesa di fornire un contenuto spirituale
al suo svolgimento10.
Non è possibile in questa sede ripercorrere il lungo dibattito nella Chiesa cattolica circa la
liceità dei conflitti e la dottrina della «guerra giusta». Sia sufficiente ricordare, insieme a Daniele
Menozzi, che la dottrina ecclesiastica in materia si è evoluta nel corso del Novecento verso una
sostanziale delegittimazione religiosa dello strumento bellico: un processo iniziato con la Prima
guerra mondiale e la condanna dell’«inutile strage»11. Alla vigilia del nuovo conflitto, era diffusa
l’idea che la tradizione agostiniana e tomistica potesse fornire gli strumenti per limitare e
condizionare la politica del regime12. Quando si arriverà all’8 settembre 1943, l’«andamento
7 F. Malgeri, La Chiesa italiana e la guerra 1940-1945, Roma, Studium, 1980, pp. 28-29. 8 Ibidem, pp. 13-14. 9 G. Miccoli, I dilemmi e i silenzi di Pio XII. Vaticano, Seconda guerra mondiale e Shoah, Milano, Rizzoli, 2007 10 Una panoramica delle posizioni in campo in R. Moro, I cattolici italiani di fronte alla guerra fascista, in La cultura
della pace dalla Resistenza al Patto Atlantico, a cura di M. Pacetti, M. Papini e M. Sarcinelli, Bologna, Il Lavoro
editoriale, 1988, pp. 75-126. Tra le poche voci apertamente contrarie, lo storico ricorda quelle di Giorgio La Pira e Primo
Mazzolari. 11 D. Menozzi, Chiesa, pace e guerra nel Novecento. Verso una delegittimazione religiosa dei conflitti, Bologna, Il
Mulino, 2008. 12 Cfr. R. Moro, L’opinione pubblica cattolica su pace e guerra durante il fascismo, in Chiesa e guerra. Dalla benedizione
delle armi alla Pacem in terris, a cura di M. Franzinelli e R. Bottoni, Bologna, Il Mulino, 2005, pp. 295-311.
4
ondulatorio» (e poliforme) del consenso dei cattolici alla guerra raggiungerà il punto più basso, quello
delle manifestazioni di piazza per la pace ritrovata13. Il divorzio con il regime si era consumato pochi
mesi prima e – vale la pena ricordarlo – solo di fronte al dato di fatto della sua caduta.
Nel messaggio natalizio del 1942, dedicato a L’ordine interno alla nazioni, papa Pacelli aveva
avanzato le prime riflessioni sul «nuovo ordine cristiano». In quello del 1944 e aveva aperto alla
democrazia, rafforzando ulteriormente i contatti diplomatici con gli Stati Uniti14. È dunque in questo
quadro complesso, tra lo sbandamento dell’esercito, la fuga del governo e la maturazione di nuovi
progetti politici per il dopoguerra (in funzione anticomunista e per una nuova Democrazia cristiana),
che bisogna leggere la scelta di alcuni settori del cattolicesimo italiano di partecipare alla Resistenza.
Il problema che si pone agli storici è capire in che modo la crisi delle relazioni tra religione e fascismo
(e sua elaborazione da parte dei protagonisti) abbia interagito con la rielaborazione della dottrina sulla
legittimità della guerra e della violenza politica e con la lettura evangelica dei «segni dei tempi» in
un momento di assenza di un principio di legittimazione governativa. Il complesso di atteggiamenti
scaturiti dalla guerra civile – spiegava già Pavone nel 1991 – è refrattario a ogni reductio ad unum15.
Si cercherà qui di fornire una rapida e insufficiente schematizzazione.
Combattere da partigiani: i cattolici nella Resistenza e la riflessione sulla violenza
Nel periodo dell’occupazione nazi-fascista la linea politica dell’episcopato si era attestata
nuovamente su un prudente apoliticità di fronte a un regime, quello di Salò, non riconosciuto dalla
Santa Sede e dalle venature fortemente anticlericali. Dietro alla scelta della terzietà (esemplare
nell’atteggiamento assunto, pur con le rispettive differenze, da vescovi importanti quali Elia Dalla
Costa, Nasalli Rocca e Ildefonso Schuster) c’erano l’idea di proteggere la Chiesa dalle persecuzioni
(come stava accadendo in Germania) e la sincera preoccupazione di evitare guai maggiori alla
popolazione civile. Rimane il fatto – sottolineato da Bruna Bocchini Camaiani – che la scelta
partigiana avvenne in una situazione di «grande reticenza da parte dell’episcopato»16. Sarebbe quindi
necessario aprire un discorso più ampio, quello delle compromissioni e dell’acquiescenza, da una
13 La definizione è di R. Moro, I cattolici italiani di fronte alla guerra fascista, cit., p. 78. 14 Su queste vicende cfr. G. Miccoli, Chiesa e società in Italia dal Concilio Vaticano I (1870) al pontificato di Giovanni
XXIII, in Storia d’Italia, V, Torino, Einaudi, 1973, pp. 1493-1548. 15 C. Pavone, Una guerra civile. Saggio sulla moralità nella Resistenza, Torino, Bollati Boringhieri, 2006 [prima edizione
1991]. 16 B. Bocchini Camaiani, I vescovi, in Cattolici, Chiesa, Resistenza, a cura di G. De Rosa, Bologna, Il Mulino, 1998, pp.
214-215. Un quadro di insieme in M. Franzinelli, Chiesa e clero cattolico, in Dizionario della Resistenza, I, Storia e
geografia della Liberazione, Torino, Einaudi, 2000, pp. 300-322.
5
parte, e della «resistenza pastorale», dall’altro, che ci porterebbe lontano17. Tornando allo svolgimento
degli eventi, – come scrive Giorgio Vecchio – «fu l’urgenza del momento a spingere i cattolici a
scelte che solo in parte potevano essere date per scontate»:
Molti parroci, ma anche molti religiosi, furono inevitabilmente spinti verso l’opposizione ai tedeschi dalla propria volontà
di compiere gesti di carità verso i militari in fuga, la popolazione, gli ebrei (un’azione di patronage, a cui contribuirono
non pochi vescovi, che risulterà fondamentale anche nel rafforzare il consenso attorno alla Chiese e la sua credibilità
agli occhi degli alleati) […]. A partire dall’8 settembre e fino al termine della guerra, una scelta si imporrà se non a tutti,
almeno a moltissimi italiani e pertanto a moltissimi cristiani: servire nelle file della Repubblica sociale italiana (Rsi)
oppure passare in montagna18.
Anche se non è necessario ricordarlo in questa sede, la storiografia degli ultimi vent’anni ha
allargato significativamente il concetto di Resistenza. Sulla scia dell’opera magistrale di Pavone,
volta a complicare la tradizione sulla «guerra di liberazione», sono state investigate le tre nature del
fenomeno: la «guerra patriottica», la «guerra civile», «la guerra di classe». Sono state poi introdotte
nuove categorie come la «Resistenza civile», la «Resistenza non armata» e la «renitenza»19. Infine,
si è fatto riferimento alla definizione di «guerra ai civili» per indicare, nel quadro della «guerra
totale», la strategia nazi-fascista che identificava nella popolazione civile un obiettivo militare20. Sulla
base di queste innovazioni concettuali è stato riletto anche il punto di vista dei cattolici. Il problema
della scelta partigiana, infatti, toccava non solo la sfera della legittimazione politica, ma anche, e non
meno, il piano etico-religioso: quale valutazione dare a un conflitto sostanzialmente nuovo nei suoi
caratteri di fondo? Come relazionarsi alla disumanizzazione del nemico?
Miccoli ha più che sufficientemente mostrato la sostanziale incapacità della Santa Sede di
comprendere il salto di qualità compiuto dalla «guerra totale», l’ostinazione con la quale veniva
portata avanti la politica antisovietica, la prudenza nei confronti della Resistenza21. Diverso era il
punto di vista dei fedeli direttamente a contatto con l’occupazione. Come si cercherà di mostrare, a
partire dal nostro caso locale, il «di più di violenza» è stato un elemento decisivo nel rafforzare la
17 Per rimanere sulle grandi linee del fenomeno, sono particolarmente dense di significativo le osservazioni sul tema
proposte da Pavone: «La distinzione che trovò particolare difficoltà a essere mediata fu quella fra religione come fatto
istituzionale, amministrativo, e la religione come fatto di coscienza. All’interno di entrambi i livelli si verificava in effetti
lo sdoppiamento fra lo stare super partes e lo schierarsi. Al primo livello lo sdoppiamento generava una prudenza
diplomatica rotta talvolta dalla compromissione con, o dalla opposizione contro, le autorità nazifasciste; al secondo livello
poneva in luce il contrasto fra la pietà religiosa, che accumuna amici e nemici, e l’impegno attivo a fianco degli amici
contro i nemici, in virtù di un’ispirazione religiosa alla ribellione contro la prepotenza e l’ingiustizia». C. Pavone, Una
guerra civile, cit., pp. 283-284. 18 G. Vecchio, Guerra e Resistenza, in Cristiani d'Italia. Chiesa, società, Stato, 1861-2011, Roma, Treccani, 2011 19 Cfr. A. Bravo, Resistenza civile, in Dizionario della Resistenza, cit, 1, pp. 20 Cfr. M. Battini, P. Pezzino, Guerra ai civili. Occupazione tedesca e politica del massacro, Venezia, Marisilio, 1997.
Sull’occupazione tedesca in Italia anche L. Klinkhammer, Stragi naziste in Italia 1943-1944, Roma, Donzelli, 2006;
Idem, L'occupazione tedesca in Italia 1943-1945, Torino, Bollati Boringhieri, 1993. 21 G. Miccoli, I dilemmi e i silenzi di Pio XII, cit.
6
scelta armata partigiana. Prima di toccare questo aspetto, occorre chiare però il punto a monte, quello
della scelta.
Se le reazioni dell’episcopato alla guerra civile sono state investigate con dovizia negli studi
sopra citati va detto che la storiografia sulla componente religiosa della Resistenza è ancora lacunosa
e spesso legata a schemi appartenenza politica22. A parziale giustificazione di questa carenza, sembra
però ancora valido quanto scriveva Vittorio Emanuele Giuntella nel 1981:
La presenza dei cattolici militanti nella Resistenza è […] assai più frantumata e sfugge ad una rilevazione numerica, o a
una sistematica classificazione, come si è tentato di fare da più parti, con intenti denigratori o apologetici, nella polemica
successiva. Nella condizione storica e geografica della Resistenza non si avrà mai abbastanza attenzione alla casualità
dell’adesione a una formazione, o all’altra, per la vicinanza topografica, il prestigio goduto, la omogeneità (ex alpini,
paesani della stessa valle, ceti sociali identici), l’urgenza della scelta, prescindendo dall’assunzione o meno dell’ideologia,
che ispirava la formazione nella quale si entrava23.
Sempre Giuntella ha sottolineato come il motivo della «guerra patriottica» fosse particolarmente
marcato nel condizionare la scelta della montagna come, del resto, dimostrerebbe la toponomastica
risorgimentale delle formazioni partigiane di matrice cattolica: Mameli, Ciro Menotti, Fratelli
Bandiera, Mazzini, Pisacane, ecc. Il richiamo al Risorgimento – aggiunge Vecchio – «metteva
insieme il rifiuto morale del fascismo e dei suoi metodi, il senso della patria e della sua indipendenza,
il ricordo – appreso a suo tempo anche sui banchi di scuola – della ‘secolare’ ostilità all’austriaco e
al tedesco, o ancora il criterio della fedeltà alla dinastia sabauda intesa come rappresentante della
legittimità dello Stato Italia»24. La tesi sulla «nazionalizzazione delle masse» cattoliche, di cui sopra,
ne esce nuovamente confermata25. Il case study al centro di questo interventi ne fornisce un’ulteriore
attestazione.
I primi incontri all’origine del gruppo parigiano di Gorrieri (e del suo compagno più fidato,
Luigi Paganelli) risalgono all’immediato 8 settembre 194326. Da tempo anche nel modenese si
muoveva nella clandestinità la rete che avrebbe iniziato la battaglia dei Gap. L’antifascismo cattolico
invece era ancora alle prese con gravi problemi d’organizzazione dovuti alla distanza tra la
componente storica degli ex-popolari, guidata da Alessandro Coppi, e il gruppo dei «giovani»
cresciuto sotto il fascismo. La distanza generazionale si ripercuoteva ovviamente anche
22 Cattolici, Chiesa, Resistenza, cit. 23 V.E. Giuntella, I cattolici nella Resistenza, in Dizionario storico del movimento cattolico in Italia. 1860-1980, diretto
da F. Traniello, G. Campanini, I,2, I fatti e le idee, Casale Monferrato 1981, p. 112. 24 G. Vecchio, Guerra e Resistenza, cit 25 Sul patriottismo del clero e dei partigiani cfr. C. Pavone, Una guerra civile, p. 299. 26 La prima biografia scientifica di Gorrieri è stata recentemente proposta dall’équipe di ricerca di P. Pombeni: M.
Carrattieri, M. Marchi, P. Trionfini, Ermanno Gorrieri (1920-2004). Un cattolico sociale nella trasformazioni del
Novecento, con la supervisione scientifica di P. Pombeni, Bologna, Il Mulino, 2009. Sulla nascita del gruppo si veda anche
Sulla nascita della Dc modenese e gli anni della lotta antifascista cfr. P. Alberghi, Le origini della Democrazia cristiana
modenese. 1943-1948, Bologna, Istituto De Gasperi dell’Emilia-Romagna, 1992, pp. 22-35.
7
sull’impostazione politica. Se per i primi infatti si trattava di proseguire la lotta iniziata dal partito di
Sturzo e Francesco Luigi Ferrari, i giovani cattolici provenivano da un mondo, quello dell’Azione
cattolica, definito da Gorrieri come «afascista»27. Venendo al nostro ragionamento sulla scelta, il
progetto politico-religioso dei giovani era indirizzato verso la «resistenza» e la «rinascita»: le due
parole chiave contenute nel nome del primo movimento dei cattolici modenesi e tenute insieme dal
richiamo alla patria. Ricorda Gorrieri:
Io e altri miei amici eravamo giovanissimi ufficiali appartenenti all'Azione cattolica. Siamo venuti alla Resistenza,
all'inizio per una motivazione esclusivamente patriottica, la reazione all'umiliazione nazionale rappresentata dal colpo di
mano dell'esercito tedesco nei confronti dell'esercito italiano28.
Senza entrare nel merito della complicata questione dei caratteri della «rinascita» (tra la permanenza
del «mito della Cristianità medievale», il ceppo cattolico-fascista dell’idea di nazione e la scoperta
della democrazia)29, va sottolineato il bisogno di ricondurre la scelta della Resistenza nelle categorie
tradizionali della legittimazione della guerra, di cui ancora nel suo libro del 1966 sulla Repubblica di
Montefiorino Gorrieri negherà il carattere di guerra civile30. Del resto, l’«antifascismo» dei giovani
modenesi era molto immaturo. Inoltre, era assente quella riflessione sulle responsabilità storiche
della Chiesa portata avanti, per esempio, da Giuseppe Dossetti con cui pure i modenesi erano in
contatto31. Come scrive Pavone: «La guerra civile renderà drammatico quello che per la maggioranza
dei cattolici italiani non aveva mai costituito un serio problema di coscienza, l’essere cioè insieme
cattolici e fascisti; svelando a un livello ancora più alto, il conflitto fra il rispetto del quinto
comandamento e l’uccidere in guerra, ora che bisognava uccidere altri italiani»32. Il «patriottismo»
permetteva ai modenesi di evitare la questione e di attestarsi su un antifascismo meno problematico
che accettava la lotta armata in assenza di un governo riconosciuto come legittimo e considerato, al
contrario, usurpatore. Questo intreccio di questioni – come spiega anche Massimo Storchi – avrà
27 (Quasi) un’autobiografia. L’ultima intervista di Ermanno Gorrieri, a cura di P. Trionfini, Modena, I Quaderni del Ferrari,
2007, p. 18. 28 Citazione tratta da P. Alberghi, Le origini della Democrazia cristiana modenese, cit. p. 19. 29 Nel novembre del 1943 Gorrieri (conosciuto con il nome di battaglia di Claudio) veniva nominato rappresentante della
Dc nel Comitato militare del Cln; nel mese seguente si tenevano le prime riunioni per l’elaborazione della linea del partito,
ma sarà necessario attendere la fine della primavera del 1944 per trovare i primi veri documenti programmatici, dopo che
avevano cominciato a circolare le Idee ricostruttive della Democrazia Cristiana di Demofilo (Alcide De Gasperi). 30 E. Gorrieri, La Repubblica di Montefiorino. Per una storia della Resistenza in Emilia, Bologna, Il Mulino, 1966, p.
712. 31 Sui contatti con Dossetti cfr. E. Galavotti, Il Professorino. Giuseppe Dossetti, tra crisi del fascismo e costruzione della
democrazia, Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 135-151. Su Dossetti partigiano, Ibidem, pp. 171-251. Sulla Chiesa modenese
e il fascismo Gorrieri scriverà alcune pagine molto caute, soprattutto circa il vescovo Cesare Boccoleri, di cui era nota la
vicinanza al fascismo. Repubblica di Montefiorino, cit., pp. 225-233. Cfr. P. Trionfini, Esperienze e aspettative dei
cattolici emiliani tra guerra e Resistenza (1940-1945), in Cattolici e Resistenza nell’Italia settentrionale, a cura di B.
Gariglio, Bologna, Il Mulino, 1997, pp.199-276. 32 C. Pavone, Una guerra civile, cit., p. 281.
8
ovviamente delle ripercussioni sul modo di combattere33.
Non è questa la sede per soffermarsi sulle vicende della Repubblica di Montefiorino. Come è
noto, l’intero svolgimento della Resistenza ha rappresentato per i cattolici una palestra politica dai
risultati, si è detto, non necessariamente unidirezionalmente in favore della Dc. In Emilia dove, a
differenza di altre zone di guerra come la Lombardia o il Friuli, i cattolici erano in netta minoranza,
l’identità democristiana era più forte e si andava specificando una modalità di combattere dai caratteri
fortemente politico-religiosi. I punti di conflitto con le forze comuniste (il comandante Davide,
Osvaldo Poppi) sono noti: la presenza dei commissari politici, la mancata separazione nelle zone
libere della gestione amministrativa da quella militare, il peso economico da esercitare sulle
popolazioni montane e quindi la critica al modello della Resistenza di massa: il trattamento dei
prigionieri e i rischi a cui venivano sottoposti i civili da certe operazioni. Tutti questi aspetti – in parte
riconducibili alla ricerca di un «uso non colpevole delle armi» perché garantito dalla copertura di un
esercito simil-regolare (Pavone) – sono trattati con dovizia di particolare nella ricostruzione storica
di Gorrieri che presenta come un successo della propria parte la progressiva «umanizzazione» della
Resistenza operata dalle Brigate Italia34. Scrive Gorrieri: «Non c’è dubbio sulla maggiore efficacia
del tipo di lotta sostenuto dai comunisti mentre dal punto di vista del costo umano è certo che esso fu
più elevato proprio a causa della impostazione comunista che accettava senza riserve il carattere
imposto dai fascisti alla guerra civile»35. Particolarmente drammatiche sono le pagine dedicate alle
stragi nazi-fasciste di Monchio, Susano e Costrignano: una conferma di quanto sopra sostenuto circa
la «guerra ai civili» e la «disumanizzazione» del conflitto come fattori di legittimazione di una
risposta armata, ma eticamente accettabile36.
Concludendo su questo punto, si può dire che il cuore della Resistenza (estate ’44-aprile ’45)
è stato il momento in cui i cattolici modenesi, ma la considerazione si potrebbe estendere anche ad
altri scenari (il reggiano di Dossetti oppure il friulano37), hanno vissuto lo scontro tra due moralità
della guerriglia entrate progressivamente in contrasto. Il punto di rottura – spiegabile anche sulla base
33 Scrive Storchi: «Il reale discrimine si pone sull’accettazione e l’uso della violenza come forma legittima di
partecipazione alla guerra. Il confronto, che torna più volte nella memoria dei testimoni (ma significativamente assai
meno nella documentazione ufficiale) è una fra un’accettazione quasi automatica delle necessità del “gioco” bellico da
parte comunista e un percorso molto più sofferto, per comprensibili motivi ideologici di quanti da parte cattolica non solo
non potevano condividere la strategia di guerra “totale” ma neppure l’atteggiamento morale nei confronti del nemico».
M. Storchi, Combattere si può vincere bisogna. La scelta della violenza fra Resistenza e dopoguerra (Reggio Emilia
1943-1946), Venezia, Marsilio, 1998, p. 43. Una paretesi ulteriore andrebbe aperta, a questo proposito, sul ruolo svolto
da una parte clero (e poi dai Cappellani parigiani) nel «rassicurare» dal punto di vista pastorale i combattenti: si pensi a
figure note alla storiografia come don Elio Monari e mons. Carlo Dondi. Su Monari si veda la ricostruzione-testimonianza
di L. Paganelli, Don Elio Monari e chiesa e società nella guerra e nella Resistenza 1940-1945, Modena, Mucchi, 1990. 34 M. Marchi, Una democrazia da costruire, in Ermanno Gorrieri, cit., pp. 163-187. 35 E. Gorrieri, La Repubblica di Montefiorino, cit., p. 292. 36 Ibidem, pp. 168-175. 37 Cfr. M. Storchi, Combattere si può vincere bisogna, cit., pp. 44-53.
9
delle preoccupazioni politiche circa i rapporti di forza per il dopoguerra– si verificherà nei giorni
dell’insurrezione e di quella che Mirco Dondi definisce la «lunga liberazione»38. Come si è detto, alla
spalle c’era un modo diverso di interpretare la lotta partigiana, ma anche uno schema secolare di
controllo teologico-politico della violenza e della resistenza (da Agostino e Tomasso fino alle
discussioni in età moderna) evidentemente estraneo alla cultura comunista. Certo, nel caso del gruppo
di Gorrieri, per esempio, la dimensione strettamente «teologica» e la casistica della «guerra giusta»
non emergono in quanto tali. Eppure, si può probabilmente leggere nel modello militare della «guerra
patriottica» dei modenesi una traduzione di quel bisogno di vivere «cristianamente» e legittimamente
la guerriglia che i partigiani cattolici, in questo non diversamente dai comunisti (se non per i principi
ispiratori), riconducevano al loro progetto di società futura (oltre ovviamente che al bisogno, anche
questo condiviso da ambo le parti, di conservare una «rispettabilità» da spendere nella trattativa con
gli Alleati). Nel passaggio dalla violenza praticata a quella «subita» la forbice culturale con i
comunisti si allargherà ulteriormente.
Dall’insurrezione alla guerra civile strisciante
Descrivendo l’insurrezione, Pavone parla dell’acme della «resa dei conti». L’esplosione di violenza
avvenuta in quei giorni cruciali – scrive lo storico – portava allo scoperto «l’esasperazione accumulata
in venti mesi con uno sfogo che, se era legittimato dalla vittoria, la vittoria stessa poteva in breve
tempo far scivolare sul terreno della mera e scomposta vendetta»39. Non è questa la sede per proporre
una sintesi delle diverse posizioni dei partiti per contenerne e, nello stesso tempo, sfruttarne la forza40.
Basti dire che era diffusa la convinzione che la giustizia avrebbe dovuto svolgersi in fretta per evitarne
un rapido insabbiamento e sotto controllo. Sullo sfondo c’era il tema dell’inserimento dei partigiani
nelle forze regolari dell’esercito e di polizia.
Tornando alla violenza spontanea, alla vigilia dell’insurrezione era chiaro a tutti che non
sarebbe stato possibile mantenere un effettivo controllo, nonostante i regolamenti emanati dal Clnai.
Lo dimostra anche solo il fatto che le forze di polizia erano quelle partigiane. Per non parlare dell’alto
livello di delinquenza comune che rende in molti casi impossibile distinguere la violenza politica
delle vendette private e da gesti criminali di altra natura. L’Emilia-Romagna, la terra del cosiddetto
«triangolo della morte» (originariamente quello modenese fra Castelfranco, Piumazzo e Manzolino e
38 M. Dondi, La lunga liberazione. Giustizia e violenza nel dopoguerra italiano, Roma, Editori Riuniti, 1999. 39 C. Pavone, Una guerra civile, cit., p. 506. 40 Sui processi cfr. H. Woller, I conti con il fascismo. L’epurazione in Italia 1943-1948, Bologna, Il Mulino, 2008. Sulla
continuità delle istituzioni cfr. C. Pavone, La continuità dello Stato. Istituzioni e uomini, in Alle origini della Repubblica,
Torino, Einaudi, 1995, pp. 70-159.
10
poi genericamente esteso dai media all’intera regione), risulta tra le zone più interessate dal fenomeno
con 2400 delitti denunciati ai carabinieri tra il 25 aprile 1945 e il 21 ottobre 194641. Il gruppo di
Gorrieri era coinvolto direttamente nella questione, tanto in quanto componente del Cln quanto, come
si dirà, come parte lesa.
Nel già citato Savage Continent, Keith Lowe suggerisce tre categorie principali di obiettivi
della violenza politica: le forze di polizia, gli agrari e i dirigenti industriali42. Questa categorizzazione
mette giustamente in rilievo quella duplice dimensione del fenomeno (politica e di classe), rilevata
anche da Crainz il quale la inserisce nel solco dei conflitti politico-economici che hanno attraversato
la storia della regione. La ripresa delle lotte mezzadrili e la giustizia post-bellica dei partigiani –
spiega lo studioso – assumevano al proprio interno le dinamiche della vendetta per la guerra civile e
per i fatti degli anni Venti e del successivo ventennio43. Tuttavia, come emerge dalle due ricerche di
Massimo Storchi sull’immediato dopoguerra nel modenese e nel reggiano, i dati a disposizioni
evidenziano una netta prevalenza tra i caduti di dirigenti del Pfr e, in misura minore, di comandanti
dei corpi armati di Salò (Gnr, Brigata Nera, X Mas)44. Nel modenese i giorni della «grande ira»
(giugno 1945) si erano conclusi con 48 casi di morte violenta che si sommano ai 91 del mese
precedente. Già il 26 aprile, a quattro giorni dalla liberazione, era stato diramato un appello a firma
di Coppi e Arturo Galavotti contro la giustizia sommaria. Lo stesso aveva fatto il sindaco comunista
e ex-partigiano Alfeo Corrassori, ma sarà direttamente Togliatti, di passaggio da Modena il 18
maggio, a ribadire la posizione del partito per la difesa dell’ordine pubblico e l’unità delle forze
antifasciste45. Per quanto riguarda la Dc, Storchi evidenzia giustamente come l’epurazione rientrasse
tra gli obiettivi più immediati delle componente di sinistra guidata da Gorrieri. Diverso invece era
l’atteggiamento assunto di fronte alla giustizia sommaria, soprattutto alla luce di alcuni episodi di
sangue che colpivano direttamente il mondo cattolico.
Se già durante la guerra si erano verificati in tutta la penisola numerosi attentati mortali ai
danni del clero, e in particolare di quei parroci che si erano mostrati collusi con il regime, le violenze
del dopoguerra assumevano un segno diverso. In maggio erano stati assassinati don Giuseppe Preci
e don Giuseppe Tarozzi. In giungo si verificava quella che Dondi definisce la prima serie di omicidi
«eccellenti»: don Giovanni Guicciardi (Lama Mocogno), Emilio Missere, membro democristiano del
Cln di Medolla, Bruno Lazzari, esponente Dc del Cln di Nonantola. Si tratta di personalità non legate
41 M. Dondi, La lunga liberazione, cit., pp. 91-101. 42 K. Lowe, Savage Continent, cit., pp. 43 G. Crainz, L’ombra della guerra, cit., p. 105. Dello stesso autore, Il conflitto e la memoria. «Guerra civile » e «triangolo
della morte», in «Meridiana», n. 13, gennaio 1992, pp. 17-55. 44 M. Storchi, Combattere si può vincere bisogna, cit., p. 109. Su Reggio Emilia nell’immediato dopoguerra si veda anche
G. Magnanini, Dopo la liberazione: Reggio Emilia, aprile 1945-settembre 1946, Analisi, 1992. 45 Idem, Uscire dalla guerra. Ordine pubblico e forze politiche. Modena 1945-1946, Milano, Angeli, 1995, pp. 24-44.
11
al mondo del fascismo e in alcuni casi coinvolte direttamente nel processo resistenziale. Il 27 luglio
a Reggio Emilia cadeva in un agguato Arnaldo Vischi, vicedirettore delle officine «Reggiane».
Questo caso, insieme a quello dei due Rizzi (padre e figlio) dei quali era noto l’antifascismo (il figlio
Ettore aveva preso parte alla Resistenza nelle Brigate Italia), scuoteranno l’atmosfera innalzando
sensibilmente il livello dello scontro46. Va letto in questa cornice l’atteggiamento assunto dalla Dc di
Gorrieri, ancora una volta segnato dal problema di una legittimazione e, in questo, caso di una
delegittimazione di una violenza di cui non si voleva essere partecipi, la giustizia sommaria contro il
nemico, e rispetto alla quale occorreva reagire con fermezza per evitare il rischio di essere coinvolti
in una (nuova guerra) civile
In uno dei suoi primi volantini, prodotto subito dopo il 25 aprile, dal titolo Rivoluzione di
sangue? NO grazie, la Dc ricordava alla cittadinanza che:
Le rivoluzioni e i rapporti di violenza tra partiti non fanno che accrescere malanni e distruzioni agli uomini e alle cose.
La rivoluzione non sarebbe che la continuazione della lotta fratricida iniziata dal fascismo.
A questo volantino facevano seguito due manifesti della Brigata Italia. Il primo, dal titolo Insomma,
denunciava il clima di intolleranza instaurato da «un qualche partito» che voleva tornare ai metodi
usati del fascismo; il secondo, Veniamo ai fatti, uscito pochi giorni dopo, si scagliava invece contro
le inefficienze della polizia e la lentezza del processo di epurazione47. Il Pci veniva direttamente
chiamato in causa:
Vedremo se quelli che sui manifesti si proclamano partiti d'ordine interverranno per fare luce e procedere con esemplare
severità contro i sabotatori della libertà. (...). Noi non taceremo perché, nonostante tutto, siamo ancora degli antifascisti e
contro il fascismo continueremo a lottare anche se questo vorrà dire per qualcuno di noi una fucilata a tradimento nella
schiena. Non abbiamo avuto paura delle fucilate dei fascisti in camicia nera, non avremo paura neppure di quelle dei
fascisti senza camicia nera.
Il 30 giugno il quotidiano locale del partito «Democrazia» tornava così sul problema:
I comunisti cercano – in perfetta malafede – di ingenerare la persuasione che il nostro sia in sostanza il partito degli
sfruttatori, delle sanguisughe del popolo, dei reazionari che tentano di incrinare l'unità dei lavoratori (...) Noi diciamo loro
con tutta franchezza che, se esula dal nostro pensiero (e dai nostri manifesti) l'intenzione di far risalire ai dirigenti della
Federazione comunista la responsabilità dei delitti e delle violenze che lamentiamo, non ci sembra tuttavia che essi
agiscano con l'energia che sarebbe necessaria. È opinione diffusissima che se il PCI si impegnasse a fondo nella difesa
dell'ordine e della legalità, le cose nella nostra provincia andrebbero assai meno peggio (...). Perché infiniti sono gli atti
46 M. Dondi, La lunga Liberazione, cit., pp.167-170. 47 P. Alberghi, Le origini della Democrazia cristiana modenese, cit., pp.62-64.
12
che vengono compiuti in dispregio dell'ordine e della legalità da elementi che sono o si dicono comunisti, compresi tra
costoro anche persone che rivestono funzioni pubbliche.48
Come si evince da questo testo, i dirigenti democristiani si mostravano consapevoli delle difficoltà
del Pci circa la gestione dell’ordine pubblico e del problema della divisone interna al partito di
Togliatti con l’area insurrezionalista, non priva a Modena di sostenitori. Circa la preoccupazione di
un nuovo conflitto, ne fornisce una prova l’intervento di Coppi alla prima assemblea del partito del
giugno 1945. Affermava il dirigente democristiano: «dopo la burrasca le onde si quietano lentamente;
ma, tanto concesso, è pur d’uopo riconoscere che i fatti lesivi del principio di libertà più che scrosci
d’acqua, sembrano prodromi di un temporale che sta per scatenarsi»49. Negli stessi giorni di giugno
– osserva Storchi – in rispondenza alla circolare di De Gasperi, la Dc ritirava i propri rappresentanti
dalle organizzazioni di massa e in novembre approvava un odg che chiedeva un intervento dello Stato
centralr50. Siamo nel pieno di quella che Dondi chiama la «fase inerziale della violenza», alimentata
dalle incertezze della giustizia istituzionale, quella del disarmo, ancora caratterizzata dal punto di
vista simbolico dal ricorso alla pratica resistenziale della «doppia morte» (con la sparizione dei
cadaveri)51. La violenza tornerà a esplodere a anno nuovo nella fase della «violenza residuale e di
classe». Si accentuerà allora anche la polemica dei cattolici modenesi contro il Pci, accusato di
coltivare un progetto parallelo a quello ufficiale della «democrazia progressiva». Come reagire di
fronte a una guerra che ci voleva lasciare alle spalle? Sarebbe stato necessario riprendere le armi
contro l’alleato in montagna? Su quali profili di legittimità religiosa e politica impostare la nuova
stagione?
Legittimazione e delegittimazione della violenza (1946-1948): le linee di continuità
Innanzitutto bisogna sottolineare che il periodo che va dalla fine del 1945 all’autunno del 1946 è stato
un punto di passaggio fondamentale nell’immediato dopoguerra: la fine del governo Parri, il
referendum istituzionale e le elezioni per la Costituente, l’amnistia e l’intervento di Pio XII contro i
nemici della croce di Cristo. L’unità antifascista era alle ultime battute, a Modena in particolare. Qui,
dopo che la Dc si era già confrontata con le difficoltà elettorali delle amministrative, il secondo
congresso dell’aprile 1946 confermava Gorrieri segretario. Ai fini della nostra riflessione, è
48 Ibidem, p. 64. 49 M. Storchi, Uscire dalla guerra, cit., p. 40. 50 Si veda anche l’appello del vescovo Boccoleri, Non più delitti, pubblicato sul «Bollettino del clero» dell’aprile-maggio
1945, citato da M. Marchi, Una democrazia da costruire, cit., p. 189. 51 Cfr. M. Storchi, Combattere si può, cit., pp. 102-103; M. Dondi, La lunga Liberazione, cit., pp. 119-132. Sulla
simbologia della violenza vedi anche G. De Luna, Il corpo del nemico ucciso, Torino, Einaudi, 2006, pp. 179-190.
13
interessante soffermarci sul modo in cui al congresso il leader partigiano impostava il discorso sulla
violenza. Se già nei mesi precedenti era intervenuto per ribadire l’estraneità delle Brigate Italia dai
fatti di sangue, Gorrieri tornava a spingere sul medesimo tasto: la vergogna per quei combattenti che
stavano macchiando la bandiera della Resistenza. Vale la pena riportare un articolo su «Democrazia»
citato anche da Storchi:
Non è ancora venuto il tempo di scrivere la storia del periodo della lotta clandestina e degli avvenimenti intercorsi
nell’anno successivo alla liberazione. É probabile che gli storici dovranno ammettere che se il nostro paese non ha
conosciuto più gravi sciagure e forse dei tentativi rivoluzionari disastrosi, lo si deve proprio all’opera prudente e energica
degli uomini della Democrazia Cristiana, i quali spesso si sono trovati costretti a contrastare la isterica mentalità
rivoluzionaria. Il nostro successo in parte lo si deve senza dubbio al nostro atteggiamento altamente ricostruttivo dei
valori che stanno alla base di una società ordinata, libera e democratica, appunto perché tale, rispettosa dell’autorità dello
Stato e della Legge.52
Torna dunque il tema della rispettabilità dell’azione politica, compresa quella armata condotta nella
Resistenza, in contrapposizione alla violenza insurrezionale dei comunisti. Questa veniva condannata
con maggiore veemenza proprio nel momento in cui lo Stato si andava riorganizzando.
Dopo le elezioni per la Costituente e lo scandalo provocato dall’uccisione di don Pessina a
San Martino di Correggio, si era insediato il secondo governo De Gasperi. Contestualmente, anche in
risposta alle pressioni della Chiesa emiliana (il nuovo vescovo Beniamino Socche di Reggio Emilia,
per esempio), si rafforzavano le attenzioni del Ministero dell’Interno nei confronti dell’Emilia. Si
erano aperte le prime inchieste nazionali a opera delle due parti in causa: quella democristiana,
sviluppatasi a partire di un rapporto del partito locale, di cui Storchi evidenzia alcune infondatezze
da sindrome di accerchiamento: la presenza di emissari russi, l’esistenza di «camere della morte»,
ecc) e quella comunista, tendente a ridimensionare fortemente il fenomeno delle violenze, i cui
risultati vennero presentati da Mauro Scoccimarro nell’autunno del 194653. In settembre il governo
lanciava un’energica operazione repressiva con l’invio di uomini e mezzi in grado di coprire tutto il
territorio regionale.
Nel corso dell’operazione principale, effettuata dal 20 settembre al 9 dicembre, in Emilia
furono controllate 77.590 persone, compiute 18.886 perquisizioni personali e 2170 perquisizioni
domiciliari; gli arresti furono 101, le denunce 57, le persone fermate per accertamenti 328. Sono cifre
da guerra civile latente, che mostrano fino a che punto lo Stato fosse deciso a utilizzare il pugno di
ferro per riportare l’Emilia, «il Messico d’Italia», sotto controllo54. Non si può dunque che convenire
con Dondi quando scrive che i casi effettivamente riconducibili a motivazioni di odio religioso (il
52 M. Storchi, Uscire dalla guerra, cit., p. 134. 53 Ibidem, pp. 172-177. 54 Ibidem, p.163.
14
parroco Pessina) o politico non sono sufficienti per giustificare l’immagine che fu veicolata di una
democrazia assediata e da liberare. Nello stesso tempo, al di là del clima da campagna elettorale che
si farà sempre più acceso con l’approssimarsi del 18 aprile, con la ripresa delle lotte mezzadrili e
contadine e la fine ufficiale dell’unità antifascista, la percezione di essere alla vigilia di un nuovo
conflitto civile non può essere derubricata come una carta propagandistica. La ricostruzione di Marchi
ha mostrato i diversi passaggi che hanno portato gli ex-partigiani della Brigata Italia a riattivare una
struttura clandestina militare in grado di rendersi operativa in caso di colpo di Stato da parte delle
sinistre all’indomani dell’esito elettorale55. È stato ormai acclarato come preoccupazioni simili non
fossero estranee neppure ai vertici del partito e nella Santa Sede, approdata da poco, e non senza
scontri al proprio interno, all’appoggio alla Dc e al suo progetto democratico.
Tornando infine al nostro discorso sul punto di vista dei cattolici modenesi sulla violenza, si
può rilevare una sostanziale continuità di impostazione da parte del gruppo di Gorrieri tra la
Resistenza e il dopoguerra. A partire dal momento della scelta partigiana, i cattolici modenesi si erano
posti il problema di inserire l’opzione della Resistenza contro l’occupazione nelle categorie della
legittimazione della violenza: quelle afferenti al modello dell’esercito regolare. Come si è detto,
questa decisione aveva alle spalle un secolare bagaglio di riflessioni teologiche e politiche sulla
moderazione e la moralizzazione della violenza che avrebbero generato tensioni durante i giorni di
Montefiorino. Il carattere di guerra civile e il suo «di più» di violenza era stato negato dai parigiani
“bianchi”, pur dovendone accettare di fatto la realtà e quindi non senza omertà e contraddizioni.
L’atteggiamento da assumere verso la giustizia sommaria del dopoguerra non poteva che essere
conseguenziale. L’idea di una contrapposizione tra due morali, avanzata dai protagonisti di parte
cattolica, non può evidentemente essere accettata come tale e risente della contrapposizione
ideologica dell’epoca: la stagione dei Comitati civici di Luigi Gedda e poi della scomunica dei
comunisti. A giudizio di chi scrive, sembra però che manchi ancora uno studio di più lunga durata
della mentalità dei cattolici verso la violenza: un problema affrontato da Pavone sul piano politico-
istituzionale (il «vuoto istituzionale») e da leggere nel medio periodo del passaggio all’adesione al
regime fino alla gestione del dopoguerra. Allora, anche in reazione ai fatti di sangue che avevano
colpito il mondo cattolico, la preoccupazione di essere a rischio di un nuovo conflitto, questa volta
evidentemente interno alle componenti politiche nazionali, risulterà in continuità con la
sedimentazione delle tensioni in montagna e con la convinzione di trovarsi nel pieno di uno scontro
di civiltà che trovava nel rapporto con la violenza una delle sue manifestazioni più acute56. Come si
55 M. Marchi, M. Marchi, Una democrazia da costruire, in Ermanno Gorrieri, cit., pp. 228-230. 56 Anche se con accenti diversi, questa mancanza veniva già sottolineata da F. Traniello, Guerra e religione in Cattolici,
Chiesa, Resistenza, cit., pp. 31-106.
15
è cercato di mostrare, il caso modenese, caratterizzato da un alto livello di scontro e di elaborazione
teorica (contemporanea e successiva ai fatti), ci suggerisce su tutti questi aspetti alcune linee di ricerca
e di interpretazione da verificare nel confronto con altre esperienze di antifascismo cattolico post-
resistenziale.