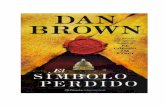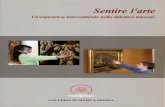Una Maison Forte del 1466: 'l Castel' a Pont-Saint-Martin (AO) da simbolo del potere a spazio...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Una Maison Forte del 1466: 'l Castel' a Pont-Saint-Martin (AO) da simbolo del potere a spazio...
Riuso e restauro degli edifici storici tutelati. Esperienze a confronto
Atti del convegno promossi da:
Associazione CulturaleRicerche Fortificazioni Altomedievali - Sezione di Trento
Ordine degli Architetti,Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Trento
Associazione culturale“Ricerche Fortificazioni Altomedievali” - Sezione di Trento
in cooperazione conOrdine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatoridella Provincia di Trento
in collaborazione conProvincia autonoma di Trento - Soprintendenza per i Beni Culturali
con il patrocinio diProvincia autonoma di TrentoComune di TrentoCastello del Buonconsiglio. Monumenti e collezioni provinciali
La pubblicazione raccoglie gli atti del convegno “Riuso e restauro degli edifici storici tutelati. Esperienze a confronto” tenutosi a Trento in data14 novembre 2014. In qualità di presidenti di giornata sono intervenuti l’arch. Michela Cunac-cia, l’arch. Cinzia D’Agostino e l’arch. Edoardo Danzi.Il convegno ha ottenuto il riconoscimento di n. 6 crediti formativi professionali - cod. ARTN20102014120028T03CFP00600 dal Consiglio Nazionale degli Archi-tetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.
atti a cura di: Giorgia Gentilinicuratela redazionale: Isabella Zamboni progetto grafico: Studio architetto Giorgia Gentilinirealizzazione grafica: Luana Gallazzini
Trento, novembre 2014
con il sostegno di: con il sostegno di:
In copertina: rappresentazione di Trento di Ludovico Sardagna de Hoenstein del XVII sec.
Il Forte di Cadine a Trento: progetto, restauro e riuso.Michela Favero
Restauro della casa del Capitolo in via Belenzani a Trento: storia di un cantiere tra ritrovamenti e scelte di intervento.Anna Bruschetti
Restaurare ciò che è quasi perduto. Note sul riuso a fini commerciali di Palazzo Nogarola-Guarienti a Trento: un restauro eseguito con bisturi, ruspe e condotte d’impianti.Manuela Baldracchi, Fabio Campolongo
Riuso, restauro e riqualificazione energetica: la rinascita di antichi masi abbandonati in Alto Adige.Klaus Ausserhofer
Recupero delle ex cavallerizze come nuovo ingresso del Museo nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano.Daniela Lattanzi
Il restauro di Villa Tomitano a Vellai di Feltre. La riscoperta e valorizzazione dell’antica casa-museo e la compatibilità con la nuova destinazione.Renata Daminato, Francesco Doglioni
Una Maison Forte del 1466: “L Castel a Pont-Saint-Martin” (Aosta) da simbolo del potere a spazio museale.Mauro Cortelazzo, Silvia Stroppa
5
15
29
51
67
85
99
Indice
Una Maison Forte del 1466: ‘l Castel’ a Pont-Saint-Martin (AO) da simbolo del potere a spazio museale.
Premessa1
Il restauro dell’edificio denominato “Grangia del Castello” o, più breve-mente e secondo consuetudine, ’l Castel, è stato voluto e finanziato dal Comune di Pont-Saint-Martin e dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta2. Il gruppo di professionisti incaricati per i lavori si è avvalso del supporto scientifico di altre figure tecnico-professionali, sia durante le lunghe e accurate fasi di indagini diagnostiche3, che hanno permesso di basare responsabilmente la progettazione su un solido bagaglio di conoscenze, sia durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori. La collaborazione tra gli amministratori locali, i progettisti e i funzionari dei diversi settori della Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali (archeologico, architet-tonico e storico-artistico), ha creato una sinergia d’intenti e di volontà propositiva che ha determinato il raggiungimento di un risultato estetico-formale coerente e rigoroso.
Destinato inizialmente ad accogliere un’intera collezione privata di scultura lignea, ’l Castel ha modificato e ampliato la prima ipotesi di uti-lizzo, durante il corso dei lavori, per divenire un centro museale atto ad ospitare esposizioni itineranti e d’arte contemporanea.
I caratteri del complesso L’articolato complesso architettonico denominato ‘l Castel, con le sue ri-levanze strutturali di epoca tardo medievale, sfugge oggigiorno a una immediata individuazione e, ancor più, all’agevole lettura dei suoi ca-ratteri arcaici. L’eterogeneo manufatto, risultato del fenomeno aggrega-tivo di vari corpi di fabbrica succedutisi nell’arco di vari secoli, si mo-stra totalmente assorbito dalla recente espansione urbanistica (fig. 1). La costrizione, all’interno di nuovi spazi cittadini, ha in larga misura con-fuso e sovvertito l’originario isolamento, la valenza simbolica e l’antico
Mauro Cortelazzoarcheologo libero professionistaSilvia Stroppaarchitetto libero professionista
Una Maison Forte del 1466: ‘l Castel’ a Pont-Saint-Martin (AO) da simbolo del potere a spazio museale. 99
1 Questo intervento è già stato og-getto in ambito locale di alcune pub-blicazioni AvAntey, Dufour, Grosso, stroppA 2007; prAmotton, stroppA 2012; De LA pierre, sArtorio, Cor-teLAzzo 2012: pizzi, ziDDA 2012. La redazione di questo testo è frutto di un lavoro comune tuttavia la stesura dei paragrafi 1, 6-13 si deve a Silvia Stroppa, mentre i paragrafi 2-5, 14 sono di Mauro Cortelazzo.
2 La Progettazione e la Direzione Lavori è stata affidata agli architet-ti Gabriele Grosso e Silvia Stroppa, affiancati dall’ing. Silvano Cheraz e dall’arch. Ferruccio Franzoia, invitato a collaborare in qualità di esperto in materia museale. All’archeologo dott. Mauro Cortelazzo è stato affidato, da parte del Comune, l’incarico di rea-lizzare un intervento propedeutico al cantiere di restauro volto a consegui-re un’analisi archeologico-stratigra-fica e una puntuale documentazio-ne conoscitiva grafica e fotografica dell’intero corpo di fabbrica.
3 La campagna di indagini diagno-stiche e analisi è stata operata sulle membrature lignee, sul corpo di in-tonaco, sulle malte di allettamento, sulle finiture, sulle pellicole pittoriche e sui serramenti, come verrà trattato più avanti specificatamente.
Fig. 1. ‘L Castel all’interno dell’odier-no tessuto urbano (foto Gabriele Grosso).
ruolo rurale. Ciò nonostante questo intervento ci ha permesso di riper-correre gli oltre cinque secoli che ci separano dalla sua edificazione e riannodare i lembi sfilacciati della sua sequenza evolutiva. L’intervento compiuto sull’edificio aveva come finalità l’elaborazione di una ricompo-sizione metodologica e tecnica, per offrire una nuova chiave interpretati-va, mediante accostamenti formali e planimetrici in associazione ai dati desunti dall’analisi archeologico-stratigrafica, e fornire, sia alla fase pro-gettuale che a quella esecutiva, un valido telaio di riferimento. Lo studio è stato altresì dilatato a considerare i caratteri peculiari di una particolare tipologia costruttiva accomunati sotto la definizione, allo stesso tempo generica e restrittiva, di “casaforte”. Per comprendere appieno le motiva-zioni di una nuova costruzione, le successive trasformazioni strutturali, gli ampliamenti e i cambi di destinazione d’uso, si è resa necessaria una ricomposizione, pur se parziale e basata quasi essenzialmente su mate-riale edito, delle vicende della casata dei Pont-Saint-Martin durante i suoi cinque secoli di vita. L’intreccio tra analisi del costruito, documentazione d’archivio e datazione dendrocronologica, ha fornito la puntualizzazione di alcuni decisivi nodi di ordine temporale attorno ai quali si sono in-tessute le diverse indicazioni e le varie considerazioni emerse anche a cantiere in corso. La storia del ‘l Castel è così stata foriera di stimoli per approfondire le logiche interne alla genesi e alla differenziazione delle tipologie strutturali e dei corredi architettonici che lo compongono.
Le datazioni dendrocronologicheLe analisi dendrocronologiche hanno costituito una discriminante d’in-dubbio valore nel determinare la corretta sequenza costruttiva dell’intero complesso4. Sono stati prelevati 29 campioni di cui 20 da sottoporre ad analisi dendrocronologica e 9 per l’identificazione delle specie vegetali (fig. 2)5. L’esame ha permesso di verificare come, trovandosi l’edificio collocato oltre che nel fondo valle anche nella porzione della Regione più prossima alla pianura, vi sia stato, necessariamente, un uso maggiore di specie vegetali legate a climi di bassa quota, da cui la forte presenza di castagno e di quercia rispetto al larice o più in generale alle resinose. Tuttavia l’impiego del larice in considerevole quantità con ritmi di cresci-ta molto eterogenei che indicano provenienze ecologiche diverse, testi-monia apporti che potrebbero essere frutto di abbattimenti non sempre predeterminati. Questi alberi arrivavano da diversi settori forestali, alcuni situati a bassa quota, cioè sotto i mille metri di altitudine, altri ad altezze più elevate. Il diverso spessore degli anelli, pur mantenendo lo stesso rapporto di crescita tra un anno e l’altro, dimostra un differente sviluppo vegetativo determinato dalla variabilità della quota altimetrica. Il larice, inoltre, è impiegato quasi esclusivamente per le grosse travature dei so-lai cui si associa l’abete rosso.
I prelievi dendrocronologici e le successive analisi hanno permesso di associare la sequenza evolutiva riscontrata attraverso l’osservazio-ne dei rapporti stratigrafici tra i vari elementi che compongono l’insie-me dei corpi di fabbrica, a datazioni di cronologia assoluta, favorendo l’interpretazione strutturale del complesso. Le sequenze dendrocrono-logiche ottenute dalle misurazioni delle travi presenti nella grande sala con camino al secondo piano che rappresenta l’ambiente principale del complesso, confermano una stretta sincronizzazione presentando una sequenza media di 79 anni e una datazione assoluta compresa tra il 1388 e il 1464. Due di queste travi, appartenenti allo stesso gruppo ma ricollocate in opera nella stanza a fianco, mostravano una leggera diso-
Riuso e restauro degli edifici storici tutelati. Esperienze a confronto.100
Fig. 2. Una fase dei prelievi dendro-cronologici eseguiti dal Laboratoire Romand de Dendrochronologie di Moudon - Vaud (CH). Carota del pre-lievo dalle travi in Larix decidua del salone principale (foto Silvia Stroppa).
4 I prelievi, le analisi e la produzio-ne del rapporto definitivo sono stati eseguiti dai tecnici del Laboratoire Romand de Dendrochronologie di Moudon – Vaud (CH), Jean Tercier e Jean-Pierre Hurni, Rapporto N. Ref. LRD09/R6301, conservato presso l’Archivio del Servizio Restauro e Valorizzazione della Soprintendenza della Regione Autonoma Valle d’Ao-sta. 5 Le specie vegetali riconosciute sono cinque: abete rosso (Picea Abies), quercia (Quercus sp.), larice (Larix decidua), castagno (Castanea sati-va) e pino silvestre (Pinus silvestris).
mogeneità cronologica, 1458 una e 1466 l’altra. Esse devono provenire da uno degli impiantiti della fase antica che furono smontati e ricollocati. La trave del 1466 in particolare consente di definire la data ultima di edifi-cazione della casaforte che, non a caso coincide con le vicissitudini della famiglia e con l’esistenza di documenti d’archivio6. Diversamente la forte preponderanza di travi appartenenti ad alberi abbattuti nel 1464 (il 65% tra quelle analizzate), permette di determinare il momento in cui prese avvio la costruzione della casaforte. Le travi dovevano essere poste in opera subito dopo il taglio in modo tale da facilitare i lavori di carpente-ria, quali decortecciamento, riquadratura e intaglio di eventuali incastri, ed evitare possibili deformazioni dovute all’essicazione. La presenza di elementi più tardi va quindi letta come un semplice protrarsi nella fase edificatoria di alcune parti. La stessa datazione è inoltre assegnabile alla loggia lignea le cui travi portanti, essendo perfettamente inglobate nella muratura, consentono di attribuire una precisa contemporaneità tra strut-tura in pietrame ed elementi lignei di carpenteria.
Lo studio stratigrafico-strutturale del complesso ha determinato per i corpi fabbrica collocati a ovest e nell’angolo a sud-est, un rapporto di posteriorità rispetto al blocco centrale e le datazioni dendrocronologiche lo hanno confermato. Se per la porzione a ovest mancano elementi che possano essere datati con precisione, diversamente all’ultimo piano del corpo a sud-est, un soffitto ligneo costituito da un considerevole numero di travetti, per la maggior parte realizzati con legname di larice, a ecce-zione di un elemento di castagno e uno di pino silvestre, ha fornito una cospicua serie di datazioni tutte riconducibili a un’unica data: 1603. Le sequenze ottenute misurando gli elementi in larice, hanno stabilito che gli alberi abbattuti avevano un’età media di 85 anni e che tale sequenza poteva essere datata in assoluto tra gli anni 1516 e 1600. Tuttavia la pre-senza dell’anello sotto corteccia in uno di questi travetti ha permesso di stimare la data di abbattimento al 1603 e in base all’omogeneità mostrata dalle curve di crescita, di poterla associare anche a tutti gli altri elementi. I successivi rifacimenti delle pavimentazioni e l’impiego di abbondante legname di castagno, non hanno consentito di verificare ulteriormente tale datazione e soprattutto di stabilire a quali momenti potevano essere associate le altre trasformazioni dell’edificio. In ogni caso le datazioni ricavate coincidono con momenti fondamentali della vita familiare di que-sta casata permettendoci di riconoscere specifiche congiunture econo-miche e politiche che hanno concorso a intraprendere l’avvio dei lavori.
L’evoluzione strutturale: da fortificazione rurale a residenzaL’impianto primitivo del ‘l Castel, databile su base dendrocronologica, alla metà degli anni sessanta del ‘400 (1464-66), è riconoscibile nel poderoso blocco centrale di forma rettangolare (fig. 3). Il suo sviluppo verticale è ri-levabile tramite la chiara evidenza dei conci di maggiori dimensioni leggi-bili su ognuno dei quattro angoli. L’edificio doveva svilupparsi su più piani compreso il vano seminterrato (fig. 4). Questo spazio, servito da un’am-pia apertura a tutto sesto e da una scala in pietra che portava all’interno, doveva essere utilizzato come magazzino o locale per la lavorazione di prodotti agricoli. L’ingresso posto sul lato est, di maggiori dimensioni, era stato concepito per facilitare il passaggio di derrate o attrezzature. La volta a botte in blocchetti di pietrame determinava un’altezza interna del vano di circa 4 m.
Lo sviluppo dei piani superiori ci permette di comprendere come questo edificio fu a suo tempo progettato prevedendo per alcune sue
Una Maison Forte del 1466: ‘l Castel’ a Pont-Saint-Martin (AO) da simbolo del potere a spazio museale. 101
6 CoLLiArD 1979, pp. 16-23; De tiLLier 1970; niCCo 1997, pp. 33-60.
Riuso e restauro degli edifici storici tutelati. Esperienze a confronto.102
Fig. 3. Individuazione del blocco strutturale del 1466, prospetti (rilievo Gabriele Grosso - Silvia Stroppa, ela-borazione grafica Mauro Cortelazzo).
A pagina seguente Fig. 4. Fasi evolutive del comples-so, piante e sezioni (rilievo Gabriele Grosso - Silvia Stroppa, elaborazione grafica Mauro Cortelazzo).
parti un carattere residenziale. Lo dimostra l’articolazione dei piani pavi-mentali che vedono l’esistenza di un camino con relative cappe fumarie, sia al primo piano (oggi scarsamente leggibile) sia al secondo, dove esi-ste ancora un camino profondamente trasformato e ridotto nel XVII seco-lo. I primi due piani, ma in misura maggiore il secondo, rappresentavano gli ambienti nobili mentre il terzo, corredato da piccole finestre con sedili, è riferibile a un utilizzo caratterizzato da requisiti più modesti. Dell’origi-nario impianto quattrocentesco rimane oggi la travatura del soffitto del
Una Maison Forte del 1466: ‘l Castel’ a Pont-Saint-Martin (AO) da simbolo del potere a spazio museale. 103
Riuso e restauro degli edifici storici tutelati. Esperienze a confronto.104
secondo piano, costituita da cinque elementi nord-sud con venti travetti perpendicolari su cui poggia l’assito del piano superiore, frutto di un ac-curato lavoro di carpenteria lignea (fig. 5). La travatura principale che compone questo soffitto è stata realizzata utilizzando del legno di larice a eccezione di un elemento in abete rosso, mentre i travetti perpendicolari e le tavolette del cassettonato sono di castagno. Questo solaio sem-brerebbe aver subito un completo smontaggio e successivo rimontaggio durante l’edificazione del corpo occidentale (datato dendrocronologica-mente al 1603). Alcune tracce visibili sull’intonaco permettono di stabilire che questo fu rialzato di una ventina di cm e non si esclude che la parte cassettonata possa appartenere a questa nuova fase. Sarebbero state mantenute le cinque travi principali in larice mentre i travetti perpendico-lari e le tavolette che racchiudono lo spazio fra travetto e travetto e la mo-danatura di collegamento, in castagno, potrebbero essere state eseguite in un secondo momento.
Questi ambienti risentono, soprattutto per ciò che concerne le fi-nestre, di importanti trasformazioni avvenute durante l’edificazione del corpo seicentesco. Le antiche aperture furono, in quell’occasione, for-temente modificate e ampliate con l’inserimento di nuovi varchi sul lato ovest per garantire comunicazione tra i due edifici. La traccia riportata in luce, attraverso i sondaggi stratigrafici sugli intonaci, ha consentito di individuare, in modo parziale, le dimensioni di una delle finestre originali. Si tratta di varchi di entità ridotta caratterizzati da una forte strombatura, che determina una dimensione delle aperture verso l’esterno molto con-tenuta (fig. 6). Questa caratteristica consente di evidenziare il carattere di arcaicità dimostrato da alcune soluzioni architettoniche adottate nella fase edilizia quattrocentesca, come le finestre, molto piccole, o le apertu-re che testimoniano scelte costruttive tutt’altro che innovative.
Sul fronte est la piccola apertura posta lateralmente, caratterizzata da stipiti in lastre di pietra e da un architrave litico di considerevoli dimen-sioni, doveva rappresentare uno degli ingressi principali e dava accesso all’ambiente di maggiore importanza. A quest’apertura si doveva accede-re con ogni probabilità attraverso una scala lignea addossata all’esterno alla parete est che saliva dall’ingresso con arco a tutto sesto del primo piano. La limitata ampiezza di questo varco trova una sua corrisponden-za con quanto osservato per le finestre della stessa fase costruttiva. Con
Fig. 5. Travatura del soffitto in larice del salone principale prima dei lavori (foto Mauro Cortellazzo).
Fig. 6. Dettaglio relativo al sondag-gio che ha evidenziato la dimensione delle piccole finestre originali (foto Mauro Cortellazzo).
Una Maison Forte del 1466: ‘l Castel’ a Pont-Saint-Martin (AO) da simbolo del potere a spazio museale. 105
ogni probabilità la volontà doveva essere quella di realizzare un edifi-cio dai connotati tendenzialmente militari basandosi su caratteri esteriori per fargli assumere l’aspetto di torre castrense. Un altro elemento che contraddistingue questo livello abitativo come piano nobile, caratteristica che conserverà anche nella trasformazione cronologicamente succes-siva, è la presenza di un’altra piccola apertura con arco a tutto sesto, collocata nell’estremo angolo sud della parete ovest. Questo elemento, che presenta uno spazio d’ambito ricavato nello spessore di muro, dove-va condurre a una latrina posizionata in aggetto rispetto alla parete. Con la costruzione seicentesca, la latrina fu eliminata e lo spazio d’ambito trasformato in un armadio a muro sfruttato poi fino a epoca recente e liberato con relativa stamponatura in occasione dell’attuale intervento di riqualificazione. Di ciò che doveva contraddistinguere la parte aggettante della latrina non rimane più nulla, così come non è stato possibile verifi-care l’eventuale presenza di tracce delle mensole, o delle buche relative all’inserimento nella parete, a causa della volta più tarda che copre que-sta porzione di tessitura muraria. Un ulteriore elemento riconducibile alla prima fase costruttiva dell’edificio è il ballatoio che prospetta sul lato sud. Anche in questo caso le analisi dendrocronologiche hanno permesso di stabilire che il legname utilizzato per la sua messa in opera appartiene a larici abbattuti nel 1464. Le travi che reggono l’assito sono perfettamente inglobate nella muratura e recano traccia nella parte inferiore di intagli nei quali si inserivano le saette collocate inferiormente che garantivano una maggiore robustezza all’insieme e una migliore tolleranza di carico.
Il blocco strutturale del Quattrocento, quindi, doveva presentarsi come un poderoso parallelepipedo articolato su quattro livelli, costruito in muratura e ricoperto da un intonaco grezzo che occultava quasi com-pletamente la tessitura in pietrame. La parte superiore era incorniciata da una balconata lignea che probabilmente risvoltava in parte sui due angoli est e ovest. Una serie di piccole aperture e di finestre assicurava accessi e illuminazione interna, con i due ingressi principali, quello al vano inter-rato e quello al piano nobile, collocati sul lato est. La comunicazione tra i vari piani doveva essere assicurata in massima parte da scale lignee esterne. L’edificio era stato progettato per gravitare a livello di aperture e ballatoi verso la fronte meridionale, mentre il lato nord doveva esserne privo ad eccezione di una piccola finestra all’ultimo piano. Nella fase di primo impianto della struttura il probabile assetto territoriale, debolmente o per nulla edificato, doveva certamente accentuarne la sua verticali-tà facendola apparire come torre isolata. Un corpo architettonico che si configurava quale riferimento visivo e topografico con una forte conno-tazione materiale all’interno di un paesaggio rurale. Una tipologia edili-zia che pur mantenendo un’intrinseca potenzialità difensiva non veniva meno sia a esigenze abitative sia a necessità più strettamente agricole. L’edificio, all’interno dell’ambiente geografico relativo alla piana di Pont-Saint-Martin, tendeva a ribadire prerogative giurisdizionali e istituzionali, rafforzando quel concetto spaziale e mentale di possesso del territorio.
La considerevole trasformazione architettonico-strutturale che av-viene nei primi anni del XVII secolo (1603), con l’edificazione del corpo di fabbrica a ovest e di un vano scalare a est, modifica radicalmente l’assetto dell’edificio quattrocentesco. L’aggiunta di questi blocchi struttu-rali viene ad avere profonde ripercussioni anche sull’insieme strutturale preesistente, poiché nel corso di quest’operazione sono modificati quasi tutti i piani pavimentali. L’idea di connotazione difensiva, determinata dal contenuto sviluppo delle aperture, è in buona parte persa a vantaggio della volontà di accentuare requisiti di tipo residenziale. Come hanno
Riuso e restauro degli edifici storici tutelati. Esperienze a confronto.106
dimostrato i saggi stratigrafici compiuti sugli intonaci, in tale occasione sono profondamente modificate anche le finestre che sembrerebbero ampliate e disassate rispetto alla loro posizione originaria ma certamente più centrate rispetto alla volumetria del locale. La volontà è di creare un amalgama totale tra i due corpi unificando le quote pavimentali e age-volando, tramite la realizzazione di nuovi e più ampi passaggi, i percorsi interni. Le caratteristiche residenziali di questa nuova costruzione sono accentuate dalla presenza di grandi camini e dalla volontà di prevedere, già in fase costruttiva, l’inserimento di un corpo aggettante posato su grossi mensoloni in pietra sulla fronte ovest, avente la funzione di pic-cola cappella (fig. 7). La qualità architettonica riservata a questo piccolo volume in fase costruttiva è evidente nella scelta dei materiali e nelle pitture interne che lo rivestono (fig. 14). L’opzione di creare un elemento sporgente rispetto alla linea di facciata, già evidentemente prevista in fase progettuale, aveva due prerogative: da un lato permettere un ade-guato isolamento che consentisse la raccolta in preghiera in un ambiente dedicato e dall’altro non occupare uno spazio all’interno del vano la cui presenza avrebbe necessitato una complessa articolazione degli spazi. Il ciclo di pitture portato in luce a seguito della rimozione di tutte quelle parti che ne avevano mutata la funzione trasformandolo ai giorni nostri in servizio igienico, quali piastrelle e sanitari in ceramica (fig. 13), con-sente di restituire la corretta valenza qualitativa dell’edificio (infra par. La
Fig. 7. La cappella seicentesca ag-gettante sul lato ovest, posata su grandi mensoloni (foto Mauro Cortel-lazzo).
Una Maison Forte del 1466: ‘l Castel’ a Pont-Saint-Martin (AO) da simbolo del potere a spazio museale. 107
scoperta). La presenza di questo ciclo, così come dello stemma nobiliare ritrovato sopra la cappa del camino al secondo piano (fig. 17), denota la sensibilità dei proprietari nel corredare gli spazi interni di elementi deco-rativi in linea con la scelta di edificare una residenza di un certo prestigio. Di fatto questa nuova fase edilizia coinvolge anche il blocco strutturale presente a sud-est, costruito in appoggio all’edificio quattrocentesco. No-nostante le numerose e radicali trasformazioni interne subite da questo corpo, la sua edificazione sembrerebbe riconducibile alla necessità di collocarvi all’interno un vano scalare. Le dimensioni di questo vano sono molto contenute, inoltre l’altezza e la posizione delle aperture non paio-no adattarsi a locali di uso abitativo. Proprio lo sviluppo in altezza e la posizione d’angolo costituiscono caratteristiche che meglio si adattano a una struttura di servizio nella quale potevano facilmente trovare posto le rampe che dovevano consentire la comunicazione tra i vari piani (fig. 8). Un altro elemento che può essere rilevato a favore dell’ipotesi che que-sto corpo di fabbrica debba essere considerato un vano scalare, viene dall’osservazione della posizione delle aperture. Le finestre si trovano, per quanto rimaneggiate, tutte sul lato verso est. Il lato verso sud pre-senta una colombaia e una sola piccola finestrella nella parte terminale. Su questo lato, essendo quello più lungo, dovevano appoggiarsi all’in-terno le rampe, e le finestre illuminare i pianerottoli a est. Negli altri due corpi, quello quattrocentesco e quello presente sul lato occidentale con la cappella aggettante, non si sono rinvenute tracce di appoggi di scale. L’unica oggi esistente, di realizzazione molto tarda e trasformata nell’at-tuale scalone d’ingresso, si trova al centro del lato est edificata succes-sivamente rispetto a un altro corpo di fabbrica nell’angolo a nord-est. Nella costruzione di questi due nuovi corpi seicenteschi, quello a ovest e il probabile vano scalare a sud-est, venne previsto in tutta la porzione inferiore un semplice addossamento rispetto alla struttura preesistente, mentre nella parte superiore si realizzò una sovrapposizione e quindi uno scavalcamento delle murature, inglobandole. Tale scelta ebbe come conseguenza il completo rifacimento delle coperture e proprio in questa fase molti degli elementi lignei che dovevano appartenere alla carpente-ria del blocco primitivo furono reimpiegati. Tale attività è stata evidenziata dalla misurazione degli anelli delle travi e dalla presenza degli intagli antichi adattati alla nuova sistemazione. Due delle sette travi prelevate datano al 1464 e l’insieme strutturale che regge il tetto è il risultato di vari elementi in larice e castagno. Stessa sorte subirono anche i livelli pavi-mentali ad eccezione del soffitto del secondo piano che, pur se rialzato di una ventina di centimetri, fu ricomposto con la stessa travatura forse per mantenere quel valore d’insieme che la sala doveva già possedere e che la nuova risistemazione doveva confermare, impreziosendola con lo stemma nobiliare sul camino (fig. 17).
Gli ultimi interventi costruttivi hanno interessato, oltre a vari riadat-tamenti interni che si sono protratti fino a tempi molto recenti, l’edifica-zione in un periodo anteriore al 1702 del corpo a nord-est. Quest’ultimo costituisce, sotto l’aspetto architettonico, l’elemento speculare rispetto al corpo scalare dell’inizio del XVII secolo. La sua presenza determinerà in seguito la creazione di una nuova rampa di scale proprio nello spazio venutosi a creare tra i due blocchi. In questa porzione la presenza della scala determinerà la completa obliterazione dei tratti distintivi dell’anti-ca facciata quattrocentesca con le due aperture a tutto sesto. L’intero edificio a questa data è ormai completamente inserito all’interno di un tessuto urbano che si è venuto generando in modo caotico. Il complesso ha perso del tutto la sua connotazione rurale trovandosi amalgamato in
Riuso e restauro degli edifici storici tutelati. Esperienze a confronto.108
uno spazio cittadino che ne rende difficilmente percepibili le peculiarità architettoniche e l’originaria funzione.
Funzione e prestigio come espressione del potere‘L Castel’ di Pont-Saint-Martin, nelle sue forme primitive, costituiva un tipico modello di costruzione signorile che godeva di una propria auto-nomia formale. Nel panorama edilizio del tardo medioevo questo edificio poteva essere considerato una fortificazione rurale indicata nei docu-menti come “casaforte” (domus fortis, maison forte). La sua presenza, se la immaginiamo nello spazio vuoto dei terreni agricoli che si alternavano verso la Dora, costituiva per il tempo un costante riferimento e un preciso legame con la mappa mentale che allora si doveva avere del territorio. La sua preminenza strutturale era ostentativa oltre che difensiva e rigo-rosamente legata alle funzioni richieste dai proprietari. Il ruolo simbolico assunto da questa dimora fortificata, la accomuna, nello stesso tempo, sia alle torri urbane sia ai castelli signorili. Una residenza che doveva assimilare in sé esigenze di sicurezza e di funzionalità pur non venendo meno nel mostrarsi quale strumento di ostentazione e di prestigio. Lo sviluppo delle caseforti, così come quella del ‘l Castel, rientra in una più generale situazione d’identità culturale condivisa con altre famiglie ari-stocratiche del territorio. Considerando la densità insediativa dell’epoca in cui fu costruito l’edificio, si deve valutare come la sua posizione e il territorio sottoposto a sfruttamento agricolo si dovessero collocare alla periferia della proprietà signorile in quello che doveva essere considerato uno spazio marginale, frutto di una nuova espansione di territori da sot-toporre a coltivo. Se si considera la regressione subita nel corso del XIV secolo, determinata anche dalle pandemie cui susseguirono complicate congiunture sociali ed economiche, la scelta topografica potrebbe anche rientrare in una fase di riconquista di quegli spazi coltivabili parzialmente abbandonati. L’incremento e la diffusione che vennero ad avere questo tipo di edificazioni tra la fine del XIV secolo e il XV secolo, deve essere altresì legata al forte sviluppo demografico di quei secoli cui conseguì un successivo avanzamento nella conquista del suolo coltivabile7. L’edificio, infatti, si trova ubicato nella parte superiore di un ampio conoide laterale, caratterizzato da una lieve pendenza, che si estende sulla riva orografica destra del torrente Lys verso sud e verso ovest in direzione della Dora Baltea. Questa porzione di territorio, dal punto di vista della resa agricola, presentava una considerevole estensione e una perfetta esposizione il che fa ritenere l’edificazione strettamente connessa alla volontà, da parte dei signori di Pont-Saint-Martin, di incentivare la crescita e le rendite di questa porzione di territorio ma anche di affermarne congiuntamente, dal punto di vista giurisdizionale, la proprietà. Quella che potremmo definire permanenza topografica è riscontrabile oltre che nell’evoluzione struttu-rale del nostro complesso anche nella sua persistenza urbanistica, che seppur soffocata dallo sviluppo edilizio di quest’ultimo secolo, mantiene una sua definita connotazione rurale. La funzione essenziale di questo tipo di strutture nel basso medioevo è, in effetti, quella di essere il fulcro dello sfruttamento e dell’utilizzazione di un territorio rurale8. Lo studio di queste strutture permette di penetrare nelle dinamiche sulla mutazione e sulle forme assunte dei possedimenti delle signorie locali, sui diversi livelli della loro affermazione e sui tempi mutevoli di questi fenomeni. Emerge, in definitiva, una società bisognosa di strutture che dessero si-curezza, seppure queste fossero solo un’illusione, e che nascevano con finalità di tutt’altro tipo.
7 CombA 1978.8 CouLet 1980, p. 60.
Una Maison Forte del 1466: ‘l Castel’ a Pont-Saint-Martin (AO) da simbolo del potere a spazio museale. 109
In un lavoro che risale ormai a più di trent’anni or sono, si analizza-va il problema delle case forti inquadrandole in un limbo apparentemente indistinto tra «azienda agricola e fortezza»9. Nonostante la loro forte va-lenza difensiva, queste costruzioni rimanevano pur sempre e «soprat-tutto centri di conduzione agricola». Occorre d’altro canto immaginare intorno a questi edifici una serie di annessi, caratterizzati da un aspetto fortemente rurale e costituiti prevalentemente da materiale ligneo, fun-zionali ad alloggiare i lavoranti, a ospitare il bestiame e a immagazzinare la produzione agricola. Necessariamente, il numero di questi fabbricati “rustici” doveva essere determinato e avere una sua relazione dimensio-nale strettamente correlata con l’estensione dei possedimenti signorili sottoposti a coltura, cui il complesso doveva far capo. Caratterizzando-si come centro di gestione del patrimonio terriero queste strutture, non sempre occupate stabilmente dai tenutari, erano insediate in aree con precisi connotati topografici, pedologici e morfologici. La funzione abi-tativa, sulla base di alcuni esempi pedemontani, potrebbe considerarsi secondaria e con un’occupazione a cadenza intermittente almeno per le sue prime fasi di utilizzo, poiché i proprietari dovevano possedere altre abitazioni in altri luoghi. È possibile che la casaforte, e quindi l’iniziativa edilizia, avesse in un primo momento soltanto una funzione simbolica e di prestigio e che l’intenzione fosse di ottenere con il tempo lo sviluppo di una precisa giurisdizione. La sua sola presenza doveva essere in grado di rimuovere ogni possibile incertezza nella definizione dei diritti e dei limiti di proprietà. Il volere del potere signorile doveva avere quale finalità il dominio dell’intero territorio costruendo edifici fortificati, stabilendo ma anche garantendo diritti giuridici, collocando i subordinati all’interno di un quadro di tipo feudale, allineando così attraverso queste operazioni i loro poteri a quelli della signoria di castello. Occorre osservare come la presenza della casaforte non sembrerebbe aver promosso e determinato in un primo momento la genesi di un agglomerato stabile10, anche perché la stessa struttura non pare essere in grado di esercitare una specifica e reale funzione protettiva sulla popolazione rurale. Caseforti, come nel caso del ‘l Castel, finiscono per divenire l’avanguardia «di quell’insedia-mento sparso che andò generalizzandosi in vaste zone dell’Italia Setten-trionale soltanto durate l’età moderna»11 e che in Valle d’Aosta avrebbe-ro costituito, in molti casi, l’elemento coagulante, nei secoli seguenti, di odierni villaggi o borgate. In quell’infinita serie di vicissitudini che hanno contraddistinto i suoi secoli di vita, ‘l Castel sembra rientrare in quel gio-co di addizione e sottrazione dei diritti e dei domini, più o meno facil-mente vulnerabili, in cui ricadono molti dei contrasti con l’altra famiglia dominante della zona, i Vallaise. ‘L Castel non è che l’apparenza della forza e nonostante esista il richiamo all’architettura castrense, anche se indubbiamente scarso, la sua struttura ne determina un evidente para-digma del potere. Le riplasmazioni hanno definito il crearsi di un prodotto storico-culturale, dove la forma e il luogo di una residenza ci permettono di tradurre l’identità del suo proprietario. Attraverso la ricostruzione di un fenomeno così complesso come quello delle caseforti «se dégagent des critères d’appartenance ou de reconnaissance pour le monde de l’ari-stocratie, pouvant se traduire par la morphologie, les dimensions ou les qualités de construction qui permettraient de dégager des hiérarchies»12. I secoli di vita di questo edificio hanno consentito di osservare «uno spe-cifico processo morfogenetico» sviluppatosi «in sintonia con precise tra-sformazioni dell’organizzazione economica e sociale dello spazio agrico-lo e dell’insediamento rurale»13.
9 settiA 1980. 10 Gli interventi eseguiti nel cortile o durante le operazioni di sottomura-zione non hanno restituito alcun ele-mento che potesse far ipotizzare la presenza di preesistenze.11 settiA 1980, p. 54.12 sirot 2007, p. 22. 13 CombA 1980, p. 12.
Riuso e restauro degli edifici storici tutelati. Esperienze a confronto.110
Il progetto
Il recupero del ‘l Castel documenta la complessità che caratterizza gli edifici di antica origine che hanno subito nell’evolversi della loro secolare vicenda continue trasformazioni, in un incessante adattamento alle esi-genze contingenti. La progettazione, nel caso specifico, ha dovuto affron-tare il duplice compito del restauro di un edificio monumentale e dell’alle-stimento museale all’interno dello stesso, ricercando il giusto equilibrio e compromesso tra le esigenze di tutela del monumento e le necessità di ordine funzionale e scenografico proprie di un museo. In tal senso è sta-to opportuno considerare il sistema museo nell’accezione più ampia del termine, non come semplice contenitore edilizio ma legato all’intorno am-bientale costruito (altri edifici, cortili) e al sistema di relazioni che poteva innescare. Il carattere severo del fabbricato, unitamente alla sostanziale neutralità che caratterizza gli ambienti interni, ben sostengono la sua naturale propensione al riuso come spazio di attività espositiva, anche nel caso delle opere d’arte contemporanea che non sempre trovano negli edifici storici uno spazio coerente con il loro carattere.
L’altra difficoltà consisteva sicuramente nella mediazione tra il nuo-vo e l’antico: osservando la struttura sia nei piani fuori terra sia nella gran-de porzione di edificato interrato, infatti, si leggevano cambiamenti, nuo-ve aperture, tamponamenti murari e forme in evoluzione, alcune anche di difficile comprensione stilistica e strutturale. L’operazione di restauro non ha inteso rimuovere le tracce impresse dalla storia sull’organismo edili-zio, ma ha mediato per quanto possibile tra questi elementi, eliminando solo quelli che ne rendevano difficoltosa la lettura complessiva (fig. 8).
Fig. 8. Vista del complesso da sud-est con il riordino della volumetria di facciata (foto Gabriele Grosso).
Una Maison Forte del 1466: ‘l Castel’ a Pont-Saint-Martin (AO) da simbolo del potere a spazio museale. 111
Fig. 9. A sinistra l’attuale ingresso principale, a destra il corpo di fabbri-ca seicentesco con, in primo piano, l’aggetto della cappella (foto Gabriele Grosso).
D’altronde si è perfettamente concordi nel ritenere che un corretto restauro è quello che non mira alla spettacolarizzazione dell’arte ma alla sua conservazione e salvaguardia. Questa premessa è stata il principio ordinatore del restauro dell’edificio, che a lavori ultimati non ha mutato di molto il suo aspetto esteriore, ma che è stato riportato alla dignità di dimora signorile, con un valore aggiunto.
Il manufatto
L’edificio sorge nel centro storico del Comune di Pont-Saint-Martin, lun-go Via Castello, mentre confina con altri immobili di proprietà privata sui rimanenti lati; lo stretto vicolo sul quale si affaccia l’accesso principale conduce a un cortile interno dal quale si dipartono ulteriori accessi se-condari all’edificio. Le esigenze di coloro che vi abitarono, hanno indotto considerevoli trasformazioni e ridotto gli ambienti in volumi disaggregati. I lavori di restauro hanno permesso di riconnettere gli spazi rendendo nuovamente riconoscibili le funzioni alle quali erano preposti. Una por-zione dell’edificio, databile all’inizio del XVII secolo, forma una sorta di torrione dall’aspetto severo, quasi a dar ragione della sua qualifica di “casaforte” (fig. 9).
L’apparente carattere di manufatto difensivo non deve però farne dimenticare il contestuale utilizzo legato alle attività produttive, delle quali sono ancora presenti, in situ, singolari testimonianze. Volte a botte, in pietra e malta, sono presenti al piano seminterrato e interrato, mentre soffitti con travature lignee a cassettoni e una pregevole incavallatura in larice e rovere sono visibili nella manica centrale e nella copertura del
Riuso e restauro degli edifici storici tutelati. Esperienze a confronto.112
corpo a torre14. L’antica balconata lignea in aggetto verso la corte interna è composta di una struttura portante in castagno con mensole a sbalzo, incastrate nel muro e appoggiate su una trave, a sua volta sostenuta da saette inserite nella muratura; l’impalcato è costruito in tavole di rovere. Il tetto, su pianta quadrata, è del tipo a padiglione con quattro falde in-clinate che poggiano nel punto centrale sull’incavallatura a ombrello con trave orizzontale, o falsa catena, a sezione circolare. I fronti esterni del complesso presentavano, prima dei lavori, una disposizione delle aper-ture disordinata e poco organica con il carattere dell’edificio; l’intervento ha visto una generale riorganizzazione delle aperture, secondo soluzioni progettuali condivise con i funzionari della Sovrintendenza e del Servizio Beni Archeologici. Gli intonaci interni avevano anch’essi subito varie ri-prese nel corso degli anni e solo quelli del salone padronale sono risultati meritevoli di conservazione e restauro. Le pavimentazioni erano il frutto di recenti interventi, quindi sono state sostituite in tavolato di castagno, tranne quelle di alcune stanze dove si è ritenuto doveroso restaurare e mantenere le originarie tavole in larice (fig. 10).
Il restauro della coperturaNell’intervento di recupero di un fabbricato il tetto rappresenta spesso un elemento un po’ svantaggiato perché, data la sua posizione, appare subito come la prima cosa da rimuovere e sostituire. La nostra scom-messa progettuale nel progetto di restauro è stata quella di convincere, e convincersi, che non sempre «il tetto va rifatto». Infatti, fin dai primi sopralluoghi al ‘l Castel, l’idea è stata quella di mantenere la struttura così come si presentava e cioè un’incavallatura in precario equilibrio, fatta di travi sporche di polvere e guano, aggredite dai tarli, ma non anco-ra fiaccate dal tempo. La decisione di mantenere quasi completamente l’orditura lignea del tetto si è basata sulla necessità di non tormentare ulteriormente l’impianto murario e sul fatto che l’interpretazione dei dati forniti dalle indagini puntuali15, avevano consentito di scoprire lo stato di salute effettivo dei pochi elementi destinati al collasso e quindi da sosti-tuire. La parte sommitale degli elementi che componevano l’incavallatura
14 La copertura dell’intero edificio e la balconata del terzo piano sul lato sud, sono state oggetto d’intervento di restauro ultimato in data 20 marzo 2006, realizzato dalla Regione au-tonoma Valle d’Aosta, Assessorato Istruzione e Cultura - Dipartimento Soprintendenza per i Beni e le Atti-vità Culturali - Direzione Restauro e Valorizzazione. 15 Indagine sulle membrature lignee a cura della Tecniter srl, Cassina de’Pecchi, Milano, centro di ricerche applicate Ingegneria Civile e Indu-striale, mediante apparecchiatura ul-trasonica (Krautkramer e Sylvatest), misuratore elettronico del contenuto d’acqua (Protimeter Timbermaster) e Resistograph, o trapano strumentato.
Fig. 10. Salone all’interno del corpo seicentesco, a destra l’interno della cappella (foto Gabriele Grosso).
Una Maison Forte del 1466: ‘l Castel’ a Pont-Saint-Martin (AO) da simbolo del potere a spazio museale. 113
della torre era completamente compromessa da un’infiltrazione d’acqua che, in modo invisibile dall’esterno, aveva alterato il legname lasciando integro il solo strato corticale. Volendo mantenere in sito la struttura, il problema è stato risolto attraverso la ricostruzione delle sezioni danneg-giate con l’inserimento di barre filettate in acciaio zincato, inghisate con resina epossidica.
Per le altre membrature è stata sufficiente un’accurata pulizia con aria compressa e spugnature d’acqua e, nei casi specifici, la ricostruzio-ne dei nodi e delle connessioni con incastri a mezzo legno. La sostitu-zione di soli 7 travi su un totale di 117 è quindi da leggere non solo come dato quantitativo, ma come dato qualitativo per la conferma delle ipotesi iniziali.
Il restauro delle superficiAnalisi mineralogica e campionatura degli intonaciGli interventi di restauro delle superfici interne ed esterne dell’edificio hanno avuto come riferimento l’analisi dei materiali presenti sulle faccia-te16, prelevati e studiati sulla base della campionatura mineralogica degli elementi di composizione delle malte dell’intonaco.
La superficie intonacata è stata pulita con applicazione di biocida, lavaggi e spazzolature per rimuovere le patine biologiche superficiali, le macchie nere e le muffe. In seguito sono state eseguite campionature con vari tipi di calce idraulica naturale, sabbie e inerti selezionati, per determinare l’intonaco raso pietra più adatto e che avesse coloritura e granulometria simile alle porzioni originali, riuscendo infine ad ottenere una soddisfacente tessitura in grado di riproporre l’aspetto originario del manufatto.
Indagine stratigraficaLa campagna stratigrafica17 ha individuato, al di sotto delle superfici visi-bili, impianti decorativi e finiture preesistenti, infatti i dati conoscitivi emer-si hanno permesso di identificare gli ambienti che avevano conservato, nonostante le modificazioni e le trasformazioni apparentemente distrutti-ve nei confronti delle fasi più antiche, materiali e finiture originali.
Nonostante le inevitabili compromissioni, sono state così riscoperte le pitture ad affresco sulle pareti di un locale trasformato in servizio igie-nico, gli intonaci originali con le coloriture coeve sulle pareti del salone e lo stemma dipinto sul camino. La riscoperta e il conseguente restauro delle superfici sono stati quindi intesi non come facies, ma come docu-mento materiale di un contesto architettonico, i cui elementi costitutivi ne definiscono l’identità storica.
Parallelamente alle varie attività d’indagine e di ripristino si sono affrontate, insieme ai competenti Uffici della Soprintendenza, le pro-blematiche riguardanti la conservazione delle superfici originali e della loro reintegrazione con materiali compatibili e tecniche applicative tali da restituire unitarietà d’immagine, intervenendo in modo coerente sugli intonaci, sulle coloriture, sugli elementi lignei (porte, infissi, solai lignei, tavolati) e sulle superfici lapidee. In quest’ottica di totale intesa con la Soprintendenza, si è fondata la decisione, ad esempio, di sacrificare l’intonaco di fine Settecento presente nel salone padronale a favore di quello più antico, per una coerente presentazione estetica. Il cantiere di restauro ha manifestato l’esigenza di utilizzare materiali e tecniche edilizie legati alla tradizione locale e in particolare è stata ottenuta una corretta relazione tra l’utilizzo delle malte di calce e gli inerti, le cui gra-
16 Campagna di analisi mineralogi-che-petrografiche (microscopio ste-reoscopico, analisi in sezione sottile e analisi delle patine e delle pellicole pittoriche in sezione lucida trasver-sale) e campionatura degli intonaci, condotte dalla ditta Furnari Restauri s.a.s, Cunico d’Asti (AT), in collabo-razione con i laboratori analisi della Primat Settore Diagnostica, Occhiep-po Inferiore, Biella. 17 Campagna di indagini stratigrafi-che e analisi delle superfici dipinte condotte dalla ditta Furnari Restauri s.a.s, Cunico d’Asti (AT).
Riuso e restauro degli edifici storici tutelati. Esperienze a confronto.114
nulometrie e lavorazione superficiale hanno ripreso le caratteristiche di quelle originali, contribuendo così a restituire identità al contesto archi-tettonico (fig. 11).
Il restauro dei serramenti
I serramenti presenti nell’edificio sono stati oggetto di una accurata ana-lisi tipologica: grazie alle caratteristiche proprie delle lavorazioni e degli incastri abbiamo potuto dare una datazione di massima ai vari manufatti, distinguendo i serramenti sei-settecenteschi da quelli ottocenteschi.
Ogni serramento è stato fotografato, catalogato in un abaco, e poi rimosso dalla sua sede, senza però sostituire l’originale telaio fisso. Tutte le finestre e le porte meritevoli di restauro sono state stuccate e restaura-te con cura, e rese nuovamente utilizzabili grazie alla revisione della fer-ramenta e alla sostituzione di alcuni chiavistelli. L’operazione più delicata è stata l’inserimento di un vetro stratificato di sicurezza all’interno delle partizioni delle ante, a causa degli spessori ridotti dei telai. Le nuove fine-stre invece sono state realizzate in legno di castagno, usando una fresa speciale per ottenere i piccoli profili necessari, che misurano solamente 55 mm di larghezza, con anta ripartita in specchiature, come le finestre originali (fig. 12).
La scoperta
Un’interessante scoperta, avvenuta nel corso dei lavori, è stata il ritrova-mento di alcuni dipinti di soggetto religioso nel piccolo vano in aggetto, posto al secondo piano fuori terra. Il locale si presentava internamente come un modesto servizio igienico, dotato di pareti azzurre, piastrelle bianche e sanitari, mentre le fattezze dell’esterno denunciavano un ma-nufatto decisamente più importante. Abbiamo ritenuto di procedere con grande cautela nei lavori all’interno del vano perché un anziano signore del luogo aveva domandato se avessimo ritrovato la «capela», della qua-le aveva sentito parlare in gioventù, benché nessuno avesse altre notizie a riguardo (fig. 13).
In effetti, i primi saggi stratigrafici hanno dato ottimi risultati e le pitture sono emerse con la pulitura al bisturi sotto alcuni strati di tinteg-
Fig. 11. Dettagli architettonici: restau-ro e integrazione degli intonaci di fini-tura (foto Gabriele Grosso).
Una Maison Forte del 1466: ‘l Castel’ a Pont-Saint-Martin (AO) da simbolo del potere a spazio museale. 115
giatura azzurrata. Il primo ad emergere è stato un viso incorniciato da capelli ramati e veste azzurra. Si tratta probabilmente, secondo il raffron-to stilistico e iconografico da noi proposto, di Margherita di Antiochia18, vergine e martire, una santa alla quale in passato, ma soprattutto nel cor-so del XVII secolo, la popolazione valdostana ha tributato un culto parti-colare, ora parzialmente dimenticato. Le altre figure sono una Incorona-zione della Vergine, rappresentata secondo un modello iconografico già in auge nel corso del XVI secolo19, e un Santo Vescovo in meditazione, non meglio identificabile, data la mancanza di attributi classici (fig. 14).
I locali interrati: ritrovamenti in corso d’operaIl locale seminterrato, destinato anticamente alla cucina rustica, si pre-sentava prima dei lavori con una parete divisoria realizzata in mattoni in epoca recente, che suddivideva l’originario ambiente in due piccole cantine ripostiglio. Il soffitto ligneo originario era stato ricoperto da un cannicciato intonacato, le pareti presentavano tracce di varie coloriture soprammesse ed era stato celato il collegamento con i vani soprastanti, ora riportato alla luce. I lavori di restauro hanno permesso di portare alla luce un gradevole vano adibito a cucina, una piccola cantina sotterranea e un meraviglioso pozzo in muratura che, posto in sicurezza e adeguata-mente illuminato rappresenta, a lavori ultimati, una particolare attrattiva per i visitatori (fig. 15).
I materialiLa scelta progettuale per il recupero delle superfici e la creazione delle necessarie strutture nuove, quali scale, ascensore e bussole d’ingres-so ai piani, si è sempre basata sullo stesso stile, connotato da severità e semplicità delle materie prime: calce, ferro, legno di castagno. Con questi materiali, scelti appositamente per consentire la prossimità con l’antico, si è cercato di rendere omaggio ed esaltare la struttura esisten-te, dotata di una grande forza espressiva nella semplicità dei suoi spazi. Gli ambienti dell’edificio sono stati trattati con intonaco a calce piuttosto irregolare e lisciato al ferro, con le tracce ben visibili delle passate; i pa-vimenti nuovi sono realizzati in larghe tavole di castagno; i soffitti e la pavimentazione originali sono stati lavati e restaurati con cura, per far riemergere le belle venature del larice e del castagno (fig. 16). Tutti gli elementi costruttivi come i cosciali e i parapetti dei corpi scala, le bussole d’ingresso dotate di mandata d’aria in sovrappressione, gli sportelli dei quadri elettrici, i totem per gli estintori, ecc. sono stati risolti progettual-
Fig. 12. Cucina rustica del corpo sei-centesco con recupero dei serramen-ti originali (foto Silvia Stroppa).
18 La tradizione agiografica latina narra della vergine martire Margheri-ta di Antiochia alla quale il demonio apparve sotto forma di un orribile drago che minacciava di divorarla, ma grazie al solo segno di croce, la donna poté liberarsi dall’animale. La vita di Marina o Margherita di Antio-chia fu segnata dal martirio perché un alto funzionario romano, governa-tore della provincia in viaggio verso Antiochia, decise di volerla prendere in moglie, ma non riuscì a convincere Margherita a sposarlo perché la ra-gazza dichiarava la sua verginità a Cristo. Per questo motivo ella dovet-te sottostare alle leggi romane contro i cristiani, scontando flagellazione e carcerazione. Nelle narrazioni suc-cessive l’episodio del drago venne reso più drammatico: l’orribile mostro la inghiotte ma la santa riesce ad uscire dalle sue viscere. Pare che da tale racconto nacque il motivo per cui la santa fu invocata dalle donne in-cinte, alfine di ottenere un parto sen-za complicazioni.
19 La nostra ricerca sul soggetto raf-figurato ci ha portati a scoprire lo stesso modello di riferimento per il dipinto, raffigurato su una vetrata conservata presso il Museo Civico di Lodi (dimensioni: cm. 48,7 x 42,7; seconda metà del sec. XVI, dono dell’Avv. Manusardi; attribuzione: for-se Giovanni Passero Fiammingo). La Direttrice del Museo, dott.ssa Cecilia Cametti, da noi interpellata su tale argomento, si è così espressa: «da una prima consultazione l’ipotesi ap-parentemente più logica è che l’auto-re (tardo 500) della vetrata e l’autore
Riuso e restauro degli edifici storici tutelati. Esperienze a confronto.116
mente grazie all’uso dell’acciaio Cor-ten, ritenuto il materiale più idoneo per valorizzare il rude carattere dell’edificio, e lavorato in maniera egre-gia da aziende piemontesi che rappresentano con onore l’eccellenza ar-tigiana sul territorio (fig. 17).
Verso uno spazio identitarioPer cogliere appieno le dinamiche di una dominazione territoriale e le scelte intraprese dai membri della casata dei Pont-Saint-Martin in merito alle vicissitudini dell’edificio oggetto dell’intervento, l’approccio diagnosti-co, voluto prima e durante la progettazione, ha certamente costituito il te-laio sulla cui base tessere le varie informazioni emerse sia dall’indagine stratigrafica che dalle analisi dendrocronologiche. La concordanza tra i termini della sequenza evolutiva, le date fornite dagli elementi lignei uti-lizzati per la costruzione dell’edificio e i momenti dettati dalla documenta-zione scritta si sono perfettamente allineati a ricomporre l’immagine del
Fig. 13. Il ritrovamento della cappel-la seicentesca di devozione privata (foto Silvia Stroppa).
Fig. 14. Pitture della volta della picco-la cappella (foto Silvia Stroppa).
dell’affresco abbiano ripreso da una stessa incisione, verosimilmente di ambito fiandro-tedesco. Una dipen-denza diretta dell’affresco dalla ve-trata mi sembra, invece improbabile, anche per il diverso registro cromati-co, che farebbe supporre una fonte originale in bianco e nero».
Una Maison Forte del 1466: ‘l Castel’ a Pont-Saint-Martin (AO) da simbolo del potere a spazio museale. 117
Fig. 15. Una giornata di visita a ‘l Castel (foto Gabriele Grosso).
Fig. 16. Dettagli costruttivi dello sca-lone d’ingresso (foto Silvia Stroppa).
Fig. 17. Salone del piano nobile del corpo quattrocentesco con un’espo-sizione temporanea di arredi d’epo-ca di proprietà privata (foto Gabriele Grosso).
Riuso e restauro degli edifici storici tutelati. Esperienze a confronto.118
complesso fornendo alla progettazione i principi chiave per dare vita al processo di rivitalizzazione dell’edificio. Queste varie componenti ci han-no autorizzato a stabilire con esattezza l’istante in cui la casaforte venne pensata e costruita. Un momento decisivo per il nuovo radicamento della casata dei Pont-Saint-Martin sul territorio e per le scelte politiche che ne derivarono. La costruzione dell’edificio rappresentò, infatti, il momento di svolta di una dinastia cui certamente contribuì il patrimonio fondiario al quale la struttura doveva essere indissolubilmente legata.
Questi presupposti, che qualificavano l’intera struttura in termini socio-culturali, hanno obbligato a ponderare le scelte d’intervento e a mediare tra restituzione del bene e fruizione degli spazi attraverso un approccio che voleva essere nel contempo rispettoso e concreto nei con-fronti dell’oggetto e della finalità progettuale. Le indagini diagnostiche operate anche nei più minuti dettagli hanno garantito un puntuale con-trollo delle scelte d’intervento. Dalle semplici parti di ferro battuto degli infissi, alle scelte delle miscele per gli intonaci fino alla carpenteria, in pratica tutte le azioni poste in essere sul manufatto, hanno avuto meto-dologicamente un comune denominatore: ridare una leggibilità evolutiva garantendo il pieno utilizzo.
I vagli progettuali hanno pienamente assimilato le potenzialità del particolarismo, facendo dell’infinitamente piccolo il perno su cui gravitare le dinamiche dell’intero intervento, non venendo meno però nell’adottare il giusto equilibrio nella visione globale tra le esigenze di tutela del monu-mento e le necessità di ordine funzionale.
La restituzione alla comunità del ‘l Castel ha trasformato questo corpo di fabbrica in patrimonio culturale proiettandolo in un nuovo ruolo urbanistico e portandolo a divenire l’espressione di un’identità collettiva in un crescendo di sensibilità per la storia del proprio territorio.
Una Maison Forte del 1466: ‘l Castel’ a Pont-Saint-Martin (AO) da simbolo del potere a spazio museale. 119
Bibliografia
AvAntey C., Dufour n., Grosso G., stroppA s., 2007, Lavori di risana-mento conservativo della copertura dell’antica casa forte denominata “Castel” in Pont-Saint-Martin, «Bollettino della Soprintendenza per i beni e le attività culturali», 3 (2006), Aosta, pp. 238-240.
CoLLiArD L., 1979, Fasti e decadenza di Antiche Dimore Signorili nella Bassa Valle d’Aosta, Aosta.
CombA r., 1978, Rappresentazioni mentali, realtà e aspetti di cultura ma-teriale nella storia delle dimore rurali: le campagne del Piemonte sud-occidentale fra XII e XVI secolo, «Archeologia Medievale», V (1978), Firenze, pp. 395-411.
CombA r., 1980, Cultura materiale e storia sociale nello studio delle di-more rurali, «Archeologia Medievale», VII (1980), Firenze, pp. 9-20.
CouLet n., 1980, La bastide provençal au bas-Moyen Âge. Contribution à une histoire de l’habitat rural disperse en Provence, «Archeologia Medievale», VII (1980), pp. 55-72.
De LA pierre C., sArtorio G., CorteLAzzo m., 2012, Il recupero del comples-so architettonico del ‘l Castel a Pont-Saint.Martin, «Bollettino della So-printendenza per i beni e le attività culturali», 9 (2012), Aosta, pp. 48-57.
De tiLLier J. b., 1970, Nobiliaire du Duché d’Aoste, édité par les soins d’André Zanotto, Aoste.
niCCo r., 1979, Pont-Saint-Martin. Trasformazioni economiche e sociali di una comunità della Bassa Valle d’Aosta, (II Ed. Aosta 1997), Aosta.
prAmotton L., stroppA s., 2012, (a cura di), ‘l Castel. Casa forte dei si-gnori di Pont-Saint-Martin, Quart.
pizzi L., ziDDA G., 2012, ‘l Castel a Pont-Saint-Martin: alcune riflessioni per un inquadramento storico artistico, «Bollettino della Soprinten-denza per i beni e le attività culturali», 9 (2012), Aosta, pp. 58-60.
settiA A. A., 1980, Tra azienda agricola e fortezza: case forti, “motte” e “tombe” nell’Italia Settentrionale. Dati e problemi, «Archeologia Me-dievale», VII (1980), Firenze, pp. 31-54.
sirot e., 2007, Noble et forte maison. L’habitat seigneurial dans les cam-pagnes médiévales: du milieu du XIIe au début du XVIe siècle, Paris.