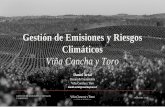Gestión de Emisiones y Riesgos Climáticos Viña Concha y Toro
Cubulteria. Ragguagli sulla moneta attribuitagli e sul controverso simbolo del toro androprosopo
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Cubulteria. Ragguagli sulla moneta attribuitagli e sul controverso simbolo del toro androprosopo
1
CUBULTERIA RAGGUAGLI SULLA MONETA ATTRIBUITAGLI
E SUL CONTROVERSO SIMBOLO DEL TORO ANDROPROSOPO
Mario Nassa
…la ricerca sulle origini della nostra storia patria, proprio tenendo
presenti i cambiamenti territoriali e le correlate cancellazioni possibili,
deve fondarsi su quel che resta di storico prima di tutto appunto sul
territorio, poi sui documenti certi e successivamente sulla tradizione
scritta e orale.
Gaetano Andrisani
Contributi per la storia di Marcianise, Caserta 2006, p. 10
PREMESSA
L’inaspettata buona accoglienza riservata alla scorsa
bibliografica su Fistelia, anche al di fuori del territorio del Medio
Volturno (al quale è bene precisare era diretta), da parte degli
appassionati di numismatica, mi ha invogliato a dare alle stampe
questi ragguagli sui bronzi cubulterini, raccolti in una sorta di
contemporanea focalizzazione degli studi passati e presenti (come
esortano le due P riflesse dello stemma associativo voluto dal prof.
Dante B. Marrocco)1 sulla monetazione che interessò svariati centri
della nostra vallata in un periodo di tempo che va dagli inizi del V
sino alla fine III secolo a.C.
Tramite essi continuo a manifestare quel senso di profonda
gratitudine che avverto verso quanti hanno contribuito, con i loro
scritti, a farci sempre di più conoscere e amare la nostra terra. Valga
per tutti loro, ancora una volta, la mia accorata invocazione al
Signore: Recordare, Jesu Pie, quod sunt causa tuae viae, eos ne
perdas illa die.
1 Nella pagina seguente esso è riportato così come appare nel Quaderno di Cultura
ASMV n. 19 L’Associazione Storica dal 1915 al 1985, Piedimonte Matese 1985.
Lo stemma e tutte le altre immagini presenti nell’articolo sono un’anticipazione
gentilmente concessa di quanto ha ricercato e adattato alla stampa Valentino
Nassa, nel suo contributo fotografico su Cubulteria costituente la seconda parte di
questo opuscolo.
2
Lettura e interpretazione - Lettura araldica: d’argento al libro di
nero bordato di rosso in palo, sostenente una penna d’oro in sbarra
accantonato da due P di nero divergenti, sormontate nel capo da due
stelle d’oro a sei punte.
Interpretazione: lo smalto d’argento indica la purezza
d’intenzione, l’azione disinteressata del sodalizio; il bordo rosso
indica che sono dettate dall’amore alla propria terra; la penna d’oro
indica il merito, il valore di chi scrive. Le due P maiuscole, nere,
divergenti significano preteritur e praesens, passato e presente, i
due campi in cui si svolge l’indagine dell’a.s.m.v. Essi vengono
illuminati dagli studi dell’associazione simboleggiati dalle due stelle,
ognuna su una P.
Lo stemma è stato illustrato dal prof. D. B. Marrocco,
discusso e approvato dal Consiglio direttivo.
Questo scudo è stato dipinto dal socio Cosimo Formichella.
***
3
LA RICERCA ARCHEOLOGICA, NUMISMATICA E MITOLOGICA
L’ubicazione di Cubulteria nel territorio del Medio Volturno,
già prospettata dal Biondo nel ‘500, fu meglio localizzata dal
Pellegrino, nel secolo successivo, e parve definitivamente
dimostrata e circoscritta dal Trutta nel 1776: concorsero alla
risoluzione del problema a favore di Alvignano (CE) la tradizione
locale, importanti carti medioevali e le evidenze epigrafiche2.
Fuorvianti, come vedremo, continuavano a dimostrarsi, invece, gli
studi numismatici.
Joseph Pellerin nel pubblicare la moneta di bronzo sotto
riportata (fig. 1), appartenente alla sua straordinaria collezione, con
ragione, avvertì che appariva totalmente somigliante ad alcune
coniazioni di Neapolis e di altre città campane (figg. 2 a, b, c);
particolare che non lasciava dubbi circa una localizzazione della
zecca emittente in ambito regionale. La scritta regressiva,
, poi, sebbene fosse in caratteri oschi, sembrava
suggerire una confederazione tra Cumae e la vicina Liternum.3
Figura 1
2 Per una più dettagliata “Storia degli studi e delle ricerche” rimando al capitolo
dedicatogli da G. CERA, Il territorio di Cubulteria, in “Carta Archeologia e
Ricerche in Campania” XV supplemento, fascicolo I, L’Erma di Bretschneider,
Roma 2004, pp. 29-37. 3 J. PELLERIN, Recueil de Médailles de Peuples et de Villes qui n’on point encore
été publiées ou qui sont peu connues, tome premier, Paris 1763, pp. 47-49 e tav.
VIII n. 25.
4
Il bue a testa umana presente nel retro, informava inoltre lo
studioso francese, era identificato da grandi antiquari del passato,
tra i quali Spanheim e Vaillant, con il Minotauro laddove altri suoi
contemporanei, ad esempio Pighius, propendevano per un simbolo
coloniale legato all’agricoltura.
Figure 2 a, b, c
a) Moneta di Suessa
b) Moneta di Nola
c) Moneta di Teano
5
Un altro esemplare, in tutto simile al precedente, appartenen-
te alla collezione del duca Di Noja a Napoli, fu reso noto, senza
significative divergenze attribuitive, da Niccolò Ignarra del quale
già conosciamo la preferenza a riconoscere nel mostro androcefalo
il mitico Akeloos, divinità fluviale, figlio di Oceano e Teti e padre, a
sua volta, delle “evanescenti creature, floride / e fluttuanti Nàiadi”4.
Un terzo inedito bronzo, con la consueta testa laureata di
Apollo nel dritto, ma con scritta incompleta, stavolta sul rovescio,
in esergo, sotto il personaggio biforme coronato da Vittoria, fu
pubblicato da Franz Neumann (fig. 3). L’austriaco, diversamente da
Matteo Egizio, da Martorelli, da Macciucca, da Winkelmann e da
altri che scorgevano in esso il nume fenicio Hebone ossia Bacco, si
dichiarava seguace dell’ipotesi sostenuta dal Burmann, dal Müller e
dal principe di Torremuzza i quali previlegiavano riconoscervi la
rappresentazione dei fiumi che scorrevano nei pressi delle città
emittenti (nel nostro caso dunque il Literno)5.
Figura 3
A questo punto Joseph Eckhel ritenne necessario mettere
ordine a tante supposizioni pertanto, nella sua opera enciclopedica,
dedicò un’intera dissertazione al problema del toro con la faccia
4 N. IGNARRA interpretò la scritta come un’abbreviazione di Cume ad Liternum,
ravvisandovi il nome di una città-fiume sita nei pressi della famosa colonia
calcidese. Vedi nel precedente articolo su Fistelia, scorsa bibliografica di una
ricerca storica appassionante, in M. Nassa – V. Nassa, “Fistelia”, Roma 2009 p. 9;
e in Annuario ASMV 2009, p. 181. I versi sono tratti dalla poesia Fantasia presso
la sorgente del Torano di DANTE B. MARROCCO. 5 F. NEUMANN, Populorum et regum numi veteres inediti, Vindobonae 1779 pp. 5-
10 e tav. 1 n. 2.
6
umana nel tentativo di confutare quanti lo ritenevano un fiume e
dimostrare, al contrario, coerente l’ipotesi della raffigurazione
dionisiaca6. Purtroppo il suo zelo scientifico, impossibilitato a
un’attenta analisi ravvicinata per la rarità e forse anche per la
cattiva conservazione dei pezzi noti, non valse a dare la giusta
assegnazione al conio in esame e anch’egli continuò ad attribuirlo a
una concordia delle comunità suddette (fig. 4).
Figura 4
Stralcio del passo di Eckhel su Cubulteria
Giusta appare, in ogni caso, la sua confutazione dell’idea
sostenuta dal barone d’Hancarville, Pierre Francois Hugues, che la
moneta fosse antichissima: un residuato, cioè, della potenza etrusca
presente in campania prima ancora della venuta dei coloni greci.
6 J. ECKHEL, Doctrina numorum veterum, vol. I, Vindobonae 1792 pp. 111-112,
120-121, 129-140. Così conclude l’autore: “…Nam, ut ajebam, mihi in hac
disputatione istud unum maxime fuit propositum, ut negarem, hoc typo fluvios
veteribus intellectos”.
7
Finalmente, agli inizi dell’Ottocento, così come apprendiamo
dalle parole dell’abate Domenico Sestini7, uno dei massimi
nummologi del tempo, ci si accorse che in realtà la scritta riportata
sulle monete era :
“Queste tre medaglie consimili8 ne sarebbero il solo esempio
ritrovato nel terzo metallo, non facendo caso delle altre credute
scritte KVMELTERNVM mentre per le osservazioni fatte da
due celeberrimi colleghi della numismatica, cioè dai Sig.
Zoega, e Uhden, fu ritrovato dai medesimi in Roma istessa, che
non così leggevisi, ma bensì distintamente KVPELTERNVM
siccome ho potuto anch’io riscontrare in quattro esemplari
quasi simili esistenti nel museo Gothano, e delle quali medaglie
ne sarà dato discarico dal Sig. Schlichtegroll nei suoi annali
numismatici, con individuarne i veri popoli, che coniar fecero
tali medaglie.”
Come anncunciato il numismatico tedesco, Adolf Heinrich
Friedrich von Schlichtegroll9, direttore del museo di Gotha in Turingia,
“sommo amico” del Sestini, pubblicò correttamente le monete suddette
e da allora si è potuto associarle giustamente al passo di Livio:
…Fabius in Samnites ad populandos agros recipiendasque
armis, quæ defecerant, urbes processit. Caudinus Samnis
gravius devastatus; perusti late agri, prædæ pecudum
hominumque actæ. Oppida vi capta Compulteria, Telesia,
Compsa, Melæ, Fulsulæ et Orbitanium. Ex Lucanis Blandæ:
Apulorum Æcae oppugnatæ. Milia hostium in his urbibus
viginti quinque capta aut occisa; et recepti perfugæ trecenti
septuaginta: quos cum Romam misisset consul, virgis in
comitio cæsi omnes ac de saxo deiecti…10.
7 D. SESTINI, Lettere e dissertazioni numismatiche…, aggiunte al tomo VIII, Berlino
1805, p. 136. Nella prefazione al tomo IX, Berlino 1806, pp. IX-X l’autore continua
“Nell’istesso tempo verificai li quattro esemplari delle medaglie state insino ad ora
descritte con KVMELTERNVM, per Cumae, e Liternum, e le quali tutte dicono
KVPELTERNVM, per essere restituite ai popoli Cubulterini della Campania, e dei
quali ne fa menzione Plinio, potendosi dire, che Cupelternum n’era la loro città, non
facendo specie, se nelle medaglie si ritrovano impiegate le lettere Π e E in luogo
delle lettere B e V che potevano avere l’istessa podestà nella lingua Osca”. 8 Si riferisce a quelle di Cuma. 9 A.H.F. SCHLICHTEGROLL, Annalen der gesammten Numismatik, parte II, Leipzig-
Gotha, 1806, p. 16. 10 TITO LIVIO, Ab Urbe condita, XXIV, 20, 4. Forme nominative meno curate che
troviamo in alcuni codici sono: C’bulteriam, Cambulteriam, Combultiram,
Combultenam e Combulcenam. Fabio passò nel Sannio a saccheggiare i campi e a
8
Pian piano tutti gli altri eruditi, tra i quali il ravveduto Francesco
M. Avellino11, si allinearono alla giusta lettura. Clamoroso fu, invece,
il caso del transalpino Gustave Daniel de Lorichs, grande esperto della
monetazione celtiberica spagnola, che ancora, a metà Ottocento,
sempre a causa di un mancato riscontro autoptico, inseriva la nostra
medaglia in una sua importante rassegna su quel gruppo etnico12.
È il caso di avvertire che le medaglie con presunta concordia
di Napoli con Cubulteria13, come anche quelle di Neapolis-Caleno,
-Suesano (fig. 5), -Aisernino, -Tiano, altro non sono che frettolose
ribattiture operate dagli zecchieri partenopei; mentre fu un equivoco
del Riccio, come egli stesso ebbe premura di ammettere, la
concordia tra Compulteria e Suessa14.
Figura 5
Esempio di pseudo concordia tra Neapolis e Suessa
tratto dalla tav. VI del Saggio di Minervini
recuperare con le armi le città che si erano ribellate. Il Sannio Caudino fu quello
devastato più crudelmente; il territorio fu bruciato per largo spazio e fu fatta razzia
di uomini e di bestiame. Furono espugnate le roccaforti di Compulteria, Telesia,
Compsa, Mela, Fulsula e Orbitanio…; altra citazione, con labiale occlusiva sonora
anziché sorda, è nel precedente libro XXIII cap. 39. In PLINIO, (Historiae
Naturalis, libro III), come già si è detto, troviamo nominati i Cubulterini tra i
popoli della Campania antica. 11 L’errore è in F. M. AVELLINO, Italiae Veteris Numismata, Napoli, 1808, p. 33; la
correzione è prima nell’Addenda al vol. I, p. 98 e poi nel Supplemento allo stesso,
1814, p. 7. Stesso discorso vale per T. E. MIONNET, per il quale si raffrontino la
Description de médailles antiques, grecques et romaines, I, Paris 1806, p. 115 n.
144 e il relativo Supplément, Paris 1819 pp. 237-238 nn. 263-267. 12 G. DE LORICHS, Recherches numismatiques concernant principalement les
médailles celtibériennes, t. I, Paris, 1852, pp. 243-244. La strana interpretazione è
spiegabile supponendo l’iscrizione in caratteri latini abbreviati nel modo seguente:
KV(rator) PE(cuniae) VT(riusque) E (= quinta) O(fficina) NVM(orum). 13 F. M. AVELLINO, Primo saggio di osservazioni numismatiche, in “Opuscoli
Diversi” vol. I, Napoli 1826, p. 14. 14 G. RICCIO, Repertorio ossia descrizione e tassa delle monete di città antiche…,
Napoli 1852, p. VII e, in appendice, Aggiunte e Correzioni della pag. VII.
9
A livello locale merita un particolare riguardo la monografia
su Cubulteria di Pasquale De Jorii15. In essa lo studioso si mostra
attento e tempestivo recettore di quanto acclarato dagli specialisti in
materia, avvalorandone, per giunta, i risultati tramite la pubblicazione
di un ulteriore pezzo in suo possesso (fig. 6). Le sue parole:
“Non abbiamo ritenuto necessario impegnarci alla spiega
de’ simboli che la moneta rappresenta. Si è scritto tanto su
di tal materia che sembra superfluo il farne più motto”
dimostrano anche una sufficiente conoscenza di quanto veniva
dibattuto intorno al significato allegorico del toro androposopo.
Figura 6
Al tempo in cui egli scrisse, sulla vexata questio, tra gli altri,
erano già intervenuti, in modo particolarmente prolisso, anche il
Millingen e l’Avellino: il primo a parziale sostegno dell’ipotesi di
Ignarra e cioè che il modo di rappresentare Acheloo fosse col tempo
“divenuto il prototipo delle forme emblematiche date a tutti i fiumi”
e il secondo a favore dell’opinione di quanti, a partire dal XVI
15 P. DI JORII, Dissertazione sul sito della distrutta città di Combulteria, Napoli 1834,
ristampata nel 1989 dall’Archeoclub di Alvignano. A indicare che la questione ad alcuni
non appariva ancora così scontata va ricordato che un decennio prima, un altro studioso
locale, il canonico della cattedrale di Venafro G. COTUGNO (v. Memorie Storiche di
Venafro, Napoli 1824, p. 253) continuava a propendere per l’ormai superata ipotesi
riproposta da G. V. CIARLANTI (v. Memorie istoriche del Sannio, Isernia 1644, ristampa
dell’Archeoclub di Alife, 1991, vol. I, p. 80) di situare Compulteria nei pressi del ponte
Latrone, in località Coppetelle di Capriati; e, riguardo alla moneta, più di un decennio
dopo, C. MINIERI RICCIO, Cenni storici sulla distrutta città di Cuma, Napoli 1846, p. 35,
ancora seguiva l’altrettanto antiquata tesi della concordia tra Cuma e Literno.
10
secolo, vi avevano ravvisato un simbolo dionisiaco16.
Intanto la costante pubblicazione di notizie sulle monete di
Cubulteria (fig. 7) non le rendeva più, a metà di quel secolo, così rare
come si presentavano agli inizi: infatti, due di esse erano state recensite
nel catalogo del Museo di Hédervàr in Ungheria, tre apparivano nelle
tavole del Carelli (LXI, nn. 10-12); due stavano presso il Museo
Numismatico Lavy di Torino (nn. 252-253); quattordici, equamente
ripartite, arricchivano il Museo Reale di Berlino e il Regio Medagliere
del Museo Nazionale di Napoli; due furono segnalate dal Müller
presso il Museo Thorvaldsen, a Copenaghen in aggiunta alle quattro
presenti nel Regio Museo di Danimarca già illustrate dal direttore
Ramus; altre due erano presso la collezione privata di Raoul-Rochette
a Parigi e altrettante in quella del barone Stanislao di Chavdoir in
Russia (oggi Ucraina)… In più, nei decenni seguenti, si susseguiranno
numerosi ritrovamenti tra i quali ricordiamo quelli di Morino17,
Tarquinia18 e Ariccia19.
Figura 7
Le due tipologie note tratte dal “Glossario Italico” del Fabretti.
16 Per quanti volessero seguirne l’interessante dibattito segnalo J. MILLINGEN, Recueil
de quelques Médailles grecques inédites, Roma, 1812 pp. 8-13. e F. M. AVELLINO,
Osservazioni sul toro a volto umano tipo di alcune medaglie della Italia e della Sicilia,
in “Opuscoli diversi” vol. I, Napoli 1826, pp. 81-153. Utile alla comprensione delle
posizioni può anche rivelarsi la lunga dissertazione, letta tra il marzo 1835 e l’aprile
1836 dal dr. F. STREBER alla Regale Accademia Bavarese delle Scienze, dal titolo Sul
toro dal volto umano sulle monete dell’Italia meridionale e della Sicilia (Monaco1837,
pp. 453-555) al termine della quale è dichiarata una vistosa concordanza tra le figure del
Dionysos e dell'Achelous così apparentemente incompatibili. 17 Nel 1860 abbiamo notizia dal GARRUCCI, Delle monete scoperte in un ripostiglio
a Morino presso Sora, di un tesoretto composto da circa trecento monete urbiche
tra le quali (p. 134) alcune di Compulteria insieme ad altre di Teano, Sessa, Cales
e Romano-Campane. 18 Per le monete di Compulteria trovate a Tarquinia v. Scavi di Corneto in
“Bullettino dell’Istituto di Corrispondenza Archeologica”, 1880 p. 50. 19 “Molti esemplari di rame coniati a Neapolis e parecchi di Aesernia, Cales,
Compulteria e Suessa” si rinvennero nel santuario di Diana all’interno del bosco
sacro di Nemi presso Ariccia, v. Bullettino dell’Istituto di Corrispondenza
Archeologica, 1885 p. 234.
11
Nel frattempo, grazie a una monetina di Napoli pubblicata
dal Riccio (fig. 8) che scioglieva “la quistione in favore dell’
Acheloo; per modo che non potrà piu muoversene alcun dubbio per
l’avvenire”, secondo le parole del Minervini, sembrò risolta anche
l’annosa polemica sul rovescio20.
Figura 8
La monetina pubblicata dal Riccio
Non fu così, e l’alternanza delle preferenze continuò. Louis
Sambon, ad esempio, tornò a privilegiare nel “dieu inconnu que les
anciens représentaient sous la forme symbolique du taureau à face
humaine” il Bacco riconosciuto da Eckhel21; viceversa, Raffale
Garrucci riconobbe in esso, ancora una volta, il dio legato al fiume
dell’Acarnania individuato da Ignarra. Da parte sua, il brillante
direttore del gabinetto numismatico di Atene Ioannes Svoronos
ritenne che si sarebbe potuto preferire l’una o l’altra supposizione a
condizione che si fosse accettato il valore astronomico del tipo22.
Arthur Sambon, infine, ritornò sul compromesso tra le due tesi
riconoscendo primariamente nella figura taurina presente nelle
didramme napoletane il mitico Acheloo pur non escludendo, nel
20 Cfr. G. MINERVINI, Moneta inedita di Napoli, che risolve la quistione del toro
androprosopo, in “Bull. Archeologico Napolitano” n. s., 8, ottobre 1852, pp. 57-58 nel
quale l’A. supera le deduzioni che nel numero di settembre, Osservazioni sulle monete
di Napoli colla protome del Sebeto, pp. 45-48 lo facevano propendere per Bacco. 21 L. SAMBON, Recherches sur les anciennes monnaies de l’Italie méridionale, Napoli
1863, pp. 29-31. Altrettanto fecero, in merito alle monete campane, il connazionale
LENORMANT, l’inglese GARDNER, il tedesco GRUPPE, l’austriaco SACKEN etc. 22 I. N. SVORONOS, Sur la signification des types monétaires des anciens, in “Bulletin
de correspondence hellénique”, vol. 18, 1894, p. 112-114. Rifà così capolino anche la
teoria della costellazione del Toro indicante Hebone, riportata in passato, tra gli altri, da
G. SANCHEZ, La Campania sotterranea…, tomo I, Napoli 1833, p. 282.
12
corso dei secoli, una perdita del suo significato originario a favore
del nuovo culto in ascesa23.
A livello linguistico il termine osco kupelternum, di seconda
declinazione, analogamente alle altre iscrizioni monetali con
desinenza –um, secondo Mommsen, esprimeva piuttosto il genitivo
plurale del nome del popolo (lat. Cubulterinorum, ita. dei
Cubulterini) che il nominativo singolare neutro ricavato dal
gentilizio (Cubulteria)24 recante quasi sempre il puntino distintivo
sopra la ů. Il professore tedesco, in altra occasione, esprimeva
anche il suo pensiero riguardo alla probabile etimologia del termine
con le parole: “Der Name Compulteria scheint abgeleitet von
Compula und dies (vgl. Compsa für Comptia) etwa von campus wie
Capua, oder von κάμπτω”25.
Dello stesso avviso, riguardo al caso, si dichiarò Huschke il
quale, “convinto che le radici dell’osco sarebbero quasi tutte greche
o parenti alle greche prische”26 provò, invece, a tradurre il nome in
Krãmerstadt ossia città mercantile, ritenendolo affine a καπηλευτής
(sostantivo derivato del verbo καπηλευεĩν = mercanteggiare) 27, pur
notando, di contro, che il termine poteva richiamare il latino
compellĕre (costringere, radunare)28. Questa seconda ipotesi sarà, in
seguito, ritenuta valida anche dal Keller, dal Weise e dalla
Bertolotti29.
23 A. SAMBON, Les monnaies antiques de l’Italie, Paris 1903, p. 173 n. 1 e p. 181.
“Le ragioni del sincretismo che de’ due culti poté farsi in tempi e da coloni diversi e
posteriori” erano state in passato dottamente illustrate anche dal presidente della Reale
Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti, N. CORCIA con la memoria De vaticinii
e del nome di Bacide, letta nella tornata d’inaugurazione del nuovo anno accademico il
17 gennaio 1865. 24 T. MOMMSEN, Sulle desinenze delle epigrafi nelle monete osche, in “Annali di
Numismatica” pubblicati da G. FIORELLI, vol. I, Roma 1846, p. 38. 25 T. MOMMSEN, Die Unteritalischen Dialekte, Leipzig 1850, p. 272. Il nome
Compulteria appare un derivato di Compula e questo (cfr. Compsa per Comptia)
più o meno come Capua, da campus, oppure dal greco κάμπτω (curvare, piegare). 26 P. RISI, Dei tentativi fatti per spiegare le antiche lingue italiche e specialmente
l’etrusca, Milano 1863 p. 78 n. 2. 27 ERODOTO parlando degli antichi abitanti della Lidia, in Asia Minore, riferisce
che essi, primi tra gli uomini a coniare monete d’oro e d’argento, erano κάπηλoi
ossia commercianti al minuto (Storie, I, 94, I). 28 PH. E. HUSCHKE, Oskische und Sabellischen Sprachdenkmäler, Elberfeld 1856,
p. 155. 29 R. BERTOLOTTI, Saggio sulla etimologia popolare in latino e nelle lingue
romanze, 1958 p. 26.
13
Ritornando alla stampa locale va debitamente segnalata
l’opinione controcorrente di Giuseppe Mennone che, al pari di altri
sostenitori del posto, ritenne di situare l’antica Compulteria sulla
sponda opposta del Volturno, nel tenimento di Gioia Sannitica in
contrada la Torre, località in passato designata col nome di
Compostella.30 Nel primo Novecento, poi, seppure in riferimento ad
emissioni alifane, affrontarono il problema del mostro mitologico
Luigi Posteraro31 e Luigi Marone32 ma anche Raffaele Marrocco e
Nicola Borrelli. Come di consueto, vediamo un po’ più nel
particolare l’opinione di questi ultimi ai quali siamo legati da una
particolare simpatia.
Non vi è dubbio che il primo fosse del parere di quanti vi
ravvisavano un fiume: tanto appare da alcune osservazioni fatte dal
Marrocco in margine all’articolo del Marone e, soprattutto, da un
suo contributo successivo intorno alle monete di Beneventum.33 Va
ricordato, a questo punto, che il benemerito direttore del piccolo
museo di Piedimonte si era anche procurato, tramite un felice
acquisto per lire 50 dal signor Nicola Caprarelli, il 16 giugno 1930,
la rara “litra di Compulteria”. Essa rimase esposta nel medagliere
cittadino fino alla notte del 29-30 agosto del 1966, quando fu rubata
insieme a tantissime altre34. “Un furto su commissione” l’ha sempre
definito, con rammarico, il figlio Dante succedutogli nella carica
direttiva, indicandone, infruttuosamente, agli inquirenti, mandanti
ed esecutori.
Diversa, ancora una volta, appare la posizione del Borrelli.
Di lui è nota la dura presa di posizione nei confronti dell’articolista
alifano, a difesa dei tanti dotti che nel corso di due secoli avevano
30 G. MENNONE, Riassunto storico dell’antico Sannio, 1895 (ristampato dall’
Archeoclub d’Italia sez. Alife nel 1997), pp. 120-121. 31 L. POSTERARO, Origini di Alife – Simbolismo delle tradizioni e della sua moneta,
conferenza inaugurativa dell’Associazone Storica Regionale pubblicata in
“Archivio storico del Sannio Alifano e contrade limitrofi”, I, 1916, I, pp. 9-19. 32 L. MARONE, Intorno al simbolismo della moneta di Alife, in “Archivio storico del
Sannio Alifano e contrade limitrofe”, VI, nn. 16-17-18, 1921, pp. 3-11. Articolo
scritto per confutare la convinzione del Posteraro in merito alla rappresentazione del
fiume Torano sulla moneta di Alife e a beneficio dell’idea “assai più nobile pei nostri
popoli, cioè il culto al benefico Sole, che era il nume protettore della città, e veniva
adorato, come anche a Napoli, sotto il nome di Ebone”. 33 R. MARROCCO, Il simbolismo nella moneta dell’antica Beneventum, in
“Bollettino di Numismatica”, Anno I, n. 2, marzo-aprile 1929, pp. 1-4. 34 Alla composizione del monetiere del Museo Civico è stato dedicato il quaderno
di cultura n. 21 dell’Associazione Storica del Medio Volturno, utile anche per i
sintetici cenni storici riportati.
14
sottoscritto l’attendibile versione del culto fluviale, anche se
personalmente non la condivideva35. Egli, in realtà, preferiva vedere
nel toro androprosopo il simbolo della terra feconda, il culto della
Terra Madre, e di questo ragionò compiutamente in un apposito
studio36 (fig. 9) dopo averne anticipato l’idea in altri dedicati alla
monetazione di Cales e di Suessa Aurunca.
Figura 9
Raffigurazioni e titolo dell’articolo di N. Borrelli
Nella parentesi sui soci scrittori del passato va ancora aggiunto
che, nello stesso periodo, a proposito della moneta similare di
Venafro, Giuseppe Cimorelli dice che essa “reca scolpito nell’una
parte la testa di Apollo, nell’altra Acheloo coronato dalla Vittoria”37;
la medesima tesi che a livello nazionale, per le coniazioni di
Neapolis, sosteneva lo storico fiorentino Giulio Giannelli38.
Anche per questo secolo, diamo ora rapidamente conto dei
più noti ritrovamenti di monete cubulterine cominciando da Riccia,
35 N. BORRELLI, Ancora del toro androprosopo in monete della Campania, in
“Miscellanea Numismatica”, 1922 nn. 3-4, pp. 56-59. 36 N. BORRELLI, Tipi monetali campani – Il toro androprosopo, in “Miscellanea
Numismatica”, 1922 nn. 5-6 e seguenti. 37 G. CIMORELLI, Edifici monumentali della Regione in “Archivio storico del
Sannio Alifano e contrade limitrofi”, Anno VII, nn. 19-20-21, Piedimonte d’Alife
1922, p. 18. Il concetto era già stato espresso dall’A. alcuni anni prima in Breve
cenno sull’origine di Venafro, c. s. anno II n. 5, 1917, p. 66 38 G. GIANNELLI, La figura taurina sulle monete della Magna Grecia, in Rivista
Italiana di Numismatica, 33, (Milano 1920), pp. 105-141.
15
in provincia di Campobasso, dove nel 1903 furono segnalati,
specialmente nei suoi casali, ritrovamenti di monete di Suessa,
Cales, Teanum, Fistelia, Compulteria, Aesernia, Allifae39.
Saltiamo poi con decisione agli anni ’50, quando gli scavi
condotti metodicamente a Carsoli portarono alla luce circa 3000
monete di cui 16 in argento. Del Medio Volturno o prossimo a esso
risultarono esservi presenze di Aesernia, Suessa, Cales, Teanum,
Cubulteria, Allifae, Fistelia40.
Negli stessi anni fu, altresì, esplorata la stipe di Rocca San
Felice nella Valle dell’Ansanto, in provincia di Avellino, che non
mancò di restituire, nel corso di alcuni decenni, numerosissimi
bronzi di Neapolis, Nola, Cales, Suessa e Compulteria.41
Ancora un balzo virtuale in un’altra fossa votiva, questa volta
a Casalvieri (FR), località Pescarola, dove tra il 1990 e il 1991
furono trovate 514 monete di bronzo tra le quali un gran numero di
quelle con Apollo/Toro androcefalo appartenenti a Aesernia, Cales,
Compulteria, Nola, Suessa, Teanum, Venafrum42.
Infine altri sporadici ritrovamenti sono stati evidenziati in
Molise43 ma anche in Lucania44 e, meno probabilmente, in Sicilia45.
Si è parlato all’inizio di un’analogia tipologica delle monete
di Cubulteria con alcune di quelle napoletane. La squisita gentilezza
della professoressa Marina Taliercio Mensitieri, autrice di un
pregevole studio sul bronzo di Neapolis46 presentato nel convegno
internazionale di Napoli del 1980, ha reso possibile l’aggiunta di
qualche parola di conoscenza in più sull’argomento.
39 B. G. AMOROSA, Riccia nella storia e nel folclore, 1903 p. 33. 40 La notizia è tratta da E. BALLA, Un deposito votivo del III sec. a.C. a Carsoli,
documento PDF da Internet. 41 BOTTINI-RAININI-ISNENGHI COLAZZO, Valle d'Ansanto. Rocca S.Felice (AV). Il
deposito votivo del santuario di Mefite, in “Notizie degli scavi di Antichità”, 1976. 42 Riprendo da I sanniti e la conquista romana a cura di A. MORELLO, in
“Quaderno di Studi del Circolo Numismatico M. Rasile” n. XXI pp. 12-20. Vedi
anche F. CATALLI, Materiali numismatici dal santuario di Casalvieri (Sora), in
“Depositi votivi e culti dell’Italia antica…”, 2005, p. 145. 43 M. J. STRAZZULLA, Reperti monetari degli scavi del santuario sannitico di
Pietrabbondante, in AIIN, n. 20, 1973, p. 98; A. DI IORIO, L’apporto della civiltà
magnogreca in area sannitica, Roma 1997, p. 35. 44 L. DE LACHENAL, Da Leukania a Lucania: la Lucania centro-orientale fra Pirro
e i Giulio-Claudii, 1993 p. 87. 45 B. BECHTOLD, La necropoli di Lilybaeum, Roma 1999, p. 440. 46 M. TALIERCIO MENSITIERI, Il bronzo di Neapolis, estratto da “La monetazione di
Neapolis nella Campania antica”, Napoli 1986, pp. 219-373 (tav. VII-XXI).
16
Secondo la famosa studiosa, il gruppo a) di terza fase (fig. 10),
caratterizzato al dritto dalla testa di Apollo e al rovescio dal toro
androprosopo incoronato da Nike (peso medio di gr. 5,43), comune
ad altri centri quali Aesernia, Compulteria, Cales, Nola, Suessa e
Teanum, rappresenta l’unità del sistema (obolo) in un periodo
abbastanza lungo che mostra il massimo sforzo coniativo, sintomo di
“un urgente ed improvviso bisogno di monetazione”, negli anni
coincidenti con la prima guerra punica (264-241 a.C.).
Figura 10
Alcune monete di Neapolis riportate dalla prof. Taliercio alla tav. XIV
Anche la professoressa Renata Cantilena ritiene che “le
contemporanee serie dei centri campani citati, siano monetazioni
della prima guerra punica”47 “coniate proprio per i contributi che
essi erano tenuti a versare, in uomini e mezzi, per sostenere Roma
nelle sue imprese militari”.48
Il dottor Alberto Campana, al quale vanno particolari
ringraziamenti per i consigli e l’incitamento alla prosecuzione dello
studio, concorda ugualmente sul fatto che queste monete “emesse in
grande quantità per sopperire alle spese collegate alla prima guerra
punica, ebbero ampia circolazione nelle zone interne della
Campania, Samnium e Frentania”49.
47 R. CANTILENA, Problemi di emissione e di circolazione monetale, in "Sannio",
1984, pp. 85-97. 48 R. CANTILENA, La moneta tra Campani e Sanniti nel IV secolo a.C., in “Studi
sull’Italia dei Sanniti”, Roma 2000, pp. 82-89. 49 A. CAMPANA, Corpus nummorum antiquae italiae – zecche minori, vol. I,
Frentania: Larinum, in “Panorama Numismatico” n. 79, Suzzara 1994, p. 258.
17
Prima di concludere la parte strettamente numismatica è
opportuno tornare un attimo sul simbolo esaminato50 per segnalare un
recente studio a suo dire “generico e introduttivo” di Antonio
Morello dal significativo titolo Acheloo -toro dal volto umano- sulle
monete di bronzo della Campania Antica. In esso l’autore,
premettendo “di non affrontare l’argomento relativo al valore
nominale delle monete di bronzo in questione, essendo oggetto di
acceso dibattito tra gli studiosi”, oltre a dare una panoramica sulle
città che adottarono il tipo trattato, mostra di propendere per l’ipotesi
sostenuta dal Garrucci ossia di una raffigurazione fluviale legata al
noto personaggio della mitologia greca; orientamento che, come
apprendiamo dall’amabile e prodiga professoressa Maricì Martins
Magalhães, sembra prevalere tra gli studiosi contemporanei:
Come si sa, le divinità fluviali dei greci sono rappresentate
iconograficamente come tori con le corna proiettate in avanti, già
noti nel mondo italiota e siceliota, rispettivamente a Laos,
Metapontum, Katane e Gelas. Nel caso specifico di Napoli,
inizialmente si è pensato di attribuire questa iconografia a una
divinità maschile barbata, venerata localmente, come Dionysos
Hebon o Zeus Zagreus, ma questi culti sono poco diffusi e di
esiguo significato prima dell’epoca ellenistica e romana.
L’esistenza di un esemplare di obolos di Neapolis con il dio
tauriforme, deve si legge chiaramente al D/ la leggenda con il nome
del fiume che scorreva nei pressi della città (ΣΕΠΕΙΘΟΣ, cfr. HNI
2001, n. 558), sembra sia stata la chiave per riconoscere che
l’iconografia del tipo di R/ dell’argento napoletano corrispondesse ad
una trasposizione del dio-fiume Acheloos (la più grande divinità
fluviale del mondo greco) nel mondo italiota (per tutto ciò, si rinvia a
Rutter 1979, pp. 42-45, con ampia bibliografia sull’argomento,
Rutter 1997, pp. 63-65; concordano sostanzialmente Cantilena-
Giove-Rubino 1986, pp. 116-119, v. anche Cantilena 1988, pp. 43-
91, specialmente alle pp. 46-47 e 67)51.
50 Valga anche per esso il monito che l’interesse tipologico non porti ad “istituire
delle teorie astratte, lì dove è solo un succedersi di dati di fatto, che tanto hanno
valore e possono avere un significato valido, quanto più restano immersi nel loro
mondo e nel loro ambiente storico in stretta connessione con gli altri aspetti ed
interessi, che muovono la moneta e ne costituiscono l’essenza”. LAURA BREGLIA,
Numismatica antica – Storia e metodologia, Milano 1967, p. 40. 51 M. M. MAGALHÃES, As moedas de Neapolis na coleção do MHN: iconografia e
epigrafia monetaria, in “Boletim N° 60” della Sociedade Numismàtica Basileira, 2°
semestre 2007, pp. 5-28. Per meglio comprenderne il significato si è qui preferito
riportare un passo similare tratto dalla nota 13 de Le monete della Campania nella
collezione del Museo Storico Nazionale di Rio de Janeiro, pubblicato dall’A. in
“Oebalus” studi sulla Campania nell’Antichità, n. 2, Roma 2007, pp. 7-47.
18
Una ulteriore “convincente dimostrazione che tutte le
raffigurazioni del toro androprosopo con corna e lunga barba sulle
monete siceliote e italiote rappresentino Acheloo, e non qualsivoglia
divinità fluviale” si deve, a detta di alcuni, al docente di Archeologia
presso l’Università di Zurigo Hans Peter Isler che, in passato, ha
dedicato al mitico personaggio un corposo libro di oltre duecento
pagine52.
“Uso esteso e prolungato, che non poteva mancare di restare
nel ricordo, tanto più che si basava su un fondo religioso antico e
tenace” il simbolo trattato (fig. 11) continuò ad apparire, secoli
dopo, sulle monete romane della gens Durmia53.
Figura 11
Il toro androcefalo sul rovescio di un denario di Marcus Durmius (18 a.C.)
UBS 78, 9 sett. 2008 n. 1303 (ingrandimento fotografico)
52 H. P. ISLER, Acheloos. Eine Monographie, Bern, 1970, pp. 81 e ss. V. anche
sotto la voce Acheloos curata dall’A. in Lexicon Iconographicum Mythologiae
Classicae I, Zürich1981, 12-36. 53 J. BAYET, Remarques sur quelques types italiotes du monnayage Julio-Claudien,
articolo pubblicato una prima volta nel 1948 in “Mélange d’Archéologie et
d’Histoire offerts à Charles Picard” e successivamente in “Idéologie et Plastique”
Rome 1974, p. 42..
19
In campo archeologico la settecentesca supposizione di
Francesco Sacco54 che riteneva Dragoni rinata dalle rovine di
Cubulteria, accettata dalla prof. Rosa Carafa55 e dal prof. Giuseppe
Guadagno56, riproposta inizialmente come probabile e in seguito
preferita dall’avv. Domenico Caiazza57, anche per la dott. Giovanna
Cera “rappresenta un’ipotesi di lavoro molto verosimile, ma al
momento non supportata da prove sicure”58. La studiosa, alla luce
dei dati raccolti e in disaccordo con quanto si dirà tra breve di altri,
ritiene che una volta superato il pericolo rappresentato dall’esercito
di Pirro, la Cubulteria romana sia andata progressivamente a
comporsi attorno al complesso santuariale di Alvignano.
Alcuni saggi di scavo promossi, a più riprese, negli ultimi
venti anni, dagli organi preposti alla tutela dei beni pubblici, nei
pressi della basilica di San Ferdinando, hanno evidenziato
inequivocabili resti di un deposito votivo indicante la presenza di
un’importante e prolungata pratica cultuale; mentre posteriori
strutture rustiche rilevate nella zona hanno portato i relatori a
escludere l’insediamento di tipo urbano preconizzato dalle fonti
citate all’inizio59.
54 F. SACCO, Dizionario geografico-istorico-fissico del Regno di Napoli, I, Napoli
1795 alla voce Dragoni. 55 R. CARAFA, Logica insediativa ed ipotesi di sviluppo nel tempo: tre centri del
massiccio trebulano, in “Antiqua” n. 4 (1977) p. 34. 56 G. GUADAGNO, Sui centri fortificati preromani nell’Alto Casertano, in “Archivio
Storico di Terra di Lavoro”, VI, 1979 pp. 267-268. 57 D. CAIAZZA, Archeologia e storia antica del Mandamento di Pietramelara e del
Montemaggiore, I, Preistoria ed età sannitica, Pietramelara-Isola Liri 1986, capitolo
XI. L’autore in questa occasione pare più orientato al riconoscimento della Rocca di
Dragoni con Atina riportata in un brano dallo storico latino Tito Livio (Ab Urbe condita
libri, IX, 28). Idem, Il territorio tra Matese e Volturno – Note di topografia storica, in
“Il Territorio tra Matese e Volturno”, atti del I convegno di studi sulla storia delle
foranie della diocesi di Isernia-Venafro – La Forania di Capriati, Capriati a Volturno 18
giugno 1994, pubblicati a Castellammare di Stabia nel 1997, pp. 17-50. 58 G. CERA, op. cit., 2004, p. 196. In merito poi alla “già più volte menzionata serie
monetale a leggenda osca Kupelternum” (si riferisce particolarmente alle pp. 26-27;
195) la giovane ricercatrice ravvisandovi un “ probabile riflesso e indizio di una
condizione di autonomia politica della comunità sannitica di Cubulteria”, conclude
che essa “andrà pertanto verosimilmente riportata agli anni della spedizione di Pirro,
entro limiti cronologici comunque compatibili con la datazione tradizionalmente
assegnatale” (p. 203). 59 Approfondimenti sull’attività della Soprintendenza per i Beni Archeologici delle
Province di Napoli e Caserta stanno in L. CRIMACO, Alvignano (Caserta). Località
S. Ferdinando. Indagine archeologica nell’area dell’antica Cubulteria, in
20
L’esborso pecuniario dell’imperatore Adriano, che ha
lasciato traccia in una famosa epigrafe caiatina60, non servì a rifare
la cinta muraria di Cubulteria ma interessò, visto il particolare
interesse palesato dal principe per questo tipo di interventi (fig. 12),
un edificio sacro61.
Figura 12
Panorama complessivo in percentuale dei 15 interventi evergetici
(6+3+2+2+1+1) attribuibili all’imperatore Adriano tratto da R. Castagna.
“Bollettino d’Archeologia” 11-12, 1991-1992, Roma 1994, pp. 144-146; IDEM, Dal
vicus al castello. Genesi ed evoluzione…, Napoli 2002 pp. 99 e ss. 60 Cfr. T. MOMMSEN, Corpus Inscriptionum Latinarum X 4574 o anche H. SOLIN,
Le iscrizioni antiche di Trebula, Caiatia e Cubulteria, Caserta 1993, pp. 86-87. 61 R. CASTAGNO, L’evergetismo di Traiano ed Adriano nelle città dell’Italia,
“LANX” 1 (2008), pp. 118 n. 49: “… Il testo che qui è stato riferito a Caiatia,
sulla base del suo luogo di ritrovamento, potrebbe anche intendersi come un
tempio dedicato invece agli abitanti di Cubulteria, riferendo «Cubulternis» non già
a «marmoribus», come qui si è fatto, bensì ad «aedem». A Cubulteria comunque
pare esistessero buone cave di marmo (Cfr. JOUFFROY 1986, p. 121 e
PANCIERA 1992, p. 154)”.
21
Bibliografia
American Journal of Philology, Baltimore 1890, XI, p. 308
AMOROSA, Berengario Galileo, Riccia nella storia e nel folclore, Casal-
bordino 1903
ANTONINI, Giuseppe, Lettera scritta al signor D. Matteo Egizio del 14
agosto 1739, in “La Lucania – Discorsi”, tomo II, Napoli 1797
ATTI della Reale Accademia dei Lincei, Notizie degli Scavi di Antichità,
Roma 1927
AURIGEMMA, Salvatore, Alvignano – Tombe romane scoperte nel territorio
dell’antica Cubulteria, in “Notizie degli Scavi di Antichità”, vol. VIII,
Roma 1911
AVELLINO, Francesco Maria, Osservazioni sul toro a volto umano tipo di
alcune medaglie della Italia e della Sicilia, in “Opuscoli diversi” vol. I,
Napoli 1826
AVELLINO, Francesco Maria, Primo saggio di osservazioni numismatiche,
in “Opuscoli Diversi” vol. I, Napoli 1826
BERTOLOTTI, Rosalinda, Saggio sulla etimologia popolare in latino e nelle
lingue romanze, 1958
BORRELLI, Nicola, Ancora del toro androprosopo in monete della Cam-
pania, in “Miscellanea Numismatica”, Napoli 1922, nn. 3-4
BORRELLI, Nicola, Appunti di Numismatica Calena, in “Archivio Storico
del Sannio Alifano”, Piedimonte d’Alife 1918, nn. 8-9
BORRELLI, Nicola, Il numerario circolante negli antichi mercati della
Campania, in “Numismatica” XII, 1946
BORRELLI, Nicola, La moneta dell’antica Cales, in “Bollettino del Circolo
Numismatico Napoletano”, Napoli 1929
BORRELLI, Nicola, Le monete dell’antica Suessa Aurunca, in “Miscellanea
Numismatica”, Napoli 1921, nn. 3-4
BORRELLI, Nicola, Tipi monetali campani – Il toro androprosopo, in
“Miscellanea Numismatica”, Napoli 1922, nn. 5-6 e seguenti
BULLETIN de l’Institut de Correspondance Archéologique, Roma 1880
22
CAIAZZA, Domenico, Archeologia e storia antica del Mandamento di
Pietramelara e del Montemaggiore, I, Preistoria ed età sannitica,
Pietramelara-Isola Liri 1986
CAIAZZA, Domenico, Archeologia e storia antica…, II, Età Romana,
Pietramelara-Isola Liri 1995
CAIAZZA, Domenico, Il territorio tra Matese e Volturno. Note di topografia
storica in Il Territorio tra Matese e Volturno, atti del I convegno di studi sulla
storia delle foranie della diocesi di Isernia-Venafro – La Forania di Capriati,
Capriati a Volturno 18 giugno 1994. Castellammare di Stabia, 1997
CAMPANA, Alberto, Corpus nummorum antiquae italiae – zecche minori,
vol. I, Frentania: Larinum, in “Panorama Numismatico” n. 79, Suzzara 1994
CANTILENA, Renata, La moneta tra Campani e Sanniti nel IV secolo a.C.,
in “Studi sull’Italia dei Sanniti”, Roma 2000
CANTILENA, Renata, Monete della Campania antica, Napoli 1988
CANTILENA, Renata, Problemi di emissione e di circolazione monetale, in
"Sannio", 1984, pp. 85-97
CARAFA, Rosa, Logica insediativa ed ipotesi di sviluppo nel tempo: tre
centri del massiccio trebulano, in “Antiqua” n. 4 (1977)
CATALLI, Fiorenzo, Materiali numismatici dal santuario di Casalvieri
(Sora), in “Depositi votivi e culti dell’Italia antica…” (a cura di A.
COMELLA - S. MELE), 2005
CATALLI, Fiorenzo, Monete dell’Italia antica, Roma 1995
CERA, Giovanna, Il territorio di Cubulteria, in Carta Archeologica e
ricerche in Campania – Fascicolo I: comuni di Alvignano, Baia Latina,
Caiazzo, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Dragoni, Piana di Monte
Verna, Ruviano. L’Erma di Bretschneider, Roma 2004 pp. 19-235
CIARLANTI Giovanni Vincenzo, Memorie historiche del Sannio, Isernia
1644. Ristampa (dell’Archeoclub d’Italia sede di Alife effettuata nel 1991)
della II edizione edita a Campobasso nel 1823
CONWAY Robert Seymour, The italic dialects, Cambridge 1897
CORCIA, Nicola, De’ vaticinii e del e del nome di Bacide, memoria di
inaugurazione pel nuovo anno accademico 1865 letta nella tornata del 17
gennaio dal presidente, in “Atti della Reale Accademia di Archeologia,
Lettere e Belle Arti”, vol. I, Napoli 1865, pp. 5-32
CRAWFORD, Michael H., Coinage and money under the Roman Republic,
London 1985
23
CRIMACO, Luigi, Alvignano (Caserta). Località S. Ferdinando. Indagine
archeologica nell’area dell’antica Cubulteria, in “Bollettino d’Archeo-
logia” 11-12, 1991-1992, Roma 1994, pp. 144-146
CRIMACO, Luigi, Dal vicus al castello. Genesi ed evoluzione del paesaggio
agrario tra Antichità e Medioevo: il caso della Campania settentrionale,
in “La Campania settentrionale tra preistoria e medioevo” (a cura di L.
CRIMACO, F. SOGLIANO) Napoli 2002, pp. 59-144
DE JORII, Pasquale, Dissertazione sul sito della distrutta città di
Cumbulteria, Napoli 1834 (Ristampa dell’Archeoclub d’Italia sede di
Alvignano del 1989)
DE LACHENAL, Lucilla, Da Leukania a Lucania: la Lucania centro-
orientale fra Pirro e i Giulio-Claudii, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato, 1993
DE LORICHS, Gustave Daniel, Recherches numismatiques concernant
principalement les médailles celtibériennes, t. I, Paris 1852
ECKHEL, Joseph, Doctrina numorum veterum, vol. I, Vindobonae 1792
FABRETTI, Ariodantis (cura et studio), Corpus inscriptionum italicarum
antiquioris aevi ordine geographico digestum et glossarium italicum in quo
omnia vocabula continentur ex umbricis, sabinis, oscis, volscis, etruscis
aliisque monumentis quae supersunt collecta et cum interpretationibus
variorum explicantur, Augusta Taurinorum 1867
FABRIZIO, Mario, Dragoni – Il territorio, la storia, le tradizioni,
Piedimonte Matese, Edizioni ASMV, 1989
FIORELLI Giuseppe, Bollettino del Museo Nazionale di Napoli, vol. I,
Napoli 1864
GARRUCCI, Raffaele, Delle monete scoperte in un ripostiglio a Morino
presso Sora, in “Bullettino dell’Instituto di Corrispondenza Archeologica
per l’anno 1860” Roma 1860, pp. 132-139
GARRUCCI, Raffaele, Le monete dell’Italia antica, Roma 1885
GUADAGNO, Giuseppe, Sui centri fortificati preromani nell’Alto Casertano,
in “Archivio Storico di Terra di Lavoro”, VI, Caserta 1979
HEURGON, Jacques, Recherches sur l’histoire, la religion et la civilisation
de Capoue préromaine, Paris 1942
IADONE, Pasquale, Memorie sopra Cajazzo, Trebula, Compulteria,
Saticola, manoscritto dei primi decenni dell’Ottocento conservato presso
l’archivio comunale di Caiazzo
24
IANNELLI, Cataldo, Veterum Oscorum Inscriptiones et tabulas Egubinae
latina interpretatione…, Neapoli 1841, pp. 32-43
ISLER Hans Peter, Acheloos. Eine Monographie, Bern, 1970
JOUFFROY, Helene, La construction publique en Italie et dans l’Afrique
romaine, Bruxelles 1986
LOMBARDI, Nicolino, Le sedi umane in territorio caudino – diario di
bordo, CD-ROM multimediale, Piedimonte Matese, Infolabs, 1999
MANCINI, Nicola, Altre iscrizioni inedite di Alife, in “Annuario ASMV
1975” Piedimonte Matese, Edizioni ASMV, 1977, pp. 108-114
MARCHESE, Leonida, Considerazioni sul toro androprosopo delle monete
greche italiote desunte dall’esegesi di monumenti funerari etruschi, in
“Bullettino del Circolo Numismatico Napoletano”, 18, 1-2, Napoli 1937,
pp. 19-30
MENNONE, Giuseppe, Riassunto storico dell’antico Sannio, s.l., s.d. (ma
1895). Ristampa dell’Archeoclub d’Italia sede di Alife del 1997
MILLINGEN, James, Recueil de quelques Médailles grecques inédites,
Roma 1812
MIONNET, Théodor Edme, Description de médailles antiques, grecques et
romaines, tome premier, Paris 1806
MIONNET, Théodor Edme, Description de médailles antiques, grecques et
romaines - Supplément, tome premier, Paris 1819
MOMMSEN, Theodor, Die Unteritalischen Dialekte, Leipzig 1850
MOMMSEN, Theodor, Sulle desinenze delle epigrafi nelle monete osche, in
“Annali di Numismatica” pubblicati da G. FIORELLI, vol. I, Roma 1846, pp.
35-44
MORELLO, Antonio, Acheloo: toro dal volto umano sulle monete di bronzo
della Campania antica, in “Monete Antiche”, Anno I n. 1, Cassino 2001,
pp. 5-12
MORELLO, Antonio, I sanniti e la conquista romana, in “Quaderno di Studi
del Circolo Numismatico M. Rasile”, Formia 1997, n. XXI pp. 12-20
MÜLLER Karl Ludvig, Musée-Thorvaldsen, troisième partie, Antiquités,
Copenhague1851
NASSA, Mario, Catalogo del Museo Alifano – Parte II, Le Monete,
quaderno di cultura ASMV n. 21, Piedimonte Matese 1995, ristampato,
con aggiunte dell’autore, dal Circolo Numismatico “Mario Rasile” nel
quaderno di Studi n. XXXIX, maggio-giugno 2000, pp. 25-44
25
NEUMANN, Franz, Populorum et regum numi veteres inediti, Vindobonae
1779
PANCIERA, Silvio, Claudio costruttore de sua pecunia! a proposito di una
nuova iscrizione templare romana, in “Claude de Lyon. Empereur
Romain”. Actes du Colloque Paris-Nancy-Lyon. Novembre 1992, Paris
1992
PELLEGRINO, Camillo, Apparato alle antichità di Capua, ovvero discorsi
della Campania Felice, 1651. Nuova edizione accresciuta da varie giunte
e note manoscritte dall’Autore, curata da Giovanni Gravier, I, Napoli
1771, pp. 428˗430
PELLERIN, Joseph, Recueil de Médailles de Peuples et de Villes qui n’on
point encore été publiées ou qui sont peu connues, tome premier, Paris
1763
RAMUS, Christianus, Catalogus numorum veterum graecorum et latinorum
musei regis Daniae, Hafniae 1816
RICCIO, Gennaro, Repertorio ossia descrizione e tassa delle monete di
città antiche comprese nei perimetri delle province componenti l’attuale
Regno delle Due Sicilie al di qua del faro, Napoli 1852
ROMANELLI, Domenico, Antica topografica istorica del Regno di Napoli,
parte II, Napoli 1818
RUTTER, N. Keith et alii, Historia Nummorum, London 2001
SACCO, Francesco, Dizionario geografico-istorico-fisico del Regno di
Napoli, I, Napoli 1795, voce Dragoni
SAMBON Arthur, Les monnaies antiques de l’Italie, Paris 1903
SAMBON, Louis, Recherches sur les anciennes monnaies de l’Italie
méridionale, Napoli 1863
SCHLICHTEGROLL, Adolf Heinrich Friedrich (von), Annalen der
Numismatik, parte II, 1804
SESTINI, Domenico, Descrizione di alcune medaglia greche del museo del
signor barone Stanislao di Chavdoir, Firenze 1831
SESTINI, Domenico, Lettere e dissertazioni numismatiche, tomo VIII,
Berlino 1805
SESTINI, Domenico, Lettere e dissertazioni numismatiche, tomo IX,
Berlino 1806
SOLIN, Heikki, Le iscrizioni antiche di Trebula Caiatia e Cubulteria,
Caserta 1993.
26
STRAZZULLA, Maria Josè, Reperti monetari degli scavi del santuario
sannitico di Pietrabbondante, in “Annali Istituto Italiano Numismatica”, n.
20, Roma 1973
STREBER, Franz, Ueber den Stier mit dem Menschengesichte auf den
Münzen von Unteritalien und Sicilien, in "Abhandlungen der
Philosophisch-Philolog. Classe der Königlich Bayerischen Akademie der
Wissenschaften", München 1837, pp. 453-555
SVORONOS, Ioannes Nikolaos, Sur la signification des types monétaires des
ancients, in “Bulletin de correspondence hellénique, vol. 18, Athènes 1894
TALIERCIO MENSITIERI, Marina, Il bronzo di Neapolis, estratto da “La
monetazione di Neapolis nella Campania antica”, atti del VII convegno del
Centro Internazionale di Studi Numismatici, Napoli 20-24 aprile 1980, pp.
219-373 (tav. VII-XXI), Napoli 1986
THOMSEN Rudi, Early Roman Coinage, Kabenhavn 1961
TRUTTA, Gianfrancesco, Dissertazioni istoriche delle antichità alifane,
Napoli 1776 (Ristampa dell’Archeoclub d’Italia sede di Alife del 1993)
WICZAY, Michael, Musei Hedervarii in Hungaria numos antiquos greco et
latinos…, Vienna 1814