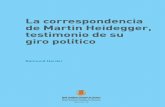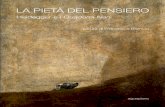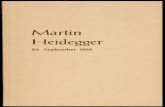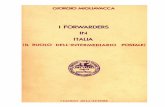Trascendenza e stati affettivi: il ruolo del πάθος in Martin Heidegger
Transcript of Trascendenza e stati affettivi: il ruolo del πάθος in Martin Heidegger
Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano
Interfacoltà di Lettere e Filosofia – Scienze della Formazione
Corso di Laurea Magistrale in Filosofia
TRASCENDENZA E STATI AFFETTIVI:
IL RUOLO DEL PATHOS IN MARTIN HEIDEGGER
Relatore: Chiar.mo Prof. MASSIMO MARASSI
Tesi di Laurea di:
ELISA ZOCCHI
Matricola n°: 4201192
INTRODUZIONE 4 1. Premessa terminologica: le tonalità emotive 4 2. Premessa tematica: l’obiettivo della ricerca 10 3. Premessa metodologica: il percorso 11
SEZIONE I. PRIMA DELLA BEFINDLICHKEIT. DALLA FENOMENOLOGIA AD AGOSTINO 15
1. Il carattere pre-mondano del patico 15 2. Paolo e Agostino tra le fonti del concetto di tonalità emotiva 26
i) Paolo e das Grundlegende 27 ii) Agostino e il sich befinden 31
SEZIONE II. DAL πάθος ALLA BEFINDLICHKEIT. ARISTOTELE 38
1. Il primo contatto con Aristotele 38 2. La Befindlichkeit tra πάθος e διάθεσις: i Grundbegriffe der aristotelischen Philosophie 42
2.1 Il πάθος in Aristotele 47 i) Il πάθος nella Metafisica: l’aspetto passivo 47 ii) Il πάθος nelle Categorie: l’emergere di un nuovo significato 48 iii) Il πάθος nell’Etica Nicomachea: la διάθεσις 49
2.2 La novità della lettura heideggeriana 53 i) Il πάθος come qualità mutevole 53 ii) Il πάθος come essere affetto 55 iii) Il πάθος come vita del corpo dotato di emozioni e passioni 56 iv) Il πάθος e la decisione: l’Augenblick 60
3. πάθος e φρόνησις: Il Sofista di Platone 66 4. Il punto della situazione 77
SEZIONE III. DALLA BEFINDLICHKEIT ALLE GRUNDSTIMMUNGEN 80
1. La Befindlichkeit come affettività: Essere e tempo 80 1.1 Gli esistenziali e la Grundgestimmtheit 81
i) Il triplice carattere di apertura della Befindlichkeit 87 ii) Il confronto con Scheler 89
1.2 Le Stimmungen 91 i) La paura 91 ii) La Grundstimmung: l’angoscia 94
1.3 Le Stimmungen, voce della coscienza 98 i) La chiamata della coscienza 98 ii) Chiamata e responsabilità 101
2. Dalle Stimmungen alle Grundstimmungen 107 2.1 Leibniz e la vis primitiva come tendenza 107 2.2 Svelamento e Grundstimmungen 116 2.3 Le Grundstimmungen tra finitezza e trascendenza 120
3. Grundstimmungen e trascendenza 128
3.1 Le due forme comuni di noia 135 3.3 Le Grundstimmungen, accadimento fondamentale dell’esser-ci 141
SEZIONE IV. πάθος ED ἦθος NELLE GRUNDSTIMMUNGEN. I CONTRIBUTI ALLA FILOSOFIA 146
1. Indicazioni per orientarsi 146 1.1 Le questioni fondamentali 146 1.2 I Contributi alla filosofia: la struttura 149
2. Ritrarsi dell’essere: il ruolo del negativo 158 i) La tecnica e il disincanto dell’ente 162 ii) L’assenza o generalizzazione degli stati d’animo: Husserl e l’Erlebnis 164
3. La prima Leitstimmung: lo sgomento, il dolore 170 4. La seconda Leitstimmung: il pudore 177 5. Le Stimmungen: voce dell’Essere 180
i) Il luogo aperto dalle Stimmungen: das Freie 184 ii) Ereignis: Il rapporto uomo-essere come befindlicher Bezug 187
6. Il ritegno: Grundstimmung del nuovo inizio? 194 i) Il ritegno come πάθος 195 ii) Il ritegno come ἦθος 196 iii) Dal Verstehen all’Entwurf: la disponibilità allo stato d’animo 199
7. L’Ereignis come spazio 203 i) Lo spazio aperto dal diniego indugiante: la fondazione 203 ii) Lo spazio-tempo e il πάθος: Entrückung e Berückung 206
8. Lo stupore, Stimmung del primo inizio: una rivalutazione 217 9. Sentieri per la ricerca di una Grundstimmung: Denken ist Danken 222 10. Il cenno e lo stare: decisione e decisioni 229
i) La decisione per la storicità 231 ii) La decisione per il salvataggio 233
11. Le tonalità emotive e il sacro 244 12. I Contributi alla filosofia: novità e limiti 250
SEZIONE V. DALLA κίνησις ARISTOTELICA ALLA BEWEGTHEIT HEIDEGGERIANA 258
1. Il Natorp Bericht 259 2. Metafisica Θ e Fisica : vis activa e vis passiva per pensare il πάθος 267
CONCLUSIONE 277 BIBLIOGRAFIA 282
4
INTRODUZIONE
1. Premessa terminologica: le tonalità emotive
Lo studio che stiamo per iniziare necessita una delimitazione chiara e preliminare del campo
d’indagine; il campo semantico dell’emotività è infatti particolarmente sensibile a
fraintendimenti e affrontarlo significa correre molto facilmente il rischio di scivolare in mera
chiacchiera. Non che la colpa sia tutta dell’interpretazione: l’ambito dell’emotivo infatti è
soggetto a mutamenti tali che la soluzione migliore è spesso sembrata – soprattutto in filosofia
– relegarlo alla sfera privata, intima dell’individuo, credendo di non poter arrivare ad alcuna
verità su di essa. L’alternativa è sempre stata netta: il rigore e la precisione dei fatti (e dunque
l’esclusione della sfera emotiva-affettiva) o il relativismo sfrenato, il molle abbandono al
soggettivo.
L’esclusività con cui, nella seconda metà del XIX secolo, la visione del mondo complessiva
dell’uomo moderno accettò di venir determinata dalle scienze positive e con cui si lasciò
abbagliare dalla prosperity che ne deriva, significò un allontanamento da quei problemi che sono
decisivi per un’umanità autentica. Le m ere scienze di fatti creano meri uomini di fatto1.
Un tale atteggiamento è dunque inammissibile, laddove si voglia avere sull’uomo uno sguardo
onnicomprensivo; non con la pretesa iniziale di capire tutto ma con l’intento tutto umano di
voler abbracciare la totalità dei fattori che costituiscono la vita, senza tralasciarne alcuni in
quanto apparentemente incerti. La tradizione occidentale ha spesso nettamente estromesso
dall’esperienza la dimensione affettiva, reputandola troppo incerta e relativa; deve esserci stato
però un “momento iniziale del conoscere”, in cui sentire e capire non erano separati ma anzi 1 HUSSERL E., Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie: Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie, hrsg. Elisabeth Ströker, Meiner, Hamburg 1996; tr. it. E. Filippini, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, a cura di E. Paci, Il Saggiatore, Milano 2008, p. 35.
5
legati in “una sorta di simbiosi”2. La sfera lasciata da parte infatti investe quei problemi
“decisivi per un’umanità autentica”, la sfera cioè del senso o non senso della vita, escludendo
ciò che maggiormente interessa, ciò per cui l’uomo ha cominciato a filosofare – meglio, ciò
per cui ogni uomo inizia la propria giornata e muove ogni passo in quel mondo che “non è ciò
che io penso, ma ciò che io vivo”3.
Se ci limitiamo al XX secolo è certamente la corrente fenomenologica che, più di ogni
altra, si è accorta di questa tendenza della filosofia ad estromettere dalla propria indagine la
domanda sull’emotività. Husserl, Scheler, Reinach, Stein, solo per citare i più noti,
rivoluzionano del tutto lo sguardo del grande maestro del fondatore della fenomenologia; se
infatti la Psicologia dal punto di vista empirico di Brentano affermava che gli atti di
sentimento non possono darsi se non sulla base di rappresentazioni, è Husserl stesso ad
affermare nelle Lezioni sulla sintesi passiva che il sentimento non è qualcosa di
semplicemente aggiunto e concomitante alla relazione intenzionale, né tantomeno un inganno,
ma che anzi proprio gli stati emotivi aprono una finestra sulla Lebenswelt, il mondo della vita.
La ricettività originaria del soggetto è data proprio dall’affettività, orizzonte e campo su cui
poi la vita intera si dispiega; rifiutare l’affettività come luogo del pensiero significherebbe
intellettualisticamente bloccare la circolarità del senso e irrigidire la vita stessa dello spirito.
Gli stati emotivi dunque non solo determinano ma costituiscono originariamente
l’intenzionalità, l’apertura al mondo da parte della coscienza husserlianamente intesa.
Abbiamo qui dunque posto la prima intuizione che occorre tenere a mente per tutto il
corso del lavoro e che ci proponiamo di confermare: gli stati emotivi non sono qualcosa di
aggiunto a posteriori ma svolgono piuttosto un ruolo costitutivo nell’esperienza umana. Ciò
significa che degli oggetti dell’esperienza “non vi sono rappresentazioni pure, prive di un
alone affettivo, ma l’alone affettivo contribuisce a determinare l’apparire stesso della
rappresentazione”4. Se fossimo puramente cognitivi non avremmo – paradossalmente – alcuna
intenzionalità, alcun accesso al mondo da conoscere; stentiamo anche a credere che potremmo
2 M. ZAMBRANO, Los bienaventurados, Siruela, Madrid 2004; tr. it. C. Ferrucci, I beati, Feltrinelli, Milano 1992 pp. 93-94. 3 M. MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Gallimard, Paris 1945; tr. it. A. Bonomi, Fenomenologia della percezione, il Saggiatore, Milano 1965, p. 17. 4 V. COSTA, Vita emotiva e analisi trascendentale, in V. Melchiorre (a cura di), I luoghi del comprendere, Vita e Pensiero, Milano 2000, p. 102.
6
conoscere solamente la nostra interiorità di soggetti “chiusi”, dato che anch’essa ci si apre e
rende conoscibile attraverso la sfera emotiva stessa. Sarebbe dunque erroneo affermare che
sentimenti ed emozioni sono puri fatti psichici che accompagnano alcuni momenti conoscitivi
senza rivestire però una funzione trascendentale: essi al contrario sono costitutivi del rapporto
col mondo. Essi ci permettono dunque di guardare al piano assiologico: il sentire è sempre
intenzionale. Nel caso di Scheler, per esempio, che tornerà a presentarsi nel corso della nostra
ricerca, essi dischiudono al mondo dei valori. L’emozione non è dunque un fatto psichico
interno, ma anzi il “termometro” della variazione dei nostri rapporti con il mondo stesso e con
gli altri.
Questo ci porta alla seconda grande affermazione che occorrerà confermare e
dimostrare: non esiste, quando parliamo di sfera affettiva, un dualismo “interno/esterno”,
“soggetto/oggetto”. Se nel parlarne a livello formale occorre certamente distinguere la
coscienza dal mondo, è proprio la fenomenologia a mostrarci che marcare eccessivamente
questa distinzione condurrebbe a una falsa comprensione del fenomeno conoscitivo. Occorre
abbandonare questo netto dualismo per poter comprendere a fondo il significato
dell’intenzionalità husserliana, di cui rimane intriso il pensiero di ogni suo successore; occorre
allo stesso modo abbandonarla per poter comprendere veramente la possibilità che le cose ci
“tocchino” al punto da ritenere necessario il filosofare. Ad aprire questa ferita nella carne della
coscienza sono proprio le emozioni, finestre sul mondo; nell’apertura della finestra non c’è
però ostacolo, distanza o frammezzo, poiché esse sono contemporaneamente dell’uomo e del
mondo.
È ora necessaria una chiara distinzione dei termini utilizzati; fare ordine ci permetterà
anche di comprendere meglio le due affermazioni fin qui mosse. In quella che generalmente
abbiamo definito “sfera affettiva” incontriamo infatti diversi fenomeni.
Prime su tutte, le affezioni sensoriali, che includono tutte le sfumature legate ai cinque
sensi e che per ora leghiamo al piacere e al dolore (volendo però fin da subito sottolineare che
se queste sono caratterizzate da piacere e dolore, non significa che questi due siano relegati
solo alla sfera sensoriale e che non abbiano piuttosto una funzione guida anche più avanti,
come emergerà in determinati punti della ricerca).
Le passioni, poi, acuti (talvolta persino violenti) fenomeni dell’animo rivolti ad una
persona, un’idea, un’occupazione, qualcosa insomma che provoca nell’animo una sorta di
7
movimento e che “infiamma” o “slancia” a causa di qualcosa che subiamo (si pensi
all’etimologia di πάθος, chiarissima per esempio nel tedesco Leidenschaft). Esse tendono però
a occupare soprattutto lo spazio del soggetto arrivando talvolta a dimenticare il rispetto
dell’oggetto che le ha suscitate.
Affezioni e passioni sono frutto soprattutto di un’azione esterna sul corpo; chi è affectus
è colpito da qualcosa nel corpo o nell’animo. È dunque uno stato di passività quello che
originariamente indica l’affetto. Ma “il passivo non sta mai senza l’attivo; e in effetti il
vivente, se colpito, reagisce inevitabilmente. Ciò che colpisce è pur sempre per lui, in
relazione a lui; e ogni relazione del/col vivente è necessariamente una qualche forma di
convenire. Perché il vivente in qualche modo sa o avverte. Ameno in questo senso, con-viene.
E ogni forma del convenire è una forma del giudicare. Ogni forma del giudicare poi afferma o
nega. Comunque, cor-risponde”5. Emozioni e sentimenti entrano ora in gioco nella nostra
classificazione in quando alludenti al “secondo lato” della relazione del vivente, quello
propriamente attivo, riguardando dunque la corrispondenza e il muovere-verso del soggetto.
Ecco dunque la differenza tra la sopra analizzata passione e le emozioni; sono in un
certo senso due facce dello stesso fenomeno. Così come le passioni sono suscitate da qualcosa,
anche le emozioni provocano in noi un movimento (si pensi all’etimologia latina emovere:
trasportar fuori, smuovere, scuotere); esse però presuppongono anche delle risposte, un
elemento di attività che nel caso della passione poteva essere invece non presente (o presente
in modo disordinato e non finalizzato, come invece nelle emozioni). Un’emozione che sia
duratura e persistente può essere infine definita un sentimento.
I sentimenti infatti, in senso proprio, coinvolgono lo strato più profondo di sé, la
cosiddetta personalità; essi consistono in disposizioni durature e risposte emotive strutturanti
ed efficaci (capaci cioè di motivare azioni e atteggiamenti, scelte, a differenza invece delle
emozioni che muovono solo risposte momentanee). Come già le affezioni sensoriali, le
passioni e le emozioni, anche i sentimenti si rivolgono o sono causati da un oggetto specifico.
Tutti i fenomeni finora analizzati hanno un tratto comune: sono dotati di un oggetto
intenzionale. Qualcosa li suscita, si dirigono verso un determinato oggetto noto alla coscienza.
Esiste però un ultimo fenomeno che apparentemente non presenta questo marcato aspetto
5 C. VIGNA, Affetti e legami. Saggio di lettura ontoetica, in F. Botturi e C. Vigna (a cura di), Affetti e legami, Vita e Pensiero, Milano 2004, pp. 3-22, p. 5.
8
intenzionale, non ha cioè un oggetto specifico. È questa la tonalità (o situazione) emotiva, che
indicheremo spesso con il termine tedesco Stimmung. Sarebbe sbagliato affermare (come
spesso fatto nella letteratura) che tali Stimmungen non abbiano un oggetto intenzionale; se così
fosse, non varrebbe affatto la pena studiarli, in quanto totalmente inutili al fine conoscitivo
della filosofia stessa. Più corretta sembra la distinzione tenuta tra alcuni studiosi che
sottolineano come l’oggetto intenzionale delle situazioni emotive sia il mondo stesso in quanto
tale. “Mentre i sentimenti si riferiscono e rivelano l’essere degli oggetti, la Stimmung si
riferisce al loro orizzonte, a quello che nella Crisi delle scienze europee verrà chiamato “il
mondo”, per cui essa si riferisce agli oggetti solo indirettamente, nel senso che rappresenta lo
sfondo emozionale del loro apparire”6. Si apre qui un problema di traduzione che ci impedisce
di scegliere un solo termine tra “tonalità” e “situazione” emotiva; riteniamo infatti che vadano
tenuti ben legati tra loro in modo da esprimere entrambi gli aspetti che il termine Stimmung
contiene. Esso è, in tedesco corrente, quella che chiameremmo atmosfera; in essa ci si trova,
non la si decide. Parlando di atmosfera crolla chiaramente il dualismo interno/esterno:
nell’atmosfera infatti si crea una sorta di sodalizio tra la coscienza e il mondo, che vanno in
sintonia. La situazione emotiva è un “tessuto atmosferico in cui ci troviamo e parlare di
atmosfera di un paesaggio, di una società, di una generazione non ha solamente carattere
metaforico”7. Abbiamo parlato di sintonia; questo ci porta al secondo termine con cui la
traduciamo: tonalità. Nell’atmosfera si crea infatti sin-tonia tra soggetto e mondo, che
sembrano risuonare insieme. Stimmung fa riferimento a Stimme, voce, ma anche al verbo
stimmen, utilizzato nel senso di accordare gli strumenti musicali (e, per derivazione, nel senso
di essere d’accordo – zustimmen)8 . “Come infatti uno strumento musicale è accordato
(gestimmt), quando è intonato (abgestimmt) con un altro (e poi, in senso derivato, con una
norma determinata) e come è abilitato alla sua funzione particolare soltanto quando è
6 V. COSTA, Vita emotiva e analisi trascendentale, p. 112. 7 “Stimmung: diffuses und vages, wenn auch sehr wohl wirksames, ja tonangebendes Grundgefühl: Stimmung ist das atmosphärisch Durchwebende, und die Rede von der Stimmung einer Landschaft, einer Gesellschaft, einer Generation hat nicht nur metaphorischen Charakter”. P.L CORIANDO, Affektenlehre und Phänomenologie der Stimmungen. Wege einer Ontologie und Ethik des Emotionalen, Klostermann, Frankfurt am Main 2002, p. 7. 8 Sul valore musicale della parola Stimmung, che dà voce ad un’armonia universale, precedente ogni dualismo soggetto-oggetto, cfr. L. SPITZER, Classical and Christian ideas of world harmony: prolegomena to an interpretation of the word “Stimmung”, Johns Hopkins Press, Baltimore 1963; tr. it. V. Poggi, L’armonia del mondo. Storia semantica di un’idea, Il Mulino, Bologna 1967. Per una trattazione più generica e specificamente filosofica rimandiamo a R. BOLLNOW, Das Wesen der Stimmungen, Königshausen und Neumann Verlag, Würzburg 2009; tr. it. D. Bruzzone, Le tonalità emotive, Vita e Pensiero, Milano 2009.
9
accordato, così si dice anche dell’uomo che rispetto a un determinato proposito è d’accordo (in
Stimmung) o in disaccordo. Ogni tonalità (Stimmung) è accordo (Übereinstimmung); quindi
anche la «tonalità dello stato d’animo» (Gemütsstimmung) è un accordo continuo di tutto
l’uomo, che nelle sue diverse parti è intonato uniformemente su un certo tono”9.
Nella tonalità emotiva l’uomo si trova intonato e dunque determinato (gestimmt) rispetto
a se stesso, al mondo e agli altri; in gioco è un orizzonte affettivo su cui poi la vita intera si
intona. La tonalità emotiva in un certo senso anticipa il valore dei futuri stimoli che si
riceveranno; è come un “basso continuo”, uno sfondo su cui emozioni e sentimenti possono
poi sorgere. Esse infatti sono proprio l’orizzonte del nostro rapporto col mondo, e sono
molteplici in quanto rappresentano come questo rapporto di accordatura (o di dis-accordo)
muti. Esse ci svelano un rapporto con un mondo ancora indiviso; “le tonalità emotive vivono
ancora nell’unità indivisa di io e mondo, che li avvolge entrambi in una tinta emotiva comune.
Pertanto è sbagliato mettere la tonalità emotiva sul piano del soggettivo e pensare che essa poi
in un certo qual modo “stringa” sul mondo”10. Questa atmosfera, come già affermato, non è
interessante meramente sul piano soggettivo; ha un potere conoscitivo, ci dice qualcosa del
mondo e dell’uomo. L’atmosfera in cui ci troviamo infatti determina (be-stimmt) l’uomo, il
suo rapporto con gli altri, con il mondo e con se stesso. Citiamo a chiarimento Heidegger:
Si tratta del sentirsi (Befinden), che noi intendiamo quando domandiamo all’altro: Come si
sente?, vale a dire: Come sta?. Questa domanda non si riferisce necessariamente solo allo stato
di salute (Befinden) corporeo-inanimato. Questa domanda può informarsi della situazione
propriamente fattuale dell’altro. Essa è l’essere-in-una-tonalità-affettiva (Gestimmtheit),
determinante-totalmente (be-stimmende) l’esserci, del suo rapporto, di volta in volta attuale, con
il mondo, con il con-esserci degli altri uomini e con se stesso11.
È proprio Heidegger che vogliamo interrogare dunque, a partire dalle prime opere, per
comprendere pienamente il significato delle tonalità emotive, degli stati affettivi, per arrivare a
9 R. BOLLNOW, Le tonalità emotive, p. 32. 10 A. CAPUTO, Pensiero e affettività: Heidegger e le Stimmungen (1889-1928), Franco Angeli, Milano 2001, p. 13. 11 M. HEIDEGGER, Zollikoner Seminare. Protokolle-Gespräche-Briefe, GA Bd. 89, hrsg. M. Boss, Frankfurt a.M 1987; tr. it. A. Giugliano, Seminari di Zollikon. Protocolli seminariali-Colloqui-Lettere, a cura di E. Mazzarella e A. Giugliano, Guida, Napoli 2000, p. 201.
10
determinare il ruolo e la funzione del patico nello stare dell’uomo.
2. Premessa tematica: l’obiettivo della ricerca
Ciò che nel confronto con Heidegger vogliamo comprendere è se il fatto di essere
soggetti ad affetti indipendenti da noi sia un elemento di chiusura, limite ed soffocamento o sia
invece segno del suo rapporto con l’essere, come eccedenza, e se l’uomo possa arrivare a
coglierlo come dono, occasione e tratto “positivamente” distintivo della sua umanità e libertà.
Per questo analizziamo la sfera pre-teoretica, qualcosa di originario che si impone come
momento essenziale della vita in sé: è impossibile non essere affettivamente intonati, e la
chiara consapevolezza di questo in Heidegger ha fatto sì che potessimo trovare in lui un
compagno di cammino, anche se talvolta incompleto. Quel che interessa, paradossalmente,
non è Heidegger in sé e per sé.
Non abbiamo la pretesa di giungere a comprendere completamente quel che intendeva,
non ci riteniamo all’altezza di una ricostruzione puntigliosa del suo pensiero, per la quale per
altro molti strumenti ancora mancano: per farlo occorrerebbe aspettare la pubblicazione di
alcuni inediti, analizzare l’intera raccolta appena edita degli Schwarze Hefte-il costante lavorio
silenzioso del filosofo che non condivideva con nessuno-, disporre di alcune note e manoscritti
esclusi dalla Gesamtausgabe. Saremmo insomma bloccati dai limiti. Non è questo, però, ciò
che ci prefiggiamo; abbiamo imparato negli anni dedicati ad Heidegger che dietro all’interesse
per la sua filosofia si è nascosto ben altro. Ci interessa, con lui, un dialogo. Senza l’arroganza
di sentirsene all’altezza, vorremmo provare a partire da Heidegger per far emergere una
riflessione nostra (non solo nostra, forse, ma di tutti quelli che fin qui ci hanno guidato). La
domanda da cui la tesi sorge non è stata “cosa pensava Heidegger delle Stimmungen?” ma, nel
travaglio della scelta, “Cos’è una Stimmung? Perché vi siamo soggetti? è solo un limite?”.
Ci vogliamo domandare, e per farlo domanderemo proprio ad Heidegger, se a ragione
nella storia del pensiero gli stati d’animo siano stati accantonati, ritenuti d’ostacolo o
comunque inutili al fine di un pensiero ma, soprattutto: ai fini di una vita. Ci sembra infatti, al
contrario, che proprio in quei momenti “pre-logici” si nasconda la possibilità per il sorgere di
un vero rapporto con le cose e con gli altri. In ultimo, forse, ma non sarà questa tesi a
ricercarlo, con l’Altro.
11
3. Premessa metodologica: il percorso
Dopo aver chiarito i termini della tematica in generale spieghiamo brevemente il criterio
di divisione del lavoro e della selezione di opere. Nella grande bibliografia heideggeriana
abbiamo selezionato le opere con due criteri: le opere che mettono a fuoco la tematica
ricercata e quelle in cui il confronto con autori del passato si dimostra fruttuoso e necessario
per l’autore. è fondamentale premettere che non sempre la lettura fornita da Heidegger è
storicamente corretta; abbiamo cercato di sottolinearlo quando necessario, volendo comunque
capire cosa di tale lettura rende ragione del pensiero heideggeriano circa la sfera
dell’affettività.
Abbiamo diviso il lavoro in cinque sezioni. La ragione di questa divisione è racchiusa
nei termini con cui Heidegger si riferisce a tale sfera, rispettivamente: Vorweltiche,
Befindlichkeit, Stimmung e Grundstimmung.
La prima sezione tratta delle opere cosiddette giovanili, e a sua volta si divide in tre
capitoli. Nel primo capitolo analizziamo uno dei primi corsi universitari, L'idea della filosofia
ed il problema della visione del mondo, nel quale allontanandosi per la prima volta in modo
esplicito da Husserl Heidegger tematizza la sfera del pre-teoretico.
Nel secondo capitolo guardiamo al corso di Introduzione alla fenomenologia della vita
religiosa; le lettere di Paolo verranno analizzate alla ricerca dell’aspetto pre-teoretico dato
dall’amore divino, mentre attraverso Agostino scopriremo se e in che senso ci sia una
connotazione marcatamente affettiva al momento iniziale del vorweltlich.
La seconda sezione tratta di Aristotele, il punto di riferimento fondamentale. La sua
analisi del vivente e del πάθος è fondamentale per Heidegger e per noi con lui, ed è segnalata
dal fatto che proprio dal confronto con Aristotele emerga, per la prima volta, il termine
Befindlichkeit. In questa sezione cerchiamo di dare ragione della scelta di Heidegger di usare
Befindlichkeit per tradurre non solo πάθος ma διάθεσις. Attraverso Aristotele cerchiamo di
rendere chiaro per la prima volta il legame tra situazione affettiva e disposizione etica,
trovando proprio in lui tracce di questo legame, soprattutto nella tematizzazione della virtù
12
dianoetica della φρόνησις.
Nel primo capitolo il confronto con lui si basa su alcuni corsi degli anni ’20. Il secondo
capitolo si confronta con i Grundbegriffe der aristotelischen Philosophie, corso del 1924 non
ancora edito in italiano nel quale Heidegger analizza la Retorica. In tale capitolo abbiamo
analizzato il pensiero del πάθος in Aristotele e la lettura che ne viene data da Heidegger.
Fondamentali sono inoltre per questa sezione sono inoltre le Categorie, la Metafisica e l’Etica
Nicomachea, analizzate nel corso di Heidegger Il Sofista di Platone, tema del terzo capitolo di
questa sezione.
La terza sezione guarda alle opere in cui il termine Befindlichkeit, emerso e consolidato
nel confronto con Aristotele, si stabilisce come centrale, per poi cedere il posto a Stimmung.
Proprio questo passaggio è ciò che da ragione della divisione in tre capitoli.
Nel primo analizziamo Essere e tempo, l’opera in cui la Befindlichkeit ricopre il ruolo di
esistenziale, dunque struttura dell’uomo. Nel confronto con tale opera indaghiamo la capacità
del πάθος di fungere da apertura all’altro, come trascendenza sia orizzontale che verticale.
Dopo un breve confronto con la posizione di Scheler si passa all’analisi delle due tonalità
tematizzate nell’opera, la paura e l’angoscia, per farne emergere le caratteristiche. Proprio
l’analisi dell’angoscia, nella sua chiarezza, ci permette di comprendere il carattere
dischiudente dell’affettività.
Il secondo capitolo guarda a tre opere successive ad Essere e tempo. Il primo, il corso
Principi metafisici della logica, si basa sull’interpretazione data di Leibniz e dal confronto con
esso cerca di trarre chiarificazioni circa l’idea di Befindlichkeit grazie al confronto tra la
monade e il Dasein. Il secondo, dedicato a Dell’essenza del fondamento, segue Heidegger
nell’indagine del patico come luogo dello svelamento della verità. Il terzo è la prolusione Che
cos’è metafisica? e la qui tematizzata perdita del primato dell’intelletto, indagando
nuovamente l’angoscia e il suo essere apertura alla trascendenza.
Il terzo capitolo è dedicato al consolidamento del concetto di Grundstimmung nel corso
universitario Concetti fondamentali della metafisica; Mondo – Finitezza – Solitudine.
Seguendo Heidegger nell’analisi della noia arriviamo a tematizzare il rapporto tra tonalità
affettive e temporalità ma soprattutto a comprendere il ruolo di accadimento fondamentale
dell’esser-ci dato ad esse e, al contempo, alla metafisica.
13
La quarta sezione mette a tema un’opera fondamentale degli anni ’30, i Contributi alla
filosofia, da cui molto del pensiero del cosiddetto secondo Heidegger si dipana. Li abbiamo
analizzati perché in essi si racchiudono molte tematiche sotto le quali sembra possibile
individuare la domanda circa il πάθος. Abbiamo dunque cercato nel corso del capitolo di
delineare e analizzare precisamente le Stimmungen che nel corso dell’opera emergono, alla
ricerca di quella fondamentale, seguendo la divisione dello stesso Heidegger in
Leitstimmungen e Grundstimmungen.
Dopo un primo capitolo introduttivo all’opera, la nostra analisi ha mosso nel secondo
capitolo dal concetto fondamentale di negativo, il ritrarsi dell’essere, analizzato nelle forme da
Heidegger criticate di macchinazione ed esperienza considerata come Erlebnis.
Questa ritrazione viene vissuta nella Leitstimmung dello sgomento, che abbiamo
analizzato nel terzo capitolo; successivamente, nel quarto, abbiamo guardato alla seconda
Leitstimmung, il pudore.
Dopo queste prime due tonalità affettive abbiamo potuto indagare il valore delle
Stimmungen in generale nell’opera, tratteggiato nel quinto capitolo; abbiamo sempre qui
cercato il loro rapporto con il concetto fondamentale dell’opera, l’Ereignis.
Nel sesto capitolo abbiamo indagato quella che Heidegger definisce Grundstimmung, il
ritegno, analizzato nel suo aspetto patico ed etico. Cercandone punti di forza e individuandone
debolezze, siamo giunti a constatare la necessità di ricercare una Stimmung più forte.
Prima di farlo abbiamo però terminato l’analisi del concetto di Ereignis, illuminato di
luce nuova dalla ricerca sugli stati affettivi. Nel settimo capitolo infatti abbiamo analizzato il
rapporto delle Stimmungen con il centrale concetto di fondazione e, soprattutto, di spazio-
tempo.
Terminate queste analisi, nell’ottavo capitolo abbiamo potuto continuare la ricerca di una
Stimmung che autenticamente sia disponente. Attraverso l’analisi dello stupore (da Heidegger
considerata tonalità del primo inizio e dunque insufficiente) in questo ottavo capitolo, siamo
giunti alla scoperta del Danken, analizzato nel nono.
Attingendo soprattutto ad un testo di poco successivo ai Contributi e non ancora edito in
Italia, Das Ereignis, abbiamo potuto analizzare il Danken come Stimmung.
Tornando ai Contributi, nel decimo capitolo abbiamo analizzato la vocazione etica in
14
essi presente, nella forma della decisione e nei suoi due aspetti intesi da Heidegger.
Nell’undicesimo capitolo infine abbiamo tematizzato il sacro, che spesso nei Contributi
emerge e che ha potuto dirci ancora molto circa il valore delle tonalità affettive.
I risultati della ricerca sui Contributi sono racchiusi in un capitolo riassuntivo, il
dodicesimo, in cui abbiamo cercato di riepilogare novità e limiti emersi nella sezione.
La quinta sezione, quella conclusiva, vuole essere una prospettiva di ricerca concentrata sul
rapporto tra la concezione heideggeriana dell’affettività e quella aristotelica del movimento,
indagando soprattutto il testo del 1922 noto come Natorp Bericht e un breve scritto del 1939,
Sull’essenza e sul concetto della φύσις, Aristotele, Fisica B,1. Sono tre le ragioni che ci
spingono a collocarlo alla fine del lavoro e non nella sezione dedicata proprio alla lettura
heideggeriana di Aristotele. La prima è che molto viene dal testo del 1939, successivo dunque
ai Contributi. La seconda, ad essa legata, è che solo grazie a quanto guadagnato nei Contributi
(soprattutto circa la valenza etica dell’affettività) si può a nostro parere pienamente
comprendere la portata del pensiero aristotelico nel tentativo heideggeriano. La terza ed ultima
ragione è che in questo legame vediamo racchiusa una sorta di risposta-chiave alla domanda
che ha mosso l’intera ricerca, pur essendo tale risposta solo un sentiero, e non mai una ricerca
conclusa.