Titulis oppida capta legam: storia di un 'topos elegiaco' da Gallo ad Ovidio, (draft) "Philologus"...
Transcript of Titulis oppida capta legam: storia di un 'topos elegiaco' da Gallo ad Ovidio, (draft) "Philologus"...
P A O L A GA G L I A R D I
T I T U L I S O P P I D A C A P T A L E G A M : S T O R I A D IU N ‘Τ Ο Π Ο Σ E L E G I A C O ’ D A G A L L OA D O V I D I O
Fin dal primo apparire, il papiro di Gallo si è rivelato undocumento eccezionale, soprattutto per la possibilità chefinalmente ha dato di conoscere qualche cosa in più dell’operapoetica del fondatore dell’elegia erotica latina e di vagliare lasua influenza sui poeti contemporanei e sui continuatori del suogenere. Certo, si tratta solo di pochi versi, ma il peso che hannoesercitato sugli autori augustei può essere facilmente compresodal numero di allusioni, citazioni, richiami ai distici di QaṣrIbrîm presenti nei loro testi. Questo genere di confronti, utile afarci intravvedere, sia pure in minima parte, il dialogo fitto trai poeti su temi cruciali come il senso della poesia o lepossibilità dell’elegia erotica, è stato spesso sfruttato ancheper cercare di ricostruire il senso complessivo dei versi mutilidi Gallo, con il rischio tuttavia di attribuire ad essi quelle chepossono essere le riscritture dei continuatori, che magari dalconfronto con quel modello mirano a far emergere la lorooriginalità.
Tale dialogo appare particolarmente interessante riguardo aivv. 2-5 del papiro, incentrati su un tema inatteso in testielegiaci quale la partecipazione del poeta ad un previsto successomilitare di un Caesar non facilmente identificabile. Dei duedistici si trovano imitazioni chiaramente riconoscibili inProperzio e in Ovidio, orientati a prendere posizione sul temadelicato del rapporto con la politica, da loro vissuto in modoassai diverso rispetto a Gallo: proprio per affermare questedifferenze, entrambi dialogano direttamente con il predecessore,facendo delle caratteristiche della su quartina un vero e proprioτόπος, soggetto a mutamenti e rielaborazioni che appareinteressante seguire nel suo svolgersi, da Properzio fino allafine dell’elegia latina, con la produzione ovidiana dell’esilio.
Delle somiglianze tra i vv. 2-5 del papiro di Gallo e Prop.3,4 ci si è accorti fin dalla scoperta dei preziosi versi
1
galliani:1 per primi gli editores principes e poi diversi altri studiosihanno sottolineato le affinità formali e lessicali tra i duebrani, o meglio, l’imitazione volutamente riconoscibile deidistici galliani da parte di Properzio, in particolare ai vv. 10(ite et Romanae consulite historiae!, cfr. PQI 1, 3: maxima Romanae pars erishistoriae) e 15-16 (inque sinu carae nixus spectare puellae / incipiam et titulis oppidacapta legam, cfr. PQI 1, 4-5: multorum templa deorum / fixa legam spolieisdeivitiora tueis). Proprio da queste affinità si è tratta la speranza dipotersi servire dell’elegia properziana per cercare di ricostruireil contesto o dedurre il senso esatto dei versi del papiro,2 ma inquesta direzione Prop. 3,4 non si è rivelata decisiva come sisarebbe potuto sperare, poiché ovviamente nel confronto bisognasempre tenere presente il lavoro di rielaborazione, per non diredi deformazione, compiuto dal poeta rispetto al modello, inparticolare se -come in questo caso- la ripresa non è solo unomaggio al predecessore, ma ha la precisa intenzione di‘dialogare’ con la sua poesia. Dall’elegia properziana in realtàsi è presunto di dedurre molto, forse anche troppo più di quantonon dica: per il fatto che essa è riferita ad una (progettata)spedizione contro i Parti si è desunto ad esempio che anche iversi galliani riguardassero una campagna analoga e che dunquedebbano essere rivolti a Cesare alla vigilia della morte;3 dallosnodarsi dei temi in Properzio (propemptikòn ad Augusto in partenza,prefigurazione del suo trionfo e accostamento di un motivo eroticonell’immagine finale del poeta tra le braccia della puella) si ècreduto di poter avvalorare l’appartenenza dei distici galliani adun’unica elegia, in cui pure al propemptikòn per Cesare seguirebbeai vv. 6-9 del papiro il richiamo alla produzione erotica delpoeta e al valore di essa,4 ovvero l’affermazione di Gallo che isuoi versi in onore di Cesare sarebbero opera delle Muse, i carminadigna della sua donna.5
1 Cfr. PQI.1, vv. 2-5: Fata mihi, Caesar, tum erunt mea dulcia quom tu / maxima Romanae parseris historiae / postque tuum reditum multorum templa deorum / fixa legam polieis deivitiora tueis. 2 Cfr. Parsons / Nisbet (1979) 142 e Nisbet, ibidem, 152; Mazzarino (1980) 37-38e nota 53; Putnam (1980); Miller (1981); Hollis (2007) 243-244. 3 Miller (2004) 76-78, e Cairns (2006) 406-411 e 436-437. Sui complessi problemilegati alla datazione della quartina (o eventualmente di tutti i distici delpapiro) cfr. Gagliardi (2009).4 [……] tandem fecerunt carmina Musae / quae possem dominae deicere dignameae / ...........].atur idem tibi non ego Visce / ..]........l.kato iudice te vereor.5 Miller (2004) 76-78, e Cairns (2006) 406-411 e 436-437. Sulla questione dellaclassificazione dei versi come appartenenti ad un componimento unico, come braniantologici di diverse elegie o come testi completi (due quartine, la prima aivv. 2-5, a seconda ai vv. 6-9) e resti non classificabili di altri componimenti,
2
Anche riguardo alla possibilità di interpretare rettamente ivv. 2-5 di Gallo Prop. 3,4 non ha fornito un aiuto concreto, datala tendenza degli studiosi ad utilizzare la sua testimonianzasecondo i loro punti di vista, per sostenere posizionipreconcette: così chi riferisce legam a v. 5 di Gallo alla letturasuccessiva (in libri, lettere o resoconti) della vittoria diCaesar, dà poco peso ai vv. 15-16 dell’elegia properziana, in cuilegam allude invece alla lettura ‘epigrafica’ dei tituli annessi allespoglie durante il trionfo, e valorizza invece il v. 10 perl’interpretazione del termine historia nel senso di ‘storiografia,racconto di fatti storici’, che pure si ritiene possibileritrovare al v. 3 di Gallo.6 Al contrario, chi intende il testogalliano riferito al momento successivo alla cerimonia trionfale,quando il bottino veniva consacrato agli dei e deposto nei templi,enfatizza la testimonianza properziana di 3,4,15-16, relativa allalettura delle iscrizioni durante il trionfo.7 Infine le somiglianzetra i versi galliani e l’elegia di Properzio sono state esaminateper ricostruire il mutato rapporto degli elegiaci augustei versoil potere e l’atteggiamento (peraltro già noto) di Properzio versoAugusto.8 E’ evidente infatti che l’impressione di interesse e dipartecipazione del poeta alle sorti di Caesar suggerita dal testodi Gallo, in cui addirittura la felicità del parlante è fattadipendere dal successo dell’impresa, è ben lontana dal tono diProp. 3, 4, troppo enfatico per risultare sincero nella primaparte e poi bruscamente mutato nel finale per esprimere unadistanza emotiva e intellettuale che si traduce nellariaffermazione del primato, per il poeta, della scelta di vitaelegiaca. In quest’ottica la ripresa dei versi di Gallo da parte
cfr. la bibliografia citata in Gagliardi (2010) 56-57, nota 3.6 Tra gli studiosi che, nella scia di Parsons / Nisbet (1979) 141-142,riferiscono legam di Gallo alla lettura di resoconti successivi, lettere ovveroopere storiografiche cfr. Giangrande (1981) 41-42; Nicastri (1984) 104, nota 29;Verducci (1984) p. 133 (che più che ad opere storiografiche pensa a poemi diargomento storico), Luther (2002). Giustamente Stroh (1983) 212, nota 25,osserva come in fondo i due valori del termine non siano in concorrenza l’unocon l’altro, essendo la storia scritta l’effetto e il riflesso di quellacompiuta.7 Cfr. Mazzarino (1980) 37-38 e nota 53, che ha proposto l’interpretazione di
una ‘lettura epigrafica’ (cfr. ibidem, 33-50, e Mazzarino 1982, 330-331), accoltada Barchiesi (1981) 154; Newman (1980) 86; Geraci (1983) 98-99; Whitaker (1981)89-90; Sbordone (1982) 63; Schoonhoven (1983) 76-78; Danesi Marioni (1985) 93-98; Morelli (1985) 151-153; Courtney (1993) 265-266; Cresci Marrone (1993) 142-143; Miller (2004) 76; Cairns (2006) 435-437.8 Cfr. in tal senso Barchiesi (1981) 160-161; Putnam (1980) 54-55.
3
di Properzio è stata letta più sul versante ‘politico’ che suquello letterario, laddove invece a me pare che Properzio con lasua imitazione voglia instaurare con il predecessore anche undialogo poetico, solitamente poco considerato.9 In esso tuttaviaciò che conta di più non sono le somiglianze, che per Properziorappresentano solo il punto di partenza per istituire ilconfronto, e che non possono certo servire ad improbabili enecessariamente aleatorie ricostruzioni dell’ipotetica elegiagalliana che conteneva i versi di Qaṣr Ibrîm, ma le differenze cheproprio attraverso le affinità apparenti il poeta umbro vuolesuggerire. Per fare ciò è necessario tuttavia analizzare in primoluogo i versi galliani nella loro singolarità e poi il rapportodialogico e talora polemico che Properzio in più di un caso sembraistituire con essi.
Tra i numerosi e notevoli elementi di novità dei distici diGallo scoperti a Qaṣr Ibrîm10 spiccano sicuramente il tema e iltono dei vv. 2-5, assolutamente imprevedibili per gli studiosimoderni per la presenza di una tematica politica. Certo,l’interesse per argomenti di questo genere in un poeta il cuiimpegno pubblico è ben noto non è fuori luogo, ma l’atteggiamentodegli elegiaci successivi verso questi temi, di totaleindifferenza o di polemica più o meno velata, rende la posizionedi Gallo un unicum nell’elegia erotica latina. Non solo;l’atteggiamento partecipe verso la spedizione di Caesar rivela unacommistione inattesa tra la figura storica dell’autore con i suoiinteressi e la persona letteraria dell’amante protagonista dellesue elegie.11 E’ una strada, questa, sulla quale Gallo non sarà9 Vi ha accennato Barchiesi (1981) 161-162 e 164-166, nell’àmbito di unconfronto tra i due poeti che segue lo sviluppo anche ideologico dell’elegiaaugustea da come appare oggi attraverso i distici di Qaṣr Ibrîm a come approdaalla produzione ‘matura’ di Properzio.10 Sulla cui autenticità oggi il dibattito appare definitivamente esaurito, dopoi dubbi sull’autenticità del papiro da Qaṣr Ibrîm, avanzati da Brunhölzl (1984)33-37, e da Silagi (1999) 357-373, e confutati da Blänsdorf (1993) 43-50; daBallaira (1987) 47-54; da Morelli (1988) 104-119; da Capasso (2004) 26-36, edopo la questione della paternità di Gallo, negata da Giangrande (1981) 41-44;Giangrande (1980) 141-153; Giangrande (1982) 83-93; Giangrande, ibidem, 99-108, eda Naughton (1981) 111-112, ma sostenuta dalla maggioranza degli studiosi (cfr.Van Sickle 1981, 115-124; Van Sickle, ibidem, 125-127; Nicastri 1995, 175-200).11 Che già l’elegia di Gallo presentasse i tratti più peculiari del genere comelo conosciamo dai successori è facilmente immaginabile quanto meno dal titolo diinventor generis datogli dagli antichi (cfr. Ov. Trist. 4,10,53-54 e Quint. inst.10,1,93), che evidentemente vedevano nei suoi componimenti gli aspetticostitutivi della nuova elegia latina.
4
seguito dai continuatori, cosicché manca del tutto in loroqualcosa di simile alla quartina di Qaṣr Ibrîm. La mescolanza ditemi nella produzione di Gallo e la presenza di interessi realidel poeta accanto ai temi d’amore hanno fatto accostare la suafigura a quella di personaggi come Lutazio Catulo e Calvo, per iquali la composizione poetica rappresentava un lusus nei momenti diotium,12 ma io credo che per Gallo il discorso sia diverso, poichésicuramente la storia d’amore elegiaca deve aver avuto per lui unacontinuità e un peso più grandi rispetto all’impegno poetico diautori di piena età repubblicana, per i quali la letteratura nonpoteva essere che uno svago tra gli impegni politici. Il titolo diinventor generis dell’elegia erotica, attribuito a Gallo dagliantichi,13 presuppone infatti una certa consistenza dellaproduzione e la fissazione di elementi destinati a diventaretipici del genere; piuttosto, la presenza di temi diversi daquello erotico e in particolare l’interesse politico attestano unostadio dell’elegia non ancora focalizzata sull’amore, secondo unverosimile percorso che da una certa libertà di temi si fissaprevalentemente su quello erotico per poi ampliarsi di nuovo negliultimi libri properziani e nelle sperimentazioni ovidiane.14
Ma la quartina galliana, al di là delle difficoltàinterpretative,15 presenta anche altri notevoli motivi di
12 Così Pinotti (2002) 63.13 Cfr. Ov., Trist., 4, 10, 53-54; Quint., Inst., 10, 1, 93. 14 Un simile percorso dell’elegia di Gallo ha immaginato Ross (1975) 39-50; 107-110, ipotizzando che da un iniziale interesse per temi mitologici eruditi delgenere del poemetto sulla Grynei nemoris origo attestata da ecl. 6,64-73 il poetafosse arrivato a privilegiare la tematica erotica, aprendo la strada aicontinuatori, che tuttavia anch’essi torneranno ad includere temi diversi in ungenere sempre a rischio della monotonia e della ripetitività connessi al temad’amore.15 Tra cui l’interpretazione dei contorti vv. 4-5, in particolare per viadell’espressione involuta fixa (sc. templa) legam spolieis deivitiora tueis, con le suedifficoltà sintattiche (non è facile legare fixa e deivitiora e intendere il valoredel participio), l’interpretazione di legam, inteso come ‘scan, survey’ daPutnam (1980), 52 e nota 10, seguito da Van Sickle (1981), 120, nota 23;Petersmann (1983), 1651; Stroh (1983), 213 e nota 26; Gómez Pallarès (2005),104-109, ma più comunemente come ‘leggerò’, in relazione alla lettura che ilpoeta prevede di fare in libri di storia o in lettere o in resoconti delsuccesso di Cesare (il che presupporrebbe che egli immagini di non poter esserea Roma al ritorno della fortunata spedizione), ma anche ad una letturacronologicamente più vicina ai fatti, quella dei tituli affissi alle spogliedurante il trionfo e poi depositati nei templi insieme agli oggetti cheindicano. Quest’interpretazione (sulla quale cfr. la bibliografia alla nota 5),generalmente preferita dagli studiosi, ha il vantaggio di ridurre lo scartocronologico tra il momento della vittoria e quello in cui il poeta ne godrà,
5
interesse: essa appare il primo esempio latino di propemptikòn ‘dainferiore a superiore’16 così come si configurerà in poesiaaugustea. Pur essendo infatti difficili da classificare in ungenere unico, come giustamente è stato osservato,17 questi versirientrano, almeno per certi aspetti, nel genere del propemptikòn,portato con ogni probabilità a Roma da Partenio di Nicea,18 la cuiinfluenza su Gallo è fuori discussione, dati gli stretti rapportiattestati dalla dedica degli Ἐρωτικὰ παθήματα. L’unico altropropemptikòn di cui si abbia notizia, anch’esso verosimilmenteinfluenzato da Partenio, è quello di Cinna per Pollione,precedente di alcuni anni ai distici galliani, ma impostato sucriteri senza dubbio diversi, in quanto dedicato ad un amico inpartenza per un viaggio in Grecia, che diventa occasione perexcursus di geografia erudita.19 Rispetto a questo standard i versigalliani appaiono diversi: innanzitutto il rapporto con ildestinatario non è di parità, anzi il poeta si presenta come uncittadino comune rispetto ad un uomo importante, secondo unostilema riconducibile alla Herrscherideologie ellenistica che fadipendere la felicità dei sudditi da quella del sovrano.20 Insecondo luogo la stringatezza del testo, ma probabilmente ancheuna consapevole scelta compositiva, elimina tutti gli aspettirelativi al viaggio e alla destinazione di Caesar per focalizzarsisul momento più importante del ritorno, che consente al poeta nonsolo di esaltare la gloria orma raggiunta dal destinatario, maanche di introdurre il tema del trionfo, sicuramente nuovo nellatradizione del propemptikòn: la natura del viaggio di Caesar e ilruolo di assoluta preminenza del personaggio consentono questeinnovazioni, destinate a trovare successo e ulteriori sviluppi in
dando all’insieme un’immediatezza sicuramente più efficace di uno scartotemporale ampio come quello necessario alla produzione, all’invio e alla letturadi resoconti, lettere o libri sugli eventi. In secondo luogo, tale letturaappare rispettosa di un aspetto tipico della mentalità romana, l’attenzione almessaggio epigrafico, al quale proprio Gallo appare particolarmente sensibile,come dimostrerà con le due iscrizioni rinvenute in Egitto, quella sull’obeliscodi piazza S. Pietro a Roma e soprattutto la grande stele di Philae. 16 Secondo la classificazione del retore Menandro di Laodicea, cfr. Nicastri(1984) 108 e 153-176, e Cairns (2007); Cairns (2006) 413-414.17 Da Nicastri (1984) 108.18 Così ritiene Cairns (2006) 413. Sul propemptikòn di Partenio si sa assai poco,ma si trattava probabilmente di un testo ricco di elementi mitologici eruditi:cfr. Nicastri (1984) 162, nota 17.19 Sulla datazione del propemptikòn Pollionis e sulle sue caratteristichericostruibili cfr. Hollis (2007) 21-23.20 Cfr. Barchiesi (1981) 157.
6
età augustea, quando i singoli poeti le adatteranno alle loroesigenze e ai loro punti di vista.
Degno di nota è anche il modo in cui Gallo introduce nel testoil tema del trionfo, non presentandolo direttamente, ma facendolobalenare all’immaginazione del lettore solo attraverso unriferimento indiretto nella menzione del bottino nei templi,mentre l’interesse preminente del testo si concentra sullaricchezza delle spoglie, segno tangibile dell’importanza dellavittoria.21 E’ una tecnica compositiva di matrice alessandrina, edunque di quel gusto in cui Gallo si era formato: la descrizionedella scena non investe l’insieme, ma si sofferma su unparticolare da cui tocca al lettore ricostruire il contesto.22 Intal modo il poeta, oltre a sorprendere con una rappresentazioneinattesa, si riserva la possibilità di dare rilievo a ciò che piùgli sta a cuore e nel giro di due versi suggerisce sia l’idea delgrandioso trionfo di Caesar, sia quella dello splendore delbottino. Interessante, infine, è la trattazione del trionfo noncome dato attuale e contemporaneo, ma come prefigurazione di unevento futuro, che l’autore dà per certo fino ad immaginarne idettagli. Anche quest’aspetto troverà notevole fortuna presso glielegiaci più giovani.
Se questi sono gli elementi più notevoli della quartinagalliana sul piano letterario, ne va rilevata l’assoluta e decisanovità nel panorama della poesia latina, che di certo non sarebbesfuggita agli autori contemporanei; né d’altra parte questatendenza all’originalità sorprende in un poeta che per molti versiappare un innovatore23 e che proprio per il propemptikòn sembra avereavuto un interesse particolare, a giudicare dalle connotazioni chedeve aver conferito al genere in àmbito erotico secondo latestimonianza di Virg. ecl. 10,46-4924. In questi versi infatti, adetta di Serv. ad loc. translati da quelli dello stesso Gallo (e cisono diverse ragioni per dare credito a questa testimonianza25), iτόποι del propemptikòn appaiono capovolti per più aspetti: non solo21 L’enfasi sulla ricchezza delle spoglie è uno degli argomenti che consentono diescludere alcune delle possibili campagne militari proposte, come quella diOttavano in Illiria del 35, sostenuta da Hutchinson (1981) 37-41 (contra, Geraci1983, 97). 22 Cfr. Nicastri (1984) 130-131.23 La stessa inventio dell’elegia erotica, attribuitagli dagli antichi, rivela lasua attitudine ad innovare i dati ella tradizione: rispetto all’ereditàneoterica e a quella ellenistica, infatti, egli riesce a dare al nuovo genereuna fisionomia e uno statuto sicuramente originali. 24 Tu procul a patria (nec sit mihi credere tantum) /Alpinas, a! dura niues et frigora Rheni / me sine solauides. a, te ne frigora laedant! / a, tibi ne teneras glacies secet aspera plantas!
7
al tradizionale itinerario marino dell’amata è sostituito unoterrestre per luoghi aspri e ostili, ma soprattutto compare lafigura del rivale,26 che rende inusitato ed estremo l’attaccamentodel poeta alla sua donna, proponendo il tema del “superamentodell’infedeltà dell’amata”,27 manifestazione massima del servitiumamoris, destinato a diventare un τόπος presso gli altri elegiaci.
La novità e le possibilità di sviluppo dei vv. 2-5 di Gallovengono pienamente colte da Properzio, che li rielabora in unsenso ben preciso. Per quello che i pochi versi di Qaṣr Ibrîm e ipossibili riferimenti all’opera galliana nella sua poesia lascianointravvedere, il rapporto di Properzio con il predecessore sembraalquanto complesso: certamente della poesia galliana egli sentìforte l’influsso, in particolare nei primi libri, anche per viadella tematica prevalentemente erotica,28 ma rispetto ad essadovette sentire il bisogno di affermare la propria originalità,talvolta estremizzando posizioni e conclusioni. Se ciò èavvertibile soprattutto attraverso il confronto di certi puntidelle sue elegie con le ecll. 6 e 10 di Virgilio, in cui Gallocompare come personaggio e sicuramente come modello poetico,29
anche i versi del papiro hanno confermato questa tendenza. Così
25 Sul dibattuto passo dell’ecloga cfr. Hollis (2007), 236-237, e Gagliardi(2014), ad loc., 182-195. Sia sul piano stilistico, sia su quello concettuale, ivv. 46-49, ribattezzati propemptikòn Lycoridis, appaiono assai distanti dalla poesiavirgiliana: il tono altamente patetico, costellato di esclamazioni (si noti lafrequenza dei tre a nei vv. 47-49, l’incidentale nec sit mihi credere tantum a v. 46,la serie di frasi esclamative), di inversioni (me sine; te ne, v. 48; tibi ne, v.49), il ricorso a termini (dura, teneras, aspera) e concetti (il contrasto tra ilduro e il molle) elegiaci, ma soprattutto la concezione di un amore così forteda superare persino il tradimento e l’abbandono da parte dell’amata e continuarea preoccuparsi per il suo benessere addirittura mentre è in fuga con il rivalesono tutti elementi lontani dalla concezione dell’amore virgiliana, basata sulladiffidenza verso gli eccessi e su una considerazione della passione violentacome temibile e distruttiva. Non facile è naturalmente intendere translati, diServ. ad ecl. 10,46: sulla difficoltà d'interpretazione del passo e suitentativi di delimitare il numero degli esametri che Virgilio può aver ripresoda Gallo, cfr. ad esempio Bardon (1949) 223; Luiselli (1967) 80; ROSS (1975) 88-89 e 100; Kelly (1977) 17-20; Yardley (1980) 48-51; Cupaiuolo (1981) 55, nota22; D’Anna (1989) 60.26 Ritenuta innovazione galliana da Du Quesnay (1979) 60-61.27 La definizione è di Nicastri (1984) 26.28 I debiti di Properzio verso Gallo, in particolare nella Monobiblos, sono statistudiati da Cairns (2006), sia pure con diverse forzature e conclusioni nonsempre condivisibili.29 Su questi rapporti cfr. il filone di studi partito da Skutsch (1901 e 1906) eproseguito da Ross (1975) e recentemente da Cairns (2006).
8
sembra ad esempio per la discussa questione della domina iudex, daintendersi probabilmente come presa di posizione estrema diProperzio rispetto alla richiesta di Gallo del giudizio di Visco(nessun iudex se non la puella stessa può esprimere una valutazionedei versi a lei dedicati),30 e forse nell’incipit del libro II labaldanzosa affermazione dei vv. 3-4 (non hec Calliope, non haec mihi cantatApollo. / ingenium nobis ipsa puella facit) potrebbe rispondere alladichiarazione dei vv. 6-7 del papiro che attribuisce alle Muse lapaternità dei versi galliani.
Nel caso dei vv. 2-5 di Gallo l’intento di Properzio èabbastanza evidente e rientra nella stessa logica diestremizzazione delle posizioni rispetto a Gallo. Se infatti iversi per Caesar sembrano mostrare che questi non limitava ancoraesclusivamente o quasi l’elegia a temi erotici, ma in essa davavoce anche alla passione politica, alla polemica letteraria eprobabilmente ad altri argomenti, Properzio -basti rileggere 1,1-mira fin dall’inizio a presentare non solo un’inscindibile unionedi vita e di poesia, ma anche una scelta di vita fermamenteportata avanti: ad essa egli dichiara in più occasioni disubordinare qualsiasi altro interesse, sia come poeta, sia comeuomo, ostentando indifferenza, quando non disprezzo, per tutto ciòche non sia Cinzia e il suo amore per lei. Non sorprenderebbedunque se egli mostrasse la volontà di ‘correggere’ anche gliaspetti dell’opera di Gallo incompatibili con quest’orientamento emirasse a ridurre i temi e i punti di vista di essa entro unavisuale erotica. Ciò apparirebbe tanto più pregevole quanto piùdistanti fossero gli argomenti dal tema d’amore, come appunto nelcaso della celebrazione di un potente e della dichiarazione delproprio coinvolgimento politico: in particolare nel libro III,quando ormai l’appartenenza al circolo di Mecenate impone aProperzio l’‘allineamento’ su certi temi e certe posizionipolitiche e la celebrazione del princeps diviene inevitabile, eglirecupera i versi di Gallo, precedente importante del tema, ma soloper adeguarli ad un punto di vista pur sempre critico, se nonpolemico, verso la propaganda augustea. Così in una scoperta econsapevole ripresa della quartina galliana Properzio ripropone iltema della campagna militare vittoriosa e del trionfo, ma con uninatteso scarto riporta il tutto ad un àmbito assolutamente
30 Se l’idea della domina iudex sia già nei versi di Gallo ovvero siaun’innovazione properziana il dibattito è aperto: cfr. Gagliardi (2012).
9
privato, connotato da elementi erotici nell’immagine di sé tra lebraccia della puella.31
L’accostamento al tema celebrativo di quello del godimentoprivato non è invero una novità di Properzio, poiché le odioraziane avevano recentemente mostrato in modo originale lapossibilità di conciliare i due àmbiti (lasciando -per inciso-intravvedere qualcosa dell’atteggiamento reale del poeta verso lapropaganda augustea32): in particolare in carm. 3,14 la gioiacollettiva per il ritorno trionfale di Augusto si traduce in unafesta privata all’insegna della misura, che risulta la parte piùsincera del componimento.33 Rispetto ad Orazio però Properzio tienea dare un taglio diverso al trattamento del tema e soprattutto aconnetterlo all’elegia, come dimostra la scelta esibita dei versidi Gallo come modello. A rivelare la differenza del suoatteggiamento verso il tema, non di entusiastica condivisione, madi interesse solo apparente, che nel finale svela a sorpresa ilsuo vero punto di vista, sono la strutturazione del testo esoprattutto le visibili deviazioni da Gallo. Naturalmentel’ampiezza assai maggiore della sua elegia rispetto ai due disticidi Qaṣr Ibrîm consente a Properzio di soffermarsi più a lungo suidettagli della scena e soprattutto di ampliare il motivo dellaricchezza del futuro bottino, forse anche con un intento criticoverso le motivazioni della spedizione, presentata ufficialmentecome occasione per vendicare l’affronto di Carre, ma in realtàmotivata -almeno secondo il poeta- dall’avidità di ricchezze.34 Mala deviazione più notevole dai versi galliani è lo spostamentocronologico al momento della sfilata trionfale e il riferimentodella lettura ai tituli condotti in processione insieme alle spoglie.Anche questo ha una precisa ratio. Al di là dell’ostentatoentusiasmo, infatti, scopo dell’elegia è trasmettere lasostanziale indifferenza del poeta per la spedizione e per ilbattage propagandistico che la accompagna: ponendo l’accento sul
31 Sulla trasformazione ideologica dei versi di Gallo in Prop. 3,4, cfr.Barchiesi (1981) 161.32 Cfr. Nicastri (1984) 110.33 Per Barchiesi (1981) 158, l’atteggiamento di Hor. carm. 3,14 è analogo aquello di Gallo nei vv. 2-5 per la “insistenza sulla partecipazione del privatoindividuo alle sorti augustee”. Orazio precisa tuttavia le modalità del tuttoprivate della festa che vorrebbe fare, laddove Gallo dà solo l’impressione dellasua totale condivisione del successo di Cesare. L’ode oraziana appare invecevicina nello spirito di distacco a Properzio a Nicastri (1984) 109-110.34 Cfr. vv. 1-3 (Arma deus Caesar dites meditatur ad Indos, / et freta gemmiferi findere classe maris. /magna, viri, merces! parat utima terra triumphos); si veda l’analisi di Wilkinson (1960)1091-1103, seguito da Barchiesi (1981) 161, e da Putnam (1980) 54-55.
10
momento culminante del trionfo per poi prendere le distanze daesso e presentarsi spettatore anonimo tra la folla, Properziodichiara di fatto quanto poco lo colpiscano le glorie nazionali,peraltro più ostentate che reali, e quanto egli continui apreferire ad esse la sua posizione defilata e la sua scelta divita. Proprio enfatizzare il momento più alto dell’evento vale asminuirne il senso e la portata, nel momento in cui ad esso èaccostato, in stridente contrasto, l’atteggiamento distante e laposizione anonima del poeta. Sintomatico in tal senso è il v. 10(ite et Romanae consulite historiae), in cui il riecheggiamento del v. 3 diGallo, evidente nel nesso Romanae … historiae in clausola, acquista unsenso completamente diverso -o meglio, opposto- rispetto allaformulazione originale: laddove infatti Gallo conquell’espressione enfatica augura a Caesar una gloria mai ottenutada alcuno, mostrandosi pienamente partecipe della gioia che daquesto deriverà, Properzio affida ad altri, i partecipanti allaspedizione, il compito di condurre a termine la grande impresa,segnando proprio con la seconda persona plurale la sua distanzadai partenti (ite in particolare, anticipato da ite agite a v. 7, èincisivo in tal senso). Invece del serrato susseguirsi di elementidi prima e seconda persona singolare di Gallo (mihi; mea; tumarcato in clausola), che rende tangibile un rapporto personale difiducia e di dedizione, ma anche l’intrecciarsi dei destini delpoeta e di Caesar, fino a far dipendere la felicità del primo dalsuccesso del secondo, c’è qui la netta separazione tra un ‘voi’ oun ‘essi’ alquanto indistinto (di Augusto si parla addirittura interza persona a vv. 19-20),35 e un ‘io’ insistentemente presentatoin disparte, le cui uniche azioni sono quelle di guardare, leggeree applaudire.36
Anche l’augurio di poter vivere quel giorno felice che ilpoeta fa a se stesso e che sembra riecheggiare l’incipit del testogalliano (in particolare l’accenno alla propria morte potrebbeevocare fata del v. 2 del papiro, pure talvolta inteso nel senso di‘morte’37) ha un tono ben diverso da quello di Gallo: se infatti35 Ipsa tuam serva prolem, Venus: hoc sit in aevum, / cernis ab Aenea quod superesse caput: cfr.Putnam (1980) 54.36 Sono proprio queste differenze -per inciso- volute dal poeta per marcare ladistanza ideologica da Gallo, a rendere difficilmente utilizzabile Prop. 3,4 perl’esegesi della quartina di Qaṣr Ibrîm: il riferimento di legam alle spogliedurante il trionfo, ad esempio, può solo vagamente essere sostenuto dal testoproperziano proprio per lo spostamento cronologico che il poeta umbro compie almomento della sfilata rispetto a quello successivo a cui pensa Gallo.37 Su quest’interpretazione di fata -peraltro non accettata da tutti- cfr. Hollis(2007) 244-245. Cfr. anche Morelli (1985) 145, che cita vari esempi properziani
11
costui, ponendo all’inizio il riferimento al suo destino (in vitao in morte che sia), dichiara subito l’importanza cruciale che haper lui il successo di Caesar, la ripresa properziana del motivo,al centro del componimento, ha soprattutto l’aria di richiamare ilmodello per ridimensionarne l’affermazione. Gallo infatti pone ladolcezza della sua sorte in relazione con la gloria ineguagliabiledi Caesar (‘il mio destino sarà dolce nel momento in cui tudiverrai la parte più grande della storia romana’), riservando alsecondo termine del confronto (la gloria di Caesar) uno spaziodecisamente maggiore che al proprio futuro (egli di fatto scomparedal resto del testo, lasciandosi solo lo spazio minimo di legam).Ciò che più risalta tuttavia nel linguaggio franco della quartinaè la sicurezza che Cesare riuscirà nell’impresa: Gallo non diceche egli sarà felice se Caesar avrà successo, ma quando ciòavverrà, dando così per scontato l’esito positivo. La sua felicitàè dunque in rapporto con un evento concreto e sostanziale, lavittoria di Cesare: rispetto a questo la lettura evocata al v. 5(sc. templa- fixa legam spolieis deivitiora tueis), con l’accenno al trionfo,sposta la prospettiva ad un momento successivo, quando la gloriaottenuta sarà sancita dal più alto riconoscimento. In tal modoGallo nel suo augurio a Cesare accosta sinteticamente i duemomenti cruciali del successo, l’effettivo ottenimento e lacelebrazione ufficiale, ma è ovvio che il secondo evento èsubordinato, sia cronologicamente, sia per importanza, al primo.
Di ben diverso tenore, invece, l’augurio di Properzio: la suasperanza è solo quella di vedere il giorno del trionfo, ma nonsarà questo a rendere felice il suo destino; quella che in Galloera la premessa di tutto il discorso, l’affermazione che la suafelicità potrà essere raggiunta solo al momento e a causa delsuccesso di Cesare, non ha riscontro nelle parole di Properzio,che si augura semplicemente di vivere tanto da assistere altrionfo, senza che questo sembri toccarlo intimamente ocondizionare il suo benessere interiore. Rispetto a Gallo,inoltre, il suo augurio ha un punto di arrivo decisamente piùfiacco, poiché il desiderio di sopravvivere fino al giorno deltrionfo si lega direttamente a quel momento, passando sottosilenzio il dato più importante della vittoria, che dovrebbeessere invece il primo motivo di gioia; tra l’altro laformulazione della frase lascia il dubbio che l’auspicio diProperzio non sia tanto quello di assistere al trionfo, ma quellodi quest’uso di fata, ma lo esclude nei versi di Gallo, che striderebbe con «lasolennità festosa del contesto». Parsons / Nisbet (1979) 141, rilevano in fata «amelanchoy note (appropriate to elegy) » e un contrasto di tono con dulcia.
12
di godere della festa in … sinu carae nixus puellae (v. 15), cioè di avereun’occasione per stare con l’amata. Anche l’insistenza sull’àmbitovisivo (videam, v. 13, spectare, v. 15, legam, v. 16) sottolinea piùil carattere spettacolare della scena che la reale importanzadell’evento e sembra ridurre il tutto ad una frivolaspettacolarizzazione, o quanto meno suggerire che per Properziosarà questo l’aspetto più importante. Il che equivale, di fatto, asminuire la portata vera e il valore storico del trionfo.
Un altro aspetto della rielaborazione properziana di Galloinduce alle stesse conclusioni: la presentazione della scena deltrionfo non è evocata indirettamente, come nel modello, ma èdescritta con vivida precisione, fin quasi a far rivivere laconfusione e le emozioni del momento (vv. 11-18).38 Eppure questo,che sembrerebbe dare all’evento un’enfasi maggiore dell’evocazionein apparenza marginale di Gallo, ottiene l’effetto contrario nelconfronto con l’atteggiamento defilato e poco partecipe diProperzio che si limita ad applaudire lungo la Via Sacra. Daquesto contrasto l’importanza del trionfo appare sicuramenteridimensionata e proprio l’enfatizzazione del suo svolgimento neattenua la portata, quando il poeta ci pone dal suo punto divista, che al di là delle dichiarazioni formali resta distante siafisicamente, sia emotivamente dall’evento. D’altronde, aconfermare quest’ottica di lettura è l’elegia successiva, la 3,5,aperta da una dichiarazione lapidaria e provocatoria (pacis Amor deusest) che precisa la posizione ideologica del poeta rispetto a temipolitici e militari e illumina il suo autentico sentire rispettoalla spedizione partica, al di là dell’enfasi di certi passi, dicui si svela ora più chiaramente l’insincerità.39
Letta in parallelo al testo galliano, con cui si poneapertamente a confronto, l’elegia 3,4 di Properzio ne apparedunque un’abile rielaborazione, capace di ‘dialogare’ al tempostesso con il modello sul piano letterario e con la propagandaaugustea su quello ideologico. Rispetto a Gallo la ripresa dimovenze e linguaggio della quartina per Caesar vale a riaffermarela prevalenza della tematica erotica nell’elegia, di contro alla
38 Mars pater et sacrae fatalia lumina Vestae, / ante meos obitus sit precor illa dies, / qua videam, spoliisonerato Caesaris axe, / ad vulgi plausus saepe resistere equos, / inque sinu carae nixus spectare puellae /incipiam et titulis oppida capta legam, / tela fugacis equi et bracati militis arcus / et subter captos armasedere duces!39 Prosegue peraltro anche qui la polemica con l’avidità di ricchezze adombratanella 3,4, a ribadire la natura non ingenua delle affermazioni lì fatte sullaconsistenza del bottino favoleggiato, dal quale il poeta prende le distanze a3,4, 21-22 (praeda sit haec illis, quorum meruere labores: / me sat erit Sacra plaudere posse Via).
13
tendenza del predecessore ad includervi temi diversi: contaminandoil tema celebrativo, opportunamente ritoccato per esprimeresentimenti e punti di vista non proprio analoghi a quelli diGallo, con quello d’amore, sia pure solo accennato nell’immaginedel poeta abbracciato alla sua donna, Properzio riafferma,ribattendo idealmente a Gallo, la priorità dell’elemento eroticonell’elegia, anche in concomitanza con temi ideologicamentedistanti, nei quali esso si inserisce mutandoli di senso e diimportanza. Ma questa contaminazione ha anche un notevole effettoverso la propaganda augustea e la poesia ‘allineata’ ad essa, ecioè quello di ribadire l’estraneità, se non la tendenza critica,rispetto all’ideologia del regime: mentre mostra di rispondere aGallo per rivendicare un ruolo preminente all’elegia erotica,l’inserimento del motivo d’amore in un testo formalmentecelebrativo del princeps e della sua politica sminuisce non solo iltema politico e propagandistico, che finisce per risultareestraneo all’ottica properziana, ma anche l’importanza dellacelebrazione in sé, ridotta in effetti ad un’occasione di incontrocon la puella. Ciò dà modo al poeta non solo di riaffermare la suavocazione elegiaca, nonostante l’appartenenza al circolo diMecenate, ma anche di esprimere in modo velato le sue remorerispetto alla politica e alla propaganda augustee. Il confrontocon Gallo diventa così occasione per un audace dialogo letterario,ma al tempo stesso offre a Properzio l’opportunità di pronunciarsisu temi e situazioni attuali senza avere l’aria di dichiarare unaperto dissenso: modificando abilmente il modello, egli riesce atrarne significati assenti e addirittura antitetici a quellioriginari e crea così un τόπος destinato ad essere ben compresonelle sue finalità e possibilità di rielaborazione.
Sarà un altro poeta elegiaco, Ovidio, a seguire Properziosulla strada della trasformazione del testo galliano, adattandoloagli scopi e al messaggio dei suoi componimenti in momenti diversidella sua vita e della sua produzione. In un lungo passo dell’Arsamatoria (1,177-228), ritenuto in origine un’elegia a sé, poiinserita nell’opera,40 l’augurio per la partenza di Caio Cesare, ilnipote di Augusto, contro i Parti si protrae enfaticamente per 35versi, in cui alla celebrazione del giovane comandante (vv. 177-197) segue la previsione entusiastica della sconfitta dei nemici(vv. 198-212);41 gli ultimi 16 versi (213-228) -quelli che ci40 Cfr. Cairns (2006) 412.41 Nicastri (1984) 110, nota 38, vede nel brano un sincero patriottismo e unacritica velata alla soluzione diplomatica della questione partica da parte di
14
interessano- sono dedicati al ritorno e alla sfilata trionfale,con la descrizione dei capi nemici catturati e dei tituli con i nomidi luoghi e persone. L’elemento interessante (e provocatorio) inquest’ultima parte (vv. 217-22042) è la notazione che allacerimonia assisteranno giovani uomini e fanciulle, e che quindil’evento può essere una propizia occasione per conoscere ecorteggiare ragazze, dandosi l’aria di illustrare i tituli,aiutandosi con i disegni o al bisogno inventando, ma in modocredibile, come scherzosamente il poeta suggerisce nell’ultimodistico. Della quartina galliana -va detto- il brano ovidianoconserva poco,43 appena il richiamo ai tituli trionfali: esso è inrealtà una rielaborazione di Prop. 3,4, di cui rappresenta unampliamento. Proprio la dilatazione dei temi e l’abbondanza diretorica denunciano l’insincerità dell’ostentato entusiasmo,mentre la conclusione, che suggerendo la possibilità d’incontrocon le ragazze ritorna al tono e al tema dell’opera, sembra anchequi, come nell’elegia properziana, sminuire l’importanza di ciòche si è detto prima: anche qui, cioè, il trionfo dopotutto non èche il pretesto per interessi di altro genere, per incontrigalanti e corteggiamenti. Coerente con la natura erotico-didascalica dell’Ars, tuttavia, Ovidio modifica il senso e lafinalità del τόπος: se infatti esso serviva a Properzio a ribadirela centralità della scelta di vita e di poesia elegiaca erotica,nell’operetta properziana rientra negli intenti didascalicidell’autore, che sta appunto elencando le situazioni e leoccasioni in cui si possono incontrare fanciulle. Così l’eventograndioso del trionfo, al di là del tono encomiastico dicircostanza, ha la stessa importanza di un banchetto o di unospettacolo circense per il fine che l’autore (e il suo idealediscepolo) si propone. In tal modo il contrasto già rilevabile inProperzio tra la grandiosità della scena e le motivazioni deltutto private del poeta diviene ancora più stridente, poiché mancaqui anche l’elemento affettivo dell’amore per la puella, che poteva
Augusto (v. 201).42 Spectabunt laeti iuvenes mixtaeque puellae, / diffundetque animos omnibus ista dies. / atque aliqua exillis cum regum nomina quaeret, / quae loca, qui montes, quaeve ferantur aquae, / omnia responde, nectantum siqua rogabit; / et quae nescieris, ut bene nota refer. / hic est Euphrates, praecinctus harundinefrontem: / cui coma dependet caerula, Tigris erit. / hos facito Armenios; haec est Danaëia Persis: / urbs inAchaemeniis vallibus ista fuit. / ille vel ille, duces; et erunt quae nomina dicas, / si poteris, vere, si minus,apta tamen.43 Nonostante l’opinione diversa di Cairns (2006) 412-434, che dal passo ovidianopretende anche di ricostruire lessico e temi di poesia galliana perduta, ma chepure riconosce a p. 417 come modello principale del passo Prop. 3,4, che Ovidioamplia.
15
in qualche misura giustificare l’indifferenza per gli affaripubblici e il desiderio di cogliere un’occasione per stare conlei: nel caso di Ovidio l’interesse per il trionfo appare talmentefrivolo da sfiorare l’irriverenza, tanto più se si pone attenzioneal particolare della lettura dei tituli. Quello che in Gallo era unodegli elementi fondamentali per la gioia del poeta, la letturalegata al trionfo e al bottino, diventa già in Properzio unaspetto marginale, quasi una curiosità geografica o‘folcloristica’ per le città e i nemici prigionieri, ma nonaccresce il piacere vero della cerimonia, quello di assistervi insinu carae puellae; in Ovidio si trasforma addirittura nello sfoggio diuna conoscenza magari solo ostentata per attirare l’attenzionedelle ragazze e far buona impressione su di loro. Labanalizzazione del tema del trionfo (e del particolare dellalettura, che ne costituisce un elemento distintivo negli elegiacida Gallo in poi) è davvero completa.
Ancora un altro aspetto, infine, contribuisce a sminuire iltema del trionfo rovesciando le premesse di Gallo: l’autore, chenell’Ars è sempre al di fuori delle situazioni rappresentate, nellequali immagina piuttosto il suo allievo ideale, non puòdescriversi presente alla cerimonia trionfale e così elimina unaltro elemento fondamentale del modello, distanziandosi in ciòanche da Properzio. Sulla partecipazione emotiva del poeta allagloria del suo Caesar si gioca infatti tutta la quartina di Gallo,impostata proprio sulla comunione di intenti e di destini tra idue: solo dopo la vittoria e il trionfo la sorte del poeta potràdirsi felice, cosicché la felicità e il successo di Caesardiventano i suoi. Di questo aspetto l’elegia properziana nonconserva molto, il rapporto con Augusto, pur nei versiencomiastici, è sempre di una certa distanza, il poeta non vuolemostrarsi troppo coinvolto nell’esito dell’impresa: quanto meno,però, si rappresenta presente alla futura cerimonia, anche se -come dice a vv. 15-16- per motivi molto personali. Stabilisce cosìcon l’evento un rapporto di partecipazione diretta, sarà lì inprima persona, per godersi lo spettacolo e guardarne incuriositola scenografia. In Ovidio si perde anche questa minima interazionecon l’evento, non sarà il poeta ad assistervi, ma l’aspiranteamante che segue i suoi consigli, e in fondo non conta neppure chesi tratti del trionfo di Caio Cesare, per gli scopi da raggiungerequalsiasi cerimonia analoga andrebbe bene; il trionfo in quantotale viene dunque per così dire ‘neutralizzato’ nella sua portatae nel suo significato, è un’occasione astratta e possibile come
16
tante altre per ottenere uno scopo superficiale. L’eroismo, lagloria, la considerazione del trionfo come il massimo onoreottenibile da un essere umano, elementi ancora ben vivi nel testogalliano, perdono via via ogni importanza, fino a scadere in unaconsiderazione assolutamente indifferente ad essi e a venire difatto cancellati. Se in questo cammino Properzio mantiene ancorauna posizione intermedia, giustificando quanto meno la sua sceltacon l’amore insuperabile per Cinzia, Ovidio compie il passodecisivo per lo svuotamento completo dell’evento e per labanalizzazione del trionfo in poesia augustea. Di pari passo conla ‘distruzione’ dell’elegia erotica di Gallo e di Properzio,anche il tema scabroso e delicato dell’esaltazione del vincitore edel trionfo subisce la stessa sorte ad opera della sorridente ecorrosiva ironia ovidiana: il percorso dalla quartina di Galloall’Ars amatoria illustra bene il mutamento della mentalità versovalori sempre meno sentiti e il sentimento verso i grandipersonaggi negli anni centrali del principato augusteo.
Sarà tuttavia proprio Ovidio, in un momento e in unasituazione ormai lontani dal clima e dallo spirito dell’Ars amatoria,a recuperare il senso e la solennità del tema nella produzionedell’esilio: nel momento in cui riscopre l’elegia, trasformandolada ciò che era stata negli augustei e nella sua stessa produzionee recuperandone l’originaria connotazione di ‘poesia del pianto’,il poeta ritorna più volte sul motivo del trionfo, rielaborandonele caratteristiche per una situazione e un messaggio assaidiversi. Beninteso, è largamente possibile che anche nella poesiadell’esilio, dietro la facciata remissiva e ‘allineata’ con leaspettative del princeps, Ovvidio continui ad usare la sua consuetaironia, e che dietro gli elogi sperticati non vi sia solol’intento di ottenere il richiamo, ma forse una strategiacompositiva e concettuale più sottile. In tal caso la ripresa deltema del trionfo, depurato di ogni implicazione erotica e di ogniapparente volontà di irrisione, potrebbe ritrovare proprionell’enfasi eccessiva l’ironia abile e arguta con cui il poeta hagiocato a lungo con i temi più solenni della tradizione. Ciò cheegli tiene a mostrare, va comunque ben la di là dell’entusiasmosincero di Gallo e si trasforma nella visione spettacolare deltrionfo, dietro la quale restano celate senza scoprirsi in modoinconfutabile le sue vere intenzioni. A Trist. 4,2, Pont. 2,1 e 3,4il tema rientra nel consueto schema dell’augurio per unaspedizione futura, di cui il trionfo è prefigurato come degno
17
coronamento: le descrizioni della sfilata e dei festeggiamentisono vivide, l’amplificazione retorica è forte, ma dell’originariomodello galliano resta ben poco. Si può riconoscere il tema dellagioia del poeta il giorno fausto in cui si compirà l’evento,44 mal’angolazione è diversa, la sua partecipazione non è e non puòessere totale, come quella di Gallo, poiché alla gioia pubblica èaccostata per contrasto l’infelicità privata dell’esule, che soloper un momento, grazie all’entusiasmo per l’evento, potrà metterlada parte.45 L’accento è così sulla dolorosa condizione dell’autore,che si intravvede in controluce anche quando dichiara che lafelicità per il trionfo sarà più grande delle sofferenzepersonali.46 Ovviamente in primo piano è il motivo della distanza,che impedendo ad Ovidio di godere di persona della festa, gliconsente solo di immaginare e cantare il momento glorioso di untrionfo immaginario. A Gallo può far pensare l’accenno di Trist,4,2,7 (donaque amicorum templis promissa deorum), che resta però solo unparticolare senza sviluppo tra i tanti che descrivono la scena,mentre piuttosto a Prop. 3,4,16 riporta il v. 20 (cumque ducum titulisoppida capta leget), laddove il particolare della richiesta diinformazioni e della risposta di qualcuno del pubblico, pure nonbene a conoscenza dei dettagli, richiama Ars 1,227-228. Tuttiquesti elementi sono però naturalmente recuperati dalla‘tradizione’ elegiaca sul tema del trionfo in modo da adattarsi adun senso nuovo, privo di richiami al tema erotico e teso piuttostoa mostrare (almeno in apparenza) la lealtà del poeta, benconsapevole di aver impiegato troppo spesso il linguaggio e leimmagini del trionfo per realtà frivole e irriverenti (si pensi,oltre che ad Ars 1,177-228, ad amor. 1,2). A questo fine -paradossalmente- Ovidio riprende l’aspetto che meno ci si potrebbeattendere in una poesia scritta sottolineando la distanzamateriale da ciò che rappresenta, e cioè la partecipazione quasifisica al vagheggiato trionfo. Con la vividezza della descrizioneinfatti, egli ricrea l’atmosfera nella quale si proiettaidealmente, superando i limiti fisici della lontananza (Trist.4,2,57-82) e vivendo le emozioni del momento come se fossepresente alla scena. Con ciò sembra restituire al motivo del
44 Cfr. Pont. 2,1,17-18: Gaudia Caesareae mentis pro parte virili / sunt mea: privati nil habet illadomus.45 Cfr. Trist. 4,2,17-18: nos procul expulsos communia gaudia fallunt, / famaque tam longe non nisiparva venit; si veda Nicastri (1984) 110.46 Cfr. Trist. 4,2,73-74: illa dies veniet, mea qua lugubria ponam, / causaque privata publica maiorerit. Barchiesi (1981) 158, assimila questo atteggiamento di Ovidio a quello diGallo, riconoscendovi “un analogo modulo «cortigiano»”.
18
trionfo la solennità e l’importanza che implicitamente gli avevasottratto nelle opere precedenti, esasperando la direzioneimpressagli da Properzio, e lo reindirizza verso la trattazioneencomiastica che esso manterrà in età imperiale, e che forse nellesue mani acquista un sapore di vaga parodia.
Così il τόπος del trionfo nell’elegia augustea conclude il suocammino: la conoscenza del papiro di Qaṣr Ibrîm consente oggi diriconoscerne l’origine, almeno per certi aspetti, in Gallo, la cuitrattazione encomiastica verso Caesar e il cui atteggiamento didevozione totale daranno l’avvio ad una serie di ripensamenti e di‘risposte’ più o meno polemiche o ironiche da parte di Properzio edi Ovidio, almeno finché i due poeti riescono a mantenere unaposizione abbastanza indipendente dalla politica e dallapropaganda del regime. I versi di Gallo divengono così punto dipartenza per un dialogo letterario in Properzio, che se ne serve,rovesciandoli, per ribadire la centralità del tema eroticonell’elegia latina, ma sono anche l’occasione per rivendicare unatteggiamento di distacco e di indipendenza rispetto alla politicae alla propaganda augustee. In Ovidio il tema segue la logica dicorrosione ironica dell’elegia e si mette paradossalmente aservizio della didascalica erotica, privato di ogni solennità egrandezza. Quando però l’ansia di rientrare nelle grazie diAugusto e poi di Tiberio muoverà il poeta esule a riprendere iltema, ciò avverrà in un tono diverso, in cui il suo interesse saràdi mostrarsi pienamente in linea con l’imperatore, così chel’enfasi retorica, sia pure forse finalizzata ad effetti ironici,disperde e priva di incisività le rare reminiscenze galliane.
Pure, nonostante il lungo percorso e le disparatetrasformazioni, che attestano la duttilità e la vitalità delτόπος, qualche cosa dell’iniziale impostazione galliana glielegiaci continueranno a mantenere: l’augurio di poter vedere ilgiorno felice in cui esso avverrà deriva dalla connessione tra lafelicità personale del poeta e il successo di Caesar nei disticigalliani, in cui un singolare linguaggio dell’affettività,tipicamente elegiaco (dulcia, v. 2), dà a Properzio lo spunto permescolare il registro solenne con quello erotico in 3,4 e ad Ov.Ars 1,217-228 l’occasione per includere audacemente il motivo dellaconquista amorosa. Da Gallo deriva anche l’accento sull’atto delvedere, deformazione di quello del leggere in conseguenza dellospostamento cronologico, attuato da Properzio, dal momentosuccessivo al trionfo a quello della manifestazione, mentre restaimmutato il motivo della ricchezza del bottino. Soprattutto, si
19
riconosce in Gallo l’origine dell’aspetto forse più notevole deltrattamento del tema, e cioè l’inserimento entro un propemptikòn edunque la dislocazione nel futuro, come previsione, non comerealtà attuale: la costanza con cui è mantenuto sia da Properzio,sia da Ovidio in tutte le riprese del tema dimostra quanto validafosse ai loro occhi la soluzione galliana e quanto importante essigiudicassero il magistero del loro predecessore e nericonoscessero meriti e pregi. La conoscenza del papiro di Galloconsente oggi di riconoscere tutto questo e di ricostruire, siapure solo a grandi linee, una linea di sviluppo e una rete dirapporti prima insospettabili all’interno dell’elegia augustea suun tema non centrale negli interessi dei poeti, ma puresuscettibile di riuscite variazioni e portatore di messaggisignificativi.
Paola Gagliardi
BIBLIOGRAFIA
R. D. Anderson ˗ P. J. Parsons ˗ R. G. M. Nisbet, “Elegiacs byGallus from Qaṣr Ibrîm”, JRS 69, 1979, 125-155.G. Ballaira, “Per l'autenticità del papiro di C. Cornelio Gallo”,Paideia 42, 1987, 47-54. H. Bardon, “Les élégies de Cornélius Gallus”, Latomus 8, 1949, 217-228.J. Blänsdorf, “Der Gallus-Papyrus - eine Fälschung?”, ZPE 67, 1993,43-50. F. Brunhölzl, “Der sogenannte Galluspapyrus von Kasr Ibrim”,CodMan 10, 1984, 33-37.F. Cairns, Sextus Propertius. The Augustan Elegist, Cambridge 2006.F. Cairns, Generic Composition in Greek and Roman Poetry, Ann Arbor 182007.M. Capasso - P. Radiciotti, Il ritorno di Cornelio Gallo – Il papiro di Qaṣr Ibrîmventicinque anni dopo, Lecce 2004.E. Courtney, The Fragmentary Latin Poets, ed. with comm., Oxford 1993.G. Cresci Marrone, Ecumene augustea. Una politica per il consenso, Roma 1993.F. Cupaiuolo, La decima ecloga di Virgilio, un problema sempreaperto, C&S 20, 1981, 50-59.
20
G. Danesi Marioni, “Una reminiscenza di Cornelio Gallo nellaConsolatio ad Liviam e il tema del trionfo negli elegiaci”, in: V.Tandoi (ed.), Disiecti membra poetae. Studi di poesia latina inframmenti, II, Foggia 1985, 93-98.G. D’Anna, Virgilio. Saggi critici, Roma 1989. I. M. L. M. Du Quesnay, “From Polyphemus to Corydon: Virgil,Eclogue 2 and the Idylls of Theocritus”, in: D. West and T.Woodman (edd.), Creative imitation and Latin literature, Cambridge 1979, 35-70.P. Gagliardi, “Per la datazione dei versi di Gallo da Qasr Ibrim”,ZPE 171, 2009, 45-63.P. Gagliardi, “Tandem fecerunt carmina Musae. Sui vv. 6-7 del papiro diGallo”, Prometheus 36, 2010, 55-86.P. Gagliardi, “Carmina domina digna: riflessioni sul ruolo delladomina nel papiro di Gallo”, MH 69, 2012, pp. 156-176.P. Gagliardi, Commento alla decima ecloga di Virgilio, Hidesheim - Zürich -New York 2014.G. Geraci, Genesi della provincia romana d'Egitto, Bologna 1983. G. Giangrande, “An Alleged Fragment of Gallus”, QUCC 34, 1980,141-153 (= Scripta Minora Alexandrina, 4, Amsterdam 1985, 501-513). G. Giangrande, “On the Alleged Fragment of Gallus”, in: G.Giangrande (ed.), Corolla Londiniensis, I, Amsterdam 1981, 41-44. G. Giangrande, “On the Pseudo-Gallus”, in G. Giangrande (ed.),Corolla Londiniensis, II, Amsterdam 1982, 83-93. G. Giangrande, “Hellenistic Features in the Pseudo-Gallus”, in: G.Giangrande (ed.), Corolla Londiniensis, II, Amsterdam 1982, 99-108.J. Gómez Pallarès, “The «Reading of Monuments» in CorneliusGallus’ Fragment”, Philologus 149, 2005, 104-109.A. S. Hollis, Fragments of Roman Poetry, c. 60 BC – AD 20, Oxford - New York2007.G. O. Hutchinson, “Notes on the New Gallus”, ZPE 41, 1981, 37-41. S. T. Kelly, “The Gallus quotation in Virgil’s tenth eclogue”,Vergilius 23, 1977, 17-20. A. Luther, “Templa deorum fixa – zum historischen Hintergrund derGallus-Fragmente aus Qaṣr Ibrîm”, APF 48, 2002, 29-41.B. Luiselli, Studi sulla poesia bucolica, Cagliari 1967.S. Mazzarino, “Un nuovo epigramma di Gallus e l'antica «letturaepigrafica» (Un problema di datazione)”, Quad. catanesi di studi classici emedievali 2-3, 1980, pp. 7-50.S. Mazzarino, “L’iscrizione latina nella trilingue di Philae e icarmi di Gallus scoperti a Qaṣr Ibrîm”, RhM 125, 1982, 312-337.
21
J. F. Miller, “Propertius 2, 1 and the New Gallus Papyrus”, ZPE 44,1981, 173-176.P. A. Miller, Subjecting Verses: Latin Love Elegy and the Emergence of the Real,Princeton 2004.A. M. Morelli, “Sulla genuinità del papiro di Gallo”, in: V.Tandoi (ed.), Disiecti membra poetae, III, Foggia 1988, 104-119. S. Naughton, “On the Syntax of the Pseudo-Gallus”, in: G.Giangrande (ed.), Corolla Londiniensis, I, Amsterdam 1981, 111-112.J. K. Newman, “De novo Galli fragmento in Nubia eruto”, Latinitas 28, 1980,83-94.L. Nicastri, Cornelio Gallo e l'elegia ellenistico-romana, Napoli 1984.L. Nicastri, “Dalla topica all'ermeneutica. Una risposta a G.Giangrande sul “nuovo Gallo””, GIF 47, 1995, 175-200.G. Petersmann, “Cornelius Gallus und der Papyrus von Qaṣr Ibrîm”,ANRW II 30, 3, 1983, 1649-1655.P. Pinotti, L'elegia latina. Storia di una forma poetica, Roma 2002.M. C. J. Putnam, “Propertius and the New Gallus Fragment”, ZPE 39,1980, 49-56.D. O. Ross, Background to Augustan Poetry: Gallus, Elegy and Rome, Cambridge1975.F. Sbordone, “Note al probabile frammento elegiaco di CornelioGallo”, RAAN 57, 1982, 57-66.H. Schoonhoven, “... si parua licet componere magnis (A Note on the NewGallus Papyrus, 11.3-5)”, ZPE 53, 1983, 76-78. G. Silagi, “Definitives zu Gallus”, Rechtshistorisches Journal 19, 1999,357-373.F. Skutsch, Aus Vergils Frühzeit, Leipzig 1901. F. Skutsch, Gallus und Vergil, Leipzig 1906.W. Stroh, “Die Ursprünge der römischen Liebeselegie”, Poetica 15,1983, 205-246.J. Van Sickle, “Style and Imitation in the New Gallus”, QUCC 38,1981, 115-124. J. Van Sickle, “Neget quis carmina Gallo?”, QUCC 38, 1981, 125-127. F. Verducci, “On the Sequence of Gallus' Epigrams: Molles Elegi, VastaTriumphi Pondera”, QUCC 45, 1984, 119-136.R. Whitaker, “Apropos of the New Gallus Fragment”, AClass. 24, 1981,87-96.L. P. Wilkinson, Propertius III 4, in Studi in onore di L. Castiglioni,Firenze 1960, 1091-1103.I. C. Yardley, “Gallus in Eclogue 10: Quotation or Adaptation?”,Vergilius 26, 1980, 48-51.
22
Abstract
La partecipazione del poeta al trionfo e la lettura dei tituli, untema presente ai vv. 2-5 del papiro di Gallo da Qaṣr Ibrîm, èpolemicamente trasformato da Prop. 3,4, che lo utilizza peresprimere la sua indifferenza verso la guerra e la poesiacelebrativa e per riaffermare la sua scelta di vita elegiaca.Ovidio in ars 1, 1177-228 lo modifica ulteriormente, in modo taleche il trionfo diventa occasione per incontri galanti, manell’elegie dell’esilio egli ripropone il τόπος in un modo ancoradiverso, che possa risultare gradito all’imperatore.
The participation of the poet to the triumph and the reading ofthe tituli, a theme present in vv. 2-5 of the Gallus papyrus fromQaṣr Ibrîm, is polemically transformed by Prop. 3,4, where it isemployed to express the indifference of the poet to war andlaudatory poetry, and his elegiac choice of life is reaffirmed.Ovid in ars 1,177-228 changes it further, so that the triumphbecomes an occasion for amorous encounters, but in the elegiesfrom exile he proposes the τόπος in a different sense, to pleasethe emperor.
Key words: trionfo; elegia augustea; celebrazione di Augusto.
Paola Gagliardi, via Due Torri, 21 85100 [email protected]
23

































![Ovidio Coelho ]os6 Queiroz Clpidio Pereira maranhAo Anno ...](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6321d1daae0f5e8191059ef0/ovidio-coelho-os6-queiroz-clpidio-pereira-maranhao-anno-.jpg)
![O. de Cazanove, S. Bourdin, « Programme Ignobilia Oppida Lucanorum », Chronique des activités archéologiques de l’École française de Rome [En ligne], Italie du Sud, mis en](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631a82c9d5372c006e038712/o-de-cazanove-s-bourdin-programme-ignobilia-oppida-lucanorum-chronique.jpg)





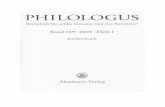
![2015_Dos nuevos cascos hispano-calcídicos en contexto urbano: los oppida celtibéricos de Aratis (Aranda de Moncayo, Zaragoza) y Contrebia Carbica (Villas Viejas, Cuenca) [2015]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6345d148596bdb97a9091aa5/2015dos-nuevos-cascos-hispano-calcidicos-en-contexto-urbano-los-oppida-celtibericos.jpg)


