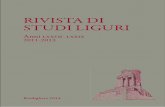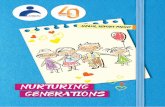The project Generations, in Parma inattesa
Transcript of The project Generations, in Parma inattesa
ISBN 978-88-7847-434-5© 2013 Monte Università Parma Editore
è vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale, dei testi e delle immagini senza esplicita auto-rizzazione. L’editore si dichiara disponibile al riconoscimento di eventuali diritti d’autore per le immagini pubblicate.
MUP Editore è una impresa strumentale dellaFondazione Monte di Parma
www.mupeditore.it
La presente pubblicazione è stata realizzata grazie al contributo di
In collaborazione con
Con il patrocinio di
I materiali della ricerca progettuale riportati in questo libro sono stati elaborati nei corsi di progettazione e teoria nel biennio accademico 2010-2012 allo IUav-venezia. Dal 21 marzo al 21 giugno 2013 sono stati oggetto di una mostra presso la Galleria Civica dell’ex-Chiesa di San Ludovico a Parma, realizzata dalla Fon-dazione Monte di Parma con l’assessorato alla Cultura del Comune di Parma.I modelli in gesso e le immagini fotografiche del progetto sono confluiti nel patri-monio artistico della Fondazione.Il Festival dell’architettura ha costituito un riferimento culturale ed organizzativo per la realizzazione dell’opera a partire dal 2009 sino alle attuali fasi di presenta-zione e divulgazione della stessa.
Si ringraziano:Dott.ssa Mariella Utili, Soprintendente del Patrimonio Storico, artistico e Demoet-noantropologico di Parma e Piacenza per la prima sistemazione dei materiali di pro-getto presso i Voltoni del Guazzatoio in Pilotta in ambito di workshop universitario; Lamberto amistadi ed Enrico Prandi con la collaborazione di Eugenia Marè, Erica Lenticchia, annapaola Nolli, Paolo Strina per l’organizzazione, Enrico Cartechini per gli aspetti logistici, Lisa Reggiani per l’attività divulgativa, appar-tenenti al gruppo di lavoro del Festival dell’architettura.
Curatori del libro: Emiliano ForcelliSusanna Pisciellaandrea RossettoLorenzo Sivieri
Fotografie:Modelli in gesso: Pietro SavorelliMatrici in gomma siliconica: Lorenzo SivieriMateriali iconografici: Giovanni amoretti (immagini n. 62, 65, 67, 69-72, 74-88)Il progetto alla Pilotta: alessandra Bello
Traduzione dei testi:alex Gillan
L’immagine n. 60 è pubblicata con autorizzazione n. 6714 in data 04.02.2013; la n. 63 con autorizzazione Prot. n. 287/28.01.02/12.2 in data 30.01.2013; le imma-gini n. 69, 71, 76, 77, 82, 83, 84, 85, 86 con autorizzazione Prot. n. 518/v.9.3 in data 06.02.2013; la n. 64 per concessione della Biblioteca apostolica vaticana; la n. 67 e la n. 73 su concessione del Ministero per i Beni e le attività Culturali.
Sommario
In attesa dell’inattuale / per un proto-museo della cittàCarlo Quintelli 9
Parma inattesaRenato Rizzi 13
Le dimensioni della TerraFranco Farinelli 21
Il buco dell’esperienzaAndrea Tagliapietra 27
Ragione pratica e ragione poeticaLamberto Amistadi 35
Le generazioni del progettoSusanna Pisciella 39
ambito geografico 75ambito storico urbano 91archetipi 121Lo spazio del pudore 171Materiali iconografici 211Schizzi 249Disegni 255Il progetto alla Pilotta 339
apparati 349Didascalie 350Elenco delle immagini 356Elenco dei modelli 358Cronoprogrammi 361
Summary
Expecting the unpresent / towards a proto-museum of the cityCarlo Quintelli 43
Parma inattesaRenato Rizzi 47
The dimensions of the EarthFranco Farinelli 55
The hole of experienceandrea Tagliapietra 61
Practical reason and poetic reasonLamberto amistadi 67
The project generationsSusanna Pisciella 71
Geographical ambit 75Historical urban ambit 91Archetypes 121The space of shame 171Iconographic materials 211Sketches 249Drawings 255The project at the Pilotta 339
Apparatus 349Captions 353List of images 356List of models 358Time schedules 361
39
Le generazioni del progetto
Nell’emisfero australe, in un punto di coordinate analoghe a quelle di Parma ma diametralmente opposte, presso la città di Wellington in Nuova zelanda, venticinque anni fa fu bandito un concorso in-ternazionale per raccogliere proposte per il nuovo museo nazionale della cultura maori e oceanica. Tra i progetti pervenuti ce ne fu uno che propose quello che si direbbe letteralmente “un buco nell’ac-qua”, destinato alle acque della baia di fronte a Wellington. Quel progetto non vinse e, per ospitare il patrimonio dei Maori e del Pacifico, fu selezionato un grande edificio tra il postmoderno e il decostruttivista, perfettamente in linea con i gusti occidentali del tempo. Era il 1988 e Wellington una città remota del globo in cui i coloni europei vivevano la nostalgia e il de-siderio (per loro lontano come le stelle) di fare parte delle categorie dell’occidente, di allinearsi alla così detta “contemporaneità”, la quale spesso, se bidimensionalizzata, rischia di risolversi però in storicismo. In questo caso con doppia beffa, immediata per i Maori e differita per quei nostalgici di attualità. La strana proposta del “buco nell’acqua” rimase qualcosa di pa-rallelo al concorso e, del resto, pensare di trasferire altrove il sito assegnato significa evadere e perciò perdere in ogni caso un bando, questo si sa. Eppure la vicenda mette in luce un fenomeno impor-tante, se non la generale presunzione della normativa nei confronti delle cose, almeno la non perfetta linearità di una consuetudine radicata, quale è l’individuazione a priori dei lotti per le opere di architettura. L’opera infatti, quando autenticamente tale, sviluppa una coscienza propria nei confronti del mondo e non c’è individuo, amministratore o architetto, che possa trovare meglio di lei il punto di apertura dove posizionarsi per rendere di nuovo visibili le imma-gini che l’usura ha reso invisibili in un paesaggio.E così, generato più dalla geologia che dalla storia, quel “buco nell’acqua” impressionò e si fissò nell’immaginario generale perché superava i bipolarismi e penetrava l’intima interiorità di quella terra dal doppio nome, riflesso di una doppia teoria1. Da una parte quella cronologico-analitica dello sbarco olandese in una nuova “zealand”. Dall’altra quella a-temporale-sintetica di una terra che scopre la propria solitudine quale de-cisione dall’indistinto del mare e proie-
SUSaNNa PISCIELLa
zione nell’indistinto del cielo, e che nulla trova di più analogo a sé che il distinguersi di una “lunga nuvola bianca”, “aotearoa”.Un nome, l’indigeno aotearoa, risultato di una lenta concrescita interiore dell’immagine e che per questo si offre come un prisma nitidissimo attraverso cui guardare l’isola perché, sebbene più ar-caico di “Nuova zelanda”, ovvero proprio in virtù di quell’arché si fa garante di una più autentica con-temporaneità2, o se non altro di un maggiore potenziale di riattualizzazione del proprio senso. Nulla di così diverso dai presupposti che generano oggi questo nuovo “buco” alle porte di Parma, dove la “Parmula” si offre a sua volta quale accesso privilegiato all’interiorità, all’ontologia della città. “Parmula”, lo “scudo”3 di forma circolare come il progetto, non è che la convessità di una pupilla la cui cavità divora immagini e ombre del mondo esteriore per ribaltarle nei paesaggi del proprio mondo interiore. Parma inattesa non è una costruzione ma una contrazione dell’architettura. Si tiene presso i limiti del linguag-gio, dove l’immaginario rinnova costantemente il proprio inizio, per questo è incomprensibile alle categorie analitiche.
Ma torniamo un’ultima volta al “buco nell’acqua” di fronte a Wel-lington, tra i due istmi montani di oriental Bay e Point Jerningham, per capire il perché dello spostamento, della direzione e della con-figurazione di quella proposta.Intanto trasferire il sito di progetto dal piano della città a quello della baia significherebbe posizionarsi non dentro la città ma den-tro la sua immagine riflessa per scoprire di essere a nostra volta “guardati” da lei. vorrebbe dire in altre parole “rigenerare il pun-to di vista” cercando quel luogo, quel preciso punctum4 in cui lo sguardo delle cose si fissa su di noi5 e ci penetra. Infatti è solo gra-zie a quella reciprocità della visione che si attiva la circolarità tra quotidiano e metafisico, che è tra l’altro una delle migliori forme di assicurazione contro la tirannia lineare della tecnica. Ci si ritira sotto proprio per fare un passo indietro rispetto a quel dominio orizzontale e accondiscendente a tutto ciò che è determi-nato e quantificabile (la tecnica), per ricordarsi che in architettura
tutto questo non è che uno dei contenuti di un sapere analogico, che ha nello scarto tra limite e illimite la propria dimensione.Da quella particolare posizione tra6 realtà tangibile e riflessa, il progetto cattura e inghiotte l’immagine acquea del promontorio e ne costruisce l’inversione, cavità sommersa sulla quale si affaccia-no figure che alla posizione ordinaria dello sguardo sfuggono. In questo processo progettuale, all’inversione “cosmologica” (dello sguardo) corrisponde un’inversione materiale della realtà rappre-sentata: la necessità di passare attraverso un calco negativo duran-te l’elaborazione del modello di gesso, attribuisce massa a quelli che sono vuoti e assenze dell’immagine, ne spalanca l’interiorità, rivelando la lunga catena delle analogie tra le cose7. Costruire dal pelo dell’acqua in giù, così come dal piano di campa-gna di Parma in giù, mette in atto un “ribaltamento del mondo”, cui consegue un inevitabile ribaltamento del linguaggio. Sprofondare dentro la terra significa in certo modo sottrarsi al nomos che divide, definisce e domina storicamente la superficie8. è un fare del pro-prio contesto non il perimetro del lotto ma l’intero globo e tutte le sue relazioni; la sua illimitata circolarità di ogni cosa, dove l’inizio è sempre un presente e la storia diventa un dettaglio. L’immersione inverte tutti i rapporti di peso dell’architettura, tutte le sue ombre, e occorre trovare una nuova consistenza perché la pressione sotto la superficie è molto più forte e richiede l’opposi-zione di un’insistenza maggiore; le fondazioni non sono più solo sotto ma tutt’intorno, diaframmi spessi anche un metro che rove-sciano all’interno tutto ciò che è all’esterno, ma non viceversa. In questo modo il dualismo dello spazio architettonico dentro-fuori si fonde nell’unità della cavità interiore e le distanze subiscono una contrazione e vengono a coincidere. L’orizzonte si stringe e lo sguardo rigenera la propria dimensione verticale, vede meno ma l’essenziale, s’interra “per vedere le stelle” come insegna Plinio il vecchio. Inverte la direzione, dal dominio su- allo stupore per- le cose; a aotearoa rinnova lo stupore per il de-cidersi delle nuvole.
Questo progetto – di scavo – per Wellington, insieme a un piccolo gruppo di progetti successivi, introduce l’orizzonte dal quale oggi emerge Parma inattesa e ne rende visibili alcuni aspetti che a uno sguardo troppo diretto possono venire meno. Del resto costruire nel fluido indistinto del mare non è troppo di-verso dal costruire nel pulviscolo indistinto della periferia parmen-se. In tutti e due i casi si richiede al progetto la forza non solo di radicarsi ma di radicare un intero contesto, quello periferico, che per sua natura galleggia. Un’archi-tettura capace di questo nome dovrà allora dotarsi della solidità propria di una nave (naòs), o for-
se di un’arca; solidità strutturale (la tèchne dell’architettura) ma soprattutto culturale, sapienziale (quella dell’arché). Se si volesse risalire ulteriormente la linea delle generazioni, si po-trebbe riconoscere a questo gruppo di progetti un ulteriore comune predecessore, di certo estraneo – se non opposto – al loro patrimonio genetico ma in tutto analogo nelle intenzioni: la House 11a di Peter Eisenman per Palo alto, California, del 1978. Si tratta dell’undice-sima casa del manifesto programmatico col quale l’architetto ebreo-americano si propone di sostituire al tradizionale asse greco-cristiano – figurativo – dell’architettura occidentale, ormai al capolinea tec-nocentrico9, una nuova (per l’architettura) codificazione ebraica del linguaggio – testuale. La riscrittura comincia dal tema della casa in quanto interiorità per eccellenza dell’abitare e la House 11a è quel-la che inaugura il radicamento (grounding; Grund) con uno scavo di dodici metri nelle piatte lottizzazioni americane, la negazione del loro linguaggio e l’emersione di un principio figurativo, quello della El-Shape (dall’Elohìm ebraico) che sottraendosi all’immediatezza del datum, mette in crisi l’idea di architettura come oggetto d’uso, per rigenerare una dimensione gnoseologica dell’esperienza dell’abitare.
Il gruppo di lavori cui appartiene Parma inattesa invece si pro-pone il medesimo scavo di tipo “archeologico”, ma sta all’interno proprio di quella tradizione greco-cristiana alla quale l’occidente deve tutto ciò che ha, anche il nichilismo delle sue periferie. Scava in cerca di quella doppia focale, contingente e a-temporale, che ge-nera il paesaggio e da cui il progetto prende il carattere. Di seguito una successione quasi stenografica dei progetti.al Cairo (2002, Grand Egyptian Museum) la dimensione teorica non è più quella della natura, come a Wellington, ma è teologica e s’im-posta sulla duplice dimensione geroglifica della vita e della morte dell’anima. Il progetto scava dentro il lotto, che si trova sulla con-terminazione del deserto presso Giza e, raggiunta la piana del Nilo quaranta metri più in basso, si costruisce in quello spessore come una grande mastaba (impianto a T) le cui “maschere” connettono e misurano il dislivello tra la dimensione fisica della vita (la piana e la città) e quella metafisica della morte (il deserto, le piramidi).varsavia (2005, Museum of Modern art), la questione è politica e, in particolare, concerne il tema della libertà. Il sito si trova nella piazza prospiciente il Palazzo della Cultura e della Scienza, l’impo-nente “dono” di Stalin alla Polonia (1953-1955). Il Palazzo è rivolto a est, lo sguardo fisso a Mosca, ma dal 1989 la città ha ufficialmente ruotato la testa a occidente. Il progetto ritaglia attorno al Palazzo un’intercapedine che la rende idealmente libera di muoversi come una “zattera” sospinta dalle correnti sotterranee del nuovo museo.
41
a Napoli (2006, Centro per la Musica) riaffiora la coscienza mitolo-gica di una terra in cui antri, forre, solfatare si sono rivelati accessi privilegiati per la circolarità tra dimensione terrestre e dimensione ctonia dell’essere. Il progetto apre nella periferia di villaricca una cavità dentro la quale preme una lente di 40 metri di diametro – riflesso del duplice sguardo di Kore – contenente a sua volta la grande sala. all’inevidenza dei volumi fuori terra corrisponde nel sottosuolo la loro crescente consistenza.Cracovia (2007, Centro Giovanni Paolo II). al centro è la cristia-nità come ecclesia, come interiorità. Sfruttando il dislivello del sito, l’aula sinodale si immerge completamente nel terreno senza proiettare alcuna ombra all’esterno, si autonega. Sviluppa il pro-prio paesaggio interiore lavorando per concentrazione. Un solo cor-po affiora dal sottosuolo, la cuspide della Cappella, essenza della Comunità nell’Uno della Persona. Lo sguardo è puntato alla collina di Wawel, riferimento sacro della città, in cui il progetto si configu-ra quale ennesimo forte, ennesimo occhio.Nello Stretto di Messina (2008, Ponte per lo Stretto) il tema fon-dante è di nuovo la mitologia, tanto più mostruosa quanto più vio-lenta è la natura del paesaggio, sintetizzata dalla coppia Cariddi-Scilla, l’una che risucchia e l’altra che dilania. Il lavoro riporta alla visibilità le potenze geologiche per evidenziare l’improprio della debolezza del ponte sospeso avanzato dalla tecnica. Il progetto si riallaccia alla soluzione subacquea del 1969 per il “ponte di ar-chimede” e lo sovrappone alle mappe dei gorghi di Pierre Ribaud e alle mappe dei forti issati sulle due sponde, per individuare le fes-sure dalle quali fare emergere, come cavità di isole Ferdinandee, la costellazione di possibili stazioni di supporto, nuovo paesaggio emerso di un collegamento sommerso.venezia (2008, Stazione Marciana della Sublagunare) è l’espres-sione stessa della contesa tra contingenza e a-temporalità ma lo è
nelle vesti di un’antitesi tra modernità e conservazione. Il progetto rigenera quell’antitesi come un’opposizione tra modernità tecnico-materialista e modernità teologico-metafisica e, nell’orizzonte di quest’ultima, costruisce la proposta. La posizione fisica è offerta da una velma in prossimità dell’isola di San Giorgio, mentre la direzione proviene dalla triangolazione San Giorgio-San Marco-Salute. La stazione sprofonda fino a 24 metri sotto il livello del mare, la quota di circolazione dei treni, e si costruisce come dop-pio, il riflesso dell’invaso marciano, del quale la lenta risalita pre-para l’apparizione. Partenza e arrivo di questa digressione è Parma inattesa, il cui ca-rattere fondamentale è quello della festa10, la simultanea epifania di grandezze disomogenee, se non di opposti, tema cardine della nascita del Teatro Farnese – la ricomposizione di una Discordia –, e asse sul quale il Battistero imposta la rotazione “cosmica” tra le figure celesti dell’esadecagono interno e quelle terrestri dell’ot-tagono esterno. a ricordarci che “celeste” non è una dimensione estranea alla nostra estensione, ma è il motore interno da cui parte ogni nostro fare e che se non ce ne avvediamo può essere che il nostro sguardo abbia accumulato un irrigidimento e vada “sbloc-cato”. è curioso come siano le iconografie stesse della città, quasi tutte orientate soprasotto, a forzare questo piccolo esercizio capo-volgendo il nord – lo sguardo – e quindi il mondo.Questa architettura, costruita come occhio spalancato sul mondo e avente vertice –la pupilla- nel sottosuolo, posizionandosi nel punto di massima tensione tra natura, città storica e periferia, avvia quel-la circolarità dello sguardo tra dimensioni diverse, che è l’inizio di ogni rigenerazione. La stessa circolarità che Correggio11 attiva nelle due cupole per Parma – ascensione e Discesa –, lo stesso esercizio che il progetto richiede a ognuno di noi.
1 La parola “teoria” nel testo è sempre usata nel senso originario di visione “theoria”. M. Heidegger, Parmenide [1942-1943], Milano 1999. K. Kerényi, Religione antica [1940], Milano 2001.
2 G. agamben, Che cos’è il contemporaneo?, Roma 2008.3 Si ricordano gli scudi di achille e di Perseo, la cui resistenza dipende più dalla
potenza della rap-presentazione o della capacità di riflessione dell’immagine che non dalla qualità di forgiatura del bronzo.
4 R. Barthes, La camera chiara, Torino 2003.5 J. Brodskij, Poesie, Milano 1986. Id., Fuga da Bisanzio, Milano 1986.6 R. Rizzi, The Beauty in Between. Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa, in In-
terstices 1. A journal of architecture and related arts, auckland, New zealand, 1991.
7 R. Daumal, Il monte analogo, Milano 1991. 8 C. Schmitt, Il nomos della terra, Milano 1991.9 P. Eisenman, Dislocation and the Metaphysic of Architecture, in Houses of Cards,
New York 1987.10 La “festa” (gr. Phainetai, manifestarsi) è, della rap-presentazione, la dimensione
atemporale, il farsi presenza visibile di ciò che normalmente non appare come dato sensibile. Kerényi, Religione antica, op. cit.
11 Cupola del Duomo, Assunzione della Vergine, 1524-1530; cupola di San Giovanni Evangelista, Discesa di Cristo per elevare a sé l’Evangelista Giovanni, 1520-1524.
71
The project generations
In the southern hemisphere, at a point of coordinates similar to those of Parma but diametrically opposite, near the city of Wellington in New zealand, twenty-five years ago an international competition was held to gather proposals for a new national museum of Maori and oceanic culture. amongst the projects entered was one that pro-posed what could literally be described as “a hole in the water”, for the waters of the bay in front of Wellington.That project did not win and, to house the patrimony of the Maori and the Pacific, a large building between post-modern and constructivist was instead chosen that perfectly accorded with the Western tastes of the time. It was the year 1988, and Wellington was a remote city of the globe where European colonists lived in nostalgia with a yearn-ing (for them as remote as the stars) to be part of the categories of the West, to be able to align themselves with so-called “contemporane-ity”, which frequently, if reduced to two dimensions, risks dissolving into historicism. In this case with a double twist, immediate for the Maori, and differed for the nostalgic ones of actuality. The odd proposal of the “hole in the water” remained something parallel to the competition and, moreover, to think of transferring the assigned site elsewhere would mean passing up and thereby losing the competition – obviously. Yet the event did highlight one important phenomenon, if not the general gall of regulations for things, namely, the non-perfect linearity of a deeply-rooted habit, like the identification a priori of lots for works of architecture. In fact, architecture, when authentically such, develops its own con-sciousness towards the world, and there is no individual, nor ad-ministrator nor architect, who can find better than it can the open-ing point to position itself to reveal again the images that wear and tear has made invisible in a landscape.and so it was that, generated more by geology than by history, that “hole in the water” impressed and embedded itself in the common imagery because of overcoming the bipolarisms and penetrated the intimate interiority of that double named land, reflection of a dou-ble theory1. on the one hand, the chronological/analytical one of the Dutch landing in a new “zealand”. on the other, the a-temporal/synthetic one of a land that unveils its own solitude as a de-scission
SUSaNNa PISCIELLa
from the haziness of the sea and a projection into the haziness of the sky, and which finds nothing more similar to itself than the discern-ment of a “long white cloud”, “aotearoa”.a name, the indigenous aotearoa, which is the result of a slow inte-rior growth of the image, and which, because of this, offers itself as a crystal-clear prism through which to gaze at the island because, even though more archaic than “New zealand”, that is to say, precisely because of that arché makes itself a guarantor of a more authentic contemporaneity2, or if not otherwise, of a greater potential of re-ac-tualization of its own sense. Nothing different from the presuppositions that this new “hole” at the gates of Parma currently generates, where the “Parmula” is of-fered in turn as a privileged access to the interiority or the ontology of the city. “Parmula”, the “shield”3 of a circular shape like the project, is none other than the convexity of an eye whose cavity devours images and shadows of the exterior world to turn it upside down into the landscapes of the interior world. Parma inattesa is not a construction but a contraction of architecture. It lingers near the limits of language, where imagery constantly renews its begin-nings, and because of this remains incomprehensible for analytical categories.
But let us return one last time to the “hole in the water” in front of Wellington, between the two mountainous isthmuses of oriental Bay and Point Jerningham, to understand the reason for the shifting, the bearings, and the configuration of that proposal.In the interim, transferring the project site from the plane of the city to that of the bay would mean it positioning itself not inside the city but inside its reflected image to discover ourselves being “looked at” in turn by it. This would mean in other words “regenerating the point of view” seeking that place, that precise punctum4 where the gaze of things stares at us5 and penetrates us. In fact it is only thanks to the reciprocity of vision that it activates the circularity between the everyday and the metaphysical, which is, moreover, one of the best forms of insurance against the linear tyranny of technique.
We withdraw below specifically to take a step backwards with re-spect to that horizontal and complaisant domain for everything that is determined and quantifiable (as technique), to recall that in ar-chitecture all of this is no more than the contents of an analogical knowledge, which has in its rejection its own dimension between limitation and delimitation.From that particular position between6 tangible and reflected reality, the project captures and ingests the aqueous image of the promon-tory and builds its inversion, a submerged cavity overlooked by fig-ures that elude the ordinary position of the gaze. In this design process the “cosmological” inversion corresponds to the material reversion of the represented reality: the need to go through a negative cast during the preparation of the plaster model, gives mass to those which normally are in the image, it opens up to interiority, revealing the long chain of analogies connecting things7. Building from the surface of the water downwards, like from the ground level of Parma downwards, initiates an “overturning of the world”, from which ensues an inevitable overturning of language. Sinking into the earth means in a certain way leaving the nomos that divides, defines, and historically dominates the surface8. What makes its own context is not the perimeter of the lot but the entire globe and all of its relations; the limitless circularity of everything, where the beginning is always a present and the story becomes a detail. Immersion inverts all the relationships of architecture’s weight, all of its shadows, and we need to seek a new constancy since the pressure below the surface is much stronger and demands the opposition of a greater insistence; the foundations are no longer merely underneath but all around, diaphragms frequently a metre thick that overturn internally everything that is external, but not the contrary. In this way the architectural space dualism of the inside/outside blends into the unity of the interior cavity and the distances undergo contraction and begin to coincide. The horizon tautens and the gaze regenerates its vertical dimension, sees less but sees the essential, buries itself “to see the stars” as Pliny the Elder taught us. It inverts the direc-tion, from dominion over- to wonder for- things; at aotearoa wonder is renewed due to the de-scission of the clouds.
This project – of excavation – for Wellington, together with a small set of successive projects, introduces the horizon from which today Parma inattesa emerges and renders visible some aspects which with a too-direct gaze might be diminished. Moreover, building in the hazy fluid of the sea is not so different from building in the hazy dust of Parma’s periphery. In both cases the project needs the strength not only to root itself but to put down the
roots of the periphery itself which by its very nature does float. an architecture worthy of the name must therefore endow itself with the robustness worthy of a ship (naòs), or perhaps of an ark; structural solidity certainly (the tèchne of architecture) but above all cultural and wisdom solidity (that of arché). If we wished to trace the line of generations back further, we might concede this group of projects a further common predecessor, un-questionably extraneous – if not actually opposed – to their genetic heritage but in every way analogous in its intentions: Peter Eisen-man’s House 11a for Palo alto, California, from 1978. This was the eleventh house of the programmatic manifesto with which the Jew-ish-american architect proposed replacing the traditional Greco-Christian axis of Western architecture – figurative –, by now at its techno-centric terminus9, a new (for architecture) Jewish codification of the language – which is textual. This re-writing began from the theme of the house inasmuch an interiority par excellence of inhabit-ing and House 11a is that which opens the grounding or Grund with an excavation of twelve metres in the level american lots, a nega-tion of their language and the emergence of a figurative principle, that of the El-Shape (from the Jewish Elohìm) which, by subtracting itself from the immediacy of the datum, sends into crisis the idea of architecture as an object to be used, to regenerate a gnoseological dimension for the habitation experience.
Instead, the group of works that Parma inattesa belongs to proposes the same excavation of an “archaeological” type, but lies within that Greco-Christian tradition which the West owes all to, including the nihilism of its periphery. It excavates in quest of that double, con-tingent and a-temporal focal point that generates the landscape and from which the project draws its character. Subsequently, an almost stenographic succession of projects.In Cairo (2002, Grand Egyptian Museum) the theoretical dimen-sion is no longer that of nature, as in Wellington, but is theological and imposes itself on the twin hieroglyphic dimension of life and the death of the soul. The project excavates inside the lot, which is lo-cated in the con-termination of the desert near Giza and, on reaching the plain of the Nile forty metres below, is built in that thickness like a grand mastaba (with a T-shaped layout) whose “masks” connect and measure off the change in level between the physical dimension of life (the plain and the city) and the metaphysical one of death (the desert, the pyramids).Warsaw (2005, Museum of Modern art); the question is political and, in particular, regards the theme of freedom. The site is located in the square adjacent to the Palace of Culture and Science, Stalin’s
73
imposing “gift” to Poland (1953-1955). The Palace faces east, its gaze stares at Moscow, but since 1989 the city has officially turned its head westwards. The project cuts out an interstice around the Palace that makes it idyllically free to move like a “raft” driven by the underground currents of the new museum.In Naples (2006, Centre for Music) what re-emerges is the mytholog-ical consciousness of a land where caverns, gorges, fumaroles turn out to be privileged accesses for circularity between the terrestrial and chthonic dimensions of being. The project opens up a cavity in the periphery of villaricca inside which lies a 40-metre diameter lens – a reflection of Kore’s twin gaze – containing in turn the large room. The lack of evidence of the volumes above ground is offset underground by their mounting importance.Krakow (2007, John Paul II Centre). In the centre is Christian-ity as ecclesia, as interiority. By exploiting the site’s differences in level, the synod hall emerges completely from the ground without projecting any shadow outside, it self-negates. It develops its own interior landscape by working with concentration. a single build-ing emerges from underground, the cusp of the Chapel, the essence of the Community in the One of the Person. The gaze is directed to the hill of Wawel, a sacred reference point for the city, where the project is configured as the nth fort, and the nth eye.For the Straits of Messina (2008, Bridge over the Straits) the found-ing theme is once again mythology, as more monstrous as the nature of the landscape is more violent, summed up by the pair Charybdis-Scylla, the one sucking the other mangling. The work makes the ge-ological potency visible to underscore the inapt slenderness of the suspended bridge advanced by technique. The project harks back to the subaqueous solution from 1969 for the “archimedes Bridge” and superimposes itself on the maps of Pierre Ribaud’s whirlpools and the maps of the forts bristling along the two banks, to identify chinks that will have the constellation of potential support stations emerge from, like the cavities of the Ferdinand Isles, a new land-scape emerging from a submerged connection.
venice (2008, the Marciana Station for the Sub-lagoon) is the very expression of the contest between contingency and a-temporality but is so in the guise of an antithesis between modernity and con-servation. The project regenerates that antithesis as an opposition between technical-materialist modernity and theological-meta-physical modernity and, on the horizon of the latter, builds its pro-posal. The physical position is offered by a velma near the Island of San Giorgio, while the bearings come from the triangulation San Giorgio-San Marco-Salute. The station sinks up to 24 metres below sea level, the level where the trains circulate, and is built double, a reflection of the Marciana invasion, from which the slow ascent prepares the apparition. The departure and arrival point of this digression is Parma inattesa, whose fundamental characteristic is that of a feast10, the simultane-ous epiphany of uneven dimensions, if not opposites, which is the cardinal theme of the birth of the Farnese Theatre – the recomposi-tion of a Discordia – and is also the axis upon which the Baptistery imposes its “cosmic” rotation between the celestial figures of the internal hexadecagon and the terrestrial ones of the external octa-gon. To remind us that “celestial” is not a dimension extraneous to our extension, but is the internal motor from which all our actions depart and which, if we do not perceive it, might mean that our gaze has accumulated a stiffness and needs to be loosened. It is curious how what the actual iconographies of the city are like, i.e. virtually all upside down, is forcing this small exercise by upending the north – and with it the order – of the world.This architecture is built as an open eye on the world whose ver-tex (the pupil) is underground; positioned at the point of maximum tension between nature, the historical city and the periphery, it initiates the circularity of the vision between different dimensions, which is the very start of each generation. The same circularity that Correggio11 imbued both his domes in Parma with – ascension and descent – the same practice that the project requires from each of us.
1 The word “theory” in the text is always used in its original sense of vision “theoria”. M. Heidegger, Parmenide [1942-1943], Milan 1999. K. Kerényi, Religione antica [1940], Milan 2001.
2 G. agamben, Che cos’è il contemporaneo?, Rome 2008.3 This recalls the shields of achilles and Perseus, whose durability depended more
on the power of re-presentation or of the reflection of the image than the quality of the forged bronze.
4 R. Barthes, La camera chiara, Turin 2003.5 J. Brodskij, Poesie, Milano 1986. Id., Fuga da Bisanzio, Milan 1986.6 R. Rizzi, The Beauty in Between. Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa, in In-
terstices 1. A journal of architecture and related arts, auckland, New zealand, 19917 R. Daumal, Il monte analogo, Milan 1991. 8 C. Schmitt, Il nomos della terra, Milan 1991.9 P. Eisenman, Dislocation and the Metaphysic of Architecture, in Houses of Cards,
New York 1987.10 That of the “feast day” (Gr. Phainetai, manifesting) is, of the re-presentation, the
a-temporal dimension, the rendering visible of something that normally does not appear as a sensible datum. Kerényi, Religione antica, op. cit.
11 Cathedral dome, Assumption of the Virgin, 1524-1530; St. John the Evangelist dome, Vision of saint John, 1520-1524.
ambito geografico
geographical ambit
In the chapters Geographic ambit, Historical urban ambit, Archetypes and The space of shame left and right pages are mutually related: on the right side the main picture and on the left side the preparatory materials.The numbers of drawings and iconographies do refer to their appropriate sections; sili-con rubber and woodpaper matrices are not numbered because they have no reference to other sections of the book. The page numbering code does indicate: above the line the page number; below the line the image numbers.
Nei capitoli Ambito geografico, Ambito storico urbano, Archetipi e Lo spazio del pudore le facciate destra e sinistra sono tra loro in relazione: a destra l’immagine principale, a sinistra i rispettivi materiali preparatori.I numeri dei disegni e delle iconografie rimandano alle relative sezioni; le matrici in gomma siliconica o in cartonlegno non sono numerate perché non hanno alcun riman-do ad altre sezioni del libro. Il codice di numerazione delle pagine indica: sopra la linea il numero di pagina; sotto la linea il numero delle immagini.
Disegno preparatorio.
Matrice negativa in gomma siliconica dei quattro moduli centrali.
1 AmbitogeograficoModello in gesso, scala 1:100.000104x104x5 cm, composto da 16 moduli da 26x26x5 cm.
La pressione degli Appennini sulla pianura Pa-dana diviene lo sfondo paesaggistico della via Emilia. Sequenza delle città lungo la via Emilia da ovest a est: Piacenza, Fiorenzuola d’Arda, Fi-denza, Parma, Reggio Emilia, Modena.
94
I
II
III
IV
Working drawing.
Negative matrix in silicone rubber of the four central modules.
1 GeographicalambitPlaster model, scale 1:100,000104x104x5 cm, consisting of 16 modules 26x26x5 cm.
The pressure of the Apennines on the Po Valley Plain becomes the landscape background to the Via Emilia. Sequence of cities along the Via Emil-ia from west to east: Piacenza, Fiorenzuola d’Arda, Fidenza, Parma, Reggio Emilia, and Modena.
Disegno preparatorio.
Matrice negativa in gomma siliconica dei quattro moduli centrali.
2 SistemaidrograficodelterritorioparmenseModello in gesso, scala 1:50.000 104x104 cm, composto da 16 moduli da 26x26x5 cm.
Gli andamenti dei fiumi sintetizzano la spinta de-gli Appennini da sud verso nord. Gli Appennini sono sezionati a quota +100 metri slm. Sequenza dei corsi d’acqua da ovest ad est: rio Piacentino, Stirone, Rovacchia, Fossazza/canale San Genesio, torrente Recchio, torrente Taro, Baganza, torrente Parma, Enza, canale di San Giacomo, Crostolo.
95
Working drawing.
Negative matrix in silicone rubber of the four central modules.
2 HydrographicsystemoftheterritoryofParmaPlaster model, scale 1:50,000 104x104 cm, consisting of 16 modules 26x26x5 cm.
The courses of the rivers summarize the thrust of the Apennines from south to north. The Apen-nines are sectioned at a height of +100 metres above sea level. Sequence of watercourses from west to east: rio Piacentino, Stirone, Rovacchia, Fossazza/San Genesio canal, Recchio, Taro, Ba-ganza, Parma, Enza, San Giacomo canal, Crostolo.
Disegno preparatorio.
Matrice negativa in gomma siliconica dell’intero modello.
3 Rappresentazionedell’ambitostoricodiParmaModello in gesso, scala 1:2.500104x104x5 cm, composto da 16 moduli da 26x26x5 cm.
La dialettica delle forze tra artificio e natura. L’unità della forma storica della città è divisa e divaricata dalla confluenza dei due torrenti Par-ma e Baganza.
Working drawing.
Negative matrix in silicone rubber of the entire model.
3 Representationofthehistorical ambitofParma
Plaster model, scale 1:2,500104x104x5 cm, consisting of 16 modules 26x26x5 cm.
The dialectic of the forces between artifice and nature. The unity of the historical shape of the city is divided and divaricated by the confluence of the Parma and Baganza streams.
Iconografia, Jacopo Lauro, 1630 ca.
Matrice negativa in gomma siliconica del modello.
6 Immaginedellacittà,1630ca.Modello in gesso, scala 1:10.000 42x42x5 cm, composto da 2 moduli 42x21x5 cm.
I modelli di questa serie (immagini 6-11) hanno lo scopo di restituire la doppia focale implicita nelle rappresentazioni iconografiche tenendo in-sieme quella zenitale e quella tridimensionale.
68
Iconography, Jacopo Lauro, ca. 1630.
Negative matrix in silicone rubber of the model.
6 Imageofthecity,ca.1630Plaster model, scale 1:10,000 42x42x5 cm, consisting of 2 modules 42x21x5 cm.
The models in this series (images 6-11) aim to restore the double focal point implicit in the iconographic representation by combining the zenithal with the three dimensional.
Iconografia, Anonimo, fine XVII secolo.
Matrice negativa in gomma siliconica del modello.
10 Immaginedellacittà–fineXVIIsecoloModello in gesso, scala 1:10.000 42x42x5 cm, composto da 2 moduli 42x21x5 cm.
73
Iconography, Anonymous, late 17th century.
Negative matrix in silicone rubber of the model.
10 Imageofthecity–late17thcenturyPlaster model, scale 1:10,000 42x42x5 cm, consisting of 2 modules 42x21x5 cm.
Iconografia, Anonimo, 1460 ca.
Matrice negativa in gomma siliconica del modello.
13 Immaginedella“PiantadellacittàdiPar-maesuoterritorioconpartedelBorghi-gianoedelReggiano”,1460ca.Modello n. 12 in gesso, scala 1:25.000 42x42x5 cm, composto da 2 moduli 42x21x5 cm.
L’immagine mette in relazione due temporalità; la periferia contemporanea e la sua preistoria fi-gurativa, della quale oggi non c’è memoria.
77
Iconography, Anonymous, ca. 1460.
Negative matrix in silicone rubber of the model.
13 Imageofthe“PlanofthecityofParmaandits territory with part of Borghigiano andReggiano”,ca.1460Plaster model no. 12, scale 1:25,000 42x42x5 cm, consisting of 2 modules 42x21x5 cm.
The image highlights two temporalities; the con-temporary periphery and their figurative prehis-tory, of which no trace remains today.
Iconografia, Michele Lopez, 1864.
Disegno preparatorio.
19 Battistero,sezioneModello n. 18 in gesso, scala 1:10042x63x21 cm, composto da 2 moduli: uno 42x21x21 cm e uno 42x42x21 cm.
Archetipo I: Monoteismo cristiano. A destra il portale meridionale.
79
155
Iconography, Michele Lopez, 1864.
Working drawing.
19 Baptistery,sectionPlaster model no. 18, scale 1:10042x63x21 cm, consisting of 2 modules: one of 42x21x21 cm and the other one of 42x42x21 cm.
Archetype I: Christian monotheism. On the right the southern portal.
Disegno preparatorio.
27 Battistero,estradossodellacupola alivellodellacopertura
Modello n. 23 in gesso, scala 1:10042x42x21 cm.
Lo strumento del modello serve alla lettura del-le categorie oppositive visibile-invisibile poiché porta alla presenza l’assenza.
136
Working drawing.
27 Baptistery,extradosofthedome atrooflevel
Plaster model no. 23, scale 1:10042x42x21 cm.
The tool of the model serves to read the opposing categories of visible/invisible since these lead to the presence/absence.
Disegno preparatorio.
Matrice negativa in gomma siliconica.
34 StudiodelleimmaginievolutivedelsistemadifensivoinrelazionealtorrenteParmaealPalazzodellaPilotta,1800ca.Modello n. 27 in gesso, scala 1:2.500 42x42x5 cm, composto da 2 moduli 42x21x5 cm.
121
Working drawing.
Negative matrix in silicone rubber.
34 Study of the evolution of the defensivesysteminrelationtotheParmastreamandthePalazzodellaPilotta,ca.1800Plaster model no. 27, scale 1:2,500 42x42x5 cm, consisting of 2 modules 42x21x5 cm.
Iconografia, L.-A. Feneulle e G. Patrini, 1780.
Disegno preparatorio.
37 PalazzodellaPilotta:posizione delTeatroFarnese
Modello n. 30 in gesso, scala 1:400 42x42x5 cm.
Archetipo II: Politeismo greco-romano.Teatro, teatrino di corte (eretto nel 1689, demo-lito nel 1827) e le fortificazioni della Rocchetta Viscontea.
83
123
Iconography, L.-A. Feneulle and G. Patrini, 1780.
Working drawing.
37 PalazzodellaPilotta:position oftheFarneseTheatre
Plaster model no. 30, scale 1:400 42x42x5 cm.
Archetype II: Greco-Roman polytheism.Court theatre (erected in 1689, demolished in 1827) and the fortifications of the Visconti Roc-chetta.
Disegno preparatorio.
Matrice negativa in gomma siliconica.
39 LaperiferiaModello n. 32 in gesso, scala 1:2500312x234x5 cm, composto da 108 moduli disposti su 12 righe e 9 colonne; moduli 26x26x5 cm.
Archetipo III: Ateismo tecnico-scientifico.
I
II
III
Working drawing.
Negative matrix in silicone rubber.
39 TheperipheryPlaster model no. 32, scale 1:2,500312x234x5 cm, consisting of 108 modules ar-ranged in 12 rows and 9 columns; modules 26x26x5 cm.
Archetype III: Technical-scientific atheism.
Disegni preparatori.
40 Lospaziodelpudore: legerarchiedelprogetto
Modelli in gesso, scala 1:250piante, 42x42x14 cmpianta delle rampe, 42x42x14 cmsezioni, 42x21x14 cm.
Da sinistra a destra, nell’ordine:Progetto A, diametro 93 mProgetto B, diametro 62 mProgetto C, diametro 41 m.
In successione dall’alto: la veduta zenitale della cavità il sistema di discesa delle rampela sezione sul diametro vista di tre quarti.
A C
I
II
III
B
Working drawings.
40 Thespaceofshame: theprojecthierarchies
Plaster models, scale 1:250plans, 42x42x14 cmplan of the ramps, 42x42x14 cmsections, 42x21x14 cm.
From left to right, in order:Project A, 93 m diameter Project B, 62 m diameter Project C, 41 m diameter.
In sequence from the top: zenithal view of the cavity the descending system of rampssection through the diameter, three-quarter view.
J. Hevelius, Costellazione di Perseo, 1690.
Disegno preparatorio.
43 Costellazionedeipunti:relazionedelpro-gettoconlacittànellasuaconfigurazionestoricaModello n. 34 in gesso, scala 1:10.000 42x42x5 cm.
Alle pagine successive:44 Costellazionedeipunti: inserimentodelprogettonellaperiferia
Modello n. 32 in gesso, scala 1:2.500.
J. Hevelius, Constellation of Perseus, 1690.
Working drawing.
43 Constellationofpoints:relationshipoftheprojecttothecityinitshistoricalconfigu-rationPlaster model no. 34, scale 1:10,000 42x42x5 cm.
On the following pages:44 Constellationofpoints: insertionoftheprojectintheperiphery
Plaster model no. 32, scale 1:2,500.
61 PiacentiaeetParmaeDucatus Egnazio Danti, 1580 ca., affresco, dimensioni 300x400 cm. Città del Vaticano, Galleria delle carte geografiche, Cortile del Belvedere. (Foto Musei Vaticani)
62 CartadelterritoriotraParmaePiacenza Ercole Pio e Giovan Antonio Paganino, 1574 ca., affresco. Biblioteca del Monastero di San Gio-vanni Evangelista di Parma, parete sud.
La rappresentazione mette in scena la doppia dimensione dello sguardo: del luogo e del suo osservatore.
61 PiacentiaeetParmaeDucatus Egnazio Danti, ca. 1580, fresco, size 300x400 cm. Vatican City, Gallery of Maps, Cortile del Belvedere. (Photo Musei Vaticani)
62 CartadelterritoriotraParmaePiacenza Ercole Pio and Giovan Antonio Paganino, ca. 1574, fresco. Library of the Monastery of San Giovanni Evangelista in Parma, south wall.
The representation depicts the double dimension of the gaze: the place and its observer.
63 CartadelterritoriocompresotraParmaeModena Anonimo, XVII secolo, china acquerellata. Mo-dena, Archivio di Stato, Mappario Estense, serie generale n. 202.
64 GenuinadescriptiototiusditionisParmensis Girolamo Cock, 1551, incisione su rame, 47,3x32,1 cm, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, St. Geogr. 43. (© 2013 Bi-blioteca Apostolica Vaticana)
La rappresentazione è sempre più evocativa del-la presentazione. I fiumi sono grandi alberi che sostengono tutto il paesaggio.
63 CartadelterritoriocompresotraParmaeModena Anonymous, 17th century, ink and watercolour. Modena, State Archives, Mappario Estense, General Series no. 202.
64 GenuinadescriptiototiusditionisParmensis Jerome Cock, 1551, engraving on copper, 47.3x32.1 cm, Vatican City, Vatican Library, St. Geo. 43. (© 2013 Vatican Apostolic Library)
Representation is always more evocative than presentation. The rivers are large trees that bear aloft the entire landscape.
67 PiantadellacittàdiParmaPietro Sottili, copia del 1875 da un originale del 1570 ca., china su carta, 63,5x84,7 cm. Museo Archeologico Nazionale, Parma.
68 ParmaJacopo Lauro, 1630 ca., incisione su rame, 17,9x23,8 cm. Collezioni d’Arte Fondazione Ca-riparma, inv. F 2495.
Le rappresentazioni iconografiche di questo periodo mettono in evidenza la dialettica degli opposti tra la dimensione finita e la dimensione infinita. La città è un’“isola” nel mare del pae-saggio. Il contrario dell’isolamento, il principio figurativo della periferia.
67 PiantadellacittàdiParmaPietro Sottili, an 1875 copy of the original from ca. 1570, ink on paper, 63.5x84.7 cm. National Archaeological Museum, Parma.
68 ParmaJacopo Lauro, ca. 1630, engraving on copper, 17.9x23.8 cm. Art Collections of the Cariparma Foundation, inv. F 2495.
The iconographic representations of this period reveal the dialectic of opposites between the fi-nite dimension and infinite dimension. The city is a “island” in the sea of the landscape. The opposite of isolation, the figurative principle of the periphery.
73 ParmaAnonimo, fine XVII secolo, china acquerellata su carta, 25,8x39,1 cm. Biblioteca Palatina di Parma, Ms. Parm. 3711, c. 46.
Ci si chiede per quale ragione oggi non si debba più riflettere sul profilo della città. Il non riflet-tere su questa questione apre una questione an-cora più grande: la perdita dell’interiorità, delle cose, del mondo, della persona.
73 ParmaAnonymous, late 17th century, ink and watercol-our on paper, 25.8x39.1 cm. Biblioteca Palatina, Parma, Ms. Parm. 3711, c. 46.
One wonders why today we should no longer reflect on the city’s profile. Failure to reflect on this question opens a still greater one: the loss of interiority, of things, of the world, of the person.
76 PlanimetriadiParmacittàetorrenteedelNavigliosinopressoColornoGiovanni Pietro Draghi, XVIII secolo, china co-lorata su carta incollata su tela, 35,9x164 cm. Archivio di Stato di Parma, Mappe e disegni XXX 20.
La natura del luogo, la confluenza dei due tor-renti e la loro spinta proveniente dagli Appen-nini tiene in tensione la struttura figurativa della città storica.
76 PlanimetriadiParmacittàetorrenteedelNavigliosinopressoColornoGiovanni Pietro Draghi, 18th century, coloured ink on paper glued onto canvas, 35.9x164 cm. State Archives of Parma, Maps and drawings XXX 20.
The nature of the place, the confluence of two rivers and their impulse coming from the Apen-nines holds the figurative structure of the historic city in tension.
77 PiantadellacittàdiParmaesuoterritorioconpartedelBorghigianoedelReggianoAnonimo, 1460 ca., tempera su pergamena, 59x92 cm. Archivio di Stato di Parma, Mappe e disegni II 85.
L’immagine archetipica della città-territorio mi-sura il divario incolmabile rispetto alla dissolu-zione della città contemporanea.
77 PiantadellacittàdiParmaesuoterritorioconpartedelBorghigianoedelReggianoAnonymous, ca. 1460, tempera on parchment, 59x92 cm. State Archives, Parma, Maps and drawings II 85.
The archetypal image of the city-region meas-ures the unbridgeable gap with respect to the dissolution of the contemporary city.
il progetto alla Pilotta
the project at the Pilotta
The project was exposed in the context of an Erasmus Intensive Programme organised by the Department of Engineering and Architecture of the University of Parma at the Voltoni del Guazzatoio in the historical complex of the Pilotta Palace, Parma (September 2012).
Il progetto è stato esposto nell’ambito di un Erasmus Intensive Programme promosso dal Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università degli Studi di Parma, presso i Voltoni del Guazzatoio nel complesso storico della Pilotta (settembre 2012).
apparati
apparatus
CaptionsList of imagesList of models
Time schedules
DidascalieElenco delle immagini
Elenco dei modelliCronoprogrammi
104 Immagine della città, 1630 ca., scala 1:10.000, cm 42x42. Sezioni costruttive per la realizzazio-ne della matrice positiva in cartoncino.
105 Immagine della città, 1630 ca., scala 1:10.000, cm 42x42. Pianta costruttiva per la realizzazione della matrice positiva in cartoncino. Distinzione tra le figure appartenenti alla base e le figure da elaborare a parte (Battistero, Duomo, San Gio-vanni Evangelista, San Vitale, Santa Maria della Steccata, Santissima Annunziata).
106 Immagine della città, 1680 ca., scala 1:10.000, cm 42x42. Sezioni costruttive per la realizzazio-ne della matrice positiva in cartoncino.
107 Immagine della città, 1680 ca., scala 1:10.000, cm 42x42. Pianta costruttiva per la realizzazione della matrice positiva in cartoncino.
108 Immagine della città, metà XVIII sec., scala 1:10.000, cm 42x42. Sezioni costruttive per la realizzazione della matrice positiva in cartoncino.
109 Immagine della città, metà XVIII sec., scala 1:10.000, cm 42x42. Pianta costruttiva per la re-alizzazione della matrice positiva in cartoncino.
110 Immagine della città, fine XVII sec., scala 1:10.000, cm 42x42. Sezioni costruttive per la realizzazione della matrice positiva in cartoncino.
111 Immagine della città, fine XVII sec., scala 1:10.000, cm 42x42. Pianta costruttiva per la re-alizzazione della matrice positiva in cartoncino. Distinzione tra le figure appartenenti alla base e le figure da elaborare a parte (Battistero, Duo-mo, San Giovanni Evangelista, Santa Maria della Steccata, Santissima Annunziata).
112 Rappresentazione della centuriazione romana, scala 1:25.000, cm 42x42.
113 Sovrapposizione della figura della città moderna con le tracce della centuriazione, scala 1:25.000, cm 42x42.
114 Immagine della “Pianta della città di Parma e suo territorio con parte del Borghigiano e del Reggiano”, 1460 ca.,scala 1:25.000, cm 42x42. Abaco degli elementi (Parma e fortezze circo-stanti) da realizzare a parte.
115 Immagine della “Pianta della città di Parma e suo territorio con parte del Borghigiano e del Reggiano”, 1460 ca.,scala 1:25.000, cm 42x42. Pianta con i riferimenti all’abaco.
116 Studio delle immagini evolutive del sistema di-fensivo in relazione al torrente Parma e al Pa-lazzo della Pilotta, 1500 ca.,scala 1:2.500, cm 42x42. Sezioni costruttive per la realizzazione della matrice positiva in cartoncino.
117 Studio delle immagini evolutive del sistema difen-sivo in relazione al torrente Parma e al Palazzo della Pilotta, 1500 ca.,scala 1:2.500, cm 42x42. Pianta costruttiva per la realizzazione della matri-ce positiva in cartoncino. Distinzione tra le figure appartenenti alla base e le figure da elaborare a parte (Battistero, Duomo, San Pietro Martire).
118 Studio delle immagini evolutive del sistema di-fensivo in relazione al torrente Parma e al Pa-lazzo della Pilotta, 1585 ca.,scala 1:2.500, cm 42x42. Sezioni costruttive per la realizzazione della matrice positiva in cartoncino.
119 Studio delle immagini evolutive del sistema difen-sivo in relazione al torrente Parma e al Palazzo della Pilotta, 1585 ca.,scala 1:2.500, cm 42x42. Pianta costruttiva per la realizzazione della matri-ce positiva in cartoncino. Distinzione tra le figure appartenenti alla base e le figure da elaborare a parte (Giardino Ducale, Santissima Annunziata, San Pietro Martire, antico palazzo ducale, Santa Maria della Steccata, Battistero, Duomo).
120 Studio delle immagini evolutive del sistema di-fensivo in relazione al torrente Parma e al Pa-lazzo della Pilotta, 1800 ca.,scala 1:2.500, cm 42x42. Sezioni costruttive per la realizzazione della matrice positiva in cartoncino.
121 Studio delle immagini evolutive del sistema di-fensivo in relazione al torrente Parma e al Pa-lazzo della Pilotta, 1800 ca.,scala 1:2.500, cm 42x42. Pianta costruttiva per la realizzazione della matrice positiva in cartoncino. Distinzio-ne tra le figure appartenenti alla base e le figure da elaborare a parte (Giardino Ducale, palazzo ducale del giardino, Santissima Annunziata, San Pietro Martire, antico palazzo ducale, Santa Ma-ria della Steccata, Battistero, Duomo).
122 Palazzo della Pilotta: posizione del Teatro Far-nese, scala 1:400, cm 42x42. Sezioni relative al modello finale in gesso con l’indicazione di inse-rimento delle figure elaborate a parte, Rocchetta e teatrino di corte (in alto) e teatro (in basso).
DidascalieDisegni preparatori per la costruzione dei modelli
94 Ambito geografico, scala 1:100.000, cm 104x104.95 Sistema idrografico del territorio parmense, scala
1:50000, cm 104x104.96 Impianto fondativo della città – Epoca romana,
scala 1:10.000, cm 42x42. Sezioni costruttive per la realizzazione della matrice positiva in cartoncino. Distinzione tra le figure appartenenti alla base e le figure da elaborare a parte (castro, teatro, anfiteatro).
97 Impianto fondativo della città – Epoca romana, scala 1:10.000, cm 42x42. Pianta costruttiva per la realizzazione della matrice positiva in carton-cino. Distinzione tra le figure appartenenti alla base e le figure da elaborare a parte (castro, tea-tro, anfiteatro).
98 Impianto fondativo della città – Epoca longobar-da, scala 1:10.000, cm 42x42. Sezioni costrutti-ve per la realizzazione della matrice positiva in cartoncino. Distinzione tra le figure appartenenti alla base e le figure da elaborare a parte (castro, teatro, anfiteatro, Duomo).
99 Impianto fondativo della città – Epoca longobar-da, scala 1:10.000, cm 42x42. Pianta costrutti-va per la realizzazione della matrice positiva in cartoncino. Distinzione tra le figure appartenenti alla base e le figure da elaborare a parte (castro, teatro, anfiteatro, Duomo).
100 Immagine della città, 1640, scala 1:10.000, cm 42x42. Sezioni costruttive per la realizzazione della matrice positiva in cartoncino.
101 Immagine della città, 1640, scala 1:10.000, cm 42x42. Pianta costruttiva per la realizzazione della matrice positiva in cartoncino. Distinzione tra le figure appartenenti alla base e le figure da elaborare a parte (Battistero, Duomo, San Gio-vanni Evangelista, Santa Maria della Steccata, Santissima Annunziata).
102 Immagine della città, 1720, scala 1:10.000, cm 42x42. Sezioni costruttive per la realizzazione della matrice positiva in cartoncino.
103 Immagine della città, 1720, scala 1:10.000, cm 42x42. Pianta costruttiva per la realizzazione della matrice positiva in cartoncino. Distinzione tra le figure appartenenti alla base e le figure da elaborare a parte (Battistero, Duomo, Santissima Annunziata).
351
123 Palazzo della Pilotta: posizione del Teatro Far-nese, scala 1:400, cm 42x42. Pianta relativa al modello finale in gesso con l’indicazione di inse-rimento delle figure elaborate a parte, Rocchetta, teatrino di corte e teatro.
124 Palazzo della Pilotta: posizione del Teatro Far-nese, scala 1:400, cm 42x42. Sezioni costrutti-ve per la realizzazione della matrice negativa in cartoncino; entrambe le sezioni riportano in alto il disegno corrispettivo del modello finito in ges-so così come verrà estratto dalla matrice.
125 Palazzo della Pilotta: posizione del Teatro Farne-se, scala 1:400, cm 42x42. Pianta costruttiva per la realizzazione matrice negativa in cartoncino con indicazione delle cavità destinate all’allog-giamento dei tre elementi realizzati a parte.
126 Palazzo della Pilotta: studio delle volte, scala 1:400, cm 42x42. Sezioni relative al modello fi-nale in gesso.
127 Palazzo della Pilotta: studio delle volte, scala 1:400, cm 42x42. Pianta relativa al modello fi-nale in gesso.
128 Palazzo della Pilotta: studio delle volte, scala 1:400, cm 42x42. Sezioni costruttive per la re-alizzazione della matrice negativa in cartoncino; entrambe le sezioni riportano in alto il disegno corrispettivo del modello finito in gesso così come verrà estratto dalla matrice.
129 Palazzo della Pilotta: studio delle volte, scala 1:400, cm 42x42. Pianta costruttiva per la rea-lizzazione della matrice negativa in cartoncino. Indicazione di tutti i volumi delle volte da co-struire in cartoncino.
130 Palazzo della Pilotta: studio delle volte, scala 1:200, cm 42x63. Sezioni relative al modello fi-nale in gesso.
131 Palazzo della Pilotta: studio delle volte, scala 1:200, cm 42x63. Pianta relativa al modello finale in gesso. Ogni volta è contrassegnata dal riferi-mento al rispettivo volume sviluppato nell’abaco.
132 Palazzo della Pilotta: studio delle volte, scala 1:200, cm 42x63. Sezioni costruttive per la re-alizzazione della matrice negativa in cartoncino; entrambe le sezioni riportano in alto il disegno corrispettivo del modello finito in gesso così come verrà estratto dalla matrice.
133 Palazzo della Pilotta: studio delle volte, scala 1:200, cm 42x63. Abaco dello sviluppo dei volu-mi negativi delle volte.
134 Teatro Farnese: sezione longitudinale, scala 1:200, cm 84x42. Sezione relativa al modello fi-nale in gesso; in nero la matrice negativa in car-toncino, in rosso il modello finale in cartoncino del teatro, da inserire nel gesso finale.
135 Battistero, estradosso della cupola a livello della copertura, scala 1:100, cm 42x42. Sezione relati-va al modello finale in gesso.
136 Battistero, estradosso della cupola a livello della copertura, scala 1:100, cm 42x42. Pianta relativa al modello finale in gesso.
137 Battistero, estradosso della cupola a livello della copertura, scala 1:100, cm 42x42. Sezione co-struttiva per la realizzazione della matrice nega-tiva in cartoncino dell’estradosso della cupola. Posizione e andamento delle centine.
138 Battistero, estradosso della cupola a livello del-la copertura, scala 1:100, cm 42x42. Pianta co-struttiva per la realizzazione della matrice nega-tiva in cartoncino dell’estradosso della cupola. Centinatura della cavità del calco.
139 Battistero, livello dei portali d’ingresso, scala 1:100, cm 42x42. Sezione relativa al modello finale in gesso. Sezioni costruttive delle matrici positive degli elementi da realizzarsi a parte e inserire nel gesso finale.
140 Battistero, livello dei portali d’ingresso, scala 1:100, cm 42x42. Pianta relativa al modello fi-nale in gesso.
141 Battistero, livello dei portali d’ingresso, scala 1:100, cm 42x42. Sezione costruttiva per la re-alizzazione della matrice negativa in cartoncino. Sezioni costruttive delle matrici negative degli elementi da realizzarsi a parte e inserire nella matrice.
142 Battistero, livello dei portali d’ingresso, scala 1:100, cm 42x42. Pianta costruttiva per la rea-lizzazione della matrice negativa in cartoncino. Posizione e andamento delle centine.
143 Battistero, livello del secondo ordine delle logge interne, scala 1:100, cm 42x42. Sezione relati-va al modello finale in gesso. Sezioni costruttive delle matrici positive degli elementi da realiz-zarsi a parte e inserire nel gesso finale.
144 Battistero, livello del secondo ordine delle logge interne, scala 1:100, cm 42x42. Pianta relativa al modello finale in gesso.
145 Battistero, livello del secondo ordine delle logge interne, scala 1:100, cm 42x42. Sezione costrut-tiva per la realizzazione della matrice negativa in cartoncino. Sezioni costruttive delle matrici negative degli elementi da realizzarsi a parte e inserire nella matrice.
146 Battistero, livello del secondo ordine delle logge interne, scala 1:100, cm 42x42. Pianta costrutti-va per la realizzazione della matrice negativa in cartoncino. Posizione e andamento delle centine.
147 Battistero, livello dell’imposta della cupola, sca-la 1:100, cm 42x42. Sezione relativa al modello finale in gesso. Sezioni costruttive delle matrici positive degli elementi da realizzarsi a parte e inserire nel gesso finale.
148 Battistero, livello dell’imposta della cupola, sca-la 1:100, cm 42x42. Pianta relativa al modello finale in gesso.
149 Battistero, livello dell’imposta della cupola, scala 1:100, cm 42x42. Sezione costruttiva per la re-alizzazione della matrice negativa in cartoncino. Sezioni costruttive delle matrici negative degli elementi da realizzarsi a parte e inserire nella matrice.
150 Battistero, livello dell’imposta della cupola, scala 1:100, cm 42x42. Pianta costruttiva per la rea-lizzazione della matrice negativa in cartoncino. Posizione e andamento delle centine.
151 Battistero, intradosso della cupola a livello dell’imposta, scala 1:100, cm 42x42. Sezione relativa al modello finale in gesso. Sezioni co-struttive delle matrici positive degli elementi da realizzarsi a parte e inserire nel gesso finale.
152 Battistero, intradosso della cupola a livello dell’imposta, scala 1:100, cm 42x42. Pianta re-lativa al modello finale in gesso.
153 Battistero, intradosso della cupola a livello dell’imposta, scala 1:100, cm 42x42. Sezione costruttiva per la realizzazione della matrice negativa in cartoncino. Sezioni costruttive delle matrici negative degli elementi da realizzarsi a parte e inserire nella matrice.
154 Battistero, intradosso della cupola a livello dell’imposta, scala 1:100, cm 42x42. Pianta co-struttiva per la realizzazione della matrice nega-tiva in cartoncino. Posizione e andamento delle centine.
155 Battistero, sezione, scala 1:100, cm 42x63. Sezio-ne relativa al modello finale in gesso. In evidenza le due grandi cavità dell’aula battesimale e dello spazio tra l’estradosso della cupola e il tetto.
156 Battistero, bassorilievo dello sviluppo interno, scala 1:200, cm 42x42. Prospetto relativo al mo-dello finale in gesso. In evidenza il doppio ritmo ottagonale esterno e esadecagonale interno.
157 Costellazione dei punti: inserimento del progetto nella periferia, scala 1:2.500, cm 312x234. Pla-nimetria relativa al modello finale in gesso. In-serimento del progetto alle tre scale tra il limite storico della città e il limite contemporaneo dato dalla tangenziale.
158 Lo spazio del pudore: progetto A. Pianta, diame-tro 93 m, scala 1:250, cm 42x42. Pianta relativa al modello finale in gesso con indicazione della direzione data dall’accesso e dei diversi livelli dei camminamenti.
159 Lo spazio del pudore: progetto A. Sezione, diame-tro 93 m, scala 1:250, cm 42x42. Sezione rela-tiva al modello finale in gesso con indicazione della posizione dei tori di chiusura dei percorsi interni a spirale e delle quote delle rampe.
160 Lo spazio del pudore: progetto A. Rampe, diame-tro 93 m, scala 1:250, cm 42x42. Pianta relativa al modello finale in gesso con indicazione del funzionamento delle rampe alle diverse quote.
161 Lo spazio del pudore: progetto B. Pianta, diame-tro 62 m, scala 1:250, cm 42x42. Pianta relativa al modello finale in gesso con indicazione della direzione data dall’accesso e dei diversi livelli dei camminamenti.
162 Lo spazio del pudore: progetto B. Sezione, diame-tro 62 m, scala 1:250, cm 42x42. Sezione rela-tiva al modello finale in gesso con indicazione della posizione dei tori di chiusura dei percorsi interni a spirale e delle quote delle rampe.
163 Lo spazio del pudore: progetto B. Rampe, diame-tro 62 m, scala 1:250, cm 42x42. Pianta relativa al modello finale in gesso con indicazione del funzionamento delle rampe alle diverse quote.
164 Lo spazio del pudore: progetto C. Pianta, diame-tro 41 m, scala 1:250, cm 42x42. Pianta relativa al modello finale in gesso con indicazione della direzione data dall’accesso e dei diversi livelli dei camminamenti.
165 Lo spazio del pudore: progetto C. Sezione, diame-tro 41 m, scala 1:250, cm 42x42. Sezione rela-tiva al modello finale in gesso con indicazione della posizione dei tori di chiusura dei percorsi interni a spirale e delle quote delle rampe.
166 Lo spazio del pudore: progetto C. Rampe, diame-tro 41 m, scala 1:250, cm 42x42. Pianta relativa al modello finale in gesso con indicazione del funzionamento delle rampe alle diverse quote.
167 Lo spazio del pudore: progetto A. Disegno per le matrici, scala 1:250, cm 42x42. Disegno co-struttivo delle matrici negative in cartoncino dei livelli gradonati per il modello delle rampe. Po-sizione delle centine.
168 Lo spazio del pudore: progetto C. Disegno per le matrici, scala 1:250, cm 42x42. Disegno costrut-tivo delle matrici positive in cartoncino con la posizione dei tori (centine) lungo gli anelli.
169 Lo spazio del pudore: progetti A, B, C, scala 1:250, cm 42x42. Abaco dei tori (centine) per le tre scale dei modelli.
170 Lo spazio del pudore: progetti A, B, C, scala 1:250, cm 42x42. Schema costruttivo di verifica del posizionamento e montaggio dei tori.
353
CaptionsWorking drawings for models’ construction
104 Image of the city, ca. 1630, scale 1:10,000, 42x42 cm. Construction sections to produce the positive matrix in cardboard.
105 Image of the city, ca. 1630, scale 1:10,000, 42x42 cm. Construction plan to produce the positive matrix in cardboard. Distinction between figures belonging to the base and figures to be developed separately (Baptistery, Cathedral, San Giovanni Evangelista, San Vitale, Santa Maria della Steccata, Santissima Annunziata).
106 Image of the city, ca. 1680, scale 1:10,000, 42x42 cm. Construction sections to produce the positive matrix in cardboard.
107 Image of the city, ca. 1680, scale 1:10,000, 42x42 cm. Construction plan to produce the positive matrix in cardboard.
108 Image of the city, mid 18th century, scale 1:10,000, 42x42 cm. Construction sections to produce the positive matrix in cardboard.
109 Image of the city, mid 18th century, scale 1:10,000, 42x42 cm. Construction plan to produce the positive matrix in cardboard.
110 Image of the city, late 17th century, scale 1:10,000, 42x42 cm. Construction sections to produce the positive matrix in cardboard.
111 Image of the city, late 17th century, scale 1:10,000, 42x42 cm. Construction plan to produce the positive matrix in cardboard. Distinction between figures belonging to the base and figures to be developed separately (Baptistery, Cathedral, San Giovanni Evangelista, Santa Maria della Steccata, Santissima Annunziata).
112 Representation of the Roman centuration, scale 1:25000, 42x42 cm.
113 Superimposition of the figure of the modern city on the traces of centuration, scale 1:25,000, 42x42 cm.
114 Image of the “Plan of the city of Parma and its territory with part of Borghigiano and Reggiano”, ca. 1460, scale 1:25,000, 42x42 cm. Abacus of the elements (Parma and surrounding fortresses) to be produced separately.
115 Image of the “Plan of the city of Parma and its territory with part of Borghigiano and Reggiano”, ca. 1460, scale 1:25,000, 42x42 cm. Plan referring to the abacus.
116 Study of evolving images of the defensive system in relation to the Parma stream and the Palazzo della Pilotta, ca. 1500,scale 1:2,500, 42x42 cm. Construction sections to produce the positive matrix in cardboard.
117 Study of evolving images of the defensive system in relation to the Parma stream and the Palazzo della Pilotta, ca. 1500, scale 1:2,500, 42x42 cm. Construction plan to produce the positive matrix in cardboard. Distinction between figures belonging to the base and figures to be developed separately (Baptistery, Cathedral, San Pietro Martire).
118 Study of evolving images of the defensive system in relation to the Parma stream and the Palazzo della Pilotta, ca. 1585, scale 1:2,500, 42x42 cm. Construction sections to produce the positive matrix in cardboard.
119 Study of evolving images of the defensive system in relation to the Parma stream and the Palazzo della Pilotta, ca. 1585, scale 1:2,500, 42x42 cm. Construction plan to produce the positive matrix in cardboard. Distinction between figures belonging to the base and figures to be developed separately (Ducal Garden, Santissima Annunziata, San Pietro Martire, ancient ducal palace, Santa Maria della Steccata, Baptistery, Cathedral).
120 Study of evolving images of the defensive system in relation to the Parma stream and the Palazzo della Pilotta, ca. 1800, scale 1:2,500, 42x42 cm. Construction sections to produce the positive matrix in cardboard.
121 Study of evolving images of the defensive system in relation to the Parma stream and the Palazzo della Pilotta, ca. 1800, scale 1:2,500, 42x42 cm. Construction plan to produce the positive matrix in cardboard. Distinction between figures belonging to the base and figures to be developed separately (Ducal Garden, ducal garden palace, Santissima Annunziata, San Pietro Martire, ancient ducal palace, Santa Maria della Steccata, Baptistery, Cathedral).
94 Geographical ambit, scale 1:100,000, 104x104 cm.
95 Hydrographic system of the territory of Parma, scale 1:50,000, 104x104cm.
96 Foundation layout of the city – Roman era, scale 1:10,000, 42x42cm. Construction sections to produce the positive matrix in cardboard. Distinction between figures belonging to the base and figures to be developed separately (castra, theatre, amphitheatre).
97 Foundation layout of the city – Roman era, scale 1:10,000, 42x42 cm. Construction plan to produce the positive matrix in cardboard. Distinction between figures belonging to the base and figures to be developed separately (castra, theatre, amphitheatre).
98 Foundation layout of the city – Lombard era, scale 1:10,000, 42x42 cm. Construction sections to produce the positive matrix in cardboard. Distinction between figures belonging to the base and figures to be developed separately (castra, theatre, amphitheatre, Cathedral).
99 Foundation layout of the city – Lombard era, scale 1:10,000, 42x42 cm. Construction plan to produce the positive matrix in cardboard. Distinction between figures belonging to the base and figures to be developed separately (castra, theatre, amphitheatre, Cathedral).
100 Image of the city, 1640, scale 1:10,000, 42x42 cm. Construction sections to produce the positive matrix in cardboard.
101 Image of the city, 1640, scale 1:10,000, 42x42 cm. Construction plan to produce the positive matrix in cardboard. Distinction between figures belonging to the base and figures to be developed separately (Baptistery, Cathedral, San Giovanni Evangelista, Santa Maria della Steccata, Santissima Annunziata).
102 Image of the city, 1720, scale 1:10,000, 42x42 cm. Construction sections to produce the positive matrix in cardboard.
103 Image of the city, 1720, scale 1:10,000, 42x42 cm. Construction plan to produce the positive matrix in cardboard. Distinction between figures belonging to the base and figures to be developed separately (Baptistery, Cathedral, Santissima Annunziata).
122 Palazzo della Pilotta: position of the Farnese Theatre, scale 1:400, 42x42 cm. Sections relating to the final plaster model with an indication of where to insert figures developed separately, Rocchetta and court theatre (at the top) and the theatre (at the bottom).
123 Palazzo della Pilotta: position of the Farnese Theatre, scale 1:400, 42x42 cm. Plan relating to the final plaster model with an indication of where to insert figures developed separately, Rocchetta, court theatre, and theatre.
124 Palazzo della Pilotta: position of the Farnese Theatre, scale 1:400, 42x42 cm. Construction sections to produce the negative matrix in cardboard; both sections show at the top the corresponding drawing of the finished plaster model as it would come out of the matrix.
125 Palazzo della Pilotta: position of the Farnese Theatre, scale 1:400, 42x42 cm. Construction sections to produce the negative matrix in cardboard with an indication of the cavity destined to house three elements produced separately.
126 Palazzo della Pilotta: study of the vaults, scale 1:400, 42x42 cm. Sections relating to the final plaster model.
127 Palazzo della Pilotta: study of the vaults, scale 1:400, 42x42 cm. Plan relating to the final plaster model.
128 Palazzo della Pilotta: study of the vaults, scale 1:400, 42x42 cm. Construction sections to produce the negative matrix in cardboard; both sections show at the top the corresponding drawing of the finished plaster model as it would come out of the matrix.
129 Palazzo della Pilotta: study of the vaults, scale 1:400, 42x42 cm. Construction plan to produce the negative matrix in cardboard Indication of all the volumes of the vaults to be built in cardboard.
130 Palazzo della Pilotta: study of the vaults, scale 1:200, 42x63 cm. Sections relating to the final plaster model.
131 Palazzo della Pilotta: study of the vaults, scale 1:200, 42x63 cm. Plan relating to the final plaster model. Each vault is marked by a reference to the respective volume developed in the abacus.
132 Palazzo della Pilotta: study of the vaults, scale 1:200, 42x63 cm. Construction sections to produce the negative matrix in cardboard; both sections show at the top the corresponding drawing of the finished plaster model as it would come out of the matrix.
133 Palazzo della Pilotta: study of the vaults, scale 1:200, 42x63 cm. Abacus of the development of the negative volumes of the vaults.
134 Farnese Theatre: longitudinal section, scale 1:200, 84x42 cm. Section relating to the final plaster model; in black the negative matrix in cardboard, in red the final cardboard model of the theatre, to be inserted into the final plaster model.
135 Baptistery, extrados of the dome at roof level, scale 1:100, 42x42 cm. Section relating to the final plaster model.
136 Baptistery, extrados of the dome at roof level, scale 1:100, 42x42 cm. Plan relating to the final plaster model.
137 Baptistery, extrados of the dome at roof level, scale 1:100, 42x42 cm. Construction section to produce the negative matrix in cardboard of the extrados of the dome. Position and layout of the centres.
138 Baptistery, extrados of the dome at roof level, scale 1:100, 42x42 cm. Construction plan to produce the negative matrix in cardboard of the extrados of the dome. Centring of the cavity of the cast.
139 Baptistery, entrance portal level, scale 1:100, 42x42 cm. Section relating to the final plaster model. Construction sections of the positive matrices of elements to be produced separately and inserted into the final plaster model.
140 Baptistery, entrance portal level, scale 1:100, 42x42 cm. Plan relating to the final plaster model.
141 Baptistery, extrados of the dome at roof level, scale 1:100, 42x42 cm. Construction section to produce the negative matrix in cardboard of the extrados of the dome. Construction sections of the negative matrices of elements to be produced separately and inserted into the matrix.
142 Baptistery, entrance portal level, scale 1:100, 42x42 cm. Construction plan to produce the negative matrix in cardboard. Position and layout of the centres.
143 Baptistery, level of the second order of internal balconies, scale 1:100, 42x42 cm. Section relating to the final plaster model. Construction sections of the positive matrices of elements to be produced separately and inserted into the final plaster model.
144 Baptistery, level of the second order of internal balconies, scale 1:100, 42x42 cm. Plan relating to the final plaster model.
145 Baptistery, level of the second order of internal balconies, scale 1:100, 42x42 cm. Construction section to produce the negative matrix in cardboard of the extrados of the dome. Construction sections of the negative matrices of elements to be produced separately and inserted into the matrix.
146 Baptistery, level of the second order of internal balconies, scale 1:100, 42x42 cm. Construction plan to produce the negative matrix in cardboard. Position and layout of the centres.
147 Baptistery, level of the dome impost, scale 1:100, 42x42 cm. Section relating to the final plaster model. Construction sections of the positive matrices of elements to be produced separately and inserted into the final plaster model.
148 Baptistery, level of the dome impost, scale 1:100, 42x42 cm. Plan relating to the final plaster model.
149 Baptistery, level of the dome impost, scale 1:100, 42x42 cm. Construction section to produce the negative matrix in cardboard. Construction sections of the negative matrices of elements to be produced separately and inserted into the matrix.
150 Baptistery, level of the dome impost, scale 1:100, 42x42 cm. Construction plan to produce the negative matrix in cardboard. Position and progress of the centres.
151 Baptistery, intrados of the dome at the impost level, scale 1:100, 42x42 cm. Section relating to the final plaster model. Construction sections of the positive matrices of elements to be produced separately and inserted into the final plaster model.
152 Baptistery, intrados of the dome at the impost level, scale 1:100, 42x42 cm. Plan relating to the final plaster model.
153 Baptistery, intrados of the dome at the impost level, scale 1:100, 42x42 cm. Construction section to produce the negative matrix in cardboard. Construction sections of the negative matrices of elements to be produced separately and inserted into the matrix.
154 Baptistery, intrados of the dome at the impost level, scale 1:100, 42x42 cm. Construction plan to produce the negative matrix in cardboard. Position and progress of the centres.
155 Baptistery, section, scale 1:100, 42x42 cm. Section relating to the final plaster model. In evidence are the two large cavities of the baptismal hall and the space between the extrados of the dome and the roof.
156 Baptistery, bas relief of the interior, scale 1:200, 42x42 cm. Perspective view relating to the final plaster model. In evidence are the rhythms given by the double external octagon and the internal hexadecagon.
157 Constellation of points: insertion of the project in the periphery, scale 1:2,500, 312x234 cm. Ground plan relating to the final plaster model. Insertion of the project at the three scales between the historical limit of the city and the contemporary limit imposed by the orbital road.
355
158 The space of shame: project A. Plan, 93 m diameter, scale 1:250, 42x42 cm. Plan relating to the final plaster model with indication of the direction given by the access and the various walkway levels.
159 The space of shame: project A. Section, 93 m diameter, scale 1:250, 42x42 cm. Section relating to the final plaster model with indication of the position of the tori that close off the internal spiral paths and the heights of the ramps.
160 The space of shame: project A. Ramps, 93 m diameter, scale 1:250, 42x42 cm. Plan relating to the final plaster model with indication of the functioning of the ramps at the various heights.
161 The space of shame: project B. Plan, 62 m diameter, scale 1:250, 42x42 cm. Plan relating to the final plaster model with indication of the direction given by the access and the various walkway levels.
162 The space of shame: project B. Section, 62 m diameter, scale 1:250, 42x42 cm. Section relating to the final plaster model with indication of the position of the tori that close off the internal spiral paths and the heights of the ramps.
163 The space of shame: project B. Ramps, 62 m diameter, scale 1:250, 42x42 cm. Plan relating to the final plaster model with indication of the functioning of the ramps at the various heights.
164 The space of shame: project C. Plan, 41 m diameter, scale 1:250, 42x42 cm. Plan relating to the final plaster model with indication of the direction given by the access and the various walkway levels.
165 The space of shame: project C. Section, 41 m diameter, scale 1:250, 42x42 cm. Section relating to the final plaster model with indication of the position of the tori that close off the internal spiral paths and the heights of the ramps.
166 The space of shame: project C. Ramps, 41 m diameter, scale 1:250, 42x42 cm. Plan relating to the final plaster model with indication of the functioning of the ramps at the various heights.
167 The space of shame: project A. Drawing of the matrices, scale 1:250, 42x42 cm. Construction drawing of the negative matrices in cardboard of the stepped levels for the model of the ramps. Position of the centres.
168 The space of shame: project C. Drawing of the matrices, scale 1:250, 42x42 cm. Construction drawing of the positive matrices in cardboard with the position of the tori (centres) along the rings.
169 The space of shame: projects A, B, and C, scale 1:250, 42x42 cm. Abacus of the tori (centres) for the three scales of the models.
170 The space of shame: projects A, B, and C, scale 1:250, 42x42 cm. Construction scheme to verify the positioning and erection of the tori.
Ambitogeografico/Geographical ambit
1 Ambito geografico2 Sistema idrografico del territorio parmense
Ambitostoricourbano/Historical urban ambit
3 Rappresentazione dell’ambito storico di Parma4 Impianto fondativo della città – Epoca romana5 Impianto fondativo della città – Epoca longobarda6 Immagine della città, 1630 ca.7 Immagine della città, 1680 ca.8 Immagine della città, 16409 Immagine della città, 1720 ca.10 Immagine della città – fine XVII secolo11 Immagine della città, metà XVIII secolo12 Immagine della città in relazione con le figure
dei suoi fiumi: torrente Baganza e torrente Par-ma, XVIII secolo
13 Immagine della “Pianta della città di Parma e suo territorio con parte del Borghigiano e del Reggiano”, 1460 ca.
14 Relazioni figurative15 Relazioni figurative16 Relazioni figurative17 Rappresentazione della centuriazione romana18 Sovrapposizione della figura della città moderna
con le tracce della centuriazione
Archetipi/Archetypes
19 Battistero, sezione20 Battistero, bassorilievo dello sviluppo interno21 Battistero, livello dei portali d’ingresso22 Battistero, livello dei portali d’ingresso, veduta
di tre quarti23 Battistero, livello del secondo ordine delle logge
interne24 Battistero, livello del secondo ordine delle logge
interne, veduta di tre quarti25 Battistero, livello dell’imposta della cupola26 Battistero, livello dell’imposta della cupola, ve-
duta di tre quarti27 Battistero, estradosso della cupola a livello della
copertura
28 Battistero, estradosso della cupola a livello della copertura, veduta di tre quarti
29 Battistero, intradosso della cupola a livello dell’imposta
30 Battistero, intradosso della cupola a livello dell’imposta, veduta di tre quarti
31 Battistero, intradosso della cupola a livello dell’imposta, dettaglio
32 Studio delle immagini evolutive del sistema di-fensivo in relazione al torrente Parma e al Palaz-zo della Pilotta, 1500 ca.
33 Studio delle immagini evolutive del sistema di-fensivo in relazione al torrente Parma e al Palaz-zo della Pilotta, 1585 ca.
34 Studio delle immagini evolutive del sistema di-fensivo in relazione al torrente Parma e al Palaz-zo della Pilotta, 1800 ca.
35 Palazzo della Pilotta: studio delle volte 36 Palazzo della Pilotta: studio delle volte 37 Palazzo della Pilotta: posizione del Teatro Farnese38 Teatro Farnese: sezione longitudinale39 La periferia
Lospaziodelpudore/The space of shame
40 Lo spazio del pudore: le gerarchie del progetto41 Costellazione dei punti: inserimento geografico
del progetto42 Costellazione dei punti: inserimento geografico
del progetto43 Costellazione dei punti: relazione del progetto
con la città nella sua configurazione storica44 Costellazione dei punti: inserimento del progetto
nella periferia45 Sezione territoriale46 Ipotesi alternativa del percorso di risalita 47 Lo spazio del pudore48 Lo spazio del pudore49 Lo spazio del pudore, veduta di tre quarti50 Lo spazio del pudore: sezione 51 Lo spazio del pudore: rampe52 Lo spazio del pudore53 Lo spazio del pudore: veduta di tre quarti54 Lo spazio del pudore: sezione 55 Lo spazio del pudore: rampe
56 Lo spazio del pudore57 Lo spazio del pudore: veduta di tre quarti58 Lo spazio del pudore: sezione 59 Lo spazio del pudore: rampe
Materialiiconografici/Iconographic materials
60 Carta topografica dei ducati di Parma, Piacenza e Guastalla
61 Piacentiae et Parmae Ducatus 62 Carta del territorio tra Parma e Piacenza 63 Carta del territorio compreso tra Parma e Modena 64 Genuina descriptio totius ditionis Parmensis 65 La città di Parma, delineata e divisa in isole
colla descrizione degli attuali possessori di tutte le case, chiese, monasteri, dei canali, cavi, ca-nadelle, condotti, coli e fontane che vi scorrono sotterra
66 Tracce della centuriazione dell’agro parmense67 Pianta della città di Parma68 Parma, 1630 ca.69 La nobilissima città di Parma70 Parma tratta da 18 piante delle più importanti
fortezze d’Italia71 Pianta della città di Parma72 La città di Parma, capitale del Ducato Parmigiano73 Parma, fine XVII secolo74 Parma, 164075 Parma, 1720 ca.76 Planimetria di Parma città e torrente e del Navi-
glio sino presso Colorno77 Pianta della città di Parma e suo territorio con
parte del Borghigiano e del Reggiano78 Battistero, Facciata a Ponente79 Battistero, Spaccato generale80 Battistero, portale sud 81 Battistero, particolare della lunetta del portale
sud82 Prospetto interno del Battistero di Parma83 Plan général du grand Théatre de Parme84 Pianta icnografica della Pilotta e degli edifizj
adjacenti85 Coupe sur la largeur du grand Théatre de Parme86 Coupe sur la longeur du grand Théatre de Parme87 Assunzione della Vergine88 Visione di san Giovanni
Elenco delle immagini / List of images
357
Schizzi/Sketches
89 Schizzi90 Schizzi91 Schizzi92 Schizzi93 Schizzi
Disegni/Drawings
94 Ambito geografico95 Sistema idrografico del territorio parmense96 Impianto fondativo della città – Epoca romana:
sezioni97 Impianto fondativo della città – Epoca romana:
pianta98 Impianto fondativo della città – Epoca longobar-
da: sezioni99 Impianto fondativo della città – Epoca longobar-
da: pianta100 Immagine della città, 1640: sezioni101 Immagine della città, 1640: pianta102 Immagine della città, 1720 ca.: sezioni103 Immagine della città, 1720 ca.: pianta104 Immagine della città, 1630 ca.: sezioni105 Immagine della città, 1630 ca.: pianta106 Immagine della città, 1680 ca.: sezioni107 Immagine della città, 1680 ca.: pianta108 Immagine della città, metà XVIII secolo: sezioni109 Immagine della città, metà XVIII secolo: pianta110 Immagine della città, fine XVII secolo: sezioni111 Immagine della città, fine XVII secolo: pianta112 Rappresentazione della centuriazione romana113 Sovrapposizione della figura della città moderna
con le tracce della centuriazione114 Immagine della “Pianta della città di Parma e
suo territorio con parte del Borghigiano e del Reggiano”, 1460 ca.: abaco
115 Immagine della “Pianta della città di Parma e suo territorio con parte del Borghigiano e del Reggiano”, 1460 ca.: pianta
116 Studio delle immagini evolutive del sistema di-fensivo in relazione al torrente Parma e al Palaz-zo della Pilotta, 1500 ca.: sezioni
117 Studio delle immagini evolutive del sistema di-fensivo in relazione al torrente Parma e al Palaz-zo della Pilotta, 1500 ca.: pianta
118 Studio delle immagini evolutive del sistema di-fensivo in relazione al torrente Parma e al Palaz-zo della Pilotta, 1585 ca.: sezioni
119 Studio delle immagini evolutive del sistema di-fensivo in relazione al torrente Parma e al Palaz-zo della Pilotta, 1585 ca.: pianta
120 Studio delle immagini evolutive del sistema di-fensivo in relazione al torrente Parma e al Palaz-zo della Pilotta, 1800 ca.: sezioni
121 Studio delle immagini evolutive del sistema di-fensivo in relazione al torrente Parma e al Palaz-zo della Pilotta, 1800 ca.: pianta
122 Palazzo della Pilotta: posizione del Teatro Farne-se: sezioni
123 Palazzo della Pilotta: posizione del Teatro Farne-se: pianta
124 Palazzo della Pilotta: posizione del Teatro Farne-se: sezioni
125 Palazzo della Pilotta: posizione del Teatro Farne-se: pianta
126 Palazzo della Pilotta: studio delle volte: sezioni127 Palazzo della Pilotta: studio delle volte: pianta128 Palazzo della Pilotta: studio delle volte: sezioni129 Palazzo della Pilotta: studio delle volte: pianta130 Palazzo della Pilotta: studio delle volte: sezioni131 Palazzo della Pilotta: studio delle volte: pianta132 Palazzo della Pilotta: studio delle volte: sezioni133 Palazzo della Pilotta: studio delle volte: abaco134 Teatro Farnese: sezione longitudinale135 Battistero, estradosso della cupola a livello della
copertura: sezione136 Battistero, estradosso della cupola a livello della
copertura: pianta137 Battistero, estradosso della cupola a livello della
copertura: sezione138 Battistero, estradosso della cupola a livello della
copertura: pianta139 Battistero, livello dei portali d’ingresso: sezione140 Battistero, livello dei portali d’ingresso: pianta141 Battistero, livello dei portali d’ingresso: sezione142 Battistero, livello dei portali d’ingresso: pianta143 Battistero, livello del secondo ordine delle logge
interne: sezione144 Battistero, livello del secondo ordine delle logge
interne: pianta145 Battistero, livello del secondo ordine delle logge
interne: sezione146 Battistero, livello del secondo ordine delle logge
interne: pianta147 Battistero, livello dell’imposta della cupola: se-
zione148 Battistero, livello dell’imposta della cupola:
pianta149 Battistero, livello dell’imposta della cupola: se-
zione150 Battistero, livello dell’imposta della cupola:
pianta151 Battistero, intradosso della cupola a livello
dell’imposta: sezione152 Battistero, intradosso della cupola a livello
dell’imposta: pianta153 Battistero, intradosso della cupola a livello
dell’imposta: sezione154 Battistero, intradosso della cupola a livello
dell’imposta: pianta155 Battistero, sezione
156 Battistero, bassorilievo dello sviluppo interno157 Costellazione dei punti: inserimento del progetto
nella periferia158 Lo spazio del pudore: progetto A. Pianta, diame-
tro 93 m159 Lo spazio del pudore: progetto A. Sezione, dia-
metro 93 m160 Lo spazio del pudore: progetto A. Rampe, diame-
tro 93 m161 Lo spazio del pudore: progetto B. Pianta, diame-
tro 62 m162 Lo spazio del pudore: progetto B. Sezione, dia-
metro 62 m163 Lo spazio del pudore: progetto B. Rampe, diame-
tro 62 m164 Lo spazio del pudore: progetto C. Pianta, diame-
tro 41 m165 Lo spazio del pudore: progetto C. Sezione, dia-
metro 41 m166 Lo spazio del pudore: progetto C. Rampe, diame-
tro 41 m167 Lo spazio del pudore: progetto A. Disegno per le
matrici168 Lo spazio del pudore: progetto C. Disegno per le
matrici169 Lo spazio del pudore: abaco170 Lo spazio del pudore: abaco
1 Ambito geografico cm 104x104x5 | scala 1:100.000 | moduli 16
2 Struttura idrografica cm 104x104x5 | scala 1:50.000 | moduli 16
3 Configurazione attuale ambito storico cm 104x104x5 | scala 1:2.500 | moduli 16
4 Bassorilievo, Epoca romana cm 42x42x5 | scala 1:10.000 | moduli 2
5 Bassorilievo, Epoca longobarda cm 42x42x5 | scala 1:10.000 | moduli 2
6 Bassorilievo, Jacopo Lauro, 1630 ca. cm 42x42x5 | scala 1:10.000 | moduli 2
7 Bassorilievo, Cornelio Dankerts, 1680 ca. cm 42x42x5 | scala 1:10.000 | moduli 2
8 Bassorilievo, Matthaus Merian, 1640 cm 42x42x5 | scala 1:10.000 | moduli 2
9 Bassorilievo, Anonimo tedesco, 1720 ca. cm 42x42x5 | scala 1:10.000 | moduli 2
10 Bassorilievo, Anonimo, fine XVII sec. cm 42x42x5 | scala 1:10.000 | moduli 2
11 Bassorilievo, G. Pietro Draghi, XVIII sec. cm 42x168x5 | scala 1:10.000 | moduli 5
12 Bassorilievo, Anonimo, 1460 ca. cm 42x42x5 | scala 1:25.000 | moduli 2
13 Bassorilievo territoriale, via Emilia e torrente Parma cm 42x42x5 | scala 1:25.000 | moduli 2
14 Bassorilievo territoriale, la figura della tangenziale cm 42x42x5 | scala 1:25.000 | moduli 2
Elenco dei modelli / List of models
359
15 Bassorilievo territorialela figura della città storica cm 42x42x5 | scala 1:25.000 | moduli 2
16 Bassorilievo territoriale, la centuriazione romana cm 42x42x5 | scala 1:25.000 | moduli 2
17 Bassorilievo territoriale, il tessuto agrario cm 42x42x5 | scala 1:25.000 | moduli 4
18 Battistero, sezione cm 42x63x21 | scala 1:100 | moduli 2
19 Bassorilievo del prospetto interno del Battistero, Giacomo Francini, XVIII secolo cm 42x42x5 | scala 1:200 | moduli 1
20 Interno Battistero, livello dei portali d’ingresso cm 42x42x21 | scala 1:100 | moduli 1
21 Interno Battistero, secondo ordine delle logge cm 42x42x21 | scala 1:100 | moduli 1
22 Interno Battistero, livello imposta della cupola cm 42x42x21 | scala 1:100 | moduli 1
23 Battistero, estradosso della cupola cm 42x42x21 | scala 1:100 | moduli 1
24 Battistero, intradosso della cupola cm 42x42x21 | scala 1:100 | moduli 1
25 Bassorilievo, genesi storica della Pilotta, 1500 ca. cm 42x42x5 | scala 1:2.500 | moduli 2
26 Bassorilievo, genesi storica della Pilotta, 1585 ca. cm 42x42x5 | scala 1:2.500 | moduli 2
27 Bassorilievo genesi storica della Pilotta, 1800 ca. cm 42x42x5 | scala 1:2.500 | moduli 2
28 La Pilotta, veduta delle volte cm 42x42x5 | scala 1:400 | moduli 1
29 La Pilotta, veduta delle volte cm 42x63x10 | scala 1:200 | moduli 1
30 Teatro Farnese cm 42x42x5 | scala 1:400 | moduli 1
31 Teatro Farnese, sezione cm 84x42x13 | scala 1:200 | moduli 2
32 La periferia cm 312x234x5 | scala 1:2.500 | moduli 108
33 Bassorilievo, costellazione dei punti, inserimento progetto cm 42x168x5 | scala 1:10.000 | moduli 5
34 Costellazioni cm 42x42x5 | scala 1:10.000 | moduli 1
35 Lo spazio del pudore, sezione territoriale, inserimento progetto cm 75x7,5x5 | scala 1:2.500 | moduli 3
36 Lo spazio del pudore, variazione percorsi cm 15x30x5 | scala 1:2.500 | moduli 1
37 Lo spazio del pudore, progetto A cm 42x42x14 | scala 1:250 | moduli 1
38 Lo spazio del pudore, progetto A – sezione cm 42x21x14 | scala 1:250 | moduli 1
39 Lo spazio del pudore, progetto A – rampe cm 42x42x14 | scala 1:250 | moduli 1
40 Lo spazio del pudore, progetto B cm 42x42x14 | scala 1:250 | moduli 1
41 Lo spazio del pudore, progetto B – sezione cm 42x21x14 | scala 1:250 | moduli 1
42 Lo spazio del pudore, progetto B– rampe cm 42x42x14 | scala 1:250 | moduli 1
43 Lo spazio del pudore, progetto C cm 42x42x14 | scala 1:250 | moduli 1
44 Lo spazio del pudore, progetto C – sezione cm 42x21x14 | scala 1:250 | moduli 1
45 Lo spazio del pudore, progetto C – rampe cm 42x42x14 | scala 1:250 | moduli 1
361
Cronoprogrammi / Time schedules
Tutti i materiali grafici preparatori sono stati elaborati dal gruppo degli assistenti, per esigenze didattiche e vincoli temporali. I modelli, invece, sono stati realizzati durante i corsi di Progettazione e di Teoria (II semestre, A.A. 2010-2011 e 2011-2012) a complemento delle lezioni teoriche. Per queste ragioni, e a causa del numero elevato degli studenti, si mostrano i cronoprogrammi dei seminari finali (A.A. 2011-2012) dai quali si può comprendere la complessità organizzativa e produttiva implicite nel metodo di lavoro.
Assistenti: Emiliano Forcelli, Susanna Pisciella, Andrea Rossetto, Denis Rovetti, Luca Sirdone, Lorenzo Sivieri, Ernst Struwig
A.A.2010-2011LaboratoriodiProgettazioneArchitettonicaI
Abitabile Domenico, Agostini Davide, Anzolin Alessandra, Balasso Tanja, Battistella Alberto, Bettin Riccardo, Bisetto Marco, Bonaldi Giovanni, Bosello Annalisa, Bressanello Sharon, Brufatto Andrea, Bruschetta Sofia, Caddeo Alberto, Campagnolo Simone, Campana Davy, Carletto Federica, Causi Gianmarco, Cedrin Roberta, Ceola Francesco, Chiefa Silvia, Chigliaro Elisa, Cicchelli Andrea, Cimegotto Simone, Costa Marco, Costantini Veronica, Da Rios Thomas, Damiani Riccardo, De Lorenzi Erika, Delpapa Simone, Fanin Mattia, Feiffer Piero, Fonderico Gianluca, Frigo Federico, Gallo Giorgio, Gambin Alessia, Ghezzo Niccolò, Ghinello Giacomo, Giovatti Sara, Girotto Ludovica, Gottardi Marco, Gozzi Francesca, Granziera Veronica, Jian Qinyang, Khamyak Yuliya, Lavarda Nicola, Lorenzetto Stefano, Lucchese Silvia, Martin Nicolo, Martini Marta, Menegon Veronica, Mezzocolli Michelangelo, Michielli Alessandro, Mion Letizia, Pasqua Andrea, Pasquali Andrea, Pasquato Riccardo, Quinzan Federico, Razza Silvia, Reggio Mattia, Relik Mirco, Rigon Francesco, Rigoni Lorenzo, Rossi Cristian, Scarabello Anna, Schiavon Alberto, Scroccaro Mario, Scudiero Michele, Sgarbi Fabio Elia, Song Jie, Sredanovic Ena, Stevanella Giovanni, Todeschini Giulia, Tonon Flavia, Trevisan Gloria, Vezzaro Sofia, Vicenzi Luca, Visentin Gianmarco, Zambon Alessandro, Zanetello Micol, Zanusso Veronica, Zin Filippo, Zoccarato Carlotta
A.A.2010-2011TeoriaeTecnicadellaProgettazioneArchitettonicaIn collaborazione con prof. Carlo Enzo
Sharon Angileri, Andrea Aragone, Sebastiano Barbieri, Anna Bazzo, Sebastiano Berlaffa, Irene Biasiolo, Sharon Bressanello, Llisa Brunello, Alessandro Cannavà, Matteo Carotta, Claudia Chimento, Marica Conte, Riccardo Crotti, Daniela Da Ronch, Emanuele D’antrassi, Alberto Degani, Michele Del Vesco, Jacopo Famularo, Andrea Fantin, Josè Maria Ferro Gabriel, Tania Filip, Nicola Fortunati, Matteo Girotto, Daniele Giurizzato, Elena Grinfan, Francesca Lain, Paola Libardoni, Marco Masini, Clara Mesaglio, Giulia Milani, Fabio Oselladore, Tarcisio Ostet, Anna Pagliaro, Luca Pisaroni, Benedetta Risi, Laura Rizzi, Ermanno Rizzo, Carlo Ronda, Giovanni Sarandrea, Alessandro Smaniotto, Cristina Tibaldi, Davide Tombolan, Giovanni Tomelleri, Debora Tonini, Giulia Torino, Alvise Trincanato, Luca Zanette
A.A.2011-2012LaboratoriodiProgettazioneArchitettonicaII
Adami Jennifer, Agostini Davide, Alfine Elena, Angileri Sharon, Ariazzi Marta, Astolfo Johnny, Baldina Marco, Barusco Lisa, Battistella Alberto, Bertollo Alberto, Bettella Tommaso, Bettin Riccardo, Bisetto Marco, Bissaro Carolina, Boccardo Alessandra, Bonato Laura, Bosello Annalisa, Bunea Alexandru Sebastian, Cagnin Sabrina, Carfagnini Teodorico, Carletto Federica, Catra Laura, Causi Gianmarco, Ceola Francesco, Chiefa Silvia, Chigliaro Elisa, Colleoni Alberto, Costa Marco, Cristofanon Serena, Da Rios Thomas, Damiani Riccardo, Delpapa Simone, Donati Alessandro, Du Chen, Endrizzi Anna, Enzo Andrea, Federici Martina, Feiffer Piero, Frigo Federico, Frison Clara, Frosi Maria Francesca, Gambaretto Vittoria, Ghezzo Niccolò, Giovatti Sara, Gottardi Marco, Gozzi Francesca, Jian Quinjang, Lavarda Nicola, Lila Riegels, Liredi Alice, Lovadina Davide, Lucchese Silvia, Marchesin Andrea, Maroso Silvia, Martin Nicolò, Martini Luca Sebastiano, Martini Marta, Masin Enrico, Mazza Isabella, Meneghetti Marta, Mezzocolli Michelangelo, Michielli Alessandro, Mion Letizia, Missiato Mirco, Monfrecola Federica, Moretti Davide, Mosetti Alessandro, Muvumbi Damaris, Nosarini Sara, Paiuscato Luca, Pasquali Andrea, Pezzini Ilaria, Pompanin Stefano, Portieri Camilla, Putti Giovanna, Qiu Shi, Rampazzo Chiara, Rampazzo Ilaria, Rampin Elena, Razza Silvia, Reggio Mattia, Rigon Francesco, Rostin Lisa, Santoro Nicolò, Scanagatta Chiara, Scarabello Anna, Schiavo Marilisa, Schiavon Alberto, Scroccaro Mario, Settimo Nicola, Sgarbi Fabio Elia, Sredanovic Ena, Stecca Marco, Todeschini Giulia, Trevisan Giacomo, Trevisan Gloria, Valentini Simone, Vanin Costanza, Vendramin Ludovica, Vezzaro Sofia, Visentin Gianmarco, Vittadini Carlo, Zancaner Eva, Zanetello Micol, Zin Filippo, Zoccarato Carlotta
A.A.2011-2012TeoriaeTecnicadellaProgettazioneArchitettonicaIn collaborazione con prof. Carlo Enzo
Barbato Marco, Baretta Francesca, Bernardi Giacomo, Bortolato Sara, Carletti Gregorio, Corazza Matteo, Corradi Nicola, Covallero Davide, Degl’Innocenti Francesco, Giordani Alessandro, Hibraj Dliar, Lucietti Stefano, Marcellini Lorenzo, Merchan Pablo, Munaretto Federico, Nardi Massimiliano, Pagan Andrea, Richelli Paolo, Scabbio Giacomo, Soligo Simone, Soligon Chiara, Vedù Viola, Vincenzi Luca, Visentini Silvia, Zambon Alessandro, Zambon Samuele, Zanatta Nicolò, Zanovello Stefano, Zilli Lucrezia