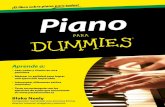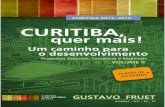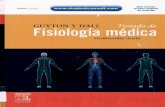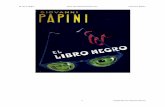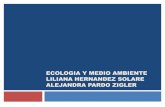Tertullianus redivivus. Il primo libro dell'Adversus Marcionem secondo Beatus Rhenanus
-
Upload
wwwuniroma1 -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Tertullianus redivivus. Il primo libro dell'Adversus Marcionem secondo Beatus Rhenanus
3
Indice
Introduzione ...................................................................................................... 4
La tradizione manoscritta di Tertulliano ......................................................... 7
1.1 Le collezioni della tradizione .................................................................... 7
1.2 Il corpus Cluniacense: manoscritti ed edizioni .........................................11
L’editio princeps ed il rapporto con il perduto Hirsaugiensis .........................18
2.1 L’acquisizione dei manoscritti e la struttura dell’edizione .........................18
2.2 Il rapporto tra l’editio princeps e l’Hirsaugiensis deperditus ...................24
La seconda edizione e l’emendatio ope ingenii .................................................43
3.1 L’edizione del 1528: alcune informazioni preliminari ...............................43
3.2 Le innovazioni apportate al primo libro dell’Adversus Marcionem ...........48
La terza edizione di Tertulliano: un nuovo testimone ....................................63
4.1 La collatio Gorziensis: la base per una nuova pubblicazione ....................63
4.2 La fine di un lavoro ventennale: le ultime modifiche al primo libro
dell’Adversus Marcionem ...............................................................................66
Conclusioni .......................................................................................................79
Bibliografia citata .............................................................................................81
4
Introduzione
Tra le numerose opere di Tertulliano, l’Adversus Marcionem è sicuramente una
delle più importanti e conosciute: per la sua estensione e per la molteplicità dei
temi che vi sono affrontati, è considerata la più rappresentativa della produzione
dogmatica del nostro autore.
Nel secolo appena trascorso, dopo che il Kroymann realizzò un’edizione
fondata per la prima volta su basi realmente scientifiche (1906), furono numerosi
gli studiosi che si rivolsero al Cartaginese e a questa sua opera: fra i tanti lavori
critici, non possiamo non citare l’edizione del Moreschini (1971), quella
dell’Evans (1972) e poi quella più recente, curata ancora dal Moreschini in
collaborazione con il Braun (1990-2004)1. Grazie a questi e a molti altri lavori che
si sono succeduti nel tempo, lo studio della tradizione manoscritta dell’Adversus
Marcionem è stato continuamente aggiornato e migliorato, ma ci sono ancora
molti aspetti che meritano di essere approfonditi.
In un articolo del 19662, il Moreschini avvertiva che alcuni risultati positivi si
sarebbero potuti ottenere da un’analisi dettagliata dell’editio princeps, ovvero di
quel testimone che coincide con la prima edizione a stampa delle opere di
Tertulliano, edita nel 1521 ad opera del filologo umanista Beatus Rhenanus
(1485-1547). L’anno successivo, in un altro breve articolo3
, il Moreschini
allargava i suoi obbiettivi: venivano infatti genericamente analizzati anche gli altri
due lavori critici curati dallo stesso editore (1528-1539).
Per quanto assennate ed autorevoli, le pagine del Moreschini rischiano di
essere troppo poche per un argomento così vasto: per scongiurare questo pericolo,
abbiamo deciso di approfondire ulteriormente la questione, limitandoci
1 In realtà si tratta di cinque diverse edizioni, una per ogni libro: le prime tre (1990-1991-1994)
sono state realizzate esclusivamente dal Braun; soltanto le altre due sono state pubblicate insieme
al Moreschini (2001-2004). 2 Cfr. C. Moreschini, Prolegomena ad una futura edizione dell’Adversus Marcionem di
Tertulliano, ASNP II, vol. 35 (1966), pp. 293-308, p. 307. 3 Cfr. C. Moreschini, Prolegomena ad una futura edizione dell’Adversus Marcionem di
Tertulliano, ASNP II, vol. 36 (1967), pp. 93-102, 236-244.
5
esclusivamente al primo libro dell’Adversus Marcionem. Proprio in questo
consiste il nostro merito ed il nostro limite: una simile scelta, se da un lato
consentirà la realizzazione di un’analisi maggiormente dettagliata, dall’altro non
ci permetterà di raggiungere considerazioni sicuramente generali.
In ogni caso, la realizzazione del presente lavoro è giustificata, a nostro avviso,
dall’innegabile importanza delle tre edizioni del Rhenanus: oltre ad aver strappato
dall’oblio i trattati del Cartaginese, queste pubblicazioni, che già ci hanno
permesso di ricostruire alcuni importanti manoscritti perduti, potrebbero fornire
ulteriori informazioni ai fini della constitutio textus. Anche nel caso in cui questa
ipotesi non si dovesse concretizzare, il nostro lavoro non perderebbe certo il suo
valore di analisi storica e metodologica di uno dei più grandi filologi ed editori del
XVI secolo. Con l’intenzione di raggiungere questi obbiettivi, abbiamo diviso il
nostro studio in quattro parti.
Nel primo capitolo presenteremo brevemente le diverse collezioni che formano
la tradizione manoscritta delle opere di Tertulliano, soffermandoci principalmente
sulla famiglia Cluniacense, l’unica ad aver tramandato l’Adversus Marcionem.
Il secondo capitolo sarà invece dedicato all’editio princeps: nella prima parte
verranno fornite alcune informazioni generali relative alla sua pubblicazione;
nell’altra si entrerà nello specifico con l’analisi del testo del primo libro
dell’Adversus Marcionem. Nel fare questo, cercheremo di selezionare quelle
lezioni che meglio permettono di cogliere il legame con il perduto codex
Hirsaugiensis, unico testimone (almeno per questo trattato) consultato dal
Rhenanus, nonché capostipite del ramo β della famiglia di Cluny.
Nel terzo capitolo si passa alla trattazione dell’edizione del 1528. Anche in
questo caso alla sezione più generale, seguirà una parte in cui l’analisi si farà più
dettagliata: si avrà così modo di conoscere le varie emendationes ope ingenii
apportate dal Rhenanus sul testo del primo libro dell’Adversus Marcionem.
Nell’ultimo capitolo, prima di concludere, tratteremo dell’edizione del 1539,
l’ultima realizzata dal filologo di Sélestat. La necessità di un ulteriore intervento
derivava dalla consultazione di un nuovo testimone: analizzando il primo libro
6
dell’Adversus Marcionem, potremo cogliere alcune delle numerose modifiche
inserite a causa di questa importante acquisizione.
7
Capitolo primo
La tradizione manoscritta di Tertulliano
In questo capitolo introduttivo si vuole offrire al lettore una breve ma completa
panoramica sulla tradizione manoscritta di Tertulliano. Tenendo a mente lo scopo
del presente studio, dopo una rapida descrizione delle diverse collezioni, seguirà
un’analisi più approfondita del Corpus Cluniacense, unica famiglia ad aver
trasmesso l’Adversus Marcionem, e dei suoi punti di maggior contatto con le
edizioni critiche realizzate dal Rhenanus nel 1521, nel 1528 e nel 1539. Se si
riuscirà anche nell’intento di illustrare quali siano i più recenti risultati ottenuti nel
campo della recensio, questo lavoro introduttivo non risulterà certo privo di una
sua utilità. Per facilitare la comprensione, viene presentato, in fondo al capitolo,
lo stemma codicum già elaborato dal Moreschini.1
1.1 Le collezioni della tradizione
Come sempre accade per i testi antichi, anche le opere di Tertulliano hanno
dovuto superare numerosi ostacoli per giungere fino a noi. Oltre al lunghissimo
tempo che separa la nostra epoca da quella del Cartaginese (fattore, questo,
certamente costante ed inevitabile), si possono trovare anche delle cause più
specifiche per spiegare il motivo per cui la tradizione manoscritta di Tertulliano
non è certo oggi rappresentata da un numero elevato di testimoni, specialmente se
escludiamo tutti quei manoscritti risalenti all’epoca umanistico-rinascimentale. In
questo periodo vi fu infatti una così intensa attività di copiatura, specie in Italia e a
Firenze, tanto che alcuni studiosi hanno parlato di una vera “riscoperta” di
Tertulliano.2 Come suggerisce il Moreschini3, almeno due fattori hanno giocato un
1 Cfr. R. Braun, , Contre Marcion: Tome I (Livre I), SChr 365, Paris 1990, p. 30. La sezione
introduttiva Manuscrits et éditions è stata curata dallo studioso di Pisa. 2 ivi, p. 20. 3 ibid.
8
peso notevole nella storia della tradizione dei testi del nostro autore: da una parte
un motivo stilistico e contenutistico, l’estrema difficoltà di lettura dei suoi testi;
dall’altra un evento storico, ovvero la condanna inflitta col Decretum Gelasianum,
tradizionalmente attribuito a papa Gelasio I e risalente con buona probabilità al
496; un documento nel quale, oltre ad una lista di opere religiose da considerare
canoniche, è presente anche un elenco di testi da rigettare: fra questi vengono
citati per l’appunto gli opuscula Tertulliani.4
Fatta questa premessa, per entrare ora nel vivo della questione, è necessario
offrire uno sguardo d’insieme ai manoscritti più significativi contenenti le opere
del Cartaginese. Con l’eccezione dell’Apologeticum, che ha attraversato i secoli in
modo indipendente dagli altri trattati (sebbene in alcuni testimoni più tardi sia
stato poi affiancato ad essi), tutte le altre opere del nostro autore sono contenute in
una serie di manoscritti, i cui esemplari più antichi, poco numerosi, non sono in
nessun caso anteriori al tardo VIII secolo. Come prima accennato, sono invece
molte le copie di epoca rinascimentale. Presi singolarmente, questi manoscritti
contengono soltanto alcune delle opere di Tertulliano: si tratta dunque sempre di
una selezione dei suoi trattati e non esiste alcun testimone che li riunisca tutti
insieme. Attraverso lo studio ed il loro confronto, è stato possibile individuare
alcuni rapporti di parentela e, ad oggi, sembra corretta la distinzione in cinque
diverse collezioni o famiglie.
Il gruppo principale, quello che conta il più alto numero di manoscritti, è noto
come corpus Cluniacense. Un antico catalogo, risalente all’XI secolo, ci informa
della presenza, nell’abbazia di Cluny, di un manoscritto costituito da due volumi e
contenente alcune opere di Tertulliano. Si tratta, in ogni caso, dei testimoni più
antichi di cui abbiamo notizia, e, seppur siano poi andati perduti, si è oggi
propensi nell’identificarli come diretti antenati della collezione successiva, della
quale possediamo alcuni esemplari. Sempre secondo la communis opinio, questo
corpus avrebbe avuto origine addirittura nel VII secolo, forse in Spagna e in un
4 < http://www.thelatinlibrary.com/decretum.html > [ultima consultazione 21- 10-2013].
9
ambiente molto vicino a quello di Isidoro di Siviglia, la cui conoscenza di
Tertulliano è infatti ormai sufficientemente documentata.5
I numerosi studi filologici condotti a riguardo hanno dimostrato che la
trasmissione di questa collezione si è separata in due rami distinti in un punto
indeterminato, ma comunque precedente ai testimoni più antichi in nostro
possesso. Tradizionalmente si parla di un “ramo α” o “Montpellier” e di un “ramo
β” o “Hirsau”: proprio in queste due città, infatti, erano conservati anticamente i
due manoscritti da cui sarebbero poi derivati tutti gli altri rappresentanti della
collezione. I manoscritti in nostro possesso appartenenti al ramo α contengono,
solitamente, ventotto trattati, uno in più rispetto a quelli del secondo ramo, nei
quali infatti non compare mai l’Apologeticum. Nel corso del tempo ed in
particolar modo durante il secolo passato, molti studiosi hanno analizzato questi
manoscritti, cercando di illustrare i rapporti e le loro reciproche relazioni: se un
enorme contributo venne offerto dal Kroymann 6 nella prima metà del secolo,
ottimi risultati si sono raggiunti nella seconda metà grazie alle opere di altri
studiosi7, tra cui fondamentale è stato l’apporto del Moreschini8.
Del corpus Corbeiense, di cui dovevano esistere sicuramente esemplari a
Corbie, Cologne e Malmesbury, non possediamo attualmente nessun manoscritto.
Fortunatamente i testi appartenenti a questo gruppo ci sono noti grazie alle
edizioni a stampa realizzate prima della scomparsa di tutti i testimoni,
inizialmente per opera del Mesnart (1545), poi del Gelenius (1550) ed infine del
Pamelius (1579). Si tratta dell’unica collezione che ha trasmesso le opere
“eretiche” del Cartaginese; questa la lista completa dei trattati presenti nel gruppo:
5 Cfr. M. Klussmann, Excerpta Tertullianea in Isidori Hispalensis Etymologiis, Hamburg 1892; A.
C. Lawson, The sources of the De ecclesiasticis officiis of S. Isidore of Seville, RBen L (1938), pp.
26-36. 6 Cfr. Q. S. F. Tertulliani, Opera, ex recensione Ae. Kroymann, CCSL I (1954), pp. 437-730. 7 Cfr. J. Ph. W. Borleffs, Zur Luxemburger Tertullianhandschrift, Mn III, 2 (1935), pp 299-308;
Tertulliani, De patientia De baptismo De paenitentia, ed. J. Ph. W. Borleffs, Hagie Comitis 1948;
Q. S. F. Tertulliani, Adversus Iudaeos, Mit Einleitung und kritischem Kommentar hereausgegeben
von H. Tränkle, Wiesbaden 1964; Q. S. F. Tertulliani, Adversus Hermogenem liber, ed. J. H.
Waszink, Ultraiecti/Antverpiae 1956. 8 Cfr. C. Moreschini, Prolegomena ad una futura edizione dell’Adversus Marcionem di
Tertulliano, ASNP II, vol. 35 (1966), pp. 293-308; vol. 36 (1967), pp.93-102, 236-244.
10
De carnis resurrectione, De Trinitate, De spectaculis, De praescriptione
haereticorum, De ieiunio adversos Psychicos, De monogamia, De pudicitia.
Del corpus Trecense abbiamo invece oggi un unico rappresentante: si tratta per
l’appunto del Codex Trecensis, scoperto a Troyes dal Wilmart nel 1916 e scritto a
Chiaravalle nel corso del XII secolo. L’edizione a stampa del Mesnart (1545) reca
nei margini alcune lezioni desunte, probabilmente, da un testo ricollegabile a
questa famiglia. Il gruppo ha trasmesso soltanto un limitato numero di opere di
Tertulliano (Adversos Iuadaeos, De Carne Christi, De resurrectione mortuorum,
De baptismo, De paenitentia).
Il corpus Agobardinus, realizzato probabilmente nel V secolo, doveva
contenere ventuno dei trattati scritti dal Cartaginese. Sfortunatamente, il nostro
rappresentante principale, il Codex Agobardinus, un codice manoscritto del IX
secolo, è giunto incompleto: privo della parte finale, contiene soltanto tredici
opere.
Per completare la panoramica sulla tradizione manoscritta di Tertulliano,
bisogna ricordare che nel corso degli anni Cinquanta del Novecento venne
scoperto un codice del XIV secolo: il Codex Ottobonianus, il quale contiene
lunghi estratti di alcune delle opere del nostro autore (De pudicitia, De
paenitentia, De patientia, De spectaculis). Un’analisi di questo manoscritto ha
fatto pensare che esso rientrerebbe in una collezione diversa da quelle che già
conoscevamo: per questo si parla oggi anche del corpus Ottobonianus.
Cluniacense, Corbeiense, Trecense, Agobardinus, Ottobonianus: queste sono
dunque le cinque famiglie che formano la tradizione manoscritta di Tertulliano,
entro le quali si possono ricondurre tutti i manoscritti in nostro possesso. Tuttavia,
concentrandosi il nostro studio sul lavoro filologico compiuto dal Rhenanus nelle
sue tre edizioni critiche alle opere del Cartaginese e prendendo in considerazione
soltanto il primo libro dell’Adversus Marcionem, sarà fondamentale, ai fini della
nostra ricerca, focalizzarsi esclusivamente su quella parte della tradizione che ha
trasmesso questo particolare trattato. Delle cinque collezioni appena presentate,
soltanto il Corpus Cluniacense lo contiene nella maggior parte dei suoi
11
rappresentanti. Sembra dunque necessaria una descrizione maggiormente
approfondita di questa famiglia.
1.2 Il corpus Cluniacense: manoscritti ed edizioni
Come già accennato, il Corpus Cluniacense rappresenta senza dubbio la
collezione principale, quella che sicuramente contiene ed ha trasmesso il maggior
numero di opere del Cartaginese. Sembra ormai certa la sua divisione in due
distinti rami, solitamente denominati e β, o anche, rispettivamente, Montpellier
ed Hirsau dal nome della località in cui sono stati ritrovati, o dovevano trovarsi, i
testimoni più antichi, dai quali si è originata questa diramazione.
Nel corso del tempo molti studiosi9 hanno cercato di definire con certezza i vari
rapporti che intercorrono tra i manoscritti e di collocare correttamente quest’ultimi
all’interno delle due diramazioni; la nostra analisi si baserà principalmente sulle
acquisizione raggiunte nella seconda metà del Novecento dal Moreschini 10 , il
quale, a nostro avviso, ha in molti punti migliorato il pur ottimo lavoro realizzato,
ormai più di mezzo secolo fa, dal Kroymann11.
L’unico testimone indipendente a noi pervenuto del Corpus Cluniacense è
conservato oggi nella Biblioteca di Medicina dell’Università di Montpellier: per
questo motivo viene chiamato Montepessulanus ed è tradizionalmente siglato M
dagli editori. Questo manoscritto, dall’aspetto elegante e raffinato, contiene
soltanto sette trattati del nostro autore (De patientia, de carne Christi, De
resurrectione mortuorum, Adversus Praxean, Adversus Valentinianos, Adversus
Marcionem, Apologeticum), ma, come suggerito dal Kroymann 12 , potrebbe
trattarsi soltanto della prima parte di una raccolta originariamente composta da
due volumi. Quei trattati che non sono contenuti nel Montepessulanus sono
tuttavia conservati nei suoi apografi e discendenti e più precisamente: nel
9 Cfr. supra, nota 6, 7, 8. 10 Cfr. supra, nota 8. 11 Cfr. Q. S. F. Tertulliani, Opera, ex recensione Ae. Kroymann, cit. 12
ibid.
12
Florentinus Magliabechianus I. VI. 9, del XV secolo, abitualmente indicato con la
lettera N; nel codex Divionensis (D), oggi perduto ma comunque ricostruibile in
buona parte grazie alle annotazioni di alcuni editori che in passato hanno potuto
leggerlo 13 ; infine nel Gorziensis (G), manoscritto anch’esso perduto e non
databile, ma considerato già dal Kroymann 14 copia di N o, più probabilmente,
dello stesso M. Rispetto agli altri apografi di M, quest’ultimo codice ha
sicuramente un’importanza maggiore, non tanto per la qualità delle sue lezioni,
quasi sempre inferiori rispetto a quelle del suo antigrafo, ma soprattutto per il
ruolo che ha avuto nella storia della tradizione dei testi di Tertulliano. Esso venne
infatti collazionato dal Rhenanus nella sua terza edizione alle opere del nostro
autore (1539): per la prima volta venivano così riuniti, e forse inconsapevolmente,
i due rami della tradizione del Corpus Cluniacense.15
Confrontato con i suoi apografi, M risulta essere un buon manoscritto, il
migliore per la qualità delle lezioni, ma per i trattati che non contiene deve
ovviamente essere sostituito con le sue copie e con i suoi discendenti. Essendo
tuttavia l’Adversus Marcionem contenuto in M, non sarà necessario, nel nostro
caso, dilungarsi troppo nella descrizione dei suoi apografi: per questo trattato il
Montepessulanus è senza alcun dubbio il miglior testimone e non solo all’interno
del primo ramo della tradizione.
Passando al secondo ramo del Corpus Cluniacense, il più antico esemplare
sembra essere il cosiddetto Hirsaugiensis, della cui esistenza ci informa lo stesso
Rhenanus. Nella praefatio dell’editio princeps (1521), curata proprio
dall’umanista alsaziano, l’editore sostiene infatti di aver consultato due
manoscritti: il codex Paterniacensis (P) ed il codex Hirsaugiensis (H). Il
Paterniacensis è ancora oggi conservato nella Bibliotèque Humaniste di Sélestat,
ma il suo valore è per la nostra indagine molto basso in quanto non contiene
13 Theodore De Beze ne trascrisse alcune varianti in una copia in suo possesso dell’edizione del
Mesnart e altrettanto fece P. Pithou su una copia dell’edizione del Gelenius; anche Rigaltius lo
deve aver consultato per il suo lavoro del 1634. Cfr. F. Chapot, Tertullien, Contre Hermogenem,
SChr 439, Paris 1999, p. 54-55 14 Cfr. Q. S. F. Tertulliani, Opera, ex recensione Ae. Kroymann, cit. 15 Più in seguito avremo certamente modo di approfondire la questione, cfr. cap. 4.
13
l’Adversus Marcionem; d’altra parte, invece, il codex Hirsaugiensis è andato
perduto, probabilmente in seguito alla distruzione dell’abbazia di Hirsau (dove era
conservato e da cui ne deriva il nome) avvenuta nel corso della Guerra dei
Trent’anni.
Questo codice è tradizionalmente considerato il capostipite del secondo ramo
della tradizione, da cui deriverebbero tutti gli altri manoscritti, tra cui i cosiddetti
Italici: enorme è dunque la sua importanza e fondamentale la sua ricostruzione.
Tendendo a questo fine, dal momento che ignoriamo quanto il Rhenanus sia
intervenuto sul testo originale, è chiaro come non ci si possa basare unicamente
sull’editio princeps (R): l’editore, seguendo le consuetudini del suo tempo, ha
emendato il testo senza specificare con precisione in quali punti e secondo quale
criterio ha apportato delle correzioni. Se R non lo riporta fedelmente, come è
possibile stabilire il testo originale di H? Per trovare una risposta è necessario
prendere in considerazione altri manoscritti, copie dirette o indirette di H, che
andranno poste a fianco di R e con esso confrontate: solo seguendo una simile
operazione sarà possibile ricostruire un testo che sia il più vicino possibile a
quello di H. È a questo punto che entrano in gioco il Florentinus Magliabechianus
I. VI. 10 e il Luxemburgensis 75.
Il Florentinus Magliabechianus I. VI. 10 (F per gli editori) è un codice
manoscritto realizzato a Pforzheim nel 1426 e scritto in lettera bastarda da due
mani, i monaci francescani Johann von Lautenbach e Thomas von Lyphain, che
distinguono due sezioni. Si trattava di un testo ricopiato per il Cardinale Giordano
Orsini e del quale entrò poi in possesso, nel 1431, l’umanista Niccolò Niccoli.
Ottenuto questo manoscritto, il Niccoli poté finalmente correggere la copia che
aveva precedentemente realizzato16
e che, dunque, egli non desunse direttamente
da F, ma da un altro esemplare, un apografo intermedio che potrebbe essere
16 Si tratta dell’attuale Florentinus Magliabechianus I. VI. 11, anche detto F1, da cui derivano tutti
i recentiores.
14
identificato con quello di cui sembra informarci il Traversari.17 Con la morte del
Niccoli le due copie (F e F1) passarono alla Biblioteca di San Marco, mentre oggi
sono entrambe conservate nella Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
A differenza del Florentinus Magliabechianus I.VI.10 (F), la stima del valore
del Codex Luxemburgensis 75 (X) si è ampiamente modificata nel corso del
tempo, specialmente durante il secolo appena trascorso. In effetti, nella prima
metà del Novecento, i vari editori che si occuparono di Tertulliano diedero i pareri
più discordi nei riguardi di questo codice: se da una parte il Kroymann, allora
considerato il massimo esperto di Tertulliano, non ne tenne considerazione né per
la preparazione del volume XXXXVII del C.S.E.L. (1906)18, né per quella del
volume LXX del C.C.S.L. (1942)19; dall’altra parte il Borleffs, con un po’ di
presunzione, credette addirittura di poterlo ritenere copia diretta
dell’Hirsaugiensis deperditus (1935) 20 . Il primo utilizzò dunque, per le sue
edizioni, soltanto F e non sistematicamente, ma esclusivamente per controllare le
lezioni di R1 (vale a dire per distinguere le congetture del Rhenanus, dalle lezioni
dell’Hirsaugiensis perduto), metodo certamente valido, ma che avrebbe avuto
maggior valore se fosse stato ugualmente applicato ad X; il secondo invece,
ipotizzando una derivazione in linea diretta dall’Hirsaugiensis, sostenne la
superiorità di X su F e sugli altri testimoni del secondo ramo della tradizione. Gli
editori successivi, abbandonato il criterio del «tutto Tertulliano», ebbero tutti
considerazione di X, seppur in maniera completamente differente l’uno dall’altro
(si segnalano i lavori del Tränkle 21 e del Waszink 22 ). A far chiarezza sulla
17 A. Traversari, Epist. 8, 37. Per maggiori informazioni cfr.: L. Labardi, Niccolò Niccoli e la
tradizione manoscritta di Tertulliano, “Orpheus”, 2 (1981), pp. 380-396; P. Petitmengin,
Tertullien entre la fin du XIIe et le début du XVIe siècle, in M. Cortesi (ed.), Padri Greci e Latini a
confronto: Atti del Convegno di studi della Società Internazionale per lo Studio del Medioevo
Latino. Firenze (2004), pp. 63-88. 18 Cfr. Q. S. F. Tertulliani, Opera, ex recensione Ae. Kroymann, CSEL, vol. XXXXVII pars III
(1906). 19 Cfr. Q. S. F. Tertulliani, Opera, ex recensione Ae. Kroymann, CCSL, cit. 20 J. Ph. W. Borleffs, Zur Luxemburger Tertullianhandschrift, cit. 21 Cfr. Q. S. F. Tertulliani, Adversus Iudaeos, Mit Einleitung und kritischem Kommentar
hereausgegeben von H. Tränkle, cit. 22 Cfr. Q. S. F. Tertulliani, Adversus Hermogenem liber, ed. J. H. Waszink, cit.
15
questione fu il Moreschini, in una sua pubblicazione apparsa nel 1966 negli
Annali della Scuola Normale di Pisa 23 . A differenza di quanto sostenuto dal
Borleffs, lo studioso italiano ha dimostrato la derivazione indipendente di F e di X
da un testimone comune che doveva trovarsi a Pforzheim24
e che poi sarebbe
andato perduto. Questo codice, definito Pforzhinensis amissus, sarebbe dunque un
intermediario tra l’Hirsaugiensis e i suoi derivati F ed X, i quali devono pertanto
essere posti sullo stesso piano, senza alcuna gerarchia di valore. Secondo questa
ipotesi è possibile ricostruire il testo dell’Hirsaugiensis deperditus tramite la
collazione di F, X e R1.
Sempre il Moreschini, e negli stessi studi, ha dimostrato la derivazione
successiva di altri due testimoni a partire da F (o, più probabilmente, da un
intermediario di F): il Vindoboniensis 4194 (V), che a partire dal 1918 è situato
nella Biblioteca Nazionale di Napoli (= Neapolitanus 55), e il Leidensis latinus 2
(L). Si tratta di due manoscritti italiani del XV secolo che, secondo la recente
ricostruzione del Petitmengin 25 , sono in strettissimo contatto: la simultanea
mancanza, in ambedue i testimoni, degli ultimi cinque fogli dimostrerebbe la
diretta derivazione di L da V. Questo particolare, per lungo tempo sfuggito agli
altri studiosi, smentirebbe la più antica considerazione di L come testimone
indipendente. Questi sono, in generale, i manoscritti più importanti del Corpus
Cluniacense.
Per concludere, tenendo a mente il nostro scopo, riteniamo utile fornire un elenco
riassuntivo di tutti i documenti più importanti che contengono l’Adversus
Marcionem e, di seguito, lo stemma codicum elaborato secondo le teorie
precedentemente esposte del Moreschini.
● Montepessulanus (M)
● Florentinus Magliabechianus I.VI.9 (N)
23 Cfr. C. Moreschini, Prolegomena ad una futura edizione dell’Adversus Marcionem di
Tertulliano, cit. 24 La stessa località dove F venne copiato nel 1426. Cfr. pp. 7-8. 25 P. Petitmengin, op. cit, p. 79.
16
● Luxemburgensis 75 (X)
● Florentinus Magliabechianus I.VI.10 (F)
● L’editio princeps curata dal Rhenanus nel 1521 (R1), riveduta e corretta
nelle successive edizioni del 1528 (R2) e del 1539 (R3). La descrizione delle varie
edizioni realizzate dal Rhenanus costituirà l’argomento dei prossimi capitoli.
18
Capitolo secondo
L’editio princeps ed il rapporto con il perduto Hirsaugiensis
Il presente capitolo mira, nella sua prima parte, a fornire al lettore una conoscenza
preliminare e generale sulla struttura compositiva dell’editio princeps, edita dal
Rhenanus nell’anno 1521, e sulle vicende storiche che hanno portato alla sua
realizzazione. Successivamente si andranno ad analizzare, ed in maniera più
approfondita, i legami che intercorrono tra questa edizione ed il perduto codice
Hirsaugiensis, limitandosi specificamente all’analisi del primo libro dell’Adversus
Marcionem. Il nostro lavoro, mediante l’ausilio delle ricerche condotte
precedentemente da alcuni autorevoli studiosi, auspica di mettere in luce la
modalità con cui Beatus Rhenanus, in questa sua prima edizione, è intervenuto
nell’emendare il testo.
2.1 L’acquisizione dei manoscritti e la struttura dell’edizione
Nel giorno delle calende di luglio dell’anno 1521, dopo un intenso lavoro
protrattosi per più di un anno, Beathus Rhenanus di Sélestat riusciva finalmente a
pubblicare la prima edizione a stampa degli Opera Omnia di Tertulliano. Prima di
lui furono ben pochi gli studiosi umanisti che si interessarono dell’antico autore
Cartaginese e delle sue opere: rimangono tracce soltanto di alcuni vecchi
incunaboli e ristampe di essi, nelle quali il solo Apologeticum veniva sempre
posto in appendice alle opere di Lattanzio. L’ultimo lavoro impostato in una
simile maniera era piuttosto recente: si trattava del primo libro stampato dalla
famosa tipografia veneziana, dopo la morte del suo fondatore Aldus Manutius
(1515).
Estremamente diversa dunque l’intenzione e la visione di fondo del Rhenanus:
la scelta di trattare l’intero corpus di Tertulliano non era soltanto originale, ma
anche piuttosto ambiziosa e introduceva lo stesso editore in un terreno irto di
19
ostacoli. Oltre alla mancanza di una documentazione piuttosto recente sulla quale
basarsi, non considerati gli anni di lungo oblio nei quale erano caduti gli scritti del
Cartaginese, determinanti, nel rendere ancor più difficile il lavoro del Rhenanus,
furono la durevolezza dello stile di Tertulliano e la presenza, nelle pagine dei
testimoni manoscritti, di numerosissime mende che andavano corrette. Tutti
fattori dei quali, come avremo modo di vedere in seguito, si lamenterà lo stesso
Rhenanus.
Egli mostra dunque di avere una duplice consapevolezza: da una parte la
coscienza di un lavoro immane, dall’altra la certezza del ruolo di salvatore. Al di
là delle refutazioni di maniera, il Rhenanus non nasconderà certo il vanto, seppur
garbato ed ampiamente meritato, di aver sottratto dall’oblio e dal dimenticatoio i
testi residui del primo scrittore cristiano di lingua latina. “Opera Q. Septimii
Florentis Tertulliani [...] per Beatum Rhenanum Seletstadiensem e tenebris eruta
atque a situ pro virili vindicata”: questa la frase fatta apporre dall’editore sul
frontespizio dell’editio princeps e poi ripetuta anche in quello delle due edizioni
successive (1528-1539). Un giudizio, questo, che il filologo umanista aveva già in
precedenza espresso, e quasi con le stesse parole, nella lettera prefatoria alla sua
edizione di Velleio Patercolo, datata 15 novembre 1520: ut nunc non solum
Velleium aediderim semilacerum, sed etiam Tertulliani libros, vetustissimi inter
chriastianos scriptoris, mendosi tamen, mea cura e tenebris erutos.1
Si tratta effettivamente di una pubblicazione di grande pregio e notevole
valore, non solo dal punto di vista filologico e contenutistico, ma anche per la
qualità della forma e dell’aspetto esteriore. Di questo, certo, va attribuito grande
merito alla tipografia di Basilea e al suo celebre proprietario, Johann Froben
(latinizzato Frobenius), collaboratore di lunga data nonché intimo amico del
Rhenanus e dello stesso Erasmo. Durante la prima metà del XVI secolo, i torchi di
Froben erano fra i più apprezzati di tutta Europa ed il loro lavoro era impreziosito
dalla collaborazione con impeccabili e rinomati artisti e artigiani, quali Jacob
1 A. Horawitz, K. Hartfelder, Briefwechsel des Beatus Rhenanus, Reihneim, 1966 [1886], p. 254.
20
Faber, noto incisore e xilografo, e i due fratelli Ambroise e Hans Holbein (il
Giovane), ambedue abilissimi pittori. L’eleganza e la raffinatezza che
caratterizzano l’editio princeps, in assoluto la più suntuosa tra le edizioni
cinquecentesche di Tertulliano, ben testimoniano l’altissima fattura del loro
lavoro. Gli ampi margini, la chiara impostazione della pagina, la forma grafica
delle lettere e i raffinati disegni costituiscono un chiaro esempio.
L’editio princeps, notevole già per la sua grandezza, si apre con un frontespizio
piuttosto raffinato: le poche righe che ci informano sul contenuto del volume,
sull’antico autore e sulle difficoltà incontrate dall’editore nel corso del suo lavoro
appaiono come incastonate fra i quadretti laterali; si tratta di incisioni che
raffigurano alcune scenette di vita aulica, nei termini in cui erano state descritte ed
immaginate all’interno dell’opera De mercede conductis dell’antico autore greco
Luciano.
Nella pagina immediatamente successiva trova spazio il Catalogus operum Q.
Septimii Florentis Tertulliani, quae in hoc volumine continentur: racchiusi entro
la rappresentazione di tre colonne, sono qui inseriti i titoli dei testi presenti
nell’edizione. L’ordine con cui questi testi sono disposti sembra essere stato scelto
direttamente dal Rhenanus, in quanto non sarebbe desunto dai due manoscritti
consultati dall’editore. Il testo dell’Apologeticum, posizionato alla fine del
volume, venne integralmente copiato dall’edizione aldina sopra citata.
In seguito, nella terza facciata, ha invece inizio una lunga lettera dedicata dal
Rhenanus a Stanislaus Turzus2, vescovo di Olmutz, città della Moravia orientale,
suffraganeo dell’arcivescovo di Brno. Al di là delle eleganti incisioni, che
decorano i margini della sua prima pagina con i disegni della storia leggendaria di
Tantalo, la lettera al vescovo Stanislao ha tutti i caratteri di un testo prefatorio: il
Rhenanus, dopo i saluti di circostanza, fornisce al lettore numerose ed utili
informazioni circa le modalità di reperimento dei testimoni, lo sforzo e i problemi
incontrati durante l’emendazione, i temi e le questioni affrontate dallo scrittore
2 ivi, p. 282.
21
antico nei diversi trattati ed il loro peso nel tempo, senza dimenticare di esprimere
la speranza di poter curare in futuro nuove edizioni.
Per completare il quadro sulla struttura compositiva dell’editio princeps,
bisognerà poi parlare della presenza di una breve descrizione della vita di
Tertulliano, di un successivo e più lungo avvertimento al lettore su alcuni dei
dogmi dello scrittore Cartaginese, per poi giungere finalmente agli stessi trattati, i
cui testi vengono presentati suddivisi in libri, ciascuno anticipato da un veloce
Argomentum (una sorta di breve riassunto). L’Adversus Marcionem, diviso in
cinque libri, inizia a pagina 142.
Ai fini della nostra ricerca, sarà tuttavia necessario fare un piccolo passo
indietro e ritornare alla lettera prefatoria: una sua attenta lettura potrà infatti
fornire utili notizie a colui che voglia indagare l’attività emendatrice del primo
editore di Tertulliano. Due i punti di maggiore interesse: alcune righe
immediatamente successive ai saluti di circostanza, nelle quali il Rhenanus espone
la storia di come sia riuscito a venire in possesso dei due testimoni, e la maggior
parte della pagina finale, dove, prima di dare commiato, illustra le difficoltà
incontrate nel percorso, spiega le cause della corruzione dei testi di Tertulliano,
espone infine le sue speranze per il futuro.
Nel primo estratto, il Rhenanus racconta al vescovo Stanislao le vicende che lo
portarono a consultare il codex Paterniacensis e l’antichissimo codex
Hirsaugiensis: i due unici testimoni sulla base dei quali fondò la sua editio
princeps.
Del primo, a giudicare dal suo racconto, egli vi entrò in possesso in una
maniera piuttosto fortuita: essendosi trovato nel corso del 1520 a Colmaria
(l’odierna cittadina francese di Colmar) in compagnia del suo amico Udalricus
Zasius, umanista tedesco ed insigne giurista, decise insieme a questi di far visita al
decano locale, tale Iacobus Zimmermanus, bonorum studiorum fautorem. Fu
consultando la sua fornitissima biblioteca che il Rhenanus si imbatté casualmente
in un codice contenente alcuni opuscula Tertulliani e proveniente dal monastero
di Paterniacum (l’attuale cittadina svizzera di Payerne). Vedendolo bramoso di
22
poter leggere quel libro, Zimmerman accettò ben volentieri di donarlo al noto
umanista. Nel giro di breve tempo il Rhenanus riuscì a mettere mano anche al
manoscritto che sapeva essere conservato nel monastero benedettino di Hirsau:
per realizzare quest’operazione si servì dell’aiuto e dell’intermediazione del suo
caro amico Thomas Rappius, vir bonus et literatus. Questo, ancor prima di
giungere ad Hirsau, riuscì fortunatamente ad incontrare l’abate di quel monastero
e lo convinse, senza troppe difficoltà, a prestargli il codice in questione affinché
l’amico Rhenanus lo emendasse. Dalla lettera del 22 settembre 1520, indirizzata
dal Rappius allo stesso Rhenanus3, apprendiamo i termini del prestito: il codice
doveva essere riconsegnato nel giro di mezzo anno o poco più, senza macchie,
danni o alcun tipo di deperimento. A sugellare il patto veniva scritta una sorta di
garanzia.
Il Rhenanus poteva così finalmente dare inizio alla sua attività emendatrice,
basandosi sulla collazione di due manoscritti antichi: da una parte il
Paterniacensis, dall’altra l’Hirsaugiensis. Il grande entusiasmo e le speranze
iniziali vennero tuttavia presto disilluse: ciascuno dei due codici conteneva un
così alto numero di mende che persino il loro confronto avrebbe condotto ad un
esito incerto. Il Rhenanus, che sperava di potersi affidare al Paterniacensis,
almeno per i trattati che contiene, fu costretto a ricredersi: tam erat utrobique
corrupta scriptura, ut alter ab altero videretur descriptus. In ogni caso, seppur il
lavoro si presentasse assai arduo, egli sapeva di non poter perdere l’occasione di
consegnare l’edizione alle stampe: il tempo di cui disponeva era limitato dalle
condizioni del prestito dei manoscritti; mentre le presse di Froben, in quel
periodo, erano per giunta prive di lavoro. A meno di un anno di distanza
dall’ottenimento del codex Hirsaugiensis, venivano dunque stampati per la prima
volta gli Opera Omnia Tertulliani, ma i risultati ottenuti dall’edizione, per stessa
ammissione di chi li aveva conseguiti, non dovevano certo essere considerati
quelli definitivi.
3 ivi., p. 248.
23
Ma quale fu dunque il metodo seguito dall’editore nell’atto di emendare i testi?
E quale l’origine dei numerosi errori presenti in ambedue i testimoni? Con un
grado di attendibilità tutto da verificare4, è lo stesso Rhenanus a darci una risposta
nell’ultimo foglio della lettera prefatoria.
L’alto numero di errori che caratterizza i due codici consultati lo costrinsero ad
intervenire numerose volte ope ingenii, ovvero mediante il ricorso a personali
congetture. Tuttavia queste congetture, a detta del Rhenanus, sono sempre state
riportate ai margini del testo proprio affinché questo, nel rispetto dei testimoni,
non venisse in alcun modo modificato: sciens religiose esse tractanda autorum
scripta non secus ac res sacras, nihil mutare volui (qui tamen multis mos est) sed
coniecturas, quae tunc mentem forte veniebant, in marginibus adieci. Il valore di
questi personali interventi, spiega poi il filologo umanista, non è sempre costante:
alcune congetture non convincono neppure il loro stesso autore, ma il suo
tentativo di fornire al lettore dubbioso una plausibile alternativa rimane pur
sempre apprezzabile.
Dopo l’invocazione e l’augurio di poter in futuro consultare altri manoscritti
(quelli conservati a Gorze, Fulda e Roma) per migliorare la correzione dei trattati,
il Rhenanus passa ad esaminare la natura degli errori riscontrati nei due testimoni,
elencandone le cause. A suo giudizio due sono le motivazioni principali: il lungo
periodo durante il quale le opere di Tertulliano non vennero più studiate (e quindi
neanche ricopiate) e lo stile arduo, affettato e veemente dello stesso autore. La
lettera prefatoria si conclude poi piuttosto velocemente con gli ultimi saluti al
vescovo di Olmutz.
Rientrando entro i margini della nostra indagine, forti di queste informazioni
preliminari e generali, possiamo ora approfondire il rapporto che lega l’editio
princeps del Rhenanus al perduto codex Hirsaugiensis, limitandoci all’analisi
testuale del solo primo libro dell’Adversus Marcionem.
4 Cfr. C. Moreschini, Prolegomena ad una futura edizione dell’Adversus Marcionem, ASNP II,
vol. 36 (1967), pp. 93-102.
24
2.2 Il rapporto tra l’editio princeps e l’Hirsaugiensis deperditus
Delle considerazioni appena esposte appartenenti al Rhenanus, riteniamo utile
approfondirne principalmente due: la denuncia dell’editore circa lo stato di grande
corruttela delle fonti ed il loro valore ai fini della constitutio textus, per come
questa appare nell’editio princeps.
Riguardo al primo aspetto, che pure crediamo di aver sufficientemente
evidenziato, non sarà superfluo aggiungere qualche breve riflessione. Come
abbiamo avuto modo di osservare, il Rhenanus non nasconde mai la difficoltà
incontrata nella fase di revisione del testo e causata dalla natura fortemente
corrotta dei due testimoni. A questo proposito, risulta certamente illuminante il
post scriptum aggiunto alla lettera dell’11 marzo 1521, inviata dallo stesso
Rhenanus al suo amico Georg Spalatinus: Edo nunc Opera Tertulliani, immo
mendas potius. Nam quidam libri tam sunt insigniter depravati, ut vix una constet
sententia. Sed tamen pergendum est, quando cepimus. Nullam venor gloriam, nec
adsequar. Duntaxat cupio prodesse. 5
Pur trovandosi a pochi mesi di distanza
dalla pubblicazione, l’editore sente il bisogno di sottolineare fortemente l’estrema
depravazione dei codici manoscritti in suo possesso. L’insistenza sul tema (nostra
e dell’editore) non sia da sottovalutare: sarà proprio questa consapevolezza che
indurrà il Rhenanus a lavorare per una nuova edizione, il cui studio preparatorio
sarà questa seconda volta ben più ampio (l’edizione verrà pubblicata infatti solo
nel 1528).
L’altra questione merita invece una trattazione certamente più ampia ed
articolata. Il Rhenanus sostiene chiaramente di aver avuto accesso soltanto ai due
codici provenienti da Hirsau (H) e da Peterlingen (P): mentre il primo è andato
perduto, il secondo è ancor oggi conservato nella Bibliotèque humaniste di
Sélestat. Abbiamo tuttavia già constatato quanto sia superfluo, ai fini della nostra
ricerca, lo studio del codex Paterniacensis: in esso non vi è infatti traccia
5 A. Horawitz, K. Hartfelder, op. cit., p. 269.
25
dell’Adversus Marcionem. Pertanto sarà bene concentrarsi unicamente
sull’Hirsaugiensis perduto.
Il codex Hirsaugiensis, come già sappiamo, è tradizionalmente considerato il
capostipite del secondo ramo della collezione Cluniacense: da esso sarebbero
quindi derivati tutti i successivi manoscritti appartenenti a questa famiglia. Dalle
notizie in nostro possesso, abbiamo la certezza che il codice, redatto
probabilmente nel corso del XII secolo, si componeva di più volumi, quasi
certamente due6. Di questo codice si sono purtroppo perse le tracce nel corso del
tempo: sembra plausibile che sia scomparso in seguito alla distruzione del
monastero di Hirsau, avvenuta durante la Guerra dei Trent’Anni. Considerata la
sua importanza ai fini della constitutio textus, questa perdita ha certamente
complicato la questione.
Fortunatamente, nell’arco di tempo in cui è esistito, il testo dell’Hirsaugiensis
è stato consultato quasi certamente almeno in due occasioni: sicuramente dal
Rhenanus, come base di collazione ma anche come testimone unico nella sua
editio princeps; molto probabilmente da un ignoto copista, il quale ne deve aver
tratto una copia poi conservata nel monastero di Pforzheim. Seguendo l’ipotesi del
Moreschini, oggi ampiamente accettata, da questo Pforzhinensis amissus
dipenderebbero poi i due codici comunemente siglati F ed X.7
Questi due
manoscritti, copiati indipendentemente l’uno dall’altro, presentano, oltre ad errori
propri, anche numerose lezioni comuni evidentemente errate o comunque inferiori
rispetto a quelle di R1.8 In questa situazione, per la ricostruzione del testo di H,
dovremo tenere in considerazione non solo l’accordo di FX (= γ) con R1, ma
anche quello relativo soltanto ad F con X nei casi in cui R1 si rivela come una
evidente emendazione di quello di H. Le altre eventualità (i casi di accordo ora di
6 Prove evidenti del fatto sono: l’utilizzo, da parte del Rhenanus, dei termini volumina e libros
rispettivamente nella prima e nella seconda pagina della sua lettera prefatoria e specialmente la
lettera indirizzata dal Rappius proprio al Rhenanus6 in cui si parla innegabilmente di duo volumina
Hirsaugiensis. 7 Cfr. supra, cap , p. 8. 8 Secondo le tradizionali norme del metodo stemmatico questa situazione è sufficiente per
dimostrare l’esistenza di un antigrafo comune: in questo caso lo Pforzhinensis amissus.
26
F, ora di X con R1 , rispettivamente contro X ed F e i casi di totale discordanza fra
i tre codici) daranno ovviamente esito ad una soluzione pacifica: si
evidenzieranno in questo modo le lectiones singulares di X o di F, evidentemente
non contenute nel subarchetipo H.
Attraverso l’analisi del comportamento tenuto dal Rhenanus nell’editare il
primo libro dell’Adversus Marcionem, il presente capitolo si prefigge ora di
illustrare i rapporti che intercorrono tra R ed il perduto Hirsaugiensis: nel caso si
riuscisse anche a giovare alla ricostruzione del testo di H o ad aprire nuovi scenari
nel campo della recensio, si sarebbero allora superate le intenzioni iniziali.
Come già anticipato, i casi di accordo tra FXR (= β) permettono di risalire
senza alcun dubbio al testo del subarchetipo H. Un’analisi maggiormente
dettagliata potrebbe condurre a due diverse possibilità. La prima è quella che si
presenta laddove il Rhenanus accoglie, in tutte le sue edizioni, le stesse lezioni di
F e di X. In questo caso il testo di H è pienamente ricostruito e può essere subito
confrontato con quello di M per l’identificazione dell’archetipo: se c’è
concordanza, il passo in questione è pienamente restituito; se invece c’è
opposizione, si manifesta allora chiaramente la divisione del corpus in due
famiglie. Nel primo libro dell’Adversus Marcionem abbiamo contato almeno
cinquantanove casi di opposizione fra β ed M. Eccone alcuni esempi:
I, 2, 2 (lin. 11) obtusis M Kr. Mor. : obtunsis β Ev.; I, 2, 3 (lin. 30) ostendemus M
Kr. Mor. Ev. : -dimus β; I, 4, 1 (lin. 5) quot β : quod M; I, 11, 5 (lin. 23)
necessarium M Kr. Mor. : necessarium sit β; I, 13, 1 (lin. 3) praesignarit M Kr.
Mor. : praesignaverit β Ev.; I, 20, 2 (lin. 11) currisset M Kr. : cucurrisset β Ev..
Riteniamo superfluo ampliare ulteriormente l’elenco, in quanto la scelta dell’una
o dell’altra variante, laddove non si ritenga di dover intervenire diversamente,
deve essere valutata di volta in volta dall’editore moderno e certo non rientra tra
gli obbiettivi di questa nostra indagine.
27
L’altra possibilità è quella che si concretizza nei casi in cui le edizioni del
Rhenanus non sono tra loro concordi. Osservando e confrontando insieme le
diverse lezioni contenute in R1, R2 ed R3 la questione diventa assai più spinosa. Si
apre così un ampio scenario che lascia spazio a diverse possibilità: si avrà modo di
identificare i casi di intervento congetturale presenti in R2 e di stabilirne il valore;
si potrà valutare il numero di congetture formulate in R2 e poi confluite in R3; si
potranno infine osservare i punti, contenuti in R3, nei quali il Rhenanus è ricorso
alla consultazione del codex Gorziensis (appartenente all’altro ramo della
collezione Cluniacense). Tuttavia, essendo sempre almeno R1 in accordo con γ, la
ricostruzione di H è comunque garantita in ciascuna di queste circostanze. Tutte
le considerazioni riguardanti le edizioni del 1528 e del 1539 verranno esposte nei
capitoli successivi. Nel testo del primo libro dell’Adversus Marcionem abbiamo
contato trentaquattro casi di accordo di FX ed almeno R1 con M e soltanto sedici
di incongruenza. Forniamo di seguito alcuni esempi:
I, 1, 3 (lin. 13) qui igitur (qui intellige ut aliqui) Mγ R1 R2 Mor. : igitur qui R3 Kr.;
I, 5, 1 (lin. 5) Sigen, tum Lat. Kr. Mor. Ev. : Sigeneum Mγ R1 Sigen, cum R2R3; I,
5, 4 (lin. 22) qua M (dubie) R3 Kr. Mor. Ev. : quae γ R1 R2; I, 8, 1 (lin. 7) ipsa R3
Kr. Mor. Ev. : ipsum Mγ R1R2; I, 10, 2 (lin. 11) tantam Mγ R1 R2 Kr. Mor. Ev. :
tanta coni. R1 R2 (unde R3); I, 10, 3 (lin. 18-19) Iudaeorum - deum M G R3 Mor.
Ev. : om. γ R1 R2 Kr.; I, 19, 2 (lin. 12) aura R3 Kr. Mor. Ev. : aula Mγ R1 R2; I,
20, 1 (lin. 7) tibi scilicet M Kr. Mor. : tibi γ R1 R2 scilicet tibi G R3 Ev.; I, 25, 6
(lin. 41-42) indignatio bilis R3 Kr. Mor. Ev. : indignabilis Mγ R1 R2; I, 28, 3 (lin.
26) quam M R3 Kr. Mor. Ev. : ut γ R1 R2. Tra gli esempi selezionati, sono a nostro
giudizio significativi i casi di omissione che ricorrono in I, 10, 3 e in I, 20, 1: la
divisione del corpus in due famiglie si manifesta qui con netta evidenza.
Oltre ai casi di totale coincidenza fra le lezioni di F, X ed R1, è necessario
prendere in considerazione anche le situazioni in cui l’accordo di F con X si
oppone ad R1: in queste circostanze, per ricostruire il testo di H, bisognerà cercare
28
di stabilire la natura della lezione presente in R1. Infatti nel caso in cui R1 si
rivelasse come una congettura realizzata dal Rhenanus, allora il testo di H
coinciderebbe, con buona probabilità, con quello di FX; se invece la lezione di R1
non sembra avere le caratteristiche di un intervento ope ingenii, allora
l’opposizione di R1 con FX richiede un’ulteriore riflessione per essere spiegata.
Su quale dei due rami dovremo dunque basare la ricostruzione di H? Se si
riconoscerà che in FX è ancora conservata la lezione del subarchetipo, allora si
dovrà ammettere che il Rhenanus, nel copiare il testo di H, ha introdotto un certo
errore (avendo precedentemente escluso la possibilità di un suo intervento
congetturale); se invece reputassimo sana la lezione di R1, dovremmo in tal caso
giudicare errata la versione tramandata da FX. Ma come può uno stesso errore
trovarsi nei testi di ambedue i codici? L’errore si è generato indipendentemente in
F e in X oppure era già presente nel loro antigrafo, il codex Pforzhinensis
amissus?
Se poi confrontassimo le lezioni di F, X ed R1 con quelle di M la questione
lascerebbe spazio a nuovi interrogativi: se M è in accordo ad R1 ed insieme si
oppongono al gruppo FX, fino a che punto siamo autorizzati a credere ad un
intervento congetturale da parte del Rhenanus?9 Se l’oscillazione di M fosse
invece verso FX, quale sarebbe il ruolo di R1 nei confronti di H? E ancora, quale
delle due varianti ricostruirebbe il testo di H: quella contenuta in R1, o quella
appartenente al gruppo FX, coincidente con la lezione di M? Se fosse quella di
FX, allora H non si sarebbe originariamente opposto ad M (e Rhenanus avrebbe
per qualche motivo modificato il testo del suo antigrafo); se invece fosse corretta
la versione di R1, in tal caso H sarebbe stato in disaccordo con M: accettando
questa ipotesi, come spiegheremmo la presenza dello stesso errore in due gruppi
9 Non si vuole qui necessariamente insinuare un dubbio di contaminazione, possibilità che pure è
stata avanzata dal Moreschini (Cfr. C. Moreschini, Prolegomena ad una futura edizione
dell’Adversus Marcionem, ASNP II, vol. 35 (1966), pp 293-308). Ci si vuole principalmente
chiedere se l’accordo di M con R1 debba inevitabilmente indurci a supporre un intervento
congetturale del Rhenanus sul testo di H; o se invece sia ancora ammissibile pensare ad una
depravazione del testo di H contenuta in modo comune in FX.
29
di codici tradizionalmente considerati indipendenti? Si tratterebbe di una mera
casualità (cosa difficile a credersi) o ci sarebbero gli estremi per ipotizzare la
presenza di contaminazione?
Da questo schema teorico così intricato e complesso, possiamo
preliminarmente dedurre che soltanto un’analisi approfondita del testo di R1 e
della sua natura potrà aiutarci a risolvere le varie questioni. Prima di scendere dal
campo teorico a quello pratico, sarà bene richiamare alla mente quanto già
evidenziato nel paragrafo precedente: nella lettera prefatoria della sua editio
princeps, il Rhenanus afferma di aver sempre agito nel rispetto totale dei suoi
testimoni e di aver quindi posto i suoi personali interventi sempre al margine del
testo. Anche questa affermazione merita di essere valutata: quanto sono attendibili
le parole dell’editore?
Negli esempi sottostanti, i richiami al testo del primo libro dell’Adversus
Marcionem sono effettuati sulla base dell’editio princeps del Rhenanus,
pubblicata nel 1521, e dell’edizione di R. Braun (1990).
● Un elenco di concordanze tra FX contro R1, con M che si discosta da
ambedue le varianti, è il seguente:
P. 150 lin. 1 - I, 9, 7 (lin. 38) ecquid R edd. : Haec, quid M hec quid γ
La lezione da adottare è sicuramente quella proposta dal Rhenanus. Viene subito
da pensare di trovarsi in questo caso di fronte ad un’ottima congettura del nostro
editore: la lezione hec attestata in γ è indubbiamente inferiore ed il Rhenanus,
accortosene, è intervenuto sul testo ope ingenii. La lezione di M ci porta a
compiere un’ulteriore riflessione: essendo infatti molto simile a quella di γ
(ricordiamo che in FX è molto frequente lo scambio tra ae ed e), si potrebbe
collocare l’origine dell’errore addirittura in θ.
P. 151 lin. 10 – I, 11, 4 (lin. 16) et hoc ex forma M Kr. Mor. Ev. : ex forma
et hoc γ coni. R2 ex forma hoc et R
30
La costruzione et hoc ex forma si ripropone identica nella proposizione successiva
ed in questo caso tutta la tradizione manoscritta si mostra concorde. Tuttavia, nel
passo in questione, avviene uno strano scambio di posizioni: ex forma è posto
dopo et hoc in M a differenza di R e γ che lo collocano prima; et hoc è attestato
secondo quest’ordine in γ e in M, mentre hoc et compare solo nelle edizioni del
Rhenanus. Se nel primo caso la posizione anticipata di ex forma può trovare
origine in un errore di sostituzione presente già in H, nel secondo caso siamo più
dubbiosi nel prendere una posizione ferma. La vicinanza di γ con M sembra
indicare che in H fosse conservata la versione et hoc; ma l’insistenza del
Rhenanus con la formula hoc et, ripetuta costantemente in ogni sua edizione,
nonché la presenza in R2 di un’annotazione marginale coincidente con la versione
di γ, potrebbero far pensare anche ad una corretta lettura del subarchetipo da parte
del Rhenanus. In caso contrario (cioè ammettendo che in H fosse attestata la
lezione di γ) bisognerà ipotizzare che il Rhenanus abbia inserito nel testo una sua
congettura, riportando invece la vera lezione di H soltanto nel margine di R2.
P. 156 lin. 38 - I, 19, 4 (lin. 27) indurantur M G R3 Kr. Mor. Ev. :
inducantur γ indicantur R1 R2
Le lezioni di R1 e di γ si differenziano soltanto per una singola vocale. Il senso
della frase è inoltre garantito in ambedue i casi. Consultando l’Index
Tertullianeus10
scopriamo tuttavia che il verbo indicare è utilizzato un’altra sola
volta in tutto il corpus del Cartaginese (Ad nationes II, 13 (7), 98,24). La lezione
di M, che è da preferire, non ci aiuta a ricostruire con certezza il testo di H. La
questione rimane a nostro avviso aperta.
P. 163 lin. 12 - I, 25, 6 (lin. 38-39) et ea Vrs. Kr. Mor. Ev. : eum θ (cum
R1)
10 G. Claesson, Index Tertullianeus, vol. 2, F-P, Paris 1975, p. 769
31
La lezione comune nei manoscritti è eum: il Rhenanus corregge in cum nella sua
prima edizione, ma ritorna su eum nei suoi due lavori successivi (1528, 1539).
Nessuna delle due lezioni ha però convinto gli editori più moderni: entrambe le
varianti limitano fortemente il senso del periodo. Con cosa concorderebbe il
successivo de quibus? La soluzione proposta dal Braun11
è piuttosto convincente:
et ea sarebbe in questo caso in correlazione con il precedente et eum e si
andrebbero così a creare due proposizioni speculari. Al di là della giusta lezione,
manifestandosi in questo caso un totale accordo in tutta la tradizione manoscritta,
sembra facile ricostruire il testo di H: esso dovrebbe coincidere con la lezione
riportata in FX, mentre R1 potrebbe essere una emendatio ope coniecturae o
anche, ma meno probabilmente, un errore del filologo umanista.
● Abbiamo riscontrato nel testo i seguenti casi di accordo di MR1 contro
FX:
P. 144 lin. 35 - I, 2, 1 (lin. 3) id est nostrum M R Kr. Mor. : om. γ
L’omissione di queste tre parole deve aver avuto origine nel codex Pforzhinensis,
intermediario tra H e i due codici F ed X. Se così non fosse, come avrebbe potuto
il Rhenanus emendare il testo, per giunta reintegrandolo con la stessa lezione
contenuta in M?
P. 146 lin. 39 - I, 5, 1 (lin. 6-7) Aeneiae Iun. Rig. Kr. Mor. Ev. : aeoneiae
M R1 R2 eoneie γ aeoniae R3
Già il Braun12
ha dimostrato l’uso perfettamente chiaro del genitivo all’interno
della frase: esso deve essere ricollegato ai triginta fetus precedentemente citati. La
presenza della o subito dopo il primo dittongo ae è testimoniata in ambedue i rami
del corpus Cluniacense: non riteniamo pertanto errato sostenere che fosse già
11 R. Braun, Tertullien, Contre Marcion: Tome I (Livre I), SChr 365 (1990), p 224. 12 ivi., p. 256.
32
presente nel testo dell’archetipo. La riduzione riscontrabile in FX dei due
dittonghi ae in e è invece sintomo di una cattiva interpretazione, che può essersi
generata indipendentemente nei due manoscritti o già a partire dal codex
Pforzhinensis (lo scambio tra ae e e è usuale in FX). L’annotazione marginale
contenuta nella terza edizione mostra tutta l’erudizione del nostro autore e del suo
primo editore: XXX cap. foetus enixa iacebat è infatti una dotta citazione
virgiliana (En. 3, 390-392; En. 8, 43-45), realizzata da Tertulliano e prontamente
colta dal Rhenanus.
P. 154 lin. 10 - I, 15, 3 (lin. 22) subsiciua Ciacconius Kr. Mor. Ev. :
subsciua M R subscidiua γ coni. R1 subcisiua coni. R3 Pam.
L’alto numero di varianti offerte nel tempo dai vari editori è già un evidente
sintomo di quanto dibattuto e oscuro sia il caso in questione. Da notare che la
lezione scelta dal Rhenanus si mantiene costante in tutte e tre le sue edizioni,
anche se al margine dei relativi testi appone diverse soluzioni alternative. Si
osservi in particolar modo la nota marginale presente in R1, la quale, introdotta dal
termine als (=alias), risulta coincidere con la lezione contenuta nel gruppo FXVL:
il Moreschini ha in questo caso ipotizzato che l’annotazione potesse essere
addirittura contenuta nel margine dello stesso Hirsaugiensis.13
Come
suggeriscono quasi tutti gli editori, il termine a cui si fa qui riferimento dovrebbe
essere subsiciua: consultando l’Index Tertullianus di G. Claesson14
, il termine
sembra costituire un hàpax all’interno di tutta la produzione del Cartaginese. A
giudicare dall’accordo di M con R, la probabile sostituzione di subsiciua con
l’inesatto subsciua sarebbe già contenuta nell’archetipo θ. Rhenanus potrebbe
dunque essere stato fedele al suo antigrafo, mentre la lezione di FX si sarebbe
ulteriormente deteriorata (probabilmente già a partire dal codex Pforzhinensis).
13 Cfr. C. Moreschini, Prolegomena ad una futura edizione dell’Adversus Marcionem, cit. (1967). 14 G. Claesson, Index Tertullianeus, vol. 3, Q-Z, Paris 1975, p. 1545.
33
P. 154 lin. 10 - I, 15, 4 (lin. 31) Et materia M R Kr. Mor. Ev. : Est materia
γ
La lezione di γ è corrotta. Secondo l’usus scribendi dell’autore, la prima posizione
del verbo all’interno della frase è alquanto improbabile. È invece plausibile che
l’accordo di R1 con M riporti in questo caso direttamente alla lezione
dell’archetipo.
● I casi in cui R1 si oppone al gruppo FXM sono ben più numerosi,
precisamente ventisei. Di seguito verranno presentati gli esempi più significativi:
P. 144 lin. 5 - I, 1, 3 (lin. 19) qui Mγ R3 Kr. Mor. Ev. : quis R1 R2 B
La lezione di R1, poi confluita in R2 ma non in R3, potrebbe essere una congettura
del Rhenanus. Infatti nel contesto in cui è inserito, il pronome indefinito quis
sarebbe preferibile rispetto al più raro pronome qui. Eppure noi sappiamo che lo
scambio di qui pro quis (così come quello di aliqui pro aliquis) rientra nelle
consuetudini stilistiche di Tertulliano: ce lo testimoniano non solo gli autorevoli
studi conseguiti da H. Hoppe e confluiti nell’utilissima Sintassi e stile di
Tertulliano15
, ma anche alcuni esempi riscontrabili nel testo dello stesso primo
libro dell’Adversus Marcionem. Soltanto poche righe più in alto (lin. 12) troviamo
infatti Pontus qui igitur e allo stesso modo si osservi I, 11, 5 (lin. 26), dove
leggiamo ut novus aliqui Triptolemus praedicaretur. Pertanto il nostro Rhenanus,
credendo di leggere in H una lezione corrotta, potrebbe essere intervenuto con
l’intenzione di riportare il testo alla sua forma originale. Seppure la nostra ipotesi
sembra essere piuttosto convincente, è tuttavia necessario soffermarci almeno su
un caso che potrebbe rimettere tutto in discussione: in un’annotazione marginale
collocata a pagina 154 dell’editio princeps leggiamo chiaramente aliqui pro
aliquis. Sebbene questo costituisca un ulteriore esempio dell’utilizzo di qui (o
15 H. Hoppe, Sintassi e stile di Tertullia, Edizione italiana a cura di Giuseppina Allegri, Brescia
1985 (Syntax und Stil des Tertullian, Leipzig 1903)
34
aliqui) al posto di quis o (aliquis), abbiamo ora la certezza che anche il Rhenanus
era consapevole della presenza in Tertulliano di questo fenomeno stilistico. La
questione rimane dunque ancora aperta.
P. 144 lin. 16 - I, 1, 4 (lin. 33) Hamaxobio R edd. : maxobio Mγ
In questo caso la lezione contenuta in M e in γ è chiaramente inferiore a quella di
R1: tutti gli editori sono infatti in accordo sulla questione. Non riteniamo errato
ipotizzare un intervento congetturale da parte del Rhenanus: l’errore sarebbe
passato ad M e a γ in quanto contenuto già nell’archetipo.
P 145 lin. 25 - I, 3, 3 (lin. 15) convenit Mγ Kr. Mor. : conveniat R Ev.
Le due varianti testimoniate differiscono unicamente per la scelta del modo
verbale. Il verbo, che svolge nella frase una funzione causale, deve essere
ricollegato al cum posto in precedenza: in questo caso, secondo le convenzioni
della grammatica classica, è previsto l’utilizzo del congiuntivo. Per svolgere le
medesime funzioni è tuttavia attestato in Tertulliano l’uso del modo indicativo.16
Appare chiaro, dunque, l’intervento congetturale del Rhenanus il quale, non
considerando l’usus scribendi del Cartaginese, ha cercato di riportare il caso
particolare alla norma tradizionale. Secondo il nostro parere M e γ conservano
pertanto il testo dell’archetipo.
P. 150 lin. 3 - I, 9, 7 (lin. 40) ad hanc R edd. : adhuc Mγ
Quella di R è sicuramente lezione poziore. I copisti di M e γ possono essere caduti
in inganno indipendentemente l’uno dall’altro: potrebbero aver ambedue ripetuto
il termine adhuc che, infatti, compare poco dopo. Non è improbabile che H si
debba ricostruire sulla base di R.
P 150 lin. 34 - I, 10, 3 (lin. 19) barbare R edd. : barbarare Mγ
16 ivi p. 154.
35
Secondo noi siamo qui di fronte ad una congettura del Rhenanus. Escludendo la
contaminatio, l’evidente lezione errata barbarare deve essere stata trasmessa a
partire da θ: solo in questo caso ci spiegheremmo la coincidenza del gruppo MFX
in lezione inferiore.
P. 151 lin. 18 - I, 11, 5 (lin. 26) aliqui Mγ Kr. Mor. Ev. : aliquis R
È il caso già citato nel primo esempio di questo elenco: se ne possono fare le
stesse considerazioni.
P. 152 lin. 17 - I, 12, 3 (lin. 21) qua R edd. : quam Mγ
La lezione di R è migliore di quella conservata in Mγ. La ripetizione del qua
riflette la composizione della frase precedente (Impuditiae, qua - Malignitatis,
qua). Si tratta anche in questo caso di un intervento ope ingenii compiuto dal
Rhenanus?
P. 153 lin. 3 - I, 13, 4 (lin. 35) aquam Mγ Kr. Mor. : aquas R Ev.
Prima Kroymann (1954), poi anche Moreschini (1971) e Braun(1990) hanno visto
in Mγ la lezione più adeguata. Anche noi siamo dello stesso parere:
nell’elencazione in cui il termine è inserito, si crea in questo modo una perfetta
specularità ( Iovem in substantiam - Iunonem in aëream - Vestam in ignem -
Camenas in aquam - Magna matrem in terram). Ci sentiamo di escludere in
questo caso il dubbio di contaminazione: la variante presentata dal Rhenanus
potrebbe essere una cattiva congettura, o anche un’errore di copiatura, causato
dalla ripetizione della desinenza -as presente nel termine immediatamente
precedente Camenas.
P.154 lin 4 - I, 15, 2 (lin. 14) domino R Kr. Mor. Ev. : -num Mγ
Corretta è la lezione di R1: domino svolge infatti nel contesto il ruolo di secondo
termine di paragone (nisi domino fortasse maiorem). La variante dominum
presente in FXM potrebbe derivare dalla presenza dell’errore già nell’archetipo.
36
P. 156 lin. 3 - I, 18, 2 (lin. 10) dehinc Mγ Kr. Mor. : deinde R Ev.
Secondo il nostro parere la lezione deinde, attestata solo nelle edizioni del
Rhenanus, non ha motivo di essere considerata poziore rispetto al dehinc
testimoniato in ambedue i rami della collezione. Il nostro editore deve essere qui
caduto in errore.
P.156 lin. 12 - I, 18, 3 (lin. 13) cognosci R edd. : cognoscis Mγ
L’utilizzo dell’infinito passivo cognosci è imposto dal senso della frase. La
lezione di R, in consenso con quella di tutti gli editori successivi, è indubbiamente
corretta. L’altra variante, presente già in M, doveva essere testimoniata anche dal
testo di H.
P. 159 lin. 36 - I, 22, 8 (lin. 51) proficiunt M γ coni. R3 Kr. Mor. Ev. :
prosiliunt R
I due predicati hanno all’incirca il medesimo significato ma, consultando l’Index
Tertullianeus17
ci si accorge che prosiliunt compare soltanto un’altra volta
all’interno degli opuscula Tertulliani (Ap. 50: 382, 4 ), mentre proficiunt è
largamente attestato. Sembrerebbe un caso di lectio difficilior e, almeno in un
primo momento, si propenderebbe per ricostruire H sulla base di R. La questione
si complica però nel momento in cui si chiama in causa M, il quale contiene infatti
la stessa lezione di FX. Come spiegare questa coincidenza? Se è da escludere una
congettura del Rhenanus, rimane comunque aperta l’ipotesi di una sua erronea
interpretazione di H. È altamente improbabile la possibilità di contaminatio tra M
ed FX.
La lunga elencazione di esempi appena fornita mette per prima cosa in
evidenza quanto sia fondamentale, nel campo filologico, l’approccio diretto con il
testo e l’analisi approfondita di ogni singolo caso: l’aspetto pratico risulta a volte
17 G. Claesson, op. cit., p. 1261.
37
molto più esplicativo di quello puramente teorico. E in effetti lo studio dei casi
appena presentati ci ha permesso di liberare la mente da alcuni dubbi sorti in
precedenza e di giungere ad alcune importanti considerazioni.
In primo luogo, alla luce dei risultati ottenuti, ci sentiamo autorizzati a credere
che il Rhenanus abbia inserito, in alcuni punti della sua editio princeps, alcune
modifiche al testo di H. Non possiamo però sapere con quale grado di
consapevolezza egli abbia agito: in alcuni casi sembra di poter identificare in
quelle presunte modifiche una emendatio ope ingenii; in altri, al contrario,
potrebbe benissimo trattarsi di un errore di comprensione o addirittura di
copiatura del testo del subarchetipo H. In ogni caso non ci sembra un aspetto di
poco conto: le parole dello stesso editore, quando sosteneva di aver riportato tutti i
suoi personali interventi congetturali ai margini del testo, finirebbero così per
essere screditate.
Fra le congetture inserite nel testo dal Rhenanus, possiamo distinguerne alcune
di maggiore valore e fortuna e altre che, non essendo in seguito state più riprese
(né dal Rhenanus, né da altri editori), hanno goduto di minor vita. Tra le buone
congetture andranno inserite quelle che sono ancora attualmente preferite dai
moderni editori, ma anche quelle poi accolte nell’edizione del 1528 e ancora
successivamente in quella del 1539.
Almeno per il primo libro dell’Adversus Marcionem, crediamo infine di poter
respingere l’ipotesi di una contaminazione fra i due rami della collezione
Cluniacense. Anche i casi che maggiormente potrebbero giustificare
un’affermazione del genere, ovvero quelli di accordo tra MFX contro R1, possono
essere spiegati molto più facilmente: o ammettendo la presenza di un errore
comune in MFX, talmente banale da essersi ripresentato nella stessa forma ma
indipendentemente in ogni testimone; o sostenendo la derivazione della menda a
partire dall’archetipo.
Nei Prolegomena ad una futura edizione dell’Adversus Marcionem, il
Moreschini invita il futuro editore di questo testo ad esaminare con attenzione
quei casi in cui l’opposizione delle due famiglie M e R1FX si spezza per dar luogo
38
ad una caratteristica oscillazione ora di X, ora di F verso M, vale a dire si
verificano dei casi di concordanza tra MF contro R1X sia in lezione inferiore, sia
in lezione poziore e di MX contro R1F, ugualmente in lezione inferiore e in lezione
poziore.18
Sempre secondo il suo pensiero, le concordanze in errore tra M e F e tra M ed
X possono essere considerate irrilevanti in quanto l’errore è spesso così banale
che i due manoscritti possono averlo commesso indipendentemente l’uno
dall’altro. In questo caso dunque, l’oscillazione di X o di F verso M sarà del tutto
apparente e la divisione in due famiglie del corpus Cluniacense risulterà ancora
preservata: la lezione del perduto Hirsaugiensis sarebbe in questo caso da far
coincidere con il raggruppamento R1F (nel caso sia X a coincidere con M) o con
R1X (nel caso sia invece F ad oscillare verso M). Ben più difficile, ipotizza ancora
il Moreschini, sarebbe spiegare i casi di concordanza tra M e F o tra M e X
(rispettivamente contro R1X e R1F) in lezione poziore. In questi casi si potrebbe a
suo giudizio insinuare il dubbio di contaminazione, perché sembra piuttosto
improbabile pensare che F o X (quando si accordano con M) rappresentino
entrambi la lezione del Hirsaugiensis, corrottasi poi tanto in R1X (nel caso del
raggruppamento MF) tanto in R1F (nel caso del raggruppamento MX) però - e
questo è il punto difficile ad ammettersi – corrottasi nello stesso modo nei due
manoscritti, ma indipendentemente in entrambi.
Esortati da questi studi, abbiamo esaminato il testo del primo libro
dell’Adversus Marcionem, cercando di evidenziare tutti i casi di opposizione fra
MF e R1X e fra MX e R1F.19
Va innanzitutto sottolineata l’estrema rarità con cui
ricorrono questi fenomeni: abbiamo individuato soltanto tre casi in cui il gruppo
MF si oppone ad R1X e nessun caso in cui MX contrasta con R1F. Inoltre in
ambedue le circostanze, la lezione migliore è sempre quella che non oscilla verso
M ma che tende a coincidere con R1. Attraverso una semplice elencazione dei casi
18 Cfr. C. Moreschini, op. cit. (1967). 19 Tralasciamo di riportare i semplici casi di opposizione tra F ed R1X e tra X e R1F in quanto la
soluzione in queste situazioni è evidentemente pacifica: si individuerebbero così soltanto le
lectiones singulares a volte di F, a volte di X e dunque i loro errori particolari.
39
in questione, sarà possibile intuire quanto banali siano gli errori presenti in MF e
quanto sia dunque alta la possibilità di una corruzione identica, ma indipendente,
nei due manoscritti.
P. 153 lin. 2 – I, 13, 4 (lin. 33) aëream X R Kr Mor. Ev. : aeriam M F;
p 159 lin. 40 – I, 22, 9 (lin. 56) oneratum X R edd. : honeratum M F;
p. 153 lin. 4 – I, 13, 4 (lin.37) Osiris R1 F : ostris M X.
In ogni occasione in cui MF o MX si mostrano in accordo contro R1X o R1F,
almeno per quanto riguardo il primo libro dell’Adversus Marcionem, possiamo
affermare con sicurezza che il testo dell’Hirsaugiensis deve essere
necessariamente ricostruito sulla base del raggruppamento di cui fa parte R1. In
altre parole, in queste situazioni (per quanto rarissime), abbiamo la certezza che il
Rhenanus ha trasmesso correttamente la lezione del manoscritto H da cui
ricopiava.
Prima di concludere, sarà bene completare questa trattazione della prima
edizione alle opere di Tertulliano fornendo una breve descrizione delle
annotazioni marginali in essa contenute.
Il Kroymann, dopo aver ricordato che l’Adversus Marcionem rientra nel
gruppo di quei tredici trattati che il Rhenanus poteva leggere soltanto
nell’Hirsaugiensis20
, affermava che tutte le annotazioni marginali contenute
nell’editio princeps sarebbero esclusivamente il risultato del lavoro congetturale
effettuato dal filologo umanista.21
Più di mezzo secolo dopo, il Moreschini22
è
intervenuto sulla questione con una posizione completamente differente:
riesaminando tutto il complesso delle annotazioni marginali, è giunto a sospettare
delle stesse parole dell’editore. Secondo il suo giudizio, non tutte le annotazioni
avrebbero l’evidente aspetto di congetture, ve ne sarebbero infatti altre che danno
20 Il Rhenanus, come sappiamo, non conosceva infatti né il Montepessulanus, né altri manoscritti
appartenenti al primo ramo del corpus Cluniacense. 21 Cfr. E. Kroymann, Kritische Vorarbeiten für den dritten und vierten Band der neuen Tertullian-
Ausgabe,SAWW 143, 6 (1900), pp. 2-3. 22 Cfr. C. Moreschini, op. cit. (1967).
40
l’impressione di essere lezioni desunte da una tradizione autonoma da quella del
Hirsaugiensis, su cui è costruita l’edizione del Rhenanus. Una prova a sostegno di
questa ipotesi potrebbe essere il frequente utilizzo di due formule che spesso si
alternano nell’introdurre le correzioni in margine: forte o forsan da un lato, alias
dall’altro. Sostiene il Moreschini che questo fatto non può essere dovuto al caso:
perché il Rhenanus avrebbe dovuto distinguere alcune congetture dalle altre, se
poi erano tutte, sia quelle introdotte da “forte” sia quelle introdotte da “alias”,
frutto della sua mirabile capacità divinatrice? E conclude affermando che a voler
giudicare senza preconcetti […] sembra logico pensare che con l’annotazione
“alias” il Rhenanus volesse indicare quelle lezioni da lui desunte dalla collazione
di un altro manoscritto (come di solito avviene in casi del genere), mentre quelle
introdotte con “forte” o simili indicherebbero le sue congetture personali.
Basandosi su alcune coincidenze testuali, il Moreschini crede di poter avanzare
l’ipotesi che il Rhenanus avesse a sua disposizione altri due manoscritti,
imparentati l’uno con l’Agobardinus, l’altro con il Magliabechianus N, se non
direttamente con il Montepessulanus
A questa affascinante teoria si è però successivamente opposto il Van der Nat,
in una lettera di risposta proprio al Moreschini. Con il suo intervento, egli cerca di
riportare la questione entro margini più tradizionali, pur distaccandosi dalle
supposizioni più radicali del Kroymann. Il Van der Nat sostiene infatti che il
Rhenanus ha costruito il testo dei trattati non presenti in P unicamente sulla base
di H; in questo caso rimangono aperte soltanto due possibilità: il Rhenanus può
avere accolto nel testo della sua edizione le stesse lezioni dell’Hirsaugiensis,
oppure può avervi introdotto una sua congettura. Nel primo caso le varianti
marginali coinciderebbero con gli interventi congetturali elaborati dal filologo
umanista, nel secondo avremmo invece conservato nei margini il testo originale di
H. Se la prima possibilità è quella certo più frequente, il Van der Nat non manca
di sottolineare che anche la seconda sembra essersi in qualche luogo
concretizzata. Non ritiene inoltre probante l’utilizzo delle due diverse formule
41
introduttive alias e forte perché la loro origine non è chiara: persino H, ipotizza,
sembra contenesse lezioni marginali.
Alla luce di tutte queste considerazioni, ci è sembrato opportuno esaminare
tutte le annotazioni marginali dell’editio princeps presenti nel primo libro
dell’Adversus Marcionem. Potremmo suddividere queste note marginali in tre
categorie: quelle introdotte da for. (= forte o forsan), quelle introdotte da als. (=
alias) e altre che non presentano formule introduttive.
Le note introdotte da als. ricorrono soltanto in tre casi: le soluzioni alternative
ivi fornite sono tutte banalizzazioni o facili miglioramenti del testo. Consultando
gli apparati critici del Braun (1990) e del Kroymann (1954) laddove il primo tace,
abbiamo verificato che in nessun caso le varianti offerte nei margini si mostrano
in accordo con l’altro ramo della collezione Cluniacense: ci sembra così di poter
respingere, almeno per quanto riguarda il primo libro dell’Adversus Marcionem,
la tesi avvalorata dal Moreschini.23
Presentiamo di seguito i casi riscontrati:
p. 145 mg. lin. 15 – I, 7, 3 (lin. 15) voce vel nota als. R1 : notae R1;
p. 154 mg. lin. 10 – I, 15, 3 (lin.22) subscidiua als. R1 : subsciua R1;
p. 154 mg. lin. 39 – I, 16, 2 (lin. 13) deo creatori als R1 : deo creatore R1.
Le annotazioni marginali introdotte da for. sono leggermente più numerose, in
totale ne abbiamo contate sette. Si tratta in ogni caso di evidenti congetture e non
ci sembra vi siano indizi per poterne negare la paternità del Rhenanus. Tra questi
interventi ope ingenii troviamo soprattutto congetture che non sono state poi
riproposte né dal Rhenanus, né da altri editori. In nessun caso una congettura
introdotta da forte e presente in R1 entra poi a far parte del testo di R2; accade
invece in una sola circostanza che essa venga riproposta nel margine di R2, seppur
con un’ulteriore aggiunta. Il caso merita di essere segnalato:
23 Sarebbe intellettualmente scorretto non ricordare che lo stesso Moreschini aveva già fatto simili
considerazioni in merito allo stesso trattato. Cfr ibid.
42
p. 150 mg lin. 28 – I, 10, 2 (lin. 11) tanta idolotriae dominatione coni. R1
vel etiam intantum coni. R2 : tantam idolotriae dominationem R1 R2
Le altre note a margine, ovvero quelle non introdotte da nessuna formula, sono
invece molto più numerose. Tuttavia esse hanno per lo più natura esplicativa:
sono quasi dei richiami al testo che il Rhenanus inserisce per migliorarne la lettura
o per spiegare il senso di qualche singolo passo. Soltanto quattro di queste
annotazioni hanno valore di congetture: in due casi la soluzione proposta non
sembra convincere neppure il Rhenanus, poiché nell’edizione successiva del 1528
la sostituirà con un’altra annotazione (p 159 mg. lin. 39,40 e p. 160 mg. lin, 29); le
altre due occasioni meritano invece di essere annotate, la prima perché da essa
dipenderà poi il testo di R2 e di R3, l’altra perché sarà riproposta a margine di R2
per poi infine entrare nel testo di R3.
P. 153 mg. lin 25 – I, 14, 5 (lin. 29) muta apocarteresi coni. R1 R2 R3 :
muta porcartere R1;
p. 156 mg. lin. 27 – I, 19, 2 (lin. 12) aura canicularis coni. R1 coni. R2 R3 :
aula canicularis R1.
Abbiamo creduto che fosse opportuno soffermarci tanto a lungo sui rapporti
che intercorrono tra il perduto codex Hirsaugiensis e la prima edizione critica alle
opere di Tertulliano, per poter così meglio definire ed inquadrare l’attività
emendatrice del nostro Rhenanus. I dibattiti e le varie ipotesi che nel corso degli
anni sono state presentate dai più autorevoli studiosi in merito al valore di questa
editio princeps, giustificano, a nostro parere, la lunghezza del presente capitolo.
Tuttavia sarà bene ora concentrarsi sulla seconda edizione di Tertulliano,
pubblicata sempre dal Rhenanus nell’anno 1528.
43
Capitolo terzo
La seconda edizione e l’emendatio ope ingenii
Nel capitolo seguente verrà presentata una descrizione della seconda edizione
delle opere di Tertulliano, curata ancora una volta dal Rhenanus e pubblicata
nuovamente a Basilea, nel mese di marzo del 1528. Nel primo paragrafo si
cercherà innanzitutto di spiegare quali sono le motivazioni che hanno spinto
l’editore umanista a rivedere il suo precedente lavoro, per poi passare ad
analizzare i nuovi presupposti e le rinnovate intenzioni. Nell’altra sezione
verranno invece segnalate le differenze più sostanziali che intercorrono tra la
prima e la seconda edizione: grande spazio verrà lasciato al tema dell’emendatio
ope ingenii, assolutamente fondamentale in questo nuovo lavoro. La nostra analisi
sarà condotta unicamente sulla base del primo libro dell’Adversus Marcionem.
3.1 L’edizione del 1528: alcune informazioni preliminari
Il 15 dicembre del 1527 Beatus Rhenanus invia da Basilea un breve biglietto al
barone polacco Jan Łaski1, il quale aveva in precedenza soggiornato presso la
dimora di Erasmo2. Nella parte finale di questo documento, dopo aver rivolto
alcuni sinceri auguri al giovane amico, lo studioso di Sélestat passa a trattare della
sua grande fatica del momento: la seconda edizione delle opere di Tertulliano.
Ancora una volta egli tende a sottolineare la complessità e la temerarietà del suo
lavoro, dettate ambedue dall’estrema difficoltà di lettura dei soliti manoscritti,
ampiamente corrotti. Le cause di questa enorme depravazione sono le stesse che
aveva già denunciato nella lettera prefatoria della prima edizione3: l’antiquitatem,
ovvero il lungo tempo di disinteresse generale per le opere del Cartaginese, e
1 A. Horawitz, K. Hartfelder, Briefwechsel des Beatus Rhenanus, Reihneim 1966 [1886], p. 374. 2 Cfr. P. Armandi, Erasmo da Rotterdam e i libri. Storia di una biblioteca,
<http://picus.sns.it/documenti/armandi_ocr.pdf, p. 32> [ultima cons. 21-10-2013]. 3 Cfr. supra, cap. 2, p. 17.
44
l’obscuritatem styli. Ciononostante il Rhenanus si mostra molto fiducioso, se non
proprio soddisfatto, dei risultati che stava ottenendo: nam innumeras mendas
castigavi, difficiliora loca quaedam aperui, vocabula autori peculiaria
loquendique formulas annotavi. Prima di congedarsi, il nostro umanista invita
l’amico a verificare personalmente i miglioramenti apportati al testo, non appena
l’edizione sarà completata.
Già da questo breve documento possiamo estrapolare almeno un’importante
informazione che sarà poi ribadita, all’interno dell’edizione, dallo stesso
Rhenanus: la mancanza di nuovi testimoni manoscritti è supplita dalle maggiori
attenzioni dell’editore verso la lingua e lo stile di Tertulliano. La consapevolezza
e la soddisfazione per i miglioramenti conseguiti, sono la testimonianza di
un’accresciuta dimestichezza con l’usus scribendi dell’autore. A tutto questo va
poi certamente unita la grande esperienza filologica ottenuta e maturata dal
Rhenanus nel corso di questi sette anni4.
Il 29 febbraio del 1528, sotto la forma di una lettera al lettore5, Rhenanus scrive
una nuova prefazione alla sua seconda editio Tertulliani. Inserita dopo un sobrio
frontespizio6 e dopo il catalogus delle opere contenute
7, questa lettera fornisce al
lettore alcune importanti informazioni: in una prima parte vengono spiegate le
motivazioni che hanno convinto l’editore a curare una nuova pubblicazione,
nell’altra sono invece illustrate le modalità con le quali il Rhenanus è intervenuto
nuovamente sul testo e le innovazioni così ottenute. Al termine di questa lettera,
viene poi presentata un’altra sezione, nella quale l’editore, oltre a fornire una
spiegazione di alcune sue importanti congetture, si preoccupa di descrivere alcune
consuetudini stilistiche, grammaticali e sintattiche dello scrittore Cartaginese: di
queste annotationes ci interesseremo più avanti.
4 Tanti ne passano fra la pubblicazione dell’editio princeps (1521) e di questa seconda edizione
(1528). 5 Cfr. Anche A. Horawitz, K. Hartfelder, op. cit., pp. 374-376. 6 Non compaiono più le splendide incisioni che erano state applicate nel frontespizio dell’editio
princeps. Oltre al titolo dell’opera e ad una sua breve descrizione, troviamo ora solo la marca
tipografica di Johann Froben. 7 Il catalogus presenta la stessa forma grafica di quello contenuto nell’editio princeps.
45
Sin dalle prime righe di questa nuova prefazione si intuisce quanto il Rhenanus
si sia impegnato per entrare maggiormente in sintonia con lo stile particolarissimo
di Tertulliano: sebbene questo venga ancora definito come oscuro, affettato e
duro, per la prima volta il nostro editore parla apertamente di un linguaggio che
presenta molte peculiarità riconducibili al latino anticamente parlato nelle regioni
africane, dalle quali Tertulliano proveniva. La lingua ardua dell’autore, unita alle
numerose mende sorte nel tempo per mano dei librarii, hanno reso difficilissima
la lettura dei suoi trattati: se per la maggior parte degli altri autori - dice il
Rhenanus - una certa facilitas sermonis permette molto spesso di cogliere il senso
del discorso, nel caso di Tertulliano, al contrario, divinandum est saepissime.
Dopo questo accenno a delle tematiche che avrà poi modo di riprendere e di
approfondire ulteriormente, il Rhenanus passa a motivare la pubblicazione di
questa sua seconda edizione. Veniamo così a sapere che, almeno nelle intenzioni
primordiali, il filologo umanista non avrebbe voluto curare una nuova edizione
critica delle opere del Cartaginese, se prima non avesse potuto consultare altri
manoscritti, reputati addirittura migliori dei precedenti. Expectabam avide ex
Mediomatrici Gorziensem codicem, et a Treviris Spectaculorum libros8, sed
frustra9: queste le parole che il Rhenanus riporta in proposito. Nonostante non
fosse dunque in possesso di nuovi manoscritti, l’umanista alsaziano decise
ugualmente di intraprendere questo nuovo lavoro critico, istigato, o meglio
pressato, dalle insistenti richieste del tipografo Froben. Quest’ultimo si era infatti
convinto della necessità di intervenire nuovamente con una seconda
pubblicazione, sia per evitare che qualche tipografo o editore rivale potesse
migliorare il loro precedente lavoro, sia per soddisfare le richieste dei molti
8 Dalle annotationes posposte all’Adversus Valentinianos (p. 403) apprendiamo ulteriori
informazioni su questo codice contenente il trattato De spectaculis: ne era in possesso il giurista
Ulrich Fabritius di Koblenz, il quale aveva deciso di cederlo al Rhenanus, affinché questi ne
curasse l’edizione. Purtroppo morì prima di consegnarlo al filologo umanista ed in seguito alla sua
scomparsa si persero le tracce del codice. 9 Sempre nelle annotationes poste al termine dell’Adversus Valentinianos (p. 403) Rhenanus parla
anche di un codice conservato a Fulda. Dice di non averlo potuto consultare a causa di non meglio
specificati “tumulti popolari”.
46
studiosi che, da più parti, ricercavano ulteriori spiegazioni sui testi di Tertulliano.
Il Rhenanus accettò quasi forzatamente questa proposta del Frobenius e, sempre
nel corso della lettera prefatoria, confessa apertamente al lettore che, almeno nelle
fasi iniziali, partecipò molto svogliatamente al progetto. Tuttavia, proseguendo nei
lavori, si rese gradualmente conto che andava ottenendo risultati sempre più
interessanti, pur citra praesidium exemplarium vetustorium, ma appellandosi
soltanto alla propria capacità divinatrice: quanto più aumentava questa
consapevolezza, tanto più accresceva la sua partecipazione ed il suo entusiasmo.
Al termine dell’opera, Rhenanus sentiva di aver compiuto un ottimo lavoro e
poteva sostenere, con un pizzico di fierezza, di aver realizzato un’edizione di gran
lunga migliore rispetto alla precedente. Tuttavia, per mantenersi coerente con la
sua indole improntata alla modestia, il filologo di Sélestat dichiara che la
superiorità di questo nuovo lavoro dipende principalmente dalla grandissima
diligenza con cui tutti (compresi i correttori) si sono applicati e non, certo, perché
ritenga che sia stata prodotta un’edizione ad unguem castigata: d’altronde, come
avrebbero potuto i suoi aiutanti non prendere degli abbagli, immersi nel gran
tumulto delle presse, mentre i librai, infastiditi dai ritardi e ansiosi di ottenere un
guadagno, incitavano alla fretta?
Terminato questo excursus, utile ad illustrare il retroscena storico inerente alla
stesura di questa seconda edizione, il Rhenanus passa ad esporre il metodo
utilizzato per emendare i trattati di Tertulliano: grande attenzione viene
naturalmente prestata al tema della emendatio ope coniecturae.
L’intervento congetturale, come prima anticipato, viene ora nuovamente
presentato, in questo specifico caso, come necessario: le opere dell’autore
Cartaginese erano così depravate che l’editore, in mancanza di altri manoscritti da
poter collazionare, si è potuto appellare unicamente a questo metodo emendatorio
e, dunque, alla sua capacità divinatrice. Tuttavia il Rhenanus, da esperto filologo
qual era, non perde occasione per avvertire il lettore circa i pericoli che si corrono
quando il prurito congetturale, usato in maniera eccessiva e sconsiderata, prende il
sopravvento persino sull’autorità dei più antichi codici manoscritti. A suo
47
giudizio, è invece fondamentale agire con estrema cautela, nel pieno rispetto della
lingua e dello stile dell’autore: nell’edizione critica di un testo non esiste minaccia
più grande di quella costituita dalla realizzazione di un intervento per divinatio,
che sia sconsiderato e frettoloso. Riconoscendo questo pericolo, il Rhenanus
spiega di essere intervenuto solo in casi di estrema necessità e, cosa fondamentale,
di aver sempre motivato ogni suo intervento congetturale: lasciare la libertà di
giudizio al lettore è un fattore che non deve essere assolutamente sottovalutato. A
questo proposito, sostiene che è molto preferibile centum loca per coniecturam
exponere, quam unicam sillabam in quocumque autore perperam mutare. Colui
che utilizza una simile impostazione – conclude poi il Rhenanus – otterrà forse
una minor gloria, ma sarà per lui minore anche la possibilità di commettere un
errore. In effetti lo scrupolo con il quale il Rhenanus ha lavorato in questa seconda
edizione è visibilmente maggiore rispetto a quello avuto nella precedente
esperienza e, di conseguenza, più numerosi sono anche i buoni risultati. Questa
sua grande diligenza lo porta a ribadire più volte la bontà del metodo utilizzato.
Infatti, nelle annotationes dell’Adversus Hermogenem10
, dopo essersi nuovamente
lamentato per il gran numero di corruttele presenti nel testo dei testimoni, ribadise
ancora una volta il largo ricorso a correzioni congetturali, che però dichiara di
aver messo sempre in evidenza, sia perché il lettore possa giudicare da sé, sia
perché magna religione tractanda sunt veterum scripta.
Proprio per non nascondere le numerose modifiche ottenute tramite divinatio,
il nostro editore inserisce nuovi spazi, separati dal testo dei trattati, nei quali
discute liberamente le scelte compiute, illustrandole dettagliatamente. La
massiccia presenza del materiale congetturale ha reso infatti impossibile il solo
utilizzo dei margini laterali, anche se questa soluzione era preferita dallo stesso
autore: Maluissemus nostras coniecturas in marginibus chartarum apponere, sed
cum longiscule essent, non est visa sufficere exiguitas spatii brevioris.11
La
presenza di questi spazi, nominati semplicemente annotationes, non solo permette
10 Opera Tertulliani (1528), pp. 355-356, Adversus Hermogenem. 11 ivi p. 356, Adversus Hermogenem.
48
all’editore di commentare le proprie proposte di modifiche al testo, ma anche di
gettare luce su alcuni passi oscuri, di richiamare l’attenzione del lettore
sull’utilizzo, da parte dell’autore, di termini proverbiali e popolari e, infine, di
analizzare le particolarità linguistiche del latino di Tertulliano: appellandosi
unicamente alla sua abilità, e a quella dei suoi collaboratori, il Rhenanus cerca in
ogni modo di avvicinarsi quanto più possibile alla ipsissima Tertulliani lectio12
.
L’introduzione delle annotationes, vero tratto distintivo di questa seconda
edizione, contribuì fortemente allo sviluppo degli studi del Rhenanus su
Tertulliano: lo stesso sistema sarà poi ripreso, e persino ampliato, nell’edizione
del 1539. In questo suo secondo lavoro, egli scrive invece otto pagine di note
aggiuntive, inserite subito dopo la lettera al lettore, nelle quali si occupa prima del
De Patientia e poi, più brevemente, dei primi sette trattati (De Patientia, De carne
Christi, De resurrectione carnis, De praescriptione haereticorum, Adversus
omneis haereses, Adversus Iudaeos, Adversus Marcionem). Ma non basta: anche
per tutti gli altri scritti il Rhenanus inserisce delle singole annotationes.
Questa, in definitiva, la struttura generale della seconda edizione di Tertulliano,
curata dal Rhenanus e pubblicata nel marzo del 1528. Già dalle sue prime pagine,
specialmente nella lettera Ad lectorem, si possono intuire quali sono gli aspetti
che, nel corso della nostra analisi, meritano di essere maggiormente indagati: il
ruolo e il peso della congettura, la modalità con cui essa viene presentata ed il
desiderio di chiarezza, l’attenzione dell’editore alle peculiarità linguistiche dello
scrittore africano. Nel paragrafo successivo, offriremo un’analisi del primo libro
dell’Adversus Marcionem, per come esso si presenta in questa seconda edizione.
3.2 Le innovazioni apportate al primo libro dell’Adversus Marcionem
12 ivi p. 545, De fuga in persecutione.
49
Il primo libro dell’Adversus Marcionem, nell’edizione a stampa del 1528,
inizia a pagina 152 ed è preceduto soltanto da un breve argomentum. Nelle
annotationes inserite subito dopo la lettera prefatoria, troviamo davvero poche
notizie che riguardano direttamente il primo libro dell’Adversus Marcionem: il
Rhenanus, dopo aver trattato singolarmente il De patientia, ha preferito infatti
esporre brevi considerazioni generali, riportando poi soltanto alcuni esempi tratti
dal testo dei primi sette trattati: neque enim commentarium scribere voluimus. Tra
queste considerazioni, non ci sono solo delucidazioni sulle congetture effettuate,
ma anche spiegazioni circa le consuetudini linguistiche di Tertulliano e sul suo
stile: il Rhenanus cerca di documentare tutti i casi in cui l’autore Cartaginese si
allontana dal latino tradizionale, in favore di quello parlato nella provincia
Africana. A volte il nostro editore, per illustrare un principio generale o per
dimostrare il valore di una sua congettura, utilizza un passo contenuto proprio nel
primo libro dell’Adversus Marcionem. Facciamo qualche esempio:
Quem tantum tu iudicem tenes dispensatorem si forte bonitatis ostendis
intelligendum, non profusorem, quod tuo vendicas. (p. 172 lin. 14 – I, 24, 3 lin.
19). Il suddetto passo viene preso come testimonianza del ripetuto uso, da parte di
Tertulliano, della formula si forte al posto del semplice forte (si forte perpetuo
Tertullianus usurpat pro forte).
Iam et bestiis illius barbariei importunior Marcion (p. 153 lin. 11 – I, 1, 5
lin. 37). Qui il Rhenanus consiglia al lettore di leggere barbariae al posto di
barbariei: nam Barbariam pro regione Barbarorum usurpat.
Tentabis ad haec de nomine dei concutere retractatum, ut passiuo et in
alios quoque permisso (p. 157 lin. 5 – I, 7, 1 lin. 2). Rhenanus riporta questa frase
per dimostrare che Tertulliano utilizza il termine passivus col significato di
“comune” o “promiscuo”. Nella nota marginale posta al fianco del passo indicato,
tenterà poi di spiegare che il termine in questione sarebbe derivato dall’avverbio
passim ed è per questo che consiglia di leggere ut passimo, in luogo di ut passivo.
50
Quo denique initiantur et indicantur in hanc haeresim ( p.166 lin. 15 – I,
19, 4 lin. 27). Indicari in haeresim – spiega il Rhenanus nelle annotationes – est
initiari haeresi, sive dedicari haeresi. Questa sua spiegazione viene poi ribadita a
fianco del testo, dove consiglierà al lettore di sostituire il verbo indicantur con
dedicantur.
Si qui pro quis frequentissum est apud Tertullianum. […] Item aliqui pro
aliquis. […] Sic dicit ne qui, pro ne quis. In questa circostanza il nostro editore
enuncia una tendenza generale che si riscontra spesso negli scritti del Cartaginese.
Sebbene egli non faccia qui una chiara allusione al primo libro dell’Adversus
Marcionem, ci è sembrato opportuno segnalare la conoscenza da parte del
Rhenanus di un tratto caratteristico dell’usus scribendi di Tertulliano; una
peculiarità che spesso incontriamo anche nel testo che è oggetto della nostra
analisi (I, 1, 3 lin. 12 e 19 - I, 11, 5 lin. 26)
Al di là delle annotationes iniziali, sarà ancora una volta fondamentale
analizzare il testo del trattato per comprendere il metodo seguito dal nostro editore
e per cogliere le differenze con la precedente edizione.
Ovviamente i casi in cui il testo di R2 coincide con quello di R1 sono
numerosissimi: ripetiamo che il Rhenanus non aveva a disposizione codici
manoscritti diversi da quelli collazionati per l’editio princeps e che, nell’edizione
del 1528, cercò di migliorare il testo facendo esclusivamente appello al suo
ingegno. Soltanto nella terza edizione (1539), con l’apporto del Gorziensis, egli
riuscirà ad inserire o a correggere molte lezioni, persino quelle che prima non
avrebbe potuto riconoscere come errate. Assai esplicativo è, a questo proposito, il
caso di omissione che si riscontra in I, 10, 3 lin. 18 e 19: l’intera frase Iudaeorum
enim deum dicunt animae deum compare solo a partire da R3. In casi come questo
51
si intravede chiaramente la netta divisione del corpus Cluniacense in due distinti
rami.13
Osservando gli spazi marginali del testo, è possibile verificare come il
Rhenanus abbia mantenuto, in molte occasioni, le stesse annotazioni già presenti
in R1, apportando tutt’al più solo piccole modifiche. Queste ripetizioni non hanno
altro valore, se non quello di mostrare i punti di continuità fra la prima e la
seconda edizione: molto più importante sarà invece l’analisi delle loro differenze,
presenti sia all’interno del testo, sia nelle note marginali.
Abbiamo riscontrato venticinque casi in cui la lezione di R2 differisce da quella
di R1. Per spiegare l’origine di queste modifiche esistono solo due possibilità: o
sono state inserite volontariamente da parte dell’editore, oppure sono confluite nel
testo indipendentemente dalla sua volontà, a causa di una svista o di qualche altro
errore. Soltanto con un esame autoptico potremo ottenere delle risposte più
concrete. Tendendo a questo fine, presentiamo qualche esempio:
p. 155 lin. 34 – I, 5, 1 (lin. 5) Bythum et Sigen, cum R2 : Bythium et
Sigeneum R1
Entrambi i sostantivi subiscono una variazione in questa seconda edizione:
bisognerà tuttavia dividere la questione in due casi separati. Il primo termine,
omesso nell’apparato del Braun14
, è stato invece discusso dal Kroymann15
:
apprendiamo così che la versione Bythum di R2 rispecchia quella contenuta tanto
in M, quanto in F; ci sembra pertanto di poter affermare che la suddetta lezione
fosse contenuta già in H16
, se non addirittura in θ, e che R1, per qualche motivo, si
discostò. L’ipotetico ritorno di R2 alla lezione di H lascia spazio ad
13 Ricordiamo infatti che, per quanto riguarda l’Adversus Marcionem e gli altri trattati non
contenuti nel Paterniacensis, R1 ed R2 sono stampati sulla base del solo codex Hirsaugiensis
(ramo β del corpus Cluniacense). In R3 si è potuto invece consultare anche il Gorziensis, venendo
così in contatto anche con il ramo α della tradizione. 14 R. Braun, Tertullien, Contre Marcion: Tome I (Livre I), SChr 365 (1990), p. 120. 15
Q. S. F. Tertulliani, Opera, ex recensione Ae. Kroymann, CCSL I (1954), pp. 437-730, p. 446. 16 Purtroppo il Kroymann non teneva in considerazione le lezioni di X, cosa che avrebbe aiutato a
chiarire maggiormente la vicenda.
52
un’interessante interrogativo: il Rhenanus aveva ancora a disposizione i due
volumi dell’Hirsaugiensis, pur dopo la pubblicazione dell’editio princeps? Mentre
il Moreschini vuole confermare questa ipotesi17
, noi, seppur propensi, riteniamo di
non poterci esprimere sulla base di questo unico passo: il Rhenanus potrebbe aver
ritenuto errata la lezione precedentemente pubblicata e la correzione di Bythium in
Bythum potrebbe essere stata pensata come evidente. Il secondo caso vede invece
la contrapposizione di Sigeneum (R1) con Sigen, cum (R2): dall’apparato del
Braun verifichiamo che la prima versione non era contenuta solo nell’editio
princeps, ma anche in M ed in γ. Nel suo secondo lavoro, il nostro editore, non
soddisfatto della precedente lezione, è quindi intervenuto per divinatio: il termine
Sigen è un’evidente grecismo. La lezione proposta dal Braun e da altri editori più
moderni (Sigen, tum) sembra essere la più appropriata.
P. 159 lin. 10 – I, 9, 7 (lin. 45-46) sin de certis R2 : si non de certis R1
La versione di R1 concordava con quella di M e di γ ed è stata poi accolta da R.
Braun nel testo della sua edizione critica18
, dal cui apparato apprendiamo invece
che Moreschini19
e Kroymann20
avevano preferito la lezione di R2 (confluita poi
in R3). Riprendendo l’editio princeps è possibile leggere, ai lati del testo, una nota
critica: Forte, si vero de certis. Come abbiamo visto, nella sua seconda edizione il
Rhenanus rifiuta la precedente congettura e, con buona probabilità, ne introduce
un’altra. Accettando questa ricostruzione, dovremo ammettere di trovarci di fronte
ad un caso nel quale l’editore, pur avendo modificato il testo tramite divinatio,
non ha in alcun modo segnalato l’intervento.
17 Cfr. Cfr. C. Moreschini, Prolegomena ad una futura edizione dell’Adversus Marcionem di
Tertulliano, ASNP II, vol. 36 (1967), pp. 93-102, 236-244. 18 R. Braun, op. cit., p. 140. 19 C. Moreschini, Q. S. F. Tertulliani Adversus Marcionem, “Testi e documenti per lo studio
dell’antichità” 35 (1971). 20 Q. S. F. Tertulliani, Opera, ex recensione Ae. Kroymann, cit., pp. 437-726.
53
P. 160 lin. 15 – I, 11, 3 (lin. 14) falsae R2 : false R1
Il testo di R1 è evidentemente errato: Rhenanus se ne è accorto ed ha corretto il
testo nella sua seconda edizione. La presenza di una variante non è segnalata
nell’apparato critico del Braun.21
P. 162 lin. 17 – I, 13, 5 (lin. 37) Osirin R2 : Osiris R1
Nella prima edizione il nome della dea Osiride era posto al caso nominativo, nella
seconda viene invece ridotto nell’inconsueta forma Osirin. Riteniamo più
probabile pensare che si tratti di un errore, piuttosto che di una congettura.
Tuttavia rimane da capire per quale motivo il Rhenanus decise di adottare la
stessa forma anche nella sua terza edizione (1539).
P. 162 lin. 20 – I, 13, 5 (lin.45) una tetraonis R2 : una tetra pauonis R1
La lezione tetra pauonis sembra piuttosto problematica: a chi dovrebbe essere
ricollegato il termine tetra? L’altra variante è invece frutto di una eccellente
congettura del Rhenanus, puntualmente delucidata nel margine laterale: tetrao,
tetraonis è un sostantivo che indica una particolare razza di uccello. L’editore
ricorda di averne già avuto notizia in Plinio, nella sua Naturalis Historia (10, 22-
29).
P. 162 lin 39 – I, 14, 4 (lin. 25) plane inimicam R2 : plane inimica R1
Il passo in questione è certamente assai oscuro e dibattuto. Il Rhenanus, in tutte e
tre le sue edizioni, cambierà sempre versione: inimica (1521), inimicam (1528) ed
infine inimice (1539). Analizzando l’apparato critico del Braun22
, leggiamo che γ
aveva inimice, mentre M tramandava la lezione inimicae, oggi più comunemente
accettata. Evidentemente in R1 il Rhenanus non era riuscito a leggere chiaramente
il testo di H da cui ricopiava o, più semplicemente, lo aveva considerato errato. In
21 R. Braun, op. cit, p148. 22 ivi., p. 166.
54
ogni caso nella seconda edizione preferisce la lezione inimicam, ponendo quindi il
termine al caso accusativo: così facendo l’aggettivo tende a riferirsi al sostantivo
terram o al successivo matricem. In questo modo si otterrebbe però una leggera
modifica del senso generale del discorso: a nostro giudizio Tertulliano vuole qui
indicare come sua nemica la carne (carnem) e non la terra (terram). Siamo dunque
propensi a ritenere corretta la lezione conservata in M. Ai fini del nostro studio è
comunque importante sottolineare che, ancora una volta, il Rhenanus ha
dimenticato di segnalare al lettore la presenza di un suo nuovo intervento
congetturale.
P. 163 lin. 3 – I, 14, 5 (lin. 29-30) Hypocritam ut apocarteresi R2 :
Hypocrita muta porcartere si R1
La lezione tramandata in γ, e da lì confluita in R1, non doveva aver convinto per
nulla il Rhenanus, il quale aveva già ammesso, in una nota marginale dell’editio
princeps, di aver ragionato molto sul passo in questione. Suggerisce infatti di
leggere muta apocartaresi al posto dell’emblematico muta porcartere: il termine
consigliato – spiega – sarebbe l’errata traslitterazione del verbo greco
αποκαρταρειν, che, tra gli altri significati indicati dall’autore della Suda,
indicherebbe l’azione di “morire per digiuno”. Nella seconda edizione il nostro
filologo giunge a mettere in dubbio, post multas coniecturas, anche il termine
muta: preferisce aggiungere un ut prima dell’ormai appurato apocartaresi e
portare poi all’accusativo il primo termine del periodo (Hypocritam). Sarebbe così
spiegata l’origine della lezione errata: il copista dell’Hirsaugiensis (o addirittura
qualcuno prima di lui), leggendo male la sequenza Hypocritam ut apocartaresi, o
non comprendendone il senso, avrebbe preferito separare la m di Hypocritam,
unirla ad ut ed alla a di aporcartaresi (=muta) e considerare indipendente la
terminazione si dello stesso apocartaresi (praticamente da HypocritaM UT
ApocartareSI si sarebbe passati a leggere Hypocrita MUTA porcartere SI). La
pregevolezza di questa congettura mostra la grande capacità filologica del nostro
55
editore. Il Braun23
preferisce non segnare in apparato l’esistenza della variante
Hypocritam, presente unicamente in R2 (in R3 Rhenanus tornerà a scrivere
Hypocrita).24
P. 163 lin. 22 – I, 15, 3 (lin. 23) aliquis R2 : aliqui R1
Come abbiamo già visto25
, il Rhenanus aveva segnalato nelle sue annotationes la
frequente presenza di questo fenomeno nei testi di Tertulliano. In questa
situazione il nostro editore sceglie la versione che sarebbe più corretta dal punto
di vista della grammatica normativa (aliquis), senza neppure segnalare la modifica
rispetto al testo della sua prima edizione. Nei margini dell’editio princeps
compariva invece la nota aliqui pro aliquis. Anche in questo caso il Braun26
tace.
P. 172 lin. 37 – I, 25, 4 (lin. 4) curabit R2 : curavit R1
Il cambio di un’unica consonante determina tuttavia la modifica del tempo
verbale. Sapendo che M e γ tramandavano concordemente la versione poi
accettata in R1, siamo legittimati a supporre che in R2 il filologo di Sélestat sia
intervenuto tramite divinatio. Osservando il contesto, l’uso del futuro sembra
effettivamente più probabile: in questo modo si creerebbe una costruzione
speculare nelle due proposizioni interrogative quasi adiacenti (Quis volet quod
non concupiscet? […] Quis enim volet quid et concupiscet, et non curabis?).
P. 172 lin. 37 – I, 25, 6 (lin. 38-39) liberaturus: eum R2 : liberaturus, cum
R1
La lezione contenuta in R2 è tramandata in tutta la tradizione manoscritta. Sorge
spontanea una domanda: come può il Rhenanus tornare alla lezione contenuta in
H, scartando invece quella precedentemente scelta nell’editio princeps? Ancora
23 R. Braun, op. cit., p. 166. 24 È invece normale non trovare alcuna indicazione nell’edizione del Kroymann, in quanto egli non
tenne minimamente conto del testo di R2 per la realizzazione del suo lavoro critico. 25 Cfr. supra, cap. 3, par. 2, p. 45. 26 R. Braun, op. cit., p. 170.
56
una volta bisognerà ipotizzare o che il nostro editore abbia congetturato il testo di
R1, fornendo casualmente la stessa lezione di H, oppure che egli avesse ancora a
disposizione il testo dell’antico codice manoscritto.
P. 172 lin. 24 – I, 27, 5 (lin. 32) circi furentis R2 : circumfurentis R1
Anche in questo caso, nell’edizione del Braun non troviamo alcuna segnalazione
che ci informi sulla presenza di due varianti.27
Dall’apparato critico fornito
precedentemente dal Kroymann28
, apprendiamo tuttavia che la lezione di R1 si
differenzia da quella contenuta in F soltanto per una minima questione di spazi
(circum furentis in F e circumfurentis in R1). Pur non conoscendo il testo di X,
siamo autorizzati a credere che la lezione di H fosse del tutto simile a quella di R1
o di F: il Rhenanus, nella sua seconda edizione, avrebbe riconosciuto l’errore
precedentemente accettato ed avrebbe così fornito una nuova lezione, molto più
plausibile. Il probabile intervento congetturale non viene però in alcun modo
segnalato al lettore.
La lunga lista di esempi appena fornita, ci permette di far luce su alcune
caratteristiche del lavoro emendatorio realizzato dal Rhenanus in questa sua
seconda edizione di Tertulliano. Per prima cosa sentiamo la necessità di
sottolineare come il nostro editore, ancora una volta, non si mantenga strettamente
fedele alle originali intenzioni: come sappiamo, il filologo umanista aveva
espresso più di una volta la volontà di commentare o segnalare ogni suo
intervento nel testo, in modo da lasciare libertà di giudizio al lettore. Da quanto
abbiamo potuto vedere, questa volontà non è stata pienamente rispettata: si
segnalano infatti molti casi in cui il Rhenanus sfugge a queste sue dichiarazioni,
inserendo tacitamente alcune modifiche. Inoltre questi cambiamenti si dimostrano
in alcune situazioni intenzionali, vale a dire delle vere e proprie congetture ideate
27 Ivi., p. 232. 28 Q. S. F. Tertulliani, Opera, ex recensione Ae. Kroymann, cit., p. 471.
57
dall’editore, delle quali molte sono per altro di gran valore; in altri casi
l’ambiguità dell’intervento induce a pensare ad un errore di stampa. Prima di
passare all’analisi ed alla trattazione delle note marginali, è bene concludere con
la ripetizione di una domanda alla quale non siamo riusciti a dare una risposta
certa: il Rhenanus, per questa sua seconda edizione, aveva ancora a disposizione il
testo dell’Hirsaugiensis deperditus? Seppur alcuni passi sembrano confermare
questa ipotesi, pensiamo di non poter esprimere un giudizio definitivo sulla base
del solo primo libro dell’Adversus Marcionem.
In uno studio basato unicamente sull’Adversus Hermogenem29
, F. Chapot ha
dimostrato che, fra le tre edizioni di Tertulliano curate dal Rhenanus, la seconda è
quella che contiene il più alto numero di note marginali. Nel nostro caso,
considerando soltanto il primo libro dell’Adversus Marcionem, basta sfogliare
velocemente il testo per rendersi conto quanto sia più ampio, rispetto alla prima
edizione, il complesso delle annotazioni marginali: per l’esattezza abbiamo
contato trentotto note contenute in R1 e almeno settantotto presenti in R2 (salgono
invece a ottantanove quelle appartenenti ad R3). Di queste settantotto note,
soltanto ventinove sono utilizzate dall’editore per indicare una variante o
comunque un problema relativo alla critica del testo30
; le altre, che sono quindi in
netta maggioranza, tendono principalmente ad attrarre l’attenzione del lettore su
un concetto importante, a chiarire il significato di una parola o di un’intera frase,
ad indicare la presenza di un detto proverbiale e, in definitiva, a fornire il maggior
numero di notizie utili a migliorare la comprensione del testo. In effetti, i dati di
questa statistica ben testimoniano il grande sforzo compiuto dal Rhenanus nel
rendere più chiaro un testo veramente molto arduo, reso faticoso non solo dalle
numerose corruttele, ma anche dall’artificiosità tipica dello stile di Tertulliano.
Tuttavia, per meglio valutare la qualità del lavoro strettamente filologico del
nostro editore, sarà bene soffermarsi principalmente su quelle note che
29 F. Chapot, Dans l’officine d’un philologue. Beatus Rhenanus éditeur de l’Adu. Hermogenem de
Tertullien (Bâle 1521, 1528, 1529), “Beatus Rhenanus (1485-1547). Lecteur et editeur des textes
anciens“ (2000), pp. 263-283, p. 266. 30 Quindici sono invece quelle contenute in R1.
58
contengono indicazioni relative alla critica testuale. Nel proporre una selezione di
queste ventotto annotazioni, preferiamo concentrarci su quelle che sono state
inserite ex novo, evitando quindi di riprendere quelle già presenti nei fogli
dell’editio princeps31
o le altre precedentemente esposte nelle annotationes
iniziali:
p. 153 mg. lin. 2 – I, 1, 3 (lin.25) livens humus coni. R2 : libens, unus R2
Nel testo della seconda edizione troviamo dapprima il termine libens, che va
ricollegato al precedente raggruppamento sol nunquam; poi l’aggettivo numerale
unus, che è invece da unire al successivo aër. Il Rhenanus, non convinto, ipotizza
una diversa costruzione: ritiene di poter considerare indipendente il gruppo sol
nunquam e propone di leggere livens humus (= terra scura) al posto del precedente
libens, unus (tra l’altro tramandato in maniera concorde dall’intera tradizione
manoscritta). Giustifica questa ipotesi ricordando che Virgilio aveva utilizzato
nell’Eneide (6, 320) la forma vada livida (= onde oscure). Nel testo della sua terza
edizione il nostro editore riproporrà la lezione libens, unus.
P. 153 mg. lin. 17 – I, 1, 6 (lin. 45) fort. illi R2 : illis R2
Tutti i manoscritti in nostro possesso conservano la lezione illis ed anche il
Rhenanus la pone nel testo dei suoi tre lavori su Tertulliano. Tuttavia la lezione è
evidentemente corrotta: nel contesto in cui è situata essa si riferisce
necessariamente al termine discipuli, ma come poteva Marcione avere dei propri
discepoli prima della sua rottura con la Chiesa? Il Rhenanus deve aver pensato ciò
nel consigliare al lettore la versione illi (mentre in R3 torna a scrivere illis volendo
probabilmente rispettare l’autorità del codex Gorziensis). Anche il Braun, e per le
stesse ragioni, preferisce questa stessa variante32
.
31 Riguardo a queste annotazioni abbiamo già fatto un accenno (cfr. cap. 3, p.46). 32 R. Braun, op. cit., p. 105, 252.
59
P. 153 mg. lin. 26 – I, 2, 1 (lin. 1) fort. Ponticus Marcion coni. R2 : Duos
Ponticos R2
Nel margine di R2 Rhenanus propone correttamente la lezione Ponticus: il
termine, precedentemente presentato all’accusativo e ricollegato ai duos deos,
svolge ora la funzione di soggetto. “Colui che proviene dal Ponto” è un chiaro
riferimento a Marcione, tuttavia l’inserimento del sostantivo Marcion, proposto
anch’esso dal nostro editore, sembra essere eccessivo: in R3 accetterà infatti la
semplice formula Duos Ponticus (in seguito accolta tanto dal Kroymann33
, quanto
dal Braun34
).
P 154 mg. lin. 3 – I, 2, 3 (lin.22) forte acore coni. R2 : acrore R2
Dalle note critiche contenute nell’edizione del Braun35
, apprendiamo che il
termine acror è una voce tipica del linguaggio popolare, usata in sostituzione di
acor. Nel contesto familiare in cui il termine è utilizzato, Tertulliano potrebbe
aver preferito questa versione quotidiana per aumentare il sarcasmo
dell’immagine (“con quel poco di lievito così ricavato fece andar a male con
l’acido dell’eresia tutta la massa della fede”). Rhenanus, magari ignorando
quest’uso popolare, suggeriva di riportare la parola nella sua forma più
tradizionale (e in R3 troveremo proprio questa versione).
P. 158 mg. lin. 2 – I, 8, 1 (lin. 4) fort. mox ob vanam coni. R2 : mox vanam
R2
A nostro giudizio il Rhenanus ha colto pienamente il senso della frase, che sembra
voler dire: “i fanciulli, a causa della loro vanagloria, saranno picchiati dal vecchio
pedagogo”. Dal punto di vista grammaticale sarebbe quindi corretto inserire la
preposizione ob che, retta dall’accusativo, introduce il complemento di causa
33 Q. S. F. Tertulliani, Opera, ex recensione Ae. Kroymann, cit., p. 442. 34 R. Braun, op. cit., p. 106, 252. 35 ivi, p. 108.
60
esterna. La concorde trasmissione in tutta la tradizione manoscritta della versione
priva di questa preposizione deve aver convinto il Rhenanus a mantenere, in tutte
le tre edizioni, la stessa forma.
P. 158 mg. lin. 10 – I, 8, 2 (lin. 15) fort. quin coni. R2 : quia R2
Non comprendiamo su quale base il Rhenanus ritenga necessario compiere questo
intervento, dal momento che la tradizione manoscritta conserva esclusivamente la
lezione quia, la quale, per giunta, non entra in conflitto con il senso della frase.
P. 162 mg. lin. 17 – I, 13, 5 (lin. 40) leones inire coni. R2 : leones mire R2
Il filologo di Sélestat, appellandosi alla sua vasta erudizione, elabora una
congettura davvero lodevole, che però verrà inficiata a partire da R3 (determinante
sarà l’apporto del Gorziensis). Ritenendo depravata la lezione che aveva ricopiato
dall’Hirsaugiensis, il Rhenanus sostiene, in questa sua seconda edizione, che sia
preferibile leggere leones inire: intendeva con questo far riferimento alla dea
Cibele, Magna Mater, la quale spesso, nei racconti dei poeti, veniva rappresentata
seduta su di un carro trasportato proprio da leoni. Il Braun non ha segnalato questa
variante.
P. 168 mg. lin. 21 – I, 22, 1 (lin.1) fort. evertetur coni. R2 : eventetur R2
La forma eventetur deve essere stata considerata errata dal Rhenanus: la proposta
avanzata nel margine di R2 sarà accettata poi nel testo di R3. Effettivamente la
sostituzione con evertetur sarebbe accettabile sia considerando il senso del
periodo, sia dal punto di vista filologico: basterebbe infatti aver errato durante la
lettura, confondendo una r per una n. Quello che è difficile ammettere è che tanto
M, quanto γ, indipendenti gli uni dagli altri, siano caduti contemporaneamente
nello stesso errore. Il Braun36
potrebbe aver risolto il problema: egli sostiene che
eventare sia un verbo piuttosto raro che dovrebbe significare “ridurre in vapore”
36 ivi., p. 200, 274.
61
(vaporando minuere); in questo caso il suo impiego potrebbe essere giustificato
con un richiamo satirico all’immagine dell’aura canicularis precedentemente
evocata (I, 19, 2).
P. 169 mg. lin 5 – I, 22, 6 (lin.42) forte quae se ita coni. R2 : quae si ita R2
Nel testo di R1 e poi di R2 troviamo la particella ipotetica si, che conferisce al
periodo un valore ipotetico. Nella seconda edizione, il Rhenanus suggerisce però
di sostituire si con il pronome riflessivo se. Questa soluzione entrerà poi nel testo
di R3. Purtroppo né il Kroymann, né il Braun hanno segnalato questa modifica
nelle loro edizioni.
P. 175 mg. lin. 20 – I, 28, 4 (lin. 33) fort. rependens coni. R2 : reprehendens
R2
In questo passo Rhenanus non è convinto della correttezza del participio
reprehendens. Progetta pertanto una lungimirante congettura: il termine
reprehendens potrebbe essersi corrotto a partire da rependens. Questa ipotesi,
avanzata in un primo momento per migliorare il senso del discorso, si è dimostrata
poi molto attendibile, essendo venuta a coincidere con la lezione trasmessa dal
Montepessulanus, il codice sicuramente più autorevole. Non è un caso se il
Rhenanus introdurrà nel testo della sua terza edizione proprio questa variante.
Gli esempi fin qui forniti sono già ampiamente sufficienti per trarre alcune
conclusioni, relative al ruolo e al valore delle congetture marginali. Due sono gli
aspetti che colpiscono maggiormente: la grande erudizione del nostro editore,
della quale abbiamo assaporato soltanto alcuni assaggi, e la sua formidabile
capacità critica. Certo, non tutte le alternative proposte dal Rhenanus in questa sua
seconda edizione saranno confermate nel corso del tempo, ma la grande
attenzione con cui ha lavorato sul testo gli ha impedito di teorizzare congetture
che non fossero in qualche modo giustificabili. Il solo fatto che molti di questi
62
interventi ope ingenii confluiranno addirittura nel testo di R3, dimostra
l’eccezionale perizia raggiunta nel campo filologico dall’umanista di Sélestat.
Da un’analisi più generale, risulterà evidente come in questa edizione del
1528, avendo già alle spalle numerosi ed importanti lavori, il Rhenanus si dimostri
ormai un critico pienamente maturo. Il notevole ampliamento del sistema delle
annotazioni riflette il suo ardente desiderio di migliorare il precedente lavoro su
Tertulliano; l’attenzione al testo dei trattati viene incrementata con lo studio più
approfondito delle consuetudini stilistiche e linguistiche dell’autore; l’intervento
congetturale, sempre rispettoso del contesto e della lingua del Cartaginese, diventa
ancora più attendibile. Vi sono però anche degli aspetti negativi che meritano di
essere indagati e che rendono il suo metodo critico ancora piuttosto distante dagli
ideali di totale chiarezza e precisione ansiosamente perseguiti: nonostante nei suoi
discorsi programmatici si faccia ripetutamente appello alla necessità di rimanere
fedeli all’autorità conferita ai testimoni manoscritti, egli spesso interviene
arbitrariamente nel testo, decidendo di ignorare la lezione contenuta nel
manoscritto e magari tralasciando persino di segnalare questa nuova introduzione.
Tuttavia, in un tempo in cui la critica testuale era ancora particolarmente
caratterizzata dall’assenza di una precisa normativa alla quale attenersi, il
tentativo effettuato dal Rhenanus di illustrare dettagliatamente qualsiasi intervento
realizzato, doveva risultare un elemento fortemente innovativo.
63
Capitolo quarto
La terza edizione di Tertulliano: un nuovo testimone
In quest’ultimo capitolo si cercherà di offrire una completa analisi della terza
edizione delle opere di Tertulliano, curata nuovamente dal Rhenanus e pubblicata
a Basilea nel 1539. Seguendo uno schema già collaudato, il capitolo si dividerà in
due parti: nella prima sezione, dopo aver presentato le motivazioni che spinsero
l’editore ad intraprendere un nuovo lavoro, viene offerta una breve descrizione
della struttura dell’edizione; nella seconda parte si cerca invece di analizzare il
metodo critico adottato dal Rhenanus, cercando di evidenziarne gli aspetti
positivi, ma anche quelli negativi. Fondamentale, per questa nuova edizione, è
l’apporto di un nuovo testimone che, come vedremo, conteneva alcune lezioni
derivate dal codex Gorziensis.
4.1 La collatio Gorziensis: la base per una nuova pubblicazione
Expectabam avide ex Mediomatrici Gorziensem codicem […] sed frustra1. Nel
presentare la sua seconda edizione, il Rhenanus esprimeva con queste parole tutto
il suo rammarico: ancora una volta non era riuscito infatti a consultare quel
manoscritto, che sapeva conservato nel monastero di Gorze e di cui aveva notizia
ormai da molto tempo. Già nella parte finale della lettera indirizzata al vescovo
Stanislao (1521), manifestava la speranza di poter in futuro visionare alcuni codici
contenenti le opere di Tertulliano e dispersi in diverse località d’Europa: fra
questi, per l’appunto, anche la copia exemplaris, quod in Gorziensi coenobio
servatur, id abest ad tertium miliarium ab urbe Mediomatricum2.
Dopo alcuni anni d’attesa, nel 1527 sembrava essersi finalmente presentata la
giusta occasione: il tipografo Froben era entrato in contatto con il giurista e
umanista Claudius Cantiuncula (Claude Chansonette), al quale aveva chiesto una
1 Cfr. supra, cap. 3, p. 40; Opera Tertulliani (1528), p. 403, Adversus Valentinianos. 2 A. Horawitz, K. Hartfelder, Briefwechsel des Beatus Rhenanus, Reihneim 1966 [1886], p. 288.
64
copia o una collazione del codex Gorziensis.3 Sembra che Chansonette iniziò
presto a lavorare su questo progetto ma, per un motivo che ancora ignoriamo, non
riuscì a completarlo in tempo per la realizzazione dell’edizione del 1528. Non
sappiamo in quale data il filologo di Sélestat ebbe a disposizione i risultati del
lavoro di Chansonette, quello che è certo è che l’attesa, seppur molto lunga, venne
ampiamente ripagata: nel marzo del 1539 il Rhenanus si vedeva infatti costretto a
pubblicare una nuova edizione delle opere di Tertulliano. Dopo quasi venti anni le
sue preghiere erano state finalmente esaudite: come aveva giustamente previsto, la
consultazione di un nuovo testimone rese possibile l’aggiunta di numerosi
interventi e il raggiungimento di indubitabili miglioramenti.
Ancora una volta il Rhenanus affida alla lettera prefatoria (molto breve in
questa edizione) la funzione di svelare le cause e di illustrare gli eventi che hanno
reso possibile la realizzazione del suo nuovo sforzo emendatorio, nonché le
modifiche e i risultati conseguiti. Scopriamo così che egli aveva ottenuto soltanto
una collazione del codex Gorziensis: realizzata dal monaco Hubertus Custineus
con l’aiuto dello stesso Chansonette e di un certo Dominicus Florentinus, essa
venne trascritta su un esemplare dell’edizione a stampa del 1528.4 Il filologo
umanista ammette poi che un grande miglioramento si è innegabilmente ottenuto
con il riconoscimento della tendenza, molto comune in Tertulliano, di latinizzare
non solo parole, ma anche costruzioni ed intere frasi idiomatiche appartenenti alla
lingua greca: il Cartaginese aveva evidentemente letto e consultato l’opera di
molti autori greci, soprattutto cristiani e, tra questi, sicuramente Ireneo. Al termine
della lettera, il Rhenanus ci informa che al momento della stampa non si trovava
personalmente a Basilea e che quindi fu Sigismundus Gelenius, homo magni in
literis iudicii et eruditione summa praeditus, a supervisionare la preparazione
dell’edizione.
3 J. F. D’Amico, Theory and Practice in Renaissance Textual Criticism: Beatus Rhenanus Between
Conjecture and History, Berkeley 1988, p. 136. 4 Di questo manoscritto siamo ancora in possesso: esso è conservato nella Bibliothèque Humaniste
di Sélestat (K 1040). Cfr. P. Petitmengin, Beatus Rhenanus et les manuscrits latin, AABS 35
(1985), pp. 245-247, p. 246.
65
Il materiale contenuto nella collazione proveniente da Gorze permise al
Rhenanus di revisionare il testo dei lavori precedenti, di ampliare e di espandere il
complesso delle annotazioni (tanto di quelle marginali, quanto di quelle premesse
al testo) e di chiarire infine numerosi passi oscuri, che finora erano rimasti sempre
piuttosto ambigui. Ancora una volta viene prestata molta attenzione alla lingua e
all’usus scribendi di Tertulliano: l’elegantia africana, tipica del suo stile, era stata
sempre più studiata ed apprezzata dall’editore umanista nel corso degli anni. Il
Rhenanus è ormai in grado di cogliere e di evidenziare numerose peculiarità
linguistiche caratteristiche del latino del Cartaginese, come la preferenza per un
lessico arcaico, la presenza di idiomi volgari, soprattutto greci. Il filologo
umanista è però consapevole che Tertulliano fu anche un grande innovatore, tanto
dal punto di vista linguistico, quanto nei confronti dei contenuti: anche se la
dipendenza dai primi autori cristiani di lingua greca è piuttosto evidente, egli non
si limitò mai a ricopiare meccanicamente un termine o un concetto, ma, nel
riportarli in latino, ha sempre contribuito a personalizzarne la forma ed il
significato. Se nelle prime due edizioni lo stile di Tertulliano veniva presentato
come oscuro, duro e ostile, ora Rhenanus preferisce parlare di un solennis mos
loquendi5
. Questa miglior conoscenza delle consuetudini linguistiche del
Cartaginese garantì, per riflesso, anche una più ampia consultazione, da parte del
Rhenanus, delle fonti utilizzate dallo stesso autore: diventava così sempre più
approfondito anche lo studio dei costumi del Cristianesimo e della Chiesa delle
origini.
Rinnovata e fortemente migliorata risulta anche la struttura dell’edizione, che
tende, in ogni suo aspetto, a raggiungere una maggior chiarezza ed omogeneità.
Benché sia ribadita la preferenza per le note poste in margine6, il sistema già
sperimentato nella seconda edizione non viene solo riproposto, ma anche
notevolmente rafforzato: ciascun trattato è ora preceduto da un argomentum, cioè
5 Opera Tertulliani (1539) p. 383, Adversus Hermogenes. 6 ivi, p. 380, Adversus Hermogenes: Maluissemus nostras coniecturas in marginibus chartarum
apponere, sed cum longiscule essent, non est visa sufficere exiguitas spatii brevioris.
66
una sorta di breve riassunto dei contenuti, e da una sezione indipendente di
annotationes7, nelle quali l’editore concentra le sue principali segnalazioni al
lettore. Rispetto alle edizioni precedenti, un’altra importante aggiunta è
sicuramente costituita dalla raccolta dei proverbia che più ricorrono nei trattati di
Tertulliano; questa nuova sezione è situata subito dopo la lettera prefatoria8.
Nonostante questi innegabili miglioramenti, permangono ancora diversi aspetti
ambigui, in special modo nei riguardi del metodo critico adottato dal Rhenanus. Si
pensi, ad esempio, all’eccessiva fiducia che pone nei confronti del documento
proveniente da Gorze: si tratta infatti di una semplice collazione e non di un vero
codice manoscritto. Il Rhenanus sembra invece non tener minimamente conto di
questa considerazione, fidandosi infatti ciecamente del lavoro di confronto
realizzato per lui dal monaco Custine e dagli altri suoi collaboratori (mentre non
sarebbe affatto infondato ipotizzare che, almeno in qualche punto, il testo della
loro collazione possa non coincidere con quello effettivo del Gorziensis). 9
Altre considerazioni sul lavoro critico del Rhenanus e sul suo metodo
emendatorio potranno essere tratte soltanto dopo un’attenta lettura dei testi
dell’edizione, analizzando in particolar modo il ruolo dei testimoni manoscritti e
quello attribuito agli interventi congetturali.
4.2 La fine di un lavoro ventennale: le ultime modifiche al primo libro
dell’Adversus Marcionem
Dopo quasi venti anni di ricerche, il Rhenanus aveva finalmente la possibilità
di leggere un nuovo documento che conteneva alcune opere di Tertulliano. Ai
testimoni precedentemente consultati, il Paterniacensis e l’Hirsaugiensis, si
7 Maggiori informazioni verranno fornite nel paragrafo successivo. 8 Opera Tertulliani (1539) p. a * 3 v. 9 Sarà importante notare che il Rhenanus, nel far riferimento al nuovo testimone, si mostra spesso
davvero poco preciso: in alcuni casi parla di lezioni provenienti ex collatione Gorziensis, ex
castigatiuncolis Gorziensis, ex Gorziensibus adnotamentis o ex annotatiuncolis Gorziensibus. In
altre circostanze accenna ad un Gorziense exemplar, ma si tratta di un errore: come sappiamo,
l’editore non aveva a disposizione il testo del manoscritto, ma soltanto una sua collazione.
67
aggiungeva ora la collazione del manoscritto conservato nel monastero di Gorze:
seppur non si trattasse del codice originale, le informazioni in esso contenute
erano comunque sufficienti per giustificare nuovi interventi e svariate modifiche.
Il Rhenanus non poteva certo comprendere a pieno l’enorme importanza di
questa sua nuova acquisizione: inconsapevolmente e per la prima volta aveva
riunito i due rami della collezione Cluniacense. Oggi sappiamo infatti che il codex
Gorziensis, attualmente perduto, faceva parte del ramo α della famiglia originata
dai due volume provenienti da Cluny: si è addirittura propensi a credere che possa
trattarsi di una copia diretta del Montepessulanus, il più autorevole fra tutti i
manoscritti della collezione.10
Tornando al Rhenanus, nel caso dell’Adversus Marcionem, era ormai possibile
fare affidamento su due diverse tipologie di documenti: l’editore aveva da una
parte le sue antiche edizioni (1521, 1528), costruite sulla base del codex
Hirsaugiensis; dall’altra la nuova collatio, fondata sul manoscritto di Gorze.
Basterà leggere il complesso delle annotazioni e analizzare con accortezza il testo,
per rendersi conto quanto ampiamente il Rhenanus abbia utilizzato il materiale
proveniente dal Gorziensis: l’editore corregge alcune vecchie lezioni, integra
diversi passi e ne illustra molti altri sulla base di questo recente documento, la cui
autorità è reputata dunque maggiore rispetto a quella dell’Hirsaugiensis. Questa
scelta, che certo non stupirebbe il moderno editore, è alquanto ingiustificata nel
caso del Rhenanus: come poteva il filologo umanista preferire un manoscritto ad
un altro, non conoscendo affatto la ramificazione della tradizione? Quella che
potrebbe sembrare una sterile e banale argomentazione, si dimostra invece
rivelatrice di un’importante lacuna nel metodo critico del Rhenanus: l’editore
umanista, pur non accontentandosi di un'unica fonte, corregge il testo ricorrendo
in modo acritico e arbitrario ai suoi testimoni. In altre parole, egli non giustifica le
10 Per la collocazione del Gorziensis nel primo ramo della famiglia Cluniacense si veda: J. -C.
Fredouille, Tertullien, Contre les Valentiniens: Tome I, SChr 280, Paris 1980, pp. 56-58; per la
derivazione di G da M si veda anche: F. Chapot, Dans l’officine d’un philologue. Beatus Rhenanus
éditeur de l’Adu. Hermogenem de Tertullien ( Bâle 1521, 1528, 1539), “Beatus Rhenanus (1485-
1547). Lecteur et éditeur des textes anciens” (2000), pp 263-283.
68
motivazioni che lo spingono a scegliere le lezioni di G, rispetto a quelle derivate
da H: questo fatto, che testimonia l’assenza di un metodo sistematico nella fase di
confronto tra le fonti, era più che consueto in ambito filologico, almeno fino
all’introduzione del moderno metodo stemmatico. Se da una parte, con la mente
rivolta al presente, non abbiamo potuto fare a meno di sottolineare questa
mancanza, dall’altra sentiamo dunque il dovere di contestualizzare la vicenda:
sbaglieremmo infatti se volessimo valutare l’operato del Rhenanus alla luce delle
più recenti tecniche filologiche; al contrario, calandoci nel tempo in cui l’umanista
si trovò a lavorare, dovremmo certo convenire di trovarci di fronte ad uno dei più
abili ed innovatori filologi del XVI secolo. Quando incitava i suoi contemporanei
a ricercare incessantemente nuovi fonti nelle varie biblioteche, oppure quando li
invitava a prestare grande attenzione alle lezioni dei manoscritti, in tutti questi
casi stava stabilendo un principio di carattere generale, valido per tutti gli autori e
per tutti i tempi. La critica testuale, come tutte le tecniche umane, ha dovuto
seguire un percorso particolare prima di giungere al suo stato attuale: il rigore di
oggi non sarebbe stato possibile senza il lavoro di questi antichi editori.
Tuttavia, iudicium ed ingenium hanno ancora un ruolo importante nel metodo
del Rhenanus: in più di un’occasione egli preferisce non accettare nessuna delle
varianti tramandate dai manoscritti, proponendo invece alcune soluzioni personali.
Nonostante egli dichiari esplicitamente che sia suo costume maneggiare con
grande scrupolo i testi degli antichi11
, il ricorso a correzioni ottenute per via
congetturale è ancora ampiamente testimoniato. Se in alcuni casi è lo stesso
editore a sottolineare (e poi anche a giustificare) la presenza di una emendatio ope
ingenii, in molte altre situazioni non riusciamo a stabilire se la variante segnalata
nelle annotazioni alluda alla lezione contenuta nella collazione del Gorziensis, o
se invece debba essere considerata frutto di una ricostruzione arbitraria. In queste
circostanze neanche la consultazione di M potrà venire in nostro aiuto: essendo
11 Opera Tertulliani (1539), p. 439, Adversus Valentinanos: Scio religiose versandum esse in
monimentis veterum autorum nec temere aut statim inutandum [sic] quod non intelligas, et hic
meus est mos.
69
perduto il testo di G, potremmo avanzare soltanto delle ipotesi. Nei casi in cui la
lezione di R3 coincide con quella di M, si potrebbe pensare, ad esempio, che essa
sia entrata nel testo perché già contenuta nella collazione del Gorziensis. Così
facendo ci addentreremmo però in un campo puramente teorico, perché la
coincidenza potrebbe avere un’origine casuale12
e sarà bene, dunque, procedere
cautamente per questa via. Rimane un’unica certezza: il testo di G, fatta eccezione
per le lezioni entrate in R3 e segnalate dal Rhenanus 13
, è ormai irrimediabilmente
perduto.
Tutte queste considerazioni possono essere dedotte semplicemente leggendo
con attenzione le annotationes premesse al testo dei vari trattati, vale a dire quegli
spazi nei quali l’editore concentra principalmente le sue segnalazioni al lettore. In
queste sezioni il Rhenanus presenta le varianti trasmesse dalle fonti, ma anche le
sue personali congetture; fornisce vari elementi utili per chiarire passi, allusioni o
concetti piuttosto oscuri e di difficile comprensione; giustifica le modifiche e le
aggiunte che si è visto costretto ad inserire; segnala, infine, quelle particolarità
linguistiche e stilistiche che si incontrano nel testo. Per riflesso, appare molto
ridimensionato il ruolo delle note marginali, seppure il loro numero sia
tendenzialmente ancora molto alto. Nel caso del primo libro dell’Adversus
Marcionem, su un totale di ottantanove annotazioni marginali14
, soltanto due
hanno carattere filologico (p. 172 mg. lin. 16; p. 175 mg. lin. 20); tutte le altre
svolgono invece la semplice funzione di richiamare l’attenzione del lettore su
alcuni aspetti particolari, i quali, nella maggior parte dei casi, sono stati
precedentemente trattati proprio nella sezione dedicata esclusivamente a contenere
i commenti critici dell’editore.
Presentiamo ora una serie di lezioni che, per differenti motivazioni, sono state
discusse all’interno delle annotationes premesse al testo del primo libro
12 Il Rhenanus, congetturando, potrebbe aver scelto una lezione casualmente identica a quella
contenuta in M. 13 Anche questo caso è, in realtà, tutto da verificare. Ricordiamo infatti che il Rhenanus non ha
accesso diretto al testo del Gorziensis, ma lo conosce solo per mezzo di una collazione di cui non
ha potuto valutare l’effettiva correttezza. 14 Contro le settantotto della seconda edizione e le trentotto della prima.
70
dell’Adversus Marcionem15
: soltanto in questo modo, fornendo cioè degli esempi
concreti, potremo confermare quanto finora detto sul metodo critico adottato dal
Rhenanus in questa terza edizione di Tertulliano:16
p. 164 lin. 10 – I, 1, 3 (lin. 12) natura R3 : om. R1 R2
Il termine natura viene inserito per la prima volta nella terza edizione, ex
Gorziensibus adnotamentis. Il Braun preferisce non annotare la questione nel suo
apparato critico17
, mentre Kroymann18
segnalava che l’omissione era presente
soltanto in R1 (non teneva infatti conto del testo di R2). Se questo fosse
confermato, come si potrebbe giustificare il fatto? Il Rhenanus, nelle prime due
edizioni, aveva omesso volontariamente il termine o si era trattato di un semplice
errore di stampa?
P. 165 lin. 19 – I, 1, 5 (lin. 38) barbariae coni. R2 unde R3 : barbariei M
R1 R2
Come aveva già suggerito nelle annotazioni della seconda edizione19
, l’editore
propone di leggere barbariae al posto della lezione barbariei, presente in R1 e in
R2. Sostiene questa scelta affermando che poco prima (I, 1, 3 lin. 15) Tertulliano
aveva utilizzato lo stesso termine, nella stessa identica forma. È interessante
notare che la lezione contenuta nelle prime due edizioni è testimoniata anche in
M: qual’era, dunque, il testo di G? Se fosse stato uguale a quello di M (e quindi a
quello di R1 R2), allora il Rhenanus avrebbe ora introdotto una sua congettura (tra
l’altro già testimoniata in R2); nell’altro caso, con G diverso da M, saremmo nel
15 Opera Tertulliani (1539), pp. 161-164. 16 Tutti i richiami al testo che sono forniti di seguito fanno riferimento alla posizione che occupa il
passo in questione nel testo della terza edizione del Rhenanus ed in quello della recente
pubblicazione del Braun (R. Braun, Tertullien, Contre Marcion: Tome I (livre I), SChr 365, Paris
1990; i commenti dell’editore, come già annunciato (cfr. nota 16), sono concentrati nella sezione
delle annotationes che precede il primo libro dell’Adversus Marcionem. 17 R. Braun, op. cit., p. 100. 18 Q. S. F. Tertulliani, Opera, ex recensione Ae. Kroymann, C.C.S.L., vol. 1 (1954), p. 441. 19 Cfr. supra, cap 3, p. 45.
71
campo delle infinite possibilità. La nostra opinione è che siamo di fronte ad un
caso di emendatio ope ingenii.
P. 167 lin. 25 – I, 4, 5 (lin. 26) si minutalibus M G R3 : si in minutalibus
R1 R2
L’editore dichiara chiaramente di aver eliminato la preposizione in, non essendo
infatti presente nel testo della collazione del Gorziensis. Questa scelta ci permette
di capire che il Rhenanus ha attributo alla sua nuova fonte una maggiore autorità,
senza giustificare tuttavia questa disparità di giudizio.
P. 168 lin. 3-4 – I, 5, 2 (lin. 10) post M G R3 : potest R1 R2 γ
Si tratta di un caso da segnalare, poiché, nel motivare la scelta, l’editore scrive:
reposuimus ex Gorziensi. La terminologia utilizzata è piuttosto ambigua:
sappiamo infatti che egli consultò soltanto una collazione del Gorziensis, non il
manoscritto stesso, come invece verrebbe da pensare leggendo queste parole.
P. 169 lin. 6 – I, 6, 4 (lin. 32) es M R3 : est R1 R2
L‘editore sostiene di aver preferito (malim) la forma es al posto della lezione est
precedentemente accettata. È una spiegazione poco chiara: ha desunto la nuova
lezione dalla collazione di G, oppure è il risultato di una sua valida congettura?
P. 169 lin. 8 – I, 7, 1 (lin. 2) passiuo R
Si tratta di una nota puramente informativa. Viene ribadito quanto già affermato
nella seconda edizione: il termine passiuum, utilizzato con l’accezione di
“comune” o “promiscuo”, sarebbe derivato dall’avverbio passim.20
P. 169 lin. 29 – I, 7, 5 (lin. 30) quia R3 : quia qui M γ R1 R2
20 Ibid.
72
A proposito di questo passo il Rhenanus scrive: qui videtur supervacaneum, senza
offrire ulteriori spiegazioni. Essendo tanto γ, quanto M concordi, saremmo portati
a credere che si possa trattare di una emendatio ope ingenii, la quale, tra l’altro, è
stata accettata dalla maggior parte degli editori moderni (Kroymann 1954,
Moreschini 1971, Evans 1972, Braun 1990).
P 170 lin. 4 – I, 8, 1 (lin. 4) vanam gloriam R
Sebbene abbia conservato in tutte le tre edizioni la stessa lezione, il Rhenanus, nel
suo secondo lavoro, aveva espresso un dubbio: nella annotazioni marginali aveva
infatti proposto la variante ob vanam gloriam. Nella terza edizione, avendo
probabilmente notato che anche la collazione fondata sul Gorziensis non
segnalava la presenza della preposizione ob, deve essersi arreso all’autorità delle
sue fonti. In compenso dichiara che, in questa espressione, è da considerare
sottointeso il termine secundum.
P. 171 lin. 39 – I, 10, 3 (lin. 18) Iudeorum enim deum, dicunt animae deum
M G R3 : om. γ R1 R2
Nel motivare l’aggiunta di questo periodo, il filologo umanista scrive: ex
Gorziensi (ecco un’altra occasione nella quale il Rhenanus confonde la collazione
del Gorziensis, alla quale aveva accesso, con il Gorziensis stesso, che non riuscì
mai a consultare). La frase in questione doveva essere sfuggita per qualche motivo
al copista dell’Hirsaugiensis, non essendo presente né in γ, né nell’editio
princeps.
P. 172 lin. 3 – I, 10, 4 (lin. 23) intellegetur coni. R2 unde R3 : -gitur M γ
R1 R2
Rhenanus preferisce inserire nel testo di R3 la congettura suggerita già nel
margine di R2. La concordanza di M con γ ci induce a credere che anche G
73
contenesse la lezione intellegitur: l’editore avrebbe dunque agito arbitrariamente,
scavalcando l’autorità dei suoi testimoni.
P. 174 lin. 16 – I, 13, 5 (lin. 40) leones Mithrae R3 : leones inire coni. R2
leones mire R1 leones Mitrae M
Nella seconda edizione il Rhenanus aveva pensato di correggere mire con inire,
facendo riferimento all’immagine con la quale veniva spesso rappresentata la dea
Cibele.21
Il testo della nuova testimonianza desunta dal Gorziensis lo induce ora a
rinunciare alla sua antica congettura e a modificare quindi mire in Mithrae. In
questo caso, la grande erudizione dell’editore lo aveva condotto fuori strada.
P. 174 lin. 20 – I, 13, 5 (lin. 45) tetraonis R2 R3 : tetra pauonis M γ R1
Come abbiamo già accennato22
, la problematica lezione tetra pauonis era
conservata in ambedue i rami della collezione di Cluny. Con buona probabilità, il
Rhenanus lesse proprio questa forma nella collazione del Gorziensis: in questo
caso preferì tuttavia dare fiducia alla lezione che aveva già inserito in R2 e che
aveva ottenuto tramite divinatio. Pur opponendosi all’autorità delle fonti, è
comunque riuscito a fornire una variante che è indubbiamente da preferire.
P. 178 lin. 11 – I, 19, 4 (lin. 29) evangelii R3 : om. R1 R2
Dal momento che Braun23
non riporta alcuna notizia in apparato, ci affidiamo
all’edizione del Kroymann24
. Purtroppo, in questo caso, non ci viene offerta
nessuna informazione relativa alla tradizione manoscritta. Nelle annotationes
della terza edizione, il Rhenanus sostiene che il termine evangelii sia stato inserito
ex Gorziensi (ancora un altro esempio di ambiguità terminologica). Sarebbe
21 Cfr. supra, cap 3, p. 55. 22 Cfr. supra, cap 3, p. 48. 23 R. Braun, op. cit., p. 188. 24 Q. S. F. Tertulliani, Opera, ex recensione Ae. Kroymann, cit., p 460.
74
interessante verificare se l’omissione di questa lezione derivi dall’Hirsaugiensis o
se invece sia comparsa per la prima volta nell’editio princeps.
P. 181 lin. 10 – I, 22, 8 (lin. 51) proficiunt M γ coni. R3 : prosiliunt R
prosiliant coni. R3
Nel testo della terza edizione troviamo la stessa lezione presente in R1 e in R2: et
exinde prosiliunt delicta25
. Nelle annotationes l’editore aveva invece suggerito
due varianti: Et exinde prosiliant delicta. Alias proficiunt. La prima proposta
sembra essere ideata sulla base della lezione inserita coerentemente in tutte le tre
edizioni; la seconda merita invece di essere maggiormente analizzata. Che cosa
intende il Rhenanus con il termine alias? Si tratta di un’altra sua congettura o
vuole invece segnalare che quella particolare lezione era presente nelle sue fonti?
Effettivamente, osservando che tanto M, quanto γ contengono proficiunt, siamo
spinti ad ipotizzare che il Rhenanus abbia letto questa lezione già
nell’Hirsaugiensis, ma che non ne sia rimasto così convinto, fino al punto di non
inserirla mai nel testo delle sue edizioni, neanche quando l’avrebbe ritrovata nella
collazione del Gorziensis. Questa teoria, seppur probabile, non può tuttavia essere
dimostrata.
P. 182 lin. 24 – I, 23, 9 (lin. 59) An putem R3 : Non putem R1 R2
Nelle annotationes l’editore scrive At putem: si tratta probabilmente di un
semplice errore di stampa, infatti nel testo della terza edizione troviamo An putem.
In ogni caso, il Rhenanus ha modificato la vecchia lezione (Non putem) presente
in R1 e in R2. Su quale base ha compiuto questo cambiamento? Pensiamo che si
possa trattare di un superfluo intervento congetturale: la negazione non, presente
nella lezione originaria, non crea infatti alcun contrasto col senso del periodo.
25 Cfr. supra, cap. 2, p. 30.
75
P. 184 lin. 37 – I, 25, 4 (lin. 27) Quis volet quod non concupiscet? γ R1 R2
: om. M G R3
Il Rhenanus spiega chiaramente che l’intero periodo non era presente nella
collazione del Gorziensis: per questo motivo lo espunge dal testo della sua terza
edizione. Ma commette un errore: su quale base conferisce maggiore autorità al
suo nuovo testimone? In questa situazione si manifesta chiaramente la divisione in
due rami della collezione Cluniacense.
P. 185 lin. 36 – I, 27, 3 (lin. 16) prae se ferunt M R3 : se praeferunt γ R1 R2
Riferendosi alla lezione se praeferunt contenuta in R1 R2, l’editore commenta:
castigavimus, atque adeo prae se ferunt Marcionitae. Ci informa quindi che nella
sua terza edizione ha effettuato una correzione, portando la vecchia lezione ad una
nuova forma: quello che non spiega è su quale base abbia effettuato tale modifica.
Si tratta di una emendatio ope ingenii o di una emendatio ope codicum?
Per quanto approfondita, l’analisi delle annotazioni inserite dall’editore non
sarà sufficiente per uno studio completo dell’edizione del 1539. Tuttavia,
un’attenta lettura del testo dei vari trattati, unita ad un serrato confronto con le
lezioni contenute nelle due precedenti edizioni, permetterà di esprimere ulteriori
considerazioni, non solo a riguardo del metodo critico adottato dal Rhenanus in
questa terza pubblicazione, ma anche, ad un livello più generale, del suo intero
lavoro filologico sulle opere di Tertulliano: uno sforzo che si protrasse per quasi
un ventennio.
Le lezioni contenute nella terza edizione, almeno per quanto riguarda il primo
libro dell’Adversus Marcionem, possono essere suddivise in tre categorie: quelle
che hanno mantenuto la stessa forma in tutte le tre edizioni; quelle che derivano
dalle congetture elaborate in R2 e, per ultime, quelle che si incontrano per la prima
volta proprio in R3. Sarà bene analizzare separatamente queste diverse situazioni.
76
Riguardo a quelle lezioni che mantengono la stessa forma in tutte le tre
edizioni, abbiamo ben poco da dire. Le uniche degne di nota sono quelle per le
quali il Rhenanus, nella sua seconda edizione, aveva proposto un’alternativa, che
però non fu accettata nella terza. Di queste lezioni, abbiamo trovato soltanto
quattro esempi, che elenchiamo di seguito:
p. 165 lin. 10 – I, 1, 3 (lin. 25) livens humus coni. R2 : libens, unus R θ;
p. 165 lin. 25 – I, 1, 6 (lin. 45) illi coni. R2 : illis R θ;
p. 170 lin. 12 – I, 8, 2 (lin. 15) quin et illum coni. R2 : quia et illum R;
p. 177 lin. 37 – I, 19, 2 (lin. 10) Marcionis insalutaris coni. R2 : salutaris
Marcionis R θ
Cerchiamo di fornire una possibile spiegazione: nell’editio princeps il Rhenanus
avrebbe semplicemente trascritto la lezione che leggeva nell’Hirsaugiensis.
Questa sarebbe stata poi riconfermata nel testo della seconda edizione, nella
quale, però, compariva anche una soluzione alternativa. Nell’ultima edizione
l’editore abbandona l’idea di un intervento congetturale e ripropone
definitivamente la vecchia lezione: la conferma era forse giunta dal confronto con
la collazione del Gorziensis?
Alcune delle numerose congetture elaborate in R226
sono entrate
direttamente nel testo di R3: in tutti questi casi sembra che l’editore abbia
compiuto una scelta arbitraria, preferendo cioè una propria ricostruzione alle
lezioni testimoniate dalle fonti. Infatti, negli esempi che andiamo ad elencare, non
accade mai di trovare M in accordo con R327
:
26 Tanto quelle inserite negli spazi marginali, quanto quelle che invece erano entrate tacitamente
nel testo. Cfr. supra, cap. 3. 27 Come già espresso nelle pp. 64-65, questo procedimento non ci permette di stabilire la reale
lezione del Gorziensis; tuttavia, avanzando per ipotesi, ci sembra più probabile supporre che
questa fosse più vicina alla lezione del Montepessulanus, piuttosto che alla congettura elaborata
successivamente dal Rhenanus.
77
p. 166 lin. 10 – I, 2, 3 (lin. 22) acrore coni. R2 unde R3 : acore R1 M; p. 167 lin.
40 – I, 5, 1 (lin. 5) Bythum et Sigen R2 R3 : Bythium et Sigeneum R1 M γ; p. 171
lin. 12 – I, 9, 7 (lin. 45-46) Sin de certis R2 R3 : Si non de certis R1 M γ; p. 174 lin.
13 – I, 13, 5 (lin. 37) Osirin R2 R3 : Osiris R1 ostris M; p. 177 lin. 39 – I, 19, 2
(lin. 12) aura canicularis coni. R1 coni. R2 unde R3 : aula canicularis R1 R2 M γ;
p. 180 lin. 13 – I, 22, 1 (lin. 1) evertetur coni. R2 unde R3 : eventetur R1 R2 M γ; p.
184 lin. 18 – I, 25, 4 (lin. 29) curabit R2 R3 : curavit R1 M γ; p. 186 lin. 23 – I, 28,
1 (lin. 5) sulphuratiorem coni. R2 unde R3 : sulphurationem R1 R2 M γ.
Fra le numerose lezioni che compaiono per la prima volta in R3, soltanto
alcune sono state discusse dall’editore all’interno delle annotationes; molte altre
non sono state invece minimamente segnalate: un difetto che possiamo definire
quindi costante nel metodo critico del Rhenanus28
. Su queste lezioni tacitamente
modificate possiamo fare poche riflessioni: non conoscendo infatti il testo di G,
non siamo in grado di stabilire se questi cambiamenti siano dovuti a decisioni
arbitrarie dell’editore, o se invece siano entrati nel testo proprio perché contenuti
nella collatio Gorziensis. L’unica possibilità, che come sappiamo non garantisce
alcuna certezza, consiste nel confrontare il testo di M con quello di R329
: se
coincidono, siamo spinti ad ipotizzare una mediazione del Gorziensis; se invece
differiscono, pensiamo che il Rhenanus abbia introdotto una nuova congettura.
Elenchiamo alcuni di questi casi:
p. 165 lin. 5 – I, 1, 3 (lin. 18) indicibus R3 : ut indicibus notentur R1 R2 M γ; p.
165 lin. 5 – I, 1, 3 (lin. 19) ne temere quis R3 : ne quis R1 R2 ne qui M γ; p. 165
lin. 19 – I, 1, 4 (lin. 37) lancinatur R3 : laciniatur R1 R2 M X lacimatur F; p. 170
lin. 6 – I, 8, 1 (lin. 7) ipsa ignorantia R3 : ipsum ignorantia R1 R2 M γ; p. 170 lin.
40 – I, 9, 5 (lin. 30) didicisti R3 M
PC : didicistis R1 R2 M
AC γ; p. 171 lin. 16 – I, 9,
9 (lin. 51) vero R3 M : vere R1 R2; p. 173 lin. 15 – I, 12, 1 (lin. 6) rem ipsam R3 M
: res ipsa R1 R2; p. 178 lin. 35 – I, 20, 3 (lin. 19) suspectam R3 M : susceptam R1
28 Cfr. supra, cap. 2, p. 31; cap. 3, p. 52. 29 Cfr. supra, pp. 64-65, 72.
78
R2 γ; p. 180 lin. 7 – I, 21, 5 (lin. 36) haeretici R3 M : haeretice R1 R2; p. 185 lin.
25 – I, 26, 5 (lin. 44) et boni R3 M : ut boni R1 R2 γ.
Grazie ai dati appena esposti è possibile notare quanto alta sia la frequenza dei
casi di disaccordo tra M e R3: questo fatto sembrerebbe spingerci a supporre che,
ancora in questa terza edizione, l’editore sia intervenuto svariate volte per
divinatio, senza neppure avvertire il lettore.
Al di là di questi aspetti negativi, che sarebbero certo imperdonabili per un
editore moderno, la terza edizione del Rhenanus permise di approfondire la
conoscenza di Tertulliano e di migliorare gli studi filologici in generale. Davanti
ai nostri occhi appare ormai la figura di un filologo davvero molto esperto, abile
nel coniugare la cultura dell’erudito con la sensibilità del critico: anche quando il
prurito congetturale sembra prendere il sopravvento, i suoi interventi non sono
mai avventati, né spregiudicati, cercando di mantenere sempre un certo rispetto
nei confronti delle norme grammaticali, delle consuetudini linguistiche e
stilistiche di Tertulliano, ma anche del contesto storico e culturale.
L’impegno del Rhenanus sui testi del Cartaginese non si esaurì con questa terza
edizione: anche negli ultimi anni della sua vita portò avanti questi studi. Prima di
morire (1547) riuscì infatti ad ottenere e a collazionare un nuovo manoscritto
proveniente da Malmesbury: l’edizione del 1550, curata dal Gelenius, si baserà
proprio su questo suo ultimo lavoro.
79
Conclusioni
La terza edizione di Tertulliano rappresenta il punto d’arrivo della nostra
analisi e della filologia del Rhenanus. Attraverso lo studio di questi suoi lavori,
abbiamo avuto l’occasione di ripercorrere alcune fasi dell’attività critica di uno
dei più noti ed esperti filologi del XVI secolo.
I maggiori risultati di questo nostro studio provengono proprio dall’analisi del
metodo critico appartenuto al Rhenanus: dalle prime esperienze dell’editio
princeps, in cui la grande corruttela delle fonti e le ristrettezze temporali avevano
giocato un ruolo fondamentale, siamo passati ad analizzare la massiccia mole
degli interventi congetturali che caratterizzano l’edizione del 1528. Di qui, siamo
poi giunti all’ultimo lavoro critico, quello del 1539, in cui l’apporto del Gorziensis
ha reso possibile realizzare numerose modifiche, che pure non hanno allontanato
alcuni vecchi difetti. La segnalazione non completa degli interventi realizzati;
l’utilizzo di un linguaggio a volte troppo ambiguo e confusionale; l’arbitrarietà
con cui sceglie tra le diverse varianti o con cui preferisce le sue personali
congetture, sono tutti aspetti che, seppur in diversa misura, si manifestano in
ciascuna delle tre edizioni. D’altra parte, l’ansiosa ricerca di nuovi testimoni; la
tendenza ad ottenere una sempre maggiore chiarezza e precisione; la grande
attenzione prestata alla lingua, allo stile, al contesto storico dell’autore e non solo
al mero dato testuale, rendono assai preziosi i contributi filologici del nostro
umanista.
Risultati più incerti sono stati invece raggiunti sull’altro nostro iniziale intento:
soltanto un’analisi più ampia, che non si basi su un unico libro, potrà verificare se
sia possibile recare ulteriori benefici alla costitutio textus tramite uno studio
approfondito delle tre edizioni del Rhenanus.
80
Abbreviazioni
AABS Annuaire des amis de la Bibliothèque Humaniste de Sélestat.
Sélestat, Soc. d’histoire et de archéologie.
ASNP Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, Cl. di Lettere e
Filosofia. Pisa, Piazza dei Cavalieri.
CCSL Corpus Christianorum Series Latina. Turnholti, Brepols.
CSEL Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum. Vindobonae,
Österreichische Akademie der Wissenschaften.
Mn Mnemosyne. Bibliotheca Classica Batava. Leiden, Brill.
RBen Revue Bénédectine. Abbaye de Maredsous, Belgique.
SAWW Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaft der DDR,
Gesellschaftswissenschaften (G). Berlin, Akademie-Verlag.
SChr Sources Chrétiénnes. Paris, Les Editions du Cerf.
81
Bibliografia citata
In via preliminare, segnaliamo l’edizione moderna alla quale abbiamo fatto
riferimento in tutto il nostro studio:
BRAUN R., Tertullien, Contre Marcion: Tome I (Livre I), SChr 365, Paris 1990.
Di seguito elenchiamo invece tutti gli altri testi consultati:
BORLEFFS J. PH. W., Zur Luxemburger Tertullianhandschrift, Mn III, 2 (1935), p.
299-308.
CHAPOT F., Dans l’officine d’un philologue. Beatus Rhenanus éditeur de l’Adu.
Hermogenem de Tertullien (Bâle 1521, 1528, 1539), “Beatus Rhenanus (1485-
1547). Lecteur er éditeur des textes anciens“ (2000).
- ,Tertullien, Contre Hermogenem, SChr 439, Paris 1999.
CLAESSON G., Index Tertullianeus, Paris 1975.
D’AMICO J., Theory and Practice in Renaissance Textual Criticism: Beatus
Rhenanus Between Conjecture and History, Berkeley 1988.
FREDOUILLE J.-CL., Tertullien, Contre les Valentiniens: Tome I, SChr 280, Paris
1980.
HOPPE H., Sintassi e stile di Tertulliano, Edizione italiana a cura di ALLEGRI
Giuseppina, Brescia 1985 (Syntax und stil des Tertullian, Leipzig 1903).
HORAWITZ A., HARTFELDER K., Briefwechsel des Beatus Rhenanus, Reinheim
1966 [1886].
KLUSMANN M., Excerpta Tertullianea in Isidori Hispalensis Etymologiis,
Hamburg 1892.
82
KROYMANN E., Kritische Vorarbeiten für den III und IV Band der neuen
Tertullian-Ausgabe, SAWW 143, 6 (1900).
LABARDI L., Niccolò Niccoli e la tradizione manoscritta di Tertulliano, “Orpheus”
2 (1981), pp. 380-396.
LAWSON K., The sources of the De ecclesiasticis officiis of Isidore of Seville,
RBen L (1938).
MORESCHINI C., Prolegomena ad una futura edizione dell’Adversus Marcionem di
Tertulliano, ASNP II, vol. 35 (1966), pp. 293-308.
- , Prolegomena ad una futura edizione dell’Adversus Marcionem di
Tertulliano, ASNP II, vol. 36 (1967), pp. 93-102, 236-244.
- , Tertulliani, Adversus Marcionem, “Testi e documenti per lo studio
dell’antichità” 35 (1971).
PETITMENGIN P., Beatus Rhenanus et les manuscrits latin, AABS 35 (1985), pp.
245-247.
- , Tertullien entre la fin du XIIe et le début de XVI
e siecle, in M. Cortesi
(ed.), Padri Greci e Latini a confronto: Atti del Convegno di studi della
Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino, Firenze 2004.
TERTULLIANI Q. S. F., Adversus Hermogenem liber, ed. J. H. Waszink,
Ultraiecti/Antverpiae 1956.
- ,Adversus Iudaeos, Mit Einleitung und kritischem Kommentar
hereausgegeben von H. Tränkle, Wiesbaden 1964.
- , De patientia De baptismo De paenitentia, ed. J. Ph. W. Borleffs, Hagie
Comitis 1948.
- , Opera, Ex recensione Ae. Kroymann, CCSL I (1954), pp.437-730.
- , Opera, Ex recensione Ae. Kroymann, CSEL XXXXVII, pars. III (1906).
83
Sitografia citata
ARMANDI P., Erasmo da Rotterdam e i libri. Storia di una biblioteca,
<http://picus.sns.it/documenti/armandi_ocr.pdf, p. 32>.
Decretum Gelasianum, <http://www.thelatinlibrary.com/decretum.html>.
Ultima consultazione in data 21-10-2013.