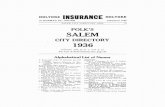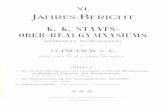Sull'origine di Verrecchie, in Aequa, (XI) 39, ottobre 2009, pp. 30-33
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Sull'origine di Verrecchie, in Aequa, (XI) 39, ottobre 2009, pp. 30-33
AEQUA
Rivista di studi e ricerche sul territorio degli Equi
Anno XI, n. 39, ottobre 2009
Direttoregiuseppe Aldo rossI
Condirettore
Artemio tacchia
Direttore responsabile
luca Verzulli
Collaboratori
gabriele Alessandri, giuseppe Bonifazio, nicola cariello, Pietro
carrozzoni, giuseppe cicolini, Amedeo ciotti, Antonio crialesi,
Antonio d’Angiò, luigi de santis, Andrea del Vescovo, Ivo di
Matteo, Alessandro Fiorillo, Annita garibaldi Jallet, Maria teresa
giovannoni, Aldo Innocenzi, Fabrizio lollobrigida, Vincenzo
Marchionne, Zaccaria Mari, Micaela Merlino, Ilaria Morini, giuseppe
Panimolle, Antonio Proietti, Walter Pulcini, gianfranco ricci,
Antonio roberti, claudio rossi Massimi, Adriano ruggeri, Birgitt
shola starp, Piero sebastiani del grande, Beatrice sforza, Paola
Elisabetta simeoni, Maria sperandio, Boris tacchia, Antonio tantari.
Autorizzazione del tribunale di roma
n. 390/99 del 20/08/99
Contributo editoriale: euro 20; sostenitore, a partire da euro 30, da
versare sul c.c.P. n.17250036 intestato a Associazione “Aequa”,
via Valeria, 62 - 00020 riofreddo (rm).
Indirizzo web: www.aequa.org
Redazione: A. tacchia, via d. Alighieri 11, 00027 roviano (rM)
tel. 0774 903112 e-mail: [email protected]
stampa: Tipografia Fabreschi in subiaco.
la collaborazione alla rivista è assolutamente volontaria e gratuita. gli
articoli e le foto ricevute, anche se non pubblicati, non vengono restitui-
ti. di quanto scritto sono direttamente responsabili i singoli autori.
Per la pubblicità su Aequa, tel. 338 9901793 - 333 1708698
AEQUA
Associazione Culturale
Sede: c/o g. roberti, Via Valeria 62, 00020 riofreddo (rm)
Segreteria: l. Verzulli, via del colle 1, 00020 riofreddo (rM)
tel. 0774 929333 e-mail: [email protected]
Quote associative annuali: soci fondatori, euro 50; soci ordinari
euro 30; soci sostenitori, a partire da euro 30, da versare sul c.c.P.
n. 17250036 intestato all’Associazione “AEQUA”, via Valeria 62,
riofreddo (rm).
Codice Fiscale: 94029830588 - Partita IVA: 05908741001
In copertina:
Chiave di portale appartenente ad
un palazzo signorile di Villa
Romana (Carsoli)
SOMMARIO
Ilaria Morini
Quinto Orazio Flacco e Licenza pag. 3
Paolo Emilio capaldi
Itinerari nella Terra degli Equi: 1 - Da Roma al
“Monte Fontecellese” tra Carsoli e Pereto pag. 7
Vincenzo Marchionne
Celso Folgori, personaggio emblematico di
Roviano tra il XVIII e il XIX secolo pag. 24
Alessandro Fiorillo
Sull’origine di Verrecchie pag. 30
Maria teresa giovannoni
Girolamo Pesci, pittore con radici a Filettino? pag. 34
luca Verzulli e Artemio tacchia
La chiesa della Madonna del Soccorso a Riofreddo
in una notizia inedita (1775-1822) pag. 40
Antonio crialesi
La contrastata costituzione del C.N.L.
di Roviano 1944-45 pag. 52
Walter Pulcini
La chiesa del SS. Salvatore in Arsoli pag. 60
Antonio d’Angiò
1948-1992: le elezioni politiche a Subiaco,
Carsoli, Pescorocchiano e Trevi nel Lazio pag. 64
Antonio tantari
Affile, 250 anni della Madonna del Giglio pag. 69
Mauro Marzolini
L’uccisione e la lavorazione del maiale
a Rocca di Botte pag. 72
James Allen
Roviano nei ricordi di un religioso americano pag. 74
gianfranco ricci
L’asino nei proverbi di Capistrello pag. 79
giuseppe cicolini
L’Istituto Magistrale “Braschi” di Subiaco
ha settant’anni pag. 82
Andrea del Vescovo
Notizie sulla chiesa di San Nicola a Orvinio pag. 87
Eugenio tiberi
Anacleto Bernardini di Vallinfreda: medico,
ostetrico e chirurgo pag. 91
Scaffale pag. 95
Referenze fotografiche: I. Morini: pp. 3, 4; P. E. Capaldi:
pp. 7, 12, 13, 14, 15, 18, 23 e copertina; V. Marchionne:
p. 27; A. Fiorillo: pp. 30, 32; M. T. Giovannoni: pp. 34,
35, 37, 38; L. Verzulli: p. 50; R. Giagnoli: pp. 60, 62; A.
Tantari: pp. 69, 70; G. Cicolini: p. 85; A. Del Vescovo:
pp. 87, 90; archivio A. Tacchia; collezioni private: J.
Allen; A. Bernardini; G. Roberti; M. T. Caffari; archivio
Aequa.
2
30
SULL’ORIGINE DI VERRECCHIE
di Alessandro Fiorillo
Il primo paese della Valle di nerfa, che s’incontra uscendo da tagliacozzo, è Verrecchie,frazione del comune di cappadocia (1).l’origine del nome c’è chi la fa derivare dal latino Verre, cioè maiale, ipotizzando che iprimi fondatori del paese fossero allevatori di maiali. c’è però chi fa notare che gli alle-vamenti di maiali sono per lo più diffusi in pianura, quindi questa associazione tra ilnome del paese ed i primi suoi abitanti, forse allevatori di suini, potrebbe essere tropposemplicistica. Altre origini potrebbero essere legate alle vicende del console romanoVerre, che in seguito ad alcuni disordini nella capitale dell’impero, fuggì dalla città, perriparare in un luogo sconosciuto. Potrebbe essere riparato in questo paese che avrebbequindi preso il nome di Verrecchie. tuttavia non esiste alcuna prova che possa suffraga-re più di altre questa ipotesi. Un’altra ipotesi ancora è riconducibile ad una parola di ori-gine olandese Verrek ja (Eureka! Finalmente ho trovato!). Probabilmente i primi abitantidi Verrecchie erano dei crociati del nord Europa che, di ritorno dalla Palestina, si sonofermati in questo nostro luogo ricco di sorgenti d’acqua, fondandovi un abitato. AncheAgnone, in Molise, è un classico esempio di colonizzazione di luoghi da parte di crocia-ti di ritorno dalla terra santa. Esiste inoltre un’antica nobile famiglia di nomeVerrecchia che, da quanto sembra, deve il suo nome al nostro paese. Essi erano per lopiù cavalieri, artisti e poeti che parlavano tedesco e traducevano testi dal tedesco. l’Istituto Araldico coccia di Firenze conferma la provenienza della famiglia Verrecchiadal nostro paese, e l’Istituto genealogico guelfi camajani di Firenze conferma la “sin-golare etimologia del nome”. la confidenza con la lingua tedesca dei primi esponentidella famiglia Verrecchia, sembra avvalorare l’ipotesi dell’origine nordica dei primi abi-tanti del paese (2). Un’altra ipotesi la troviamo nel libro di Walter cianciusi, Profilo di
storia linguistica della Marsica, che propone altre spiegazioni circa l’origine del nomeVerrecchie: il toponimo potrebbederivare dal latino verrucula,
diminutivo di verruca, “altura,piega del terreno”, con cambio disuffisso in –icula, per cui il nomedovrebbe significare “piccole altu-re”, e vi sarebbe corrispondenzacon l’orografia del paese. Ma ilcianciusi considera anche l’esi-stenza di una base idronimicamediterranea ver- (cfr. Veroli,Verona, Veretum oppidum), e lesorgenti dell’Imele, poste sottoVerrecchie, giustificherebbero labase idronimica del toponimo.Veduta di Verrecchie
31
Ancora il cianciusi tiene conto anche di Verreculum, “sagittae acumen” e diverrai=scopae, onde il significato sarebbe di “scopette”, “luogo in cui si raccoglie ilmateriale per fare scopette” (3).su Verrecchie è interessante segnalare quanto riporta don Alessandro Paoluzi (1869 –1930) nel suo Storia documentata di Tagliacozzo e del suo ducato. Vol. III, che a pagina1.328 scrive: «il nostro storico Gattinara, a pagina 37 dell’opera sua, dice che dove
oggi è il cosiddetto Ponte Verecano (da Verucolae=Verrecchie), in località detta Vigne
di Verrecchie, sotto il Santuario dell’Oriente, esisteva un’antica Vericulae. Da quel ter-
ritorio l’abbate di Verrecchie riscuote anche al dì di oggi buona rendita di grano e di
danaro». dovremmo dedurne, stando a quanto afferma don Paoluzi (riprendendo unpasso del gattinara contenuto nel suo libro, Storia di Tagliacozzo), che l’anticaVerrecchie si trovava non nella posizione del paese odierno, ma nei pressi ditagliacozzo, vicino al santuario della Madonna dell’oriente. la cosa è interessante,purtroppo mancano altri elementi utili per avvalorare questa ipotesi. riprendendo ilpasso citato da don Paoluzi, a pagina 37 di Storia di Tagliacozzo il gattinara afferma:«E qui credo necessario dare un’idea delle ville e casolari che presero parte a popolare
Tagliacozzo. 1° Cassioli (…) 2° Santa Cecilia (…) 3° S. Anzuino (…) 4° S. Nicola in
Populano (…) 5° Vericulae. Proseguendo il cammino verso sud, alla contrada
Quercette era situata Vericulae. Tuttora ritiene la denominazione di vigne di Verrecchie,
e quell’abbate curato vi riscuote buona rendita di grano e di danaro, e Verrecano si
denomina quel ponte della strada provinciale, per il quale gli scoli della valle di Sorbo
s’immettono nell’Imele. La parrocchia era sacra a S. Egidio abbate». Il gattinara conti-nua elencando gli altri villaggi che, secondo lui, hanno contribuito a popolare e a forma-re tagliacozzo. tra questi cita pure Cacumen e Verumpano.
continuando con don Alessandro Paoluzi, è interessante riportare ancora un passo dellasua opera, dove nelle pagine 1.328, 1.329, 1.330 e 1.331 scrive: «Cacume e Verumpano pare erano due villaggi, situati nel territorio di Verrecchie e
precisamente sulla boscosa montagna, tutta cosparsa di praterie e di annosi faggi, in
località, detta anche adesso Morbano e Cacume. Il Di Pietro nel secondo volume del-
l’opera sua (Agglomerazioni marse pag. 49) dice che in un manoscritto, conservato in
casa di D. Marino Tomassetti di Pescina si raccontava quanto segue: Esistevano sulla
montagna di Tagliacozzo due paesetti, chiamati uno Verrumpano e l’altro Cacume.
Erano gli abitatori scambievolmente nemici fino al segno di meditare gli uni la distru-
zione degli altri. Eseguirono il concepito disegno; nella stessa notte quei di Verrumpano
partirono per incendiare Cacume e quei di Cacume per incendiare Verrumpano, come
fecero risolutamente. Quando poi senza saperlo vollero rientrare nelle proprie abitazio-
ni, ognuno le trovò bruciate, e così strinsero amicizia e andarono ad abitare a
Verrecchie. Il Gattinara (Op. cit. pag. 39) riportando anch’egli il fatto, dice che così in
un giorno e nell’ora stessa perirono questi due villaggi, i di cui abitanti si rifugiarono
parte in Tagliacozzo e parte in Verrecchie, ove trasportarono la campana grande, che
trovasi in quel campanile. L’epoca di tale avvenimento rimonta, secondo la tradizione
dei vecchi al secolo XVI. In essa campana si legge la data del 1525. Sul monte Cacume
ancora si possono osservare i ruderi del villaggio, come nei pressi del fonte, detto la
Vetrina o Utrina, sotto il monte della Maddalena, si veggono gli avanzi delle case e la
via di Verumpano, o Urbano, o Morbano, che conduceva alla fontana. Nel nostro popo-
lo è ancor viva la tradizione di tale avvenimento, tanto è vero che raccontano come un
pastore, diversi anni fa, ritrovò in un sotterraneo di Urbano una botticella, che ancora
conteneva del vino di quei tempi, quando il paese fu bruciato, e ne prese diverse solenni
sbornie. Sfido io! Quel vino era davvero annoso! Dove un giorno sorse Verumpano, ora
si veggono piantate delle crocette, dette le crocette di Urbano, a ricordo degli uomini
ivi caduti in uno scontro, avvenuto tra i clienti del principe Colonna e i Verrecchiani nel
secolo passato per questioni riguardanti il bosco, di proprietà dei Colonna stessi. Non
possiamo finire di parlare di Verrecchie senza riportare che secondo alcuni in questo
paese anticamente esisteva un monastero di Benedettini cistercensi».Ancora don Paoluzi a pagina 593 della sua opera, scrive: «Il 15 luglio di quell’anno
1391 i cittadini di Verrucole e gli abitanti di Cappadocia, e di Petrella prestarono giu-
ramento di fedeltà a Giacomo Orsini loro novello Signore, in presenza di Francesco
Colonna, due notari testimoni e dell’altro notaio Egidio Lelli di Gallese. Qui dobbiamo
notare l’importanza che ebbe Verrecchie nel medio-evo, perché nell’atto in parola, men-
tre i nativi di Verrucole vengono chiamati cittadini, invece quelli di Cappadocia e di
Petrella vengono detti semplicemente abitanti. Dell’importanza che ebbe Verrecchie al
tempo dei conti de’ Marsi, parlammo, quando nel processo del 1207, svoltosi nel cortile
di S. Cosma in Tagliacozzo, vedemmo
presiederlo un giudice Oderisius de
Vericulis». nelle pagine 1326 e 1327 scriveancora: «Abbiamo già veduto che a
Verrecchie nel 1207 esisteva un
Giudice Camerario di Federico II, a
nome Oderisio, il quale tenne un
Placido o una Corte nel cortile dei
SS. Cosma e Damiano in Tagliacozzo
per una causa tra quelle monache
Benedettine e Bartolomeo de
Pontibus, detto Bartholomeaus de
Taliacozo». Anche all’interno delfamoso Catalogus Baronum, redattonel 1150 e aggiornato nel 1167-68, viene citato l’oderisio da Verrecchie menzionatosopra dal Paoluzi. Per la precisione la citazione avviene nel paragrafo 1117:«odErIsIUs dE VErrEclIs tEnEt A doMIno rEgE VEtErEcclAM QUodsIcUt dIXIt Est PHEUdUM IJ MIlItUM, Et tEnEt / In MArsI MEdIEtA-tEM cAstEllI dE FlUMInE, Et QUIntAM dE PErEto In gArZolI, EtQUIntAM dE PodIo / In MArsI, Et QUIntAM dE trEMontIBUs QUodsIcUt dIXIt Est PHEUdUM IIJ Et MEdII. UnA PHEUdUM VIII / Et AUg-MEntUM sUnt MIlItEJ VII. UnA IntEr PHEUdUM Et AUgMEntUMoBtUlIt MIlItEs XIIII Et sErVIEntEs XXVIII». (4)sempre lo stesso don Alessandro Paoluzi riferisce che, secondo alcuni, a Verrecchieanticamente esisteva un monastero di benedettini cistercensi. si tratta, con tutta probabi-
32
Il vecchio mulino di Verrecchie
33
lità, di un ritiro annesso all’antica chiesa di s. Egidio, situata nella parte alta del paese erisalente al XII sec. di recente a Verrecchie è stato inaugurato un Museo delletradizioni contadine, ricavato all’interno del vecchio mulino del paese (5).❖
__________
1-Verrecchie, già frazione del comune di cappadocia, con regio decreto del 28 gennaio 1929 fu aggregataal comune di tagliacozzo, per iniziativa del Podestà di tagliacozzo rag. domenico Amicucci e per espres-sa volontà degli abitanti stessi di Verrecchie. Ma questa unione durò poco, infatti nel libro di Matildetorres, La dottoressa di Cappadocia, a pag. 96 leggiamo: “(…) Verrecchie in passato era stata una frazio-
ne di Tagliacozzo; poi, con un referendum indetto nel 1948, preferì aggregarsi al più ricco comune di
Cappadocia”.2-Queste ipotesi relative all’origine del nome Verrecchie, riconducibili alle ricerche del sig. MarioVerrecchia, non convincono il prof. Elio Mercuri, il quale sostiene di possedere un documento del 1573(anno del concilio di trento) che riporta i cognomi degli abitanti dei nostri tre paesi e tra questi non risultanessuna famiglia Verrecchia. dalle ricerche del prof. Mercuri risulta pure che uno dei cognomi più diffusidi cappadocia, Ferrazza, è in realtà un cognome non autoctono del luogo, ma introdotto in tempi relativa-mente recenti, risalendo la prima famiglia Ferrazza residente a cappadocia soltanto al primo ottocento.Queste affermazioni del prof. Mercuri sembrerebbero però in parte smentite da altre mie ricerche, in quantoho trovato dei riferimenti a un tal Ferrazza di cappadocia in un testo riconducibile alla seconda metà delsettecento. 3-W. cIAncIUsI, Profilo di storia linguistica della Marsica, pag.111. È interessante esporre quanto ilcianciusi propone in riferimento al significato etimologico della toponomastica locale. Il fiume Imele vasecondo lui confrontato con Imaeus mons…forse da imus, “profondo”. la “profondità” potrebbe derivaredal fatto che l’Imele si tuffa in un inghiottitoio naturale per ricomparire a tagliacozzo, in località sfratati. IlMonte o la Valle della dogana debbono tale denominazione al fatto che in questa zona passava il confinetra stato della chiesa e regno di napoli. Il Monte Valminiera deve il toponimo all’esistenza di miniere diferro. riporto un passo del t. BonnAnnI, La provincia del II Abruzzo ulteriore, Aquila 1872: “…In
Trasacco Pagliara e Petrella si racchiudono trentaquattro utilissime ed inesauribili miniere di ferro…”.Per Morbano, ancora il cianciusi, propone l’etimo derivato dal latino morbus. nerfa deriverebbe invece dauna base idronimica mediterranea ner-/nar (cfr. narni, nera, nereto). nella Valle di nerfa ha le scaturiginied il primo sviluppo il fiume liri. 4-con le barre oblique ho indicato le originarie suddivisioni delle frasi, così come appaiono nel testo delCatalogus dell’edizione di E. Jamison. dalla traduzione del passo riportato apprendiamo che il feudo dioderisio da Verrecchie comprendeva Verrecchie (Veterreclam), castello a Fiume (Castelli de Flumine), laquinta parte di Pereto, la quinta parte di Poggio (da identificarsi, forse, con Poggetello, frazione ditagliacozzo), la quinta parte di tremonti (Tremontibus). garzoli sta per carsoli, e sicuramente doveva indi-care il territorio un tempo appartenente alla Carsioli romana.5-la mostra è stata allestita dalla Pro loco di Verrecchie. Per ulteriori informazioni, anche sugli orari divisita ed apertura del museo, si può consultare il sito internet www.verrecchie.it
BIBlIogrAFIAA. PAolUZI (1869 – 1930) , Storia documentata di Tagliacozzo e del suo ducato, vol. III – Biblioteca delsantuario della Madonna dell’oriente a tagliacozzo.g. gAttInArA, Storia di Tagliacozzo, città di castello 1894, ristampa anastatica a cura della libreriaVincenzo grossi, tagliacozzo 1999.A. FIorIllo, Storia di Cappadocia, Petrella, Verrecchie, roma 2005, Ass. cult. nuovo Mondo.V. MAssottI, Historia Cappadociae, 1996, Ente Provinciale turismo l’Aquila – Associazione Pro-cappadocia.W. cIAncIUsI, Profilo di storia linguistica della Marsica.
M. torrEs, La dottoressa di Cappadocia.
Il FoglIo dI lUMEn, Miscellanea 8, anno 2004 – documenti & ristampe.