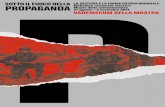Sotto il velo della normalità
Transcript of Sotto il velo della normalità
meltemi.edu
15
Edizione originale:Né de la Terre
Editions du Seuil, 1996
antropologia/epistemologia/psicoterapia
EECopyright © 2004 Meltemi editore srl, Roma
È vietata la riproduzione, anche parziale,con qualsiasi mezzo effettuata compresa la fotocopia,
anche a uso interno o didattico, non autorizzata.
Meltemi editorevia dell’Olmata, 30 – 00184 Romatel. 06 4741063 – fax 06 4741407
Pietro Barbetta, Michele Capararo,Telmo Pievani
Sotto il velo della normalità
Per una teoria alternativa dei sistemi di cura della mente
MELTEMI
Indice
p. 9 PrefazionePietro Barbetta, Michele Capararo, Telmo Pievani
13 Capitolo primoExaptation: la biologia dell’imprevedibile.Un approccio costruttivista all’idea di “adattamento”Telmo Pievani
143 Capitolo secondoBricolage e degenerazioni, un saggio di antropologia clinicaPietro Barbetta
195 Capitolo terzoLa personalità e i suoi disturbi Pietro Barbetta
223 Capitolo quarto Storie umane di (neuro)scienza e sistemi di curaMichele Capararo
267 Bibliografia
Catron, 6 marso 1954
Tema: Una gita
Domenica siamo ndatia lamadona demontebericoa chiedere la grassiapar miasorela che èmaridata da cinque anie no a gnanca tosatei.Siamo ndati, poi siamo pregati, poi siamo mangiati,poi siamo venuti casa.O che siamo pregati maleo che no si siamo capitico la Madona, fatostàche è rimasta insintalaltra sorella che noè gnanca maridata
www.tatare.it/Naltra/Tema_1.htm
PrefazionePietro Barbetta, Michele Capararo, Telmo Pievani
Il volume che proponiamo intende analizzare dal puntodi vista teorico e clinico le connessioni tra le teorie biologi-che a orientamento sistemico, alcune delle più significativeteorie antropologiche sulle relazioni mente/cervello e i si-stemi clinici e terapeutici.
In generale l’appello alla natura, in campo psichiatri-co e psicologico, rinvia a un insieme di teorie biologichedi stampo riduzionista che vanno dalle ipotesi sociobio-logiche – corroborate da incauti riferimenti all’etologia –fino alle teorie che ipotizzano una relazione bi-univoca efissa tra i principali neurotrasmettitori e i comportamentiumani.
Questo libro presenta un primo tentativo di confrontotra le scienze evolutive a orientamento costruttivista e lepratiche cliniche sistemiche e costruzioniste.
Il libro è il frutto di un insieme di seminari, conversa-zioni pubbliche e private tra noi tre.
La domanda dalla quale siamo partiti è: è possibile pen-sare alla nozione di exaptation come a qualcosa di fecondoper lo sguardo clinico? Lo sguardo clinico che si orienta intale direzione può vedere risorse e processi evolutivi ove losguardo clinico (neurologico, psichiatrico e psicologico)orientato a modelli riduzionisti vede malformazioni, re-gressioni e disturbi?
Siamo partiti dunque dall’idea di avere un chiarimentosu quale fosse il significato del termine exaptation. Termineche abbiamo deciso di non tradurre in italiano per noncreare un inutile neologismo.
Il saggio di Telmo Pievani ha precisamente un tale sco-po chiarificatore.
Una volta comprese le molteplici valenze in cui questotermine viene usato dagli studiosi delle teorie evoluzioni-ste, abbiamo sondato alcune sue possibili declinazioni nel-l’ambito dell’antropologia clinica, della psicoterapia e deisistemi di cura.
Il primo capitolo di Telmo Pievani, intitolato Exapta-tion: la biologia dell’imprevedibile illustra, fino ai più recentisviluppi teorico-concettuali, la storia del movimento scienti-fico che ha portato all’ipotesi exattativa. Il suo lavoro è in-sieme un quadro storico e concettuale e ha il ruolo di torna-re a Darwin per reperire lì, in alcuni aspetti essenziali delsuo pensiero, le origini di questa ipotesi. Nello stesso tempoPievani spiega quante diverse possibilità di pensare all’evo-luzione siano aperte e quanti materiali scientifici si stianoancora raccogliendo per continuare una ricerca appena ini-ziata intorno all’idea di “bricolage evolutivo”.
Il primo dei due saggi di Pietro Barbetta, Bricolage e de-generazioni, un saggio di antropologia clinica, si sviluppa ri-prendendo proprio la metafora del bricolage. Così comePievani ritorna a Darwin per reperire aspetti tralasciati delsuo pensiero, Barbetta ripercorre alcuni snodi del pensierodi Bateson allo stesso scopo: cercare quanto è trascuratodel suo pensiero. Ovvero le ragioni antropologiche di unpensiero sulla psicoterapia che possa fare a meno dell’ideadi potere, che non riduca la terapia a un gioco strategico,bensì la liberi trasformandola in un insieme di giochi nar-rativi imprevedibili. Il secondo saggio dello stesso autoreinvece (La personalità e i suoi disturbi) nell’osservare l’inge-nuità epistemologica e la ristrettezza metodologica di granparte degli studi sui disturbi della personalità in campopsichiatrico e psicologico, propone una sorta di linguisticturn della psicologia. È possibile che, in qualche modo, idisturbi della personalità possano essere considerati comedisturbi del linguaggio? L’incapacità immaginativa del lin-guaggio normale, della razionalità moderna, non è forseuna fonte privilegiata dei disturbi della personalità?
P. BARBETTA, M. CAPARARO, T. PIEVANI
Infine il saggio di Michele Capararo, Storie umane di(neuro)scienza e sistemi di cura, ci propone una sorta di ri-flessione eretica sulle neuroscienze a partire da un’analisilinguistica del guarire/guardare, del de-lirare e del lirico perportare il lettore a una riflessione critica intorno a una con-cezione antropomorfa del sistema nervoso, largamente inuso nei sistemi di cura, mostrando come l’uomo indaghi lestrutture e i processi neuronali attraverso linguaggi metafo-rici coerenti con i diversi paradigmi dominanti in un deter-minato periodo storico.
Dall’epoca di Kraepelin in poi, la salute mentale è statain gran parte concepita come una sorta di competenzaadattativa. Si teorizzava così che coloro che presentavanosistematiche incapacità adattative fossero i degenerati. I pa-ranoici di Kraepelin, i criminali di Lombroso, gli ebefrenicidi Bleuler, le isteriche di Charcot, le omosessuali di Caprio.Ma più recentemente i borderline, i depressi, i bambini ipe-rattivi e disattenti, le ragazze anoressiche.
Un’interpretazione riduttiva del darwinismo, un adatta-zionismo fondamentalista, ha prodotto in neurologia, psi-chiatria e psicologia un’idea del medico e dello psicologocome di meccanici che aggiustano il cervello e la mente(l’hardware e il software) di una macchina banale, l’uomo.
Con questo libro cerchiamo di mettere assieme i fram-menti di una teoria alternativa dei sistemi di cura, a partireda un approccio bio-psico-sociale non riduzionista.
L’esergo del libro dice tutto questo meglio di noi in po-che parole1.
Mentre scrivevamo questo libro, sono improvvisamentee prematuramente scomparsi Marco Della Lena e Gian-franco Cecchin. Marco è la persona che ci ha proposto discrivere il libro, iniziato con lui e grazie a lui. Gianfranco èstato per ognuno di noi un punto di riferimento e un mae-stro. A loro dedichiamo queste pagine.
1 Ringraziamo Francesca Barile per averci mostrato il testo dell’esergo.
PREFAZIONE
Capitolo primoExaptation: la biologia dell’imprevedibile.Un approccio costruttivista all’idea di “adattamento”Telmo Pievani
Parafrasando il sig. Huxley in un famoso conte-sto, io sono disposto ad andare al rogo perl’exaptation, poiché questo nuovo termine si tro-va in notevole contrasto con adaptation, definen-do in tal modo una distinzione che si colloca alcuore della teoria dell’evoluzione e colmandoanche un vuoto imbarazzante nel nostro prece-dente lessico relativo ai processi fondamentalinella storia della vita (Gould 2002b, p. 1.540).
L’adattamento: soluzione o problema?
In una vicenda esemplare della storia naturale, la so-pravvivenza e l’estinzione improvvisa della cosiddetta “alceirlandese” (erroneamente considerata un’alce, perché sitrattava in realtà di un cervo di grandi dimensioni), trovia-mo un messaggio importante sul ruolo effettivo della sele-zione naturale nella costruzione delle forme organiche(Gould 1977a, pp. 75-85; ma la prima descrizione dell’ani-male è riportata da Molyneux nel 1697). La caratteristicapeculiare di questo cervo delle terre subartiche erano lecorna ramificate di dimensioni eccezionali: la loro aperturaraggiungeva i 3,65 metri ed erano sostituite ogni anno. Permolto tempo la si ritenne una piccola specie confinata al-l’Irlanda, poi si scoprirono esemplari provenienti da un’a-rea assai estesa: dalla Siberia all’Africa settentrionale. Pro-babilmente si estinse prima nelle altre zone del pianeta epiù tardi, circa 11.000 anni fa, in Irlanda. L’enigma evoluti-vo dell’alce irlandese è duplice. In primo luogo, perché sisvilupparono corna così ingombranti e pesanti? Che valoreadattativo potevano avere le corna gigantesche di un cer-vo? Il secondo interrogativo è speculare: se le corna aveva-
no un senso adattativo, perché l’alce irlandese si estinse co-sì velocemente?
Una domanda analoga riguarda, nelle scienze evoluzio-nistiche contemporanee, anche altri episodi cruciali dellastoria naturale. Perché l’Uomo di Neanderthal, con il suocervello di 1600 cc, la sua efficiente organizzazione sociale,le sue discrete tecnologie musteriane, il suo ottimo adatta-mento ai climi rigidi dell’Europa glaciale, si è estinto la-sciando il posto a Homo sapiens? Una competizione fraspecie? È possibile, ma allora perché in tempi abbastanzarapidi, qualche decina di milioni di anni prima, le “lucerto-le terribili” e con esse intere famiglie di esseri viventi, benadattati ai loro ambienti di terra e di mare, si sono estintelasciando in eredità il pianeta a piccoli roditori a sanguecaldo che daranno ben presto origine alla diversità di for-me attuali dei mammiferi? Una competizione di specie?Possibile, ma allora perché Homo neanderthalensis primadi lasciarsi estinguere convive con il suo nemico mortaleper decine di migliaia di anni? Perché il Tirannosaurus rex,fiero dominatore delle praterie del Giurassico e ora iconadei musei di storia naturale di ogni parte del mondo, non silascia per nulla intimorire, non per poco ma per decine dimilioni di anni, dai minuscoli “ratti del Mesozoico”? Perneanderthal e per i dinosauri vale quanto afferma Jack Ni-cholson in L’onore dei Prizzi: “Se era così maledettamentein gamba, com’è che è così irrimediabilmente morto?”(Darnton 1996).
Molti scienziati creazionisti dei secoli XVII e XVIII soste-nevano che “l’estinzione di una specie sarebbe stata in con-trasto con la bontà e la perfezione di Dio” e cercarono in-vano esemplari viventi corrispondenti ai resti fossili. Nel1812 George Cuvier utilizzò proprio l’alce irlandese per di-mostrare la realtà delle estinzioni.
La prima questione, il valore adattativo di strutture in-gombranti, ricevette una risposta chiara e coerente da par-te di Darwin: i cambiamenti evolutivi riscontrabili in unorganismo sono frutto della selezione naturale che premia,attraverso il successo differenziale delle varianti più favo-
TELMO PIEVANI
revoli, gli individui meglio adattati all’ambiente. Le tra-sformazioni organiche sono (quasi) sempre, e in modi di-versi, utili per la sopravvivenza dell’organismo. Le cornadell’alce irlandese devono aver senz’altro offerto all’ani-male un vantaggio riproduttivo sostanziale, nella competi-zione fra maschi per l’accoppiamento o nella scelta sessua-le stessa da parte delle femmine, tale da mettere in secon-do piano la scomodità di sobbarcarsi un palco di cornacosì impegnativo.
Tuttavia, la spiegazione non convinse l’intera comunitàscientifica e nei primi cinquant’anni dalla pubblicazione deL’origine delle specie si organizzò una forte opposizione an-tidarwiniana che sul tema specifico del ruolo dell’adatta-mento aderì a una teoria della genesi degli organi del tuttodifferente: la teoria dell’ortogenesi.
La teoria della selezione naturale di Darwin implicava il fattoche i cambiamenti evolutivi fossero adattativi, cioè risultasse-ro utili agli organismi. Perciò gli antidarwiniani cercarono neifossili casi in cui l’animale in questione non poteva aver trattoalcun giovamento dalla sua evoluzione (Gould 1977a, p. 79).
I paleontologi antidarwiniani (Lull 1924), nella ricercadi episodi evolutivi in cui l’adattamento non potesse essereconsiderato il principio causale determinante, ipotizzaronoche l’evoluzione procedesse in linea retta, lungo direzioniprestabilite quasi indipendenti dall’influenza della selezio-ne. Questi sentieri obbligati dei processi di sviluppo e ditrasformazione, in taluni casi, potevano anche condurre ir-reversibilmente all’estinzione della specie: le tigri dai denti asciabola si sarebbero soffocate e infilzate da sole; i mammutsi sarebbero estinti per la crescita eccessiva delle zanne; lealci irlandesi perché immobilizzate fra i rami da corna ingo-vernabili. Come si può facilmente arguire, non si trattava diuna teoria “esplicativa” dei fenomeni di non-adattamento,ma di una teoria esclusivamente “descrittiva”: si ricostruivaa posteriori un percorso di estinzione interpretandolo comela sequenza evolutiva di un suicidio pre-ordinato.
EXAPTATION: LA BIOLOGIA DELL’ IMPREVEDIBILE
Queste ricostruzioni ortogenetiche non durarono alungo e furono smentite dalla “teoria dell’allometria” ela-borata da Julian Huxley negli anni Trenta (Huxley 1932).Secondo Huxley, e secondo la biologia animale attuale,l’aumento delle dimensioni degli organi di un animaleprocede secondo tassi di crescita differenziali interrelati.Alla crescita delle dimensioni corporee corrisponde uncerto tasso di crescita (maggiore) delle corna, anche perun cervo particolarmente grande come l’alce irlandese. Lerelazioni allometriche in questione furono confermate daricerche successive: l’incremento delle dimensioni possie-de alcuni effetti collaterali, fra cui l’aumento corrispon-dente delle corna.
Il punto però rimane un altro: l’utilità adattativa portòprimariamente all’aumento delle dimensioni del corpo (eper relazione allometrica secondaria di quelle delle corna)o, viceversa, l’aumento delle dimensioni delle corna prece-dette quelle corporee? Nella spiegazione allometrica resta-va infatti un residuo ortogenetico, per cui l’allargamentodelle corna doveva essere una conseguenza derivata e ne-cessaria di un processo evolutivo principale. Alcuni moder-ni studi sul comportamento sociale delle alci irlandesi han-no rivelato però che, come per molte altre specie, le strut-ture maschili considerate di solito come armi da battaglia oornamenti per ammansire le femmine (nell’ottica della sele-zione naturale centrata sulla sola lotta per la sopravviven-za) erano usate invece per i combattimenti ritualizzati framaschi. Erano simboli di potere e di forza che, fissandopreventivamente una gerarchia nel gruppo, rendevano su-perflue le battaglie fisiche fra i più forti. Questo utilizzo, inquanto manifestazione di predominio, rappresenta un va-lore adattativo molto preciso, nel senso della “selezionesessuale” introdotta da Darwin ne L’origine dell’uomo, chesembrerebbe smentire anche l’interpretazione di Huxley.Le corna ramificate erano in un certo senso lo “status sym-bol” di questi cervi, un ottimo espediente per accrescere ilproprio successo riproduttivo attirando il maggior numeropossibile di femmine.
TELMO PIEVANI
La vicenda dell’alce irlandese assume nuovi connotati:non si estinse a causa delle grandi corna, ma nonostante legrandi corna. La fine della glaciazione comportò una seriedi rapidi mutamenti climatici, dannosi per la sua sopravvi-venza: solo allora le corna, così utili in precedenza, diven-nero un impaccio a causa del cambiamento delle circostan-ze ambientali. Anche se a prima vista questo slittamento in-terpretativo rafforza l’argomento adattativo per l’organo inquestione rispetto a spiegazioni ortogenetiche, in realtàl’attenzione si è spostata da un asse esplicativo adattamen-to-disadattamento (che sovrappone il concetto di estinzio-ne a quello di “inadeguatezza” adattativa) a una considera-zione storica su cambiamenti contingenti delle regole am-bientali di sopravvivenza. Come notò il paleontologo diHarvard Stephen J. Gould (1977a, p. 85):
L’estinzione è il destino della gran parte delle specie, general-mente a causa della loro incapacità di adattarsi abbastanza ra-pidamente ai cambiamenti climatici o alla competizione. L’e-voluzione darwiniana esclude che un animale possa sviluppa-re attivamente una struttura dannosa, ma non può garantireche strutture utili continuino ad essere vantaggiose in circo-stanze ambientali mutate. Probabilmente l’alce irlandese fuvittima del suo stesso precedente successo.
In realtà, dietro ricostruzioni evolutive come questa siannida un preconcetto a proposito della “perfezione” na-turale. La perfezione adattativa di un organo o di un ani-male (il suo grado ottimale di fitness) misurata in relazioneal contesto ecologico specifico è un concetto facilmenteadottabile da un creazionista ortodosso: nella natura sareb-be inscritto un progetto divino, un disegno supremo di in-gegneria naturale; è del tutto prevedibile che gli organismisiano perfettamente “equipaggiati” e ben inseriti nell’am-biente insieme al quale sono stati creati.
Nel 1802 l’arcidiacono Paley decide di rendere gloria a Dioillustrando gli straordinari adattamenti degli organismi ai ruo-li cui erano stati assegnati. La perfezione meccanica dell’oc-
EXAPTATION: LA BIOLOGIA DELL’ IMPREVEDIBILE
chio dei vertebrati gli ispirò un estatico discorso sulla perfe-zione divina; persino la fantastica somiglianza di certi insetti apezzi di sterco suscitò la sua ammirazione, perché Dio sem-brava proteggere tutte le sue creature, grandi e piccole. Lateoria dell’evoluzione finì per distruggere il grande disegnodell’arcidiacono, ma qualche brandello della sua teologia na-turale sopravvive ancora oggi (p. 100).
Darwin comprese molto acutamente la centralità diquesto concetto forte del creazionismo (rimanendone in unprimo tempo anche affascinato) e concentrò il suo impe-gno teorico sui particolari curiosi e su quelle strutture evo-lutesi in modo non lineare da forme ancestrali differenti,come nel caso delle orchidee (Darwin 18772). Egli intuì, inun certo senso, che il nocciolo della controversia fra evolu-zionismo e fissismo si dovesse giocare sulle “stranezze”della natura, e non sui percorsi evolutivi standard.
Oggi sappiamo che i fenomeni adattativi si presentanocome strategie complesse e non-banali di sopravvivenza dif-ferenziale. Una prima acquisizione in questo senso, intornoalla metà degli anni Sessanta, è venuta dalle ricerche sulla“biogeografia delle isole” dell’ecologo teorico R. H. Ma-cArthur e di Edward O. Wilson (1967), in cui furono illu-strate le cosiddette “strategie vitali”. Si scoprì allora che gliorganismi si adattano al contesto ecologico non solo modifi-cando le proprie dimensioni e forme, ma anche regolando ladurata delle diverse fasi della vita e differenziando l’apportodi energia alle diverse attività nel corso del tempo. Questestrategie di adattamento non morfologico sono significativesia per la comprensione del funzionamento del sistema gene-tico attraverso riorganizzazioni e canali di crescita in correla-zione, sia per la comprensione, fatta propria dall’ecologiateorica contemporanea, dell’irriducibile eterogeneità dellenicchie ecologiche potenziali. Molte di queste richiedonoagli organismi forme di adattamento articolate sui ritmi disviluppo, non solo “adeguamenti” morfologici meccanici co-me se l’adattamento fosse un processo di “sintonizzazione”dell’animale a un ambiente uniforme e ripetitivo.
TELMO PIEVANI
Le due strategie vitali individuate in particolare da Wil-son e MacArthur sono la strategia riproduttiva-r (o r-sele-zione), per cui l’organismo si adatta ad ambienti molto in-stabili massimizzando l’incremento riproduttivo, e la stra-tegia vitale K (o k-selezione), per cui l’organismo si adattaad ambienti stabili minimizzando la prole e massimizzandol’adattamento morfologico. Potremmo intendere la r-sele-zione come una strategia di sopravvivenza basata sullaquantità (adottata per esempio da molte specie di insetti),la k-selezione una strategia basata sulla qualità adattativadel discendente (come nel caso dei primati). Altre soluzio-ni possono essere miscele elaborate e sofisticate delle duesoluzioni adattative principali, rivolte alla sopravvivenza inambienti speciali attraverso la manipolazione dei proprischemi riproduttivi: è il caso, studiato da tempo, di alcunecicale “periodiche” (Lloyd, Dybus 1966) o di alcuni vege-tali come il bambù (Jenzen 1976), che regolano gli sbalziriproduttivi in base al ciclo vitale dei predatori. Se l’esi-stenza è una lotta, non è detto che le armi usate debbanoessere sempre le stesse:
Noi uomini, con il nostro sviluppo così lento, la nostra lungagestazione e le figliate ridotte al minimo, siamo dei consumatiesperti in strategie “K” e guardiamo con perplessità alle stra-tegie degli altri organismi, ma è certo che gli insetti dei funghihanno trovato una giusta soluzione per poter vivere nel loromondo r-selettivo (Gould 1977a, p. 92).
L’adattamento contempla una molteplicità di soluzioniegualmente plausibili. Eppure la scomoda questione dellaperfezione organica non può essere aggirata con il solo ar-gomento della diversificazione. L’esistenza di organi moltocomplicati e tuttavia estremamente “perfetti”, come l’oc-chio dei vertebrati, angustiò a lungo lo stesso Darwin.Com’era possibile che ingranaggi così sofisticati e delicatipotessero essere stati costruiti, passo dopo passo, dalla se-lezione naturale? Il problema è diametralmente opposto alprecedente, e complementare. Là Darwin doveva giustifi-
EXAPTATION: LA BIOLOGIA DELL’ IMPREVEDIBILE
care forme di vita e comportamenti “bizzarri” apparente-mente incomprensibili in un’ottica adattazionista, risolven-do la difficoltà attraverso l’ipotesi di una proliferazione distrategie adattative vitali. Qui si trattava di spiegare l’origi-ne selettiva di forme organiche il cui senso e “pregio” adat-tativo è fin troppo evidente, talvolta addirittura sorpren-dente per ingegnosità e funzionalità.
La soluzione darwiniana del “pre-adattamento”
L’adattamento è la maggiore evidenza empirica dellabiologia evolutiva, la caratteristica principale delle struttu-re naturali, il segreto della sopravvivenza di ogni essere vi-vente: nei casi di mimetismo animale, per esempio, la natu-ra tocca i suoi picchi di ingegnosità e di creatività. L’adatta-mento è ciò che qualsiasi teoria evoluzionistica deve spie-gare e nella visione darwiniana esso diviene l’espressionedel cambiamento organico che ogni essere vivente deveprodurre in risposta alle modificazioni e alle pressioni del-l’ambiente circostante. L’adattamento è in costante evolu-zione ed è il risultato dell’azione incessante della selezionenaturale che agisce sulle mutazioni genetiche individuali.
Eppure, l’idea di adattamento si è rivelata ingombranteper le teorie evoluzionistiche. Essa richiese l’onere dellaprova fin dall’inizio, perché era ben radicata anche nellaprecedente visione creazionista del sapiente disegno divinoe della perfetta “armonia” del creato. In tal senso, l’adatta-mento era inteso come il giusto accomodamento di ogniorganismo agli equilibri inscritti da sempre nel creato. Inun’ottica evoluzionistica l’adattamento doveva essere inve-ce spiegato come qualcosa di non immutabile, come unatrasformazione incessante delle forme naturali. In questosenso, Darwin capì che l’adattamento doveva essere sem-pre parziale, in fieri, e non una soluzione perfetta data unavolta per tutte.
Come spiegare dunque l’evoluzione di organi così ela-borati e perfetti come un occhio, un’ala d’uccello o come i
TELMO PIEVANI
mimetismi stupefacenti di molte specie animali? L’evolu-zione sapeva fin dall’inizio di voler costruire quella partico-lare struttura, come se nel processo evolutivo vi fossero inazione cause finali dirette a un costante progresso e miglio-ramento, oppure deve essere successo qualcosa di diverso?Una struttura così perfetta avrà ancora un’evoluzione o ègiunta al suo apice evolutivo, al suo culmine adattativo?
Nel capitolo sesto dell’edizione del 1872 de L’originedelle specie, intitolato Difficoltà della teoria, Darwin inseri-sce un intero paragrafo sugli “organi di estrema perfezio-ne e complessità”, nel quale ammette apertamente il pro-blema:
Supporre che l’occhio con tutti i suoi inimitabili congegni perl’aggiustamento del fuoco a differenti distanze, per il passag-gio di diverse quantità di luce, e per la correzione della aber-razione sferica e cromatica, possa essersi formato per selezio-ne naturale, sembra, lo ammetto francamente, del tutto assur-do (Darwin 1859, p. 239).
In una visione classicamente darwiniana, l’adattamentoprocede nella costruzione dell’organo attraverso una lungaserie di trasformazioni continue e molti stadi intermedi dievoluzione:
La ragione mi dice che se si può dimostrare l’esistenza di nu-merose gradazioni da un occhio semplice e imperfetto a unocomplesso e perfetto, essendo ogni grado utile per chi lo pos-siede, come è certamente il caso; che se inoltre l’occhio variasempre e le variazioni sono ereditarie, fatto altrettanto vero, eche se queste variazioni sono utili a un animale in condizionimutevoli di vita, allora la difficoltà di ammettere che un oc-chio perfetto e complesso si formi per selezione naturale, seb-ben insuperabile per la nostra immaginazione, non deve esse-re considerata come sovvertitrice della nostra teoria (ib.).
Tuttavia, la difficoltà di un ragionamento selezionistasta proprio nel giustificare il valore adattativo delle struttu-re intermedie. Fra gradualismo e funzionalismo si apre una
EXAPTATION: LA BIOLOGIA DELL’ IMPREVEDIBILE
contraddizione esplicativa: come tenerli insieme? Le primecritiche alla teoria darwiniana centrate su tale difficoltànello spiegare le strutture incipienti provennero da EdwinD. Cope, nel 1887, e da George Mivart, nel 1871, cuiDarwin rispose lungamente proprio nella sesta edizionedell’Origine. A cosa può servire un abbozzo di occhio, sichiesero polemicamente Cope e Mivart? Il risultato finaledel processo ha un chiaro significato per la sopravvivenza,ma un embrione di occhio non può servire per vedere. Il5% di un’ala non basta per volare, come il 5% di una mi-metizzazione non serve certo a nascondere una preda alsuo predatore.
Secondo Mivart, il “problema del 5% di un’ala” era unfalso problema, perché il 5% di un’ala semplicemente nonè mai esistito: le modificazioni in una specie si manifesta-no repentinamente, tutte in una volta, a causa di una forzainterna e seguendo certi piani strutturali prefissati. MaDarwin non poteva in alcun modo accettare una similespiegazione “saltazionista”, che negava l’efficacia della se-lezione naturale di tipo gradualista. La risposta a questadifficoltà venne allora dall’ipotesi del pre-adattamento, cheintrodusse un’idea di grande rilievo nella teoria dell’evolu-zione. Un abbozzo di occhio non serve per vedere, notòDarwin: non esiste un dispiegamento teleologico dell’or-ganismo verso la costruzione di una forma la cui utilità siasolo nel futuro. Ciò che conta è che vi sia una continuitànel successo riproduttivo differenziale, cioè nell’azionedella selezione naturale, e non tanto una continuità nellafunzione assunta dal singolo organo. Può sembrare un’ac-quisizione banale ma non è così, poiché si tratta di scinde-re l’utilità attuale di un carattere dalla sua origine storica.Gli stadi incipienti di una struttura devono aver recato unvantaggio riproduttivo ai loro possessori, vantaggio chepoi è stato “convertito” in un beneficio differente al muta-re delle condizioni.
Questa soluzione viene seguita, nell’argomentazionedarwiniana, da un corollario non meno importante: se lefunzioni cambiano, significa che nell’evoluzione non è be-
TELMO PIEVANI
ne che vi sia una stabile corrispondenza “uno a uno” frauna struttura e una funzione. Gli organi possono funziona-re in più modi, possiedono cioè una “capacità intrinseca”ridondante. Una singola funzione potrà essere assolta dapiù organi, di modo che, all’occorrenza, uno di questi pos-sa essere “cooptato” per nuovi utilizzi senza che la salutecomplessiva dell’organismo ne risenta (primo principio diridondanza). Viceversa, un singolo organo potrà espletarepiù funzioni, alcune delle quali operative, altre soltanto po-tenziali, pronte per essere “reclutate” all’occasione (secon-do principio di ridondanza).
Nell’evoluzione vi saranno allora, di norma, funzioni“primarie” (pre-adattamenti) disgiunte dalle funzioni deri-vate attuali (adattamenti). Dobbiamo cioè accettare il fattoche che gli stadi intermedi di strutture attuali non avevanola funzione che poi assumeranno. Ammettiamo allora chevi sia un cambiamento funzionale nell’ambito di una conti-nuità strutturale. Parti dell’organismo selezionate per unacerta funzione ancestrale (per esempio gli ossicini necessarinei pesci al sostegno dell’arco branchiale) vengono “riadat-tate” a funzioni nuove (per esempio andando a sostenere lamascella e consentendo la masticazione):
I primi pesci erano privi di mascelle, come è possibile che uncongegno così complicato composto di diverse ossa intercon-nesse, si sia evoluto dal nulla? Quel “dal nulla” si dimostra inrealtà solo un modo di dire. Le ossa erano presenti già neipredecessori, ma servivano ad altro, sostenevano un arcobranchiale situato subito dietro la bocca. Erano ben disegnateper il loro ruolo respiratorio, erano state selezionate solo perquesto e non “sapevano” nulla di una qualsiasi funzione futu-ra. Col senno di poi, si può dire che le ossa erano ammirevol-mente pre-adattate a divenire mascelle. La complicata strut-tura c’era già, ma veniva usata per la respirazione anziché perla masticazione (Gould 1977a, p. 104).
La funzione può variare anche radicalmente, senza chela forma dell’organo cambi considerevolmente. La pinnadotata di un resistente asse centrale, sviluppata da alcuni
EXAPTATION: LA BIOLOGIA DELL’ IMPREVEDIBILE
pesci di fondale d’acqua dolce, era un ottimo pre-adatta-mento per il movimento sulla terraferma:
Questa struttura era ammirevolmente pre-adattata a divenireuna zampa terrestre, ma si era evoluta semplicemente per isuoi scopi nell’ambiente acquatico, probabilmente per con-sentire all’animale di correre sul fondo con rapidi movimentidell’asse centrale (ib.).
Il passaggio può non essere una soglia brusca di disconti-nuità: si può ipotizzare che la funzione ancestrale continui aessere soddisfatta anche quando la nuova funzione sta su-bentrando e prevalendo. Mentre la struttura primordiale as-solve degnamente al compito per cui è stata selezionata ori-ginariamente, una pressione adattativa concomitante ma ete-rogenea preme per un’evoluzione della tecnologia dell’orga-no in un’altra direzione, fino al punto in cui la funzione ori-ginaria è soppressa. I lembi del mantello del Lampsilis po-trebbero essere stati implementati per una funzione mimeti-ca gradualmente, mentre assolvevano ad altre funzioni.
L’intuizione, già di Darwin ma poi passata a lungo insecondo piano, è che alla continuità di una trasformazionemorfologica per selezione non necessariamente corrispon-da una continuità progressiva della funzione. In un certosenso la funzione è un’entità discreta, che non può esserecostruita per adattamenti successivi, ma emerge dalla ri-dondanza morfologica dell’organismo in evoluzione. Senon si fosse ammesso questo, intuì Darwin, sarebbero ri-maste soltanto due strade: negare che gli stadi intermediavessero una qualsiasi funzione primaria (e quindi che fos-sero stati fissati per selezione); oppure postulare una crea-zione improvvisa della forma perfetta finale. Due posizio-ni egualmente inaccettabili dal suo punto di vista. CosìDarwin, per salvare il gradualismo, fu costretto a offrireall’evoluzione una notevole flessibilità funzionale:
Ma dobbiamo essere estremamente cauti prima di concludereche un organo non può essersi formato attraverso gradazionitransitorie. (...) la selezione naturale potrebbe specializzare
TELMO PIEVANI
per una sola funzione, se qualche vantaggio fosse in tal modoacquistato, un organo o una parte di organo che in preceden-za esplicava due funzioni, così da modificare considerevol-mente la sua natura attraverso gradi insensibili. (...) Inoltredue organi distinti, o lo stesso organo in due forme molto di-verse, possono compiere contemporaneamente la stessa fun-zione nello stesso individuo, e questo è un modo molto im-portante di transizione. (...) uno dei due organi potrebbe fa-cilmente modificarsi e perfezionarsi in modo da compiere tut-to il lavoro, essendo aiutato durante il processo di modifica-zione dall’altro organo; poi quest’altro organo potrebbe mo-dificarsi per un altro scopo del tutto differente, oppure scom-parire completamente (Darwin 1859, p. 243).
Il problema della perfezione naturale divenne alloraquello di spiegare come fosse possibile passare per selezio-ne naturale da strutture incipienti, non adattabili a una cer-ta funzione, all’organo completo, perfetto, che si vede allaconclusione del processo. Un 5% di ala non può servireper volare, ma è pur vero che la struttura alare non è com-parsa all’improvviso pronta all’uso né è stata costruita “invista” dell’utilità futura. La soluzione darwiniana è quelladi rompere la continuità funzionale e ciò introdurrà unlungo ragionamento sulla separazione sempre più accen-tuata fra “funzione” e “struttura” nella scienza dei sistemiviventi.
Il mutamento funzionale nella continuità strutturale (opre-adattamento) suggerisce di non considerare quel 5%di ala come un’ala provvisoria in senso funzionale. Un 5%di ala è un altro organo, con una configurazione, un’utilitàe una storia del tutto incommensurabili rispetto al suo de-stino futuro. Le ipotesi, poi, sulla funzione originaria pos-sono divergere: il 5% di ala forse serviva per sostenerel’apparato respiratorio (teoria del passaggio dalla respira-zione al volo di Darwin), o forse (ipotesi consolidatasi sullabase degli studi sul primo paleo-volatile, l’Archaeopteryx)serviva come organo termoregolatore, sostenendo l’appara-to di penne e piume e accrescendo la superficie esposta alsole (Kingsolver, Koehl 1985). Il cambiamento funzionale è
EXAPTATION: LA BIOLOGIA DELL’ IMPREVEDIBILE
consistito allora, probabilmente, in una transizione dallatermoregolazione al volo.
Alcuni studiosi hanno individuato, attraverso elabora-zioni grafiche (ottenute comparando l’utilità aerodinamica,l’utilità termodinamica e le dimensioni alari in insetti e inuccelli), le “zone di transizione funzionale”, fasi cruciali incui l’organo passa da uno sviluppo orientato verso una cer-ta funzione (quella termodinamica) a una crescita orientataverso un’altra funzione (aerodinamica). I vantaggi derivantidal “primo adattamento” a un certo punto diventano mi-noritari rispetto ai vantaggi derivanti dal “secondo adatta-mento”. Il punto di transizione, nel caso delle ali degli in-setti, dipende dalle dimensioni corporee di partenza: tantopiù grande è l’insetto tanto prima raggiunge il punto ditransizione tra la funzione termodinamica e la funzione ae-rodinamica. In questo caso, una soglia quantitativa innescauna variazione “qualitativa” che rivoluziona sia la morfolo-gia sia il comportamento, uno spunto che Stephen J.Gould accostò provocatoriamente (ma non troppo) alla se-conda legge della dialettica della natura di Engels.
Le due argomentazioni sulla non-banalità del meccani-smo di adattamento funzionale si completano a vicenda.Nel primo caso c’è una diversificazione “spaziale” (o inorizzontale) delle soluzioni adattative, una proliferazionepotenziale dei cammini di sopravvivenza, una ramificazio-ne delle linee adattative (la più macroscopica delle quali èsenz’altro il parallelismo adattativo fra mammiferi marsu-piali e mammiferi placentati, con gradi di fitness compara-bili). Nel secondo caso vi è una diversificazione “tempora-le” (o in verticale), uno slittamento funzionale e adattativonon accompagnato necessariamente da trasformazioni del-la struttura organica: non a caso citiamo un “primo” e un“secondo” adattamento.
Tuttavia, il contenuto della seconda diversificazionedella nozione di adattamento è più forte, perché escludeche la semplice esistenza di una struttura ben funzionanteoggi sia la prova di un adattamento finalizzato esteso alpassato. Un concetto tradizionale di adattamento implica
TELMO PIEVANI
lo sviluppo attivo verso un fine, determinato in un proces-so di selezione naturale. Ma il modello esplicativo classicobasato sulla reciprocità fra problema ambientale e soluzio-ne individuale non regge quando eliminiamo dalla nostraargomentazione sull’adattamento ogni implicazione finali-stica. In discussione è allora un concetto di adattamentoappiattito sul presente che si riduce, nell’abitudine argo-mentativa, a vuota tautologia: l’organo “esiste” perché“adatto” a un certo tipo di vita (se non fosse adatto, nonesisterebbe).
Il problema di fondo è che la discussione critica sulconcetto di adattamento non è una riflessione marginalesui meccanismi evolutivi: essa riguarda profondamente ilnostro modo di pensare la “storicità” della natura. Un pri-mo passo nella direzione di una migliore comprensione diquesta storicità è quello di capire che nei nostri modi diconcepire l’evoluzione si instaura un conflitto fra una con-cezione adattazionista di tipo funzionale che, appiattendol’idea di adattamento sul presente e retrodatandola finali-sticamente al passato, nega di fatto la possibilità della sto-ria e una concezione non-adattazionista che, introducendola trasformazione funzionale in itinere, accetta integral-mente la costruzione storica contingente delle strutturepresenti.
Di questa stretta implicazione fra il cambiamento fun-zionale non teleologico (ribattezzato “quirky functionalshift” da Gould 2002b) e il ruolo della contingenza nellastoria naturale Darwin fu pienamente consapevole. In al-meno due sensi fondamentali. Gli organismi si adattano adambienti locali in mutamento, cioè a condizioni ecologicheper definizione contingenti: anche se il meccanismo seletti-vo può rendere ragione, deterministicamente, dell’utilità diogni struttura in ogni contesto, il percorso generale di vitadi una specie non è deterministico. Inoltre, il cambiamentofunzionale “bizzarro” separa origine storica da utilità at-tuale, aggiungendo un ulteriore grado di contingenza alprocesso poiché ciascuna struttura porta con sé un’ampiagamma di riadattamenti possibili.
EXAPTATION: LA BIOLOGIA DELL’ IMPREVEDIBILE
La nozione di exaptation, ovvero cooptazione funzionale
Alle spalle di questa visione molto “possibilista” diDarwin vi è una concezione della selezione naturale di tipodebole, che permette una molteplicità di strategie evolutivepossibili: la selezione naturale è il filtro che vaglia, di voltain volta, le forme dimostratesi più efficienti nella lotta per lasopravvivenza (indipendentemente dai fattori che produco-no questo successo evolutivo) e favorisce per esse la tra-smissione genetica di generazione in generazione. La sele-zione naturale, in sostanza, è un puro meccanismo materia-le che produce effetti (la sopravvivenza differenziale deiportatori di mutazioni vantaggiose), e non rappresentaun’intenzione progettuale inscritta nella natura. In molteteorizzazioni successive, a partire dai testi fondamentali delprogramma neodarwinista (la cosiddetta “Sintesi Moder-na”), il ruolo della selezione naturale subì invece un sostan-ziale indurimento, trasformandosi in principio progressivodi sviluppo delle strutture organiche: in questo senso “for-te”, l’obiettivo di ogni individuo biologico è la competizio-ne riproduttiva, cioè la lotta per la massima trasmissionepossibile dei propri geni alla discendenza, e la selezione na-turale è il risultato diretto di questa competizione attiva.Ogni genere di attività degli organismi (sia essa di tipo eco-nomico o riproduttivo; o, nella nostra specie, di tipo cultu-rale, psicologico, sociale…) diviene dunque uno strumentoper vincere la competizione genetica. L’adattamento divienein tal senso la struttura scelta attivamente dalla selezione na-turale per massimizzare la trasmissione genetica, “espedien-te per facilitare la diffusione dell’informazione genetica diun organismo, processo che reca vantaggio all’organismostesso” (Eldredge 1995, p. 43). Così, la confusione termino-logica fra adattamento come processo (il meccanismo seletti-vo che filtra le varianti migliori per un contesto) e adatta-mento come prodotto (il risultato finale espresso in un orga-no o in un comportamento) generò molti fraintendimenti.
Se la selezione modella direttamente gli adattamenti,ogni caratteristica biologica sarà funzionale alla competi-
TELMO PIEVANI
zione genetica: in natura ogni cosa avrebbe dunque unoscopo, una finalità che ne giustificherebbe l’esistenza, e gliorganismi sarebbero semplicemente i veicoli per la massi-mizzazione della trasmissione genetica. Tuttavia, non tardòa emergere nel dibattito evoluzionistico, intorno agli anniSettanta, una profonda insoddisfazione per queste “narra-zioni” adattazionistiche circa l’utilità di ogni struttura or-ganica e l’onnipervasività della selezione genica.
In effetti, il termine “pre-adattamento” non aveva giova-to all’originaria intuizione darwiniana: esso mantiene l’am-bivalenza di un approccio teleologico all’adattamento, giac-ché la specie non ha ovviamente “pre-veggenza” dell’appli-cazione futura di un organo che si chiamerà “occhio” o“ala”. Il prefisso implica infatti un’accentuazione troppoforte dell’utilità potenziale futura del carattere in questione:la piuma come “pre-adattamento” (termoregolativo) “per”il volo. In realtà, le due funzioni (termoregolazione e volo)sono completamente indipendenti l’una dall’altra. GeorgeWilliams, uno dei padri della Sintesi, nel suo classico Adap-tation and Natural Selection del 1966, propose opportuna-mente di attribuire il termine adaptation soltanto a quei ca-ratteri plasmati dalla selezione naturale per la funzione chesvolgono effettivamente oggi, riservando a tutti gli altri casidi conversione funzionale in itinere il termine di effect (ef-fetto). Come aveva già scritto Darwin nel 1859, le suture delcranio nei piccoli di mammifero sono utilissime, quasi indi-spensabili, al momento del parto, ma chiaramente non sonoun adaptation per il parto poiché suture identiche sono pre-senti anche nei rettili e negli uccelli, che non ne hanno al-cun bisogno. Nei mammiferi, le suture sono un carattereche ha un ottimo effetto nel parto, ma che non esistono in“funzione” del parto.
I paleontologi Stephen J. Gould ed Elisabeth Vrba, in unsaggio del 1982 dal titolo Exaptation, a Missing Term in theScience of Form, scelsero un altro termine, più preciso, da at-tribuire ai caratteri sorti per una ragione indipendente dallaloro utilità attuale. Essi circoscrissero l’insieme generale deicaratteri definibili come aptations, cioè tutte le caratteristiche
EXAPTATION: LA BIOLOGIA DELL’ IMPREVEDIBILE
biologiche in qualche modo utili (aptus) per il benessere degliorganismi e delle specie, identificando due sottoinsiemi: ilsottoinsieme dei caratteri plasmati dalla selezione per la fun-zione che ricoprono attualmente (adaptations); e il sottoinsie-me dei caratteri formatisi per una determinata ragione, o an-che per nessuna ragione funzionale specifica, e poi resisi di-sponibili alla selezione per il reclutamento attuale. L’ipotesifu cioè quella di non considerare come ad-aptations (utili per,“ad”, la funzione attuale) tutti i casi in cui vi fosse un cambia-mento sostanziale di funzione a parità di struttura: si parlòdunque di ex-aptations in tutti i casi in cui vi fosse una coopta-zione, in vista di nuove funzioni, di strutture impiegate in pas-sato per funzioni diverse o per nessuna funzione. Il secondosottoinsieme divenne dunque quello degli exaptations (in ita-liano suonerebbe “exattamenti”), cioè strutture resesi utili(aptations) in conseguenza della loro struttura o forma (ex).Detto secondo la terminologia di Williams, gli adaptations as-solvono a “funzioni”, gli exaptations producono “effetti”.
Qualora la funzione originaria non sia nota o comun-que non si conoscano i cambiamenti funzionali subiti daun carattere, la proposta fu quella di mantenere il terminegenerale aptations. Da ciò si evince chiaramente, a dispettodi talune interpretazioni successive, che il concetto di exap-tation non è assolutamente sostitutivo dell’idea di adatta-mento. Gli exaptations stanno alla base della teoria dell’e-voluzione, fin dalla sua prima formulazione, come una sot-tocategoria di tutti caratteri che contribuiscono alla so-pravvivenza. Alcuni di questi sono modellamenti direttidella selezione naturale, altri sono cooptazioni funzionali.Come già aveva notato Darwin (1859, p. 243):
L’esempio della vescica natatoria nei pesci è particolarmenteappropriato, perché dimostra chiaramente un fatto molto im-portante: che un organo originariamente costruito per unoscopo, cioè la funzione idrostatica, può trasformarsi in un or-gano capace di una funzione completamente diversa, cioè larespirazione. La vescica natatoria in certi pesci si è trasforma-ta anche in un accessorio dell’organo dell’udito.
TELMO PIEVANI
La tassonomia dei caratteri evolutivi diventa (Gould2002b, p. 1.539):
Con questa nuova cornice teorica, che si oppone all’a-dattazionismo (cioè all’equivalenza generale fra origine sto-rica e utilità attuale) tipico di alcune elaborazioni internealla Sintesi Moderna, si opera una scissione fra la forma ela funzione di un organo: la funzione non precede semprela forma, determinandola; le funzioni possono variare a pa-rità di forma e di struttura. In tal modo, l’evoluzione nonappare più come il regno della necessità e di un’ottimalitàadattativa di tipo finalistico, ma come il risultato polimorfoe imprevedibile di percorsi contingenti, di adattamenti se-condari e sub-ottimali, di bricolage imprevedibili. L’impie-go adattativo attuale (più o meno soddisfacente) di unastruttura non implica che questa sia stata costruita gradual-mente e selettivamente per quell’impiego: l’utilità attuale el’origine storica di un carattere devono essere distinte, unatesi che Gould fa risalire addirittura a Friedrich Nietzsche(pp. 1.516-1.521). In effetti, ne La genealogia della morale,Nietzsche critica aspramente le ricostruzioni genealogicheche giustificano un comportamento, un carattere o un’isti-
EXAPTATION: LA BIOLOGIA DELL’ IMPREVEDIBILE
Processo
La selezione naturale modellail carattere per un uso attuale– adattamentoUn carattere, precedentemen-te modellato dalla selezionenaturale per una particolarefunzione (un adattamento), ècooptato per un nuovo uso –cooptazioneUn carattere, la cui originenon può essere ascritta all’a-zione diretta della selezionenaturale (un non-adattamen-to), è cooptato per un uso at-tuale – cooptazione
Carattere
Adaptation
Exaptation
Exaptation
Uso
Funzione
Effetto
Effetto
tuzione presente (per esempio, i sistemi di punizione nellesocietà contemporanee) deducendo la loro origine storicadalla funzione che svolgono attualmente. Una corretta me-todologia storica deve scindere la genesi di una strutturadal suo fine attuale:
Per bene che sia compresa l’utilità di un qualsiasi organo fi-siologico (o anche di un’istituzione giuridica, di un costumesociale, di un uso politico, di una determinata forma nellearti o nel culto religioso), non è per ciò stesso ancora com-preso nulla relativamente alla sua origine: comunque ciòpossa suonare molesto o sgradevole. Da tempo immemora-bile, infatti, si è creduto di comprendere nello scopo com-provabile, nell’utilità di una cosa, di una forma, di un’istitu-zione, anche il suo fondamento di origine, e così l’occhio sa-rebbe stato fatto per vedere, la mano per afferrare. Così ci siè figurata la pena come fosse stata inventata per castigare(Nietzsche 1887, p. 66).
L’airone nero africano utilizza le ali (a loro volta unexaptation!) per creare in acqua un cono d’ombra nel qua-le attira i pesci: non un adattamento diretto dunque, maun doppio effetto collaterale (Gould, Vrba 1982; Eldredge1995). Di certo, le ali non servono “per” fare ombra nel-l’acqua, ma un loro effetto secondario utile può anche es-sere quello. L’insieme dei caratteri definibili come apta-tions viene così ulteriormente circoscritto dalla definizionedi un sottoinsieme che specifichi la possibilità di un cam-biamento funzionale in una continuità strutturale almenoparziale:
Noi abbiamo coniato il termine “exaptation” per quei trattiformatisi per una certa ragione, e poi resisi fortunosamentedisponibili e cooptati dalla selezione per un’altra ragione(Gould, Vrba 1982). Le correlazioni forma-funzione possonoessere onnipresenti in natura, e possono esprimere il buon di-segno degli organismi e delle altre entità, ma non necessaria-mente esse discendono direttamente per “adaptation” (nelsenso di Williams 1966), cioè per selezione diretta in vistadell’utilità attuale (Vrba, Gould 1986, p. 225).
TELMO PIEVANI
Il termine ex-aptation deriva dunque dalla sostituzionedel prefisso “ad” di ad-aptation, indicante una sintonizza-zione graduale dell’organismo alle esigenze ambientali, conil prefisso “ex”, indicante una trasformazione funzionale“a partire da” strutture già disponibili. L’etimologia ci con-sente di associare in un certo senso il termine exaptationcon “bricolage evolutivo”. Se l’organo cooptato svolgeràuna funzione diversa da quella per cui è stato selezionato,potremo in molti casi definirlo un carattere “sub-ottimale”,evidenziando in tal modo l’intuizione darwiniana circal’importanza della parziale imperfezione in natura: l’impie-go attuale, più o meno soddisfacente, di una struttura nonimplica che questa sia stata costruita gradualmente e selet-tivamente per quell’impiego.
L’adattazionismo “teleologico” del programma neo-darwiniano è lo sfondo critico di questa proposta teorica:non possiamo sostenere che esista una sola forza, in sensofunzionale, di “trazione” del processo evolutivo. Non esi-ste una direzione univoca del processo, determinata dal-l’avvicinamento progressivo a un’ottimalità funzionale. Lateoria degli exaptations (usato spesso al plurale dagli auto-ri, che così intendono per exaptation il singolo carattere),specialmente nella sua versione allargata a tutte le relazionievolutive gerarchiche
(...) contiene un’importante lezione per la nostra attitudine dibase verso la storia. Le ipotesi sulla ottimalità adattativa rap-presentano il grado massimo della nostra sottovalutazionedella storia e illustrano la forma e l’ecologia come un proble-ma di equilibrio naturale in un mondo senza tempo. Exapta-tion accoglie invece tutta la bizzarria della contingenzastorica. (...) La gerarchia e lo status exattativo (exaptivestatus) della causazione fra i livelli evolutivi ci insegnano cheabitiamo in un mondo di enorme flessibilità e contingenza,un mondo costruito da una storia irreversibile (p. 226).
Come scrive Gould in un saggio del 1987, la nozione diexaptation ha tre radici teoriche principali, risalenti alle ri-cerche della prima metà degli anni Settanta:
EXAPTATION: LA BIOLOGIA DELL’ IMPREVEDIBILE
La prima derivò dai sette anni di lavoro al libro Ontogeny andPhylogeny (1977) e dal mio crescente rispetto per la grandeletteratura strutturalistica europea sulle leggi della forma (ri-salenti a pensatori così fondamentali come Goethe e Geof-froy Saint-Hilaire). La seconda si sviluppò da una serie di ar-ticoli tecnici da me scritti fra il 1973 e il 1977 in collaborazio-ne con David Raup, Tom Schopf, Dan Simberloff e JackSepkoski su strutture ordinate nella filogenesi che hanno ori-gine all’interno di sistemi puramente casuali (ma che in pre-cedenza erano state attribuite senza discussione all’adatta-mento darwiniano). La terza radice mi fu fornita dalla socio-biologia, mentre mi sforzavo di capire che cosa ci fosse disbagliato in una letteratura speculativa che raggiungeva con-clusioni sulle persone così in disaccordo con i miei concettidella realtà (Gould 1987a, p. 41).
In questa “archeologia dell’exaptation” possiamo dun-que rintracciare una radice filosofica dell’exaptation, ovve-ro il debito di Gould per la tradizione strutturalista in bio-logia, inaugurata da Goethe e Geoffroy de Saint-Hilaire, equindi rinvigorita dalla “scienza della forma” di D’ArcyThompson, il cui “classico paradigmatico” Crescita e forma(1917-42) rappresentò per lui il manifesto dell’anti-funzio-nalismo; una radice sperimentale connessa, ovvero la pre-senza di omologie strutturali nelle discendenze filogeneti-che, oggi attribuite ai vincoli dello sviluppo determinatidall’azione dei geni regolatori; e una radice politica, ovverola condanna delle interpretazioni sociobiologiche, forte-mente riduzionistiche, della natura umana e dei comporta-menti individuali e collettivi. In un passo dello stesso libroGould sintetizza in questo modo il suo percorso di ricerca:
L’errore consistente nell’inferire un’origine storica dall’utilitàattuale si evidenzia nel modo migliore notando che molte, senon tutte, le strutture biologiche sono cooptate da usi prece-denti diversi, non progettati in vista di funzionamenti attuali.Gli arti erano pinne; gli ossicini dell’orecchio erano ossa dellamascella, e le ossa della mascella erano ossa dell’arco bran-chiale; ali incipienti non potevano permettere il volo, ma po-trebbero essere servite per la termoregolazione. Lo stesso er-
TELMO PIEVANI
rore mina la tesi centrale della sociobiologia popolare. Il cer-vello umano divenne grande per opera della selezione natura-le (chissà perché, ma probabilmente per una buona causa).Eppure senza dubbio la maggior parte delle “cose” che oggifa il nostro cervello, e che sono essenziali sia per la nostra cul-tura sia per la nostra sopravvivenza, sono epifenomeni dellacapacità di elaborazione dell’informazione propria di questamacchina, e non entità darwiniane con una base geneticacreate specificamente dalla selezione naturale in vista della lo-ro funzione attuale. La sociobiologia popolare deve accampa-re la pretesa di svelare le origini e il significato del pensiero edel comportamento umani. Se però la maggior parte dei com-portamenti sono epifenomeni cooptati e non entità seleziona-te, le spiegazioni sociobiologiche nel senso dell’adattazioni-smo non possono riguardarli (Gould 1987a, p. 49).
Quello che per Gould è l’errore centrale dell’adattazio-nismo sociobiologico (da lui definito il “darwinismo ste-reotipato” di Edward O. Wilson – Wilson 1971; 1975) èoggi più forte che mai nei programmi di ricerca della psi-cologia evoluzionistica e della genetica comportamentale.Viceversa, sul versante etologico, la nozione di exaptationsuggerisce che i comportamenti siano valutabili come “epi-fenomeni cooptati” rispetto alla funzione adattativa attua-le. La definizione di exaptation sopra riportata reca con séalmeno tre conseguenze epistemologiche fondamentali. Laprima è una conferma ulteriore della “grande asimmetria”che regna nella storia dell’evoluzione. È infatti evidente,dall’idea di exaptation, che la selezione naturale opera effi-cacemente laddove si tratti di distruggere o comunque farregredire le varianti sfavorevoli (gli organismi poco adatti),mentre è molto meno efficiente quando si tratta di plasma-re in positivo o di costruire dal nulla (e in modo univoco)le strutture utili alla sopravvivenza:
Una grande asimmetria (...) pervade le storie dell’evoluzione.Io sono disposto ad ammettere che le strutture dannose sa-ranno eliminate dalla selezione naturale se causano abbastan-za disagio. Ma l’altra faccia dell’argomentazione non è sim-metrica: non è vero che la selezione naturale sia in grado di
EXAPTATION: LA BIOLOGIA DELL’ IMPREVEDIBILE
costruire strutture utili: molte forme e molti comportamentihanno successo per altre ragioni (Gould 1987a, p. 50).
Possiamo addirittura estendere l’affermazione osservan-do che se frequentemente l’opera distruttiva della selezionemostra i suoi frutti, raramente assistiamo alla creazione dinuove forme in vista di un fine selettivo preordinato. Sullosfondo di questa argomentazione sull’asimmetria dell’azio-ne della selezione vi è una divaricazione concettuale fra l’i-dea di “successo” in natura (successo riproduttivo, succes-so per supremazia, per “superiorità” adattativa) e l’idea di“progetto” in natura: l’exaptation recide il legame fra ilsuccesso nella lotta per la sopravvivenza e il presunto pro-getto evolutivo dell’individuo.
In secondo luogo, l’exaptation mostra, per un verso,che è in genere arduo ricostruire una sequenza graduale econtinua di piccoli passi impercettibili, dal “nulla adattati-vo” al soddisfacimento ottimale della funzione. L’evolu-zione assomiglia piuttosto a un percorso accidentato, riccodi biforcazioni e di svolte imprevedibili da uno scenario divita a un altro quasi inimmaginabile. Mostra, per altro ver-so, che l’evoluzione non è in genere riconducibile alla fis-sazione selettiva di singole parti autonome ottimali in vistadella realizzazione di un disegno complessivo: il tracciatoaccidentato dell’evoluzione è percorso da sistemi di svi-luppo integrati e gerarchicamente interconnessi, non daautomi “adattativi” (morfologici e comportamentali) pro-grammati per un perfezionamento progressivo. In questomodo, l’idea si riconnette a una visione antideterministadel “potenzialismo” biologico, per cui alla base dei pro-cessi evolutivi vi è principalmente la disponibilità di unariserva di mutamenti potenziali largamente ridondante:l’evoluzione deriva da un principio di flessibilità potenzia-le e non da derivazioni deterministiche riguardanti ognisingolo “atomo” evolutivo.
Infine, quella di exaptation è una teoria post-darwinianache integra e arricchisce, in un terzo significato, la teoriaoriginaria successivamente irrigiditasi nel programma adat-
TELMO PIEVANI
tazionista e funzionalista della Sintesi Moderna. Getta unanuova luce sulla possibilità di riabilitare una biologiamorfologico-strutturale che reinterpreti l’evoluzione comeinterazione di forze interne (regole strutturali, vincoli gene-tici) e forze esterne (nicchie ecologiche, cambiamenti di re-gole ambientali):
Il darwinismo stereotipato (...) è una teoria di puro funziona-lismo che nega la storia e che considera la struttura organicacome neutra dinanzi a un ambiente attivamente plasmante. Èuna teoria riduzionistica a senso unico sull’innesto di infor-mazione dall’ambiente nell’organismo attraverso la selezionenaturale di buone soluzioni. Noi abbiamo bisogno di unateoria più ricca, di una biologia strutturale, che consideri l’e-voluzione come un’interazione di esterno e interno, dell’am-biente e delle regole strutturali, per l’architettura genetica eontogenetica: regole fissate dalle contingenze della storia eleggi fisico-chimiche della materia stessa. La caduta della so-ciobiologia popolare segnerà un beneficio, per quanto picco-lo, per questa teoria più ricca; la soddisfazione principaleverrà da una nozione più profonda dell’integrazione: am-biente e organismo; funzione e struttura; funzionamento at-tuale e storia passata; il mondo esterno che passa attraversoun confine (sia esso la pelle di un organismo o la frontierageografica di una specie) nella vitalità organica al suo interno(Gould 1987a, p. 51).
L’evoluzione come “trasformazione del possibile”: la pri-ma accezione di exaptation
In un saggio sulla teoria ortogenetica antidarwiniana diCharles Otis Whitman (Gould 1993, pp. 407-424), appli-cata alla selezione dei colori del piumaggio dei colombi,Gould prende provocatoriamente le difese del biologo an-tiselezionista americano di fine Ottocento, sostenendo chel’ortogenesi suggerì una soluzione interessante del rappor-to fra variazioni casuali e “canali” dello sviluppo. La mo-nografia sul piumaggio dei piccioni di Whitman fu presen-
EXAPTATION: LA BIOLOGIA DELL’ IMPREVEDIBILE
tata nel 1904, durante un congresso collaterale all’Esposi-zione Internazionale di Saint Louis. La scelta dei piccionifu fatta da Whitman in aperto contrasto con Darwin, cheaprì L’origine delle specie proprio con una dissertazionesulla selezione artificiale dei piccioni. Se non prendiamo al-la lettera le tesi ortogenetiste sull’inflessibilità delle tenden-ze evolutive privilegiate, l’accento posto sull’esistenza didirezioni dello sviluppo offre uno spunto interessante perfissare la prima accezione del concetto di exaptation. Con“accezione” intendiamo una gamma di meccanismi natura-li che può fornire il contesto opportuno per il verificarsi diuna dinamica evolutiva per exaptation.
Il primo di questi meccanismi consiste, propriamente,nell’intreccio evolutivo fra caratteri portati dai canali disviluppo, in particolare i canali del processo di accresci-mento dell’individuo o “canali ontogenetici”, e caratterideterminati dalla normale selezione naturale. Lo studiodell’ontogenesi, evidenziando l’influenza della prima radi-ce teorica di exaptation, ha condotto Gould all’idea cheesistano direzioni vincolate dello sviluppo individuale,coordinate da geni regolatori e da articolate interconnes-sioni genetiche. Queste non sono naturalmente “vie a sen-so unico”, cioè tendenze intrinseche di matrice geneticanon influenzabili da alcun processo selettivo come nellateoria ortogenetica antidarwiniana, ma “forti tendenzenella direzione della variazione disponibile al mutamentoevolutivo”:
Se la selezione naturale controllasse completamente l’evolu-zione, non esisterebbero tali limiti e vie prefissati, e gli organi-smi sarebbero come palle da biliardo, capaci di muoversi inqualsiasi direzione e soggetti a qualsiasi mutamento di posi-zione indotto dalla stecca da biliardo della selezione naturale.Ma, per prendere in prestito un’antica metafora da FrancisGalton, supponiamo che gli organismi, anziché palle da bi-liardo, siano poliedri, e che possano muoversi solo spostan-dosi da una faccia (...) verso un’altra adiacente. Per muoversi,possono avere bisogno di una spinta dalla selezione naturale,ma sono limitazioni e possibilità interne a fissare la direzione
TELMO PIEVANI
del mutamento possibile. Se le facce del poliedro di Galtonvengono costruite sulla base di programmi genetici e ontoge-netici ereditari, devono esistere forti costrizioni interne al mu-tamento evolutivo, e l’intuizione di Whitman è corretta pur-ché trasformiamo la sua via a senso unico in un canale, ossiain una forte tendenza nella direzione della variazione disponi-bile al mutamento evolutivo (Gould 1993, p. 422).
“Riconoscere un potenziale limite significa pensare astrumenti che consentano di trascenderlo. La libertà, comedisse Spinoza, è il riconoscimento della necessità” (p. 424).Questa prima accezione di exaptation, sottolineando il ruo-lo evolutivo dei vincoli genetici e ontogenetici (i “lati pro-duttivi” del poliedro di Galton), pone allora un chiaro limi-te alla presunta onnipervasività e progressività della selezio-ne naturale, intesa dai panselezionisti avversari di Whitmannei primi anni del Novecento come una macchina a motoperpetuo indirizzata al miglior adattamento possibile, allasoluzione ottimale per ciascun problema ambientale:
Il più grave fra i fraintendimenti maggiormente diffusi consi-dera l’evoluzione come una macchina inesorabile, la quale la-vora a produrre adattamenti ottimali come le migliori soluzio-ni a problemi posti da ambienti locali, soluzioni non vincolatedalle bizzarrie e dalle storie passate di organismi (p. 422).
Fenomeni biologici come l’allometria (mutamenti diforma associati a variazioni di volume), la simmetria bilate-rale, l’assenza di strutture motorie circolari, lo stile cogniti-vo animale di decisione sì-no fondato su stimoli evocatorisemplici, la predilezione per arti superiori con cinque ditadimostrano l’incidenza di canali primari dello sviluppo “ar-chitettonico” individuale: canali che poi si mescolano e siintegrano in forme contingenti con le variazioni indottedalla particolare storia della specie e dell’individuo. Le vieontogenetiche sono l’eredità ancestrale, le tracce della sto-ria profonda che si mescolano e si ibridano con le tracce distorie “locali”. Richard Owen, massimo anatomista dei ver-tebrati ottocentesco, ne parlò già a suo tempo, riferendosi
EXAPTATION: LA BIOLOGIA DELL’ IMPREVEDIBILE
alla costanza del modello attuale delle cinque dita, in quan-to riduzione progressiva da un modello archetipo ridon-dante di otto dita, come a uno degli “archetipi o modelliprimordiali” delle anatomie animali. Per analoghe ragioni,le ruote funzionano molto bene ma gli animali non posso-no costruirle a causa di vincoli strutturali e fisici. L’adatta-mento, in sostanza, non ha i poteri di un ingegnere, maquelli di un bricoleur che opera con le parti di cui dispone,generando da poche strutture originarie una grande varietàdi forme. Come scrive ancora Gould (p. 423):
Se fosse valida la visione puramente adattazionista, potrem-mo avere il conforto di vedere noi stessi, e tutte le altre crea-ture, essenzialmente “giusti”, ossia perfettamente adattati, al-meno in relazione agli ambienti locali in cui si esercita la sele-zione naturale. L’evoluzione è però la scienza della storia edella sua influenza. Nasciamo nel nostro ambiente locale por-tandoci appresso un bagaglio di miliardi di anni; non siamomacchine costruite recentemente, in vista delle nostre realtàcorrenti. Questi bagagli storici si esprimono nei termini deicanali genetici e ontogenetici che condussero Whitman trop-po lontano. Ma questi stessi canali, correttamente interpretaticome tendenze fortemente definite nella variazione, piuttostoche come vie di mutamento a senso unico, ci darebbero unavisione molto più ricca dell’evoluzione come sottile equilibriotra costrizioni della storia e modificazioni imposte dalla sele-zione naturale.
Lo sviluppo è simile al “poliedro di Galton” in cui ci sipuò muovere soltanto in un numero limitato di direzioni de-finite. Queste costrizioni, in quanto principi di organizzazio-ne strutturale delle anatomie animali, non immobilizzanol’evoluzione, ingessandola entro schemi direzionali immuta-bili come avviene per l’ortogenesi e per taluni suoi “sbanda-menti” teorici verso l’eugenetica (di cui proprio Francis Gal-ton, “eccentrico cugino di Darwin”, fu il fondatore). Questilimiti al potere del “lento scrutinio” della selezione naturalesi traducono in opportunità di cambiamento inedite quandointeragiscono con l’ambiente. “Vincoli” e “limiti” non han-
TELMO PIEVANI
no necessariamente un’accezione negativa. L’evoluzione ap-pare piuttosto come un’interazione di forze interne di cana-lizzazione dell’ontogenesi e forze esterne di rimodellamentofunzionale. I vincoli sono dunque co-generatori di fitness,sono il contributo interno che gli organismi offrono al lorofuturo evolutivo:
Le direzioni reali del mutamento evolutivo registrano un’inte-razione dinamica tra spinte esterne e costrizioni interne. Le co-strizioni non sono solo limiti negativi a possibilità panglossiane,bensì partecipano in modo attivo al mutamento evoluzionisti-co. (...) Dobbiamo modificare la nostra immagine dell’evolu-zione, rappresentandocela come un’interazione di esterno (se-lezione) e di interno (costrizioni), e non come una traiettoria li-bera verso un maggiore adattamento (p. 441, corsivi nostri).
Le costrizioni ontogenetiche non frenano l’evoluzionema la vincolano creativamente, sono anzi una fonte di va-riazione potenziale pressoché inesauribile, un deposito pri-mario del cambiamento evolutivo. I limiti ontogenetici so-no la ricchezza funzionale del passato (una sorta di reper-torio delle “funzioni storiche”) che si mescola alla ricchez-za adattativa del presente (l’“utilità attuale”).
La prima gamma potenziale di exaptations sarà definitaallora dall’interazione complessa fra eredità e ambiente, omeglio fra vincoli interni e possibilità esterne quale motoredel cambiamento evolutivo (exaptation 1).
Potremmo vedere questi temi in una luce pessimistica, comeun freno imposto al potere della selezione di costruire con tut-ta la libertà di uno scultore umano. Ma suggerisco una letturapiù positiva. Le costrizioni che si esercitano sullo sviluppo in-carnano i due temi gemelli e non poi così contraddittori dei li-miti e delle opportunità. Le costrizioni precludono certi risul-tati fantastici, ma forniscono anche un pool enorme di poten-zialità disponibile per futuri mutamenti (p. 451, corsivi nostri).
Nella tensione essenziale tra fattori interni e fattoriesterni si perde ogni possibilità di “armonizzazione” li-
EXAPTATION: LA BIOLOGIA DELL’ IMPREVEDIBILE
neare fra organismo e ambiente, deviando la visione evo-lutiva del pensiero naturale classico fondato sulle “spe-ranze” di un adattamento ottimale lamarckiano (per ere-ditarietà dei caratteri acquisiti) o darwiniano (per selezio-ne dei migliori):
Ciascun comportamento individuale può essere un adatta-mento meraviglioso, ma deve essere plasmato all’interno diuna costrizione dominante. Che cos’è più importante: la bel-lezza dell’adattamento o il vincolo che lo limita a un ambitopermissibile? Noi non possiamo scegliere, e non abbiamo ne-cessità di scegliere, poiché entrambi i fattori definiscono unatensione essenziale che regola l’intera evoluzione (Gould1983, p. 54).
In un passo successivo dello stesso saggio del 1983 tro-viamo una prima classificazione estesa dei caratteri adatta-tivi, che sarà ripresa da Lewontin e da Vrba negli anni se-guenti:
Le fonti della forma organica e del comportamento sonomolteplici e comprendono almeno tre categorie primarie. Neabbiamo appena esaminato due: adattamenti diretti plasmatidalla selezione naturale (sfruttamento da parte di fratellimaggiori dello stile intellettuale dei loro genitori, con facileeliminazione dei compagni di nido); e conseguenze poten-zialmente adattative di modelli strutturali fondamentaliagenti come vincoli sui tipi di adattamento possibili (lo stileintellettuale di decisioni sì-no fondato su stimoli evocatorisemplici). In una terza categoria troviamo adattamenti ance-strali ben definiti che vengono usati oggi in modi diversi daidiscendenti (p. 54).
I caratteri acquisiti da un organismo che vive con di-screto successo in un ambiente non sono prevedibili né de-ducibili dalle caratteristiche dell’ambiente stesso, comehanno dimostrato molti studi (fra cui quello anticipatoredell’ortogenetista John T. Gulick sulle forme imprevedibilidelle conchiglie delle chiocciole hawaiane, del 1905; le tesidi Gulick furono confermate dalle ricerche sistematiche di
TELMO PIEVANI
Henry Edward Crampton, che dedicò ben cinquant’anniall’analisi delle conchiglie su isole oceaniche, convenendoalla fine sulla natura non adattativa della maggior partedelle differenze su piccola scala di forma e di colore frachiocciole di valli adiacenti) su specie animali adattate adambienti e climi identici che pure mostrano caratterimorfologici sostanzialmente eterogenei.
Non sempre una classe di stimoli ambientali uniformiproduce soluzioni morfologiche identiche. O la conoscen-za del rapporto organismo-ambiente è così superficiale danon aver ancora individuato la differenza fra un “sistemadi sviluppo” e l’altro, e se così non resta che attendere lascoperta dell’adattamento ottimale che non si era indivi-duato (come tentò di dimostrare Wallace reagendo alla tesidi Gulick; e come lo stesso Gould, definitosi un “incrolla-bile adattazionista” in età giovanile, tentò di fare nella suatesi di dottorato insieme a David Woodruff, conclusa nel1969), oppure la fonte del mutamento creativo degli orga-nismi non è solo la selezione naturale. Se in un contestoecologico possono trovarsi ben adattate molte anatomiepossibili di una stessa forma animale, forse l’incidenza difattori congeniti (ereditari, strutturali, o anche solo dovutia vincoli fisici) non è irrilevante.
La produzione di “stranezze che hanno un senso” evo-lutivo dimostra la sorprendente flessibilità evoluzionisticaderivante da conseguenze di un disegno ereditato:
Il materiale organico non è plasmabile senza limiti e la sele-zione naturale non è onnipotente. Ogni piano organico è pre-gnante di possibilità evoluzionistiche, ma limitato nelle dire-zioni di mutamento potenziale che può seguire (p. 157).
Exaptation 1 è anche il compimento di un altro temaimportante del lavoro di Gould: la sovrapposizione deltempo lineare e del tempo ciclico in natura. L’esempio del-l’ittiosauro è senza dubbio il più chiaro. In questo “pesce-lucertola” ancestrale troviamo una mescolanza originale dielementi indotti dal suo adeguamento a un’ecologia marina
EXAPTATION: LA BIOLOGIA DELL’ IMPREVEDIBILE
(per cui si registra una serie di “convergenze evolutive”,cioè lo sviluppo di caratteri simili a partire da strutture ini-ziali diverse, con i pesci) e caratteri ereditati dalla sua di-retta discendenza dalla famiglia dei rettili. Anche se nel1836 l’anatomista William Buckland, proseguendo gli studipionieristici di Richard Owen sugli ittiosauri in una pro-spettiva adattazionista, invocò la precisa convergenza fra it-tiosauro e pesce come prova della bontà di Dio, vi è chiara-mente una coevoluzione di caratteri “analogici” (determi-nati da fattori esterni) e caratteri “omologici” (determinatida strutture interne ereditate). Genealogia e funzionalitàinteragiscono nel formare un organismo peculiare che nellasua “storicità” rappresenta la coimplicazione fra la “frecciadel tempo” (modificazioni cumulative, irreversibili, di tipofunzionale) e il “ciclo del tempo” (il continuo ritorno divincoli omologici sedimentati, Gould 1987b).
Da qui il merito storico di scienziati non ortodossi, co-me il russo Nikolaj I. Vavilov (oppositore sfortunato delpotente stalinista e genetista lamarckiano Trofim D. Ly-senko nel 1936), che in disaccordo con il darwinismo sele-zionista insistettero sull’importanza delle omologie di svi-luppo. Vavilov introdusse il “principio delle serie omolo-ghe”, interpretando in chiave ortogenetica le serie paralleledi varietà morfologica negli animali come “risposte identi-che degli stessi sistemi genetici” (Vavilov 1922):
Una teoria completa dell’evoluzione deve riconoscere unequilibrio fra forze ambientali “esterne” che impongonouna selezione per conseguire un adattamento alle condizionilocali e forze “interne” che rappresentano vincoli impostidall’eredità e dallo sviluppo. Vavilov insistette in misura ec-cessiva sui vincoli interni e sottovalutò il potere della sele-zione. I darwiniani occidentali hanno però sbagliato in egualmisura ignorando praticamente (pur riconoscendoli in teo-ria) i limiti imposti alla selezione dalla struttura e dallo svi-luppo: quelli che Vavilov e i biologi del passato chiamavano“leggi della forma”. C’è bisogno, in due parole, di una veradialettica fra i fattori esterni e interni dell’evoluzione(Gould 1983, p. 144).
TELMO PIEVANI
Il disegno anatomico rettiliano ereditato impedisce diconsiderare l’ittiosauro un pesce nonostante le evidentianalogie formali e comportamentali: se infatti esaminianoattentamente le principali convergenze dell’animale notia-mo alcune differenze strutturali dovute al persistere diforme ancestrali irriducibili e non plasmabili dall’adatta-mento. Il piano corporeo, o se vogliamo la “forma” ance-strale, oppone dialetticamente una resistenza evolutiva al-l’adattamento. Gli organi “da pesce” dell’ittiosauro, comeintuì il paleontologo belga Louis Dollo nel 1892, sonosub-ottimali rispetto all’ambiente marino (Dollo 1892).
Exaptation 1 illustra quindi un concetto dialettico di“indistruttibilità del passato” che Dollo presentò nel1893 come fondamento del suo “principio di irreversibi-lità” dell’evoluzione. La “legge di Dollo” è un’acquisizio-ne importante del pensiero evolutivo contemporaneo.L’intreccio fra condizionamenti interni e modificazioni in-dotte dall’esterno fa sì che le trasformazioni evolutive sia-no così complesse da rendere di un’improbabilità astro-nomica la ripetizione identica di due percorsi evolutivi.Nella coevoluzione fra forme e funzioni, il “film della vi-ta” non si ripete mai due volte: l’evoluzione, in quantostoria irreversibile ed espressione di percorsi unici, si ri-vela come un “concatenamento di improbabilità”. Exap-tation era “il termine che mancava nella scienza della for-ma” (Gould, Vrba 1982).
Exaptation di secondo tipo: l’asimmetria fra utilità attua-le e origine storica
La seconda gamma potenziale di exaptations si differen-zia dalla prima nella considerazione del primo dei due poli,quello ereditario o interno. Non sempre, infatti, la funzio-ne ancestrale è un tributo dato dall’organismo all’ereditàontogenetica. Può anche essere che la funzione primariasia stata a sua volta selezionata per un’utilità passata, deltutto indifferente all’utilità attuale. Con questa seconda let-
EXAPTATION: LA BIOLOGIA DELL’ IMPREVEDIBILE
tura del meccanismo exattativo rientramo nel caso specifi-co del pre-adattamento darwiniano e consideriamo comemeccanismo quello di un passaggio fortuito da una funzio-ne primaria (per esempio la termoregolazione) a una fun-zione secondaria (il volo): un riorientamento funzionaledella struttura organica.
Una componente casuale interviene non solo nel fornirela mutazione favorevole iniziale (la “materia prima”), maanche nel permettere il passaggio da una “pre-funziona-lità” soddisfacente della struttura (l’origine storica) a unafunzione adattativa che è incommensurabile alla sua ante-cedente (l’utilità attuale). C’è insomma una pre-funziona-lità, ma non un pre-condizionamento adattativo nel pro-cesso di transizione.
Un caso di pre-funzionalità, incommensurabile al suofuturo adattativo, è quello dei “precondizionamenti sen-soriali in un contesto genealogico”, cioè propensioni sen-soriali e cognitive degli animali che nel contesto di unadinamica di selezione sessuale inducono a sviluppare ta-lune strutture o taluni comportamenti fortuiti rispetto autilizzazioni successive. Nel caso del comportamento del-le quaglie studiate dall’etologo Patrick Bateson (1982), adesempio, una preferenza estetica ancestrale le porta a evi-tare rapporti incestuosi svantaggiosi sul piano selettivo.Le pre-funzioni che, a posteriori, potevano risultare utiliper quell’adattamento specifico erano naturalmente infi-nite. Al cuore di questa spiegazione del cambiamento tro-viamo allora un principio di “ridondanza funzionale”.Ogni carattere complesso racchiude in sé un ampio mar-gine di potenzialità funzionale, una gamma estesa di uti-lizzazioni possibili:
Qui l’eredità storica è un’ampia regola cognitiva ricca di po-tenzialità che potrebbero realizzarsi in mille modi possibili:preferisci maschi più grossi o preferisci maschi di familiaritàintermedia. Un adattamento precisa poi la regola scegliendouna manifestazione: una spada, uno schiocco o un cugino pri-mo (Gould 1993, p. 437).
TELMO PIEVANI
Appurata la “buona sorte” iniziale, l’evoluzione si inca-nala poi in una traiettoria fra tutte le possibili. In tal modoessa rivela un’ulteriore dualità: appare sempre come l’in-treccio fra una “bizzarria” (in un senso tecnico e non soloevocativo, cioè il perdurare di una funzione passata, eredi-taria o selettiva a sua volta, nel presente) e un aggiusta-mento “ragionevole” (l’adattamento per selezione succes-sivo). A volte l’ambiguità fra utilità attuale e origine stori-ca è tale da consentire autentiche inversioni della causalitànaturale: si scambia l’effetto dell’emergenza di una strut-tura con la causa della sua comparsa. È il caso della aplo-diploidia, un particolare sistema di determinazione delsesso di alcuni insetti, per cui uova non fecondate dannomaschi e uova fecondate danno femmine. L’aplodiploidiaè causa dell’organizzazione sociale delle specie che la pra-ticano e non effetto delle (o adattamento alle) organizza-zioni sociali medesime:
È un chiaro errore, anche se deplorevolmente comune, sup-porre che l’utilità corrente di un carattere consenta di formu-lare un’inferenza sulle ragioni della sua origine evolutiva. L’u-tilità corrente e l’origine storica sono cose ben diverse. Ognicarattere, indipendentemente dal come o dal perché si siaevoluto in origine, diviene disponibile per la cooptazione adaltri ruoli, spesso sorprendentemente diversi. I caratteri com-plessi sono ricchissimi di potenzialità: il loro uso concepibilenon è limitato alla loro funzione originaria (io confesso diavere usato una carta di credito per forzare una porta). Equesti mutamenti evolutivi di funzione possono essere tantostrani e imprevedibili quanto sono grandi i potenziali di com-plessità. È un fenomeno ricorrente, a cui si deve il caratteremirabilmente indefinito dell’evoluzione (Gould 1983, p. 63).
Gli esempi di cooptazione funzionale sono i più disparati:
Le pinne equilibratrici dei pesci si trasformarono negli artipropulsivi dei vertebrati terrestri, mentre la coda, che avevanei pesci una funzione propulsiva, divenne un organo chespesso contribuisce all’equilibrio. L’osso che sospendeva al
EXAPTATION: LA BIOLOGIA DELL’ IMPREVEDIBILE
cranio la mascella superiore di un pesce ancestrale divennel’osso che trasmette i suoni nelle orecchie dei rettili. Dueossa che articolavano le mascelle di quel rettile divenneropoi gli altri due ossi che trasmettono i suoni nell’orecchiomedio dei mammiferi. Quando vediamo con quanta perfe-zione il martello, l’incudine e la staffa funzionino nell’udi-to, chi potrebbe immaginare che un tempo uno di questiossicini sospendeva la mascella al cranio, mentre gli altridue articolavano le mascelle? (...) E un modo di determina-zione del sesso che potrebbe essere stato in origine d’aiutoa una colonizzatrice solitaria divenne evidentemente la basedi sistemi sociali con cui solo il nostro può rivaleggiare incomplessità (p. 64).
Questa tessitura fra “bizzarria” storica e miglioramentoadattativo è la seconda gamma potenziale di exaptations,che potremmo definire propriamente come l’asimmetria, ol’incommensurabilità, fra utilità attuale e origine storica(exaptation 2).
La sopravvivenza del più flessibile: exaptation del terzo tipo
Se operiamo adesso una specificazione ulteriore diexaptation 2, approfondendo le cause ecologiche che pos-sono innescare la transizione funzionale, oltre a una dilata-zione temporale del meccanismo exattativo, troviamo laforma più caratteristica di exaptation che intenderemo quicome sua terza accezione.
Il “sorriso del fenicottero” (Gould 1985) deriva da uncapovolgimento up-down del becco dell’animale, causatoda un ribaltamento nella postura di alimentazione. L’ani-male ha sviluppato un comportamento anomalo (mangiarecon la testa capovolta, filtrando il cibo) e ciò ha comporta-to un’inversione delle forme e delle dimensioni dei due ra-mi del becco (da cui deriva la linea rovesciata “a sorriso”del becco). L’esempio degli organismi che vivono capovolti(ve ne sono molti altri, fra cui una particolare medusa, Cas-siopea, che ha sviluppato articolate modalità di adattamen-
TELMO PIEVANI
to alla vita capovolta) offre lo spunto per una terza formu-lazione di exaptation, questa volta orientata al cambiamen-to delle regole comportamentali.
Il sorriso del fenicottero è dato da una sequenza dieventi evolutivi:
- alcuni esemplari sviluppano un cambiamento radicalenel modo di vita: l’animale si alimenta, o addirittura vive,alla rovescia;
- per adattarsi al nuovo stile di vita l’animale riprogettaintegralmente, secondo modalità del tutto inedite, la suastruttura anatomica, invertendo le funzioni delle parti; ilpiano costruttivo dell’organismo è stravolto a seguito dellafissazione per selezione naturale del nuovo comportamento(una pressione adattativa modifica la struttura nel suocomplesso);
- la selezione tuttavia non può modificare a piacimentoforma, disposizione e dimensioni degli organi; essa riutiliz-za per funzioni nuove il materiale disponibile, cioè le partidel piano costruttivo e funzionale precedente.
Il risultato di questo bricolage evolutivo è ancora unavolta una condizione di adattamento sub-ottimale:
L’adattamento ha una sorprendente capacità di alterare unpiano costruttivo anatomico, diffuso e stabile in migliaia dispecie, per le esigenze di un bizzarro stile di vita alla rovescia,adottato da una sola o da poche forme aberranti. Non si do-vrebbe però concludere da questo che l’adattamento darwi-niano alle condizioni ambientali locali abbia una capacità illi-mitata di elaborare forme teoricamente ottimali per ogni si-tuazione. La selezione naturale, come processo storico, puòfunzionare solo con materiale già disponibile: in questi casi, ipiani costruttivi convenzionali, sviluppati per uno stile di vitacomune. Le risultanti imperfezioni e soluzioni bizzarre, messeinsieme alla meglio, partendo da ciò che è a portata di mano,documentano un processo che si svolge nel tempo a partireda antecedenti non idonei, non l’opera di un architetto per-fetto che crea dal nulla. Cassiopea coopta un gruppo di mu-scoli, generalmente utilizzati per nuotare, e forma un bordorilevato per attaccarsi al substrato. I fenicotteri incurvano il
EXAPTATION: LA BIOLOGIA DELL’ IMPREVEDIBILE
becco in una curiosa gobba, come unica soluzione topologicaa una nuova orientazione (Gould 1985, p. 27).
La forma più caratteristica di exaptation è dunque illu-strata dalle imperfezioni di un adattamento che può conta-re su risorse organiche limitate dal piano costruttivo prece-dente. L’imperfezione è allora l’autentico segno della storiae il meccanismo di exaptation illustra meglio di ogni altrola natura della storia naturale. Uno stimolo comportamen-tale stravolge la struttura precedente e obbliga l’organismoa un riorientamento complessivo: il risultato è un bricolageadattativo a partire dai materiali disponibili. In questo sen-so possiamo immaginare il meccanismo di exaptation comeuno sfruttamento delle risorse fortuitamente disponibilimomento per momento, mentre il meccanismo di adatta-mento come una reazione a problemi ambientali emergen-ti, un’espressione di progettualità evolutiva.
Questo meccanismo biologico di bricolage adattativo edi sub-ottimalità a seguito di un cambiamento comporta-mentale rappresenta una sorta di exaptation per “cambia-mento delle regole del gioco” (in questo caso etologiche) esarà definito come la terza gamma potenziale di exaptations(“modello etologico di exaptation 3”, o exaptation 3a). Inparticolare, exaptation 3a consiste in un modello evolutivocontingente di cambiamento delle regole interne di soprav-vivenza (cioè regole di comportamento).
Un altro esempio interessante di bricolage adattativoinnescato da un cambiamento di regole comportamentaliè il “pollice del panda”, un dito opponibile del tutto atipi-co per mammiferi carnivori specializzati nella corsa comeorsi e procioni, con i quali il panda è imparentato. Comeriportano le migliori monografie sui panda giganti (laprincipale è dell’anatomista D. Dwight Davis, del FieldMuseum of Natural History di Chicago, 1964), il cosid-detto “pollice” non è in realtà un dito ma una deformazio-ne adattativa di un osso del polso, il sesamoide radiale,sviluppata per facilitare al panda la manipolazione deibambù di cui si ciba per gran parte della giornata. Questo
TELMO PIEVANI
sesto dito aggiuntivo è una parte anatomica completa (conmuscoli e cuscinetti) sviluppatasi a seguito di una rivolu-zione alimentare subentrata nella vita di un ex-carnivoro.L’ipertrofia del sesamoide radiale deve essersi fissataquando il panda, abbandonando le vecchie abitudini, co-minciò a cibarsi esclusivamente di bambù e fu spinto amonopolizzare il suo tempo in funzione dell’alimentazione(il contenuto energetico del bambù, molto più basso diquello della carne, obbliga l’animale ad assumerne inquantità massiccia e in continuazione).
La soluzione adattativa del panda è illuminante per duemotivi. In primo luogo perché dimostra che di fronte a ne-cessità nuove e a different rules di comportamento l’organi-smo non inizia a plasmare gradualmente nuove strutture,ma utilizza al meglio ciò che già possiede. Un polso ingran-dito fino a formare una specie di pollice è una bizzarria in-gegnosa ed efficace, degna del miglior bricoleur naturale,per affrontare un’emergenza vitale. Se non fosse un termi-ne con una connotazione negativa in italiano, si potrebbedire che si tratta di un ottimo esempio di “opportunismo”evolutivo.
In secondo luogo, si è notato che anche l’osso corri-spondente del piede del panda, il sesamoide della tibia, si èingrandito senza tuttavia essere utilizzato dall’animale. Ciòmostra che la chiave della comprensione di queste trasfor-mazioni sta in mutazioni genetiche al livello del coordina-mento della crescita delle varie parti dell’organismo: l’ani-male è una rete intrecciata di correlazioni genetiche di svi-luppo (cioè di correlazioni ontogenetiche).
Come notò il biologo Michael Ghiselin, la scoperta dellastraordinaria ingegnosità della natura nel riciclare i materia-li organici disponibili risale proprio a Darwin, che nel suostudio analitico sulle orchidee del 1862 elencò un’incredibi-le varietà di espedienti elaborati da questi vegetali per atti-rare su di sé gli insetti e garantire le fecondazioni incrociate.Una frase come la seguente può, meglio di ogni altra argo-mentazione, mostrare come la nozione di exaptation non so-lo non possa definirsi “antidarwiniana” ma costituisca un
EXAPTATION: LA BIOLOGIA DELL’ IMPREVEDIBILE
approfondimento, un arricchimento e un’estensione coe-rente della teoria originaria di Darwin. Alla conclusionedella sua monografia sulle orchidee Darwin scrive:
Anche se un organo può non essersi formato in principio peruno scopo particolare, se oggi viene utilizzato efficacementeper quello scopo, possiamo giustamente dire che è particolar-mente adatto ad esso... In tutta la natura quasi ogni parte diciascun essere vivente è probabilmente servita, con pochemodifiche, ad altri scopi e ha funzionato come parte dellamacchina vivente di molte e diverse forme antiche (Darwin,cit. in Gould 1980, p. 19).
Le strutture delle orchidee offrono un prezioso com-pendio dei possibili “espedienti” di exaptation:
Le orchidee costruiscono i loro complessi congegni con icomponenti normali dei fiori comuni, con parti che vengonoin genere utilizzate per scopi differenti. Se Dio avesse volutocostruire una splendida macchina che riflettesse la sua sag-gezza e il suo potere, non avrebbe certo usato dei pezzi mo-dellati per altri scopi. Ma le orchidee non sono state costruiteda un ingegnere ideale, esse sono il risultato dell’assemblag-gio di una serie limitata di componenti disponibili (p. 14).
A questo proposito è bene precisare che l’introduzionedi exaptation come possibile fonte della forma organica edel comportamento non esclude in alcun modo che si rea-lizzino normalmente adattamenti diretti, plasmati linear-mente dalla selezione naturale. La sfida che un’epistemolo-gia dell’evoluzione di tipo costruttivista lancia è quella dimoltiplicare le sorgenti del cambiamento e i meccanismi diorigine della funzionalità organica.
Una versione più generale del modello delle differentrules illustra una seconda variante di exaptation 3. Moltipaleontologi hanno opportunamente insistito sui falsi ste-reotipi presenti nella ricostruzione storica del rapportoevolutivo fra dinosauri e mammiferi e sulla indebita equi-valenza fissata fra estinzione e inadeguatezza adattativa.
TELMO PIEVANI
Anche se vittime di un’estinzione di massa i dinosauri nonerano affatto animali disadattati. Oggi sappiamo che i di-nosauri sono stati i precursori degli uccelli (Ostrom 1979);che il loro sangue era probabilmente “tiepido” (Bakker1975); che svilupparono complessi comportamenti sociali(Bakker, Galton 1974); che tutto sommato (fatta eccezioneper i grossi erbivori) godevano di una relazione soddisfa-cente fra dimensioni del corpo e dimensioni cerebrali (Ho-pson 1977).
La loro efficienza adattativa è dimostrata palesementedal periodo complessivo di sopravvivenza: più di cento mi-lioni di anni. Viceversa, sappiamo oggi che i mammiferi delMesozoico erano prevalentemente piccoli roditori nottur-ni, a sangue caldo, pelosi, dai movimenti scattanti e dallavita piuttosto breve: animali ben adattati ma di nicchia ri-stretta.
Il fatto notevole riguardo ai dinosauri non è la loro estinzio-ne, ma la durata del periodo in cui hanno dominato la Terra.I dinosauri furono padroni del campo per cento milioni dianni durante i quali i mammiferi erano minuscole creatureche occupavano gli interstizi del loro mondo. Dopo esserestati sulla breccia per settanta milioni di anni, noi mammiferipossiamo nutrire qualche speranza di vita futura, ma dobbia-mo dimostrare la capacità di resistenza dei dinosauri (Gould1980, p. 259).
Ciò che accadde durante e dopo l’estinzione in massaK-T fu sorprendente ed è il racconto dell’exaptation stori-co forse più affascinante. Le caratteristiche di nicchia deimammiferi si rovesciarono in vantaggi adattativi straordi-nari. Le proprietà dei dinosauri, autentici dominatori delpianeta, si trasformarono al contrario in trappole mortali.Uno sconvolgimento delle regole ambientali rovesciò i rap-porti di “forza adattativa” fra mammiferi e dinosauri. In unpianeta reso probabilmente freddo e oscurato dall’impattodi un asteroide, il piccolo roditore peloso e a sangue caldosopravvisse come in una notte particolarmente lunga: l’albaseguente sarà l’inizio di una delle più spettacolari radiazio-
EXAPTATION: LA BIOLOGIA DELL’ IMPREVEDIBILE
ni adattative della storia naturale. Possiamo considerarequesto rovesciamento adattativo contingente come un mo-dello questa volta ecologico di exaptation 3 (o exaptation3b). Le modificazioni ambientali improvvise, innescandoperiodi di estinzione di massa e di successiva radiazioneadattativa, cioè immensi turnover pulses (impulsi di avvi-cendamento) di specie (Vrba 1983; 1984), rappresentanodunque episodi “exattativi” su larga scala: essi generanoexaptations potenziali trasversalmente a specie e popolazio-ni (ciò che per una specie era un adattamento può diventa-re un exaptation fortunato, o viceversa un pericoloso disa-dattamento).
Per questo, in termini statistici generali, la nozione diexaptation, cogliendo il nesso fra potenzialità morfologica eproduzione della novità funzionale attraverso una sorta di“assemblaggio” opportunista, introduce nella concezionedella storia un importante principio di ridondanza come“fondamento della creatività” (Gould 1993, p. 131). L’evo-luzione è un “processo straripante di ridondanza” (ib.) el’adattamento più che un’ottimizzazione diretta è un effet-to collaterale. La flessibilità funzionale è direttamente pro-porzionale alla capacità degli organismi di reagire creativa-mente ai cambiamenti di regole ambientali e, dato che ilcambiamento di regole è la norma in un processo contin-gente di trasformazione, la flessibilità è direttamente pro-porzionale alla possibilità di sopravvivenza: “gli organismicomplessi esistono grazie all’imperfezione, alla molteplicitàd’uso e alla ridondanza” (p. 111).
Effetti collaterali di struttura: exaptation del quarto tipo
Una quarta accezione di exaptation sposta ulteriormen-te il peso dell’origine della funzionalità primaria sul carat-tere capriccioso e, insieme, intrinsecamente strutturale delcambiamento evolutivo. La riflessione riguarda in questocaso uno degli enigmi adattativi che più misero in diffi-coltà Darwin: la spiegazione evolutiva del cannibalismo
TELMO PIEVANI
sessuale. Perché mai le femmine di vedova nera o di man-tide religiosa dovrebbero cibarsi del maschio dopo l’ac-coppiamento? Mentre per altre conformazioni insolite (gliornamenti del pavone) l’ipotesi darwiniana della selezionesessuale riusciva a compensare le insufficienze della sele-zione naturale (giacché non possono avere valore adattati-vo diretto strutture ingombranti e obiettivamente svantag-giose), nel caso del cannibalismo sessuale anche la selezio-ne sessuale vacillava.
A dispetto delle teorie convenzionali sul vantaggio ri-produttivo del cannibalismo, si era probabilmente di fron-te a un fenomeno che esulava da meccanismi selettivi. Lefemmine potrebbero aver sviluppato una rapacità incon-trollabile nell’atto dell’accoppiamento come conseguenzacorrelata di un qualche altro adattamento funzionale. Uncambiamento adattativo, per il principio strutturale dellosviluppo integrato, potrebbe influenzare derivatamente unaltro carattere morfologico o comportamentale, determi-nando conseguenze del tutto imprevedibili e sganciate daqualsiasi funzionalità organica:
Ogni cambiamento adattativo porta nella sua scia una grandequantità di conseguenze, alcune felicemente cooptate per unvantaggio futuro, altre no. Alcune grosse femmine sviluppanouna indiscriminata rapacità per ragioni loro e alcuni maschine soffrono le conseguenze, malgrado la loro corsa, dettatadall’evoluzione, a fuggire. Progetti sviluppatisi per una ragio-ne (o per nessuna ragione) hanno altre conseguenze, alcunefortuitamente utili. I maschi delle mantidi possono diventareportenti senza testa; i maschi delle vedove nere possono rima-nere sulla tela della femmina. Entrambi i comportamenti pos-sono essere utili, ma non abbiamo alcuna prova che o l’uno ol’altro siano sorti per selezione attiva allo scopo di sacrificareil maschio (Gould 1985, p. 42).
In virtù dell’integrazione sistemica di ogni organismo edelle “correlazioni di crescita”, come furono definite già daDarwin, un cambiamento in senso adattativo può propaga-re conseguenze non adattative in altre parti dell’organismo.
EXAPTATION: LA BIOLOGIA DELL’ IMPREVEDIBILE
Il segno contingente della storia è dunque rappresentato,in questa quarta accezione, dall’effetto del cambiamentoevolutivo strutturale, che può estendere la propria influen-za fino a innescare effetti del tutto indipendenti dalla fun-zione adattativa iniziale (exaptation 4).
Conclude Gould (ib.):
(...) un altro potente principio evolutivo, che pure viene spes-so dimenticato, interviene e impedisce qualsiasi corrispon-denza ottimale tra un organismo e il suo ambiente immediato:sono le curiose, tortuose e coercitive vie della Storia. Gli or-ganismi non sono come creta di fronte a un ambiente che liva modellando o come palle da biliardo di fronte alla steccadella selezione naturale. Le loro forme e i loro comportamen-ti ereditati li frenano e li spingono indietro; non possono rapi-damente trasfomarsi in qualcosa di nuovo e di ottimale ogniqualvolta l’ambiente si modifica.
E poco dopo troviamo un’espressione particolarmentesintetica dell’idea di exaptation:
Il mondo in cui viviamo non è un luogo ottimale, ben sinto-nizzato dalle forze onnipotenti dell’evoluzione. È invece unabizzarra massa di imperfezioni, che malgrado ciò funzionanobene (spesso in modo ammirevole); una serie, messa insiemealla bell’e meglio, di adattamenti fatti di parti insolite forniteda storie passate in differenti contesti. Darwin, che era unacuto studioso di Storia, non soltanto un patito della selezio-ne, intese questo principio come la prova principale dell’evo-luzione stessa. Un mondo adattato in modo ottimale alle con-dizioni ambientali del presente è un mondo senza Storia e unmondo senza Storia potrebbe essere stato creato così comenoi lo troviamo. Invece, è la Storia che interessa ed è la Storiache scompiglia la perfezione e dimostra che la vita del presen-te ha trasformato il proprio passato (p. 43).
La contrapposizione fra un’idea dell’evoluzione comerincorsa all’adattamento (o come “sintonizzazione” pro-gressiva dell’organismo all’ambiente che cambia) e un’i-dea della storia naturale come creatrice di una “bizzarra
TELMO PIEVANI
massa di imperfezioni” non può essere più radicale. Rife-rendosi al vincolo strutturale della conformazione penta-dattila nei vertebrati (Coates, Clack 1990), Gould (1993,pp. 80-82) scrive:
Perché dunque cinque? Fra i due tipi di risposta principali aquesto interrogativo, la strategia convenzionale darwiniana, oadattazionista, cerca di discernere nel numero cinque ungrande vantaggio, o addirittua un’inevitabilità, nei terminidella sua utilità in relazione all’habitat di un organismo (unvantaggio in grado di promuovere questa configurazione perselezione naturale). (...) Il secondo approccio importante (...)sostiene che il cinque non è stato progettato in vista di un fi-ne, me è semplicemente il risultato di un’evoluzione in cui so-no intervenuti elementi di casualità. Anche altre configurazio-ni avrebbero funzionato e si sarebbero potute evolvere, maciò non avvenne, e il cinque funziona abbastanza bene.
La casistica dei fenomeni di exaptation è oggi moltoestesa (Coddington 1988). Per gli exaptations di primo ti-po, possiamo citare: le capacità linguistiche del cervelloumano, le uova del kiwi, la conformazione “mescolata”dell’ittiosauro. Sono esempi di exaptation del secondo ti-po: il piumaggio degli uccelli, il mimetismo cromatico esensoriale, l’aplodiploidia negli insetti, il rituale di corteg-giamento delle sule. Sono esempi di exaptation del terzotipo: la radiazione adattativa dei mammiferi, l’utilizzo sul-la terraferma della pinna ossea centrale dei pesci di fon-dale, gli ossicini della mascella dei pesci, il pollice delpanda, il sorriso del fenicottero. Sono esempi di exapta-tion del quarto tipo: i petali deformati delle orchidee, ilcannibalismo sessuale, il batrace che alleva i girini nellostomaco.
Dodici anni dopo la sua formulazione, l’importanzaoperativa del concetto di exaptation fu oggetto di un lungoe importante saggio del biologo teorico E. N. Arnold(1994), i cui risultati rafforzarono notevolmente la consa-pevolezza dell’estensione e del valore empirico del fenome-no. A esso seguirono molte ricerche applicative, che hanno
EXAPTATION: LA BIOLOGIA DELL’ IMPREVEDIBILE
portato negli ultimi dieci anni all’adozione della terminolo-gia proposta da Gould e Vrba in ampi settori delle discipli-ne evoluzionistiche (Almada, Santos 1995; Ketterson, No-lan 1999). Secondo Arnold, è possibile in molti casi distin-guere lo statuto exattativo o adattativo di un carattere ana-lizzando la sequenza degli eventi evolutivi con tecniche cla-distiche. Le quattro aree di exaptations individuate delinea-no i contorni di una strategia pluralista di diversificazionedei fattori di evoluzione. Una considerazione estensiva deifenomeni che contribuiscono alla fitness indica che la sele-zione naturale non è il principio esclusivo della trasforma-zione naturale. Nel 1983 (pp. 156-157), in un divertentesaggio sulla formazione non adattativa dei genitali femmi-nili peniformi delle iene, Gould scrive di “miti e realtà del-la iena”:
Noi non viviamo in un mondo perfetto in cui la selezione na-turale vaglia spietatamente tutte le strutture organiche pla-smandole in vista di un’utilità ottimale. Gli organismi eredi-tano una forma corporea e uno stile di sviluppo embrionale,i quali impongono costrizioni su mutamento e adattamentofuturi. In molti casi, le vie evolutive riflettono modelli eredi-tati più che richieste ambientali correnti. Queste eredità im-pongono vincoli, ma forniscono anche opportunità. Un mu-tamento genetico potenzialmente secondario – in questo ca-so un aumento del livello degli androgeni – comporta una se-rie di conseguenze complesse, non aventi alcun significato diadattamento. La flessibilità primaria dell’evoluzione potreb-be derivare da prodotti secondari non adattativi che di tantoin tanto permettono a taluni organismi di imboccare direzio-ni nuove e imprevedibili. Quale “gioco” avrebbe l’evoluzio-ne se ciascuna struttura fosse costruita in vista di uno scoporistretto e non potesse essere usata per alcun’altra cosa? Inche modo gli esseri umani potrebbero imparare a scrivere seil nostro cervello si fosse evoluto per la caccia, per la coesio-ne sociale o per qualunque altra cosa, e non potesse trascen-dere i confini adattativi del suo fine originario? (...) PeterMedawar ha descritto la scienza come “l’arte del solubile”.L’evoluzione potrebbe essere etichettata come “la trasforma-zione del possibile”.
TELMO PIEVANI
Se uno stile evoluzionista di matrice pluralista si affer-masse nella scienza biologica, immagina Gould, in alterna-tiva al “funzionalismo che nega la storia” si assisterebbealla rinascita della tradizione morfologico-strutturale cheintende i soggetti “storici” (e pertanto “imperfetti” pro-dotti della contingenza) come intrinsecamente molteplici einterconnessi, come sistemi integrati in evoluzione. Nonsempre, a dire il vero, l’applicazione del concetto di exap-tation ha mantenuto fede a questa sua radice strutturalistae sistemica: più generalmente, e in discipline oggi diversis-sime, si usa il termine exaptation per definire qualsiasicambiamento funzionale bizzarro, qualsiasi riutilizzo inge-gnoso di caratteri e strutture formatesi per tutt’altre ragio-ni. Il termine, ormai, non compare soltanto nei dizionaridi teoria dell’evoluzione o addirittura di lingua inglese ge-nerale, ma è diventato di uso comune in zoologia (Mont-gomery, McFall-Ngai 1992, sui batteri fosforescenti usatidal calamaro Euprymna scolopes come fonte di luce spri-gionantesi dal ventre; Jablonski, Chaplin 1999; Roy, 1996),in paleoantropologia (Chatterjee 1997), in biologia mole-colare (Weiner, Maizels 1999; Smit 1999; per un “classico”dell’exaptation in campo molecolare si veda la sintesi diGould sulle scoperte di Piatigorsky e Wistow sull’evolu-zione delle cristalline delle lenti oculari di vertebrati e in-vertebrati, in Gould 2002b, pp. 1.551-1.555), in linguistica(Markey 1997), nelle scienze cognitive (Skoyles 1999), insociologia (Catton 1998).
Andare al rogo per l’exaptation
Gould si proclama pronto ad andare al rogo per difen-dere l’idea di exaptation. Ma per rischiare davvero il “ro-go” dell’inquisizione evoluzionistica neodarwinista dob-biamo cogliere fino in fondo le implicazioni del primo edel quarto tipo di exaptation qui descritto. Nel caso dellaseconda e della terza tipologia, tutto sommato, la conti-nuità dell’azione selettiva è garantita: una funzione, qua-
EXAPTATION: LA BIOLOGIA DELL’ IMPREVEDIBILE
lunque essa sia, più o meno provvisoria, è sempre insedia-ta per darci una misura dell’utilità di un organo. Vi è unospostamento contingente di funzioni, ma pur sempre difunzioni e di utilità si discute. Limitatamente a ciascunasequenza, vi è sempre una condizione minimale di fitnessche giustifica la presenza di un carattere. Che sia un pre-adattamento, una trasformazione di vincoli strutturali, unriutilizzo creativo a seguito di cambiamenti di regole disopravvivenza, il governo della selezione naturale non èmai sospeso.
Ma che dire di una struttura, poi cooptata per un’uti-lità attuale, che originariamente non aveva alcuna funzio-ne? Significa forse che in natura non tutto serve sempre aqualcosa? Che la presa della selezione naturale non con-trolla l’intera panoplia dei caratteri emergenti? In effetti,questo è il risvolto più radicale del concetto di exaptation,quello per il quale si rischia davvero qualche serio capo diimputazione da parte della “tavola alta” della scienza evo-luzionistica. Esistono infatti, per Gould e Vrba, due sot-toinsiemi diversi di fenomeni exattativi: quelli derivantida caratteri che originariamente avevano una funzioneadattativa riconoscibile (cooptazioni o cambiamenti fun-zionali bizzarri di vario tipo); quelli derivanti da caratteriaventi un’origine non adattativa, cioè che non avevano al-cuna funzione precedente.
Per “non adattativi” si possono intendere naturalmentedue tipi di caratteri: quelli che recano con sé svantaggi perl’organismo che li possiede (e non è questo il caso, perchési presuppone che verranno subito eliminati dalla selezio-ne naturale) e quelli che non recano né svantaggi né van-taggi, sono cioè “neutri” rispetto alla selezione, la quale inmolti casi potrebbe semplicemente ignorarli e lasciarli esi-stere finché non si rivelino dannosi o finché non venganocooptati per diventare exaptations. Già Darwin aveva no-tato che molte “correlazioni di crescita” negli organismi,pur non avendo alcuna utilità specifica, erano tolleratedalla selezione, che sembrava non vederle proprio. Fraquesti caratteri “invisibili” alla selezione, secondo Gould,
TELMO PIEVANI
possiamo annoverare moltissimi sottoprodotti architetto-nici o strutturali degli organismi, vere e proprie riserve diexaptations potenziali.
Il significato di questo tipo di exaptations è più radica-le, perché non soltanto l’utilità attuale non può essere in-ferita dall’origine storica, ma la stessa origine storica nonpuò essere attribuita all’azione della selezione naturale.Non è un caso che le reazioni provenienti dal versanteadattazionista si siano concentrate su una duplice strate-gia: considerare il primo tipo di exaptation come banale ecompletamente riconducibile alla tradizione neodarwini-sta; bocciare il secondo tipo di exaptation come inammis-sibile o, nella peggiore delle ipotesi, del tutto marginale(Dawkins 1986; Ridley 1993; Dennett 1995). Nella pro-spettiva pan-selezionista tradizionale si ritiene infatti cheun carattere non adattativo, per poter sopravvivere, deb-ba essere o pressoché irrilevante, o molto marginale nellafisiologia dell’organismo, o comunque dipendente passi-vamente da altri caratteri adattativi.
La casistica dei fenomeni exattativi di primo e quarto ti-po sembra invece indicare la rilevanza evoluzionistica deicaratteri non adattativi nei sistemi biologici. Ancora unavolta, sono considerazioni di tipo strutturalista e sistemicoa spingere in questa direzione. Se gli organismi sono entitàintegrate, la frequenza di correlazioni e di conseguenze col-laterali, generatrici di caratteri non adattativi, sarà moltoalta: non solo il bianco delle ossa, il rosso del sangue e lemammelle maschili (Gould 2002b, p. 1.572), ma anche glispazi di riempimento nella costruzione delle chiocciole, la“gobba” dell’alce irlandese, l’animale da cui siamo partiti(che ha trasformato l’attaccatura dei muscoli che sorreggo-no le pesanti corna in una concrescenza colorata, per unafunzione connessa alla selezione sessuale), i genitali a imita-zione maschile delle iene maculate, l’orgasmo clitorideo(exaptation femminile di un adattamento maschile), e moltialtri esempi. Più la complessità dell’organo aumenterà, piùsarà alta la probabilità di propagare caratteri non adattatividotati di utilità potenziale futura. Nulla più delle utilizza-
EXAPTATION: LA BIOLOGIA DELL’ IMPREVEDIBILE
zioni attuali del cervello umano eccede sicuramente i moti-vi funzionali della sua origine.
Ma vi è un’altra ragione per confidare nella grande diffu-sione di caratteri non adattativi in natura, una ragione messain luce da Gould e Vrba in un saggio del 1986 e poi ripresada Gould insieme all’epistemologa Elisabeth Lloyd (Gould,Lloyd 1999). Se le unità di selezione non sono soltanto gliorganismi singoli, ma si dispongono su una struttura gerar-chica, come prevede la teoria omonima proposta da Gouldinsieme a Niles Eldredge a partire dalla metà degli anni Ot-tanta (sull’interpretazione della quale, tuttavia, i due si sepa-reranno nelle fasi successive di elaborazione), allora potran-no sorgere caratteristiche adattative al livello gerarchico d’o-rigine, ma non adattative se considerate dal punto di vistadegli altri livelli. Un’innovazione emersa a un livello microe-volutivo per ragioni selettive può tradursi in un caratterenon adattativo a livello di organismi o di specie, e viceversa.Questa logica plurale di evoluzione su più livelli moltiplicale occasioni di insorgenza di caratteri imprevedibili fra livel-li, detti cross-level spandrels (dal termine “spandrels”, ovvero“pennacchio architettonico”, che introdurremo fra poco).
In effetti, Gould e Vrba hanno dato due definizioni di-verse di exaptation. Nel lavoro del 1982 essi diedero unaprima definizione ristretta di exaptation, limitandolo ai ca-ratteri che a uno stesso livello della gerarchia evolutiva fos-sero stati cooptati da una funzione originaria a una funzio-ne differente. Nel 1986 allargarono il campo di exaptationsecondo le modalità di reciproca influenza causale fra i li-velli all’interno del loro modello gerarchico:
L’obiettivo di exaptation diventa molto più esteso in una pro-spettiva gerarchica, perché tutte le causazioni all’insù o all’in-giù che producono nuovi caratteri possono portare a exapta-tion. Le mutazioni insorgono per proprie ragioni e al propriolivello. Se però esse influenzano i fenotipi, in un modo taleche la selezione su organismi li favorisca, allora questi fenoti-pi mutanti sono exaptations al livello degli organismi (Vrba,Gould 1986, p. 225).
TELMO PIEVANI
Ciò vale in entrambi i sensi dell’azione causale gerarchica:
Possiamo cogliere chiaramente questo fatto per la causazioneupward, senz’altro ereditabile, in cui la novità emergente chediventa soggetta a selezione può essere descritta come exapta-tion. Ma il principio vale anche per la causazione downward.Le estinzioni di massa, per esempio, possono generare una ri-strutturazione complessiva della diversità della vita. Le nuoveproporzioni e i nuovi tipi di creature disponibili per il model-lamento adattativo negli ambienti ordinari, rinnovati radical-mente dopo un evento tanto straordinario, formano un pool,largamente fortuito, di potenziale exattativo (exaptive poten-tial) (ib.).
Gould, nella sua ultima opera (2002b), dà una grandeimportanza a questo concetto di exaptation gerarchico, ri-tenendolo la sua acquisizione decisiva per una revisione edestensione della teoria dell’evoluzione darwiniana. Peresempio, la duplicazione di elementi genici, prodotta dallaselezione a livello micro, può propagarsi o “iniettarsi” a li-vello degli organismi. In linea teorica tutte le mutazioni ge-netiche dette comunemente “casuali”, lo sono in quanto“non adattative” rispetto ai livelli gerarchici superiori(Eble 1999): le perturbazioni che generano mutazioni ge-netiche (siano esse riconducibili ai raggi cosmici o all’in-quinamento ambientale) sono sempre “exattative” rispettoai loro effetti al livello degli organismi. Detto in altri termi-ni, l’intera letteratura evoluzionistica rubricata sotto il tito-lo di “caso” (complementare alla “necessità” della selezio-ne naturale) diventerebbe un sottoinsieme dei fenomeniexattativi, rendendo assai difficile per definizioneun’“estrapolazione” lineare e deterministica delle tendenzemacroevolutive dall’accumulo di modificazioni adattativeai livelli inferiori.
Questo per quanto concerne il passaggio dal livello mi-cro al livello intermedio degli organismi. Ma anche gliexaptations trasversali fra il livello degli organismi e il livel-lo macroevolutivo delle specie hanno conseguenze di vastaportata. Essi sarebbero infatti il presupposto per fondare e
EXAPTATION: LA BIOLOGIA DELL’ IMPREVEDIBILE
comprendere un aspetto dell’evoluzione rimasto finora ab-bastanza inesplorato nella tradizione neodarwinista, cioèl’evolvibilità delle specie, il loro grado di “capacità evoluti-va” futura. Alcuni aspetti (la flessibilità genetica, la ridon-danza funzionale, la diversità interna) sembrano infatti fa-vorire una lunga sopravvivenza delle specie, a differenza dialtre caratteristiche che sono molto utili come adattamentilocali e specializzati a livello di singoli organismi ma delete-rie a livello di specie. Un problema della teoria darwinianaè infatti quello di spiegare il motivo per cui un’accentuataspecializzazione favorisca gli organismi in un dato conte-sto, ma vada a discapito delle probabilità di sopravvivenzaa lungo termine della specie (al primo mutar di condizioniecologiche, gli specializzati corrono seri rischi rispetto aigeneralisti).
La soluzione al problema può venire, secondo Gould,da una rideclinazione dei fenomeni exattativi all’interno diuna teoria gerarchica delle unità selettive. Anche le specie,innanzitutto, possono avere meccanismi di cernita e di va-glio differenziale (se non proprio di “selezione” vera e pro-pria, non essendoci un meccanismo di fissazione delle va-rianti fra “popolazioni di specie” o cladi) sulla base di ca-ratteristiche come la propensione a speciare (cioè a “ripro-dursi”) e la resistenza all’estinzione (tasso di “mortalità”basso). Per gli stessi motivi potrebbero esistere meccanismidi sopravvivenza differenziale fra interi cladi: alcuni sonopiù resistenti e prolifici, altri meno. Rimane un problema:l’evolvibilità si misura su caratteristiche potenziali, cioè at-tualizzabili in futuro, e non su caratteristiche effettive sullequali possa agire la selezione. Ma la difficoltà potrebbe es-sere aggirata proprio grazie al concetto di cross-level span-drels: l’evolvibilità potrebbe essere favorita proprio dallacapacità delle specie (intese come “individui darwinianiricchi ma diversi”, Gould 2002b, p. 1.615) di far tesoro de-gli exaptations provenienti dal livello degli organismi, miti-gando così i loro pericolosi eccessi di specializzazione. L’e-volvibilità sarebbe cioè direttamente proporzionale alla ri-serva exattativa disponibile, o “pool exattativo”.
TELMO PIEVANI
L’exaptation sarebbe allora cruciale per la fitness, perl’idoneità delle specie nella macroevoluzione. La resistenzaall’estinzione, per esempio, potrebbe dipendere propriodal grado di flessibilità fornita dal pool exattativo. Come lemutazioni genetiche “casuali” sono cross-level spandrelsper gli organismi, allo stesso modo le modificazioni degliorganismi sono cross-level spandrels per le specie: quelleche sanno “exattarne” il più possibile hanno maggiori pro-babilità di sopravvivere. La base strutturale dell’evolvibilitàsarebbe dunque il pool exattativo, la riserva di utilità po-tenziali, il potenziale concesso per futuri episodi di selezio-ne a tutti i livelli, che Gould così decide di ridefinire ne Lastruttura della teoria dell’evoluzione (p. 1.598):
Tassonomia del pool exattativo
A. Potenziali inerenti (cioè capacità intrinseche, funzioni po-tenziali interne alternative a quelle attuali, già presenti in uncarattere ed “exattabili”): la categoria che riassume in sé ilconcetto di pre-adattamento darwiniano e tutte le modifica-zioni, conversioni, cooptazioni di funzioni già presenti in po-tenza nei caratteri. Nel passaggio da potenziale inerente aexaptation, la selezione naturale non è mai sospesa.
B. Cose a disposizione (cioè caratteri, strutture, materiali bio-logici già presenti, senza un utilizzo corrente, non adattativi):la categoria che riassume in sé tutte le tipologie di “pennac-chi” non adattativi. La selezione ha un ruolo nella fissazionedell’exaptation successivo, ma non nell’origine del carattere.Questa categoria si suddivide in materiali a disposizione nonadattativi generati come conseguenze strutturali e materialinon adattativi frutto di una sequenza storica.
B1. Conseguenze architettoniche (origine strutturale):pennacchi (spandrels), a loro volta suddivisi in:i) Pennacchi a un solo livello gerarchico, generati comeeffetti collaterali meccanici, automatici (quelli descritti inGould, Lewontin 1979)ii) Pennacchi trasversali (cross-level spandrels), generatimediante iniezione da un livello gerarchico a un altro(Gould, Vrba 1986; Gould 2002b).
EXAPTATION: LA BIOLOGIA DELL’ IMPREVEDIBILE
B2. Dismissioni o manomissioni (origine storica) (atavi-smi, vestigia: caratteri che hanno perso un’utilità origi-nale, totalmente o parzialmente, senza acquisirne unanuova)B3. Introduzioni invisibili o “insinuazioni” (origine sto-rica) (caratteri neutrali rispetto alla selezione, introdotti aseguito di derive genetiche o effetti del fondatore).
La scelta di quest’ultima tassonomia rispecchia eviden-temente la volontà di Gould di dare un peso sempre mag-giore ai caratteri genuinamente non adattativi: “una sfidavera e propria all’esclusività del meccanismo adattazionista(...) il miglior strumento tassonomico per l’esplorazione delruolo del non adattamento e del vincolo strutturale nelpool exattativo dell’evolvibilità” (2002b, p. 1.606). Se il pa-radigma neodarwinista fosse dogmatico quanto un appara-to inquisitorio (fortunatamente non lo è, se non in rari ca-si), questa in effetti sarebbe una sfida degna di un simboli-co “rogo”.
Occhio di talpa: un esperimento sulla trasformazione fun-zionale per exaptation
Ma negli ultimi anni l’evidenza empirica sembra giun-gere in soccorso di Gould. In una serie di ricerche speri-mentali compiute a partire dalla fine degli anni Ottanta, siva profilando un nuovo indirizzo di studio che potrebbecontribuire alla crisi della tendenza adattazionista di marcaneodarwiniana e a confermare anche su un versante “rigo-rosamente” quantitativo l’esistenza di una polifunzionalitàridondante alla base di processi evolutivi per exaptation. Inun articolo del 1987 i genetisti W. Hendriks, J. Leunissen,E. Nevo, H. Bloemendal e W. W. de Jong hanno mostratocome i modelli casuali di misurazione genetica dei ritmi disviluppo, ispirati a una versione moderata della teoria neu-tralistica (“moderata” nel senso che non accantona la sele-zione naturale come epifenomeno marginale) possano esse-
TELMO PIEVANI
re efficaci, plausibili e relativamente più semplici dei mo-delli deterministici.
Lo studio riguarda gli occhi completamente ciechi diuna particolare talpa nord-americana, lo Spalax ehrenbergi,che ancora si formano al di sotto di uno spesso strato dipelle e di pelo. Abbiamo di fronte un caso di exaptationpotenziale di grande interesse: una struttura morfologica,vestigia del piano strutturale ancestrale del piccolo mam-mifero, giace inutilizzata e atrofizzata dove un tempo c’era-no occhi regolarmente funzionanti. Per la situazione evolu-tiva presente i casi sono tre:
1) gli occhi della talpa sono definitivamente fuori uso ein via di graduale riassorbimento;
2) servono ancora a qualcosa (hanno cioè una nuovafunzione per exaptation), ma ancora non abbiamo scopertoin che modo;
3) sono momentaneamente inutilizzati, ma stabilizzatidall’ontogenesi “in attesa” di possibili riconversioni future.
Il principio neutralista attesta che la velocità di sosti-tuzione delle proteine è indirettamente proporzionale al-la funzionalità selezionata (Kimura 1983) e permette didare una risposta credibile al quesito su quale delle treipotesi evolutive sia quella esatta: nel primo caso il ritmodi sostituzione neutrale rispetto alla selezione sarebbemassimo; nel secondo caso sarebbe minimo; nel terzo ca-so avrebbe valori intermedi. Basterà a tal fine compararei valori del ritmo evolutivo registrati per la talpa conquelli dell’occhio normalmente funzionante di un rodito-re genealogicamente simile.
L’operazione è riuscita grazie alla definizione della se-quenza del gene che codifica la proteina del rudimentalecristallino che ancora si forma nell’occhio della Spalax.L’esito è stato dei più intriganti: il ritmo di sostituzione èmolto alto (circa il quadruplo rispetto al valore tipico perocchi funzionanti, quindi l’ipotesi seconda è scartata),però non sufficientemente basso da indicare una neutra-lità pura (il cui valore medio di comparazione è quello
EXAPTATION: LA BIOLOGIA DELL’ IMPREVEDIBILE
della velocità di sostituzione di pseudogeni). Su una scalada 0% a 100% di neutralità, il cristallino dà valoridell’80%: lo Spalax usa ancora i suoi occhi quel tanto chebasta per abbassare di un 20% il ritmo di sostituzioneneutrale del cristallino. Esiste dunque una pressione se-lettiva residuale o derivata, che abbassa il ritmo del muta-mento casuale.
I modelli casuali semplici di derivazione neutralisticasono in grado quindi di fissare una norma sperimentaledi misurazione indiretta della funzionalità organica. È unrisultato di grande interesse. Le ipotesi funzionali sul cri-stallino dello Spalax si sono concentrate pertanto sul pos-sibile utilizzo degli occhi ancestrali come organi di rice-zione mediata della luce (attraverso la produzione di me-latonina dalla retina), da cui l’animale dedurrebbe latemperatura esterna e adatterebbe la sua fisiologia al cli-ma (attivando la crescita del pelo e altre trasformazionistagionali). Si tratterebbe in sostanza di un exaptationappartenente alla categoria B2 della tassonomia del poolexattativo di Gould del 2002 (atavismi o dismissioni, ditipo parziale).
Nevo e colleghi alla metà degli anni Ottanta avevano giàsperimentato che lo Spalax è sensibile alla luce ambientalediffusa, ma non alla temperatura circostante. Il cristallinosarebbe una struttura derivata, senza finalità adattative, chel’animale ricostruisce ancora durante l’embriogenesi perobbedienza al piano ancestrale di strutturazione dell’oc-chio. Avrebbe in altri termini una funzionalità potenzialenel percorso di sviluppo che conduce alla formazione corre-lata della retina, e non un’utilità diretta. Probabilmente sen-za la costruzione di una vescicola del cristallino non sareb-be possibile neppure la formazione della retina: da qui l’ab-bassamento, seppur modesto, del ritmo di sostituzione neu-trale nei geni di codifica delle proteine del cristallino.
L’interesse di questi studi è duplice. In un primo senso,essi dimostrano ancora una volta che il processo evolutivosi gioca nello spazio potenziale di intersezione e intercon-nessione di vincoli interni ontogenetici (che tendono a
TELMO PIEVANI
conservare i programmi di sviluppo) e di accomodamentiambientali (che tendono alla trasformazione funzionale).Un cambiamento evolutivo importante difficilmente si af-ferma se non c’è stata una modificazione, anche impercet-tibile, nei sistemi di coordinamento dei tassi e delle loca-lizzazioni della crescita.
In un secondo senso, riallacciandosi alla seconda radicestorica dell’exaptation, le ricerche statistiche sui cladi stoca-stici nella filogenesi di Gould, Raup, Sepkoski, Schopf eSimberloff (1977), la misurazione quantitativa del ritmo dimutamento è un primo passo, decisivo, verso una compren-sione sottile dei mutamenti funzionali (corrispondenti o me-no a mutamenti strutturali) nello sviluppo. Il risultato per ilcristallino dello Spalax è stato prossimo al valore intermedio(con tendenza verso l’alto): questo significa che la strutturaha perso definitivamente l’utilità diretta per cui si era conso-lidata nell’organismo (la vista in un roditore ancestrale, abi-tuato a vivere in superficie), ma che non è comunque deltutto disattivata nel quadro delle funzioni organiche attuali.A questo punto siamo autorizzati a prevedere una funzionecorrelata alla crescita dell’occhio nel suo complesso. Le ri-cerche sull’utilizzo della retina come recettore di fotoni, invista dell’adattamento al mutare delle stagioni, confermanola previsione. Il cristallino è probabilmente uno stadio preli-minare e interconnesso nello sviluppo embriologico che por-ta alla costruzione di una struttura completa (l’occhio ciecodotato di retina) avente una funzione attuale precisa e sele-zionata. Si sta delineando, in buona sostanza, la possibilitàsperimentale di una valutazione quantitativa e predittiva del-la trasformazione funzionale. I modelli neutralisti di misura-zione del ritmo di sostituzione casuale permettono cioè unapproccio sperimentale al meccanismo di exaptation.
Bricolage molecolari
I fenomeni exattativi sembrano essere particolarmentediffusi, secondo molti studiosi, a livello molecolare. La
EXAPTATION: LA BIOLOGIA DELL’ IMPREVEDIBILE
scoperta di un elevato grado di ridondanza funzionale(l’uso multiplo di molti prodotti genetici) e di ridondanzastrutturale (duplicazioni geniche e ripetizioni) offre l’op-portunità di applicare la categoria dell’exaptation, secondoGould, in modo pressoché ubiquo (Gould 2002b, p.1.550). Qui, infatti, i due principi di ridondanza darwinia-ni assumono oggi un’importanza cruciale: un singolo genepuò espletare diverse funzioni; una stessa funzione è nellagran parte dei casi espletata da pool genici estremamentecomplessi e articolati. Le possibilità di spostamenti funzio-nali sono dunque molto alte.
Tale considerazione può valere sia in termini di evolu-zione filetica sui tempi lunghi della storia naturale, sia intermini di emergenza di singoli caratteri in una specie.Alcuni biologi molecolari hanno ipotizzato, per esempio,che una delle cause della misteriosa “esplosione delCambriano”, la comparsa improvvisa di tutti i più im-portanti piani anatomici pluricellulari il cui carattere di-scontinuo aveva già preoccupato Darwin, possa risiederein una particolare “flessibilità” genetica trasversale, co-me presupposto per la costruzione rapida di una molte-plicità di architetture organiche differenti. Agli inizi delCambriano nascono infatti tutti i phyla fondamentali del-la natura vivente attuale, e molti altri oggi estinti (Gould1989). Il picco di diversità di phyla (disparità) di quel pe-riodo non verrà mai più raggiunto nella storia. Come èpossibile?
La distinzione cladistica fra caratteri condivisi primi-tivi e caratteri condivisi derivati risolve alcune ambiguitàtassonomiche dell’interpretazione tradizionale, senzaperò aiutarci del tutto nella attribuzione delle morfologiecambriane a uno schema classificatorio ben definito.Sembra che il grado di complessità delle forme e delladisparità anatomica di quel periodo sia irriducibile anchead approcci tassonomici più aperti e flessibili: sfugge aitentativi anche più sottili di ricostruzione delle linee ge-nealogiche. In particolare si registrano somiglianze moltoforti e ben focalizzate in organismi diversissimi, senza
TELMO PIEVANI
che queste possano essere considerate come analogiefunzionali: si tratta di omologie genetiche distribuite tra-sversalmente e localizzate nei modi più differenti. DerekBriggs, in una monografia del 1983, avanza un’ipotesi digrande interesse, su cui Gould si sofferma nel testo del1989, La vita meravigliosa.
L’analisi delle bizzarre e variegate soluzioni anatomi-che di Burgess Shale, il più importante ritrovamento difossili con parti molli di organismi del primo Cambriano,in particolare degli appartenenti al phylum degli artropo-di (nelle quattro famiglie moderne e nelle venti indipen-denti), rivela l’esistenza di una sorta di “riserva di carat-teri comuni” trasversale, cui gli animali delle varie fami-glie attingerebbero liberamente. L’ipotesi di Briggs è chei caratteri comuni condivisi e primitivi di Burgess nonidentifichino mai linee genealogiche definite, ma sianoun patrimonio genetico comune a tutte le famiglie. Soloin questo modo possiamo giustificare la ripetizione, e ilriutilizzo “creativo”, di strutture identiche in anatomiediversissime di Burgess. Il primo Cambriano sembra es-sere un’epoca di sperimentazione evolutiva e di flessibi-lità genetica potenziale: l’intervallo di tempo corrispon-dente alla spinta estrema della radiazione adattativa po-trebbe essere stata una fase di sperimentazione funziona-le a partire dalla disponibilità di una riserva exattativa ditipo genetico.
Supponiamo che in questa prima fase di sperimentazione elabilità genetica senza pari tali tratti potessero sorgere ripe-tutamente in ogni nuova linea genealogica di artropodi,non per una evoluzione lenta e separata in relazione a unafunzione comune (giacché i tratti rappresenterebbero inquesto caso analogie classiche), ma come potenziali latentinel sistema genetico di tutti gli artropodi primitivi, recluta-bili separatamente per trovare espressione aperta in ogni li-nea genealogica. In tal caso tratti come la forma corporeadei meristomoidi e il carapace bivalve potrebbero emergereripetutamente in tutto l’albero genealogico evolutivo(Gould 1989, p. 220).
EXAPTATION: LA BIOLOGIA DELL’ IMPREVEDIBILE
Non è da escludere, quindi, che la riduzione successi-va della disparità nei tempi e nei modi di un’estinzione dimassa non selettiva si sia verificata contemporaneamentealla riduzione del potenziale genetico originario. Ciò con-fermerebbe, a parere di Gould, il modello più recentedelle estinzioni non selettive, per cui l’evento catastroficopotrebbe anche inserirsi e sovrapporsi a una situazione di“crisi” adattativa preesistente, senza che questo pregiudi-chi il carattere, trasversale e non selettivo dell’estinzione.Lo scenario della biosfera dopo la catastrofe sarebbedunque, come prevedibile e come verificabile nella docu-mentazione successiva, quello di una minore disparità, diuna maggiore diversità interna ai phyla rimasti, di unacoerenza genetica e strutturale più forte fra i gruppi resi-dui e di un divario morfologico più marcato fra i phylasopravvissuti.
Le linee genealogiche persero il loro potenziale genetico ori-ginario di reclutamento di ogni parte importante da moltepossibilità latenti e, in secondo luogo, l’eliminazione dellamaggior parte delle linee genealogiche lasciò solo poche lineesuperstiti, con grandi lacune fra l’una e l’altra. La radiazionedi queste poche linee superstiti (in una grande varietà di spe-cie, con una disparità ristretta di forme complessive) produs-se i gruppi distinti che noi conosciamo oggi come phyla eclassi (ib.).
Il modello della riserva exattativa, chiamato in questocaso da Gould “modello del sacco di caratteri alla rinfusa”,potrebbe addirittura interessare trasversalmente tutti i phy-la di Burgess e non solo la divisione degli artropodi cam-briani. In questo caso la riduzione di disparità e l’abbassa-mento della soglia di “disponibilità” di strutture latenti deiperiodi successivi comporterebbero una “cristallizzazione”dei confini genetici e una canalizzazione genetica delle li-nee genealogiche macroevolutive superstiti. Si tratterebbe,in altri termini, di una modulazione del grado di evolvibi-lità trasversale fra cladi, il primo Cambriano sarebbe unperiodo di picco di evolvibilità:
TELMO PIEVANI
Forse al sacco di caratteri di Burgess potevano attingere ad-dirittura phyla diversi. Forse strutture articolate con una fon-dazione genetica comune non erano limitate agli artropodi.La loro presenza limitata altrove non implicherebbe unostretto rapporto genealogico con gli artropodi, ma solo unavasta gamma di strutture latenti e reclutabili che non rispet-tavano ancora i posteriori confini invalicabili fra i phyla mo-derni (p. 221).
La appendici boccali di Anomalocaris e le mandiboledi Wiwaxia non sono riducibili al “reclutamento” di ca-ratteri tipici del phylum degli artropodi: potrebbe trat-tarsi di caratteri disponibili in un “contenitore” più va-sto, tale da trascendere le demarcazioni poi fissatesi fra igruppi maggiori. Questa fluidità genetica rappresente-rebbe, in altre parole, un contesto evolutivo antico carat-terizzato da un’azione combinatoria molto più libera ericca che nelle epoche seguenti. I vincoli strutturali dellatrasformazione morfologica (regole di costruzione, di or-dine, di sviluppo embriologico...) potevano probabil-mente operare su un range di possibilità genetiche piùlargo: la gamma di percorsi evolutivi e funzionali possibi-li era sensibilmente maggiore, l’evolvibilità massima.Erano garantite soluzioni alternative ridondanti, così darendere praticabile una diversificazione delle strutturefunzionali a parità di sollecitazione ambientale, o vice-versa il delinearsi di percorsi evolutivi paralleli in organi-smi diversissimi.
La ricostruzione delle connessioni genealogiche degliorganismi di Burgess, persino con le più raffinate tecnichecladistiche nella seconda metà degli anni Ottanta, si riveladunque estremamente difficoltosa:
Sono stati compiuti vari sforzi per costruire un cladogrammaper gli artropodi di Burgess. Finora questi sforzi hanno avutoassai poco successo, poiché le diverse possibilità non conver-gono in modo soddisfacente. Se il modello del sacco miscella-neo è corretto, e ogni carattere principale di ogni nuova lineagenealogica deriva separatamente da una serie di possibilità
EXAPTATION: LA BIOLOGIA DELL’ IMPREVEDIBILE
latenti comuni a tutti gli artropodi, allora la connettività ge-nealogica dei fenotipi è spezzata, e il problema può risultareinsolubile con i comuni metodi cladistici (ib., nota 20).
La definizione di “bricolage”, usata per illustrare intui-tivamente il meccanismo di exaptation o di “eterogenesidella funzione biologica”, potrebbe allora essere estesa aitre livelli gerarchici delle unità evolutive. Il modello del“sacco di caratteri” latenti, come caratteristica della fase“creativa” della discontinuità evolutiva cambriana, con li-velli altissimi di evolvibilità fra i phyla, si integra pertantoad altri due nodi concettuali della interpretazione dell’e-voluzione come bricolage a partire da strutture e tratti giàesistenti.
I) Bricolage macroevolutivo. In alcune fasi critiche dellastoria naturale (i cosiddetti “spartiacque” evolutivi, legrandi soglie di discontinuità), generalmente caratterizza-bili da un’alternanza estrema fra una fase di diversificazio-ne esplosiva delle forme viventi e una fase di restrizionenon selettiva dei piani anatomici risultanti, la differenzia-zione delle strutture funzionali potrebbe avvenire per “re-clutamento” di caratteri disponibili nel corredo genetico,fino al raggiungimento di un culmine di disparità anatomi-ca. Si verificherebbe, in altri termini, un bricolage macroe-volutivo di diversificazione dei piani anatomici fondamen-tali, a partire da un potenziale genetico reso più “libero”nelle fasi di radiazione adattativa. È quanto appena de-scritto per la diversificazione esponenziale delle forme diBurgess.
II) Bricolage mesoevolutivo. La trasformazione funziona-le in continuità di struttura, o meglio la cooptazione di uncarattere per una funzione indipendente dalla sua origineevolutiva, rappresenta una forma di bricolage evolutivo alivello di selezione darwiniana normale fra singoli organi-smi all’interno di una specie.
Ecco come presenta questa idea dell’evoluzione-brico-lage il medico e fisiologo parigino François Jacob, in unaconferenza del 1977 a Berkeley:
TELMO PIEVANI
Spesso senza progetti a lungo termine, il bricoleur dà ai suoimateriali funzioni non previste per la produzione di un nuovooggetto. Da una vecchia ruota di bicicletta costruisce una car-rucola, da una seggiola rotta ottiene la scatola per la radio.Allo stesso modo, l’evoluzione costruisce un’ala da una zam-pa, o un pezzo di orecchio con un frammento di mascella.Naturalmente ci vuole tempo. L’evoluzione si comporta comeun bricoleur che nel corso di milioni e milioni di anni rima-neggiasse lentamente la sua opera, ritoccandola continuamen-te, tagliando da una parte, allungando da un’altra, cogliendotutte le occasioni per modificare le vecchie strutture in vistadelle nuove funzioni (Jacob 1978, p. 18).
Un esempio molto interessante di bricolage, nello stessopasso, è riferito a una ricerca che già nel 1964 Ernst Mayraveva ultimato a proposito dell’origine dei polmoni neivertebrati terrestri (un caso nel quale si era cimentato an-che Darwin, giungendo a una conclusione erronea):
Lo sviluppo del polmone è iniziato in certi pesci d’acqua dol-ce che vivevano in acque stagnanti, e quindi povere di ossige-no. Questi pesci presero l’abitudine di inghiottire aria e di as-sorbire l’ossigeno attraverso le pareti del loro esofago. In talicondizioni qualunque allargamento delle pareti si traducevain un vantaggio selettivo. Si formarono così dei diverticolidell’esofago, che sotto l’effetto di una spinta selettiva conti-nua poco a poco si ingrandirono per trasformarsi finalmentein polmoni. L’evoluzione ulteriore dei polmoni fu solo unaelaborazione sul tema con l’accrescimento della superficieutilizzata per il passaggio dell’ossigeno e con la vascolarizza-zione. Fabbricare un polmone con un pezzo di esofago asso-miglia molto alla pratica del bricoleur (p. 19).
Un secondo esempio, molto noto nella formulazionedatagli da Jacob ma ben presente anche nella riflessione diGould, è quello della formazione del cervello umano:
Il cervello umano si è formato grazie all’accumulazione dinuove strutture sulle vecchie. Al vecchio rinencefalo deimammiferi inferiori si è aggiunta una neocorteccia che ha as-
EXAPTATION: LA BIOLOGIA DELL’ IMPREVEDIBILE
sunto rapidamente, forse troppo rapidamente, il ruolo princi-pale nella sequenza evolutiva che porta all’uomo. (...) Forma-zione di una neocorteccia dominante, conservazione di un an-tico sistema nervoso e ormonale, in parte rimasto autonomo,in parte posto sotto la tutela della neocorteccia: questo pro-cesso evolutivo assomiglia molto al bricolage (p. 31).
III) Bricolage microevolutivo. Come ebbe a suggerire lostesso Jacob nel 1977, anche a livello genetico si può assi-stere a una forma generalizzata di bricolage evolutivo. Ilfunzionamento del genoma, nella sua integrazione gerar-chica e autoregolativa (la cui scoperta regalò a Jacob, insie-me a Jacques Monod, il premio Nobel per la medicina e lafisiologia nel 1965), è paragonabile in qualche modo all’u-tilizzo in chiave combinatoria di una serie non illimitata divarianti possibili. Come scrive il fisiologo parigino:
È forse a livello molecolare che si manifesta più chiaramente ilcarattere di bricolage della selezione naturale. Ciò che caratte-rizza il mondo vivente sono la sua diversità e, insieme, la suaunità di fondo. Esso comprende batteri e balene, virus ed ele-fanti, organismi che vivono a -20° C nelle regioni polari e altria 70° C nelle sorgenti calde. Tutti questi oggetti presentanotuttavia un’importante unità di struttura e di funzioni: gli stes-si polimeri, acidi nucleici e proteine, composti dagli stessi ele-menti, le quattro basi e i venti acidi amminici, svolgono sem-pre gli stessi ruoli. Il codice genetico è lo stesso e l’apparato ditraduzione non cambia affatto. Gli stessi coenzimi intervengo-no in reazioni simili. Dal batterio all’uomo, numerose tappedel metabolismo restano sostanzialmente le stesse (p. 21).
Naturalmente l’evoluzione necessita di una costanteproduzione di varietà e di una molteplicità di componentigenetiche disponibili. Non è detto, tuttavia, che la diversi-ficazione di base debba crearsi di volta in volta come no-vità assoluta (cioè come una trasformazione chimica checonduca a sequenze nucleotidiche inedite):
(...) Ma una volta iniziata la vita sotto la forma di qualche or-ganismo primitivo capace di riprodursi, l’evoluzione sarebbe
TELMO PIEVANI
proseguita soprattutto con il rimaneggiamento dei compostiesistenti. Funzioni nuove si sono sviluppate con la comparsadi nuove proteine. Queste erano però soltanto delle variazio-ni su temi noti (p. 21).
Analogamente a quanto riscontrato nei fenotipi cam-briani, anche a livello di sequenze nucleotidiche di organi-smi moderni si registrano le due “disobbedienze” alla ge-nealogia e alla discendenza ereditaria: forti somiglianze inanimali diversissimi fra le sequenze di proteine che svolgo-no la stessa funzione; e, viceversa, somiglianze focalizzatefra proteine con funzioni diverse. Ciò sembra essere più inaccordo con una concezione della trasformazione geneticain cui le strutture molecolari non si presentano ex novo, maper alterazione e ricombinazione delle strutture preesisten-ti. In particolare, converge su questa interpretazione l’ipo-tesi neutralistica di S. Ohno, secondo cui la derivazione dinuove sequenze può avvenire per duplicazione libera e ri-combinazione neutra di geni che a un certo punto della lo-ro replicazione possono presentare strutture proteiche mo-dificate “visibili” alla selezione e in quanto tali rinforzate.Si tratterebbe anche in questo caso di un exaptation a par-tire da elementi non adattativi di livello inferiore (cross-le-vel spandrels), perché la duplicazione e l’amplificazione dielementi genetici per selezione genica (ipotesi del “Dnaegoista” di Orgel, Crick 1980, proposta indipendentemen-te anche da Doolittle, Sapienza 1980) forniscono materialegenico ridondante che rende più flessibili gli organismi.Ciò che abbiamo spregiativamente definito “Dna spazzatu-ra” (junk Dna) potrebbe essere in realtà Dna ridondante,momentaneamente inutile e neutrale rispetto alla selezione,ma anche preziosa riserva potenziale per l’evolvibilità futu-ra. Conclude Jacob (p. 23):
Ciò può anche portare a una perturbazione nell’interazionecon altre proteine e favorire alla fine delle modificazioni diqueste proteine. Un largo settore dei genomi degli organismicomplessi potrebbe di fatto derivare da pochi geni ancestrali.(...) Le poche grandi tappe dell’evoluzione esigevano l’acqui-
EXAPTATION: LA BIOLOGIA DELL’ IMPREVEDIBILE
sizione di nuova informazione. La specializzazione e la diver-sificazione hanno richiesto, però, solo una diversa utilizzazio-ne della stessa informazione strutturale.
L’insistenza sul ruolo centrale e gerarchico dei geni re-golatori e dei geni predisposti alla conduzione dello svilup-po embrionale conferma, da una seconda angolazione, lanatura di bricolage della trasformazione genetica:
È una questione di regolazione più che di struttura. (...) Si puòdire che la diversificazione e la specializzazione dei mammiferisiano il risultato di mutazioni riguardanti i circuiti regolatoripiù che le strutture chimiche. Sono sufficienti piccoli cambia-menti che ridistribuiscono le stesse strutture nel tempo e nellospazio, per modificare profondamente la forma, il funziona-mento e il comportamento del prodotto finale, cioè l’animaleadulto. Si tratta sempre di utilizzare gli stessi elementi, di mo-dificarli, ritagliando di qui o di lì, di disporli in combinazionidifferenti, per produrre nuovi oggetti di complessità crescen-te. Si tratta sempre di fare del bricolage (p. 25).
Secondo le suggestioni teoriche di Jacob, l’ottimizzazio-ne funzionale si rivela come un autentico paradosso, unapretesa esplicativa senza riscontri effettivi. Interni a unaprospettiva di progressione funzionalistica e di specializza-zione focalizzata, non riusciremmo a spiegare l’insorgenzadella “novità” biologica: sfuggirebbe, in altri termini, lapossibilità di ricostruire il processo di emergenza di unastruttura fra le molte possibili. Affidandosi, viceversa, auna teoria della sub-ottimalità evolutiva possiamo afferrareil “significato evoluzionistico della creatività”, per cui dallaimperfezione, dalla bizzarria e dalla molteplicità funzionalesi delinea una sorta di principio evolutivo di ridondanza.In un saggio recente sulla formazione dell’udito a partiredalla sensazione tattile ancestrale tipica dei pesci, Gould(1989, p. 107) scrive:
Spesso le opere sulla natura scritte con toni lirici esaltano l’e-vidente perfezione e l’ottimalità del disegno organico. Eppure
TELMO PIEVANI
una tale posizione precipita la natura in un paradosso paraliz-zante, storicamente parlando. Se una tale perfezione esistessenormalmente, voi potreste rallegrarvi ed esultare, a parte ilpiccolo problema che la natura non esisterebbe (almeno nellaforma di organismi complessi) se i suoi prodotti godesserosempre di una tale ottimalità.
Tra perfezione del disegno organico e creazione di no-vità sussisterebbe dunque una proporzione inversa. La “lu-singa” dell’ottimalità rischia di mascherare il carattere di“stallo evolutivo” rappresentato dalla configurazione per-fetta di un organo: “Un mondo adattato in modo ottimalealle condizioni ambientali del presente è un mondo senzastoria” (Gould 1985, p. 43). Il bricolage molecolare mostrainsomma che in numerose occasioni la novità emerge dalleconseguenze accidentali, e spesso non adattative, di strut-ture molecolari evolutesi per altri motivi.
Variazioni sull’universo di Pangloss
La diversificazione dei fattori di evoluzione e la limitazio-ne del potere della selezione naturale costituiscono il frontedi un programma di revisione ed estensione, e non di nega-zione o confutazione, della teoria darwiniana. Se l’ortogenesi,cimentandosi con il problema dell’evoluzione convergente,sfocia in ipotesi interniste antidarwiniane come quelle avan-zate da Arthur Koestler (1979), in polemica con la visione diJacques Monod dell’evoluzione per “caso e necessità”, si cor-re il rischio di commettere un errore di prospettiva. La leggedi Dollo sull’irreversibilità dei percorsi evolutivi è un’ottimasintesi della questione: ci sono “corsi privilegiati” dell’evolu-zione, ma nessuna traiettoria è uguale a un’altra perché cia-scuna si ibrida in modo imprevedibile con fattori esterni; vi-ceversa, esistono convergenze adattative molto pronunciate,ma i segni del passato vengono inevitabilmente conservati.
È interessante a questo punto notare che entrambe leradicalizzazioni, quella esternalista (panselezionismo di
EXAPTATION: LA BIOLOGIA DELL’ IMPREVEDIBILE
Wallace) e quella internalista (ortogenesi), conducono auna riduzione della diversità naturale, fino a sottovalutarnesistematicamente l’esistenza nei dati empirici. Possiamo al-lora ipotizzare che l’exaptation, inteso come una sorta dieterogenesi della funzione biologica, sia una traduzione fe-dele del principio della massima varietà possibile in natura.L’unicità dei percorsi funzionali, data da quello che Gouldchiama “il principio della utilizzazione delle parti disponi-bili”, produce una molteplicità potenzialmente infinita di“storie” naturali e una tendenza intrinseca alla massima di-versificazione e ramificazione dei cammini evolutivi. Inquesto senso Gould si appella alla presenza ologrammaticadi tutto “il senso della storia” in piccole bizzarrie apparen-temente insignificanti, esiti incerti e imprevisti di bricolageadattativi, imperfezioni e stranezze da cui possiamo trarrela ricchezza della contingenza evolutiva.
La formulazione dell’exaptation, nelle quattro accezio-ni, ribadisce la sua connessione con la teoria morfologicadi D’Arcy Thompson, la cui sostanza strutturalistica (sesfrondata da ipotesi troppo vincolanti, e “neoplatoniche”,sul potere dei vincoli fisici nel formare gli individui indi-pendentemente dalla storia) sembra significativamente at-tuale: le forme complesse sono generate da sistemi elemen-tari di regolazione superiore, sono cioè correlazioni di cre-scita ontogenetiche sulle quali la selezione può agire sol-tanto in negativo, come filtro, sulla base del loro valoreadattativo derivato (per nulla escluso, nemmeno nella for-mulazione originaria di D’Arcy Thompson). L’interferenzadata da una piccola modificazione in un fattore della cre-scita può allora scatenare effetti imprevedibili. Uno studiodella metà degli anni Settanta di David Raup (Raup, Gould1974) ha ribadito che i gradienti di crescita che produconolo sviluppo morfologico sono abbastanza elementari:
Le forme complesse sono spesso generate da un sistema diforze molto più semplice (spesso estremamente semplice). Levarie parti vengono tra loro connesse in modi intricati attra-verso la crescita, e la trasformazione di una sola di queste par-
TELMO PIEVANI
ti può avere un effetto risonante sull’intero organismo e mo-dificarlo in molteplici e insospettabili modi. David Raup delField Museum of Natural History di Chicago ha creato unprogramma di calcolatore sulla base dell’ipotesi di D’ArcyThompson e ha dimostrato che è possibile produrre le formedi base delle varie conchiglie (nautili, bivalve e chiocciole) va-riando solo tre semplici gradienti di crescita. (...) In sistemicomplessi, la regolarità di entrata può tradursi in un cambia-mento episodico in uscita (Gould 1980, p. 36).
Esistono pertanto correlazioni di crescita molto artico-late, dipendenti da pochi fattori di regolazione, un princi-pio utilizzato in modo fecondo da Davis per la ricostruzio-ne della derivazione dei panda dalla famiglia degli orsi co-muni: pochissimi meccanismi genetici, forse non più di unamezza dozzina, vennero coinvolti nella primitiva transizio-ne dall’Ursus all’Ailuropoda (panda) (Davis 1964). Tali cor-relazioni sistemiche costituiscono al contempo i limiti e laflessibilità potenziale su cui poggiano le dinamiche di tra-sformazione funzionale. Il tema della varietà irriducibiledella vita è bilanciato e intrecciato al tema dell’unità e dellamodularità delle forme ripetute, suggerito da D’ArcyThompson nei termini, oggi datati, delle forme fisiche fon-damentali inscritte nella natura (come le strutture ad alvea-re, le onduloidi, le molteplici combinazioni superfici/volu-mi, i moduli a bolla). L’idea di exaptation ci riporta aconsiderare il sistema di sviluppo come un’inestricabile e ir-riducibile totalità integrata. È solo attraverso questa totalitàintegrata di elementi “interpenetrati”, intesa però comesoggetto evolutivo, che si riesce a comprendere la creativitàdella storia e la capacità degli organismi di cambiare dire-zione al loro sviluppo (Oyama 2000b).
La domanda iniziale dell’evoluzionismo neodarwinia-no – “a che cosa serve?” – si è ora trasformata in: “comefunziona?”. Si è cioè passati da un’interrogazione sulla fi-nalità adattativa della parte esaminata (con successivaestrapolazione funzionalistica al passato) a un’interroga-zione sulla struttura integrata e sulla rete di correlazionigerarchiche in cui si è sviluppata la singola parte. Nei ter-
EXAPTATION: LA BIOLOGIA DELL’ IMPREVEDIBILE
mini classici della tipologia causale aristotelica, vi è unaprevalenza delle “cause efficienti” che contribuiscono allacostruzione dei caratteri, i quali potranno poi avere (onon avere) una causa finale di tipo funzionale. Quest’ulti-ma sarà una conseguenza derivata della costruzione, nonla sua ragione costitutiva.
Sul piano epistemologico, l’avversario allora più“onesto” di questa prospettiva resta il panselezionismodi derivazione “wallaciana”, l’erede intellettuale del “mi-gliore dei mondi possibili” leibniziano, oggetto del sarca-smo di Voltaire nel Candide. Il mondo naturale di Walla-ce è l’universo del dottor Pangloss, in cui utilità attuale eorigine storica sono costantemente collegati. Tutto va peril meglio, perché ogni struttura presente è frutto di unsapiente e onnipervasivo processo di adattamento “in vi-sta” della funzione attuale. Ogni individuo ha un posto“giusto” e appropriato nella natura: è una nota nellasinfonia complessiva.
In un certo senso, essi avevano quasi reintrodotto la conce-zione creazionista dell’armonia naturale sostituendo alla divi-nità benevola l’onnipotente forza della selezione naturale.Darwin, invece, aveva sempre mantenuto un atteggiamentopluralista nei confronti di un universo che gli appariva confu-so (Gould 1980, p. 44).
Questa tautologia della perfezione naturale è l’antidotodella storia: così la natura non ha storia ed è espulsa arbi-trariamente dal suo quadro esplicativo la nozione di “tem-po”. I meriti della corrente morfologico-strutturale delpensiero biologico nello svelare questo pregiudizio adatta-zionista e nello smascherare le false speranze indotte dagli“occhiali di Pangloss” sono forse sottovalutati. Si inscrivein questo tentativo di “salvare la storia” il provocatorio tri-buto gouldiano al padre dello strutturalismo biologicoGeoffroy Saint-Hilaire:
La discussione sull’adattamento non è un’insignificante sot-tigliezza astratta della vita accademica. Essa include i nostri
TELMO PIEVANI
atteggiamenti fondamentali verso la storia. La biologia evo-luzionistica è la scienza primaria della storia; un adattazio-nismo rigoroso, per una curiosa ironia, degrada la storia al-l’insignificanza, considerando il rapporto dell’organismo al-l’ambiente un problema isolato di ottimalità corrente. (...)Scrivendo molto brillantemente sul condizionamento eser-citato dalla teoria sulla nostra capacità di osservare, Geof-froy Saint-Hilaire affermò nel 1827: “Dapprima inutili,questi fatti dovettero restare non percepiti sino al momentoin cui i bisogni e i progressi della scienza ci sollecitarono ascoprirli”. È venuto il momento di salvare la storia dal po-tere sovversivo degli occhiali del dottor Pangloss (Gould1987a, p. 25).
Eppure, le due versioni più accreditate ed estreme di“panglossismo” contemporaneo, autentiche teorie dell’uti-lità universale, hanno avuto un’ampia divulgazione e susci-tato un vivace dibattito negli ultimi vent’anni. La prima,rappresentata dalla sociobiologia, è una forma di adattazio-nismo classico, espresso con chiarezza programmatica edepistemologica. Inveterati pregiudizi sono ora confessabili,senza paura di ritorsioni, grazie alla sanzione scientificadarwinista, il cui meccanismo funzionalista e individualistadi spiegazione è applicato questa volta alle manifestazionidella cultura umana e alle abitudini della specie Homo sa-piens. La sociobiologia compendia in modo mirabile loschema interpretativo del determinismo, mescolando il ri-duzionismo genetico atomistico all’ottimismo panglossianoentro un mondo di organismi e comportamenti perfetti perle circostanze:
Il principale punto debole della sociobiologia è una conse-guenza dell’assunto darwiniano che i comportamenti che lateoria pretende di spiegare devono essere interpretati comeadattamenti di organismi. In un periodo in cui, all’internodella teoria dell’evoluzione, queste nozioni sono fatte segno afrequenti critiche, le rivoluzioni fondate sull’ortodossia dellaselezione sembrano curiosamente anacronistiche. (...) L’adat-tazionismo rigoroso ha incespicato malamente, in quanto unamigliore comprensione dell’architettura genetica e ontogene-
EXAPTATION: LA BIOLOGIA DELL’ IMPREVEDIBILE
tica ci costringe a considerare le parti dell’organismo comeintegrate in sistemi sottoposti a vincoli dalla storia e da regoledi struttura, e non come un insieme di strumenti, ciascunoadattato individualmente a beneficiare organismi nelle loroecologie immediate (p. 32).
La seconda è invece quella che Gould definì un’estensio-ne cosmologica del “panglossismo” unita a un’esplosioneparossistica di presunzione antropocentrica: si tratta del co-siddetto principio antropico, sostenuto da autorevoli fisici ecosmologi (Barrow, Tipler 1986). In questo caso l’equivalen-za fra utilità attuale e origine storica è estesa al destino co-smico dell’umanità: l’uomo è perfettamente adattato alle leg-gi naturali dell’universo, come da evidenze empiriche; ciòera molto improbabile che accadesse, dato che una minimavariazione delle costanti fisiche fondamentali avrebbe irri-mediabilmente compromesso l’avvento della vita; quindi, leleggi universali devono essere sorte in vista della posteriorecomparsa dell’intelligenza umana. La causalità è rovesciatain un’inferenza che cerca di ricostruire la storia sulla basedella situazione presente: l’universo è tale in quanto “appro-priato” alla nostra esistenza, è il migliore universo possibile.
La versione forte di questo principio dice, all’incirca, che poi-ché la vita umana è adattata in un modo così complesso in ununiverso governato da leggi naturali (utilità attuale), questeleggi devono essere sorte con la nostra posteriore apparizioneal livello della mente (origine storica) (p. 49).
Come scrisse l’autorevole fisico dell’Institute for Ad-vanced Study di Princeton, Freeman Dyson (1979, p. 289),fra i maggiori sostenitori del principio antropico:
quanto più esamino l’universo e studio i particolari della suaarchitettura, tanto più numerose sono le prove che l’universo,in un certo senso, doveva già sapere che saremmo arrivati.
L’universo si sarebbe evoluto per alcuni miliardi di anniper costruirci la migliore dimora possibile. Se anche una
TELMO PIEVANI
sola delle “costanti fisiche” cosmologiche fosse infinitesi-mamente diversa dai valori reali, la vita non sarebbe statapossibile: la speranza è che vi sia un “senso” in questacoincidenza favorevole. Diversamente, il fascino della con-tingenza risiede nel constatare, con autentica “meraviglia”,l’esito imprevedibile di questa concatenazione vertiginosadi improbabilità che ha portato all’esistenza di esseri intel-ligenti. In questo consiste la ricchezza del caso e della sto-ria: poter misurare sulla propria “improbabilità” la prezio-sa eredità che ci tocca.
Eppure, l’attrazione verso l’inevitabilità del destino dinoi esseri umani, “attesi” al centro della scena dell’univer-so, è così forte da condizionare impianti teorici pur di ma-trice spiccatamente strutturalista (e in aperta antitesi ri-spetto al funzionalismo selezionista) come quello propostodal biologo teorico Stuart Kauffman per la spiegazione del-le origini della vita e dell’emergenza di strutture ordinatenei sistemi viventi. In questo caso le leggi di autorganizza-zione spontanea e di “morfogenesi” interna della vita, im-ponendosi direttamente sulla materia organica e limitandodrasticamente il ruolo della selezione naturale, produconouna tendenza inevitabile all’aumento di complessità, checulmina nella comparsa di esseri autocoscienti (Kauffman1995; Goodwin 1994). Ci stavano proprio aspettando allascintillante reception dell’Hotel Universo.
1978, Royal Society di Londra...
Il concetto di exaptation ha una genesi abbastanza pe-culiare, che forse è utile richiamare per poterlo poi inserirenel contesto più ampio, e appropriato, di una ridefinizionein senso sistemico e costruttivista dell’idea di adattamento.Nel 1978 Richard Lewontin fu invitato a un convegno del-la Royal Society di Londra per sostenere la posizione criti-ca espressa dopo l’uscita del testo programmatico di Wil-son sulla sociobiologia nel 1975. Al genetista statunitensefu offerto l’intervento conclusivo dell’intera manifestazio-
EXAPTATION: LA BIOLOGIA DELL’ IMPREVEDIBILE
ne. Lewontin fu tuttavia costretto a rifiutare l’invito e pro-pose in sua sostituzione il collega Stephen J. Gould. I dueconcordarono per il prestigioso appuntamento londineseun intervento che fece scalpore, suscitando non poche rea-zioni polemiche nell’establishment accademico britannico.In quell’occasione iniziò il lungo scambio polemico a di-stanza fra Gould e il biologo inglese Richard Dawkins, cheaveva pubblicato due anni prima il suo libro di maggiorsuccesso, intitolato Il gene egoista (1976).
Il soggetto dell’intervento di Gould e Lewontin, dal ti-tolo The Spandrels of San Marco and the Panglossian Para-digm: A Critique of the Adaptationist Programme (1979),segnò una tappa decisiva per la teorizzazione del concettodi exaptation. Gould, come abbiamo visto, aveva condottoin quegli anni con Raup, Schopf e Simberloff i primi studisui modelli stocastici nella filogenesi e alcune ricerche teo-riche sulla tradizione biologica strutturalista dell’Europacontinentale (contrapposta alla tradizione selezionista in-glese). Era inoltre motivato da un impegno critico moltoaccentuato verso le teorie sociobiologiche panselezionisteallora diffusamente propagandate sulla stampa statunitenseed europea.
Il lavoro di Lewontin in genetica, d’altra parte, puntavaalla delineazione di un “pensiero biologico non adattazio-nista”, cioè di una concezione del processo evolutivo che,senza negare la plausibilità e la frequenza relativa dei feno-meni di adattamento, non assegnasse un campo di validitàonnicomprensivo al meccanismo adattativo nella spiegazio-ne del cambiamento. L’allocuzione di fronte ai maggioriteorici del “programma adattazionista” anglosassone sinte-tizzò quindi una molteplicità di filoni di studio e raccolsele idee di un gruppo di scienziati impegnati nel tentativo di“ridimensionare” il potere della selezione naturale nell’e-voluzione e di diversificare i fattori e i meccanismi di cam-biamento delle forme e dei comportamenti biologici.
L’articolo sui “pennacchi di San Marco” rilanciò inoltreuna tesi cui Gould lavorava da alcuni anni e che abbiamocercato di affrontare nel primo capitolo del presente lavo-
TELMO PIEVANI
ro: l’affermazione di un programma di ricerca pan-adatta-zionista non può essere imputata a Charles Darwin che, co-me già si è detto, in più di una occasione rifiutò la confu-sione fra la sua teoria e le più radicali forme di pan-selezio-nismo escogitate negli anni successivi alla prima edizionede L’origine delle specie. La cristallizzazione della teoriaevolutiva attorno a una nozione forte e onnipervasiva dellaselezione naturale risale agli ultimi anni dell’Ottocento,quando A. R. Wallace e A. Weissmann accreditarono all’a-dattamento immediato l’origine della quasi totalità dellestrutture morfologiche degli organismi e identificarono ilmeccanismo di selezione del più adatto con il criterio stes-so di evoluzione dei viventi.
L’intervento di Gould fu apprezzato onestamente dallostesso Maynard Smith come “evento culminante” dell’in-contro e fu pronunciato in uno stile a tratti felicemente di-vulgativo e a tratti rigorosamente “accademico”, tanto daessere citato dal maggior agente letterario americano, JohnBrockman, come esempio migliore della nuova divulgazio-ne scientifica “d’autore” ai confini delle due culture(Brockman 1995). Alcuni anni dopo, fra i molti dibattiti ele polemiche sulla rilevanza dei “pennacchi” trascinate peranni (Dennett 1995; Queller 1995; Houston 1997), questoepisodio di storia dell’evoluzionismo fu addirittura sceltoda alcuni storici della scienza e della letteratura come em-blema delle capacità narrative e retoriche degli scienziati,divenendo una specie di “caso letterario” studiato nei corsiuniversitari (Selzer, a cura, 1993).
Gould in quell’occasione sostenne che il programmaadattazionista si presenta come una forma di fedeltà quasiinconsapevole a un’“abitudine profondamente radicata”fra gli studiosi dell’evoluzione. Questa particolare posizio-ne teorica e questo stile interpretativo dei processi naturalisono riassumibili in alcune proposizioni di base. L’intentoè di presentare, subito dopo, quella che Gould chiama“una tipologia parziale” delle alternative possibili alla spie-gazione di forme, funzioni e comportamenti naturali se-condo il concetto di adattamento ottimale e immediato,
EXAPTATION: LA BIOLOGIA DELL’ IMPREVEDIBILE
una tipologia estesa che rappresenta lo sfondo e la visionepiù comprensiva entro cui collocare i meccanismi di exap-tation descritti precedentemente.
Come viene definito da Gould e Lewontin nel saggio, il“paradigma di Pangloss” ruota attorno ad alcune assunzio-ni teoriche principali:
1) la selezione naturale è la causa primaria e prevalentenella costruzione del progetto organico; l’azione di vincolistrutturali che limitano o comunque deviano il corso dellosviluppo per selezione è sottovalutata e accantonata come“fenomeno marginale”;
2) l’organismo analizzato è “atomizzato” nei suoi trattiorganici singoli, ciascuno dei quali è poi interpretato espiegato come “struttura ottimale forgiata dalla selezionenaturale per la sua funzione attuale”; la spiegazione delcambiamento evolutivo non contempla la considerazionedell’organismo come totalità integrata non riducibile allasomma o alla giustapposizione delle sue parti, l’oggettodello studio evolutivo è a sua volta una “collezione di og-getti discreti” presi singolarmente;
3) questa idea di ottimizzazione “part by part” si affian-ca a una concezione delle interazioni fra le parti organichecentrata sulla nozione di “compromesso” o meglio di“equilibrio”: la sub-ottimalità funzionale di una parte è in-terpretata come contributo al miglior disegno possibiledell’organismo intero; viceversa, l’ottimizzazione funziona-le di una parte avrà un “costo” evolutivo su altre parti: laselezione agisce attraverso un equilibrio di forze e un bi-lanciamento funzionale che garantisce costantemente l’otti-malità dell’organismo intero;
4) fenomeni di formazione di nuove strutture per via dimeccanismi non adattativi non sono negati per principio(non si possono escludere dallo studio del cambiamentoeventi come le derive genetiche o le correlazioni di crescitaallometriche), così come un programma non adattazionistanon potrà negare la frequenza e l’importanza dei processidi adattamento funzionale; non è questione, dunque, di vi-sioni teoriche e sperimentali incommensurabili, come spes-
TELMO PIEVANI
so la reciproca caricaturizzazione delle posizioni potrebbesuggerire: il nocciolo della contrapposizione sta nella defi-nizione del dominio di azione dei diversi principi esplicati-vi; nel programma adattazionista ortodosso l’area di spie-gazione adattativa è largamente preponderante su ogni al-tra ipotesi esplicativa, l’alternativa non funzionalista è con-siderata non essenziale o comunque minoritaria;
5) la procedura di ricostruzione del processo evolutivo siconfigura come un “riavvolgimento” temporale a partiredall’utilità attuale: a) “a cosa serve?”, è la prima interroga-zione cui rispondere, b) “come ci si è arrivati?”, la seconda.
Questo modo particolare di concepire le leggi e le causedella variazione evolutiva corrisponde anche a una moda-lità peculiare di “raccontare le storie naturali”. Le tecnicheargomentative adattazioniste sono così sintetizzate daGould: a) “se un argomento adattativo fallisce, cercane su-bito un altro”, anziché vagliare storie alternative; b) “se unargomento adattativo fallisce, deve per forza esisterne unaltro” (il paradigma legittima la propria esposizione a ipo-tesi non verificate, pur di non cedere alla proliferazione distorie alternative); c) “in assenza di un buon argomentoadattativo al momento, attribuisci le difficoltà all’imperfet-ta conoscenza di dove un organismo vive e di cosa fa”(strategia epistemologica delle “testimonianze imperfette”,cui restò vittima per molti decenni la paleontologia); d)“enfatizza l’utilità immediata ed escludi altri attributi dellaforma organica” (trasforma cioè una caratteristica seconda-ria, l’utilità attuale, nel criterio essenziale di spiegazionedell’origine e dell’intero processo).
Lo stile interpretativo si manifesta nella scelta di unacerta gamma di “storie plausibili”, a partire dal principiodella selezione naturale. Anziché scegliere fra un “set” dipossibili percorsi evolutivi per ogni risultato attuale, si con-centra l’attenzione su una sola ed esclusiva modalità dispiegazione. Ciò vale estesamente per la divulgazionescientifica, ma coinvolge anche una larga parte della lette-ratura specialistica. Le deboli, minute e atrofizzate gambe
EXAPTATION: LA BIOLOGIA DELL’ IMPREVEDIBILE
anteriori del Tyrannosaurus Rex “saranno pur servite aqualcosa”, spiega la scritta esplicativa del museo di Bostoncitata da Gould: non certo per cibarsi, forse “per aiutarel’animale a rialzarsi dalla posizione di riposo sdraiato”.Quasi implicitamente siamo portati ad accogliere un ragio-namento rovesciato:
Noi non dubitiamo che il Tyrannosaurus abbia usato le suapiccole gambe anteriori per qualcosa. Se esse si fossero pre-sentate ex novo, noi incoraggeremmo la ricerca di qualche ra-gione adattativa immediata. Ma esse sono, dopo tutto, il pro-dotto residuale di omologhi ancestrali normalmente funzionali(le gambe più robuste dell’Allosaurus, ad esempio). In quantotali, non abbiamo più bisogno di una spiegazione adattativaesplicita per la loro riduzione successiva. Si tratta probabil-mente di una correlazione dello sviluppo dei campi allometricipreposti alla crescita differenziale delle dimensioni degli arti.Questa ipotesi non-adattativa può essere verificata attraverso imetodi convenzionali dell’allometria e ci sembra molto più in-teressante e feconda di una speculazione inverificabile basatasull’utilità secondaria nel migliore dei mondi possibili. Non bi-sogna confondere il fatto che una struttura è usata in un certomodo con la ragione evolutiva primaria della sua esistenza econformazione (Gould, Lewontin 1979, p. 153).
“A cosa serve il mento umano?”, recita l’esempio favo-rito di Lewontin (1978) per illustrare il fraintendimentoadattazionista:
Se consideriamo il mento come una “cosa” anziché come unprodotto dell’interazione tra due campi di crescita (alveolaree mandibolare), siamo inevitabilmente condotti a un’interpre-tazione della sua origine evolutiva (ricapitolatoria) esattamen-te opposta a quella ora generalmente accettata (neotenica)(Gould, Lewontin 1979, p. 151).
L’esperimento che Gould decide di usare come esem-pio di ragionamento aprioristico adattazionista è quello diDavid P. Barash sugli schemi di aggressione dei pettirossidi montagna (1977). In esso l’etologo tentò di ricostruire
TELMO PIEVANI
una presunta strategia adattativa “anti adulterio” degliesemplari maschi di ritorno al nido nel periodo di deposi-zione delle uova (per mezzo di modelli artificiali di femmi-ne e maschi antagonisti, posti nelle vicinanze della covata).La “storia plausibile” di Barash entra in crisi non appena labanale modificazione di una variabile sperimentale aprel’esperimento a una molteplicità di altre storie plausibili, dialtri percorsi evolutivi ed esplicativi possibili.
Spesso gli evoluzionisti usano il concetto di “consistenza”con la selezione naturale come unico criterio e consideranoil loro lavoro compiuto solo quando hanno escogitato unastoria plausibile in tal senso. Ma storie plausibili possonosempre essere raccontate. La chiave della ricerca storica stanell’individuare i criteri per identificare le spiegazioni accet-tabili all’interno di un set sostanziale di percorsi evolutivipossibili verso qualsiasi risultato attuale (Gould, Lewontin1979, p. 154).
Se la scienza si accosta allo stile della “ricerca storica”,come dovrebbe senza “invidie” epistemologiche verso lescienze fisico-matematiche – sostengono in più occasionigli autori –, non possono esistere storie a senso unico, rico-struzioni aprioristiche a partire da criteri esplicativi assolu-tizzanti. Nello spirito autentico del pluralismo darwiniano,al cui interno non v’è mai stato posto per una omogeneiz-zazione dei meccanismi evolutivi sotto il criterio della sele-zione del più adatto (come sottolineò per la prima voltaGeorge J. Romanes nel 1900 – in AA.VV. 1900), possiamo aquesto punto tracciare una tipologia estesa delle alternativealla spiegazione selezionista ortodossa del cambiamentomorfologico e funzionale.
Perché gli alberi non crescono fino in cielo
La classe generale degli episodi di cambiamento evolu-tivo riconoscibili può comprendere al proprio interno, ol-tre agli eventi di normale adattamento primario, anche:
EXAPTATION: LA BIOLOGIA DELL’ IMPREVEDIBILE
1) trasformazioni (morfologiche, funzionali o compor-tamentali) il cui meccanismo di consolidamento non regi-stra né un adattamento né gli effetti della selezione naturale;è il caso delle variazioni dovute a fattori puramente casuali,come nel caso delle derive genetiche, in cui si verifica unprocesso stocastico di cambiamento nelle frequenze geni-che; tali variazioni non presentano alcuna “direzionalità”adattativa e rispetto alla selezione possono aversi:
- per fissazione di differenze e diversificazioni in assenzadi pressione selettiva,
- per fissazione e diversificazione a dispetto della pres-sione selettiva in atto,
- per rimozione di frequenze geniche favorevoli, fissatesiin precedenza per selezione naturale;
2) trasformazioni in cui non vi è né adattamento né se-lezione naturale nella parte in questione: la forma della par-te considerata è una conseguenza correlata e concomitantedegli effetti della selezione naturale su altre parti; è il casodelle correlazioni di crescita, dell’allometria, della pleio-tropia genica, dei fenomeni di compensazione evolutiva,delle correlazioni meccaniche di sviluppo; come già sugge-rito embrionalmente nella teoria delle “coordinate di tra-sformazione” di D’Arcy Thompson, le correlazioni di svi-luppo di un organismo, inteso come totalità integrata enon come ingranaggio di parti discrete ben disegnate dallaselezione, sono molto fitte per ragioni fisiche e rientranoin due categorie principali:
- correlazioni di crescita relativa delle dimensioni cor-poree (allometria), i cui effetti possono assumere un ruoloadattativo secondario, ma i cui tassi effettivi di svilupponon sono sotto controllo adattativo diretto;
- alterazioni dei tempi di maturazione biologica dell’in-dividuo (come le strategie r-selettive e la neotenia), nonaventi un valore adattativo primario ab initio;
3) trasformazioni in cui vi è un disaccoppiamento fraadattamento e selezione; nei due sensi:
TELMO PIEVANI
- selezione senza adattamento, come avviene in presenzadi pressioni selettive multiple e divergenti (il cui studio èmerito dello stesso Richard Lewontin) che si intrecciano fi-no al raggiungimento di un grado di stabilità senza neces-sariamente la “guida” di adattamenti primari; il caso piùnoto è forse quello della sovrapposizione fra una pressioneselettiva “da predatore” (la prole di una specie è minaccia-ta da un potente predatore) e una pressione selettiva con-traria “da scarsità di risorse” (la fecondità della specie rad-doppia per reazione alla decimazione operata dai predato-ri, la prole aumenta fino a esaurire le risorse alimentari di-sponibili);
- adattamento senza selezione, come nei casi di “plasti-cità fenotipica”: un cambiamento geografico o climaticoinduce una trasformazione fenotipica di carattere pretta-mente adattativo senza che vi sia stata una pressione selet-tiva di lunga durata e continuativa (l’esempio citato soven-te è la modificazione fenotipica delle spugne e dei coralliper adattarsi ai mutevoli regimi di flusso e correnti delleacque; per una sistematizzazione recente dell’argomento,Pigliucci 2001);
4) trasformazioni per adattamento e selezione, senza tut-tavia una base selettiva per le differenze fra i vari tipi diadattamento; organismi simili possono sviluppare diversestrategie adattative come soluzione alle medesime sollecita-zioni ambientali, si parla in questo caso di “picchi adattati-vi multipli”; non sempre la selezione è un criterio sufficien-te per la loro valutazione e comparazione: si tratta spessodi ingegnose soluzioni scelte fra molte altre altrettantoplausibili, la morfologia risultante (il “picco adattativo” piùo meno funzionale) sarà il prodotto di una storia contin-gente e non di un progetto ottimale preordinato dalla sele-zione; rientra in questa tipologia lo studio specialistico del-lo stesso Gould sulla lumaca Cerion delle isole Bahamas, lecui diversificazioni fenotipiche rappresentano picchi adat-tativi non giustificabili da pressioni selettive proporzionalima da percorsi evolutivi ramificatisi in modo contingente;
EXAPTATION: LA BIOLOGIA DELL’ IMPREVEDIBILE
5) trasformazioni per adattamento con selezione, in cuil’adattamento è un’utilizzazione secondaria di parti formate-si per ragioni non selettive di “architettura” organica, di svi-luppo o di variazione esogena contingente: la tipologia spe-cifica indicata tecnicamente con il termine di exaptation.
La trattazione di Gould e Lewontin sulle tipologie diazione della selezione naturale non implica né una sottova-lutazione del ruolo e della frequenza dei fenomeni adattati-vi né l’appello vago ad “altre cause” che caratterizza alcuneforme europee di “antiriduzionismo forte” di marca inter-nalista. Le trasformazioni non primariamente adattative ocomunque non dettate dalla causazione lineare della sele-zione non sono equiparate a fenomeni “non ancora ben co-nosciuti” all’interno degli organismi, né si assume che ilnon-adattamento equivalga alla non-intellegibilità dell’ori-gine e dell’evoluzione di un carattere biologico. Gould èmolto esplicito nel rifiuto di queste forme “misticheggian-ti” di opposizione al riduzionismo adattazionista. Optapreferibilmente per una forma coerente e rigorosa di “anti-riduzionismo debole”, centrato su un’idea portante (la“forma” è debole ma l’efficacia esplicativa è “paradossal-mente più forte”, nota Gould): l’opera della selezione na-turale interagisce costantemente, a tutti i livelli gerarchici,con i vincoli imposti dalla struttura organica individuale.L’evoluzione scaturisce, o per meglio dire “emerge”, daquesta interazione fra spinte selettive e resistenze struttura-li. L’evoluzione è l’emergenza di una struttura utile a parti-re dalla interazione contingente fra vincoli di crescita epressioni selettive.
Come scrive lo zoologo austriaco Rupert Riedl nel1978, questo stile “organicista” del pensiero biologico, lacui ricca tradizione attraversa l’opera di Goethe, di Geof-froy de Saint-Hilaire fino a D’Arcy Thompson e ConradWaddington, si trova oggi in netta minoranza fra i maggio-ri teorici dell’evoluzione: “non è stato più neppure inse-gnato in molte università americane”. Ma non si tratta, indefinitiva, di negare l’azione dell’adattamento, bensì di in-
TELMO PIEVANI
debolire la riconduzione unilaterale di ogni schema strut-turale, divergente in qualche tratto rispetto ai simili e agliascendenti, a una funzionalità adattativa primaria additataautomaticamente come causa della divergenza stessa. L’ori-gine evolutiva è invece spesso il prodotto di una storia con-tingente influenzata da vincoli architettonici e da possibi-lità adattative eterogenee.
I vincoli che cambiano in modo così profondo il nostro“approccio all’evoluzione” in un senso non adattazionista (etuttavia non antiadattazionista) e che giustificano quindiun’operazione epistemologica di reinterpretazione dei prin-cipi del cambiamento naturale non sterilmente oppositiva(come di chi vorrebbe negare la validità della spiegazioneprecedente o marginalizzarla) bensì “estensiva”, sono fon-damentalmente riconducibili a quattro categorie principali:
a) vincoli filetici residuali: resistenze al cambiamentodovute all’inerzia evolutiva filetica sedimentatasi nel passa-to (Homo sapiens ha ancora, per esempio, una qualche re-sistenza ancestrale alla postura eretta); si tratta dei “resi-dui” di comportamenti o morfologie superate;
b) vincoli filetici di tipo fisico: i limiti fisiologici che leleggi della fisica impongono al cambiamento degli indivi-dui (i molluschi non volano, gli insetti non sono grandi co-me elefanti e gli alberi non crescono fino in cielo – Gould,1996);
c) vincoli filetici dello sviluppo: restrizioni alle trasfor-mazioni evolutive possibili dovute ai “canali di sviluppo”ontogenetici refrattari al cambiamento e alla manipolazio-ne (filone di studio spesso ricordato da Gould che, comeabbiamo visto, nel suo Ontogeny and Phylogeny si rivolge aVon Baer e a Haeckel per i loro studi su embriologia e on-togenesi, oltre che a Waddington per la teorizzazione deivincoli ontogenetici);
d) vincoli ontogenetici strutturali o “architetturali”: teo-rizzati e descritti perfettamente, secondo Gould senza il ri-scontro dovuto presso la comunità scientifica, dal paleon-tologo tedesco A. Seilacher nel 1970 (che si occupò nellospecifico delle strutture corporee divergenti dei molluschi
EXAPTATION: LA BIOLOGIA DELL’ IMPREVEDIBILE
e dei brachiopodi); si tratta delle restrizioni al campo deicambiamenti evolutivi potenziali da attribuire alla strutturacorporea e materiale degli organismi, cioè alla particolarecostruzione e interconnessione dei componenti del Bau-plan organico, “forme di base” divergenti (senza alcunafunzionalità manifesta e probabilmente non adattative, senon secondariamente) che condizionano l’evoluzione e l’e-sito delle interazioni fra strutture organiche e derive evolu-tive per selezione naturale.
Su questi quattro tipi di vincoli evolutivi Gould espri-me alcune considerazioni interessanti:
Se lo sviluppo riguarda “pacchetti integrati”, e non può esse-re condotto pezzo per pezzo nell’evoluzione, allora il pro-gramma adattazionista non può spiegare l’alterazione dei pro-grammi di sviluppo che sottendono intimamente ogni cam-biamento del Bauplan... Gli schemi divergenti sono un vinco-lo architetturale fondamentale. Occasionalmente, dopo la lo-ro comparsa, possono essere utilizzati per un effetto benefico(Gould, Lewontin 1979, p. 162).
Dopo aver citato il “poliedro di Galton”, che abbiamo vi-sto essere la metafora forse più trasparente della nozione dicoevoluzione fra vincoli strutturali e spinte selettive, gli autoriconcludono il loro intervento con l’invito a un approccio plu-ralista verso gli agenti, i modi e i principi dell’evoluzione:
Noi siamo convinti che la ricompensa potenziale per l’abban-dono di una visione esclusiva come quella del programmaadattazionista potrebbe essere davvero grande. Non diamo ilconsiglio di rinunciare per sempre alla comprensione, comespesso ci accusano di fare gli adattazionisti. Per non-adattati-vo non intendiamo “non-intellegibile”. Accogliamo la ric-chezza che un approccio pluralistico, così vicino allo spiritoautentico di Darwin, può procurarci. Sotto il programmaadattazionista i grandi temi storici dello sviluppo morfologicoe del Bauplan sarebbero largamente abbandonati, perché se laselezione può rompere ogni correlazione e ottimizzare le sin-gole parti separatamente allora l’integrazione di un organismo
TELMO PIEVANI
non conta più nulla. Spesso quindi il programma adattazioni-sta ci ha dato una biologia evolutiva fondata su parti singole esu geni, ma non su organismi. Ha assunto aprioristicamenteche ogni transizione possa avvenire passo passo e ha sottova-lutato l’importanza dei “blocchi” integrati di sviluppo e deivincoli pervasivi della storia e dell’architettura. Una visionepluralistica potrebbe riportare gli organismi, con tutta la lororecalcitrante, e pure intellegibile, complessità, nel cuore dellateoria evolutiva (p. 163).
Da un punto di vista epistemologico, è interessante no-tare l’abitudine argomentativa di fondo del programmaadattazionista, messa abilmente in discussione da Gould eLewontin nel 1978. Potremmo definire questo habitus pa-radigmatico del programma come una “inversione della lo-gica esplicativa”: l’effetto risultante del processo evolutivo(il “prodotto”) viene inteso coma causa del processo stes-so. Nel celebre esordio del saggio fin qui esaminato gli au-tori presentano tre situazioni esemplificative di questa in-versione logica, traendole da discipline non attigue allabiologia evolutiva.
I pennacchi di San Marco
Se la costruzione della cattedrale di San Marco prevedela sovrapposizione di una cupola circolare, divisa in quat-tro quadranti, su un corpo quadrato la cui sommità è costi-tuita da quattro archi sui lati, necessariamente si otterran-no ai quattro angoli degli spazi triangolari, affusolati versoil basso. Questi “pennacchi” (spandrels se bidimensionali;più precisamente pendentives se tridimensionali) sarannodelimitati dagli archi di sostegno e dal bordo inferiore delquadrante della cupola. Ciascun pennacchio contiene unmosaico perfettamente adattato allo spazio disponibile: unevangelista è seduto nella parte superiore, affiancato dallecittà celesti, mentre al di sotto un uomo simboleggiante ifiumi biblici versa acqua da una brocca nello spazio che sirestringe fino a chiudersi ai suoi piedi. Il disegno è “così
EXAPTATION: LA BIOLOGIA DELL’ IMPREVEDIBILE
armonioso ed elaborato che siamo tentati di vederlo comeil punto iniziale di qualsiasi analisi, come la causa di tuttal’architettura circostante”.
Restando nella metafora, l’argomentazione adattazioni-sta suonerebbe così: il disegno attuale è ottimamente adat-tato allo spazio dei pennacchi, quindi i pennacchi sono sta-ti concepiti e progettati per garantire la rappresentazionedegli evangelisti e della profusione dell’acqua dai quattroestremi della costruzione allegorica. Una scansione logicanon-adattazionista riporta invece la causa come effetto del-la struttura preesistente: le regole architettoniche di costru-zione della cattedrale impongono dei vincoli alla ripartizio-ne dello spazio all’interno dell’edificio; si formano necessa-riamente degli spazi interstiziali, secondari, fra le compo-nenti maggiori della costruzione; questi spazi vengono ri-utilizzati con ingegno e creatività dai mosaicisti che trasfor-mano la regolarità dei quattro pennacchi in una composi-zione allegorica; questa regolarità in base quattro, di tipoexattativo, ricade poi sull’intera struttura perché, per sim-metria compositiva, altri mosaici e altre rappresentazionidovranno essere organizzate dagli artisti in base quattro; daqui l’impressione funzionalistica, fallace, che tutto l’im-pianto espositivo sia stato studiato appositamente in que-sto modo fin dall’inizio e quindi che i pennacchi stiano lì“proprio per” ospitare i quattro evangelisti.
I pennacchi sono una conseguenza collaterale di un’ar-chitettura complessiva, strutture “non adattative” poicooptate per alloggiare opere d’arte all’apparenza “perfetteper” quegli spazi. In altri casi (Gould cita, in 2002b, p.1.569, la chiesa di San Fedele a Milano), l’exaptation arti-stico non sembra altrettanto ben riuscito, svelando la suasub-ottimalità di fondo. Attraverso lo stesso principio dicoevoluzione fra i vincoli della costruzione e le possibilitàcreative di decorazione, l’intersezione delle volte a venta-glio del soffitto della cappella del King’s College di Cam-bridge produce uno spazio centrale romboidale che gli ar-tisti hanno utilizzato per introdurre delle borchie con al-l’interno alternativamente la rosa dei Tudor e la “saracine-
TELMO PIEVANI
sca” araldica. La struttura non esiste “a causa” dell’alter-nanza fra i due stemmi:
Il disegno, in un certo senso, rappresenta un “adattamento”,ma il limite architettonico è chiaramente primario. Gli spaziaperti sorgono come un prodotto collaterale della volta a ven-taglio: il loro uso appropriato è un effetto secondario (Gould,Lewontin 1979, p. 149).
Un terzo esempio, particolarmente illuminante, interes-sa invece direttamente il bersaglio polemico preferito dagliautori che, come già abbiamo detto, concepirono questointervento “in terra inglese” nel pieno della discussione at-torno alle teorie sociobiologiche. Uno studio dell’antropo-logo Michael Arnet del 1977 propose di interpretare lapratica del sacrificio umano presso gli Aztechi come unasoluzione adattativa alla mancanza di carne: si scoprì infattiche gli arti delle vittime erano frequentemente consumatidai nobili. E. O. Wilson, l’anno successivo, estese l’argo-mentazione di Arnet come illustrazione di una “predisposi-zione primaria adattativa, di tipo genetico, per il cannibali-smo negli umani”.
In questo caso il rovesciamento argomentativo può es-sere condotto in due sensi diversi: a) per prima cosa non èdetto che una pratica religiosa e culturale come il sacrificioumano dovesse servire al rifornimento di carne (sia per laquantità di carne ricavata effettivamente che per le moda-lità della pratica stessa); essa rientrava infatti in un sistemaculturale e cosmologico elaborato ed esprimeva probabil-mente anche esigenze di amministrazione del potere socia-le e politico; b) non necessariamente un’usanza ereditata econsolidata per trasmissione culturale deve avere un signi-ficato adattativo primario. In questo caso in discussionenon è solo l’inversione logica fra causa evolutiva ed effettipresenti (come in una gamma vastissima di altri esempi ri-cavabili dalla sociobiologia), ma anche la linearità e unidi-rezionalità del ragionamento funzionalista applicato allostudio del comportamento. Non necessariamente deve esi-
EXAPTATION: LA BIOLOGIA DELL’ IMPREVEDIBILE
stere un solo significato adattativo e, in presenza di limitistrutturali primari, questo può essere comunque un “epife-nomeno” evolutivo rispetto alla struttura.
Sostenere che qualcosa nasce come “effetto seconda-rio” in un contesto già organizzato non implica né unasottovalutazione di principio dell’effetto stesso né una ri-nuncia alla sua intellegibilità. In un’altra occasione Gouldscrive:
Torniamo ora al cervello umano: probabilmente, attraversola selezione naturale, esso si è ingrandito per assolvere a unnumero limitato di funzioni legate alla sopravvivenza del-l’uomo nella savana africana. Ma come conseguenza di que-sti adattamenti, si sono creati alcuni “pennacchi”, cioè spazicerebrali liberi utilizzati per migliaia di nuove funzioni nonpreviste dal progetto evolutivo di partenza (Gould, inBrockman 1995, p. 47).
La confusione fra processo e risultato è dunque risolvi-bile solo applicando ai principi dell’evoluzione un approc-cio pluralista che limiti il campo di azione dell’adattamentoprimario e diversifichi le tipologie delle cause di trasforma-zione morfologica e comportamentale. Nello stesso breveintervento del 1995 Gould riconduce la “teoria dei pen-nacchi” a una definizione estesa (più comprensiva di quellatecnica vista al punto quinto della classificazione sulle al-ternative all’adattamento) della nozione di exaptation:
La teoria dei pennacchi permette di spiegare l’esistenza diuna struttura ben funzionante in modo indipendente dalla se-lezione. Oggi definisco queste strutture exaptations, un termi-ne che ho coniato insieme ai paleontologi Elisabeth Vrba eNiles Eldredge. Gli exaptations, a differenza degliadaptations, sono strutture utili perché cooptate. Sono ex-ap-ted: atte a qualcosa pur non essendo progettate per esserlodalla selezione naturale. I darwinisti non possono negare laloro esistenza, anche se si affrettano ad aggiungere che si trat-ta di eventi molto rari e insignificanti. Tuttavia l’esempio deipennacchi dimostra che il fatto di essere conseguenza di qual-cos’altro non li rende necessariamente insignificanti (p. 49).
TELMO PIEVANI
Abbiamo cercato di descrivere la critica al programmaadattazionista sottolineando il senso complessivo dell’ope-razione epistemologica: non è in gioco il destino scientificoe l’esistenza teorica dell’adattamento in quanto tale, piutto-sto una sua interpretazione totalizzante e unilaterale. È be-ne approfondire questo concetto anche in un’altra direzio-ne. Spesso la controversia su questo principio dell’evolu-zione si concentra sulla spinosa questione del ruolo più omeno ampio da riconoscere al caso nel processo del cam-biamento biologico macroevolutivo e microevolutivo. Inquesto senso però il rischio è quello di cadere in un’estre-mizzazione teorica della controversia, fino ai tentativi dimettere in caricatura reciprocamente la posizione dell’av-versario: casualisti irresponsabili e pseudoscientifici controdeterministi scientisti. Si potrebbe obiettare che il parago-ne con il dottor Pangloss sia già una caricatura artificiosadi un serio programma di ricerca sperimentale. Non menoforzate sono però le caricature che gli avversari, a comin-ciare da Richard Dawkins e Daniel Dennett, riservano al-l’approccio pluralista dell’evoluzionismo.
In occasione della stesura del testo collettaneo diBrockman citato poco fa, il grande biologo evoluzionistadella New York State University George C. Williams, a tut-ti gli effetti uno dei padri nobili del programma adattazio-nista e tuttavia fra i più aperti e meno dogmatici sostenitoridella visione tradizionale, commentò l’intervento di Gouldsul concetto di exaptation con un’obiezione particolarmen-te arguta e interessante:
L’esempio dell’ala dell’uccello è quello che Gould chiamaexaptation e succede continuamente in natura. Ma quandochiamiamo “ala” l’ala dell’airone, subentra anche un problemasemantico. Originariamente quella struttura era infatti unapinna, e solo casualmente si è dimostrata utile per camminare,e ancora accidentalmente si è trasformata in un’appendice uti-le al volo. Pertanto occorre sempre specificare prima la pro-spettiva funzionale. Un’ala può essere definita alternativamen-te un adattamento o un exaptation a seconda che la si riferiscaal volo o alla precedente capacità di camminare (p. 59).
EXAPTATION: LA BIOLOGIA DELL’ IMPREVEDIBILE
Il ragionamento di Williams è molto sottile e si sottraeai due soliti argomenti svalutativi dell’approccio post-darwiniano, così come presentati e sostenuti da John May-nard Smith:
a) sottovalutazione sperimentale: i fenomeni di exapta-tion sarebbero insignificanti sul piano dei dati empirici,poco frequenti sul piano statistico e in quelle poche occor-renze marginali sul piano evolutivo;
b) sottovalutazione della novità: non c’è nulla di rivolu-zionario nella teoria dell’exaptation, i migliori sostenitoridel programma adattazionista non si sono mai sognati disostenere il contrario.
Williams invece accetta che gli eventi di exaptation sia-no la norma in natura. Ritiene tuttavia che non sia necessa-rio sostituire il termine adaptation: è sufficiente concepireexaptation come il susseguirsi, contingente, di più adatta-menti funzionali. Il problema semantico sollevato da Wil-liams può essere accolto favorevolmente da un non-adatta-zionista: possiamo anche definire exaptation un “adatta-mento secondario” o “derivato”. Anzi, il fatto che Williamsaccetti questa idea rafforza la proposta teorica di Gould eLewontin. Il concetto di exaptation non è in contrapposi-zione alla teoria della selezione naturale: anzi, la presuppo-ne. La differenza è un’altra e consiste propriamente inquella “inversione logica” argomentativa descritta poc’an-zi, su cui Williams non si sofferma. Accettare l’idea chepossa verificarsi un cambiamento funzionale a parità distruttura morfologica significa negare (e Williams implici-tamente lo fa) la legittimità di ogni estrapolazione dall’uti-lità attuale all’origine evolutiva. E qui sta la critica, sostan-ziale, al programma adattazionista classico.
Il pollice del panda è stato regolarmente fissato dalla se-lezione naturale: possiamo immaginare che i panda con ilsesamoide radiale ipersviluppato siano stati per qualchemotivo avvantaggiati nella competizione per le risorse, chea un certo punto quel sesamoide radiale sia diventato la ba-se per un sesto dito opponibile, che si sia quindi diffuso a
TELMO PIEVANI
tutto la specie, e così via. Il meccanismo della sopravviven-za differenziale in un contesto di lotta per la sopravvivenzanon è affatto messo in discussione. Ma un conto è dire chela selezione naturale ha prodotto il pollice del panda, unaltro è affermare che il sesamoide radiale del panda era lìproprio “per” costruire un pollice opponibile. Più precisa-mente, secondo la terminologia proposta da Gould, dire-mo che il sesamoide radiale in sé è “exattativo” rispetto alpollice opponibile, mentre le modifiche ipetrofiche del se-samoide sono “adattative” rispetto all’utilità del pollice op-ponibile. La fase di cooptazione iniziale è infatti distintadalla fase di ritenzione successiva attraverso il normale fun-zionamento della selezione naturale.
Anche nei casi in cui l’exaptation sia una cooptazione distrutture originatesi per nessuna funzione, la selezione,benché non agisca nel rendere disponibile tali strutture dipartenza (in quanto “pennacchi”), agisce comunque nelfissare l’exaptation. Il concetto espresso da Williams, sem-mai, ci obbliga a un approfondimento della nozione diadaptation alla luce di un approccio pluralista applicato al-le cause potenziali di trasformazione morfologica e funzio-nale. Una volta introdotto il concetto di exaptation e unavolta mostrato che non si tratta di una rimozione della teo-ria classica, ma di una sua coerente estensione, come potràessere ridefinita in senso costruttivista l’idea di adattamen-to biologico?
Serpenti erbivori e batteri marziani: i sentieri della coevo-luzione
Il concetto di “adattamento” trova nella prospettiva diricerca post-darwiniana una rideclinazione interessante.Procediamo per generalità decrescente: ci accorgeremo chequesta riformulazione consiste principalmente in una limi-tazione dell’area di influenza dei fenomeni di adaptation(ma non per questo in una loro marginalizzazione) operan-te a due livelli diversi.
EXAPTATION: LA BIOLOGIA DELL’ IMPREVEDIBILE
Già nel saggio del 1979, Gould e Lewontin propongo-no una tripartizione gerarchica della nozione di adaptation,notando che solo in un caso è pienamente legittimo utiliz-zare le categorie interpretative dell’adattamento darwinia-no classico. Una prima limitazione, molto generale (e me-todologica), è allora quella di provare a non considerarecome “darwiniano”, o in altri termini come prodotto dellaselezione naturale intesa quale principio causale determini-stico, ciò che per abitudine si definisce “adattamento” an-che a livello fenotipico e a livello di evoluzione culturale. Sidistingue allora:
1) un “adaptation fenotipico”, cioè la manifestazione diuna buona adeguazione fra organismo e ambiente circo-stante per via della plasticità fenotipica individuale; lamorfologia è modificata durante l’ontogenesi in funzionedi un migliore adattamento alle circostanze esterne (peresempio l’adattamento dell’uomo e di altri mammiferi alleforti altitudini): tale manifestazione di adaptation in sé nonè ereditabile, lo è invece la capacità genetica dell’organi-smo di sviluppare la plasticità fenotipica da cui deriva;
2) un “adaptation culturale”, cioè una forma ereditabiledi adattamento non biologico; l’ereditarietà è data natural-mente dalla possibilità di trasmettere le conoscenze attra-verso l’insegnamento e l’apprendimento;
3) un “adaptation genotipico”, cioè la forma convenzio-nale di adattamento derivante dall’azione della selezionenaturale sulla variazione genetica potenziale.
Molti dei fraintendimenti sociobiologici derivano dallaconfusione fra adaptation culturale e adaptation genotipico:solo l’adattamento basato con sicurezza sulla variazione ge-netica come “materia prima” e sulla selezione come crite-rio costruttivo può essere considerato darwiniano, nonogni forma di buona disposizione verso l’ambiente indi-pendentemente dal meccanismo della sua fissazione. Per lostesso motivo non può essere considerato darwiniano l’a-daptation fenotipico a carattere esclusivamente fisiologico.Scrivono Gould e Lewontin (1979, p. 158):
TELMO PIEVANI
Adaptation, il buon adattamento degli organismi al loro am-biente, può verificarsi a tre differenti livelli gerarchici concause diverse. È una sfortuna che il nostro linguaggio si siafocalizzato sul risultato più comune e abbia chiamato tutti etre i fenomeni adaptation: le differenze nel processo sono sta-te oscurate e gli evoluzionisti hanno spesso frainteso le originidi questa eterogeneità estendendo la modalità darwiniana aglialtri due livelli.
Poco oltre si aggiunge, riassumendo il senso di questalimitazione gerarchica della nozione darwiniana di adap-tation:
La mera esistenza di un buon adattamento fra organismo eambiente è un’evidenza insufficiente per dedurre l’azione del-la selezione naturale (p. 159).
La gerarchia dei tre significati evolutivi della nozioneestesa di “adattamento” richiede dunque una prima limita-zione generale dell’applicazione pedissequa di un’interpre-tazione darwiniana (selezione naturale su variazione geneti-ca) ai meccanismi adattativi nel loro complesso. Da questopunto di vista, la critica al programma della sociobiologiaumana riguarda solo l’aspetto metodologico e di imposta-zione generale di una ridefinizione in senso pluralista deiprincipi evolutivi.
Ciò che più conta è affrontare una seconda limitazioneattinente al livello gerarchico stesso dell’adaptation darwi-niano tradizionale. Quello che abbiamo definito nel para-grafo precedente il “disaccoppiamento” fra adattamento eselezione naturale concerne infatti anche l’ambito stretta-mente fenotipico dei meccanismi adattativi. Approfonden-do il principio appena citato, potremmo dire che neppurela mera esistenza di un adattamento genotipico fra organi-smo e ambiente è un’evidenza sufficiente per dedurre l’a-zione della selezione naturale.
La riconcettualizzazione dell’idea di adattamento bio-logico trova la sua massima espressione teorica, pochi an-ni dopo, in una serie di saggi illuminanti di Richard
EXAPTATION: LA BIOLOGIA DELL’ IMPREVEDIBILE
Lewontin. Nel 1978 il genetista di Harvard affronta, inun saggio intitolato Adaptation (1978), la questione dellanecessità di un nuovo approccio a questa categoria delpensiero biologico. L’autore esamina in primo luogo leorigini storiche dell’idea di adattamento darwiniano. Ingioco, agli albori della teoria evolutiva moderna, era laconnessione logica fra due aspetti apparentemente con-trastanti della storia naturale: la diversità irriducibile del-le forme viventi e l’ottima idoneità degli organismi mede-simi all’ambiente circostante. Molto schematicamente po-tremmo sintetizzare il nodo concettuale della spiegazionedarwiniana in questo modo:
a) la variabilità morfologica può essere spiegata conl’idea di una fissazione delle piccole mutazioni degli orga-nismi attraverso l’ereditabilità delle variazioni stesse e lariproduzione differenziale all’interno della specie madre:le forme di vita si diversificano e divergono in ambientidiversi;
b) le forme di vita sono anche ottimamente adattate al-l’ambiente che le ospita, nei modi più semplici per organi-smi elementari fino a strutture complicatissime e meravi-gliose come l’occhio: ciò fa pensare che vi sia un criterioper la riproduzione differenziale identificabile con la pre-valenza a medio termine delle forme più “idonee” al lorohabitat, il tutto mosso e diretto dalla selezione naturale edalla lotta per la sopravvivenza.
Non fu difficile per i darwinisti, alcuni decenni dopo,confondere la perfezione risultante dal processo evolutivocon l’opera di una selezione naturale sempre più commisu-rata alle caratteristiche del “divino artefice”. In realtà la“perfezione” naturale poneva al darwinismo una questionecruciale, risolta temporaneamente con la teoria del prea-dattamento, che abbiamo visto essere l’antecedente logicodelle ricerche sull’exaptation. L’analisi di Lewontin muoveperò da un’altra angolatura, altrettanto decisiva: quella delrapporto logico, implicito in questa storia dell’idea di adat-tamento, fra organismo e ambiente:
TELMO PIEVANI
La moderna visione dell’adattamento stabilisce che il mondoesterno pone certi “problemi” che gli organismi devono “ri-solvere” e che l’evoluzione mediante selezione naturale è ilmeccanismo che crea queste soluzioni. L’adattamento è ilcambiamento evolutivo attraverso il quale l’organismo forni-sce una “soluzione” via via migliore al “problema”: il risultatofinale è la condizione di “essere adattato” (fitness) (Lewontin1978, p. 3).
E poco oltre (ib.):
Il concetto di adattamento implica un mondo preesistenteche ponga un problema la cui soluzione consista appunto nel-l’adattarvisi. Una chiave viene adattata alla serratura taglian-dola e limandola.
Un altro modo per esprimere lo stile di ragionamentoadattazionista è quello di dire che la natura garantisce ladisponibilità di forme ideali cui le cose, attraverso il di-spiegamento di mezzi della selezione naturale, si confor-mano e si approssimano. L’analisi adattazionista procederàallora a ritroso: a cosa servono le placche dorsali dello Ste-gosaurus, essendo senz’altro la soluzione ottimale a unproblema specifico? ...e di seguito un elenco di funzionialternative: per difesa, per il corteggiamento, per autore-golazione termica. Esiste in sostanza uno spazio definito(un paesaggio) di funzioni adattative, che attraggono gliorganismi sui loro picchi.
Nel testo della voce “Adattamento” scritto da Lewontinper l’Enciclopedia Einaudi troviamo:
(...) l’impiego stesso della nozione di adattamento introduceinevitabilmente nella biologia moderna la concezione teologi-ca di un mondo fisico preformato cui gli organismi sono statiadattati (Lewontin 1977, p. 200).
Nel porre in questi termini la questione ci riavviciniamoall’obiezione di Williams illustrata nel paragrafo preceden-te: siamo di fronte a un susseguirsi di adattamenti, compa-
EXAPTATION: LA BIOLOGIA DELL’ IMPREVEDIBILE
tibile in via teorica con l’idea di exaptation (per esempionella sequenza evolutiva rettile - uccello - pinguino). Inrealtà l’argomentazione è diversa, più problematica, e ri-guarda appunto le due assunzioni del meccanismo proble-ma-soluzione e del rapporto fra mondo preesistente in evo-luzione e organismo in perenne “rincorsa” adattativa:
se l’evoluzione viene descritta come processo di adattamentodegli organismi alle loro nicchie, allora queste devono esistereprima delle specie che vi si adattano, cioè devono esservi nic-chie vuote in attesa di essere occupate in seguito all’evoluzio-ne di nuove specie (Lewontin 1978, p. 5).
Potremo parlare di “nicchia vuota” solo astraendo dallecaratteristiche degli altri organismi che già vi abitano. Maquesta operazione è arbitraria: è sempre possibile immagi-nare nicchie vuote “relativamente” a qualche caratteristicabiologica, basta prendere un parametro reale e modificarloin modo tale da prefigurare una “nicchia” ancora non oc-cupata. Lewontin immagina ad esempio la nicchia fantasti-ca dei “serpenti che si nutrono di erba” o degli “animali asangue caldo che depongono uova”. Il problema della defi-nizione teorica di una nicchia ecologica vuota, senza riferi-menti agli organismi che la potrebbero abitare, ha segnatole immense difficoltà di valutazione delle possibilità di esi-stenza di forme di vita non terrestri.
Lewontin ama citare le diatribe su come verificare la pre-senza di vita su Marte (progetto “life detector”) che anima-rono le riunioni della commissione scientifica del governostatunitense cui fu invitato a partecipare alla metà degli anniSettanta: come si poteva “cercare” la vita in un ambiente do-ve effettivamente non era possibile considerare fattori ecolo-gici relativi alla presenza di organismi (che era ciò che si do-veva per l’appunto verificare)? L’esobiologia incappa in unautentico paradosso: se la nicchia è anche costruita dai suoiabitanti e gli abitanti sono costruiti dalla nicchia in un rap-porto di cospecificazione e di reciproco bricolage evolutivo,come si possono fissare per via ipotetica i parametri per rile-
TELMO PIEVANI
vare la presenza di organismi viventi su Marte partendo daivalori e dalle proprietà della vita sulla Terra?
Si tentò di verificare la presenza di batteri immergendoun campione di terriccio marziano in una “zuppa radioatti-va” sensibile alle forme di vita terrestri (qui sta il nocciolodel paradosso). La radioattività aumentò esponenzialmentenei primi secondi, per poi azzerarsi completamente. Se nededusse che non c’erano batteri (o meglio, non c’eranobatteri il cui metabolismo fosse analogo a quello terrestre)e che la violenta reazione era stata scatenata dall’argillamarziana (Lewontin 1995).
Un altro problema, ancor più profondo, riguarda il fat-to che organismi e nicchie sembrano così compenetrati ecosì vicendevolmente definiti da rendere virtualmente im-possibile la distinzione fra proprietà degli uni e delle altre:
Gli organismi non sperimentano passivamente gli ambienti,ma creano e definiscono l’ambiente in cui vivono. (...) C’èuna costante interazione tra organismo e ambiente, per cuianche se la selezione naturale può fare adattare l’organismo auna particolare serie di circostanze ambientali, l’evoluzionedell’organismo modifica a sua volta quelle circostanze. Gli or-ganismi stessi determinano, infine, con le loro attività qualifattori esterni devono far parte della loro nicchia. Costruendoun nido, la pavoncella rende la disponibilità del fieno, neces-sario per costruirlo, una componente importante della pro-pria nicchia e rende, al tempo stesso, il nido un’altra compo-nente di quella stessa nicchia (ib.).
Riguardo dunque alla nozione di adattamento il passag-gio concettuale è sottile:
Se le nicchie ecologiche possono essere specificate soltantodagli organismi che le occupano, l’evoluzione non può più es-sere descritta come un processo di adattamento perché tuttigli organismi risultano già adattati (ib.).
Cosa è successo, in sostanza? Cadute le due assunzioniadattazioniste (modello problema-soluzione e postulato del
EXAPTATION: LA BIOLOGIA DELL’ IMPREVEDIBILE
mondo preesistente indipendente), si sgretola la concezio-ne classica di ad-aptation come “corrispondenza”. L’adatta-mento è un processo “costruttivo”:
Dobbiamo sostituire la concezione adattazionistica della vitacon una concezione costruttivistica. Non è che gli organismitrovano gli ambienti e vi si adattano o muoiono: essi costrui-scono effettivamente il loro ambiente a partire da pezzi e pez-zetti (Lewontin 1991, p. 82).
Organismi e nicchie si fanno e disfano a vicenda: “ogniorganismo contemporaneamente produce e distrugge lecondizioni della propria esistenza” (p. 85).
Una radicale unicità dei percorsi di sviluppo
L’ipotesi è che a parità di tutte le condizioni (genetichee ambientali), il processo di adattamento possa condurrecomunque su sentieri epigenetici molto eterogenei e so-stanzialmente imprevedibili: su di essi agisce infatti unamolteplicità di fattori e di perturbazioni (come ipotizzatodalla “teoria del rumore di fondo genetico”) in grado dideviare la trasformazione su traiettorie diverse. L’intreccioineludibile e la coevoluzione fra vincoli genetici e possibi-lità ambientali, uniti alla conoscenza ancora parziale del-l’embriogenesi, sono tali da scongiurare il rischio di unaperfettibilità indefinita e omogeneizzante del genoma edel piano organico: la storicità della natura e la sua capa-cità di cambiamento e di adattamento si fondano sulla va-riabilità, sulla imperfezione e sulla subottimalità dellestrutture organiche.
In altri termini, gli influssi ambientali e quelli geneticiinteragiscono fra loro in forme così diverse e passano attra-verso perturbazioni casuali così sottili che il risultato delprocesso coevolutivo fra geni, ambienti e organismi è sem-pre un individuo unico e irripetibile (Lewontin 1998, pp. 3-33), allo stesso modo in cui il processo di sviluppo del cer-
TELMO PIEVANI
vello appare caratterizzato, secondo alcune importanti teo-rie neurologiche (basti pensare a quella della “selezione deigruppi neuronali” di Gerald Edelman), da una intrinsecaunicità evolutiva e da differenze fra individuo e individuonon imputabili né all’ambiente né alla genetica (Edelman,Tononi 2000).
Nel flusso di reciproca specificazione fra organismo eambiente, in cui entrambi a tutti gli effetti sono “soggettievolutivi”, l’evoluzione assume contorni inediti: per “adat-tamento” intenderemo la pre-condizione, e non più la fina-lità, dello sviluppo. Con ciò non si nega la realtà evolutivadegli eventi di adaptation, ma si nega che essi possano di-ventare discriminanti a posteriori per una ricostruzione delprocesso evolutivo stesso come accade nelle “retrospezionifunzionalistiche” dell’adattazionismo darwinista.
Una prova a favore di questa interpretazione “costrutti-vista” dell’intreccio evolutivo fra organismi e ambienteproviene da un dato sperimentale che ha fatto molto discu-tere i paleontologi: il valore costante della probabilità me-dia di estinzione di una specie biologica. La possibilità cheuna specie si estingua, è stato notato, non dipende né dallacollocazione geografica, né dall’età della specie, né da altrifattori legati al tempo e alla storia della specie stessa. Il tas-so di “estinguibilità” deriva dalle caratteristiche del gruppoa cui la specie appartiene e non è in alcun modo inversa-mente proporzionale all’età della specie come una lettura“progressionista” dovrebbe supporre. L’opera della sele-zione naturale non accresce, né a medio né a lungo termi-ne, le capacità di sopravvivenza medie degli organismi diuna specie. Anche dallo studio della condizioni di estingui-bilità sembra avere conferma l’idea che la stabilità, e nonun processo di incessante adattamento progressivo, sia lasituazione più frequente dell’evoluzione. Non c’è, insom-ma, un’azione evidente di miglioramento progressivo deipiani morfologici e comportamentali.
Una spiegazione di questo dato interessante è stata forni-ta, nella seconda metà degli anni Settanta, dal biologo evolu-zionista dell’Università di Chicago Leigh Van Valen, che co-
EXAPTATION: LA BIOLOGIA DELL’ IMPREVEDIBILE
niò al proposito la cosiddetta “ipotesi della Regina Rossa”(dal nome di un personaggio di Lewis Carroll che, nella fa-vola intitolata Attraverso lo specchio, è costretto a correre al-l’infinito e sempre più velocemente per poter restare allostesso posto). Il suggerimento di Van Valen è semplice: la se-lezione naturale non determina un accumulo di “esperienzaadattativa” positiva perché gli ambienti cambiano senza unadirezione prevedibile e così velocemente da obbligare gli or-ganismi a una “rincorsa adattativa” potenzialmente infinita.Come la Regina Rossa, la selezione trasforma incessante-mente gli organismi per “tenerli al passo” con l’evoluzioneambientale. Se ci riesce abbiamo una situazione di “adatta-mento”, che è quindi a maggior ragione una pre-condizionedi esistenza e non un obiettivo, se non ci riesce il “differen-ziale” fra velocità evolutiva ambientale e velocità evolutivaindividuale cresce al punto di determinare l’estinzione dellaspecie. Per essere più precisi, la prima eventualità non è maisoddisfatta del tutto. Gli organismi, secondo Van Valen, “so-no sempre un po’ disadattati”, un po’ “arretrati” rispetto al-la nicchia ambientale, e quindi mai in una situazione di fit-ness ottimale (le due velocità evolutive avrebbero in tal casodifferenziale uguale a zero).
Vogliamo far notare che l’ipotesi della Regina Rossa èin accordo con quanto detto finora in almeno due puntiessenziali:
1) essa conferma che l’opera della selezione è prevalen-temente e sostanzialmente un’azione stabilizzatrice: essamantiene lo “status quo antea” evolutivo più che introdur-re forme innovative;
2) ribadisce che non c’è corrispondenza fra estinzione einadeguatezza organica: la “rincorsa adattativa”, sospinta dal-la selezione naturale, anche nei casi migliori non garantisceda cambiamenti ambientali irreparabilmente incompatibilicon le proprietà e le esigenze degli individui di una specie.
L’ipotesi conferma, poi, che il rapporto fra possibilità disviluppo (inversamente proporzionali al tasso di “estingui-bilità”) e variabilità potenziale è decisivo. In questo passag-gio concettuale l’intuizione darwiniana sulla ricchezza ine-
TELMO PIEVANI
stimabile della diversità biologica è pienamente conferma-ta: il combustibile per la “rincorsa adattativa” sta nella di-sponibilità ridondante di variazione genetica. Quanto più èvasta l’area di variabilità genetica potenziale, tanto più altesono le possibilità di proseguire nel cammino evolutivo.
I punti deboli della teoria di Van Valen, dal punto di vi-sta che stiamo descrivendo, sono principalmente tre: a) es-sa sembra convalidare un approccio gradualista all’evolu-zione accoppiata organismi-ambiente (tanto che abbiamoprecisato che il cambiamento ambientale trascende talvoltale possibilità evolutive della specie): la gradualità adattativadegli organismi, secondo Van Valen, rafforza ricorsivamen-te nel “sistema di sviluppo” la gradualità delle trasforma-zioni delle nicchie e viceversa; b) favorisce un’interpreta-zione a lungo andare “esternalista” del processo evolutivo,con gli organismi in affannosa ricerca del minor disadatta-mento possibile; c) non spiega completamente le diversifi-cazioni evolutive seguite a episodi di estinzioni di massa (lecosiddette “radiazioni adattative”): in queste occasionil’impostazione di Van Valen andrebbe rovesciata perché siha una vastissima nicchia ecologica “indulgente” e tanti or-ganismi che scelgono altrettante strategie adattative piùche soddisfacenti (le specie sono qui “in vantaggio”, nellametafora della Regina Rossa, rispetto all’ambiente).
L’ipotesi di Van Valen risulta poi inefficace nella descri-zione dell’evoluzione umana e delle conseguenze delle tec-nologie di trasformazione e sfruttamento delle risorse, conle quali la nozione di adattamento fra organismi e ambientesi è letteralmente rovesciata:
l’invenzione culturale sostituisce la mutazione genetica comesorgente effettiva di variazione e il pensiero cosciente rendein pratica possibili l’analisi e l’intervento deliberato. Ne deri-va che l’adattamento dell’ambiente all’organismo è divenutala forma dominante (Lewontin 1977, p. 201).
In generale, come ha notato recentemente Niles El-dredge, ciò che manca in queste ricostruzioni neodarwini-
EXAPTATION: LA BIOLOGIA DELL’ IMPREVEDIBILE
ste del processo evolutivo, centrate esclusivamente su po-polazioni e geni, è la considerazione del reale contesto delcambiamento adattativo in tutta la sua complessità: un con-testo nel quale occorre spiegare il cambiamento e la stasidelle specie nel loro insieme (e non solo di individui o dipopolazioni); un contesto nel quale è necessario capire inquali circostanze e con quali modalità opera la selezionenaturale; un contesto nel quale non si può prescindere dal-la considerazione dei diversi livelli gerarchici, ecologici,economici e genealogici che si intrecciano durante il pro-cesso evolutivo (Eldredge 1999).
Biologia ingegnerista e biologia costruttivista
Una tattica più efficace per cogliere nel segno la criticaal programma adattazionista consiste anche nell’approfon-dire non solo la dimensione esteriore del rapporto organi-smo-ambiente, svelando in tal modo le ambiguità della no-zione di adattamento in relazione alla nostra idea di “nic-chia”, ma anche le modalità di analisi del processo adattati-vo all’interno della stessa struttura organica individuale. Èa questo punto che Lewontin introduce una seconda me-tafora, dopo quella della coevoluzione costruttiva del “si-stema di sviluppo”, altrettanto decisiva:
Il procedimento seguito attualmente per giudicare l’adatta-mento dei caratteri è un’analisi ingegneristica dell’organismoe dell’ambiente in cui vive. Il biologo è nella posizione di unarcheologo che scopre una macchina senza alcuna indicazio-ne scritta e tenta di ricostruirne non solo il funzionamento maanche la finalità (Lewontin 1978, p. 9).
Il fondamento epistemologico del programma adatta-zionista, secondo Lewontin, è quello di un “neo-meccanici-smo” evolutivo: l’organismo, si è detto, è scomposto inparti discrete ciascuna delle quali troverà una funzioneadattativa ottimale in corrispondenza della sua comparsa.
TELMO PIEVANI
La buona realizzazione di una funzione specifica, come ap-punto per una macchina, è confusa indistintamente con lafinalità di costruzione dell’ingranaggio. L’adattazionismo èuna forma di “analisi ingegneristica”. Lewontin sembraprivilegiare come bersaglio delle proprie argomentazioninon tanto il riduzionismo, quanto l’altro aspetto epistemo-logico caratteristico del determinismo scientifico conven-zionale, vale a dire lo stile analitico di marca meccanicista.
Questa seconda dimensione del programma adattazio-nista non presenta meno problemi e ambiguità teoriche eterminologiche della prima. Molte delle questioni più deli-cate riconducibili a questa “dissezione” per “unità ottima-li” sono già state affrontate nel paragrafo precedente, se-guendo le suggestioni dell’intervento del 1978. Nei saggisuccessivi Lewontin individua una serie di nuove “aporie”implicite nell’approccio tradizionale e le riordina nel qua-dro di una nuova (e più precisa) tipologia estesa dei mecca-nismi di aptation.
L’analisi ingegneristica dell’adattamento incontra alcu-ne difficoltà metodologiche generali. La prima è che non èdel tutto scontato, al momento della ricerca sperimentalevera e propria, in che modo si debba (o si possa) dividereun organismo nelle sue componenti discrete (ammesso chene esistano). Si può decidere di partire, nell’analisi, dalproblema specifico per poi individuare il carattere adattati-vo corrispondente, o viceversa analizzare prima i caratteririnvenibili e poi le funzioni soddisfatte volta per volta. Inentrambi i casi la domanda è quella cruciale indicata daGould – a cosa serve? – e si dà per appurato che vi sia unacerta divisione in “unità” costitutive. Ma la decisione sucome calibrare questa divisione in parti del continuum or-ganico è del tutto arbitraria: dovremo considerare “unitàdiscreta” funzionale all’adattamento l’arto nel suo com-plesso, il piede, il dito, il singolo costituente osseo o mu-scolare? Il rischio evidente è quello di una crescente astrat-tezza e incoerenza dell’analisi funzionale stessa, sempre piùcieca di fronte alle connessioni e correlazioni fra le parti aqualsiasi livello di divisione ci si soffermi. Senza contare
EXAPTATION: LA BIOLOGIA DELL’ IMPREVEDIBILE
(ed è la seconda difficoltà metodologica) che alcune “par-ti” non possono da nessun punto di vista essere considera-te unità funzionali, come nel caso già citato del mentoumano (zona residuale di origine neotenica, generata dallaintersezione fra la contrazione della struttura ossea dellamandibola e la contrazione, più rapida, della zona alveola-re su cui poggiano i denti). Non è sempre possibile pertan-to l’individuazione di una corrispondenza lineare e univo-ca, per adattamento specifico, fra “parte singola” e “singo-la funzione”.
Una seconda aporia teorica dell’analisi ingegneristicainteressa invece la topologia della ripartizione. Dove sonocollocate le varie unità funzionali e in che modo si può vi-sualizzare la loro indipendenza dal resto? Ciò vale soprat-tutto per l’analisi di “organi” particolarmente complessi,primo fra tutti il cervello (Lewontin ama citare a questoproposito le obiezioni alla presunta localizzazione cerebra-le di funzioni specifiche come la memoria), e l’analisi deicomportamenti, spesso viziata da “compartimentazioni”arbitrarie in categorie rigide e antropocentriche come “ag-gressività”, “divisione del lavoro”, “cooperazione”. Il rife-rimento in questo senso è proprio Sociobiology: the NewSynthesis che Wilson pubblicò nel 1975. In essa il compor-tamento animale e umano è sezionato in “organi di com-portamento”, a ciascuno dei quali corrisponderebbe unaspiegazione adattativa lineare.
Un’altra difficoltà concerne, viceversa, l’individuazionedelle varie funzioni distribuite fra le unità adattative. Spes-so anche la decisione su quale problema specifico ogni ca-rattere di un organismo sia preposto a risolvere è arbitra-ria. A parere di Lewontin la “condizione adattativa” di uncarattere o di un organo è frequentemente rappresentatada una pluralità di funzioni e non da una sola. La specializ-zazione non sarebbe cioè una caratteristica diffusa in natu-ra. Di fronte abbiamo spesso “intrecci di cause” e non de-terminazioni lineari da causa singola a effetto singolo: leparti ci sembrano distinte, ma la distinzione sta talvolta nelnostro modo di concepire le domande sperimentali. Ciò
TELMO PIEVANI
vale a maggior ragione per i tentativi di operare un “calco-lo delle cause”, come nel caso della ormai classica riparti-zione fra 80% di cause genetiche e 20% di cause ambien-tali tipica di talune semplificazioni “interazioniste”. Comeha scritto l’epistemologa Susan Oyama, l’interazionismo ri-schia di essere una risposta insufficiente, perché sterilmen-te demarcazionista, all’ideologia dominante del determini-smo genetico e al suo opposto determinismo ambientale(Oyama 2000b). Se i “sistemi di sviluppo” sono reticoli diinteragenti in trasformazione, a suo avviso non è quasi maipossibile, se non molto astrattamente, individuare una cau-sa specifica o causa ultima di un fenomeno. Ciò che condu-ce all’effetto è più spesso una concomitanza e una correla-zione complessa di “interagenti” diversi.
I molti esempi di non-adattamenti (dalle corna dell’al-ce irlandese da cui siamo partiti alle natatoie delle testug-gini) dimostrano ampiamente la sopravvivenza di carattericontroproducenti, non sempre giustificabile attraverso ivantaggi riproduttivi richiesti dalla selezione sessuale. Ilnocciolo delle difficoltà appena descritte, e in particolaredell’ultima, sta, per Lewontin, in una particolare assunzio-ne metodologica del programma adattazionista:
L’assunto fondamentale di tutte le analisi ingegneristiche èquello dei ceteris paribus, cioè della “parità di tutte le altrecondizioni”. Per poter sostenere che un carattere è una solu-zione ottimale di un particolare problema, dev’essere possibi-le osservare quel carattere e il suo problema isolati dal resto, aparità appunto di tutte le altre condizioni. Se le altre condi-zioni non sono tutte uguali, cioè se un cambiamento che siverifica in un carattere come soluzione di un problema modi-fica il rapporto che l’organismo ha con altri problemi dell’am-biente, diventa impossibile effettuare l’analisi pezzo per pez-zo e si rimane nella posizione senza sbocco in cui l’intero or-ganismo appare come se fosse adattato solo all’ambiente nelsuo complesso (Lewontin 1978, p. 9).
L’autore fa riferimento in questo brano alla teoria dellapluralità di spinte selettive che coinvolgerebbero incessan-
EXAPTATION: LA BIOLOGIA DELL’ IMPREVEDIBILE
temente l’esistenza di tutti gli organismi. La moltiplicazio-ne e sovrapposizione delle funzioni adattative, inintellegi-bile in un’ottica meccanicistica deriverebbe in definitivadalla compresenza nella nicchia ecologica di una serie dipressioni selettive divergenti che obbligano l’individuo atrovare un “compromesso” o un equilibrio temporaneonella propria disposizione adattativa.
L’assunto evoluzionista dei ceteris paribus racchiude insé le caratteristiche paradigmatiche dell’approccio riduzio-nista e meccanicista, incontrando una prima limitazione diprincipio nel tentativo di definire la morfologia ideale peruna determinata funzione. L’analisi ingegneristica non puòcogliere la ricchezza e la diversità delle forze e delle unitàevolutive costantemente in gioco nei processi di trasforma-zione. Esiste tuttavia un secondo motivo di insoddisfazionenei confronti di un approccio adattazionista tradizionale,che interessa questa volta il nocciolo stesso della teorizza-zione darwiniana originale, laddove sancisce un legame di-retto e biunivoco fra selezione naturale come azione causa-le e adattamento come criterio risolutivo.
I tre principi fondamentali dell’analisi darwiniana,principio di variazione, principio di ereditarietà e princi-pio di riproduzione differenziale a opera della selezionenaturale, si integrano solo in un secondo tempo (e per unaserie di influenze teoriche eterogenee) con il principio del-l’adattamento e con l’idea di una lotta per la sopravviven-za come normale situazione di “scrematura” dei più adat-ti. Abbiamo già definito anche la differenza fra adaptationinteso come fatto reale (l’esistenza di piani organici obiet-tivamente più idonei al proprio ambiente) e adaptation in-teso come criterio risolutore e previsionale della “buonaevoluzione”. In un’analisi ingegneristica che utilizzi la me-tafora della macchina, l’organismo è un progetto evolutivoin costante perfezionamento, bisognoso di manutenzionee di aggiornamenti progressivi. Esistono tuttavia due classidi dati osservativi in contraddizione con questa visione delprogetto autoperfezionantesi: a) il tasso di “estinguibilità”è indipendente dal tempo, b) un grande numero di “scel-
TELMO PIEVANI
te” morfologiche non presenta un valore adattativo prima-rio e talvolta non presenta alcun valore adattativo in sé.Lewontin ritiene che si possa spiegare questa contraddi-zione solo immaginando che il campo di potenzialità e divariazione della selezione naturale sia un sovrainsieme delcampo di variabilità dell’adattamento in senso stretto. Sitratta della critica più profonda al programma adattazioni-sta perché punta al nocciolo della costellazione teoricaneodarwiniana.
Potremmo dire che l’adattamento, in un approccio po-st-darwiniano, non solo è la precondizione (e non più la fi-nalità) del processo evolutivo, ma è anche un meccanismo“interminato” e interminabile nella sua realizzazione. Que-sto non tanto e non solo per la rincorsa adattativa perennetipo “Regina Rossa”, quanto piuttosto per il fatto che ilcampo di variabilità della selezione è comunque più ampiodi quello adattativo. Si guadagna in questo modo una sortadi rottura di simmetria fra selezione e adattamento. Non esi-ste un rapporto biunivoco di congruenza fra le due dimen-sioni, pena lo scivolamento nella tautologia della sopravvi-venza (che è poi un’altra forma per esprimere la retrospe-zione funzionalistica): il più adatto è sopravvissuto perchéera il più adatto.
La nozione di adaptation si trova pertanto connotataentro tre aree semantiche: adattamento senza un’origineunivoca (precondizione di ciò che “già da prima” riescea sopravvivere in una nicchia); adattamento senza uncompimento definito (interminato); e infine adattamentorelativo: se la selezione naturale può sempre qualcosa inpiù rispetto all’adattamento, quest’ultimo non sarà maiassoluto (come dire, nuovamente, che la condizione dispecializzazione funzionale assoluta è l’anticamera dell’e-stinzione).
Quando si considera l’adattamento come il risultato della se-lezione naturale sotto la pressione della lotta per la sopravvi-venza, si vede che esso è una condizione relativa e non assolu-ta. Anche se una specie potesse sopravvivere ed essere nume-
EXAPTATION: LA BIOLOGIA DELL’ IMPREVEDIBILE
rosa, e quindi essere adattata in senso assoluto, potrebbecomparire di essa una nuova forma con un maggior tasso diriproduzione, anche se con le stesse risorse, e ciò provoche-rebbe l’estinzione della forma precedente. Il concetto di adat-tamento relativo rimuove l’evidente tautologia della teoriadella selezione naturale. Senza di esso, questa teoria stabilisceche gli individui più idonei hanno un maggior numero di di-scendenti e quindi definisce i più idonei come coloro che la-sciano una prole più numerosa. Ma, poiché alcuni individuiavranno sempre per puro caso più discendenti di altri, nullaviene spiegato (p. 10).
L’espressione “per puro caso” non deve confondere:con essa si intende che il raggio d’azione della selezione na-turale e di altri fattori evolutivi è più esteso di quello dei fe-nomeni di adaptation funzionale. L’enunciazione dellaasimmetria fra selezione e adattamento è bene espressa daLewontin poco dopo nel saggio del 1978:
La relazione tra adattamento e selezione naturale non proce-de in ambedue i sensi. Mentre un maggior adattamento relati-vo conduce alla selezione, la selezione naturale non conducenecessariamente a un maggior adattamento (p. 11).
In altri termini, l’evoluzione non sembra procedere per“vie maestre” predefinite in senso funzionale o “ingegneri-stico”. Al contrario essa sembra diramarsi in una pluralitàdi cammini evolutivi alternativi e incommensurabili sulpiano della valutazione adattativa:
a) In condizioni di pressioni selettive similari, gli stessiorganismi possono sviluppare morfologie differenti, ossiapercorsi evolutivi alternativi, senza che sia possibile discri-minare fra di essi il più efficiente in senso adattativo.
b) In condizioni di pressioni selettive similari, una po-polazione può privilegiare la propria idoneità a una pres-sione selettiva (per esempio aumentando la fecondità),un’altra potrà rispondere meglio alla pressione selettiva perun miglior utilizzo delle risorse alimentari. I “picchi adatta-tivi” corrispondenti possono anche essere incommensura-
TELMO PIEVANI
bili: non è lecito decidere quale delle due vie sia più idoneain generale.
c) Una trasformazione funzionale, originatasi in rispostaa una certa pressione selettiva, produce sempre un venta-glio di trasformazioni collaterali, il cui consolidamento puòsempre condurre a nuove “diramazioni” evolutive impre-vedibili.
La ridefinizione del concetto di adaptation nella pro-spettiva del pluralismo evolutivo ha condotto alla formu-lazione della nozione di “adattamento” come sottoinsie-me del cambiamento evolutivo: non tutto il cambiamentoevolutivo può essere compreso in termini di adattamento.Da una visione onnicomprensiva centrata sull’idea di unadeguamento passivo fra ambienti e organismi, l’attenzio-ne si è spostata verso una concezione estesa del cambia-mento inteso come costruzione di percorsi evolutivi alter-nativi fra organismi e ambienti che si codeterminano reci-procamente.
Siamo approdati quindi a una nuova classificazioneestesa del cambiamento evolutivo che Lewontin proponealcuni mesi dopo la lettura dell’allocuzione anti-adattazio-nista alla Royal Society londinese. In essa Lewontin chiari-sce meglio le diverse aree del cambiamento evolutivo, in-troducendo come ultima la tipologia di adaptation funzio-nale vera e propria, senza cui, precisa l’autore, “non vi sa-rebbe evoluzione”. Le tipologie del cambiamento evolutivonella classificazione di Lewontin diventano sei.
1) Cambiamento evolutivo, di natura non adattativa,guidato direttamente dalla selezione naturale (è il punto“b” precedente: picchi adattativi separati, senza un signifi-cato adattativo generale per la comparazione).
2) Cambiamento evolutivo, di natura non adattativa (al-meno primariamente), determinato dall’influenza indirettadi cambiamenti differenziali nella crescita e di fenomeni al-lometrici.
3) Cambiamento evolutivo, di natura non adattativa,determinato da fenomeni di pleiotropia genetica: la selezio-
EXAPTATION: LA BIOLOGIA DELL’ IMPREVEDIBILE
ne favorisce la moltiplicazione di un gene in virtù di un suoeffetto fisiologico, ma il gene stesso ha una molteplicità dialtri effetti collaterali (“pleiotropici”).
4) Cambiamento evolutivo, di natura adattativa, dovutoa soluzioni alternative (egualmente funzionali) alla medesi-ma sollecitazione ambientale: la scelta di una “via adattati-va” e il raggiungimento di un picco adattativo alternativonon è decifrabile, a sua volta, in senso funzionale. La“biforcazione” ha ragioni contingenti e tuttavia determi-nanti (come per le condizioni iniziali in un sistema fisiconon in equilibrio) e non vi può essere misurazione o grada-zione dei picchi adattativi (misurazione di fitness).
5) Cambiamento evolutivo, di natura non adattativa,dovuto a fenomeni del tutto casuali: deriva genetica, fissa-zione di mutazioni casuali in piccole popolazioni, effettihitchiking per cui un gene selezionato “trascina” con sé ungene cui è legato nel genoma.
6) Cambiamento evolutivo, di natura adattativa, deter-minato dalla selezione naturale per l’assolvimento di unafunzione specifica, come in tutti i casi di “convergenza fun-zionale” (quando animali diversissimi sviluppano le stessestrutture per adattarsi a un certo ambiente) e nei casi in cuisi verifica effettivamente un cambiamento adattativo gra-duale (cambiamento continuo) e indipendente da effetticollaterali (cambiamento focalizzato).
L’adattamento, in conclusione, non può essere conside-rato in tale prospettiva una diretta e univoca conseguenzadella selezione naturale, ma consiste in una molteplicità distrategie evolutive eterogenee, creative, flessibili, ridon-danti, spesso imprevedibili a priori. Questo slittamentoteorico porta con sé feconde implicazioni filosofiche edepistemologiche riguardo al nostro modo comune di in-tendere il cambiamento e la relazione fra gli organismi (fracui noi stessi) e l’ambiente; permette di superare le aporieiniziali della teoria evoluzionistica riguardo all’idea diadattamento, già intuite da Charles Darwin; e, non ultimo,apre uno squarcio di comprensione e di rinnovato stupore
TELMO PIEVANI
sulla fantasia, sulla diversità e sull’ingegnosità con le qualila vita esplora ogni volta nuovi sentieri di sopravvivenza edi sviluppo.
Homo sapiens, una specie “exattativa”
Facendo tesoro di questa tassonomia estesa propostadal collega e amico Lewontin, Gould, in alcuni scritti deiprimi anni Novanta, ipotizzò che il principio di ridondanzae flessibilità potesse avere un’estensione epistemologica,come nuova metafora del cambiamento e schema euristicodi ricerca, all’insieme dei sistemi evolutivi e alle proprietàdell’organizzazione in generale (naturale o socio-culturale).In particolare, egli fu affascinato dall’idea che anche il pro-gresso tecnologico, che pure presenta caratteristiche la-marckiane estranee all’evoluzione biologica, fosse soggettoa meccanismi di exaptation funzionale e a un principio ge-nerale di flessibilità creativa.
Come pare dimostrato dalla prevalenza del tutto “sub-ottimale” della tastiera QWERTY nelle macchine da scriveree nelle tastiere per computer, la contingenza (contingency)e l’occupazione di una posizione dominante (incumbency)appaiono come regolarità che governano la natura delleconnessioni temporali sia in natura sia nella produzionetecnologica e culturale. Uno studio particolarmente bril-lante sul consolidamento di prodotti tecnologici indipen-dentemente dalla loro efficienza è quello dell’economistateorico William Brian Arthur che, nel contesto di una ri-flessione generale sul sistema economico come “sistemaauto-organizzato” in cui si assiste a un’evoluzione contin-gente di configurazioni o “proprietà emergenti”, avanzò alproposito la teoria dei “rendimenti crescenti” e dei feno-meni di lock-in (Anderson, Arrow, Pines, a cura, 1987).
“Designiamo un evento storico – l’avvento dei mammi-feri o il successo della QWERTY – ‘contingente’ quando siverifica come il risultato casuale di una lunga sequenza diantecedenti imprevedibili, anziché come l’esito necessario
EXAPTATION: LA BIOLOGIA DELL’ IMPREVEDIBILE
di leggi di natura” (Gould 1991a, p. 68). L’exaptation fun-zionale (ribattezzato “principio del Panda”) potrebbe dun-que essere, secondo Gould, una caratteristica dei sistemistorici ed evolutivi in generale.
Il concetto di “sistema adattativo non ottimizzato” èstato fecondamente applicato anche in altre discipline, fracui l’economia teorica. Secondo John Holland (1992), eco-nomista dell’Università del Michigan, il sistema economicova considerato a tutti gli effetti come un “sistema comples-so adattativo”, in grado di apprendere dalla propria evolu-zione e incapace, pena l’estinzione, di stabilizzarsi in unasituazione di equilibrio ottimale. Questa idea del non-equi-librio adattativo e della produzione di novità come condi-zione di sopravvivenza (come in un gioco d’azzardo fral’organismo, che deve produrre nuovi modelli per interpre-tare e prevedere la realtà, e l’ambiente, ridefinito come“spazio delle possibilità”) si riconnette esplicitamente allaconcezione di un adattamento “relativo e interminato” eall’idea di una “danza coevolutiva” fra organismi e ambien-te suggeriti da Lewontin.
In una prospettiva ancora più generale, le nuove me-tafore del cambiamento suggerite dal pluralismo evolutivopotrebbero rivelarsi illuminanti per la comprensione deimeccanismi evolutivi e creativi di un particolare “campodi exaptation”, il cervello umano, su un terreno disciplina-re in cui il concetto di adattamento neodarwinista ha an-cora un ruolo soverchiante. Non solo la psicologia evolu-zionista, ma anche la storia della scienza e l’epistemologiarisentono oggi di una generale obbedienza alla visioneadattazionista, eppure:
I pennacchi a cascata del cervello umano non dovranno forseessere più influenti dei presunti adattamenti primari degli an-tenati africani cacciatori-raccoglitori per fissare i contorni diciò che chiamiamo “natura umana”? (Gould 2002b, p. 1.566).
Molti comportamenti umani e molte proprietà del cer-vello umano potrebbero non essere adattamenti diretti, ma
TELMO PIEVANI
conseguenze collaterali, riadattamenti, cooptazioni funzio-nali, bricolage evolutivi, in altri termini exaptations. Fra es-si, Gould menziona attività della massima importanza co-me le capacità linguistiche, la lettura, la scrittura, la produ-zione artistica, l’elaborazione religiosa (Gould 1991a, b). Sipotrebbero studiare in una luce nuova, in particolare, iprocessi cognitivi di invenzione, di scoperta, di creazionedi alternative inesplorate per la soluzione di un problema,di immaginazione e di innovazione.
Alcuni neurobiologi e scienziati della cognizione hannoaccolto in questi anni l’invito di Gould a un’applicazionedell’exaptation all’evoluzione cognitiva e neurale, con risul-tati incoraggianti. La capacità dei circuiti neurali di acqui-sire con estrema flessibilità e rapidità funzioni per le qualinon erano stati “programmati” nel corso dell’evoluzione,caratteristica che John Robert Skoyles e altri neuroscienzia-ti hanno definito “plasticità neurale”, potrebbe essere daun lato un ottimo adattamento (la plasticità neurale, cosìcome la plasticità di altri tessuti, garantirebbe una buonacoordinazione dello sviluppo neurale, in sostanza la possi-bilità di espandere adattativamente alcune aree a scapito dialtre nel corso dello sviluppo), dall’altro un’utilissima riser-va di exaptations possibili: nel corso dell’evoluzione circuitiinizialmente dedicati a determinate funzioni adattative (peresempio, di natura senso-motoria) vengono cooptati perfunzioni differenti (utilizzo di strumenti, comunicazione,comprensione simbolica…) al mutare del contesto. Migra-zioni neurali, compensazioni, ristrutturazioni, inaspettateconversioni (cortecce uditive che diventano visive, e vice-versa) ci restituiscono l’immagine di un cervello polivalen-te, le cui componenti, anche se momentaneamente focaliz-zate su un compito, possono assumere funzioni completa-mente diverse da quelle per le quali sembrano essersi evo-lute. Da queste ricerche sembra dunque emergere un’im-magine dell’evoluzione della psicologia umana intesa comecontinua apertura di possibilità nuove, non iscritte in unprogramma innato fissato adattativamente per selezionenaturale (Skoyles 2002; Deacon 1997, pp. 338-341): il cer-
EXAPTATION: LA BIOLOGIA DELL’ IMPREVEDIBILE
vello, come il genoma, sembra essere insomma un organodi potenzialità inespresse, un organo che costruisce nicchieecologiche che poi retroagiscono sulla co-costruzione dellasua fisiologia, un organo specializzato nel non avere specia-lizzazioni.
Come ha notato Nicholas Humphrey, questi studi pre-suppongono la disponibilità ad affrontare il sistema neu-rale come sistema evolutivo, frutto di una storia intesa co-me esplorazione di possibilità, e non più soltanto a parti-re da un modello astratto di ciò che il cervello sembra fa-re nel qui e ora. In tal senso, è sorprendente notare la si-militudine fra ciò che vanno scoprendo questi primi “pa-leo-neurologi” e ciò che da qualche tempo i paleoantro-pologi hanno scoperto a proposito dei modi e dei tempidell’evoluzione dell’intelligenza umana. Il cervello, piùche un organo adattato, sembra una congerie di riorga-nizzazioni, un organo versatile pieno di “ri-adattamenti”,con aree e mappe nuove costruite sulle vecchie, converti-te a nuove funzioni, ristrutturate. La comparsa degli indi-zi tipici di un’intelligenza simbolica e cosciente sembraavvenire rapidamente nella storia evolutiva della nostraspecie, nell’epoca che chiamiamo Paleolitico superiore(intorno a 45.000-40.000 anni fa), nel punto terminale diun lunghissimo processo di espansione graduale del cer-vello iniziato quasi due milioni di anni prima. Come hafatto notare il paleoantropologo Ian Tattersall, l’intelli-genza capace di produrre opere d’arte e sepolture ritualisembra emergere improvvisamente, dopo una lunga storiadi trasformazioni anatomiche che non avevano dato con-seguenze di rilievo in termini cognitivi. Anche se esistonoevidenze sporadiche di comportamenti “moderni” anchein tempi più antichi (pare fino a 150.000 anni fa con i pri-mi sapiens africani), è come se l’intelligenza fosse a uncerto punto “decollata”, come se avesse improvvisamenteacquisito la portanza necessaria per sollevarsi dopo unalunga rincorsa a terra.
Nel cespuglio ramificato delle forme ominidi, portatricisenz’altro di molteplici “forme di intelligenza” a noi scono-
TELMO PIEVANI
sciute, compare un nuovo modello, un nuovo modo di es-sere umani. Scrive Tattersall (1998, p. 170) nel capitolo fi-nale di Becoming Human:
Ciò che è stato concisamente definito “capacità umana” non èderivato per semplice estrapolazione dalle più antiche tenden-ze della nostra linea evolutiva che gli studi paleoantropologicihanno il compito di chiarire. Si tratta di qualcosa di più similea una “proprietà emergente”, per mezzo della quale una nuo-va combinazione di caratteristiche produce casualmente un ri-sultato del tutto inatteso. (…) È certamente la natura emer-gente del nostro organo di controllo e delle capacità da essoderivate a spingere oggi l’uomo a riflettere su se stesso.
Secondo Tattersall, in sostanza, l’intelligenza coscientenon è “estrapolabile” da una lunga tendenza progressivaprecedente, è qualcosa di diverso: una proprietà emergen-te, una “riorganizzazione” a partire dal materiale già a di-sposizione. Eppure, si tratta chiaramente di un’“invenzio-ne” assai potente dal punto di vista adattativo. Come scriveHumphrey in The Uses of Consciousness, la storia naturaledella coscienza implica una ragione funzionale e adattativamolto forte e, pertanto, la coscienza deve emergere per ri-spondere a un’esigenza ambientale imposta dalla selezionenaturale. La coscienza è un adattamento formidabile e na-sce come tale.
Ma come spiegare allora la discontinuità dell’emergenzadella coscienza? Come spiegare il “decollo” che interrom-pe un lungo periodo di crescita graduale e lenta dell’anato-mia cerebrale? Se era così utile fin dall’inizio, perché ab-biamo aspettato tanto? Ancora una volta, le “storie propriocosì” dell’adattazionismo funzionalista non riescono a ri-spondere. Tattersall propone un’interpretazione diversa:
La coscienza è un prodotto del nostro cervello, il quale a suavolta è un prodotto dell’evoluzione. Ma le proprietà del cer-vello umano sono emergenti, sono il risultato di una serie diacquisizioni casuali (naturalmente basate sull’eccezionale ri-sultato di una lunga storia evolutiva) le quali possono essere
EXAPTATION: LA BIOLOGIA DELL’ IMPREVEDIBILE
state favorite dalla selezione naturale solo dopo che il cervellosi fu formato (p. 171).
In quel “solo dopo” sta il nocciolo di una prospettivaevoluzionistica non adattazionista. La selezione naturale,nella maggior parte dei casi (e sicuramente nei casi più in-teressanti), interviene dopo l’emergenza della “forma”, as-segnando a essa una funzione, e non prima. Il cervelloumano non si sarebbe evoluto perché indispensabile a unaqualche funzione biologica specifica (che neppureHumphrey identifica chiaramente, se non riferendosi gene-ricamente a una certa capacità di “comprensione intersog-gettiva” utile per un comportamento sociale elaborato), maper una riorganizzazione contingente a partire da unastruttura anatomica ridondante (che Skoyles, insieme amolti altri, identifica nella corteccia prefrontale) prodottada una lunga storia evolutiva.
L’espansione del cervello a partire dalle prime formedel genere Homo in Africa orientale e meridionale, genera-ta probabilmente da una mutazione dei geni regolatori del-lo sviluppo (alterazione definita “neotenia”, cioè ritenzionedei caratteri giovanili), non si sarebbe sviluppata “in vista”delle sue utilizzazioni future. Se davvero le capacità intro-spettive garantivano un grande vantaggio riproduttivo con-ferito dalla selezione naturale, perché solo una delle lineedi discendenza dei primati le ha sviluppate? Se davvero l’e-voluzione della coscienza e della soggettività è stata “co-struita” passo dopo passo dalla selezione naturale operantesul corredo genetico, amplificando gradualmente i piccolivantaggi comportamentali derivanti dall’esperienza co-sciente, perché gli indizi della presenza di un’intelligenzasimbolica e concettuale appaiono così tardivamente?
Nella storia naturale della coscienza vi è gradualità(anatomica) e discontinuità (funzionale): questi due trac-ciati evolutivi sono indipendenti dal punto di vista funzio-nale. Il primo, l’innesco neotenico, è un effetto collateraledi una mutazione genetica, fissata poi dalla selezione natu-rale in virtù della sua plasticità adattativa e probabilmente
TELMO PIEVANI
accentuata dalla competizione per le risorse fra le specieominidi (exaptation del quarto tipo). Il secondo è un’emer-genza evolutiva repentina, una riorganizzazione funzionalea partire dal riutilizzo creativo di strutture già formate(exaptation del primo e secondo tipo). Anziché essere mac-chine per geni plasmate dalla selezione naturale o dalla se-lezione di parentela (seducente metafora alla base del re-cente successo della psicologia evoluzionistica), gli organi-smi manifestano spesso la capacità di riorganizzare oppor-tunisticamente i propri vincoli strutturali interni e di tra-scendere se stessi trasformando il possibile: “la natura èun’esperta dell’arte del riciclaggio” (Skoyles 2002, p. 126).La storia naturale della mente è forse una storia di exapta-tions ben riusciti, una storia di possibilità sempre nuovepiuttosto che di adattamenti necessari:
L’evoluzione del cervello non è proceduta per semplice ag-giunta di qualche nuova connessione qua e là, fino a diventa-re, dopo eoni, una grande macchina perfettamente oliata.L’evoluzione opportunistica ha arruolato, in maniera alquan-to disordinata, vecchie parti del cervello per svolgere nuovefunzioni e sono state aggiunte nuove strutture, mentre alcu-ne delle vecchie sono state ampliate in modo piuttosto casua-le (p. 174).
“Plasticità neurale più corteccia prefrontale più menteantropomorfa: uguale mente umana”, sintetizza Skoyles(2002, p. 129). Bricolage evolutivo, selezione naturale, spe-ciazione ramificante e contingenza evolutiva contribuisco-no, in una visione pluralista e antiriduzionista, alla storianaturale dell’intelligenza nella nostra specie:
A partire da un precursore che possedeva la gamma di exapta-tions necessari comparve il cervello dell’uomo moderno all’in-terno di un’antica popolazione locale e per mezzo di modifica-zioni che ancora non comprendiamo. In seguito la selezionenaturale operò all’interno di quella popolazione fissando la va-riante come norma. Poi intervenne la speciazione che stabilìl’identità storica della nuova entità. Infine, la nuova specie vin-
EXAPTATION: LA BIOLOGIA DELL’ IMPREVEDIBILE
se la competizione con le altre a essa imparentate, in un pro-cesso che – forse per al prima volta poco dopo la comparsadell’ominide ancestrale, finì per lasciare sulla scena un’unicaspecie ominide: l’Homo sapiens. Vista in questo modo, la pie-na coscienza umana è solo uno dei risultati di quel processoroutinario e casuale di comparsa e affermazione delle innova-zioni che si verifica nell’evoluzione di tutte le linee (ib.).
L’evoluzione delle capacità di introspezione, di astra-zione simbolica e di comprensione delle menti altrui deveaver poi conferito alla nostra specie uno straordinariovantaggio riproduttivo, ovviamente, ma questo sembra es-sere più l’effetto che non la causa del processo. Come hasottolineato molto bene Niles Eldredge, l’evoluzione èuna rete complessa di relazioni che si struttura su più li-velli gerarchici (dal livello macroevolutivo delle specie allivello microevolutivo dei geni) e le trasformazioni avven-gono solo in parte per finalità riproduttive (adattarsi pertrasmettere geni egoisti di generazione in generazione):ben più frequentemente le strategie degli esseri viventisono dettate da finalità economiche, da esigenze di repe-rimento delle risorse, dalla colonizzazione di nuovi habi-tat, dalla reazione a cambiamenti climatici, dalla competi-zione fra intere specie.
Oggi molti scienziati, fra i quali principalmente Ian Tat-tersall e Jeffrey Lieberman (Lieberman 1991; Falk 1992;Tattersall 2002), stanno lavorando all’ipotesi che l’innescocruciale dell’intelligenza simbolica sia in qualche modoconnesso all’emergenza del linguaggio articolato, a sua vol-ta un exaptation legato alla morfologia allungata della gola(peraltro assente nel ramo parallelo dei neanderthaliani). Il“grande balzo in avanti” dell’uomo anatomicamente mo-derno, nel Paleolitico superiore, sarebbe dunque un effettocollaterale congiunto dell’adattamento della gola a climisecchi e della riorganizzazione cerebrale conseguente al-l’acquisizione del linguaggio articolato:
Quasi certamente, dunque, la discesa della laringe e la riorga-nizzazione delle strutture sopralaringee necessarie per l’arti-
TELMO PIEVANI
colazione delle parole avvennero in un più generale contestorespiratorio. Da ciò consegue che il tratto sopralaringeo dimorfologia moderna è un exaptation per il linguaggio: unacondizione preesistente che rese possibile questa notevole in-novazione una volta acquisiti i necessari collegamenti cere-brali (p. 204).
Alcuni recenti ritrovamenti sembrano indicare che la“forma di intelligenza” dei neanderthaliani non prevede-va, probabilmente, questo exaptation per la formazionedelle corde vocali e la loro deriva evolutiva ha preso un’al-tra direzione: dunque, non un’intelligenza per qualchemotivo “inferiore”, ma un’intelligenza “altra”, un altromodo di essere ominidi. Diversamente, intorno a 40.000anni fa, il cervello della specie Homo sapiens era ben“exattato” per il linguaggio e il ragionamento simbolico.Mancava soltanto uno stimolo, un innesco, probabilmentedi tipo culturale e sociale. Così tutto avvenne in un “batterdi ciglia” evolutivo:
Dopo un paio di milioni di anni di irregolare espansione cere-brale e di altre acquisizioni avvenute nella linea umana, dove-vano essere presenti gli exaptations necessari per permettere ilcompletamento dell’intero edificio attraverso una mutazioneche in termini genetici era presumibilmente di minore entità.Nello stesso modo in cui la chiave di volta di un arco è solouna piccola parte dell’intera struttura, ma è vitale per la suaintegrità, un cambiamento della struttura neurale relativa-mente modesto deve avere avuto questo notevole effettoemergente nel nostro cervello. E questa innovazione neuraledeve essere stata acquisita nell’ambito di un’esigua popolazio-ne nostra progenitrice quando tutte le strutture perifericheessenziali – l’apparato vocale, per esempio – erano già dispo-nibili per permetterne l’espressione (p. 206).
La velocità di diffusione del nuovo comportamento ècosì alta che difficilmente l’innesco può essere stato di tipoanatomico, perché ciò presupporrebbe una sostituzione dipopolazioni. È molto più probabile uno stimolo di tipoculturale o sociale, nato all’interno di una popolazione e
EXAPTATION: LA BIOLOGIA DELL’ IMPREVEDIBILE
poi trasmesso rapidamente a tutta la specie per diffusione(Gamble 1994). Quando le potenzialità exattative dell’ap-parato vocale e neurale furono al completo, bastò forse una“sperimentazione” casuale, magari promossa per gioco ingruppi di bambini (Tattersall 2002), a innescare la rivolu-zione della semantica: l’uomo, copiando i suoi cuccioli, co-minciò ad associare parole a oggetti. Da questo exaptation,nelle fasi successive, emergeranno i legami sintattici e l’arti-colazione in frasi.
Gli exaptations sono stati dunque fondamentali nell’e-voluzione umana, e non solo per quanto riguarda le fa-coltà “superiori” della mente e del linguaggio. Per esem-pio, una proposta avanzata alla fine degli anni Ottanta dalpaleoantropologo e fisiologo inglese Peter Wheeler hapermesso di interpretare in modo nuovo l’emergenza delbipedismo nella famiglia degli ominidi (Wheeler 1988;Tattersall 1993, pp. 79-80), cioè l’evento “originario” dacui ebbe inizio tutta la nostra storia funzionale. Se la po-stura eretta è comparsa nel contesto di una speciazioneavvenuta in Africa orientale prima di quattro milioni dianni fa, è possibile che il bipedismo sia stata una caratte-ristica fissata nel patrimonio genetico della nuova specieper motivi indipendenti dai pur formidabili adattamentiche ne sono poi derivati.
Nelle fasi di esplorazione delle radure aperte e senzaombra un grande problema adattativo è quello di mante-nere nei limiti fisiologici la temperatura del corpo, espostodirettamente al sole, e in particolare della testa. I quadru-pedi adattati alla savana hanno sviluppato alcune opportu-ne contromisure, che mancano negli ominidi. La “soluzio-ne” escogitata dalla nostra famiglia potrebbe essere statadiversa e, accidentalmente, foriera di grandi novità adatta-tive impreviste. La postura eretta diminuisce infatti drasti-camente la superficie esposta al sole e garantisce un con-trollo efficace della temperatura corporea. Congiuntamen-te, gli ominidi potrebbero aver perso gradualmente la pel-liccia, aver sviluppato le ghiandole sudoripare e aver scuri-to la pelle.
TELMO PIEVANI
Con questo “ritrovato” evoluzionistico inedito, gli omi-nidi poterono colonizzare gli spazi aperti e la savana. Unproblema di dispersione del calore provocò dunque una ri-strutturazione complessiva del loro piano organico. Ma pa-re che non fossero così impazienti di farlo, se è vero cheper molto tempo rimasero ai margini della foresta per pro-teggersi. Certo, la scoperta del bipedismo diede loro un’in-tera cascata di ricadute adattative straordinarie, dalla loco-mozione alla liberazione degli arti superiori e forse alla cre-scita dell’encefalo. Ma si tratta di effetti collaterali: il bipe-dismo è nato come exaptation rispetto alla vita nella savana(Tattersall 1998). Si è affermato originariamente per fun-zioni termoregolative in un habitat misto ed è stato riutiliz-zato opportunisticamente per una serie di altri adattamentisecondari che hanno permesso agli ominidi di sopravviverenegli spazi aperti e di sfruttarne le risorse. La dispersionedel calore corporeo potrebbe essere stato l’adattamentoprimario acquisito dalla prima scimmia bipede, mentre tut-ti gli altri vantaggi, comprese le modificazioni della fisiolo-gia femminile e le ipotetiche trasformazioni sociali che nesono conseguite, sarebbero il frutto dei suoi potenti exapta-tions. In altre parole, la rivoluzione biologica che diede ilvia al processo di ominizzazione fu una rivoluzione di fles-sibilità, non di specializzazione. Gli ominidi impararono adavere una molteplicità di comportamenti alternativi che lirese più plastici e adattabili a un habitat mutevole.
L’alta frequenza dei fenomeni di exaptation, anche nell’e-voluzione umana, altera profondamente l’idea di un “pro-getto” o “programma” inscritto nella natura. L’evoluzionediventa il regno del possibile. Le strutture della locomozionee dell’intelligenza umane sarebbero, in questo senso, il fruttodi una deriva evolutiva singolare, l’esito di una sequenza dieventi contingenti e irreversibili, un’emergenza tardiva e im-provvisa innescata da un piccolo cambiamento. Ripetendodue volte lo stesso processo evolutivo noi otterremmo due“forme di intelligenza” (cioè due “forme di vita”) molto di-verse. Si può allora comprendere meglio il limite di incom-mensurabilità che divide la nostra forma di intelligenza dalle
EXAPTATION: LA BIOLOGIA DELL’ IMPREVEDIBILE
eventuali “intelligenze” animali: se il processo evolutivo èuna deriva irreversibile, il limite di incommensurabilità è unlimite di contingenza evolutiva. Fra due forme di intelligen-za contigue vi saranno certamente elementi comuni derivan-ti da analoghi vincoli ambientali e da pressioni selettive con-vergenti, ma sapere “che cosa si prova a essere un pipistrel-lo” (Nagel 1974), o “che cosa si proverebbe a essere unneanderthal”, rimarrà un compito assai difficile.
L’evoluzione produce dunque una grande varietà di for-me di vita e di intelligenza che, come i mondi cromatici nonsovrapponibili indagati da Francisco Varela (Thompson, Pa-lacios, Varela 1992), rappresentano ciascuno una traiettoriasingolare di coevoluzione fra organismi e ambienti, una “de-riva naturale”. Questo aspetto di unicità della morfogenesirende peraltro impossibile, per ragioni evoluzionistiche enon logiche, una simulazione artificiale dell’intelligenzaumana. Le soglie di contingenza e di riadattamento attraver-sate dalla nostra forma di intelligenza sono così numerose eradicali da rendere una tale simulazione tanto improbabilequanto la riscrittura della Divina Commedia dal battere ca-suale di una scimmia sulla tastiera di un computer. Potrem-mo allora intendere il fenomeno di exaptation, cioè la di-sgiunzione fra l’origine storica di una struttura e la sua fun-zione attuale, come la chiave di volta di un “teorema di im-possibilità evoluzionistica dell’intelligenza artificiale in sensoforte”: se le proprietà di un sistema biologico non sono de-ducibili dalle loro funzioni attuali, come può un progetto ar-tificiale (che per sua definizione deve stabilire a tavolino unacorrispondenza tra forma e funzione) ricreare fedelmente ta-li proprietà? La sola cosa che possiamo fare è creare le con-dizioni favorevoli per l’innesco di un processo evoluzionisti-co, che dopo il primo passo non sarà più sotto il nostro con-trollo e il cui esito sarà divergente rispetto a qualsiasi dire-zione progettuale aprioristica.
Risulta ancor più evidente, in questo frangente, che ilconcetto di exaptation e la scissione fra origine storica eutilità attuale introducono nella storia una componenteineludibile di contingenza e di imprevedibilità: diventa
TELMO PIEVANI
molto difficile intendere l’evoluzione passata di un organocome un progresso verso la funzione attuale e altrettantodifficile sarà prevedere il prossimo utilizzo a partire dallaconfigurazione corrente. Il messaggio della contingenzaevolutiva accomuna inaspettatamente Darwin e Nietzsche:
L’intera storia di una “cosa”, di un organo, di un uso può essereun’ininterrotta catena di segni che accenna a sempre nuove in-terpretazioni e riassestamenti, le cui cause non hanno neppurebisogno di essere in connessione fra loro, anzi talvolta si susse-guono e si alternano in guisa meramente casuale. “Evoluzione”di una “cosa”, di un uso, di un organo, quindi, è tutt’altro che ilsuo progressus verso una meta, e ancor meno un progressus logi-co e di brevissima durata, raggiunto con un minimo dispendiodi forza e di beni – bensì il susseguirsi di processi di assoggetta-mento pretesi su tale cosa, più o meno spinti in profondità, piùo meno indipendenti uno dall’altro (Nietzsche 1887, p. 67).
Per Nietzsche una “volontà di potenza” formativa fapresa sulla storia, influenzando ogni uso o riadattamentosecondario successivo. In una concezione strutturalista, in-vece, a far presa sulla storia sono i vincoli di sviluppo, i ca-nali morfogenetici che si trascinano di utilizzo in utilizzo,coevolvendo con le funzioni assunte di volta in volta, inuna danza fra ordine strutturale e ordine funzionale cheguida il sistema su traiettorie imprevedibili.
Exaptation, ordine e prevedibilità: la parabola “exattati-va” di Kauffman
In tal senso, un’applicazione sistemica più attenta econseguente del concetto di exaptation potrà essere utile acomprendere le dinamiche di autoproduzione di ordinenelle fasi di discontinuità evolutiva che caratterizzano moltisistemi. Le modellizzazioni di sistemi complessi autorga-nizzati che fanno affidamento su un’acritica utilizzazionedella nozione classica di adattamento (inteso come sinoni-mo di “apprendimento” tout court dall’ambiente) si rivela-
EXAPTATION: LA BIOLOGIA DELL’ IMPREVEDIBILE
no talvolta unilaterali ed esageratamente semplificanti. Il“motore” che porta il sistema evolutivo verso la transizionedi fase, come ha sostenuto opportunamente Stuart Kauff-man, non è il semplice adattamento (una sorta di adegua-zione o corrispondenza rappresentantiva organismo-am-biente), ma la coevoluzione fra tutti gli agenti dell’ecosiste-ma e l’ecosistema stesso, nel quadro di un’organizzazionegerarchica e integrata delle unità evolutive. Un importanteindirizzo di ricerca dei prossimi anni sarà proprio quello diintegrare la nozione di exaptation nei modelli dei sistemicomplessi adattativi (Gell-Mann 1995) e nelle simulazionidi vita artificiale.
La relazione fra l’opera di Gould e quella di Kauffmansvela però alcuni ulteriori elementi di interesse attorno alconcetto di exaptation. Le prime ricerche di Kauffman,biologo teorico amico e collega di Gould, nonché co-fon-datore del Santa Fe Institute for the Study of Complex Sy-stems, indirizzato allo studio dei sistemi viventi dall’operadei maestri francesi François Jacob e Jacques Monod suigeni regolatori, avevano riguardato lo sviluppo delle celluleembrionali. Egli aveva ipotizzato (1993) che le cellule del-l’embrione fossero strutturate come una rete coesiva (siste-mi in cui ciascun componente interagisce con gli altricreando una catena a sostentamento reciproco), funzionan-te grazie al fitto scambio di messaggeri chimici fra le super-fici delle cellule che così si attivano vicendevolmente. Il si-stema, evolvendosi, si autorganizza e produce una serie diconfigurazioni ordinate a partire da contesti caotici: l’ordi-ne si produce “ai margini del caos”. La tesi di Kauffman èche questo ordine autoprodotto (per “autocatalisi”) sia“gratuito”, cioè spontaneo, naturale, in qualche modo in-scritto nella struttura del sistema e nelle sue innate pro-prietà auto-organizzatrici (sia esso una rete casuale di genio una rete neurale).
Pur nella condivisione della critica al funzionalismo dimatrice neodarwiniana, fra l’approccio storico di Gould ele ricerche sulle “leggi naturali dei sistemi complessi” ispi-rate a una forma più forte di strutturalismo biologico e
TELMO PIEVANI
centrate sull’idea guida di auto-organizzazione, come quelledi Stuart Kauffman a Santa Fe e quelle di Brian Goodwinin Inghilterra, si è consumato negli anni Novanta un dibat-tito, su posizioni diverse, di estremo interesse. In Gould,una lunga traccia intellettuale, passata attraverso lo spar-tiacque principale di una ridefinizione pluralista e non piùfunzionalistica del concetto di adattamento, riaffiora nelladelineazione di una concezione della storicità naturale co-me processo contingente di elaborazione di improbabili ecomplesse forme viventi. In Kauffman, la spiegazione dellanatura profonda dei sistemi complessi è data invece dall’ap-plicazione estensiva delle “proprietà emergenti in un siste-ma autoorganizzato”, come integrazione al principio dellaselezione naturale darwiniana. Il connubio fra autorganizza-zione e selezione, attraverso l’interpretazione dell’evoluzio-ne come di un’incessante “emergenza di configurazioni or-dinate ai margini del caos”, sposta l’accento sul concetto di“produzione di ordine” (che Kauffman chiama anche “anti-caos”) e sull’idea di una creatività “interna” (una sorta di“legalità”) dei sistemi viventi che li sottragga sia al determi-nismo della selezione sia al bricolage fine a se stesso.
Tuttavia, nella definizione di questi “arrangiamenti” del-la natura (thinkering) Kauffman ha sempre riunito sotto l’e-tichetta di “contingenza storica”, senza distinzioni, sia l’o-perato della selezione naturale nel produrre strutture adat-tate sia il riutilizzo creativo di materiali già esistenti. “Sele-zione”, “storia”, “contingenza”, “exaptation”, “arrangia-menti” sono sempre caduti, per lui, sotto la stessa area se-mantica, rifiutando così la tassonomia di Gould. Quest’ulti-mo, dal canto suo, ha sempre interpretato la prospettiva diKauffman, probabilmente in modo erroneo, come uno“strutturalismo dissidente” (Gould 2002b, pp. 1.473-1.515)al pari di quello di D’Arcy Thompson: l’eresia consistereb-be nel fatto che Kauffman, Goodwin e il loro illustre prede-cessore hanno concepito una versione dello strutturalismoin cui le cause fisiche vengono “imposte” ai sistemi organicidall’esterno, e non dall’interno come nella corrente struttu-ralista ortodossa. A nostro avviso ciò può essere corretto
EXAPTATION: LA BIOLOGIA DELL’ IMPREVEDIBILE
per la teoria delle forme di D’Arcy Thompson, mentre l’in-troduzione della nozione di proprietà emergente in Kauff-man e Goodwin rappresenta una novità: le leggi di autopro-duzione di ordine sono sì universali e astoriche, ma emergo-no dall’interno dei sistemi complessi, non sono imposte dal-l’esterno. Anche se in effetti tali leggi pre-esistono alla vita,esse sono consustanziali al fenomeno vivente.
L’ordine strutturale spontaneo di Kauffman non è in al-ternativa all’ordine funzionale costruito dalla selezione na-turale. Quest’ultima ha infatti un duplice ruolo nella suateoria delle origini della complessità organica: a livello diindividui, filtrare, conservare e perfezionare le differenti“varianti” che scaturiscono dai processi di autorganizzazio-ne; a livello di specie, produrre un trend generale verso si-stemi che abbiano caratteristiche di flessibilità, di diversitàinterna e di connettività che li renda massimamente creati-vi e adattativi (avvicinandosi a un valore limite di “fitnessai margini del caos”). Dunque non esisterebbe soltanto l’e-voluzione delle forme viventi, ma anche un’evoluzione disecondo livello, la stessa “evolvibilità” di cui parla Gould,una sorta di “evoluzione delle condizioni di evoluzione”.
Il problema, almeno nelle formulazioni fino al 1995, èche l’accentuazione del potere della generalità strutturalesottostante alle specificità funzionali (autocatalisi, attrattoridell’ontogenesi, modelli a cespuglio, curve di riempimentodei picchi adattativi, e così via) giunge fino al punto di ne-gare un qualsiasi ruolo alla dimensione storica irreversibile.Esistono, secondo Kauffman, percorsi storici contingenti,ma a lungo andare essi vengono riassorbiti da un ordinestatistico riconoscibile. Dipende solo dalla scala temporaleconsiderata. Di deriva in deriva, a lungo andare emergenuovamente una regolarità. Ciò significa, allora, che la sto-ria non ha il potere di intaccare la prevedibilità di tali sche-mi generali: ripetendo il film della vita infinite volte, inqualche modo dovremo ritrovare ogni volta gli stessi mo-delli e un’analoga tendenza verso la complessità autorga-nizzata. L’origine della vita non è un miracolo di improba-bilità, ma una conseguenza necessaria, date certe condizio-
TELMO PIEVANI
ni iniziali astratte (il supporto non conta), delle leggi uni-versali della complessità. Allo stesso modo, noi esseri uma-ni non siamo l’ultimo capitolo di una lunga sequenza dibiforcazioni storiche contingenti e fortunate, ma l’esitoprevedibile di tali leggi: eravamo previsti nella logica dell’e-voluzione; siamo “a casa nell’universo”.
Possiamo dunque ipotizzare l’esistenza di un algoritmouniversale, fondato sulla chimica senza tempo della com-plessità emergente, che includa per intero la teoria dell’evo-luzione, rendendo la storia un processo più o meno preve-dibile? Nelle fasi più recenti della sua riflessione (2000),Kauffman sembra essersi allontanato dalle posizioni piùestreme assunte al riguardo da colleghi come Chris Lang-ton: la storia, comunque sia, conta. Ebbene, in tale riconsi-derazione dell’area di influenza rispettiva delle leggi univer-sali e degli eventi singolari, la nozione di exaptation ha avu-to per Kauffman un ruolo fondamentale. Forse la definizio-ne di “sistema complesso” ha bisogno di una terza gamba: isistemi complessi sono sistemi auto-organizzati (ordine “gra-tuito” ai margini del caos); sistemi etero-organizzati (selezio-ne naturale e coevoluzione con il contesto); ma anche siste-mi ri-organizzati (per sequenze di exaptations).
In primo luogo, i fenomeni exattativi sono stati separatidalle costruzioni funzionali per selezione naturale. Qui sitratta di strutture già formate, con o senza una funzione,che diventano effetti collaterali, adottando una nuova fun-zione, che si tradurrà potenzialmente in altri effetti, e cosìvia. Funzioni ed effetti si propagano esponenzialmente: “lafunzione di una parte di un organismo è un sottoinsiemedelle sue conseguenze causali” (p. 130). Tali conseguenzecausali a cascata dipendono da ciascun contesto in cui laparte viene a trovarsi. Pertanto, ciascun “accidente conge-lato” (una struttura attuale funzionante) rappresenta unpunto di potenziale propagazione di effetti, alcuni dei qualidiventeranno a loro volta “accidenti congelati” nella dina-mica coevolutiva di accoppiamento fra sistemi in evoluzio-ne. La domanda circa la prevedibilità del processo storicoottiene allora una risposta ben diversa:
EXAPTATION: LA BIOLOGIA DELL’ IMPREVEDIBILE
Pensate di poter stabilire, avanti nel tempo, tutte le possibiliconseguenze causali di parti e pezzi di organismi che potreb-bero, in una qualche strana circostanza come in un’altra, tra-sformarsi in exaptations, essere quindi selezionati e fare il loroingresso nella biosfera? Detto ancor più francamente, pensatedi poter pre-stabilire con certezza tutte le conseguenze causa-li, dipendenti dal contesto, delle componenti di tutti i possi-bili organismi che potrebbero diventare exaptations, essereselezionati ed entrare nella biosfera? Io credo, e questa è unafaccenda di centrale importanza se sono nel giusto, che la ri-sposta sia no (p. 131).
Il tentativo di Kauffman è ora quello di provare in qual-che modo questa impossibilità. Sulla base di elementari va-lutazioni combinatorie, l’insieme di tutte le funzioni biolo-giche possibili non è definibile una volta per tutte, men chemeno lo sarà l’insieme di tutti gli effetti potenziali dipen-denti dal contesto. Il loro numero non è infinito, ma tran-sfinito, cioè così immensamente grande da non poter esse-re processato da alcun sistema computazionale nell’univer-so (infinito procedurale). Dunque, l’emergenza di unastruttura exattata rappresenta un’esplorazione nello spaziodelle funzioni possibili che non è estrapolabile o derivabilealgoritmicamente dalla configurazione precedente. Taleexaptation potrebbe benissimo rappresentare un aumentodi complessità nel sistema, ma tale aumento non sarebbederivabile dagli stadi precedenti. Secondo Kauffman, que-sto è il motivo per cui i più sofisticati modelli di simulazio-ne della complessità, come Alchemy di Walter Fontana oTierra di Tom Ray, hanno grosse difficoltà nel predire le di-rezioni dei possibili salti di complessità nei loro sistemi. Ta-le difficoltà sarebbe intrinseca, non dovuta a difetto di co-noscenza: se anche conoscessimo perfettamente la configu-razione precedente, lo spazio delle possibili configurazioniderivabili non sarebbe dominabile. Le modalità per “exat-tare” una struttura non sono algoritmicamente comprimi-bili. L’unica procedura per computarle sarebbe quella diun algoritmo lungo tanto quanto l’intera sequenza dellepossibilità attualizzate. Ma un algoritmo di questo tipo, as-
TELMO PIEVANI
solutamente inutile per i suoi scopi, non sarebbe altro cheuna descrizione del sistema, o se preferiamo, non sarebbeniente altro che la storia di quel sistema e dei suoi exapta-tions effettivamente realizzati.
Se questa argomentazione è corretta possiamo allora direche il fenomeno dell’exaptation rappresenta un “teorema dilimitazione” di principio della possibilità di comprimere al-goritmicamente qualsiasi sistema in trasformazione. L’evolu-zione procede attraverso la selezione naturale, ma l’evolvibi-lità dipende dal grado di flessibilità “exattativa”, in un co-stante accoppiamento fra contingenza e potenzialità struttu-rale. Il “margine del caos” sarebbe dunque una regione di bi-lanciamento fra esigenze funzionali di sopravvivenza al qui eora ed esigenze di evolvibilità potenziale, da non far mai ab-bassare al di sotto di una certa soglia. Il motore che mantienela “fitness ai margini del caos” potrebbe essere proprio ilmeccanismo exattativo (la disponibilità al reclutamento perfunzioni indipendenti dalle precedenti), il quale però, pro-prio nel momento in cui garantisce l’evolvibilità, pregiudicala possibilità di circoscrivere completamente lo spazio delleconfigurazioni potenziali. È una sorta di teorema di Godelper la modellizzazione algoritmica di sistemi complessi:
In breve, noi non deduciamo le nostre vite, le viviamo. Le sto-rie sono il nostro modo di dare un senso alle azioni, dipendentidal contesto, di noi come agenti autonomi. (...) La biosfera sipropaga exattativamente, vive la sua vita e sembra proprio chenoi abbiamo bisogno assolutamente di storie per spiegare comelei riesca a fare questo. Noi infatti facciamo lo stesso. Che stra-no. Snow scrisse delle due culture, quella scientifica e quellaumanistica, che non si incontrano mai. La nostra incapacità dipre-stabilire lo spazio delle configurazioni di una biosferapreannuncia un approfondimento della scienza: una ricercadella storia e della contingenza storica, e pur tuttavia ancora unluogo dove trovare leggi naturali (Kauffman 2000, p. 135).
Non è un’ammissione da poco per chi aveva semprecercato le leggi atemporali della complessità. Ma la scienzaè piena di questi exaptations.
EXAPTATION: LA BIOLOGIA DELL’ IMPREVEDIBILE
Capitolo secondoBricolage e degenerazioni, un saggio di antropologiaclinicaPietro Barbetta
Prima parte: Bricolage e degenerazioni
Bricolage: giocare senza teoriaAnche il bricolage è globalizzato. Oggi, per chi volesse
fare bricolage, ci sono i supermercati del bricolage, doveognuno può trovare ciò che cerca. Mio nonno il bricolagelo faceva raccogliendo oggetti da terra, utilizzando parti dioggetti rotti, ammassando stracci, soprattutto mettendo daparte cose inutili, che non avevano più, o che non avevanomai avuto alcuna funzione.
Tutta quella massa di oggetti inutili, tutta quella spazza-tura, veniva poi riutilizzata. In parte per fare cose utili, co-me uno straccio, in parte per fare cose inutili: una bamboladi pezza, un triciclo per i nipotini, una decorazione. Inepoche più antiche, un’icona, un idolo, un simbolo che de-finiva la propria identità.
Il bricoleur è capace di eseguire un gran numero di compitidifferenziati, ma, diversamente dall’ingegnere, egli non li su-bordina al possesso di materie prime e di arnesi, concepiti eprocurati espressamente per la realizzazione del suo progetto:il suo universo strumentale è chiuso, e, per lui, la regola delgioco consiste nell’adattarsi sempre all’equipaggiamento dicui dispone, cioè a un insieme via via “finito” di arnesi e dimateriali, peraltro eterocliti, dato che la composizione di que-sto insieme non è in rapporto col progetto del momento, néd’altronde con nessun progetto particolare, ma è il risultatocontingente di tutte le occasioni che si sono presentate di rin-novare o di arricchire lo stock o di conservarlo con i residui dicostruzioni e di distruzioni antecedenti.
A questa magistrale descrizione di Claude Lévi-Strauss(1962, p. 30) mi pare possano essere fatti solo due appunti:non è detto che l’universo strumentale del bricoleur sia chiusoe, di conseguenza, non è detto che l’attività del bricoleur con-sista sempre nell’adattarsi all’equipaggiamento di cui dispone.
Poteremmo dire che l’universo dell’ingegnere è chiusoe infinito, mentre quello del bricoleur è aperto e finito.
Si tratta di ciò che distingue l’universale dal locale: l’in-gegnere possiede, in linea di principio, un controllo gene-rale di tutti i materiali e di tutte le forme. Il suo progettogli permette di costruire, con il materiale funzionalmenteottimale, la forma funzionalmente ottimale. Ciò che pensaviene realizzato precisamente nel modo in cui è stato pen-sato. Come, per esempio, la diga del Vajont, vanto e onoredell’ingegneria civile italiana.
Il bricoleur invece, non solo ha un numero limitato dimateriali e di forme a disposizione. Spesso gli arnesi e i ma-teriali li mette in luoghi tra loro eterogenei, li ammassa, inmodo che gli uni coprano e nascondano gli altri, li spostadi volta in volta e, soprattutto, il bricoleur si sposta, migra,poi rientra, o magari se ne va per sempre e si stabilisce innuovo posto, dove deve raccogliere nuovi materiali, diversida quelli che già possedeva. Poi, quando deve costruirequalcosa, il bricoleur cerca i materiali e gli arnesi. Li cercaguardando qua e là, indagando nella propria memoria eandando a scovare quel che cerca, spesso senza successo. Ilmateriale che cercava ieri, per costruire un oggetto ormaifinito, lo trova oggi, ma dovrebbe smontare ciò che ha co-struito, e spesso questo è impossibile.
Il bricoleur può mettere in quel punto della sua costru-zione un certo numero di oggetti che svolgono più o menola stessa funzione. Non tutti allo stesso modo e certamenteil suo prodotto sarà meno affidabile di quello dell’ingegne-re, tuttavia potrebbe essere più flessibile. Ma, soprattutto,il bricoleur non pretende di avere tutto sotto controllo, è,in ogni momento, consapevole che qualcosa può sfuggirglidi mano; per questo si affida agli dei e mantiene aperto ilprincipio di speranza.
PIETRO BARBETTA
Un concetto analogo a questo mi pare si possa trovarenel termine “degenerazione” così come viene utilizzato daGerald Edelman (1987, p. 65):
L’ipotesi della degenerazione implica l’esistenza di elementiisofunzionali nel repertorio, nonostante siano funzionalmentemolto diversi; cioè, una certa struttura può realizzare più d’u-na funzione e una certa funzione può essere svolta da più diuna struttura. Mentre in una certa fase un gruppo può realiz-zare una funzione, può realizzarne un’altra in un momentodiverso.
Anche questa limpida descrizione crea tuttavia una cer-ta insoddisfazione. Che cosa intende infatti Edelman perfunzionale e isofunzionale? Questi due termini rinviano aun’idea di perfezione. Un guanto di cotone ripara dal fred-do una mano, come un guanto di lana o uno straccio di la-na. Se la temperatura scende sotto lo zero, il guanto di lanaè più funzionale a riparare la mano dal freddo, ma se nonho un guanto di lana a disposizione, devo scegliere tra unguanto di cotone, che mi ripara la mano in modo parzial-mente funzionale e mi permette di utilizzare l’opposizionedel pollice e uno straccio di lana che è più funzionale dalpunto di vista del freddo, ma meno funzionale dal punto divista del movimento della mano. In generale noi, come i bri-coleur, abbiamo a che fare con mezzi parzialmente disfun-zionali. I sistemi parzialmente degenerati sono sistemi par-zialmente disfunzionali.
In altri termini si tratta di ciò che Gilles Deleuze e FélixGuattari (1972, pp. 8-9) hanno descritto nei termini dimacchine desideranti.
Quando definisce il bricolage, Lévi-Strauss propone un insie-me di caratteri ben legati tra loro: il possesso di uno stock odi un codice multiplo, eteroclito e purtuttavia limitato; la ca-pacità di far entrare i frammenti in frammentazioni semprenuove, donde deriva un’indifferenza del produrre e del pro-dotto, dell’insieme strumentale e dell’insieme da realizzare.La soddisfazione del bricoleur quando innesta qualcosa su
BRICOLAGE E DEGENERAZIONI
una conduttura elettrica, quando devia una conduttura d’ac-qua, si spiegherebbe assai male con un gioco di “papà-mam-ma” o con un piacere di trasgressione. La regola di produrresempre del produrre, di innestare del produrre sul prodotto,è il carattere delle macchine desideranti o della produzioneprimaria: produzione di produzione.
Deleuze e Guattari ci parlano di una sorta di indifferen-za tra l’atto del produrre e l’oggetto prodotto, di modo chel’oggetto prodotto, ciò che rende funzionale l’atto del pro-durre, è nulla, e tutto diventa l’azione produttiva: il pro-durre del produrre.
A che pro? Per il desiderio.Questo i bambini lo capiscono molto chiaramente e an-
che gli adulti lo possono intuire, ogni volta che si tratta diconvincere un bambino a scendere dalla giostra. È eviden-te che qui si parla del desiderio in una maniera molto di-versa da come ce ne parla la tradizione tecnologica preva-lente nei sistemi sanitari moderni.
Per questo mi servirò di William Shakespeare, ove perun cavallo Riccardo III darebbe il suo regno. Per il deside-rio, che in quel caso è continuare a combattere.
Prendiamo il Re Lear (Shakespeare 1603-06, 434-446)verso la fine del secondo atto le due figlie Regana e Go-nerilla decidono di levare al padre i servitori al suo segui-to, ultimo gesto di una progressiva spoliazione di tutti isuoi beni.
Gonerilla: Datemi ascolto, mio signore: che bisogno avetemai voi dei venticinque o dei dieci o dei cinque uomini al vo-stro seguito in una casa dove ne trovate due volte tanti co-mandati e pronti a servirvi?Regana: Ma anche d’uno solo, che bisogno avete?Lear: Non ragioniamo di bisogno. I nostri mendicanti, i piùsquallidi, hanno un superfluo di cose miserrime. Non date al-la natura più del minimo che alla natura occorre, e la vita del-l’uomo varrà al più quanto quella della bestia. Tu, che sei unadama: se le tue vesti solo per farti caldo le portassi così sfar-
PIETRO BARBETTA
zose, la natura non saprebbe che farsi dello sfarzo, che non èquello certo a tener caldo (…).
Ciò che il pensiero sanitario moderno, nella sua versio-ne filosofica essenzialista, sembra non avere tematizzatoabbastanza è proprio la natura del superfluo.
Il superfluo si presenta nei due modi della spazzatura edell’opulenza. Di ciò che viene gettato e di ciò che vienemostrato. Si tratta di qualcosa che ha a che fare con gliaspetti mimetici della nostra esistenza, con il bisogno disenso.
D’altro canto la moderna tecnologia è riuscita a ridurrepersino la mimesi a una funzione: la preda, la usa per nonessere percepita.
Il maschio perdente del branco mostra segni di sotto-missione per interrompere il combattimento e non ricevereulteriori danni fisici. Tuttavia, è stato osservato (Selvini Pa-lazzoli, Boscolo, Cecchin, Prata 2003, pp. 19 sgg.) comenegli esseri umani tali segni di sottomissione possano, a lo-ro volta, essere mimetici e nascondere invece il dominiodel gioco. Nietzsche aveva già colto pienamente come ilressentement non fosse altro che una manifestazione dellavolontà di potenza nell’epoca del nichilismo.
Tuttavia non si riesce, neppure qui, a uscire dalla me-tafora strategica, persino la mimesi appare funzionale a unsistema strategico. Il carnevale (Bachtin 1965) – come pe-riodo di insania a-finalizzata (“semel in anno licet insani-re”), come licenza dalle relazioni di potere e di autorità,come rilivellamento o ridefinizione temporanea delle rela-zioni umane – viene rinchiuso tra parentesi, così come ilgiullare di Lear, che può dire ciò che vuole senza venirepunito proprio perché si è autodefinito giullare, cioè folle.
La domanda che emerge è la seguente: perché le perso-ne stanno insieme, con-vivono? Perché esistono comunitàfamiliari, tribali, sociali, istituzionali e via dicendo?
In uno scritto del 1961, Jay Haley (Sluzki, Ransom1976, pp. 116-117) riporta i termini delle discussioni avuteall’interno di un gruppo di ricerca organizzato da Gregory
BRICOLAGE E DEGENERAZIONI
Bateson, in cui, oltre a Bateson e allo stesso Haley, c’eranoJohn Weakland e William Fry. Il gruppo di ricerca, inizial-mente finanziato dalla Fondazione Rockefeller, ebbe da di-scutere a lungo sul perché una famiglia convive: “[Bate-son] si oppose all’idea che la famiglia dovesse essere de-scritta in termini di membri che stanno tentando di con-trollare il comportamento l’uno dell’altro”.
L’opposizione di cui scrive Haley era tra lui e Bateson.Si tratta di un’opposizione decisiva e Bateson, commentan-do lo scritto di Haley, protesta vivamente su quanto pocoquesta divergenza fosse stata sottolineata dall’autore delrapporto di ricerca (p. 135).
Oltre a non prestare sufficiente considerazione al nostro lavo-ro in comune, Haley sorvola troppo leggermente su differen-ze epistemologiche molto importanti tra me e lui. Secondome, egli credeva nella validità della metafora del “potere” nel-le relazioni umane. Io allora credevo – e ancor di più lo credooggi – che il mito del potere corrompe sempre (…).
Il mito del potere fu adottato per un lunghissimo perio-do dai terapeuti familiari e queste brevi considerazioni diBateson, sebbene riprese nella texture di tutta la sua operasuccessiva, furono poco considerate. La terapia familiarestrategica, a partire da Haley, attraverso Minuchin e SelviniPalazzoli, divenne il cardine di una concezione strategicadelle relazioni familiari e umane e, ben presto, le teorie so-ciologiche dell’attore, che sono una variante sociologicadella teoria dei giochi di von Neumann, presero il postodelle teorie dei sistemi complessi. In un certo senso si dis-se: i sistemi sono semplici, come vuole von Neumann, noncomplessi come ipotizza Bateson.
A mio avviso, la differenza tra il concetto di ridondan-za e quello di degenerazione può fornire una spiegazionedi questa deriva teorica. Inizierei enunciando la mia im-pressione che ridondanza sia un termine che si accompa-gna con gerarchia, mentre degenerazione si accompagnacon rizoma.
PIETRO BARBETTA
Il termine ridondanza deriva dal prefisso red-, che indi-ca una ripetizione, un ritorno su se stesso del termine chesegue, e -unda (Carassiti 1997, p. 321).
Il termine, utilizzato dalla teoria dell’informazione, in-dica la presenza di variazioni sistematiche in un processoche, a prima vista, può mostrare variazioni casuali.
Si dice che una catena di eventi mostra di comportarsi acaso (randomness) se ogni elemento ha un’eguale probabi-lità di verificarsi in qualunque momento. Per cui non sipuò trarne alcuna conclusione, come non si può predirenulla sulla sua sequenza futura. Che è un altro modo perdire che non reca informazione.
Il modello statistico in grado di determinare quantitati-vamente e di misurare la sistematicità di una catena dieventi è l’analisi della varianza. Utilizzando i modelli mate-matici dell’analisi della varianza si è in grado, ad esempio,di dire se la varianza tra diverse catene di eventi sia tale dainformarci sulla diversità di ognuna delle catene di eventioppure no.
Prendiamo l’esempio di due automobili di due diversemarche, ma con caratteristiche simili. Vogliamo sapere seeffettivamente le due auto abbiano la medesima velocità.Prendiamo un medesimo percorso e lanciamo a velocitàmassima le due auto ognuna per cinque volte. A secondadei risultati ottenuti in ciascuna prova per ciascuna auto-mobile, noi potremo misurare se la varianza dei risultati èinterna (within) alla singola auto oppure tra (between)un’auto e l’altra. Risparmio al lettore la concettualizzazio-ne matematica di questo ragionamento perché richiede-rebbe lo studio dei primi dieci capitoli di un manuale distatistica. L’analisi della varianza ci permette di trarre unaconclusione sulla maggiore velocità di un’auto rispetto al-l’altra (varianza between), oppure sulla casualità di unasingola prestazione.
In altri termini, se un valore di un certo tipo si ripete inuna catena di eventi, tale valore può costituire una regola.Dunque, secondo le teorie statistiche di regressione linea-re, un processo può essere casuale, oppure sistematico.
BRICOLAGE E DEGENERAZIONI
Secondo la teoria cibernetica, invece, è possibile pro-durre un’azione che trasformi i processi casuali in processisistematici. Se una catena di eventi casuali viene sottopostaa un meccanismo operatorio si produce un processo stoca-stico che crea una legittimazione interna a una catena dieventi. L’omeostato di Ashby è considerato uno dei primimeccanismi operatori che genera il controllo di eventi ca-suali producendo un’autoregolazione interna agli eventi erendendoli dunque, nel trascorrere del tempo, sistematici.
Trasferiamo questa concettualizzazione alle relazioniumane. Unità di osservazione estremamente significative acui applicare questo modello sono le famiglie, le aziende, lesquadre sportive, i team di lavoro, i partiti politici, ecc.
Il gruppo umano, in questa lettura, viene consideratocome un meccanismo omeostatico che trasforma eventi ca-suali in catene sistematiche di eventi. Il gruppo umano si ècosì trasformato in un meccanismo autoregolatore e i sin-goli componenti del gruppo si sono trasformati in vincoliche esercitano il controllo sulle azioni degli altri compo-nenti in maniera reciproca e sistematica.
Di fronte a questa concettualizzazione si potrebbero as-sumere due posizioni: la prima che sostiene che “i sistemisono quello che sono”, cioè che non ci si può fare niente.Come non è ammessa la manipolazione genetica, così nondovrebbe essere ammessa neppure quella relazionale.
Altri sostengono invece che, a fin di bene, si possono am-mettere interventi. Per esempio, una squadra perde le partite,un’azienda perde profitti, un partito politico perde consensi.
A questo punto entra in scena il consulente. Il consu-lente è tale perché è un esperto di funzionamento dei siste-mi umani. Il suo compito dunque è di analizzare i meccani-smi omeostatici di un gruppo umano per vedere se le ope-razioni che vengono compiute da tale gruppo vanno nelladirezione delle finalità corrette. Se cioè producono le ge-rarchie che ci si aspetta, oppure no.
Ma una famiglia che perde? Si dice allora che, a diffe-renza di un’azienda o di una squadra, una famiglia è un si-stema a-finalizzato in modo esplicito.
PIETRO BARBETTA
A partire dal secondo dopoguerra, le famiglie sono sta-te oggetto di riflessione nelle scienze sociali sulla base delleteorie del sociologo americano Parsons (1951). Sul model-lo americano dell’epoca, la famiglia moderna viene definitacome un sistema funzionalmente differenziato.
Si tratta di un’idea orientata secondo due metaforeprincipali:
1. La metafora biologica che vede nell’evoluzione dellaspecie un cammino da una minore a una maggiore diffe-renziazione funzionale degli organismi viventi. Una talemetafora può essere rappresentata dall’idea che gli organi-smi biologici, nella loro filogenesi, aumentano la comples-sità sistemica del loro funzionamento e, pur conservando lecaratteristiche precedenti, le inglobano e le integrano inmodelli di funzionamento sempre più differenziati e com-plessi. In quest’ottica la patologia si manifesterebbe comeuna sorta di regressione verso modelli di funzionamentoprecedenti nella catena evolutiva;
2. La metafora organizzativa che fa riferimento ai siste-mi orientati a uno scopo, come le aziende produttive. Inquesto secondo caso, la differenziazione gerarchico/funzio-nale viene pensata come condizione indispensabile all’or-ganizzazione razionale della macchina produttiva e la pato-logia come confusione o sovrapposizione di posizioni in li-nea gerarchica o sul piano funzionale.
È così che Parsons pensa alla famiglia come a un siste-ma differenziato con un uomo che riveste il ruolo di profes-sional breadwinner – colui che si guadagna il pane in modoprofessionale – e una donna che assume la parte di profes-sional homemaker – casalinga di professione (Dizard, Gad-lin 1990).
Già negli anni Sessanta, e per più di una ragione, questaimmagine monolitica e compatta della famiglia incominciaa entrare in crisi. Nel 1963, Betty Friedan (1963) scrivevaun libro dal titolo The Femminine Mistique. Friedan avevaintervistato un certo numero di donne appartenenti alle fa-miglie americane della middle class: le professional home-maker di Parsons. Queste donne godevano di una serie di
BRICOLAGE E DEGENERAZIONI
vantaggi e privilegi che andavano dal possesso degli elet-trodomestici all’avere una bella casa con camere funzional-mente differenziate, un’auto propria, due bei figli, un red-dito di una certa consistenza. Insomma, tutti quei vantaggiche, siamo agli inizi degli anni Sessanta, fanno di una fami-glia una famiglia confortevole e felice, nel senso modernodel termine.
Eppure queste donne, in gran parte, passavano il pome-riggio sedute sul sofà del loro living room a piangere. Ilmale di cui soffrivano, racconta Friedan, era un male chenon aveva nome: infatti queste donne raccontavano cheneppure loro comprendevano le ragioni di questo piantoquotidiano, in fondo non mancava loro nulla. Di qui la de-finizione di “mistica della femminilità” data dall’autrice aquesto stato d’animo diffuso.
Non ci volle molto perché la Psichiatria ufficiale tra-sformasse questa condizione diffusa in depressione. Si dis-se che negli Stati Uniti la nevrosi femminile più diffusa nonera più l’isteria, che stava lasciando il campo alla diffusionedella depressione. A pochi, oltre Friedan, venne in menteche questo disagio costituiva la cifra di una crisi della fami-glia funzionalmente differenziata che descriveva e, in qual-che modo, prescriveva Parsons.
Né possiamo pensare che il disagio della famiglia mo-derna riguardasse solo le donne americane. Morte di uncommesso viaggiatore, scritto da Arthur Miller nel 1949, ègià un preciso ritratto del disagio della famiglia di classemedia americana, basato su mutui e ratei, relazioni extra-coniugali nascoste dietro l’apparenza di una vita moral-mente irreprensibile e sogni di una vita altra, all’ombra deiquali uno dei figli sviluppa una sindrome disadattiva che inostri manuali diagnostici classificherebbero nei termini di“disturbo borderline di personalità”.
La crisi di questa idea di famiglia si accompagna, neglianni Sessanta, con la crisi dei sistemi istituzionali di salutementale.
Nel caso della terapia familiare, dove questo modello èstato a lungo e ampiamente praticato, la teoria di Haley del
PIETRO BARBETTA
“triangolo perverso”, la teoria strutturale di Minuchin, lateoria dei “giochi psicotici” di Mara Selvini Palazzoli sonoaltrettanti esempi delle applicazioni di questa teoria.
Nel modello parsonsiano, il terapeuta sa come una fa-miglia “sana” si organizza e interviene, in un modo o nel-l’altro, per cambiare i meccanismi omeostatici degeneratidella famiglia patologica.
La prima critica a questa impostazione è che si trattadi un’impostazione meccanicistica che legge i processi deisistemi sociali fondamentalmente in maniera isomorfa.Come ho detto sopra, tale impostazione può essere usataper famiglie, gruppi aziendali, partiti politici, squadresportive, ecc.
Per parafrasare la critica di Hegel all’assoluto di Schel-ling: “La notte in cui tutte le vacche sono nere”.
Si tratta di un meccanicismo che può fare a meno didue aspetti centrali: la storia e l’etica. Oppure che non limette in questione, considerandoli – etica e storia – caeterisparibus.
Per sintetizzare le mie considerazioni sul termine ridon-danza, si tratta di un termine che rimanda a un modello diricerca quantitativo e lineare di tipo meccanicistico, utilequando si ragiona in chiave unicamente tecnologica. Taleconcetto, utilizzato, insieme al concetto di omeostasi, comestrumento per produrre controllo nei gruppi umani, di-scende direttamente dall’idea di Haley che gli esseri umanistiano insieme per ragioni strategiche, di controllo e di po-tere. Idea che Bateson aveva rifiutato per lo meno fin dallafine degli anni Cinquanta.
Un’idea per alcuni aspetti simile a questa fu quella chemosse la grandiosa ricerca sulla storia dei sistemi di pensie-ro di Foucault, almeno fino a una certa fase del suo pensie-ro. Tuttavia la teoria di Foucault presenta più di una diffe-renza. In primo luogo, Foucault si pone come un osserva-tore esterno al fenomeno. Non pretende, in altri termini, dimetterlo, a sua volta, sotto controllo. Egli, semplicemente,studia i meccanismi attraverso i quali gli esseri umani si au-torganizzano in sistemi di controllo sempre meno fisici e
BRICOLAGE E DEGENERAZIONI
sempre più culturali, sempre meno centrali e sempre piùdecentrati. Inoltre, Foucault non nasconde una certa am-mirazione per i meccanismi degenerativi e perturbatori,che di volta in volta mettono in scacco le strutture del sa-pere/potere, costringendole a rinnovarsi e a produrre sem-pre nuove forme del dominio. In altri termini, Foucaultanalizza la questione proprio da un punto di vista storico,focalizzando l’attenzione, anziché sull’omeostasi, sui mec-canismi del cambiamento.
In questo modo, per Foucault, i sistemi di pensiero e isistemi sociali a questi collegati non sono più affatto “lanotte in cui tutte le vacche sono grigie”. L’organizzazionestorica del sistema manicomiale, di quello carcerario, delregime della sessualità e delle perversioni, della cura di sé,sono altrettante costellazioni complesse che si articolano inun processo storico che presenta fasi di stabilità e periodidi cambiamento nei sistemi di significato. Le omeostasitemporanee – per usare un linguaggio che Foucault proba-bilmente avrebbe scansato – sono sistemi di significato chehanno precise implicazioni sociali. Come per esempio l’o-meostasi diagnostico/manicomiale, che nasce dalla separa-zione della follia dalla sragione, operata a partire dalla se-conda metà del XVIII secolo da Pinel e da Tuke, attraversol’opera filantropica della costituzione di asili per la cura deimalati di mente, e terminata nella seconda metà del XX se-colo con la chiusura dei manicomi, conseguente a un movi-mento del pensiero che, a partire da Freud, delegittima l’e-sercizio delle pratiche mediche a carattere coercitivo a fa-vore di meccanismi di controllo sociale più sofisticati.
Tuttavia, anche Foucault prescinde dal terreno dell’eti-ca. Lo fa già negli anni Cinquanta, quando decide di nonproseguire il suo internato in psicologia al Sant’Anne perdedicarsi allo studio dei sistemi sociali dal punto di vistastorico genealogico.
Per riassumere in modo del tutto riduttivo l’opera diFoucault, potremmo dire che egli analizza le relazioni e iconflitti tra ridondanza, intesa come la continua ricostru-zione storica degli strumenti del potere, e degenerazione,
PIETRO BARBETTA
intesa come la produzione dei saperi che decostruiscono imodelli dominanti del sapere/potere.
Ermeneutica della degenerazioneIl termine degenerazione ha un’etimologia che si è fatta
sempre più interessante a partire dalla grande ricerca diFoucault. Si tratta del prefisso de-, che può avere un valoresottrattivo, negativo, conclusivo, intensivo o estrattivo, alquale si aggiunge il termine genus. Nei Topici, Aristoteledefinisce il genere in questo modo: “Genere è ciò che sipredica secondo l’essenza di molti che differiscono specifi-camente” (Aristotele, Topici, 102a, 31 sgg.).
Dunque il termine genere, nella tradizione filosoficaclassica, comporta la presenza di un qualcosa che fa sì che,per quanto due elementi possano essere tra loro differenti,se essi appartengono allo stesso genere, devono avereun’essenza in comune. Così, nell’esempio aristotelico, l’uo-mo e il bue appartengono allo stesso genere animale, con-dividono cioè la medesima essenza, sebbene la differenzaspecifica che distingue l’uomo come animale sia la raziona-lità. Il termine genere indica dunque la presenza di un’es-senza non ulteriormente discutibile, a meno di non trasfor-mare tale termine in de-genere.
Tuttavia il prefisso de- rende il concetto di degenerazio-ne terribilmente polisemico.
Il suo valore può essere sottrattivo, in questo caso signi-fica al di sotto del genere, sub-genere, come per esempionelle classificazioni razziali proposte nel 1795 da Blumen-bach (1830).
Blumenbach, come noto, ideò un sistema di classificazio-ne razziale che vedeva coma razza originaria e superiore larazza bianca caucasica e altre quattro razze che costituivanosuccessive degenerazioni della razza caucasica. Da un partela razza detta malese, degenerazione della razza caucasica, ela razza africana, degenerazione della razza malese. Dall’altrala razza amerindia, secondo tipo di degenerazione della razzacaucasica, cui segue, per successiva degenerazione, la razzaorientale. In questo caso il degenerato è un sub-caucasico.
BRICOLAGE E DEGENERAZIONI
Il valore del prefisso de- può essere invece negativo, co-me nel caso di un figlio che nega, o cui è negata l’apparte-nenza a una famiglia, o di una persona cui è negata l’appar-tenenza a una comunità. Il caso di Antigone, che cerca diseppellire il cadavere del fratello Polinice in territorio teba-no, è un esempio di duplice degenerazione. Polinice, dege-nerato in quanto nemico di Tebe, la sua stessa patria, e av-versario di suo fratello Eteocle, viene seppellito da Antigo-ne entro le mura della città. Antigone, in questo modo,presenta una seconda forma di degenerazione pretendendoche il fratello già degenerato venga reintegrato. Antigoneottiene da quest’atto, a sua volta, la propria degenerazione.
Il valore di de- può essere conclusivo, come nel caso incui si parli di degenerazione di un sistema che va esauren-do progressivamente le sue funzioni. È il caso del concettodi degenerazione in neuropatologia e, in alcuni casi, in psi-copatologia. Si pensi per esempio all’idea, ancora in partediffusa, della schizofrenia come progressiva degenerazionedelle funzioni psichiche individuali. È un argomento cheriprenderemo verso la fine di questo saggio. Oppure del-l’Alzheimer come progressiva degenerazione delle funzionineurologiche superiori.
Quando invece il prefisso de- ha valore estrattivo, ilconcetto di degenerazione si riferisce a qualcosa che si to-glie dal genere, o che è esterno al genere. Per esempio, neiregimi totalitari si parla di arte degenerata, intendendo ri-ferirsi a forme d’arte che, venendo percepite come antago-niste rispetto al pensiero totalitario, vengono escluse. Si di-ce allora che queste forme sono fuori dal canone artistico,sono degenerazioni dell’arte, che conducono l’arte verso lapropria fine, ecc.
Un altro esempio, in questo senso, è quello relativo algenere come identità sessuale. In questo caso, la personache non si sente appartenere al genere a cui dovrebbe ap-partenere per essenza può venire considerata degenerata.In entrambi questi casi, i regimi totalitari, così come i regi-mi familiari più rigorosi, possono trasformare l’estrazionein negazione.
PIETRO BARBETTA
Infine il prefisso de- può avere un valore intensivo. Èquesto il caso che più ci interessa. Negli esempi precedentiabbiamo visto dei concetti limite: possiamo ben immagina-re come, nel linguaggio quotidiano, i valori negativo, sot-trattivo, conclusivo ed estrattivo si colleghino l’un l’altro inuna struttura di rinvii semantici difficilmente districabili.In ognuno di questi sensi forniti al termine degenerazionec’è una connotazione negativa.
C’è invece un ultimo senso da attribuire al prefisso de-che indica un approfondimento, un’intensificazione. Comenel termine decaduto, depravato, deputato – e chissà se èun caso che ho messo insieme proprio questi tre termini –il prefisso de- indica un approfondimento, un’intensifica-zione dei termini cadere, pravus (che significa storto, perver-so) e putare (che significa valutare).
In questo senso il termine de-genere indica una prospet-tiva antiessenzialista e antifunzionalista.
I pennacchi di San Marco, dei quali ci parla StephenJay Gould, menzionati da Telmo Pievani in questo libro,sono un esempio di questa accezione del termine degenera-zione.
Ritorniamo alla definizione di Edelman (1987, p.385). Nel glossario della sua opera Darwinismo neurale,egli ci dà una definizione ancora più chiara e sinteticadel termine:
degenerazione (degeneration). Termine, mutuato dalla teoriadell’informazione, che in biologia indica la presenza di più al-ternative per svolgere la stessa funzione. Per esempio, il codi-ce genetico è degenerato perché vi sono 64 codoni per speci-ficare 20 aminoacidi.
Ora, ciò che ci interessa è cercare di risalire da qui all’i-dea, più generale e più letteraria, che ciò di cui necessitia-mo non sia affatto l’essenziale bensì, come vuole Shake-speare, il superfluo. Si tratta certamente di una dichiarazio-ne paradossale, la quale però presuppone l’abbandono del-l’idea tradizionale di gerarchia.
BRICOLAGE E DEGENERAZIONI
Gerarchia è infatti un termine aristotelico legato all’ideache il genere sia l’insieme di tutti gli elementi che condivi-dono un’essenza. Il genere sta dunque sopra gli elementiche gli appartengono, è loro sovraordinato.
A questa regolazione universale, la cibernetica, attraver-so il concetto di ridondanza, ha sostituito la ricerca e l’ap-plicazione di modelli di autoregolazione dinamica in cui leessenze, anziché elementi dati, si costituiscono nel proces-so omeostatico, un’idea che già in parte si può ritrovarenello stesso Aristotele.
È solo attraverso l’idea di una sovrabbondanza inutile enon funzionale che emerge il processo creativo che portaall’exaptation. Si tratta di un processo rizomatico localizza-to, un po’ come nel bricolage. Vediamo allora i caratteriapprossimativi del rizoma così come sono esposti da GillesDeleuze e Felix Guattari (1980, pp. 20 sgg.).
I primi due principi, enunciati insieme, sono quello diconnessione e quello di eterogeneità: “qualsiasi punto di unrizoma può essere connesso a qualsiasi altro e deve esserlo”.
Secondo questi due criteri il rizoma non ha un puntoche fissa la tassonomia degli elementi. L’oggetto polemicofondamentale di questi primi due assunti è la linguisticagenerativa di Chomsky, con il suo albero linguistico che fis-sa, in sommità, un punto S dal quale segue un ordinamen-to ad albero.
Il terzo principio del rizoma è il principio di moltepli-cità. Si tratta di una molteplicità che non presuppone alcu-na unità che faccia da perno:
Nel rizoma non ci sono punti o posizioni come ne troviamoin una struttura, un albero, una radice. Non ci sono che linee.Quando Glenn Gould accelera l’esecuzione di un pezzo, nonagisce semplicemente da virtuoso, trasforma i punti musicaliin linee, fa proliferare l’insieme. Il numero ha smesso di esse-re un concetto universale che misura gli elementi secondo illoro posto in una dimensione qualsiasi, per divenire esso stes-so una molteplicità variabile che segue le dimensioni conside-rate (primato del campo su di un complesso di numeri fissatoa questo campo) (p. 22).
PIETRO BARBETTA
Il quarto principio, definito di rottura asignificante, in-dica che un rizoma può essere rotto in qualsiasi punto sen-za che smetta di ricostituire se stesso e che le sue linee simuovono in modo imprevedibile comprendendo sia unprincipio di territorializzazione che un principio di deterri-torializzazione.
Infine, il quinto e sesto principio, enunciati insieme, co-me il primo e il secondo, sono il principio di cartografia e ilprincipio di decalcomania. Essi indicano che il rizoma nonsegue alcuna regola strutturale o generativa: è dunqueestraneo a ogni asse così come a ogni struttura profonda.In questo senso il rizoma comprende una dimensione radi-calmente antiomeostatica, e rifiuta ogni dimensione evolu-tiva predeterminata.
Dopo avere enunciato i sei principi rizomatici, Deleuzee Guattari (1980, pp. 43-44) menzionano le ricerche diGregory Bateson su Bali.
Come noto, Bateson si recò a Bali pensando di potereapplicare alla cultura balinese uno schema interpretativocostruito a partire da una ricerca, pubblicata nel 1936 conil titolo di Naven (Bateson 1958) sulla popolazione degliiatmul. In quella circostanza, in particolare osservando lastruttura degli scambi tra le famiglie iatmul, emergevanotemi ricorrenti, che avevano portato Bateson (1972, p. 138)a formulare la teoria della schismogenesi.
Si era visto che il funzionamento della società Iatmul com-prendeva tra l’altro due classi di circoli rigenerativi o “vizio-si”. Ambedue erano sequenza d’interazione sociale in cui leazioni di A erano stimoli per le azioni di B, che a loro voltadiventavano stimoli per un’azione più intensa da parte di A, ecosì via; A e B erano persone agenti o come individui o comemembri di un gruppo.
Da queste osservazioni, Bateson ricavò un modello,preso poi a prestito e trasformato in una specie di dogmasecondo il quale le relazioni umane erano riducibili a duetipi essenziali: le simmetriche e le complementari, con il
BRICOLAGE E DEGENERAZIONI
rischio di una relativa schismogenesi. Creando nel primocaso competizione e rivalità, nel secondo caso autorità-sottomissione, assistenza-dipendenza, esibizionismo-am-mirazione.
Per una serie di circostanze, Bateson non poté applica-re lo schema di Naven alle interazioni tra i balinesi. Nonsolo, egli – che all’epoca si occupava della psicogenesi del-le relazioni nell’interazione adulto-bambino – fu costrettoall’osservazione di un particolare tipo di interazione asim-metrica, quella appunto madre-figlio durante i primi annidi vita.
Fu così che Bateson si accorse che nell’interazione ma-dre-bambino tra i balinesi non si prospettava alcun tipod’interazione riconducibile al modello di Naven.
In particolare Bateson (1972, p. 142) focalizza la sua at-tenzione sui giochi erotici madre-bambino.
Spesso la madre inizia col bambino un’interazione scherzosatitillandogli il pene e stimolandolo altrimenti a un’attività in-terpersonale; questo ecciterà il bambino, e per breve tempoavrà luogo un’interazione cumulativa. Poi, proprio quando ilbambino, avvicinandosi a questa piccola acme, getta le brac-cia al collo della madre, quest’ultima si distrae; a questo pun-to il bambino inizia un’altra interazione cumulativa, comin-ciando un capriccio. La madre o starà a guardare, divertendo-si alle escandescenze del bambino, o, se questi l’aggredisce,respingerà il suo attacco non mostrandosi affatto adirata.
Data questa descrizione, la conclusione di Bateson sem-bra essere che si crei una sorta di regione continua a inten-sità costante, che evita di orientarsi su un punto culminan-te. Questo tipo di interazione, a differenza dell’interazioneschismogenetica, sembra del tutto a-finalizzata. O quanto-meno sembra del tutto indifferente a orientarsi rispetto aun fine esterno.
Si tratterebbe di un tratto difficile da prendere in consi-derazione da parte della cultura occidentale perché nellacultura occidentale è egemone il principio della finalizza-zione esterna delle azioni.
PIETRO BARBETTA
In apertura di un noto saggio sul deutero-apprendi-mento, Bateson (1972, pp. 195-196) torna di nuovo sullaquestione della finalità esterna citando le ricerche di Mar-garet Mead. Egli parla della ricerca come di un processo diinvestigazione interno alle direzioni e ai valori del fenome-no che viene indagato.
A partire dall’indagine su Bali, Bateson formula unacritica radicale alla teoria dei giochi di von Neuman,orientata all’idea che le organizzazioni sociali si costitui-scano essenzialmente in forma di coalizione. Di qui il suorifiuto polemico nei confronti delle posizioni di Haley e diqualsiasi approccio strategico. Il rifiuto del modello strate-gico presuppone il rifiuto di una visione essenzialista e ge-nerativa, così come di una struttura gerarchica ad albero.Il potere, la gerarchia, l’appartenenza a un genere è unmondo possibile, storicamente determinato, certamenteegemonico nell’Occidente moderno, ma neppure qui ge-neralizzabile. Una famiglia non è riducibile a un partitopolitico, un’istituzione giuridica non ha la stessa forma diuna squadra di calcio. La cibernetica senza l’apporto diGregory Bateson è, nel migliore dei casi, “la notte in cuitutte le vacche sono nere”.
Me se gli esseri umani non stabiliscono relazioni tra lo-ro per il potere, allora come mai stanno insieme?
La proposta rizomatica non ci fornisce alcuna rispostageneralizzabile. Tuttavia non è un caso, a mio avviso, cheBateson riveda il modello schismogenetico e critichi radi-calmente la teoria dei giochi dopo avere cominciato a usarestrumenti osservativi di carattere psicogenetico.
Bateson si avvicina qui alla concezione di HannahArendt (1929; Kristeva 2001). Noi nasciamo in un mondoche è già sempre là. E questo mondo è rivestito cultural-mente da un linguaggio del quale siamo parte. Il nostroorizzonte è dunque sempre localizzato e il nostro corpo èsempre già al centro di un sistema di significati pre-co-struiti. Questa visione della mente ci permette di scorgerela sua circolarità bio – noi nasciamo e abbiamo un corpoproprio – psico – chi nasce è un individuo unico e irripe-
BRICOLAGE E DEGENERAZIONI
tibile – sociale – siamo già sempre in un orizzonte di sen-so pre-costruito.
Godere di(s)piacereLe metafore strategiche sono uno strumento che produ-
ce egemonia. L’egemonia si produce raramente attraversodiscorsi che si fondano unicamente su dimostrazioni logi-che o modelli di eloquenza retorica; raramente avviene cheuna persona, seppure convinta da un discorso razionale, netragga conseguenze per le sue condotte quotidiane, sia sulpiano delle propria vita privata, che su quello delle propriepratiche professionali. L’egemonia “si mostra”, direbbeWittgenstein, attraverso le parole chiave che vengono uti-lizzate nel linguaggio quotidiano.
Termini come “imbroglio”, “resistenza”, “coalizione”,“neutralità”, “confini”, ecc. hanno un effetto immediatosulla terapia. Infatti agiscono immediatamente sulle prati-che terapeutiche, trasformando il consulente in un attorerazionale che ha il compito di ristrutturare le relazioni fa-miliari patologiche – perché soggiogate a strategie degene-rate – in relazioni sane. La premessa semplicistica che le re-lazioni umane possano essere soltanto simmetriche o com-plementari, e il susseguente assunto che entrambe questerelazioni abbiano una struttura schismogenetica, cioè chetendano all’escalation, rende il lavoro del terapeuta unasorta di tecnologia dell’intervento strategico. Ma questo ègià parte del discorso razionale. Ho visto molti terapeutiche condividono la critica al discorso razionale utilizzarenelle pratiche terapeutiche le medesime metafore di “coali-zione”, “gioco”, “imbroglio”, ecc. Io stesso le ho usate equalche volta le uso ancora. Come mai?
Per anni la terapia sistemica è vissuta nel terrore di nonricadere nelle pratiche psicoanalitiche, come se questo fos-se un punto d’onore, una questione di distinzione. Quandolo stesso Bateson aveva ipotizzato un modello non strategi-co, in polemica con Haley, Haley (Sluzki, Ransom 1976, p.118) stesso liquidò la faccenda in poche righe: “In genera-le, Bateson optò per l’ipotesi, tradizionalmente sostenuta,
PIETRO BARBETTA
che gli individui sono motivati da sentimenti di paura, diodio e di amore, da minacce di punizione e dal desiderio dievitare la sofferenza”.
Naturalmente Bateson (p. 134) non permise che le sueconsiderazioni venissero liquidate così rapidamente:
Nel 1961, quando Jay Haley mi mostrò questo manoscritto[dal quale è tratta la citazione appena sopra] in quanto capodel gruppo di ricerca, io lo criticai e lo dissuasi dal pubblicar-lo. Oggi sono contento di vederlo pubblicato. Questa testi-monianza dei nostri furori e tormenti potrebbe ispirare diver-timento, o anche perseveranza, forse addirittura saggezza, nellavoro di altri e più recenti gruppi di ricerca.
Certamente Bateson, con il suo lavoro, non aveva datoun contributo al behaviorismo per fare fuori la psicoanalisie in generale le teorie definite volgarmente come “intro-spettive” in psicologia. Questa non era, mi pare, in alcunmodo la sua intenzione. Dunque Bateson non criticava unametanarrativa, quella psicoanalitica, a vantaggio di unanuova metanarrativa, quella strategico-behaviourista.
A quarant’anni di distanza da quella polemica, possiamodire che, nonostante Bateson sia stato enormemente più ci-tato e ufficialmente riconosciuto di Haley, le idee di Haleyhanno prodotto egemonia in terapia familiare per almenoventi-venticinque anni. Solo intorno alla metà degli anniOttanta, dopo che una parte del gruppo di Milano adottòun’ottica costruttivista, e successivamente con l’avvento del-le teorie post-moderne e delle pratiche conversazionali e so-cio-costruzioniste, riemerse l’influenza di Gregory Bateson.
D’altro canto, c’è una ragione storica che ha permessoalle teorie strategiche di avere una tale influenza nel campodella psicoterapia. Invero la psicoterapia è sempre stata, asua volta, egemonizzata dal linguaggio medico, mentre illinguaggio filosofico e letterario è sempre stato considera-to, in qualche modo, materiale di rincalzo1.
In campo medico le metafore di guerra sono dominanti(Capararo 2003) sia in immunologia, che in epidemiologia,
BRICOLAGE E DEGENERAZIONI
farmacologia, neurologia, ecc. La medicina, nel suo com-plesso, si presenta come un insieme di tecnologie volte acombattere la malattia. In ogni paese moderno, le spese perla difesa della salute sono sempre insieme alle spese per ladifesa della nazione, e le armi per questo tipo di difesa so-no i farmaci (Pakman 2003).
La psicoterapia è stata sempre più ricondotta a questoordine del discorso e oggi si trova a competere con i farma-ci e a dimostrare che, nell’ordine psicologico, la sua poten-za è, caeteris paribus, più efficace dei farmaci. Non puòquindi che produrre un linguaggio strategico.
A partire dal Settecento, che Foucault definisce comel’epoca della nascita della clinica, il linguaggio medico di-viene sempre più descrittivo e visivo, uno sguardo che su-bordina la storia del sintomo alla filosofia della sindrome,ma che si connette a questa sotto lo sguardo medico.
Si tratta di una concezione che parte da una premessaindiscutibile: il dolore porta di dis-piacere. Una premessacondivisa ampiamente dalla filosofia utilitarista dell’epoca,che riprendeva il grande dibattito dell’Illuminismo e loriassumeva in alcuni concetti chiave quali l’idea che il pia-cere e il dolore fossero i due principi antagonisti sotto iquali la natura avrebbe posto l’umanità. Di qui il modelloetico e pratico che imponeva la ricerca del piacere e il rifiu-to del dolore, fondamentale per il paradigma medico.
Si tratta tuttavia di un’epoca in cui di fronte a unafondazione nuova del discorso medico, si assiste anche auna sua decostruzione radicale a partire dalla letteraturae dalle pratiche libertine che hanno in de Sade uno deisuoi maggiori esponenti. Scrive David Morris (1990, p.292):
La medicina in Sade è così completamente trasvalutata da co-stituire una sorta di fondazione instabile di un mondo, quellolibertino, d’altro canto senza fondamenti. Dove la ragioneconduce sempre all’irrazionale, dove le idee chiare e le veritàcomprensibili si sviluppano in modo indistinto e instabile in-contrando il potere oscuro, corrosivo e liberante del deside-
PIETRO BARBETTA
rio. Il dolore, per Sade, è molto più di un argomento medico(quale noi tendiamo a considerarlo), e dopo Sade, il dolorenon sarà mai più lo stesso.
In questa prospettiva, la trasvalutazione del discorsomedico-naturalistico, che si fonda su una prospettiva bioe-tica di tipo utilitaristico, si presenta nella forma del para-dosso dell’equazione sado-masochista del dolore come pia-cere. Solo così si assiste a un rivolgimento completo del di-scorso sul potere, perché chi ha il potere di togliere il dolo-re, nella relazione sadomasochista, è colui che, nell’inter-rompere la schismogenesi dell’interazione simmetrica ocomplementare, blocca il desiderio.
La stessa indicazione viene fornita, sebbene in altri ter-mini e con altro linguaggio, nella dialettica servo-padrone,dalla Fenomenologia dello Spirito di Hegel. In entrambi icasi, il potere viene dislocato al di fuori del suo detentoreufficiale. Si tratta di un sapere/potere che solo a prima vi-sta riguarda il padrone o il carnefice e che invece, a unosguardo più attento, riguarda, ed è detenuto, dal servo edalla vittima2.
Lacan (1991, pp. 27 sgg.), in Il rovescio della psicoanali-si del 1969, paragona la relazione psichiatra/isterica alladialettica hegeliana padrone/servo e Foucault scrive, nel1954, una cosa ancor più importante allorché sostiene chemai la psicologia potrà spiegare la follia, perché è nella fol-lia che risiede la verità della psicologia.
Che cosa può significare ciò se non che il senso dellapsicologia e della medicina non può essere che riposto nel-l’oggetto che le costituisce?
Allora potremo dire che i poteri del medico, quelli del-lo psicoterapeuta, sono, in un certo senso, illusori perchéesercitano il loro dominio su ciò che non possono conosce-re intimamente e che possono dominare solo attraverso ildiscorso tecnico.
Si tratta di quanto Bateson sostiene quando parla deldominio di un modello di ricerca orientato a finalità ester-ne ai valori e agli effetti del fenomeno osservato, una ricer-
BRICOLAGE E DEGENERAZIONI
ca orientata dai valori e dalle finalità della cultura dell’os-servatore. Nello studio foucaultiano sulla nascita della cli-nica, per esempio, si tratta dell’occhio del medico nellacultura dello sguardo clinico.
La trasformazione post-moderna – se possiamo definir-la con questa facile formula – della bioetica, l’idea che i sa-peri sono molteplici e che il sapere sul dolore appartiene inprimo luogo al corpo che lo contiene e, di lì, alla personache è quel corpo, ha conseguenze ampie non solo sulla re-lazione tra il punto di vista esterno – della terza persona,dell’esperto, del medico, dello psicologo – e quello interno– della prima persona – ma anche sullo sguardo della terzapersona.
Infatti, se la terza persona è il detentore unico del sape-re/potere, il suo sguardo non può che essere uno sguardostrategico. La clinica nasce come un’impresa di sottomis-sione strategica dei corpi feriti, doloranti, menomati, clau-dicanti al dominio anamnestico, diagnostico e prognosticodella nosologia medica. La psicoterapia, nella sua versionedi psicologia del profondo, diventa un movimento di ri-scatto del povero io, servitore di tre padroni, verso una po-sizione di controllo; e la psicoterapia della relazione nonpuò che mostrare la propria competenza nel cambiamentodei meccanismi di potere interni alle relazioni familiari,nella capacità di trasformare le omeostasi sistemiche.
Tra i tanti cambiamenti e rivolgimenti del pensiero psi-coanalitico, ancora assai poco è stato scritto, a mio avviso,sul caso del presidente Schreber. Freud lo definisce come uncaso eccezionale, poiché non si tratta di un caso di nevrosi,bensì di psicosi paranoica. Un caso non indicato per il trat-tamento analitico, tant’è vero che l’interpretazione di Freudsi basa sulla lettura dell’autobiografia di Schreber e sull’ope-ra di Jung Psicologia della demenza praecox, del 1907.
Ma ciò che sembra in parte sconvolgere le categorieanalitiche è la considerazione di Schreber che “la beatitu-dine, (…) anche se non esclusivamente, è purtuttavia, al-meno nello stesso tempo, un sentimento di voluttà estre-mamente intenso”.
PIETRO BARBETTA
Come noto, Schreber ebbe il secondo attacco di folliasubito dopo essere stato nominato presidente della Corted’Appello di Dresda, nel 1893. Gli capitò, tra il sonno e laveglia, di pensare che “dovesse essere davvero bello essereuna donna che soggiace a una copula”. Di lì in poi il rico-vero psichiatrico durato quasi dieci anni.
Schreber fu dimesso nel 1902 e gli furono reintegrati idiritti civili, grazie alla sua personale battaglia per liberarsidalla psichiatrizzazione. Fu così che gli fu data la possibi-lità di pubblicare il suo delirio: egli si stava trasformandoin donna in virtù di una relazione speciale con Dio. Il suorapporto con Dio viene descritto come un rapporto di odioe amore, di tipo carnale e, a tratti, di prostituzione.
Lo scandalo di Schreber consiste nel dissolvere, nel suodelirio, la distinzione, posta da Agostino, tra l’amore divi-no, come caritas, e l’amore fisico, come concupiscentia.
Di lui Deleuze e Guattari scrivono: “Il presidente Sch-reber ha i raggi del cielo nel culo. Ano solare. E state certiche funziona; il presidente Schreber sente qualcosa, produ-ce qualcosa, e può farne la teoria”.
Ciò che si impara dal discorso schizofrenico, la saggez-za contenuta nel delirio, indica che il dolore non è il con-trario del piacere, l’amore non è opposto alla concupiscen-za: il controllo dell’io sui meccanismi inconsci non è piùcosì indispensabile e le omeostasi che trasformano le fami-glie in servomeccanismi si dissolvono. Lo sguardo clinico sitrasforma in uno sguardo antropologico. La cultura, la let-teratura, la filosofia, l’arte ritornano al centro dell’attenzio-ne clinica.
Visti da un altro mondo si potrebbe dire: gli esseri uma-ni si incontrano, interagiscono, entrano in relazione, comu-nicano, soffrono e forse muoiono come muoiono senza unaragione, ma tutto ciò sembra dare un senso alla loro vitadal loro punto di vista. Per questo motivo, questi stranianimali hanno sviluppato capacità ex-attive enormi, chetuttavia non vengono tenute da loro – in particolare a par-tire degli ultimi trecento anni – nella dovuta considerazio-ne. Essi non credono più che uno di loro, allontanandosi
BRICOLAGE E DEGENERAZIONI
dagli altri per andare su un monte, riceva le tavole dellaLegge, né che recandosi in una particolare città l’Oracoloindichi il loro destino; essi non usano più il delirio, o me-glio, lo usano ancora, ma, in media, solo mezz’ora prima diaddormentarsi.
Seconda parte: studio di tre casi cinici
Dia-lexiaCi sono però eccezioni. Una di queste riguarda una
donna, attualmente laureata in filosofia, che da bambinaera stata dislessica. Questa donna mi aveva raccontato diavere superato ogni difficoltà nella lettoscrittura intornoai dodici anni, allorché aveva cominciato a prendere le-zioni di danza classica. Invero, quando lo ascoltai per laprima volta, un tale resoconto mi sembrò del tutto impro-babile. A quel tempo, una quindicina d’anni or sono, nonavevo una grande esperienza clinica. Tuttavia, in questiquindici anni ho avuto modo di osservare numerose si-tuazioni in cui un bambino con difficoltà di apprendi-mento, con difficoltà di ordine motorio – ad esempio dimotricità fine – o con disturbi dell’attenzione cambiassein modo discontinuo grazie a un cambiamento del corpoproprio. In molti casi la difficoltà si dissolve con lo svi-luppo, basta che una bambina o un bambino diventi ado-lescente.
A lungo ho pensato ai possibili meccanismi evolutiviconnessi con il racconto di questa donna, come più in ge-nerale a questi cambiamenti discontinui. Ho cercato tutta-via di comprendere il fenomeno in modo differente rispet-to alle spiegazioni dominanti in psicologia evolutiva. La di-slessia venne descritta in Inghilterra per la prima volta a fi-ne Ottocento e incominciò a diffondersi nella prima metàdel Novecento. Attualmente le teorie eziologiche sulla di-slessia sono molteplici: un disturbo all’area corticale pre-posta all’elaborazione fonologica, un disturbo nella rapi-dità a elaborare l’informazione uditiva, eventuali disturbi
PIETRO BARBETTA
dell’equilibrio legati a un danneggiamento pregresso all’o-recchio medio, condizioni di svantaggio socioculturale chehanno effetti sull’area degli apprendimenti, ecc.
Ciò che ognuna di queste ipotesi – spesso antagoniste etra loro in contrasto – ha prodotto è fondamentalmente ladiffusione, soprattutto negli Stati Uniti, di metodi “infalli-bili” per la guarigione dalla dislessia. In generale si tratta diapprocci basati su forme di adattamento.
Il metodo di addestramento fonologico è, in questosenso, paradigmatico, poiché, partendo dall’ipotesi che ilcattivo funzionamento di un’area corticale limiti le compe-tenze spontanee al riconoscimento dei fonemi, prevedeuno specifico addestramento fonetico, in modo da produr-re un controllo consapevole di alcune competenze che nonvengono attivate spontaneamente.
Non credo vi siano motivi per dubitare che in alcuni ca-si questo metodo di addestramento abbia avuto una certaefficacia, tuttavia il ragionamento istruzionista che lo sor-regge consiste nell’agire sulle supposte cause di un distur-bo cercando un meccanismo per metterle sotto controllo.Inoltre, nell’individuare un’area corticale come dis-funzio-nale, si costituisce una sorta di “protesi mentale” atta asvolgere la medesima funzione, a risolvere il problema del-la dis-funzionalità.
Il tentativo da me percorso per comprendere la dissolven-za prodotta dalla danza sulla dislessia, nel racconto presenta-to sopra, va in tutt’altra direzione. Ho cercato una ragionenel campo dell’ermeneutica e dell’analisi del linguaggio.
Che cosa significa essere dis-lessica? Il termine derivadal prefisso dys-, che significa una mancanza, un male, cuisi aggiunge il termine léxis (discorso, parola, locuzione) de-rivato dal verbo lego, tra i cui molteplici significati vi è an-che quello di “leggere ad alta voce”.
Come interpretare allora il resoconto della donna di-slessica il cui disturbo si dissolve in concomitanza con ilsuo apprendimento della danza classica?
Platone, nel Fedro, racconta il mito di Theut, una divi-nità minore dell’antico Egitto, che aveva grandi capacità
BRICOLAGE E DEGENERAZIONI
inventive: i numeri, il calcolo, la geometrie, l’astronomia, ilgioco dei dadi, ecc. Theut, un giorno presentò a Thamus, ilre dell’intero paese, un sistema che chiamava scrittura.Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, Thamusnon accolse con grande entusiasmo la scoperta. La scrittu-ra non è utile all’uomo per ricordare (mnémes), ma per ri-chiamare alla mente (hypómnesis). Infatti, dice Thamus aTheut, gli esseri umani, fidandosi di ciò che scrivono: “ri-chiameranno le cose alla mente non più all’interno di sestessi, ma al di fuori, attraverso segni estranei” (Platone, Fe-dro, 275a, corsivo mio).
Secondo Walter Ong (1977) la differenza tra oralità escrittura si presenta come una differenza culturale checoinvolge l’intera struttura psicologica degli individui.
Nel mondo a oralità primaria si assiste a un’indifferen-ziazione tra l’aspetto noetico e l’aspetto noematico dellacomunicazione. L’aspetto noetico della comunicazione puòessere considerato come il gesto del comunicare, mentrel’aspetto noematico consisterebbe nel contenuto della co-municazione. Il primo è da considerare come un flusso vi-vente, il secondo come ciò che rimane depositato al termi-ne di questo flusso. Nelle culture a oralità primaria la di-stinzione tra questi due elementi è praticamente inesisten-te. Essa si manifesta attraverso l’uso di tecniche linguisti-che ripetitive e ritmiche, come formule, metriche, melodi-che, di cliché, di giochi di parole e rebus che mantengonouna certa riproducibilità del discorso. In generale, il deten-tore di queste conoscenze noematiche è rappresentato dal-lo sciamano, che conosce i rituali che ripetono il discorsoimportante, quello che va ricordato. Al di fuori di questetecniche mnemoniche, il tipo psicologico della personanella cultura a oralità primaria non possiede alcuna tecnicadi esternalizzazione del significante dal corpo proprio, se siesclude l’uso del graffito.
La tecnica della scrittura produce un radicale muta-mento della psicologia individuale, difficile da immaginareper noi che siamo già sempre interni alla civiltà della scrit-tura. Si tratterebbe di un vero e proprio meccanismo di
PIETRO BARBETTA
scissione tra l’aspetto noetico, il gesto del comunicare, el’aspetto noematico, il suo contenuto. Non solo, il gestodella comunicazione si scompone in una quantità di modipossibili rendendo la comunicazione differita molto piùimportante della comunicazione faccia a faccia e rendendoa sua volta la comunicazione faccia a faccia come una sortadi variante della comunicazione differita.
Il processo di apprendimento della lettoscrittura sem-bra consistere dunque in una profonda trasformazione psi-cologica della persona, che non coinvolge soltanto i pro-cessi cognitivi, lasciando invariate tutte le altre dimensioni.Si tratta, in primo luogo, di una profonda trasformazionedel corpo proprio, che deve venire addestrato ad assumerele posture indispensabili, le tecniche di motricità fine, ladocilità nel rimanere fermo per tempi lunghi, le coordina-zioni fisica, oculomotoria, visiva ad hoc per questo tipo dioperazioni.
È necessario allora rileggere le connessioni mente-cor-po. La grande ragione del corpo dis-lessico – che viene tra-dizionalmente curata con la piccola ragione di un addestra-mento radicato in una spiegazione semplicistica – si pre-senta, a uno sguardo curioso, come un rigoglioso cespuglioirriducibile alla sola area corticale che non elabora l’infor-mazione, come se il resto del corpo – tutto ciò che eccedel’area di Broca, sia nel cervello che al di fuori di esso – nonavesse alcuna rilevanza.
Frances Yates (1966, p. 29), in quella meravigliosa ope-ra che è L’arte della memoria, menziona un frammento da-tabile introno al 400 a.C., dal curioso titolo di Dialexeis, incui vengono date indicazioni estremamente interessanti aproposito delle tecniche di memoria che rinviano al temadell’exaptation: “(…) ciò che odi, riponilo in ciò che cono-sci. Per esempio: devi ricordare Krysippos (Crisippo); locollochiamo su krysós (oro) e héppos (cavallo)”.
Il gioco di parole, l’anagramma, l’invenzione di strate-gie nascoste, il rebus può essere naturalmente reso talmen-te complesso e oscuro da richiedere più di un esercizio diermeneutica.
BRICOLAGE E DEGENERAZIONI
Come nel caso delle profezie oracolari, si tratta di modiper nascondere/dischiudere i segreti riposti nella mente.
Come non ricordare, a proposito del termine krysós, l’i-nizio dell’Ulisse di Joyce, ove l’autore svela e nasconde unaspetto autobiografico attraverso la parola Crisostomo ri-posta tra due punti?
Crisostomo, che è l’unione di krysós (oro) e stóma (boc-ca), indica – in greco si direbbe semainei – contemporanea-mente due segreti: l’immagine delle “schegge d’oro” che“brillavano qua e là” nella bocca di Buck Mulligan (Joyce1937, p. 6) e il dato autobiografico della temporanea coabi-tazione – in una torre a Sandycove – dello stesso Joyce conlo scrittore Oliver Saint John Gogarty.
Come nel romanzo Stephen Dedalus coabita con l’usur-patore Buck Mulligan – appunto Crisostomo per via deidenti d’oro – così Joyce aveva coabitato con Oliver SaintJohn Gogarty, che porta (Saint John) lo stesso nome di sanGiovanni Crisostomo.
L’Ulisse, d’altro canto, non viene qui citato per caso.Potrebbe servire, a chi soltanto ne leggesse alcune pagine,a provare, lungo le pagine della sua lettura, il sentimentodella dislessia.
La sottovalutazione del corpo, o meglio, la considera-zione del corpo come un peso totalmente dipendente dallearee del controllo nella corteccia, ce lo presenta come unqualcosa di completamente manipolabile e riducibile a uninsieme di meccanismi di funzionamento.
Si tratta di una sorta di collo di bottiglia evolutivo incui, partendo dalle aree più evolute, via via si regredisce inmodo lineare alle aree più primitive, come l’amigdala ol’ippocampo, per ritrovare la nostra natura di animali sem-pre più primitivi in una sorta di archeologia della degene-razione.
Le tecnologie sanitarie faticano enormemente a uscireda questa ipotesi del collo di bottiglia adattazionista.
Per riprendere una distinzione di Bachtin, la terapia,dopo aver attraversato una fase tecnologica e mono-logica,si sta addentrando nella fase di pluridiscorsività. La cura si
PIETRO BARBETTA
trasforma in tempo congiuntivo, nel duplice senso di tem-po per l’incontro tra persone e di apertura disposizionale amondi possibili. Bachtin (1979, p. 274) critica in modo ef-ficace le teorie strutturaliste:
Nella linguistica trovano tuttora cittadinanza finzioni comel’“ascoltante” e il “comprendente” (…). Nei corsi di linguisti-ca generale (…) spesso si raffigurano con uno schema didatti-co i due partner della comunicazione verbale: il parlante e l’a-scoltante (…) si schematizzano cioè i processi attivi del discor-so (…). Non si può dire che questi schemi siano erronei (…)ma, quando vengono fatti passare per la reale totalità della co-municazione verbale, essi diventano una finzione scientifica.In effetti, l’ascoltante, percependo e comprendendo il signifi-cato (linguistico) d’un discorso, contemporaneamente assumenei riguardi di esso una posizione responsiva attiva: è in accor-do o in disaccordo (del tutto o in parte), lo integra, lo applica,si prepara ad eseguirlo, ecc., e questa posizione responsivadell’ascoltante si forma nel corso di tutto il processo dell’a-scolto e della comprensione, fin dal suo inizio (…).
La critica di Bachtin è rivolta ai modelli strutturalisti del-la linguistica, ma ha un valore anche riguardo i sistemi di cu-ra, purché essi non vengano ridotti ai sistemi di aggiustaggioimplicati nel concetto adattazionista di guarigione.
Il racconto della donna che dissolve la dislessia graziealla danza non è il racconto di una malattia che guariscegrazie a un intervento tecnologico mirato: è il racconto diuna contaminazione culturale che permette alla persona ditrovare una congiunzione imprevista, un po’ come nelledescrizioni proposte da Telmo Pievani nel saggio prece-dente a proposito dell’evoluzione biologica.
Falsa memoria e referenzialitàIl secondo caso clinico riguarda Paul, un giovane pazien-
te neuroleso che rimane impigliato nel gioco referenziale.Il triangolo semiotico è notoriamente controverso.
Ognuno, su quei tre vertici, ci ha messo un po’ del suo.Diciamo che, per pacificarsi le coscienze e per facilitarsi
BRICOLAGE E DEGENERAZIONI
la vita, i più ci hanno messo la triade segno-significato-referente.
Non v’è alcun dubbio che una tale soluzione, oltre a es-sere ovvia, ci permette di costruire un sistema logico for-male con referenzialità binaria: vero/falso.
Nello stesso tempo questa soluzione ci permette di met-tere sotto controllo la realtà, perché il linguaggio diventauno strumento di verifica: “c’è del formaggio nel frigorife-ro”, basta andare a controllare.
- C’era del formaggio nel frigorifero, ce l’avevo messo io, oranon c’è più. Qualcuno l’ha preso?- Sì, l’ho mangiato io stanotte.
Tutto a posto. Mi posso arrabbiare perché con quel for-maggio dovevo farci qualcosa, per esempio mi serviva co-me maquillage. Ma il principio di realtà, fin qui, è salvo.
- Come stanotte! Io quel formaggio l’ho comprato stamattinaalle 10.- Oh… è vero, l’ho mangiato a pranzo.- Ma se dobbiamo ancora pranzare!- Ehm, volevo dire a colazione.- Se abbiamo fatto colazione assieme alle 9 e poi io sono scesoad acquistare il formaggio, mentre tu eri già uscito di casa.- [silenzio]
Pian piano la conversazione si trasforma in un interro-gatorio.
Il referente si trasforma da un comodo e utile espedien-te per risolvere i problemi posti dal triangolo semiotico inun maledetto meccanismo morale, un meccanismo di con-trollo e di emarginazione.
È il caso di Paul. La famiglia di Paul chiede un intervento di riabilitazio-
ne post-traumatica all’unità ospedaliera. Paul fu trovato morente dopo essere caduto da un pon-
te. Non è dato sapere con certezza se si sia trattato di ten-tato suicidio oppure di tentato omicidio, la Magistratura
PIETRO BARBETTA
chiude rapidamente le indagini. Paul viene salvato e, dopoun periodo di degenza ospedaliera, viene dimesso.
Presenta disturbi neurologici post-traumatici e inizia unpercorso di valutazione diagnostica a cui segue una riabili-tazione dell’area del linguaggio.
Secondo la valutazione pre-trattamento, Paul presenta-va competenze adeguate nell’area linguistica e difficoltànell’area della memoria a lungo termine e nelle abilità pra-tico-manipolative.
Presso l’unità di riabilitazione Paul veniva sottoposto,come di routine in questi casi, a una batteria di test e provedalle quali emergevano punteggi patologici in quasi tutte leprove di memoria a lungo termine e lievemente patologicinelle prassie costruttive. I risultati del test d’intelligenza(test di Wechsler per adulti), pur nella norma, fornivanouna notevole differenza tra punteggio verbale sopra la me-dia e di performance ai limiti inferiori della media, e altreprove di intelligenza logica che davano punteggi superiorialla media.
Le conclusioni dell’indagine neuropsicologica eviden-ziavano un grave disturbo della memoria anterograda.Conservate apparivano la memoria procedurale e semanti-ca mentre apparivano compromesse sia la memoria episo-dica che prospettica. Era inoltre presente un marcato diso-rientamento temporale. I test dell’attenzione selettiva risul-tavano nei limiti inferiori della norma e non si rilevavanodeficit a carico dell’attenzione spaziale.
L’indagine ecologica effettuata attraverso questionarisull’efficienza e l’autonomia mnesica, l’efficienza compor-tamentale, la consapevolezza di sé e le attività della vitaquotidiana confermavano i deficit sopra descritti.
Paul presentava una discreta consapevolezza dei suoideficit.
Fin qui, la relazione tecnica riferisce di quanto discre-panti fossero, rispetto al principio del triangolo semioticosegno-significato-referente, le performance del Paul post-traumatico. Riconosce la relazione segno-significato (me-moria semantica) e, in una certa misura, il rapporto signifi-
BRICOLAGE E DEGENERAZIONI
cato-referente (memoria procedurale), ma se si tratta dimettere in relazione i tre elementi, casca il referente. Se ilreferente non esistesse, o meglio, se il referente, anzichéchiamarsi “referente”, si chiamasse “possibilità”, oppure“senso”, i problemi di Paul sarebbero notevolmente ridot-ti. Poi vedremo perché.
Ora introduciamo uno scoop, che nessuna unità di ria-bilitazione è in grado di mettere sotto controllo. La relazio-ne neuropsicologica recitava: “Durante la valutazione il pa-ziente si è mostrato collaborante ma presenta disturbi com-portamentali da disinibizione (ipersessualità ) che spessosono elemento di distrazione”. Paul è degenerato.
Nel corso dei primi due mesi di trattamento Paul avevagià ottenuto discreti miglioramenti nelle abilità mnesiche enell’orientamento temporale.
Tuttavia, quel che succede alle riabilitatrici è il forte im-barazzo connesso con i pesanti e continui apprezzamentisessuali che Paul fa nei loro confronti. Naturalmente ciòsuccede anche al di fuori dell’area sanitaria, in particolarecon le amiche della sorella di Paul che chiameremo Mary.Tanto che la famiglia viene inviata in terapia familiare.
Chi era Paul prima dell’incidente? Paul era un brillantestudente di fisica teorica che stava terminando la laureacon i voti più alti del suo corso. Viveva fuori casa e solo ditanto in tanto tornava a trovare i propri familiari. La sorel-la studiava antropologia e viveva in famiglia. Di Paul la fa-miglia pensa avesse una relazione clandestina con una don-na sposata, ma si dice anche che avesse numerose altre re-lazioni sessuali. L’ipotesi dell’omicidio viene avanzata dallamadre di Paul in connessione alla vita affettiva e sessualealquanto travagliata del giovane. Naturalmente Paul nonricorda nulla dell’episodio tragico, né delle circostanzeconcomitanti.
Sta di fatto che Paul, da anni fuori casa e del tutto in-dipendente, con la sua vita privata quasi sconosciuta aifamiliari, tutto a un tratto, dopo l’incidente, ripiomba incasa, in condizione di massima dipendenza e con una di-sinibizione sul piano degli approcci sessuali verso qual-
PIETRO BARBETTA
siasi giovane donna si trovi a incontrare, conosciuta osconosciuta.
Durante il primo incontro di terapia familiare si reca-no al Centro di psicoterapia Paul e i due genitori. È pas-sato un anno dall’incidente. Parla quasi sempre la madreche descrive soprattutto la sofferenza di Mary in conse-guenza dei comportamenti così pesantemente disinibiti diPaul nei confronti delle amiche (e anche di Mary? Di ciònon si parla). Inoltre, sembra che Paul abbia stabilito unrapporto di dipendenza da Mary, la quale non ha più al-cuno spazio per studiare in casa, perché Paul continua a“disturbarla”. Anche durante la notte, Paul la sveglia perparlarle.
Balena l’idea che possa anche proporle sesso, sebbeneciò non venga dichiarato.
Paul cerca di difendersi e di sdrammatizzare. Dice chequesti comportamenti sono la conseguenza della gioia divivere di una persona che sente che Dio gli ha dato unasorta di seconda vita. Anche Paul, come il presidente Sch-reber, sembra fondere caritas e concupiscentia.
A un secondo incontro vengono invitati solo Paul eMary, quindici giorni dopo.
L’incontro viene fatto in un’altra stanza del medesimoCentro, per permettere alla riabilitatrice di Paul di assisteredietro uno specchio unidirezionale alla conversazione, co-me concordato con Paul.
Riporto qui alcune sequenze di conversazione tra me(T), Paul (P) e Mary (M).
T. - Paul le ha detto qualcosa dell’incontro dell’altra volta?M. - Sì, qualcosa, ma è abbastanza dura portarlo perché nonvuole venire.T. - Allora, Paul, lei si ricorda un pochino quello di cui abbia-mo parlato l’altra volta?P. - No, questo è il punto, no. E quindi perché mi serve, tantoqua dopo cinque minuti non me ne ricordo più!T. - Dopo cinque minuti?P. - Più o meno [fa segno con la mano].T. - Questo però è da vedere… lei non ricorda proprio niente?
BRICOLAGE E DEGENERAZIONI
P - No, non è così. Tipo, una stupidata… la sua faccia la ri-cordo benissimo.T. - Perfetto, è già qualcosa… qualche altro ricordo?P. - [indica vari oggetti] L’ufficio, le sedie, i giochi, i giocatto-li, il tappeto, lo specchio, le telecamere, benissimo, i quadri diKandinskij benissimo…
Nessuno dei ricordi di Paul può essere vero dal puntodi vista referenziale, noi l’altra volta eravamo in un’altrastanza dove niente di quanto ricordato da Paul, a parte me,era presente.
Di qui in poi si dipana una conversazione a doppio co-dice. Un codice adattivo e un codice exattivo. Ho numeratole sequenze conversazionali a seconda che appartengano alcodice adattivo (numeri dispari) oppure al codice exattivo(numeri pari). Il lettore potrà scegliere di leggere le sequen-ze in ordine di numerazione (1, 2, 3, ecc.) passando da uncodice all’altro e osservandone l’imbricazione, oppure dileggere le sequenze così come le ho disposte, separando leparti adattive da quelle exattive. Gli effetti della lettura diquesta conversazione appariranno assolutamente diversi.
Codice adattativo 1T. - Secondo lei [rivolto a Mary], Paul che difficoltà ha a livel-lo di memoria?M. - Allora, primo non vuole ricordarsi tante cose e secondome mente spudoratamente, perché si ricorda solo quello chevuole lui… Ho notato anche in casa, nelle cose in cui viene ri-preso, magari abbiamo una discussione e chissà perché dopocinque minuti si dimentica. Quindi secondo me si ricorda so-lo quello che vuole lui. Capisco che certi problemi effettivi dimemoria li ha, però per tante cose fa finta.3M. - Anche quando dice che si ricorda.T. - Per esempio?M. - [Guardando Paul negli occhi] Per esempio, sì, magari fafinta di qualcosa… Gli chiedo una cosa… non so, adesso, adesempio, sta facendo delle cose con il computer, un piccololavoretto e gli chiedo “L’hai fatto?”; “Sì sì ricordo benissimo,
PIETRO BARBETTA
ho fatto questo e quello e quest’altro”. No, assolutamente, lamaggior parte delle volte non è vero, ha fatto la metà di quel-lo che dovrebbe fare e lo dice solo perché così poi è a posto.5M. - Sì, però in quel caso lì, secondo me, è proprio una situa-zione di comodo, perché non gli costerebbe niente dire “nonmi ricordo”, oppure “vado a controllare sul computer dueminuti che cosa ho fatto”, ma non lo fa perché così è a postoe non gli dice niente nessuno.T. - Invece se dicesse “non mi ricordo”, cosa succederebbe?P. - Diciamo la cosa che voglio, io voglio essere tranquillo.M. - Sì infatti lo ripete sempre che vuole essere tranquillo…però Paul [scuotendo la testa e guardandolo] …boh.T. - Cioè, se lui non si ricordasse, in che senso non sarebbetranquillo? Chi è che non lo lascerebbe tranquillo?P. - No, no.M. - No, ma è perché noi cerchiamo sempre di fargli ricorda-re le cose. Magari gli dico “Va be’ non ti ricordi”, allora glielodico io, e vedo se dicendoglielo lui ricorda.P. - Sì ma io non sono un bam…M. - E invece lui non si ricorda.7T. - Per esempio, Mary, quali sono secondo lei le cose che luiha ricordato effettivamente e su quali invece si è sbagliato ri-spetto all’incontro precedente?… Se dovesse fare un’ipote-si…provi a pensarci…M. - Assolutamente si è dimenticato, tra virgolette, il discorsoche avete fatto con mia mamma… mi ha detto mia madre chele ha spiegato che era abbastanza arrabbiata con lui… quello,chissà perché, se l’è dimenticato… invece si ricordava il postodove eravate venuti, si ricordava lei, mi ha descritto lei, lastanza e tutto quanto…9T. - …dice le bugie, in un certo senso.M. - Alcune volte va beh… lo capisco, altre volte mi sembraproprio che menta proprio spudoratamente… non so perché.11M. - Per me adesso si rende conto abbastanza tanto, per mesì. Infatti, mi sembra proprio che non si sposta da questo si-stema qua, proprio per una situazione di comodo, soprattuttoadesso che ha più responsabilità rispetto a solo sei mesi fa.
BRICOLAGE E DEGENERAZIONI
T. - Cioè lei ipotizza, in pratica, che lui adesso è normale,però fa finta…M. - No, non proprio così. Io mi rendo conto che ha ancoratante difficoltà a ricordarsi, infatti non è che gli sto addossoproprio, tante volte lascio passare…P. - Più o meno…M. - [ride] …però insomma, certe volte…T. - Bisogna capire bene se ci sono delle ragioni, o se ci sonosempre delle ragioni, di comodo perché lei [rivolto a Mary]dà un po’ questa spiegazione…M. - Sì, secondo me il settanta per cento delle volte sì, adessoper me sì. Infatti, appena glielo faccio notare, mi salta addos-so subito, sembra proprio un atteggiamento abbastanza di-fensivo.T. - Cioè lei dice: “se lui si è dimenticato qualcosa dell’incon-tro dell’altra volta è perché gli fa comodo”.P. - No, no.M. - Sì, secondo me sì, perché vuole dimenticarsi certe cose.Come quando appunto ha dei compiti a casa da fare. O ti di-ce che li ha già fatti, senza controllare, o inventa scuse su scu-se pur di non farli… Proprio queste responsabilità che haadesso lui, niente, le vorrebbe cancellare.13M. - Però…tante volte ho proprio questa sensazione.
Codice exattativo 2T. - Secondo lei [rivolto a Mary] Paul, come dire… lei ha usa-to la parola “mente”, soltanto quando dice che si dimentica oanche quando dice che si ricorda?[Paul e Mary si guardano, Paul ride]4P. - Oppure un quarto, ma io riempio le cose che non mi ven-gono secondo la mia logica [indicandosi la testa].T. - Riempie le cose che non si ricorda secondo la sua logi-ca…M. - Sì, sì…T. - Cioè. Lei dice, “Io, per esempio, a un certo punto devodarmi delle spiegazioni di quello che succede”…P. - Sì, sì…T. - “Io so che sono stato qui”, per esempio…
PIETRO BARBETTA
P. - …Sì, ma non sono delle spiegazioni che rimangono sem-pre, sono solo temporanee, dopo un attimo, un’ora, cambia-no…T. - Sì, sì…6P. - Non sono un bambino, ormai una certa psicologia di basel’ho sviluppata.T. - Certo…P. - E uso quella.T. - Certo, è lì il contrasto, è sul fatto che lei, da una parte unacerta psicologia di base l’ha sviluppata, però dall’altra ha mol-ti problemi di memoria… ogni tanto riempie…P. - Sì, manca… capisco benissimo che il mio discorso è unpo’ strano, un po’ pieno di parole grosse, però… al massimolo correggo.8T. - Quale stanza?M. - Questa… non so se era questa, boh? [guardando Paul], miha descritto tutto un po’… e poi mia mamma mi ha detto disì…P. - La stanza dell’altra volta è questa.M. - …mi ha detto che era tutto vero, adesso non mi ricordobene, però si ricordava piccole cose piuttosto superficiali,mentre invece quella cosa lì… ad esempio, quando l’ha dettamia mamma, lui subito “non mi ricordo” e basta, chiuso.T. - Quello che a me colpisce è che Paul dice una cosa inte-ressante, dice: “In un certo senso io devo dare delle spiega-zioni. E siccome dal punto di vista logico funziono abbastan-za bene, do delle spiegazioni provvisorie. In che senso provvi-sorie… nel senso che, siccome dal punto di vista della memo-ria non mi ricordo, allora devo riempire, ha usato questa pa-rola, ‘riempire’, di contenuti. E quindi do delle spiegazioniprovvisorie”. E questo a lei sembra che…P. - Dico la…10P. - …Dico la… tranne in certi casi… però di solito dico lacosa più plausibile.M. - Però secondo me lui si rende conto che mente, perchétante volte non riesce neppure a finire le frasi che scoppia aridere… [Paul ride e si copre il volto con le mani…] È ve-ro…
BRICOLAGE E DEGENERAZIONI
P. - No non è così, tante volte mi rendo conto che proseguo…T. - Certe volte si rende conto che sta dando delle spiegazioni…P. - …Sì, assurde…T. - Assurde, quindi le viene da ridere.M. - Spesso perché poi amplia le cose in modo abbastanza[ride]… cioè si capisce insomma che sta mentendo…T. - Secondo lei [rivolto a Mary] fino a che punto si rendeconto/non si rende conto? Adesso lei usa questa parola,“mentire”, no?M. - Sì.T. - Però lui ha usato un termine diverso che è “dare dellespiegazioni provvisorie”… Fino a che punto si rendeconto/non si rende conto di questo?P. - Sì.T. - “Riempire con delle spiegazioni provvisorie”… Fino ache punto si rende conto/non si rende conto di questo?12T. - Sentiamo Paul. Delle cose che mi ha detto… lei mi hadetto prima “Mi ricordo una serie di cose della seduta prece-dente”, quali sono le cose che si è inventato?P. - Niente!T. - Niente.P. - Ho detto quello che mi ricordo…T. - Mmh... che cosa si ricorda?P. - La sua faccia, la stanza, i quadri, i giocattoli…T. - E poi?P. - E poi basta…T. - Lei mi ha detto anche il microfono e la telecamera…P. - Sì, la telecamera, esatto…T. - Allora quale ragione ci sarebbe per cui lei mi dice che siricorda i quadri, i giochi, questa stanza, la telecamera… se noil’incontro, l’altra volta, l’abbiamo fatto di là, nello studio del-la mia collega?M. - [ride]P. - Sììì!? Non ho mai visto questo!? [ridendo]T. - Non ha mai visto questo… Mary, qual è il comodo?M. - No, magari in questo caso… non so.T. - Come lo spiega? [rivolto a Mary]M. - Io ammetto che tante volte…P. - Eh!M. - Non lo spiego...
PIETRO BARBETTA
T. - Cioè, c’è dietro qualcosa di comodo?M. - No, in questo caso credo proprio di no. Poi anche perme, tante volte penso proprio di sbagliarmi e infatti sono ab-bastanza aggressiva nei suoi confronti…
Ho definito il codice delle sequenze numerate con cifredispari come adattativo perché il tentativo di recupero allanormalità avviene attraverso un meccanismo istruttivo.Certamente questo meccanismo ha a che fare con il concet-to stesso di ri-abilitazione. La ri-abilitazione nelle praticheodierne è egemonizzata da modelli cognitivo-comporta-mentali di tipo rieducativo. Consiste, in gran parte, di eser-cizi ripetitivi che assegnano compiti da svolgere e di valuta-zioni lineari sui compiti eseguiti.
Si tratta di un modello che ha risvolti nella relazione trala riabilitazione e la famiglia. Si assegnano compiti al pa-ziente attraverso il controllo familiare. I familiari vengonoimpegnati in pratiche, spesso faticose, di supervisione degliesercizi che il paziente deve fare a casa, al fine di poterprogredire verso un ritorno alla normalità.
Il codice delle sequenze numerate con le cifre pari, cheho definito exattativo, si fonda invece sulla curiosità riguar-do ai modelli creativi che il paziente mette spontaneamentein atto per cercare di trovare una propria equilibrazione in-torno a nuove modalità di relazionarsi con il mondo.
Non è detto che, in questi tentativi creativi, il pazienteottenga immediatamente risultati apprezzabili. Spesso sitratta di annaspamenti, tentativi, prove basate sulle compe-tenze e sulle risorse che il paziente sente di mettere in atto,che sono i suoi punti di forza, per recuperare i deficit neu-rologici.
Il primo approccio corrisponde alla scomposizione de-gli esercizi in termini di corrispondenza tra area cerebraledanneggiata e insieme di competenze perdute o deficitarie.Un modello analitico e tecnologico che risponde all’ideadell’intervento mirato alla guarigione.
Il secondo approccio ha invece a che fare con il concet-to di scienza romantica (Capararo 2003); il paziente non
BRICOLAGE E DEGENERAZIONI
viene ridotto all’area cerebrale danneggiata, ma è una per-sona intera, che vive una vita in un contesto familiare, inun’ecologia esistenziale, con un passato, un presente e unfuturo.
La conversazione mostra il contrasto tra questi due ap-procci.
Il codice adattativo, quantitativamente prevalente nellaprima parte del dialogo, cede, pian piano, il posto al codiceexattativo. Quest’ultimo permette di mobilitare nuove ri-sorse nel momento in cui la sorella di Paul rimette in que-stione le proprie emozioni. Mary non è più solo l’istruttoreperfetto di un Paul deficitario, diventa una persona in car-ne e ossa, che soffre nel vedere il proprio fratello ferito gra-vemente.
A questo punto della conversazione, Mary racconta del-l’imbarazzo verso le sue amiche per i comportamenti delfratello e del dolore che prova nel vedere come il fratello sisia trasformato.
Durante il colloquio, Paul presenta una situazione difalsa memoria. Ricorda la stanza, i quadri appesi, il vetrounidirezionale e la telecamera. Tutto ciò viene elencato daPaul, senza che sia necessario fare domande specifiche.Presenta, in altri termini, una narrazione del tutto convin-cente e coerente.
Semplicemente lui non poteva avere visto né la teleca-mera, né quella stanza (la stanza del primo incontro era no-tevolmente più grande), né i due quadri. Questo peròMary non poteva saperlo. Dunque, mentre Paul parlava,Mary raccoglieva conferme della propria convinzione chePaul aveva recuperato gran parte delle sue competenzemnestiche e che le nascondeva solo quando gli faceva co-modo. Almeno fino al momento in cui il terapeuta rivela lafalsa memoria.
D’altro canto Paul non aveva ricevuto alcun danno alsenso dell’ironia, né tanto meno alla capacità di configura-re un intrigo narrativo.
Grazie a questa competenza Paul compie la stessa ope-razione descritta da Nadine Gordimer (1995, p. 16) a pro-
PIETRO BARBETTA
posito della narrativa di finzione: sebbene non colga l’in-sieme degli elementi che costituiscono gli eventi “realmen-te accaduti”, coglie il “campo di trasformazioni”, “il giocodelle congetture”.
In altri termini, Paul non aveva perso la sua competenzanarrativa, e il fatto di non raccontare cose corrispondenti aifatti “realmente accaduti” non sembrava turbarlo molto.
Al triangolo semiotico segno-significato-referente, Paulera stato costretto a sostituire un triangolo più tollerante,segno-significato-mondi possibili.
La cosa era però fonte di grande turbamento per la so-rella, per il resto della sua famiglia, per gli amici, per ilmondo reale, che si vedeva quotidianamente negato da unmondo di fiction.
Mary ascriveva questa condotta alle pratiche di perditadi dignità e considerava ancor più doloroso il fatto chePaul non se ne facesse in alcun modo un problema. Ilmondo reale fa della referenzialità una questione morale,non può accettare descrizioni troppo distorte, troppo de-generative, non può capire.
Paul ripeteva spesso: “Per me essere qui adesso è già unagran cosa, è come se Dio mi avesse permesso di resuscitare,come se mi avesse dato ancora una possibilità dopo la fine”.
In un’opera di Frank Kermode (1967, pp. 36-37), Thesense of an ending, l’autore si riferisce al poeta Wallace Ste-vens, scrivendo:
(…) “la credenza finale deve essere in una finzione”. Questopoeta (…) vide che pensare in questo modo era posporre lafine per sempre: quando si può dire che la finzione corrispon-da alla realtà. Fare di ciò una finzione, un momento immagi-nario dove “al termine” il mondo dei fatti e il mundo dellafinzione saranno uno solo (…) una tale finzione della fine ècome l’infinito più uno e i numeri immaginari in matematica,qualcosa che noi sappiamo non esistere, ma che ci aiuta a darsenso al mondo e a muoverci in esso.
Quando si parla della coincidenza tra finzione narrativae realtà fattuale in connessione con alcune invenzioni ma-
BRICOLAGE E DEGENERAZIONI
tematiche, come ad esempio i numeri immaginari, si co-struisce un gioco linguistico all’interno del quale una per-sona come Paul, benché profondamente trasformata dauna violenta discontinuità, tuttavia conserva una traccia dicontinuità. Un po’ come quando, nel film Il pianeta dellescimmie, il personaggio interpretato da Charlton Eston, infuga dalle scimmie che dominano il pianeta sul quale è ro-vinata la sua nave spaziale, si accorge – quando scopre, se-misepolto dalla sabbia, un grosso frammento della statuadella libertà – che quel pianeta non è altro che la Terra.
In questo senso, il problema della riabilitazione di Paulè, direbbe Wittgenstein (1953), un problema etico. Si “av-venta contro i limiti del linguaggio”; il suo rientro nel con-sorzio umano avviene avendo perduto la competenza so-ciale a segmentare la realtà (Whorf 1956) secondo i giochilinguistici della sua comunità.
La vita quotidiana non può accettare con facilità la pre-senza di differenti forme di segmentazione della realtà; inquesto senso, la riabilitazione di una persona neurolesapuò essere paragonata al rientro a casa di una persona mi-grata all’estero per molto tempo. Il suo rientro lo porrà inuna condizione ormai a disagio.
La trance e la scrittura, il delirio come gioco linguisticoermetico
Tuttavia la discontinuità non ha sempre un caratteremateriale e traumatico, può essere anche un evento imma-teriale. Qualcosa di misterioso – un’idea, una suggestione –si impadronisce della persona e la trasforma. L’idea delpresidente Schreber – presidente della Corte d’Appello diDresda nel 1893 – fu come dovesse essere bello essere unadonna che si fa fottere. Una ben strana idea per un presi-dente di Corte d’Appello tedesco a fine Ottocento.
Si sa che la psicoanalisi, ai suoi esordi, considerava lepsicosi come patologie inguaribili. Il presidente Schreber èinfatti oggetto di analisi indiretta.
Si tratta dell’analisi dell’autobiografia che Schreberpubblicò (Schreber 1955).
PIETRO BARBETTA
Schreber era convinto che Dio lo stesse trasformandoin donna, per una missione salvifica nei confronti dell’uma-nità intera. La follia di Schreber potrebbe essere letta comeuna contestazione del concetto di amore in Agostino. Egliafferma infatti che la beatitudine è, almeno parzialmente,un “sentimento di voluttà estremamente intenso”. SecondoFreud (1943, pp. 237 sgg.) si tratterebbe di una “sorpren-dente sessualizzazione della beatitudine celeste” legata allacondensazione di due significati del termine tedesco Selig:“defunto” e “sessualmente felice”. La qual cosa richiamaalla mente di Freud il duetto “Là ci darem la mano” delDon Giovanni di Mozart.
Nel caso di Schreber, il delirio è connesso con unagrandiosa visione mistica e cosmica del creato scandalosa-mente inaccettabile da parte dei credenti.
Non sempre, ovviamente, il delirio si esprime in terminicosì grandiosi. Nella maggior parte dei casi si tratta di teo-rie che coinvolgono soltanto la persona che esprime il deli-rio ed eventualmente la cerchia delle persone intime o conle quali entra in contatto.
D’altro canto, la teoria di Schreber rappresenta ilpunto di arrivo di un processo incominciato anni prima.L’esordio di questo processo, in termini psichiatrici, vie-ne definito con il termine di “scompenso”. Lo scompen-so, o esordio psicotico, è l’episodio discontinuo che vie-ne individuato come una sorta di conversione. Ha, nelladescrizione che viene spesso fatta, tutta una serie di ca-ratteristiche che lo accomunano alle grandi conversionireligiose.
Valga per tutte la conversione di san Paolo.In questo senso, lo scompenso/conversione necessita di
una doppia descrizione in cui i verbi e gli aggettivi chiavesono l’elemento differenziale. Nei colloqui con le personepsichiatrizzate, il momento dello scompenso/conversioneviene spesso descritto con estrema lucidità, come nel casodi Giacobbe Liberati3.
Dodici anni dopo quell’evento, Giacobbe – pazientepsichiatrico con diagnosi di schizofrenia paranoide/interes-
BRICOLAGE E DEGENERAZIONI
sato all’ermeneutica biblica – ci raccontò che, nel suo caso,lo scompenso/conversione avvenne nella palestra del liceoche allora frequentava.
Si stava allacciando le scarpe da ginnastica e pensavache di lì a poco sarebbe andato in bagno a masturbarsi,quando alzò la testa e vide un suo compagno che lo guar-dava con disapprovazione.
Improvvisamente si convinse/si accorse che il compagnostava leggendo il suo pensiero e pensò/capì che, da quel mo-mento, chiunque avrebbe potuto leggere il suo pensiero.
Giacobbe era rimasto impigliato nel suo delirio in mo-do da non riuscire più a disincagliarsene; io e i miei colle-ghi di quell’équipe di psicoterapia, dopo tre anni di lavoro,fummo costretti ad abbandonare il campo. Fu solo alcunianni dopo che venni a sapere, attraverso la lettura di unsaggio di Gilles Deleuze, di come una persona simile aGiacobbe Liberati, il newyorkese Louis Wolfson, fosse riu-scita a scrivere il suo delirio in due romanzi: Le schizo et leslangues e Mia madre musicista è morta….
Wolfson, che si definiva jeune homme schizofrenique, oétudiant de langues schizofrenique, viveva nel cuore di NewYork rifiutandosi di parlare l’inglese e persino di ascoltarechiunque parlasse inglese; di qui i suoi due romanzi scritti infrancese. Allo scopo di evitare di sentir parlare inglese, Wolf-son si era munito di una radiolina sintonizzata su trasmissioniin lingue straniere e collegata in qualche modo con uno steto-scopio. Deleuze (1993, p. 24) parla a questo proposito diWolfson come di colui che aveva inventato il walkman.
Se è esatto che mette a punto questo dispositivo fin dal 1976,molto prima della comparsa del walkman, si può ritenere, co-me lui afferma, che ne sia stato il vero inventore e che, per laprima volta nella storia, un bricolage schizofrenico sia all’orfi-gine di un apparecchio che si diffonderà nel mondo intero erenderà a sua volta schizofrenici popoli e generazioni.
I giochi linguistici di Wolfson vengono in parte esplici-tati da lui stesso durante un’intervista rilasciata dopo la
PIETRO BARBETTA
pubblicazione della sua seconda opera – Mia madre musici-sta è morta… – a Anne Leguil-Duquenne (Wolfson 1984,pp. 201 sgg.).
Il titolo di questo libro mette in evidenza la straordinaria pos-sibilità d’allitterazione sulle circostanze della sua [di mia ma-dre] morte. In base ai miei calcoli, questa allitterazione avevauna sola possibilità su molti milioni di verificarsi, come si hauna sola possibilità di vincere alla lotteria. Come se si trattas-se di qualcosa di divino: infatti mia madre, che era musicista, èmorta – tutte queste parole cominciano per m – a Manhattan– ancora m – a metà maggio, a mezzanotte, tra martedì e mer-coledì e si diceva che avesse un mesotelioma, e si muore dicancro per metastasi – mesotelioma metastatizzante – per dipiù all’ospedale Memorial di New York.
Deleuze – nel saggio Schizologie, che funge da introdu-zione a Le schizo et les langues – prende in considerazionealtri giochi linguistici costruiti sull’uso di una pluralità di lin-gue (francese, tedesco, ebraico, a volte russo, oppure yddi-sh) al fine di trasformare l’inglese in qualcosa di accessibileal giovane uomo schizofrenico; come la trasformazione didon’t trip over the wire – non inciampare sul filo – in tu’nichttrébucher üeber èth hé Zwirn. Frase in cui si alternano partidi frasi in tedesco (tu’nicht), francese (trébucher), di nuovotedesco (üeber), ebraico (èth hé) e ancora tedesco (Zwirn).
Gli studi sulla lingua schizofrenica sembrano riprodur-re, come in una sorta di ologramma, il dibattito Bateson-Haley a cui ci si riferisce nella prima parte di questo stessosaggio.
Haley, infatti, nel 1959 – probabilmente nel pieno dellapolemica con Bateson – descrive in termini strategici il lin-guaggio schizofrenico. Secondo Haley, dietro l’apparenteincongruenza dell’insalata di parole schizofrenica c’è unastrategia relazionale che caratterizza la schizofrenia comemalattia mentale. Si tratterebbe di portare fino in fondo lastrategia di evitare di definire la propria relazione conun’altra persona. Haley (1959, p. 327) descrive questa stra-tegia nel seguente modo:
BRICOLAGE E DEGENERAZIONI
Dal momento che tutto ciò che egli dice o non dice definiscela sua relazione, [lo schizofrenico] dovrebbe qualificare conuna negazione o un diniego qualsiasi cosa dica o non dica. Al-lo scopo d’illustrare i modi con cui egli potrebbe negare isuoi messaggi, possiamo scomporre le caratteristiche formalidi qualunque messaggio inviato da una persona a un’altra inquesti quattro elementi:1) Io2) sto dicendo qualcosa3) a te4) in questa situazioneUna persona può evitare di definire la propria relazione ne-gando uno qualsiasi o tutti e quattro questi elementi.
Si tratta, come si può ben vedere, di una riduzione scar-na ed essenziale. Secondo Haley, lo schizofrenese sarebbeinteramente riducibile a una strategia di radicale diniegodella relazione.
Mi pare invece che l’interpretazione di Deleuze siorienti verso un modello di spiegazione locale, che nonpuò fare a meno della storia di vita della persona, delsuo stile di scrittura e di comunicazione, degli episodipresi in considerazione, degli atti linguistici che, voltaper volta, vengono proferiti. Deleuze si orienta dunqueverso un’ermeneutica basata sulla molteplicità e l’impre-vedibiltà dei giochi linguistici, un’ermeneutica dellapoiesis.
Jakobson (1976, p. 57), nell’analisi del linguaggiopoetico di Hölderlin, si orienta nella medesima direzionedi Deleuze. Nel capitolo Tecnica verbale e linguistica del-la schizofrenia del saggio Hölderlin. L’arte della parola,Jakobson osserva la dicotomia, presente nell’ultimo Höl-derlin, tra “la grave perdita della capacità di prendereparte ai colloqui con altri uomini… e il gusto nonché lacapacità – stranamente intatti, anzi accresciuti – perun’improvvisazione poetica agile…”.
Che cosa c’è dunque, secondo Deleuze e Jakobson, die-tro il linguaggio schizofrenico? Leggendo i testi di questidue autori ci si sente come trasportati dentro il meccani-
PIETRO BARBETTA
smo del disvelamento di un rebus. Il buon giocatore, neirebus, è colui che sa connettere, come il bricoleur, elementidisparati per giungere alla soluzione. Il rebus ci trasportain un’atmosfera strana, in cui oggetti del tutto incongruiconvivono in un’unica immagine. Oggetti a cui sono, incerti casi, sovrapposte lettere dell’alfabeto. La frase che sidisvela agli occhi dell’esperto giocatore non ha nulla a chevedere, a sua volta, con gli oggetti o le circostanze che ven-gono presentate nella vignetta.
L’esperto giocatore di rebus utilizza i medesimi stru-menti che, nella tradizione ermetica – dal Corpus Hermeti-cum a Giordano Bruno – hanno dato vita a un modo dipensare legato alla complessità e all’irriducibilità di ciò che“si mostra”, direbbe Wittgenstein, agli schemi logici preco-struiti.
Un modo di pensare e di agire antagonista rispetto alpensiero classico occidentale moderno. Quel modo di pen-sare che, attraverso il Rinascimento italiano (in particolarenella figura di Bruno) ha profondamente influenzato il tea-tro di Shakespeare, o l’opera di Goethe.
Di fronte a quest’arte della memoria e dell’immagina-zione, la scarna riduzione all’essenza del linguaggio schi-zofrenico proposta da Haley si trasforma in un nuovo cri-terio diagnostico per individuare le basi relazionali dellapsicosi. Rimette lo psichiatra in cattedra e gli ridà il pote-re/sapere di decidere intorno alla malattia mentale.
L’ultima storia che mi piace raccontare in questo saggioè quella di Rosa.
Di come fu che Rosa, a un certo punto della sua vita, sifosse trovata di fronte a una suggestione misteriosa, nonvoglio qui narrare. Al lettore basti sapere che ebbe più diuna buona ragione.
Sta di fatto che – un certo giorno, a una certa ora, in-contrando una persona che non aveva mai visto, ma che sa-peva qualcosa di banale rispetto al suo passato – Rosa inco-minciò a perdere l’orientamento, a confondersi, a non ca-pire più che cosa stesse accadendo a lei e intorno a lei:“Come può costui sapere questo di me?”.
BRICOLAGE E DEGENERAZIONI
E poiché Rosa è una persona assai discreta, anziché irri-tarsi apertamente, ne rimase sconcertata e, in un certo sen-so, sconvolta.
Di lì alla consultazione psichiatrica il passo fu breve. Rosa incontra un buon psichiatra, che le prescrive, è ve-
ro, un farmaco neurolettico, ma che l’ascolta e l’accoglieogni volta che lei pensa sia utile fare con lui una conversa-zione. Una persona, prima che uno psichiatra, che forse ri-mane affascinato da lei.
Nel frattempo Rosa intraprende un percorso psicotera-peutico in due fasi: nella prima fase, con una psicologa chela rinforza e la protegge, le dà il coraggio di essere assertivae di poter affrontare questa nuova fase della vita – la sua vi-ta dopo il misterioso evento di confusione – con dignità econ grinta. Poi con uno psicologo che si limita a riconosce-re e ad accettare il suo cambiamento e le sue nuove emo-zioni. Con quest’ultimo, Rosa sperimenta un nuovo mododi gestire le sue invisibili suggestioni: scopre – da sola, lopsicologo le fa solo da specchio, riconoscendo la validitàdei suoi tentativi – che quando ha queste suggestioni invisi-bili può scrivere.
Sperimenta la scrittura in trance, ma non la usa per evo-care spiriti scomparsi, bensì per cimentarsi in un divertentegioco di parole strane e sconosciute. È come se si trovassein uno stato di ipnosi.
Il suo materiale è in gran parte tratto dal linguaggio deisuoi consulenti, ma non è usato più in funzione referenzia-le, cioè nello stesso modo in cui i suoi consulenti ritengonodi usarlo, ma in funzione ludica.
In quel che scrive Rosa non vuol dirci qualcosa sullarealtà scientifica, medica o psicologica che sta là fuori. Alcontrario, gioca gioiosamente con questo linguaggio, dan-dogli connotazioni a volte esilaranti – in terapia si parago-na a Bergonzoni – a volte misteriose – si ispira ad Alda Me-rini – a volte curiose, oppure evocative.
Rimasi talmente colpito dall’ars poetica di Rosa da in-vitarla a provare a pubblicare alcune parti del suo fanta-stico delirio poetico, pur sapendo che una donna che
PIETRO BARBETTA
scrive difficilmente viene compresa. Emily Dickinson in-segni.
Nulla può ormai più togliere valore all’ars poetica di Ro-sa, non certo il mancato riconoscimento di qualche agenteletterario.
Non intendo rubare a Rosa l’autorship del suo lavoro espero vivamente che, in un tempo non lontano, il lettorepossa recarsi in qualche libreria a comprare un suo libro.Tuttavia non posso fare a meno di dare al lettore un’ideadella sua scrittura in stato di trance.
Le spirali hanno movimenti di evoluzione e involuzione. L’at-trito o il cambio di vibrazione scuotono le molecole di tutto ilsistema linfatico, maggiormente localizzato nella parte supe-riore del corpo. Questa contrazione provoca un abbassamen-to di adrenalina e il sistema simpatico per un attimo si altera.Ma una volta invertito il movimento la vibrazione aumenta eil livello del sangue torna alla norma.In qualsivoglia situazione pragmatica o involutiva l’accenno auna sintomatologia di una condizione precoce di instabilitàracchiude nel suo potenziale un’attrattiva alquanto plausibiledi un’enunciazione patologica di accaparramento di dati stati-stici illusori. L’andirivieni di fenomeni soggioganti altera lacorteccia cerebrale in un susseguirsi di immagini illusorie enon reali.
Sulla follia e sui rapporti tra follia e arte/letteraturasono state scritte pagine e pagine da parte di numerosiautori, dall’epoca antica – bastino le lettere sulla follia diDemocrito scritte da Ippocrate, oppure il Problema 30,1sulla melanconia di Aristotele – fino ai giorni nostri. Que-ste considerazioni, che costituiscono un enorme patrimo-nio culturale dell’umanità, sono state sistematicamenteignorate e marginalizzate dalla psichiatria ufficiale.
La ragione principale di questa marginalizzazione con-siste a mio avviso nell’atto di fede che la psichiatria ufficia-le ha, anche recentemente, rinnovato nei confronti di unabiologia riduzionista e lineare. L’unica che può ancora giu-stificare la scotomizzazione delle componenti del nostro
BRICOLAGE E DEGENERAZIONI
funzionamento mentale e dunque considerare l’azione chi-mica sui neurotrasmettitori come elemento risolutivo dellacosiddetta malattia mentale.
In particolare i farmaci più in voga nelle psicosi, i cosid-detti neurolettici, sembrano avere come principale effettoquello di ridurre il delirio. La paura di de-lirare, di usciredal seminato, sembra essere una delle caratteristiche domi-nanti del pensiero tecnologico moderno.
Come ha invece osservato Sass (1992), attraverso un’am-pia documentazione, la caratteristica del delirio è rappre-sentata da una sorta di iper-riflessività. Una sorta di scom-posizione di ciò che, in generale viene dato-per-scontato.L’arte moderna, secondo Sass, presenta precisamente le me-desime caratteristiche della schizofrenia. Non si tratterebbedunque di un degrado, o di una regressione delle funzionimentali dell’individuo; al contrario, di una sorta di freneticosovrafunzionamento del pensiero e della riflessione. Un talesovrafunzionamento è ciò che ci impedisce di stare fermicon il pensiero, che ci sollecita continuamente a rimettere inquestione le immagini, i concetti, le parole. Si tratta di unacontinua arte della scomposizione e della ricomposizione,di una continua pratica di costruzione dell’assurdo, di qual-cosa che, attraverso l’immaginario e il pensiero disposizio-nale ci permette di creare continuamente mondi possibili.
Non credo che questo saggio possa rappresentareun’arte così complessa. Se così fosse, anche lo scrivente po-trebbe, in qualche modo, uscire dalla sua Normalità peravere l’onore di entrare, seppure temporaneamente, nelmondo schizofrenico.
1 Anche Haley era uno psichiatra, mentre Bateson era un antropologo.Inoltre lo stesso Freud, in più di una circostanza, sostiene che il suo linguag-gio mitologico e filosofico sarebbe rimasto valido fino a quando non fosserostate fatte le scoperte biologiche necessarie al suo superamento.
2 Si veda anche la splendida opera di Elaine Scarry (1985) The body inPain. The Making and Un-making of the World.
3 Si tratta di un caso da me descritto in un altro saggio (Barbetta 1998).
PIETRO BARBETTA
Capitolo terzoLa personalità e i suoi disturbi Pietro Barbetta
Sollevare il velo
Gran parte dei ricercatori che si sono occupati dei di-sturbi di personalità hanno concluso che gli individui chesi trovano in queste condizioni raramente vengono a con-tatto con i servizi psichiatrici e ancor più raramente si re-cano dallo psicologo per chiedere una psicoterapia. Si di-ce che i disturbi della personalità stiano, in generale, sot-to il velo della normalità e che si mostrino solo in circo-stanze particolari, ma solo quando le condotte conse-guenti a tali disturbi diventano eclatanti: nei tribunali,nelle carceri, nei servizi per le tossicodipendenze, tra lebande giovanili violente.
Questi almeno sono i luoghi, soprattutto carceri e ser-vizi per le tossicodipendenze, dove i ricercatori fanno ri-cerca. A volte, tuttavia, si scopre che un grande imprendi-tore ha truffato per anni, e per decine di miliardi, i propricreditori; che uno stimato professionista gestiva un traffi-co di cocaina oppure una rete di pedofilia; che un inte-gerrimo uomo politico aveva rapporti con la delinquenzaorganizzata.
Oppure: che famiglie apparentemente del tutto nor-mali sono affiliate alla mafia e in famiglia si pratica l’omi-cidio organizzato in modo professionale; che in altre fa-miglie l’abuso sessuale è una pratica di vita condivisa;che nelle famiglie dei più noti criminali nazisti vigeva unclima sereno.
O ancora: che ci sono persone che fanno la guerra e laconsiderano un’attività professionale, che addirittura ciprovano gusto e passione; persone che fanno il torturatorecon la medesima ottica.
Tutte queste persone non le troviamo ospiti dei servizipsichiatrici, né vanno dallo psicologo. Sono normali.
D’altro canto, questi fenomeni interessano solo margi-nalmente gli studiosi dei disturbi di personalità i quali, ingenerale, si occupano di popolazioni cliniche o carcerarie.Continuano, cioè, a ricercare i disturbi della personalità inambiti nei quali la ricerca diventa una tautologia. Se il di-sturbo di personalità antisociale lo cerco in carcere, lo indi-viduerò nell’80% dei carcerati.
Gli altri fenomeni che ho elencato, normalmente glistudiosi dei disturbi di personalità li considerano affariche riguardano i sociologi, i politologi, gli economisti.Ciò accade in primo luogo perché questi studi vengonosvolti con metodi quantitativi, di taglio epidemiologico,che necessitano di popolazioni numerose, attraverso l’u-tilizzo di reattivi diagnostici che se vengono sommini-strati a un carcerato “sta bene”, ma se vengono sommini-strati a un imprenditore o a un uomo politico “non stabene”.
Vi è però un’altra ragione, più ampia, che riguarda ilvelo della normalità. Il velo della normalità non può esseresollevato con la somministrazione di un reattivo diagnosti-co, è necessario invece uno sguardo critico-interpretativo.
Nel saggio Il discorso filosofico della diagnosi (Barbetta,a cura, 2003) ho tentato di discutere le teorie dominantinel campo delle emozioni e della personalità. Tali teorie so-no sperimentate e largamente condivise dagli etologi (Eibl-Eibesfeldt 1970), dagli psicologi generali (Ekman, Friesen1975), dagli psicologi dello sviluppo (Ainsworth 1967;Bowlby 1988; Sroufe 2000), dagli psichiatri sociali (Paris1996; Eysenk 1977) e da un certo numero di terapeuti fa-miliari (Doane, Diamond 1994). Tutti questi studiosi han-no portato evidenze e “dati” a favore dell’idea che le emo-zioni espresse hanno un’influenza diretta o indiretta riguar-
PIETRO BARBETTA
do la psicopatologia individuale, soprattutto in rapportoalla personalità e ai suoi “disturbi”. A questi “dati” si op-pongono gli psichiatri a orientamento organicista. Coloroche, in sostanza, attribuiscono ogni causa delle condotteumane a variazioni biochimiche. Il disaccordo tra i conten-denti riguarda le “cause”, non l’“esistenza oggettiva”, deitratti e dei disturbi della personalità.
Lo spazio per una riflessione culturale e storica su taliargomenti – dopo la grande esperienza di uno studioso co-me Foucault (1972; 1954) a partire dagli anni Sessanta –sembra limitato a pochi ambiti di carattere perlopiù filoso-fico o antropologico (Boughali 1988; Ehremberg 1998).Ambiti che poco interessano il mondo degli studi clinici eche raramente si trovano in quelle bibliografie.
La contesa è dunque in gran parte ridotta alla discussio-ne sulle “cause” dei disturbi, tra organicisti e ambientalisti.
Un dibattito tra due forme di essenzialismo. Le mie contestazioni alle teorie relazionali delle emozio-
ni e dei tratti di personalità non vanno affatto nella direzio-ne di avvalorare le teorie organiciste. Quel che accomuna idue contendenti è il medesimo modello epistemologico li-neare e universalista.
Lineare perché, per quanto ci si sforzi di argomentareriguardo alla circolarità dei fenomeni causali, tale circo-larità è sempre interna alle dinamiche relazionali interin-dividuali e non mette in questione, se non marginalmen-te, le categorie diagnostiche. Facciamo l’esempio più no-to in psichiatria: si discute se la “schizofrenia” sia gene-rata da un cattivo funzionamento dei neurotrasmettitori,oppure dalla presenza di modelli comunicativi patogeninella famiglia. Ma, se si escludono poche eccezioni (Saas1992; Boyle 1991; Barbetta 1998), non si discutono i para-digmi che conducono la comunità degli psichiatri e deglipsicologi clinici a definire la “schizofrenia”.
Come spiegare il declino della categoria di “schizofre-nia ebefrenica” – oggi definita con il termine “disorganiz-zata” – più o meno parallelo alla crescita delle diagnosi di“schizofrenia paranoide”?
LA PERSONALITÀ E I SUOI DISTURBI
Il termine ebefrenico è stato utilizzato per indicare queltipo di condotte caratterizzate da apparente incoerenza sianell’ambito della conversazione che in quello dell’espres-sione delle emozioni accompagnate da manierismi e dastranezze nel comportamento. Il manuale diagnostico piùin uso descrive laconicamente questo disturbo in tre punti:linguaggio disorganizzato, comportamento disorganizzato,piattezza o inappropriatezza affettiva.
Quali erano gli elementi sociali che organizzavano que-ste condotte quando la categoria di ebefrenia era più diffu-sa? Tra le altre ragioni, ce n’è sicuramente una largamentetrascurata: la categoria di ebefrenia, e anche quella catato-nica, possono essere considerate costruzioni manicomiali,nel senso che si sviluppavano e trovavano un senso com-piuto nell’universo concentrazionario manicomiale.
Invero le schizofrenie ebefreniche, almeno nella descri-zione di Bleuler (1950), altro non erano che “manifestazio-ni autistiche”. Ora, è ipotizzabile che almeno talune diqueste manifestazioni autistiche, che si mostravano nel-l’ambito manicomiale, altro non fossero se non la conse-guenza della vita quotidiana nel manicomio ed è probabileche ciò riguardi pure le schizofrenie catatoniche, anch’essein netta diminuzione dopo la chiusura dell’istituzione ma-nicomiale.
Situazioni del medesimo tipo, infatti, vengono descrittenel dettaglio da autori come Primo Levi (1957) nell’ambitodella vita quotidiana nei campi nazisti.
Di converso, oggi prevalgono le schizofrenie paranoi-che. Non è escluso che questa prevalenza abbia a che vede-re con la riorganizzazione dei servizi psichiatrici. La finedell’istituzione manicomiale ha dato alle famiglie un pesodecisivo nella cura della schizofrenia. In questo caso si assi-ste a una dislocazione del tutto differente delle emozioninell’ambito delle relazioni familiari.
Mentre dentro l’istituzione manicomiale la persona ve-niva schiacciata da un potere medico e concentrazionariosovrastante, in famiglia si costruiscono giochi negozialimeno poderosi, che danno al paziente la possibilità di co-
PIETRO BARBETTA
struire un delirio meno frammentato e autistico. La perso-na trova l’energia di formulare ipotesi deliranti con unacoerenza narrativa. Nascono allora fantastiche idee dicomplotti internazionali, oppure di voci diaboliche, di let-ture del pensiero, ecc. che assumono un carattere narrati-vo tanto affascinante quanto inquietante. Tali ipotesi han-no evidentemente un effetto sugli altri componenti dellafamiglia che, per evitare al paziente di ingigantire il deli-rio, tendono a non dargli informazioni che, pur apparen-do banali per una persona normale, assumono invece, agliocchi del paziente schizofrenico, un significato nella co-struzione del proprio delirio. Il paradosso consiste perònel fatto che l’omissione di tali informazioni non riescemai a essere ermetica, lascia sempre trasparire qualcosa.Così come il segreto è tale perché si mostra come segreto.Tutto ciò, anziché ridurre i temi deliranti, ovviamente liamplifica perché il paziente pensa che se gli altri non vo-gliono che lui sappia qualcosa che lo riguarda, o che ri-guarda la propria famiglia, è perché c’è effettivamente uncomplotto contro di lui.
L’esempio qui proposto intende mostrare come le prati-che sociali che conseguono al dominio teorico di un para-digma psichiatrico tendano a confermare il paradigma do-minante. Se le diagnosi di schizofrenia ebefrenica si ridu-cono a partire dalla fine dell’istituzione manicomiale, men-tre aumentano le diagnosi di schizofrenia paranoide, ciòpotrebbe avere a che fare con il fatto che paradigmi psi-chiatrici diversi costruiscono pratiche sociali che tendono aconfermare i paradigmi di riferimento.
Tutto ciò però non avviene in un solo colpo, bensì in li-nea di tendenza, non senza porosità. Quando le pratichesociali cambiano entrano in crisi parti dei paradigmi, altreparti rimangono in piedi, ma si ristrutturano, così come al-l’inverso, quando cambiano i paradigmi tendono a cam-biare le pratiche sociali, ma non in modo completo. Laforma è: “questa malattia mentale è scomparsa o va scom-parendo, quest’altra va aumentando” ma le ragioni riman-gono misteriose se non si considerano le pratiche sociali
LA PERSONALITÀ E I SUOI DISTURBI
come parte dei paradigmi che costruiscono la malattiamentale. È ovvio, dunque, che scompaiano l’ebefrenia e lacatatonia (sistemi concentrazionari) e aumenti la paranoia(sistemi di comunicazione familiari).
Questo non significa negare l’esistenza dei neurotra-smettitori, ma i neurotrasmettitori costruiscono un sensoall’esistenza umana dentro quadri relazionali, culturali esociali specifici.
Il modello epistemologico prevalente e condiviso daorganicisti e ambientalisti in psicoterapia è, oltre che li-neare, universalista perché, in questa mancanza di pen-siero intorno al paradigma diagnostico, non si discute lacultura occidentale moderna come un modello possibile,e storicamente determinato, di costruzione dei discorsisulle condotte umane, bensì come il modello scientificonecessario al fine di scoprire le forme patologiche di talicondotte.
Si dice così, ad esempio, che la schizofrenia è culturefree perché è una malattia diagnosticata nella stessa per-centuale in tutto il mondo, ma non si dice che, in tutto ilmondo, chi diagnostica la schizofrenia è uno psichiatra,ovvero una persona che aderisce ai paradigmi del discorsopsichiatrico.
In questo approccio epistemologico, l’appendice cultu-rale dei manuali diagnostici registra solamente categorie re-siduali, non ancora completamente colonizzate e si presen-ta come un residuo folclorico di scarsa importanza. Diver-so sarebbe se venissero seguite le raccomandazioni che ilgruppo incaricato alla parte culturale del DSM (Lewis-Fer-nandez, Kleinman 1995) ha indicato e che sono state deltutto disattese dalla task force che ha redatto la quarta edi-zione del DSM1.
Al contrario di ciò, nei modelli esplicativi dominanti siprocede per “strategie della bonifica” (Ceruti 1986), che sibasano sull’idea che la scienza occidentale, procedendo inmodo lineare di scoperta in scoperta, bonifichi i territoridella non conoscenza, trasformandoli in territori cono-sciuti. Si pensa, in altri termini, che le malattie mentali sia-
PIETRO BARBETTA
no dei territori da scoprire. Le medesime strategie sonousate dal colonialismo per bonificare i territori selvaggi eprimitivi.
Avere, per esempio, la prova terapeutica (Ehremberg1998) che i farmaci inibitori selettivi di alcuni neurotra-smettitori riducono la condizione depressiva di molte per-sone che vivono in Europa o negli Stati Uniti significhereb-be saperne di più su quell’insieme di condotte umane chevengono connotate come depressive di quanto Aristotele,circa 2500 anni or sono, non sapesse di quell’insieme dicondotte che descriveva come manifestazioni della malin-conia. O, per fare un altro esempio, l’avere scoperto chel’espressione delle emozioni dei componenti di una fami-glia occidentale è correlato con le recidive psichiatriche diuno dei suoi membri significherebbe saperne di più sullepsicosi dell’area schizofrenica di quanto nel mondo islami-co non si sappia a proposito dei differenti stati di posses-sione in cui può cadere una persona che entra in contattocon un jiin2.
Nel primo capitolo del libro Le radici culturali della dia-gnosi (Barbetta 2003) sostengo una critica a quel tipo diteorie relazionali che definisco “naturaliste”. La premessadi tali teorie risiede nell’idea che l’attaccamento umano siafondato su basi biologiche e che gli aspetti culturali sianosolamente una sorta di sovrastruttura di comportamentiuniversali. In parte, tale posizione può essere ricondotta al-la filosofia del “buon selvaggio”.
Tuttavia, se guardiamo alla personalità come a una co-struzione di senso, assumiamo un’ottica differente, comeafferma Vivien Burr (1995, p. 19):
Non potremo mai provare l’esistenza dei tratti della persona-lità, né dimostrare il contrario. Allo stesso modo non possia-mo dimostrare la “verità” del punto di vista socio-costruzio-nista con un richiamo all’evidenza. Alla fine il nostro obietti-vo potrebbe essere di decidere quale punto di vista offra ilmodo migliore per comprendere noi stessi e gli altri e per gui-dare le nostre ricerche e le nostre azioni.
LA PERSONALITÀ E I SUOI DISTURBI
Dunque, secondo Burr, gli argomenti a favore o con-tro tale scelta sono orientati dalla vita activa (Arendt1958).
La vita activa della psicoterapia, il lavoro quotidiano dipsicoterapeuta sembrano confermare che una visione co-struzionista della personalità è utile a sviluppare, durantela conversazione terapeutica, una decostruzione dei trattiattribuiti alle persone e promuovere una visione fluida del-la persona. La persona, nella conversazione terapeutica, di-venta una narrazione a finale aperto, una polifonia (Bach-tin 1981; Chiaretti, Barbetta 2000).
Al contrario, a mio parere, le premesse epistemologicheche muovono le teorie relazionali “naturaliste” rimangonointerne alle pratiche discorsive sanitarie e non tematizzanogli aspetti culturali relativi alle loro stesse origini. Esse nonpossono sfuggire a numerose obiezioni culturali e cliniche,sebbene tali obiezioni siano obiezioni pragmatiche, cioèobiezioni che non cercano una dimostrazione teorica apodit-tica, ma che si orientano in relazione a questioni pratiche.
Nel seguito di questo saggio proporrò solamente due diqueste obiezioni.
La prima contiene due argomenti che si intrecciano cosìfortemente nella mia esposizione da rendermi impossibilesepararli, l’argomento della triade e quello del paradosso.Infatti le teorie dell’attaccamento, che sono il punto di rife-rimento più in voga tra i sostenitori del “naturalismo rela-zionale”, sottolineano fortemente come la diade madre-bambino (o, come si dice oggi caregiver-bambino) sia es-senzialmente in gioco nello sviluppo psicopatologico deitratti di personalità.
Prima obiezione: la triade e il paradosso
Gli studi sulla triade sono iniziati con l’esame della si-tuazione edipica in psicoanalisi e continuati nelle ricerchesulla personalità autoritaria (Adorno et al., a cura, 1950;Horkheimer 1999).
PIETRO BARBETTA
Possiamo tuttavia dire che la figura del padre è, in uncerto senso, lentamente caduta nell’oblio non solo tra glipsicoanalisti; la prima formulazione della teoria sistemicadel doppio legame era fondamentalmente legata a un mo-dello interpretativo diadico, tanto da far parlare gli psico-terapeuti di “madre schizofrenogenica”.
Lo stesso Bateson (1972), in più di un saggio, sente ilbisogno di una riformulazione del doppio legame.
La sua prima formulazione può essere riassunta in trepunti:
- la madre produce il doppio legame, il padre è margi-nale, il figlio (maschio) è vittima;
- il doppio legame è inevitabilmente patogeno, senza al-cuna possibilità alternativa;
- il doppio legame è una condizione patologica della co-municazione, alternativa a una condizione sana, quella coe-rente, gerarchica e lineare.
Vediamo una per una queste tre considerazioni inco-minciando dalla prima: la madre produce il doppio lega-me, il padre è marginale, il figlio (maschio) è vittima.
Questa considerazione può essere contestata a partiredalla stessa rilettura di un episodio clinico (Bateson1972, p. 262) descritto nella prima formulazione dellateoria:
L’analisi di un incidente accaduto tra un paziente schizofre-nico e sua madre può illustrare la situazione di doppio vin-colo. Un giovanotto che si era abbastanza ben rimesso da unaccesso di schizofrenia ricevette in ospedale una visita di suamadre. Contento di vederla le mise d’impulso il braccio sul-le spalle, al che ella s’irrigidì. Egli ritrasse il braccio, e la ma-dre gli domandò: “Non mi vuoi più bene?”. Il ragazzo ar-rossì, e la madre disse ancora: “Caro, non devi provare cosìfacilmente imbarazzo e paura dei tuoi sentimenti”. Il pa-ziente non poté stare con la madre che per pochi minuti an-cora, e dopo la sua partenza aggredì un’inserviente e fu mes-so nel bagno freddo.
LA PERSONALITÀ E I SUOI DISTURBI
Si possono dare molteplici interpretazioni a questo re-soconto, non ultima quella che vede le ragioni delle con-dotte di questo ragazzo come un effetto delle pratiche re-pressive – il bagno freddo – dell’ospedale.
Tuttavia, l’idea che qui si intende trasmettere al lettoreè che la “schizofrenia” di questo ragazzo sia la conseguen-za del doppio legame comunicativo posto in essere dallamadre in quell’episodio e, per “induzione completa”, negliepisodi che in generale caratterizzano le relazioni madre/fi-glio.
Senza discutere questa indebita generalizzazione, cer-chiamo di analizzare l’episodio “incriminato” nel testo:“D’impulso [il ragazzo] le mise il braccio sulle spalle, alche ella s’irrigidì”.
Che significa che “ella s’irrigidì”? Forse la madre si eraspaventata di quel gesto? Se così fosse, come mai lo spa-vento? Se, per ipotesi, il figlio in passato avesse spaventatola madre mettendole, per esempio, “le mani addosso”, l’ir-rigidimento del corpo della madre non potrebbe avere unsenso differente?
“Egli ritrasse il braccio, e la madre gli domandò: ‘Nonmi vuoi più bene?’”. Come mai “egli ritrasse il braccio”?Nel brano la punteggiatura sembra essere “a causa dell’irri-gidirsi della madre”. Se così fosse, e se la madre si fossespaventata del braccio al collo, il figlio non potrebbe aver-lo tolto per rassicurarla?
Dopodiché la madre gli domanda “Non mi vuoi piùbene?”.
Come mai? Non potrebbe per esempio avere provatodispiacere per aver avuto paura e dunque avere provato aincoraggiare il figlio a rimetterle il braccio sul collo? Secosì fosse, come mai la madre prova paura quando il fi-glio le si avvicina e prova dispiacere quando si allontanada lei?
Nel liberarci da una descrizione comportamentista eoggettivante di questa interazione, cerchiamo di uscire dauna visione lineare, per trovare un punto di vista ermeneu-tico. In questo caso, è necessario lasciare il campo dell’os-
PIETRO BARBETTA
servazione comportamentista “qui e ora” e costruire unanarrazione.
La narrazione di un figlio che spaventa la madre quan-do le si avvicina, forse perché maschio, dunque potenzial-mente violento, in senso sia fisico che sessuale. D’altro can-to a questa madre dispiace di attribuire al figlio queste ca-ratteristiche che la impauriscono, dunque lo richiama, inmodo forse maldestro, a una vicinanza.
Per cercare di comprendere questo fenomeno, e non li-mitarsi a descrivere un’interazione allo scopo di dimostrareuna teoria psichiatrica, dobbiamo introdurre un sistema disignificati ipotetico, un tertium nella diade.
Che ruolo svolge il terzo, il padre, nella costruzione delsistema dei significati di questo gruppo familiare? Se fosse“marginale” quale significato assumerebbe la sua margina-lità?
La seconda considerazione (il doppio legame è inevita-bilmente patogeno, senza alcuna possibilità alternativa)comporta che la comunicazione, per essere “sana”, debbaeliminare i doppi legami, i paradossi e i circuiti riflessivi.
Ben presto Bateson si accorse che il doppio legame è unfenomeno che caratterizza la comunicazione umana in ge-nerale e che può essere fonte di creatività.
Infatti, perché si crei una condizione definita comedoppio legame sono necessari due elementi:
- un messaggio verbale e un messaggio non verbale traloro contrastanti, che si negano reciprocamente,
- l’impossibilità di abbandonare il campo da parte dichi riceve il messaggio.
Questi due elementi impediscono a chi riceve il mes-saggio di poter rispondere senza commettere un errore,lo costringono perciò a trovare una risposta creativa chegli permetta di trasfigurare il contesto. Il de-lirio, seprendiamo il termine in senso etimologico, non è altroche un’uscita dal seminato (Deleuze 1993; Barbetta1998).
LA PERSONALITÀ E I SUOI DISTURBI
Lo spiega Mauro Ceruti (1989, p. 81), uno dei più im-portanti studiosi di Bateson nel nostro paese:
Il fatto che spesso la soluzione creativa di un problema si ma-nifesti in maniera improvvisa, facendo parlare di “insight”,non è un indizio di una presunta preesistenza di tale soluzio-ne, ma dipende proprio dal rapporto fra il processo creativoda una parte e il risultato dall’altra, che è riferibile al modellospecifico qui considerato.Alla base di alcuni processi creativi si possono identificaredunque delle vere e proprie sindromi transcontestuali.
Il terzo punto di contestazione riguardo alle prime for-mulazioni del doppio legame riguarda il rapporto tra pa-tologia e circolarità. Secondo le prime formulazioni del-l’approccio sistemico la patologia nella comunicazionesembrerebbe consistere nella confusione dovuta alla circo-larità tra i contesti. Un messaggio è sempre composto dadue aspetti, il suo contenuto e la relazione tra coloro checomunicano. Quando un messaggio mette in questione larelazione, si rompe la gerarchia tra i contesti. Il contenutodel messaggio non è più comunicato nel contesto della re-lazione e si crea una sorta di indecidibilità su quale deidue aspetti – contenuto e relazione – facciano da contestol’uno dell’altro.
Studi successivi hanno mostrato che le questioni postein quegli anni avevano una maggiore complessità.
Le ricerche di un gruppo di studiosi di Comunicazio-ne dell’Università di Amherst sfociarono in una rielabo-razione del pensiero di Gregory Bateson che mise a pun-to un modello di analisi dei contesti definito CoordinatedManagement of Meaning, gestione coordinata dei signifi-cati.
Secondo questi ricercatori, nel linguaggio quotidianonon esistono comunicazioni che non siano permeate daun certo grado di circolarità. La circolarità è data dall’e-sistenza stessa della comunicazione, è l’aggiunta di signi-ficato che sempre una comunicazione porta con sé, ciò
PIETRO BARBETTA
che Cronen (1991) e colleghi (Cronen, Johnson, Lanna-man 1982) hanno chiamato forza implicativa di un mes-saggio.
Inoltre una comunicazione avviene sempre all’internodi una molteplicità molto più ampia di contesti che non ilcontenuto e la relazione. Tra gli altri contesti, sembrano as-sumere notevole importanza le dimensioni della biografia edel modello culturale, che rivestono ogni rapporto di co-municazione di significati esistenziali e antropologici(Branham, Pearce 1985).
Infine, la comunicazione viene re-interpretata comeun processo sociale di tipo prospettico. In altri termini, isignificati vengono continuamente costruiti in un gioco diinterazioni che prevede tre componenti: il coordinamen-to, la coerenza e il mistero (Pearce 1993). Nel mio lavoropiù recente ho posto l’attenzione soprattutto sul terzoaspetto, quello del mistero (Barbetta 2004).
Lungi dall’essere patologica, la circolarità, dentro que-sta prospettiva, è il motore della stessa comunicazione,produce nuove occasioni d’incontro e di relazione tra gliesseri umani e permette a questi di raccontare sempre nuo-ve storie della loro vita, delle loro relazioni e della loro cul-tura.
Che cosa allora può essere definito come patologico? Amio avviso, sembra esserci un ribaltamento della teoria deldoppio legame. Se il doppio legame è in gran parte sorgen-te di cambiamenti creativi discontinui, ciò che è patologiconon è necessariamente la loro presenza, bensì la loro scar-sità e la loro ripetitività.
Una comunicazione fortemente gerarchizzata, in cui laforza implicativa, cioè la creazione di nuovi significati, vie-ne negata, oppure una comunicazione in cui i circuiti ri-flessivi assumono lo strano aspetto di ritornare sempre alpunto di partenza, inceppa un gruppo umano.
“Essere inceppati” è una metafora che indica l’essereprigionieri del presente, incapaci di uscire dal solco che cicostringe a ripetere ogni giorno lo stesso atto della stessacommedia.
LA PERSONALITÀ E I SUOI DISTURBI
Deleuze sceglierebbe probabilmente questa definizione“incapaci di de-lirare”, di uscire dal solco.
Ma in quest’ottica, ciò che preoccupa di più il terapeu-ta, non è la differenza, la devianza, ma la normalità.
Seconda obiezione: il linguaggio dell’Altro
La seconda obiezione al “naturalismo relazionale” èquella – per usare una felice espressione di Greenblatt(1991) – del linguaggio rapito.
Il “naturalismo relazionale” sembra proporre l’ideache le emozioni siano l’anello di congiunzione tra natura ecultura.
Anche qui il dibattito appare spesso epistemologica-mente ingenuo. Ci si chiede: le emozioni sono naturali oculturali?
E ancora nessuno è giunto a una conclusione convin-cente.
Secondo Morin (1973) il sentimento di attaccamentogenitori/figli è la conseguenza del processo evolutivo diominizzazione, collegabile alla scoperta del fuoco, sia comestrumento di difesa dai predatori, sia come strumento at-torno al quale gli ominidi pre-sapiens si riunivano per scal-darsi e, in questo modo, producevano vicinanza e socialità:il focolare.
Secondo Stone (1977), invece, il sentimento di attacca-mento genitori/figli è la conseguenza di un processo stori-co: nasce con l’affermazione della famiglia coniugale inti-ma, in epoca moderna, a partire dall’affermazione dellamedicina clinica e soprattutto in conseguenza della ridu-zione dei tassi di mortalità infantile e perinatale.
La prima versione connette l’attaccamento con il pro-cesso di giovanilizzazione della specie, il prolungamentodell’infanzia e la neotenia. Secondo l’altra versione, l’at-taccamento è la conseguenza storica della scoperta del-l’infanzia come fase della vita caratteristica dell’epocamoderna.
PIETRO BARBETTA
Ma si parla dello stesso fenomeno? Come viene costrui-ta un’emozione? Si tratta di una questione biologica oppu-re di una questione storica?
Molti studiosi dell’uno o dell’altro campo pongonoquestioni diadiche. Tali questioni parlano, in alcuni casi, diemozioni “primarie” e “secondarie”.
Per esempio, Damasio (1994, p. 195) propone questadistinzione:
Le emozioni primarie… dipendono dai circuiti del sistema li-bico (…). Ma il meccanismo delle emozioni primarie non de-scrive l’intera gamma dei comportamenti emotivi. Esse costi-tuiscono sicuramente il meccanismo di base; io credo che intermini di sviluppo dell’individuo, esse siano seguite dai mec-canismi delle emozioni secondarie, che si presentano una voltache abbiamo cominciato a provare sentimenti e a formareconnessioni sistematiche tra categorie di oggetti e situazioni, daun lato, ed emozioni primarie dall’altro [corsivo dell’autore].
Nella stessa direzione si muovono gli argomenti diSroufe (1996, p. 69), sebbene la sua tematizzazione riguar-di la fenomenologia dello sviluppo infantile anziché lastruttura del sistema nervoso:
(…) i bambini di sei mesi possiedono tutti i comportamentiindividuali che noi abbiamo descritto nelle reazioni dei bam-bini di dieci mesi (…). Non sono le capacità in sé (…) ma ilnuovo livello di complessità dell’organizzazione che megliodescrive il cambiamento evolutivo tra i sei e i dieci mesi. Cosìi bambini di dieci mesi sono capaci di una partecipazione alprocesso sociale che è di gran lunga più attiva [corsivo mio].
Per entrambi questi autori le emozioni primarie, preco-struite o innate, sono una condizione di base, necessariama non sufficiente, per spiegare le condotte umane. A que-ste si connettono, come una sorta di sovrastruttura orga-nizzativa più complessa, le emozioni secondarie, che sonoinscindibili dalla cognizione e dalla consapevolezza. Que-sto secondo aspetto delle emozioni è il frutto di una co-
LA PERSONALITÀ E I SUOI DISTURBI
struzione interattiva e relazionale che, per Damasio, co-struisce l’esperienza personale: “unica, che confeziona ilprocesso per ogni singolo individuo”.
Come osserva ancora Sroufe (1996, p. 78):
Tutto ciò, ovviamente, può comportare dei problemi per chicerca di studiare le emozioni dei bambini, poiché lo stessoevento può portare a reazioni diverse in bambini differenti oanche nello stesso bambino in situazioni differenti. Gran par-te di questa complessità è dovuta alla sensibilità al contestoche hanno i bambini più grandi nell’elaborare il significatodegli eventi.
Entrambe le analisi espongono il carattere di integrazio-ne tra emozioni primarie e sviluppo cognitivo nella costru-zione delle emozioni secondarie. Questo apporto evolutivoe costruttivista, sia in campo filogenetico (Damasio 1994)che ontogenetico (Sroufe 1996), è certamente decisivo eimportante.
A mio avviso però, sia Damasio che Sroufe sottovaluta-no un terzo elemento: il carattere culturale connesso allacostruzione dei significati.
Per Damasio (1994, pp. 189 sgg.)
Nella sua essenza (…) l’emozione è l’insieme dei cambiamentidello stato corporeo che sono indotti in miriadi di organi daiterminali delle cellule nervose, sotto il controllo di un apposi-to sistema del cervello che risponde al contenuto dei pensierirelativi a una particolare entità, o evento.
Ma, se così è, dove finiscono i significati di questo even-to? A mio avviso questa spiegazione sembra dibattersi trala Scilla dell’universalità e la Cariddi dell’unicità delle emo-zioni.
Come spiega Damasio (1996, p. 199) allora che “Le re-lazioni tra tipo di situazione ed emozione sono in larga mi-sura simili per i diversi individui”? [corsivo mio].
Se sono individuali sono assolutamente diverse, se sonouniversali sono assolutamente identiche.
PIETRO BARBETTA
Non si esce da questo dilemma senza introdurre i concetticulturali di “comunità linguistica”, “campo linguistico” e “si-tuazione linguistica” (Hymes 1967), senza, in altri termini,definire in che misura è larga questa misura di similitudine.
Perché questo avvenga è necessario pensare alle emo-zioni come a una costruzione sociale (Harré 1986).
Ugualmente Sroufe (1996, p. 39), nel definire questacostruzione come un processo diadico che successivamentediviene una capacità individuale, sostiene:
(…) la strutturazione e la qualità della regolazione diadicaprecoce rappresentano l’Anlage o il prototipo dell’emergeredell’autoregolazione delle emozioni [corsivo dell’autore].
In questa ipotesi, così affascinante per molti psicologi,si nasconde l’idea che la diade sia una sorta di intercapedi-ne tra il concetto di natura e quello di cultura. Tale interca-pedine è felicemente espressa dal termine inglese nurture(Oyama 1985).
La diade è un luogo protetto, confortevole, caldo emorbido, come la scimmia di pezza di Harlow (1958), nonpuò essere un luogo freddo e ostile, pena la sofferenza del-l’individuo. Ma questa descrizione non è già parte di un si-stema che osserva e descrive la diade? Nel raccontare que-sta narrazione dello sviluppo delle emozioni, non c’è giàsempre un terzo che le racconta?
La mia tesi è che, se questo luogo di protezione e di ca-lore esiste – e io penso, con Edgar Morin (1973), che “esi-sta” come il frutto dell’evoluzione bio-psico-sociale di ho-mo sapiens/demens – esso sta nel linguaggio, nella conver-sazione e nella possibilità, attraverso l’uso del linguaggio inconversazione, di costruire quei momenti evanescenti cheMartin Buber (Anderson, Cissna 1997) chiama dialogo.Quei momenti, a mio avviso, non possono che essere tria-dici e da quei momenti è, a mio avviso, ineliminabile la di-mensione culturale.
Le emozioni possono essere pensate come disposizio-ni, situazioni intenzionali (Harré 1986; Scarry 1985).
LA PERSONALITÀ E I SUOI DISTURBI
Ogni emozione è in relazione con un suo “oggetto inten-zionale”. La paura ci dispone alla fuga, la rabbia all’ag-gressione, la tristezza al pianto e alla disperazione, il di-sgusto alla nausea e al vomito, la felicità al sorriso e allariconoscenza, la vergogna alla reticenza e all’evitamento.Tali azioni sarebbero la conseguenza di cambiamenti de-gli stati interni individuali dovuti a modificazioni neuro-vegetative, a loro volta, queste modificazioni neurovege-tative sarebbero l’effetto di episodi di perturbazione pro-venienti dall’ambiente, ma l’ambiente umano possiede, inprimo luogo, una foggia culturale. Queste perturbazioninon hanno lo stesso effetto individuale su persone diver-se, ma non hanno neppure lo stesso effetto sociale in cul-ture diverse. Harré (1986), nel descrivere fenomenologi-camente le emozioni in base a ciò che chiama il loro “og-getto intenzionale”, pone l’accento sull’importanza deci-siva che ha il vincolo morale e sociale nella costruzionedelle emozioni.
Gli studi di Averill (1984) riguardo all’acquisizione del-le emozioni durante l’età adulta mostrano che in qualsiasimomento, del corso della vita, un individuo può apprende-re nuove emozioni, in relazione ai vincoli e alle risorse co-struiti dal contesto. Un esempio di questo tipo lo possiamoricavare dal disastro aereo di alcuni calciatori uruguaiani.In quel caso la ridefinizione della loro necessità di soprav-vivere, nutrendosi del corpo dei loro compagni di viaggiodeceduti attraverso il discorso sacro della comunione cri-stiana, permise loro di imparare a non provare disgusto eorrore nei confronti delle pratiche antropofagiche che do-vevano esercitare.
Gli studi di Heelas (1986) sulla definizione delle emo-zioni tra le culture analizzano invece la questione dal puntodi vista antropologico. Parlando del termine Liget utilizza-to dagli ilongot, una popolazione asiatica, Heelas osserva lamaniera in cui, per differenza con la cultura occidentale,un’emozione si costruisce.
Liget significa un insieme di emozioni che nelle lingueoccidentali possono essere definite e scomposte in una se-
PIETRO BARBETTA
rie di nomi, ma che, presso gli ilongot, vengono tutte rag-gruppate sotto un unico termine. Così, per esempio, l’emo-zione che provo durante una battuta di caccia è Liget, co-me l’emozione che provo quando vengo offeso, oppurequando mi appresto a una relazione sessuale.
Il linguaggio rapito
Il pensiero occidentale si basa sulla logica formale, i cuiassunti, non ulteriormente discutibili, sono il principio diidentità, di non contraddizione e del terzo escluso.
I logici moderni, a partire da Bertrand Russell, hannotuttavia riscoperto paradossi già posti nel V secolo a.C. daimegarici a proposito del pensiero logico formale.
Tali paradossi giungono alla constatazione che in logicanon si può parlare allo stesso livello di elementi e di classidi elementi. L’esempio megarico è illuminante. Epimenideè un abitante di Creta, un cretese. Ebbene, Epimenide dice“Tutti i cretesi mentono”. La domanda che ci si pone è seEpimenide, nel fare questa affermazione, a sua volta mentao sia sincero. In quanto cretese si direbbe che menta, ma semente, conferma ciò che dice, dunque è sincero, ma se èsincero, in quanto cretese, mente, ma se mente… Così diseguito all’infinito.
Secondo Russell, un tale paradosso si determina perchéEpimenide, un membro della classe di cretesi, viene messosullo stesso piano della classe cui appartiene, i cretesi ap-punto. Ciò in logica formale, secondo Russell, non dovreb-be essere fatto. Tuttavia nel linguaggio quotidiano ciò av-viene costantemente.
Prendiamo, per esempio, una relazione coniugale econsideriamola come la classe di tutte le interazioni traquella moglie e quel marito. Poniamo ora di considerareuna di queste interazioni.
Moglie - Hai comprato una nuova auto senza neppure dirmelo!È possibile che io non conti proprio nulla in questa casa?
LA PERSONALITÀ E I SUOI DISTURBI
Marito - Basta! La nostra relazione non può continuare! Tumi togli la libertà!
È evidente come questo elemento della classe – questainterazione – si confonda con la classe delle interazioni, larelazione coniugale.
In altri termini, nel linguaggio quotidiano, il divieto po-sto da Russell non può essere rispettato.
Ma ci sono ulteriori complicazioni. Insieme alla scoper-ta del paradosso di Russell, Goedel aveva dimostrato cheun sistema di logica formale di una certa complessità è in-trinsecamente incompleto, ovvero contiene in sé un teore-ma che dimostra la sua stessa incompletezza.
Gli studi di logica formale hanno tentato di inserirecorrettivi e di porre rimedio ai paradossi, ai teoremi di in-decidibilità e incompletezza.
Contemporaneamente, tuttavia, autori come Wittgen-stein prendevano atto delle caratteristiche del linguaggioumano. In primo luogo della sua natura non rappresenta-zionale e radicalmente costruttiva. L’asserzione che il signi-ficato di un termine si mostri nell’uso che viene fatto deltermine stesso indica la natura sociale e autoriflessiva dellinguaggio, il quale non rappresenta una realtà là fuori, macostruisce la realtà della quale parla.
In particolare Wittgenstein considerava il suo stessotentativo di determinare la struttura logica del linguag-gio, avvenuto con la stesura del Tractatus Logico-Philo-sophicus, un’operazione etica che tentava di definire i li-miti del linguaggio stesso. Nel Tractatus Wittgenstein sirendeva già conto che questa operazione, l’operazioneche lui stesso tentava, era intrinsecamente impossibile. Inun punto dell’opera, Wittgenstein (1959, 5.631, p. 64)sostiene:
Se io scrivessi un libro “Il mondo come io lo trovai”, vi si do-vrebbe riferire anche del mio corpo e dire quali membra sot-tostiano alla mia volontà, e quali no, etc., e questo è un meto-do d’isolare il soggetto, o piuttosto di mostrare che, in un
PIETRO BARBETTA
senso importante, soggetto non v’è: D’esso soltanto infattinon si potrebbe parlare in questo libro. Il soggetto non appartiene al mondo, ma è un limite delmondo.
Una gran parte delle considerazioni teoriche relative al-le emozioni, non tiene affatto conto di questo limite coltoda Wittgenstein e parla delle emozioni come se fossero deifenomeni extralinguistici. Tuttavia ne parla, ovvero usa illinguaggio per definire fenomeni extralinguistici.
Gli studiosi di etologia umana, ai cui studi si riferisconole ricerche sull’attaccamento, ritengono che l’osservazionedel comportamento umano attraverso lo stesso metodo uti-lizzato per l’osservazione del comportamento animale pos-sa fornire spiegazioni altrettanto generalizzabili e definiti-ve. È sulla base di queste ricerche che Bowlby, e altri stu-diosi hanno tratto la conclusione, per loro definitiva, che ilcomportamento di attaccamento sia altrettanto innato nel-l’uomo quanto il comportamento di nutrizione.
Avanzerò alcune obiezioni metodologiche a tali consi-derazioni partendo da un esempio tratto da uno studio dietologia umana. Un esempio che sembra definire scientifi-camente le emozioni attraverso l’osservazione dei compor-tamenti.
Alle pagine 30 e 31 della mia edizione del volume di Ei-bl-Eibesfeldt (1970) Amore e odio, si trovano disegni divolti di persone impegnate in ciò che Eibl-Eibesfeldt defi-nisce “saluto oculare”.
Così scrive l’autore a tale proposito: “Nel saluto ocularele sopracciglia vengono di colpo alzate per circa 1/6 di se-condo”.
I disegni rappresentano un balinese, un papua woitap-min, una donna francese e un indio waika: tutti sembranoimpegnati precisamente nella stessa attività.
Com’è che Eibl-Eibesfeldt ritiene di poter affermareche queste persone stiano facendo esattamente la stessa co-sa? Ovvero, come può l’autore pensare che il loro gesto ab-bia il medesimo significato?
LA PERSONALITÀ E I SUOI DISTURBI
Prendiamo ora un’interpretazione diversa, che non ri-guarda la presunta universalità del “saluto oculare”, bensìun movimento affine, riguardante anch’esso l’area oculare:la rapida contrazione della palpebra dell’occhio destro.
A questo proposito, Geertz (1987, p. 153) propone diconfrontare il medesimo movimento in due ragazzi, e inprima battuta non c’è neppure bisogno che questi appar-tengano a diverse comunità culturali:
I due movimenti, come tali, sono identici: un’osservazione ditipo meramente fotografico, “fenomenico”, non potrebbe di-re quale sia un tic e quale un ammiccamento, e neanche seentrambi o uno dei due siano tic o ammiccamenti. Tuttavia ladifferenza tra un tic e un ammiccamento, per quanto non fo-tografabile, è grande, come sa chiunque abbastanza sfortuna-to da avere scambiato l’uno per l’altro.
Che cosa manca all’osservazione dell’etologo? Egli dàper scontato il senso di quanto accade: vi è un segno, l’in-nalzamento delle sopracciglia, un significato, il saluto ocu-lare, e un referente, qualcuno che viene salutato da qual-cun altro in quel modo. E questo è tutto. Fine della spiega-zione.
In questo modo l’etologo studia i comportamenti uma-ni come un geologo le epoche di stratificazione del territo-rio e un paleontologo le attribuzioni di un femore a un ani-male preistorico.
Non considera neppure la possibilità che l’uno, il salu-tante, sia in effetti una persona con un tic e l’altro, il saluta-to, una persona che crede di venire effettivamente salutata.Troppa complessità.
Invero, con buona pace per gli studi di Eibl-Eibesfeldt(1970), il semplice innalzamento delle sopracciglia per unistante sembra non avere esattamente il medesimo signifi-cato in differenti culture, anche tralasciando l’esistenza deitic, degli ammiccamenti, dei turbamenti, degli esempi acca-demici a proposito dell’innalzamento delle sopracciglia, evia dicendo.
PIETRO BARBETTA
Per esempio, tra i britannici, sembra avere un signifi-cato del tutto particolare in relazione alla loro identitàpolitica.
Così scrive Elaine Scarry (1985, p. 110) a questo propo-sito: “L’identità politica del corpo viene spesso appresa in-consciamente, senza sforzo e molto precocemente. Si diceche i bambini britannici imparino a tenere le sopraccigliaalzate sin dai primi mesi di vita”.
Una tale abitudine non sembra connessa con qualsiasisaluto, ma in primo luogo con il saluto alla bandiera. Ad-dirittura, sembra che la posizione degli occhi sotto le so-pracciglia alzate sia differente a seconda che la bandierasia la propria o un’altra. In questo secondo caso, gli occhiassumerebbero una posizione che distoglie lo sguardo(Scarry 1985).
Quale dunque il limite della spiegazione etologica di Ei-bl-Eibesfeldt? Egli propone di interpretare un gesto che havalore linguistico usando il linguaggio, ma non consideral’autoreferenzialità della sua operazione. Per lui il referentedi quanto avviene nel “saluto oculare” è esterno al linguag-gio, dunque non ulteriormente interpretabile. È così e ba-sta, come l’affermazione che la dimensione di un uovo distruzzo è maggiore di quella di un uovo di quaglia.
Le emozioni in quest’ottica sono disposizioni che acca-dono agli esseri umani indipendentemente dal linguaggio esolo un esperto può, dall’esterno, conoscere il significato diquanto succede a un essere umano.
Il triangolo semiotico di questo discorso sulle emozioniè formato da un segno, un significato e un referente ester-no al linguaggio. La conoscenza di tale referente fa dell’e-sperto colui che può – è scientificamente autorizzato a –spiegare il significato di quel segno.
Le posizioni epistemologiche di Geertz e Scarry neces-sitano invece di un triangolo semiotico formato da un se-gno (Zeichen), un significato (Bedeutung) e un senso (Sinn).Se il segno viene significato, si assiste a una descrizione, maancora non si è compreso il senso di quanto accade. Si èsemplicemente preso atto di quell’accadere.
LA PERSONALITÀ E I SUOI DISTURBI
Il terzo, nella relazione, è l’elemento che costruisce ilsenso di quell’accadere. In una relazione semiotica statica,il terzo viene definito come “referente”. Ciò che sta nellarealtà là fuori deve soltanto essere rappresentato dal lin-guaggio.
In una relazione dinamica, invece, il terzo non è esternoal linguaggio, ma ne è la condizione differenziale. Esso co-stituisce perciò l’elemento che rende dinamica la relazionetra i tre elementi.
Riferire queste considerazioni al tema delle emozioni edella personalità, significa:
(…) precisamente che ciò che diamo per scontato è reso pro-blematico da questo approccio. Riguardo alla nostra nozionedi persona, ciò significa che l’idea che la nostra vera esistenzasia data in quanto individui distinti e separati, che le nostreemozioni siano espressioni personali e spontanee di un sé in-terno che potremmo chiamare “personalità”, sono poste radi-calmente in dubbio (Burr 1995, p. 24, corsivo mio).
Si potrà obiettare che le osservazioni presentate sopraappaiono capziose e ci complicano enormemente la vita.
Non è più economico fermarci alle definizioni di Eibl-Eibesfeldt?
La mia impressione è che la questione sia, in un certosenso, una questione storica e politica. La ricerca scientifi-ca classica sulle emozioni ha, a mio parere, continuatoun’operazione di colonialismo culturale che ha origine nel-la modernità.
Secondo Greenblatt (1991, pp. 159-160) una tale ope-razione può essere riscontrata, sul piano storico, nella pri-ma grandiosa operazione coloniale dell’epoca moderna: lascoperta delle Americhe.
Il paradosso è che il segno pieno di significato – o, più sem-plicemente, pieno – è vuoto, nel senso di cavo, trasparente:una lente attraverso la quale Colombo cerca ciò che si aspettadi trovare o, più precisamente, forse, una parola straniera cheegli si aspetta di costruire od incorporare nel proprio linguag-
PIETRO BARBETTA
gio. Nel tardo Cinquecento Richard Mulcaster chiamò acuta-mente “affrancamento” (enfranchisement) questa incorpora-zione, il processo attraverso il quale le “parole straniere presein prestito” vengono “legate alle regole della nostra scrittu-ra”. I segni che Colombo non è in grado di “affrancare”,quelli che risultano irriducibilmente strani od opachi, si av-viano a perdere il loro status, appunto, di segni.
Gran parte delle ricerche psicologiche sulle emozionisembrano risentire dello stesso limite epistemologico: ri-condurre il linguaggio delle emozioni dell’altro al sistemainterpretativo del ricercatore. “I gesti, le espressioni faccia-li e le frasi reciprocamente incomprensibili” nella relazionetra il ricercatore, o il clinico, “esperto”, e l’altro, fanno spa-zio oggi all’offerta, da parte del ricercatore e del clinico, dispiegazioni. Si pretende di apprendere la lingua dell’altro,senza riconoscere preventivamente alcuna differenza lin-guistica. “Il Requierimento3, strana miscela di rituale, cini-smo, finzione legale e perverso idealismo, era imperniatosulla convinzione che non esistesse alcuna seria barrieralinguistica tra indiani ed europei”.
Potremmo interpretare il DSM-IV come una sorta di Re-quierimento contemporaneo. Dovremmo allora domandar-ci come liberarci dalla trappola che ci costringe a “rapire illinguaggio” delle persone che si rivolgono al consulente, oal clinico.
Nella diade non si costruiscono significati, si realizzanoinvece pure identificazioni, per usare la metafora freudia-na, la diade può essere interpretata come un atto di reci-proco cannibalismo: “io so che cosa lei/lui prova in questomomento”.
A questo modello naturalistico, utilizzato da molti tra isostenitori della teoria dell’attaccamento, io propongo, nelprimo capitolo del libro Le radici culturali della diagnosi,un uso midarshico della conversazione clinica.
L’idea di usare così liberamente e al di fuori del propriodominio specifico il termine ebraico midrash non è affattonuova. La mia fonte di ispirazione principale è un’opera di
LA PERSONALITÀ E I SUOI DISTURBI
Kermode (1979) dal titolo The Genesis of Secrecy. Nellamia lettura di quest’opera traggo l’idea che non esista nar-razione senza segreti, porosità e misteri. Nello stesso tem-po ritengo che questi misteri siano, in qualche modo, lafonte della curiosità e del fascino che permette alle personedi continuare a raccontare storie. Il midrash è un’interpre-tazione non esegetica, bensì narrativa, delle scritture. Inquanto interpretazione narrativa ha tre caratteristiche im-portanti:
- sollecita la produzione di nuovi significati, interrogan-dosi costantemente sul senso della narrazione;
- usa il medesimo linguaggio della narrazione sulla qua-le esercita la propria ermeneutica, non usa, come nell’ese-gesi, un linguaggio “altro” (colto, astratto, da esperto);
- emenda, con nuove narrazioni, il segreto e il mistero,ma, poiché esercita questa operazione in forma narrativa,produce nuovi misteri e nuovi segreti.
Homo demens non può uscire dal midrash nel quale sitrova già sempre, dal momento della sua nascita (Arendt1929; Kristeva 2001). Il lettore interessato a questa propo-sta troverà in altri miei lavori (Barbetta, a cura, 2003) alcu-ne indicazioni di approfondimento per l’applicazione diquesta metodologia clinica. Sul piano teorico ho affrontatol’argomento del midrash in un saggio sui rapporti tra clini-ca e letteratura (Barbetta 2003).
Il midrash è un bricolage narrativo: non me ne voglianogli esegeti biblici ortodossi e rigorosi, mi considerino pureun eretico. Tutto ciò ha un forte legame con il delirio delquale scriverà in modo più diffuso Michele Capararo nelprossimo saggio.
1 Nel saggio di Lewis-Fernandez e Kleinman (1995) si racconta di comela task force (il gruppo di redazione) preposta alla revisione del Manualediagnostico psichiatrico dell’American Psychiatric Association (APA) avessecreato una sottocommissione preposta a fornire indicazioni in relazione allequestioni culturali e antropologiche della diagnosi. I due autori erano parte
PIETRO BARBETTA
di questa commissione che, dopo una serie si incontri, aveva formulato setteraccomandazioni su come redigere il manuale (DSM) in modo da non sotto-valutare le questioni culturali. Nel saggio i due autori raccontano di comel’APA abbia del tutto disatteso queste raccomandazioni riproponendo unavisione della diagnosi basata sulla filosofia universalistica. Vero è che più re-centemente, in occasione della redazione del DSM-IV-TR, l’APA ha pubblicatoun saggio sulla psichiatria culturale (APA 2002). Tuttavia le considerazionidel saggio sono, a mio avviso, ancora lontane da una seria considerazionedel fenomeno culturale.
2 Con ciò non intendo sostenere la maggior validità del punto di vista ari-stotelico, o di quello islamico, rispetto al punto di vista occidentale moderno,semplicemente non vorrei dare per scontato il contrario.
3 Il Requierimento fu un documento, in spagnolo, che informava gli indianidei loro diritti e dei loro obblighi come vassalli del re e della regina di Spagna.
LA PERSONALITÀ E I SUOI DISTURBI
Capitolo quartoStorie umane di (neuro)scienza e sistemi di curaMichele Capararo
Premessa I: io sono una storia
C’è qualcuno in ascolto?
Premessa II: la cura
MorteLa morte non significa morire.La morte è morta. Non così del morire.(Carmelo Bene, in Bene, Deleuze 2002, p. 121)
ResurrezionePrevediamo un periodo in cui l’umanità realizzerà il controllocompleto sui processi biologici, compreso l’invecchiamento.Un’era nella quale l’intelligenza artificiale e la manipolazionemolecolare elimineranno la povertà, la malattia e la durata fis-sa della vita come le conosciamo oggi. Un’era in cui una lun-ga vita, una buona salute e un potenziale illimitato sarannodiritto di nascita di ogni essere umano. Purtroppo molti dinoi viventi sono nati troppo presto per vedere questa era. Olo erano? (http://www.alcor.org)1
ParadossoTuttavia, se è vero che anche questo illuminismo scientificocome quello dell’antichità incontra il suo limite ultimo nel ca-rattere inconcepibile della morte, è altrettanto vero che l’oriz-zonte di indagine, entro il quale si muove il pensiero di frontea questo enigma, rimane circoscritto da [simili] dottrine della
salvezza e quindi, per noi, da quella cristiana con tutte le suevariazioni di chiese e sette (Gadamer 1993, p. 78).
Premessa III: la scienza
È questo spazio-tempo paradossale che costituisce iconfini entro i quali si muovono le scienze umane (ne co-nosciamo altre?).
La clo-Nazione
Se l’ordinamento di una società è cattivo (come il nostro lo è),e un piccolo numero di persone ha il potere sopra la maggio-ranza e l’opprime, ogni vittoria sulla Natura servirà inevitabil-mente soltanto a rafforzare quel potere e quella oppressione.Questo è ciò che attualmente sta accadendo.È trascorso circa mezzo secolo da che Tolstoj scrisse questeparole e ciò che in quel tempo stava accadendo ha continuatoad accadere. Scienza e tecnica hanno fatto notevoli progressinegli anni intercorsi – e altrettanto la centralizzazione del po-tere politico ed economico, e così l’oligarchia e il dispotismo(Huxley 1946, p. 23).
È trascorso un altro mezzo secolo e più da che Huxley,al termine della seconda guerra mondiale, scrisse questeparole “e ciò che in quel tempo stava accadendo ha conti-nuato ad accadere”.
Il progresso della scienza ha contribuito all’assottiglia-mento delle libertà personali, di pari passo a quello dei tele-visori. In questo contesto dobbiamo inserire ogni discussio-ne che si identificava come “vittoria sulla Natura” ripren-dendo Tolstoj. A tutt’oggi l’accezione più diffusa nell’imma-ginario comune della scienza divulgata e praticata in camposanitario vede i sistemi di cura come una strategia per com-battere e riportare una vittoria dell’uomo2 sulla natura.
Ho già descritto in un saggio precedente (Capararo2003) le metafore mediche utilizzate per acquisire consen-
MICHELE CAPARARO
so generale sull’inevitabilità delle guerre: dal virus del ter-rorismo agli effetti collaterali dei bombardamenti. Ma è ve-ro anche il contrario: i sistemi sanitari possono essere visticome organizzazioni belliche che proteggono, prevengono,combattono e spesso sconfiggono l’invasione della naturapatogena che ci circonda, e dall’invenzione del microsco-pio abbiamo scoperto una massa enorme di nemici invisi-bili a occhio nudo che respiriamo, beviamo, mangiamo etocchiamo o, nella maggior parte dei casi, con i quali con-viviamo. Ci affidiamo con fiducia alle cure mediche in casodi bisogno e lo facciamo portando una storia di sofferenzache percepiamo unica e personale, ma siamo spesso trattaticome un terreno biologico invaso da nemici sul quale latecnica medica combatte la battaglia per la salute. Siamoosservatori, straniati, di un sé corporeo che sembra non ap-partenerci.
Un’amica che aveva un serio problema cardiaco mi haconfidato di essere stata molto più agitata (tanto da soffriredi insonnia per settimane) dopo l’intervento chirurgico mi-croinvasivo al cuore (perfettamente riuscito) che nei mesiprecedenti l’operazione. Quale può essere il significato diun atteggiamento apparentemente così irrazionale? Checosa è mancato al successo della terapia perché si attivasseun processo di guarigione non solo efficace ma anche rassi-curante? Forse aspettava con fiducia che delle persone chefanno i medici si prendessero cura di una persona con unamalattia e non che il sistema sanitario accettasse in ospeda-le una cliente. Le è stato guarito il muscolo cardiaco manon vi è stata cura della persona. Non vi è stata, mi raccon-tava, alcuna preparazione all’intervento se non farmacolo-gica: nessun colloquio, nessuna conoscenza del corpo nellastoria che lo accompagna, nessun interesse alla sua unicitàcome individuo, qualcosa in più di un sistema di organi ininterazione tra i quali quel cuore da riparare. Nessuna spie-gazione chiara, nessun dialogo preparatorio al fatto che do-po l’intervento avrebbe iniziato ad assumere un cocktail difarmaci per molto tempo. Come se quei farmaci li assumes-se il suo corpo e non lei nella sua identità, che nasce dal-
STORIE UMANE DI (NEURO)SCIENZA E SISTEMI DI CURA
l’intreccio irriducibile di corpo e storia. Storia con la esseminuscola, storia minore, come lo sono tutte le storie dav-vero importanti: le storie di ognuno di noi.
Un intervento che solo pochi anni fa avrebbe richiestomesi di ospedalizzazione è stato risolto in pochi giorni didegenza: questo è oggi il prevalente metro di valutazionedel progresso in medicina.
Questa è la tendenza evolutiva dei sistemi dominanti dicura nella cultura tecnologica nella quale le percentuali diguarigione sono sempre in aumento e i tempi di guarigionesono sempre in diminuzione, ma la cura, il prendersi cura?
È importante distinguere i sistemi di guarigione dai si-stemi di cura. Guarigione viene dal longobardo warjan chesignifica tenere lontano. La ricerca e la clinica tecno-medi-ca in questo campo hanno fatto davvero passi enormi negliultimi cinquant’anni. Oggi siamo in grado di allontanare lamalattia dai corpi in tempi e modi sempre più efficaci e ve-loci. Curare, invece, ha la stessa radice etimologica di curio-sità: kwei. Prendersi cura implica essere curioso. Intreccia-re la propria storia di curante con quella del paziente signi-fica assumere un atteggiamento di curiosità, un atteggia-mento ricettivo nei confronti dell’altro che presuppone ri-spetto per la diversità al fine di generare un sentimentopervasivo di com-prensione. Curiosità intesa in senso cec-chiniano che
conduce verso una esplorazione e invenzione di visioni alter-native e le mosse alternative generano curiosità (Cecchin1987, p. 406).
Il corpo che cura e il corpo che soffre costruiscono vi-cendevolmente identità salutari nella narrazione di una sto-ria comune che predispone a una possibile guarigione, cheli comprende e li distingue nei ruoli. Riprendo un concettodi Gadamer sulla relazione tra la persona malata che perce-pisce, proprio in questa condizione del corpo, la salute e ilguaritore consapevole delle proprie ferite. Nel nostro siste-ma di cura la curiosità del medico è orientata, sin dai primi
MICHELE CAPARARO
studi universitari, verso la definizione di un corollario disintomi che devono successivamente essere sintetizzati inuna diagnosi. Un procedimento ana-mnestico che fa dellascomposizione analitica del “deficit” lo strumento principedel curante. Esempio classico in neurologia è la costruzio-ne di una nosologia delle differenti sindromi fondata sullacorrispondenza tra lesione d’organo e deficit funzionale.Evincere il funzionamento neurobiologico della mente dal-le sue menomazioni è insindacabilmente utile da un puntodi vista rigorosamente scientifico e rappresenta una meto-dica che ha portato enormi risultati nel campo della terapiamedica non solo in campo neurologico. Ciò che, tuttavia,rimane troppo spesso sullo sfondo è il processo straordina-rio che ogni paziente mette in atto per ripristinare funzionicerebrali deteriorate da una lesione organica. L’incredibilecaleidoscopio di interazioni tra riorganizzazione neuronalee riadattamenti comportamentali di un individuo menoma-to è raramente l’obiettivo della curiosità medico-scientifica.Una delle ragioni principali di questo atteggiamento risiedenel fatto che per essere praticato è necessario considerarel’individuo malato come un soggetto con una propria sto-ria personale che influenza e rende comprensibili le, spessobizzarre, strategie di autoguarigione: un caso clinico si tra-sforma in narrazione scientifica. Almeno fino a una decinadi anni or sono la sempre più potente e raffinata tecnologiadiagnostica rinforzava il pregiudizio della separazione nettatra Letteratura e Scienza in nome di un rigore scientificoche, in verità, assomigliava più a un delirio classificatorio.Solo pochi “fissati” si immergevano in letture classiche diStoria della neurologia affascinati dalla raffinatezza delledescrizioni. Potremmo sintetizzare questo atteggiamentogenerale con la domanda: perché leggere Charcot se abbia-mo la Risonanza Magnetica Nucleare? Ricordo che nel pe-riodo della mia formazione specialistica in neurologia ven-ni casualmente a conoscenza del libro di Oliver Sacks inti-tolato Emicrania. Quando ne parlai con entusiasmo ai mieicolleghi del centro per lo studio e la cura delle cefalee ebbil’impressione di aver introdotto un libro da spiaggia nel
STORIE UMANE DI (NEURO)SCIENZA E SISTEMI DI CURA
tempio della scienza. Oggi, grazie alla rivoluzione episte-mologica dello studio del vivente iniziata e portata avantiin differenti campi del sapere da scienziati rigorosi ma po-co ortodossi come Rose, Gould, e Lewontin, stiamo intro-ducendo storie di scienza che descrivono eventi unici e irri-petibili in ogni singola forma di vita. Forse possiamo inizia-re con meno “pudore” a parlare di romanzo scientifico ri-leggendo con occhi nuovi le meravigliose narrazioni di unneuroscienziato ante litteram come Lurjia, scritte letteral-mente a due mani con i propri pazienti. La ricerca scienti-fica all’interno dei laboratori porta avanti un continuo la-voro che definisco mitolitico, ovvero di decostruzione diverità storiche della scienza. Recenti ricerche sulla plasti-cità neurale propongono l’idea che il complesso funziona-mento cerebrale adotti i meccanismi exattivi (Skoyles1999) descritti esaurientemente da Pievani nel saggio cheapre questo volume. Altri studi mettono in dubbio le fun-zioni vitali della ormai consolidata (in letteratura) strutturacolonnare delle aree cerebrali deputate alla visione riscon-trando invece una “enorme variabilità” individuale nellaloro espressione di dominanza, definita nell’articolo “ca-pricciosa” (Adams, Horton 2003). Quando il dato scienti-fico sfugge al paradigma di riferimento la scelta delle paro-le rivela le emozioni dei ricercatori: un certo disappuntoconseguente al fatto che i neuroni non si comportano comedovrebbero, neuroni degenerati direbbe Edelman. Il proce-dimento scientifico nello studio degli esseri viventi, quan-do inserisce un sistema biologico in un contesto evolutivo,ha un duplice e ricorsivo effetto: dal punto di vista ontoge-netico (lo studio di quel particolare neurone, in quel parti-colare cervello di quel particolare animale) agisce in sensoprevalentemente mitolitico, generando peculiarità, dubbi,eccezioni, degenerazioni e amputazioni; dal punto di vistafilogenetico, invece, agisce in senso prevalentemente mito-poietico, unificando le particolarità in una Storia coerente econdivisa definita Teoria scientifica. La costante oscillazio-ne tra i due poli di questa doppia descrizione, prendendo inprestito un celebre concetto batesoniano, garantisce la fles-
MICHELE CAPARARO
sibilità del sistema scienza (e come vedremo successivamen-te del sistema di cura) senza rischiare di cadere nel cul desac dell’irriducibilità ontogenetica e della rigidità filogene-tica. Più avanti vedremo anche come le metafore descritti-ve dell’architettura e della fisiologia cerebrali siano figlie diquelle sociali che vengono a loro volta influenzate dalleprime in un processo di costruzione di senso circolare.
Riprendiamo, ora, il discorso sui sistemi di cura.Se, con un certo gusto per l’iperbole, consideriamo la
guarigione come un epifenomeno desiderato all’interno diuna rete complessa di interazioni che definiamo sistema dicura, allora notiamo come un epifenomeno sia nel corsodei secoli divenuto l’obiettivo in cui si esauriscono tutti i si-gnificati insiti nel termine cura. Le sempre maggiori sco-perte medico-scientifiche rinforzano l’idea di una teoriamedica certa, sicura delle sue applicazioni, ma a questa si-curezza non corrisponde certezza nella riuscita della tera-pia e quindi della guarigione (concetto istituzionalizzato inquanto il medico nello svolgimento della sua professionenon ha l’obbligo del risultato). Quindi la propaganda diuna scienza medica sicura ha almeno due conseguenze im-portanti: da una parte genera l’illusione della certezza dellaguarigione, dall’altra inaridisce l’atteggiamento di curiositàverso la teoria medica (di cui viene rafforzata l’ipotesi do-minante) e la mancanza del dubbio trasforma l’uomo incorpo macchinico. Gadamer parla di “dissoluzione dellapersona” in un corpo frammentato frutto dell’oggettivazio-ne, da parte della metodologia medica, di tutti i dati dispo-nibili che creano una molteplicità ricomposta attraversouna visione analitica del corpo (1993).
Viene meno il privilegio del dubbio costitutivo di ognivera relazione di cura, aperta necessariamente all’impreve-dibile. Il guaritore consapevole che gioca continuamentecon i propri pregiudizi li considera elementi ineludibili maflessibili del proprio essere nel mondo e lascia che si con-frontino con quelli della persona sofferente.
L’ideologia della guarigione come unico obiettivo dellacura ha conseguenze spesso drammatiche nelle situazioni
STORIE UMANE DI (NEURO)SCIENZA E SISTEMI DI CURA
in cui la patologia non dà speranze in tal senso, come neimalati cronici e nei malati terminali. In questo caso la me-dicina deve giocare a carte scoperte, dichiarare i propri li-miti, e spesso i medici entrano nel panico con i propri pa-zienti. La società intera non ne vuole parlare. Un malatoterminale, ancora vivo, è lo svelamento della rimozione sucui si fondano la tecnica e i suoi progressi, la rimozionedella vita attraverso la negazione della morte (ib.).
La relazione di cura comprende il processo lineare ver-so la guarigione dalla malattia ma non si esaurisce in esso.L’accettazione del dolore altrui come proprio dolore possi-bile è una fase naturale del processo di cura. L’artificio del-la classificazione diagnostica non dovrebbe mai nasconderela naturale risposta al dolore altrui che Skoyles sottolineainiziare molto precocemente nei mammiferi sociali: le ma-dri riconoscono il pianto del proprio figlio fra mille altri eanche i neonati reagiscono al pianto di altri neonati (Skoy-les, Sagan 2002).
Nell’incontro con l’altro, con il malato, la persona cu-rante non deve temere la messa in discussione delle certez-ze della terapia, non deve rassicurare ma curare. È dalprendersi cura che può nascere la rassicurazione e non vi-ceversa. L’atteggiamento di cura, abbiamo già detto, è sem-pre un atto di decostruzione nel quale la curiosità verso l’e-sperienza dolorosa rivela l’accettazione dell’altro, del mala-to, come un’occasione per
mantenere aperti quei varchi, quelle crepe che, interrompendola chiusura di ogni ordine stabilito, in primo luogo concettuale,consentono all’altro di venire (Deleuze, in Resta 2003, p. 17).
La visione della cura come via più breve alla guarigio-ne (certa) ha assunto una valenza esclusivamente tecnolo-gica e nasce da una visione locazionista della patologia cheha origine nell’alimentazione e nella guerra. L’anatomia ha“scoperto” il corpo, lo ha tagliato e suddiviso in organi:nasce lo sguardo anatomico. La preparazione di animalinell’arte culinaria e l’esposizione dell’interno del corpo
MICHELE CAPARARO
nelle ferite di guerra, con il loro carattere di urgenza, pos-sono essere considerati l’origine delle conoscenze anato-miche e del loro uso terapeutico (Parodi 2002). Lo sguar-do anatomico che mette in luce un isomorfismo degli or-gani animali di specie differenti è sempre stato terrenoprivilegiato della ricerca scientifica in medicina. Il fronte-spizio di un volume di anatomia descrittiva e dissezionedella seconda metà del XVIII secolo (Fort 1871) recita:“Manuale dell’anfiteatro. Dissezione, preparazione deipezzi secchi pei musei, pei concorsi”.
Si tratta dell’apoteosi dello sguardo medico foucaultia-no della Nascita della Clinica. Il palcoscenico sul quale sifa a “pezzi secchi” il corpo, spettacolo d’illusione nel qua-le la scienza scopre la morte e ne svela il mistero al pubbli-co. Questa tradizione del teatro anatomico, consolidatasicon Andrea Vesalio nella prima metà del XVI secolo, consi-steva letteralmente nella dissezione di cadaveri in pubbli-co, in cui l’attore principale della rappresentazione non èné il medico, né il corpo privo di vita sul tavolo operato-rio, ma è l’atto in sé dello svelamento dell’invisibile, cioèdi qualcosa che non sarebbe percepibile dai nostri sensinaturali. È forse l’assunto fondamentale della scienza sindai suoi albori. Rendere visibile l’invisibile è già realtà mi-surabile, un passo verso la verità, ma come scrive Merleau-Ponty (1964, p. 41), “La scienza presuppone la fede per-cettiva e non la illumina”.
Il cervello, da quando il cerebrocentrismo di derivazioneippocratica lo ha posto al vertice della gerarchia degli orga-ni, è l’attore principale del teatro anatomico e gli ultimidieci anni del secolo scorso sono stati dichiarati Il decenniodel cervello dal mondo accademico. L’esplosione delle neu-roscienze e la ripresa dello studio della coscienza, concettorientrato nel discorso scientifico dopo il lungo esilio impo-stogli a partire dal comportamentismo, coincidono con losviluppo delle tecniche di visualizzazione dinamica (Dyna-mic Brain Imaging) che, sempre più raffinate, evitano l’in-
STORIE UMANE DI (NEURO)SCIENZA E SISTEMI DI CURA
vasività e permettono l’analisi in vivo di ciò che accade nelcervello. Il rischio più evidente è un ritorno acritico a unneo-lombrosianesimo tecnologico in cui finalmente è pos-sibile misurare il cervello in vivo.
Quasi un’invasione nel sacro, nel mondo dell’invisibileper eccellenza. Il cervello, organo percepito quasi incorpo-reo, massa insensibile in senso fisiologico, ovvero privo diterminazioni sensitive. Il cervello non sente se stesso, nonha recettori dolorifici o tattili: non sente dolore se lesiona-to, caratteristica unica nell’organismo animale. La scenadel dottor Lecter3 che degusta con un cucchiaino il cervel-lo scoperto di un uomo “tranquillamente” seduto, è unametafora scientificamente plausibile. Il corpo sano è l’e-stensione concettuale del cervello insensibile, astratto, invi-sibile ai sensi naturali.
È possibile, infatti, individuare due tendenze oppostenel gestire il corpo nell’attuale immaginario sociale.
Il corpo sano diviene etereo, svanisce all’interno dellediscussioni medico-scientifiche che si fanno astrazione fi-siologica e filosofica. I sistemi di cura sono concentrati sul-la malattia, ritenendo la conservazione della salute priorita-riamente una responsabilità individuale. Esempio ne è ilfatto che la ricerca medica, nella sua veste istituzionale,persegue con tenacia gli studi su possibili sfuggenti retrovi-rus oncogeni come causa di neoplasie, ma lascia spesso solii comitati cittadini e le associazioni civili nel dimostrare edenunciare l’impatto ambientale dell’inquinamento elettro-magnetico, da monossido di carbonio, da agenti chimici discarto dell’industria, da scorie nucleari, ecc.
Il corpo malato, invece, che è la massima espressionedi corpo vissuto nella sua inevitabile e irritante caducità,viene analizzato, sezionato, riparato come se fosse estra-neo all’esperienza di sé. La natura (maligna) che si ribella,l’improvvisa consapevolezza dell’alterità della nostra car-ne, l’altro in noi, il diverso che rientra immediatamentenel paradigma socio-medico della guerra al male che èsempre altro da sé: aggressione esterna, ingiustificata eimmeritata e quindi malvagia.
MICHELE CAPARARO
In effetti la malattia è considerata meno malvagia, inquesto senso, se colpisce l’omologo; la degenerazione checolpisce il degenerato è vissuta come plausibile conseguen-za (o forse sarebbe meglio dire punizione) di una condottade-lirante: l’omosessuale con l’AIDS, la prostituta con un tu-more uterino, l’alcolista con la cirrosi epatica, l’uomo dipotere colpito da infarto.
L’organo malato incarna lo strumento della giustizia tra-scendente che riporta l’ordine naturale di tutte le cose chesignifica la sopravvivenza dei migliori.
Ogni anno nel mondo vengono uccisi circa trecento mi-lioni di animali, quasi un milione ogni giorno, per la ricercascientifica, cosmetica e per scopi didattico-dimostrativi. Iprimi dubbi sulla reale attendibilità scientifica di tali prati-che da parte degli stessi vivisettori sono sorti più di qua-rant’anni fa sino a diventare oggi un progetto critico escientificamente rigoroso, ricco di proposte alternative al-l’utilizzo di esseri viventi (Barnard, Kaufman 1997). Preva-le, comunque, un fortissimo interesse economico dietroqueste stragi, legato principalmente alla commercializza-zione di farmaci e prodotti cosmetici, che ne impedisceuna seria discussione pubblica supportata adeguatamentedai media. Ma il profitto non sarebbe sufficiente a spiegareil largo disinteresse sociale per i milioni di morti ogni annoper la vivisezione, sempre più criticata dalle nuove genera-zioni. Insieme all’idea dell’assenza di alternative, vi è an-che, come abbiamo anticipato, la seduzione dello sguardo.Siamo così sovrastimolati dalle immagini da ergerle, senzamediazione riflessiva, a principio di realtà. Il linguaggio co-mune è costellato dalla premessa dell’immagine come ve-rità: si dice un’immagine vale mille parole, vedere per crede-re, l’ho visto coi miei occhi, e i testimoni sono consideratipiù attendibili se oculari. Vera è l’immagine della cartellasulla vera scrivania del computer; fatichiamo a pensare chesi tratta di lunghe stringhe di zero e di uno che codificanol’accensione o lo spegnimento dei pixel su uno schermo.Vero è che se osservo le viscere di un cane assomigliano aquelle di un uomo; fatichiamo a pensare che l’isomorfismo
STORIE UMANE DI (NEURO)SCIENZA E SISTEMI DI CURA
visivo sottenda differenze evolutive e biologiche spessoscientificamente inconciliabili. L’uomo occidentale accettala giustificazione dell’isomorfismo perché è perfettamentein risonanza con il paradigma del vero è ciò che vedo. La ri-presa televisiva di un evento ci appare più vicina alla realtàdi qualsiasi servizio radiofonico o giornalistico. Non è uncaso che, in ogni regime contemporaneo, il popolo si con-quisti attraverso i televisori e la censura inizi proprio dalletrasmissioni televisive, mentre i canali radiofonici avverto-no solo l’onda d’urto del colpo di mannaia.
Ma vi è un altro motivo che porta all’accettazione diquesta massa di morti sempre crescente. L’uomo combattela consapevolezza della propria caducità in due direzioniopposte: la prima, già descritta in precedenza, è l’allonta-namento del pericolo, la guarigione; la seconda è esatta-mente il suo opposto ovvero il gettarsi nel pericolo e sfida-re la morte. Canetti (1960, pp. 274-275) esprime con paro-le dure questa tensione:
La forma più bassa del sopravvivere consiste nell’uccidere.Così come l’uomo ha ucciso l’animale di cui si nutre, che hatrovato indifeso – e può farlo a pezzi e distribuirne i pezziquali parti della preda per sé e per i suoi –, così l’uomo vuoleanche uccidere l’uomo che gli è di ostacolo, che gli si con-trappone quale nemico. (…) La sensazione di forza che scatu-risce dal sopravvivere è fondamentalmente più forte di ogniafflizione: è la sensazione d’essere eletti fra molti che hannoun comune destino. Proprio perché si è ancora vivi, ci si sentein qualche modo i migliori.
I vivi, dunque, alimentano il sogno dell’immortalità so-pravvivendo ai morti. Il rapporto tra pratiche vivisettorie epratiche di guerra è molto più profondo di quanto possaapparire a un’analisi sommaria e prevedibile. Più la massadi morti accresce, più accresce l’hybris consolatoria dei vi-vi. Ancora una volta la guerra e la medicina intrecciano leradici nello stesso terreno, terreno di battaglia, in cui ilguaritore è solo guerriero. Mi viene in mente il quadro Iltrionfo della morte di Bruegel il Vecchio in cui nella massa
MICHELE CAPARARO
di persone “assediate dalla morte” durante una festa popo-lare si vede un sopravvivente che sta sguainando la spada.Accanto vi è una tavola imbandita sotto la quale si sta infi-lando un uomo, cercando protezione. Alle spalle del com-battente ci sono due donne accovacciate, che si rivolgonovicendevolmente uno sguardo estatico; una delle due suo-na uno strumento a corde. Riprendendo la citazione in epi-grafe di Gadamer, penso alla Medicina che sguainando laspada cerca di proteggere dalla morte il malato che si infilasotto il tavolo della Scienza, mentre i sani suonano unostrumento ignorando consapevolmente la tragedia in atto.
Se sappiamo guardare con disincanto weberiano (e con-sideriamo la razionalità come mezzo e non come fine asso-luto), appare evidente che il progresso scientifico, dai labo-ratori di ricerca alle applicazioni mediche, fino alle profon-de implicazioni filosofiche, ci dice molto di più sulla scien-za dell’uomo che sulla conoscenza dell’uomo.
L’indagine della scienza e in particolare del progressoneuroscientifico, come eventi storici inseriti in un processoevolutivo, è di per sé uno strumento epistemologico che tro-va nella ricorsività un metodo paradossale e coerente. Lascienza emersa dal cervello studia il cervello emerso dallascienza. E se vogliamo chiederci con senso di responsabilitàcome funziona il cervello abbiamo il dovere di chiedercicontemporaneamente come funziona la scienza oggi.
Da quando Russel e Whitehead, all’inizio del secoloscorso, con la Teoria dei Tipi Logici cercarono di metterefuori legge il paradosso in quel dominio cognitivo cheoscilla tra linguaggio e pensiero, il paradosso stesso si èsempre più rivelato nel corso degli anni una delle chiavi diriflessione più interessanti sul pensare umano ma soprat-tutto del pensare sul pensare. E ciò che questa sfuggenteastrazione, che ripiega su se stessa, invita a compiere è unribaltamento epistemologico in cui ortodosso ed eterodos-so ruotano attorno al perno del paradossale, segmenti in-ventati di uno stesso cerchio che l’atto della distinzionecrea allo stesso momento, necessari entrambi perché sipossano ri-conoscere.
STORIE UMANE DI (NEURO)SCIENZA E SISTEMI DI CURA
La scienza non sfugge al paradosso, è una teoria cheriesce a spiegare ciò che è accaduto in un esperimento, tal-volta riesce a ripeterlo e allora si trasforma in tecnologia.Ma soprattutto la scienza è una teoria formidabile perchémaestra nello spiegare per quale ragione ciò che doveva ac-cadere non è accaduto convalidandosi nella propria auto-giustificazione. È ricorsivamente perfetta, inattaccabile.Forse in un futuro lontano si studierà la Scienza come unvecchio modello teorico, affascinante e approssimativo, maesempio ancora valido di creazione della verità attraversoun’efficace visione autoreferenziale della realtà.
Ma la scienza è un seme che germoglia fra gli uomi-ni, sul terreno della politica e dell’economia. È un semeantico dal quale cresce una pianta che attraverso i suoidifferenti rami punta verso un’unica direzione: l’im-mortalità.
Gli studi, i progressi e le relative polemiche sulla mani-polazione genetica e conseguentemente sulla clonazione ascopo terapeutico rappresentano insieme alle neuroscienzelo stato dell’arte della ricerca scientifica incarnando il desi-derio latente di ogni uomo di vivere per sempre sentendosinecessario, magari, per ora, congelando il proprio corpo inattesa dei progressi tecnologici che lo salveranno ripetuta-mente in eterno.
Due sono i differenti aspetti che comporta il tema dellamanipolazione genetica.
Uno è quello individuale: l’uomo singolo comune po-trà essere più che uno e trino, potrà essere uno e multiplo,rigenerarsi, sostituirsi, ricambiarsi, insomma essere persempre.
L’altro è quello sociale, legato all’idea di clo-Nazione:tutti saranno così migliori a furia di rigenerarsi che genere-ranno discendenti sempre migliori fino a essere tutti similial meglio, insomma praticamente uguali. Una nazione for-mata da individui che non possono che pensarla allo stessomodo, quello migliore. Questo è il futuro che i nostri “si-stemi di cura” costruiranno insieme a tutti i sani e i malati,entrambi comunque destinati alla perfezione.
MICHELE CAPARARO
Einstein, uno dei più grandi visionari del ventesimo se-colo, scriveva
È un pregiudizio che i fatti possano e debbano tradursi in co-noscenza scientifica di per sé, senza libera costruzione con-cettuale. Un tale errore è possibile solo perché è difficile ren-dersi conto dell’arbitrarietà di tali concetti che, attraverso laverifica ed il lungo uso, sembrano invece collegati con il ma-teriale empirico (Schilpp, a cura, 1955, p. 26).
Einstein stesso ci mette in guardia dalla verità che sem-pre poggia sull’abitudine, sul consueto, così da dimenticareche persino la fisica è una libera costruzione del pensiero.Un frullatore non è utile perché è vero ma è vero perchéfunziona ogni volta, o quasi, esattamente come ci aspettia-mo che funzioni; così come un bambino non è ubbidienteperché è normale, ma è normale perché reagisce ogni volta,o quasi, come ci aspettiamo che reagisca. La ripetizione, unaltro fondamento unico di religione e scienza: la messa do-menicale e il telegiornale danno il ritmo alla vita dell’uomoche attende la verità, così come l’esperimento scientifico inlaboratorio dà il ritmo alla vita dell’uomo che cerca la ve-rità: i metronomi del nostro tempo, i rinforzi pavlovianidelle nostre credenze implicite.
Ci tuffiamo nel passato producendo pura linearità, ri-ducendolo a fatto attraverso cui predire il futuro che nesarà la ripetizione prevedibile. Questa manipolazione delfuturo che reitera il passato non viene certo dal determini-smo scientifico, dalla ricerca di laboratorio, ma dalle sovra-strutture in cui l’approccio scientifico è costantemente co-stretto. Politica, burocrazia, economia imbrigliano tutte lescienze possibili.
La scienza potrebbe essere la maggiore opportunità di libertàche ci sia rimasta: il suo (presunto) scopo di predire il futuroè la principale scusa socialmente accettabile che ci permettedi perseguire i sogni più assurdi – e talvolta di realizzarli, difarne il nostro presente (Bencivenga 1997, p. 64).
STORIE UMANE DI (NEURO)SCIENZA E SISTEMI DI CURA
La scienza non può essere che un viaggio programmatonell’impossibile, un contenitore socialmente accettato distorie de-liranti.
Dal de-lirio al lirismo
Il sogno dei logici, cioè che gli uomini debbano comunicaretra loro soltanto per mezzo di segnali discreti non ambigui,non si è avverato e probabilmente non si avvererà (Bateson1972, p. 422).
È importante precisare che in questo saggio il sistema dicura viene inteso come istituzione dinamica che pone l’ac-cento sulla sua natura processuale. Riprendendo le idee diCastoriadis sull’istituzione immaginaria della società (1975)si evita di intendere il sistema di cura come un quadrostrutturato e stabilizzato di attività sociali, di norme, regolee funzioni (produzione istituita). La definizione qui propo-sta si rifà al concetto di produzione istituente, ovvero all’e-vento di istituire un ordine, un paradigma, attraverso unacontinua tensione processuale che definisce gli attori, iquali, a loro volta, possono definirsi solo attraverso il para-digma costituito. Una società consumistica produce perso-ne consumiste che confermeranno la realtà e inevitabilitàdella società consumistica. Ogni specifico sistema di curaproduce specifiche persone malate che confermano il siste-ma di cura. È nella consapevolezza individuale di questatensione creatrice ricorsiva (autonomia) che risiedono lemaggiori capacità curative di ogni singolo corpo e di ognisocietà. Dice Castoriadis (1990, p. 56):
La società crea il suo mondo, lo investe di senso, lo provve-de di significato destinato a coprire in anticipo tutto quantopotrebbe accadere. Il magma di significati immaginari so-cialmente istituiti riassorbe potenzialmente qualunque pos-sibile evento e non può, in linea di principio, essere sorpre-so o preso alla sprovvista. (…) Ma anche il mondo, in quan-to “mondo pre-sociale, limite del pensiero, benché in se
MICHELE CAPARARO
stesso non “significhi” nulla, è sempre lì come provvista ine-sauribile di alterità [corsivo mio], come rischio sempre im-minente di lacerazione nel tessuto di significati di cui la so-cietà lo ha rivestito.
Quale alterità è più lacerante di quella di un malatocronico, di un malato terminale e di un malato psichico, diun folle?
La paura di de-lirare, di uscire dal seminato (solco),sembra essere una delle caratteristiche dominanti del pen-siero moderno occidentale, sostiene Barbetta nel saggioprecedente.
Nella mia pratica di neurologo e psicoterapeuta, in ef-fetti, capita non di rado di incontrare persone che hannopaura di impazzire. Persone spesso angosciate da problemiconcreti, contingenti, direi consueti nel nostro stile di vita,che passano sullo sfondo rispetto al terrore della pazzia.
Di quale pazzia parlano? Quale pazzia intendete voi, adesso, mentre state leggen-
do queste righe?Possiamo identificare questa angoscia profonda princi-
palmente come paura dell’incomunicabilità e paura dell’ir-responsabilità:
l’incapacità di esprimere concetti comprensibili e dicomprendere i concetti dell’altro.
L’incapacità di controllare le proprie azioni/reazioni. L’impossibilità, quindi, di rimanere nel solco del con-
sentito, all’interno di paradigmi concettuali e comporta-mentali consueti e riconoscibili.
Ciò che unisce queste paure, inoltre, è l’idea di reversi-bilità: a differenza della paura della morte, la paura dellapazzia è sempre riferita alla possibilità di un ritorno allanormalità: stato nel quale si suppone verrà richiesta unagiustificazione sullo stato alterato precedente. Potremmodire che ciò che ci spaventa maggiormente è l’incapacità diun’assunzione di responsabilità anche solo nell’ipotizzareun rientro nel solco. Nella cultura moderna occidentale
STORIE UMANE DI (NEURO)SCIENZA E SISTEMI DI CURA
ogni essere umano viene definito normale se è in grado diarticolare consapevolmente una personale teoria esplicativache giustifichi entro paradigmi condivisi il proprio mododi essere nel mondo: la normalità è soggiacere all’illusionecomune, alla menzogna condivisa che noi siamo necessari,nati per un fine, si tratta solo di scoprire quale esso sia. Chiagisce mettendo solo in dubbio tale teoria ansiolitica e an-tidepressiva rischia l’esilio dal consorzio umano.
Uno studioso del vivente come Monod (1970, pp. 43-44) prova a renderci più consapevoli:
Nessuno rimprovererebbe a una teoria universale di non af-fermare e prevedere l’esistenza di quella particolare configu-razione atomica; basta che quell’oggetto attuale, unico e reale,sia compatibile con la teoria. Secondo quest’ultima esso nonha il dovere ma il diritto di esistere. Tale ragionamento ci sod-disfa nel caso del sasso, ma non di noi stessi. Noi vogliamo es-sere necessari, inevitabili, ordinati da sempre. Tutte le religio-ni, quasi tutte le filosofie, perfino una parte della scienza, so-no testimoni dell’instancabile, eroico sforzo dell’umanità chenega disperatamente la propria contingenza.
Siamo socialmente costretti, il che significa anche auto-costrizione, a dare al nostro concetto di necessità dell’uo-mo un consenso indiscutibile
Il consentito, pregiudizio condiviso di normalità, si rifàa un altro concetto fondante la modernità che Latouche,rifacendosi a Leibniz, definisce “Ordine Sociale Naturale”(2001, p. 41).
La tradizionale storia della scienza narra che Galileo,de-scrivendo il libro della natura suddiviso in cerchi, trian-goli e altre figure geometriche e identificando in esse l’uni-co mezzo per raggiungere la verità, separasse definitiva-mente scienza e teologia e introducesse la modernità. Lascienza è la nuova religione e la morale è “ordinata” geo-metricamente.
Da questo punto in poi si susseguiranno liberi pensato-ri, filosofi illuministi e da qualche decade autorevoli acca-demici, accuratamente selezionati per la divulgazione
MICHELE CAPARARO
scientifica, a dare il ritmo alla morale come metronomi nonpiù super-partes, ma “scientificamente” extra-partes equindi capaci di uno sguardo obiettivo sul mondo, divulga-tore di verità e di una precisa idea di “cura” che abbiamodiscusso nel capitolo precedente.
Secondo Latouche l’Ordine Sociale Naturale costituisceuno dei miti fondatori delle scienze sociali e partecipa all’i-stituzione immaginaria della nostra società (ib.).
Il presupposto fondamentale è l’unità del reale, quindil’unità della scienza.
Quest’ultima si fonda su un’antropologia naturalista dicui la figura perfetta è l’homo oeconomicus. L’idea è checi sia una natura umana, totalmente naturale, mossa da bi-sogni materiali. Latouche sostiene che questa antropologianon sia alla base della sola economia politica ma, costi-tuendo la fisica sociale, risulta il fondamento di tutte lescienze sociali
L’individuo – equivalente dell’oggetto fisico – è il punto d’in-contro di forze opposte indipendenti dalla sua volontà; e so-no queste forze d’attrazione e repulsione a comandare la gra-vitazione politica e sociale (p. 48).
L’individuo delle scienze sociali è quindi un ingranaggioall’interno di un sistema universale naturale dominanto daforze centripete e centrifughe. È evidente il tentativo (riu-scito) di portare sul piano delle relazioni sociali l’universomeccanicistico della fisica newtoniana: l’essere umano, ato-mo individuale, lotta in un universo mosso da forze contra-stanti per aumentare il proprio piacere e diminuire il pro-prio dolore.
Il mito del controllo è l’astrazione del comportamentonaturale della fuga dal dolore, reazione di difesa/attacco.
Il profitto è l’astrazione del comportamento naturaledella ricerca del piacere, reazione di necessità ai bisogni pri-mari dell’uomo. Si tratta della raffinata sublimazione dellalegge della giungla elaborata dalla cultura occidentale chegenera una precisa gerarchia dei bisogni la cui prima di-
STORIE UMANE DI (NEURO)SCIENZA E SISTEMI DI CURA
stinzione è tra primari e secondari, altro postulato di ogniscienza sociale, formalizzato negli anni Settanta daAbraham Maslow.
Ma la causalità tra bisogno primario e comportamentofinalizzato a soddisfarlo è meno implicita di quanto si pos-sa pensare. Roberto Contessi (2003, p. 127), in un interes-sante libro su Wittgenstein, porta un esempio suggerito da-gli scritti del filosofo austriaco. Per la chiarezza dell’esposi-zione voglio riportarlo per intero:
Avere una grande fame non produce un’azione intenziona-le, nel senso che agire sulla base dei crampi per fame nonspecifica un fine da ottenere. L’azione di procacciarsi cibosulla base dello stimolo della fame è realizzata appena l’af-famato ha placato i suoi stimoli e questo, tra l’altro, non so-lo può verificarsi procurandosi qualsiasi tipo di cibo, maaddirittura ricevendo un colpo piuttosto forte allo stomaco.In linea di principio, qualsiasi evento traumatico può estin-guere lo stimolo, e in questo senso seguire l’istinto della fa-me non provoca un’azione intenzionale (Wittgenstein 1980,pp. 23-24).
Ma l’Ordine Sociale Naturale impone all’uomo naturaledi seguire naturalmente precise linee ordinarie di condotta:è meglio non dire a una cena con uno psichiatra “ho fame,datemi un pugno allo stomaco” (sebbene sia formalmentecorretto sia in senso linguistico che organico); e la paura diimpazzire rientra nell’idea più generale della paura di de-viare (di ammalare), termostato di autoregolazione socialedell’idea istituzionalizzata di normalità. Con l’invenzionedel soggetto psicologico, attraverso la distinzione tra inter-no del corpo (che genera la causa) e esterno (lo spazio del-l’effetto), le scienze umane studiano il simulacro della per-sona, ovvero il suo concetto, entro un determinato periodostorico (Contessi 2003). Viene, cioè, a costituirsi, parallela-mente a quello sociale, un Ordine Mentale Naturale chenoi viviamo come intrinseco al nostro proprio corpo fisico,che deve inevitabilmente produrre ormoni, neurotrasmetti-tori, idee e comportamenti normali; ogni storia individuale
MICHELE CAPARARO
deve essere compresa nella Storia istituita. Inevitabilmente,però,
all’uomo astratto che pensa per il piacere di pensare, si con-trappone l’uomo organico, che pensa sotto l’effetto di unosquilibrio vitale, e che è al di là della scienza e dell’arte (Cio-ran 1934, p. 33).
e, aggiungo, della Storia. In questo al di là convergono l’e-sperienza dell’impossibile di Derrida, l’alterità di Castoria-dis, l’infinitudine del vivente di Jaspers e il paradosso dellamedicina secondo Gadamer. Questo al di là profondamen-te immanente che affonda nella carne esprime le tensionicontrapposte dell’uomo verso l’istituzione di società con isuoi simili che costruiscono il sé, l’altro e l’ambiente, e nel-lo stesso tempo verso un lirismo che rappresenta, al contra-rio, “un impulso a disperdere la soggettività”, fondendosinell’altro,
perché denota, nell’individuo, un’effervescenza insopprimibi-le che esige espressione. Essere lirici significa non poter resta-re chiusi in se stessi (p. 16).
È il lasciar venire l’altro senza calcolo e senza condizio-ni, accettando, seguendo Derrida, “una certa esperienzadell’impossibile” (Resta 2003, p. 25). Un incontro con l’Al-tro sofferente in cui il guaritore consapevole (che vive nelmondo) affianca il guaritore guerriero (che guarda il mondocreando oggetti). Dalla radice di warian deriva, infatti, an-che guerra, guardare e guardiano. Forse nel corso dell’evo-luzione della nostra specie abbiamo imparato a stare inguardia; attraverso l’evoluto organo della vista abbiamo im-parato a guardarci da ciò che ci circonda. Il nostro metododi guardiani della salute è quello di riconoscere le ripetizio-ni e imparare a controllarle, a prevederle. L’impossibile, in-vece, si propone come compito di apertura di narrazioniimprevedibili di cura che partono dalla traccia di procedu-re note del metodo scientifico (causale) verso decostruzioni
STORIE UMANE DI (NEURO)SCIENZA E SISTEMI DI CURA
e ricostruzioni continue di senso che possano generarecontesti salutari (comprensione). Già nel 1948 Jaspers, nelsuo trattato di psicopatologia generale, affronta il tema del-la ricorsività tra pensiero causale e pensiero comprensivorifacendosi a Dilthey
La causalità unilaterale è una categoria inevitabile nel nostromodo di intendere causale, ma con ciò la vita non può essereesaurita. Il processo vivente è un’infinita azione-reazione incircoli di questi processi che, morfologicamente, fisiologica-mente e geneticamente sono totalità (Ganzheiten) o formepermanenti (Gestalten). La vita si serve in verità dei meccani-smi (…) ma i meccanismi sono essi stessi prodotti della vita,sono condizionati da questa, sono variabili. Contrariamenteall’automatismo di una macchina, la vita è una continua auto-regolazione del macchinario, ma in modo tale che l’ultimopunto centrale della regolazione possiamo incontrarlo solocome idea generale dell’infinitudine del vivente, senza mairaggiungerlo in lui stesso (p. 155).
Si tratta, dunque, parafrasando Fayerabend, di andareoltre il metodo e non contro il metodo. Il guaritore guerrierodeve saper immergersi nel mondo inclassificabile della de-costruzione trasformandosi temporaneamente in guaritoreconsapevole. Il guaritore consapevole sospende il suo sape-re scientifico per andare oltre, e come dice Caterina Resta(2003, p. 17) interpretando Derrida
svela ciò che muove, ciò che mette in movimento ogni deco-struzione: un desiderio in-finito di corrispondere a un appelloche, proprio perché giunge dall’altro, la precede e perciò innessun modo può essere soddisfatto.
La potenzialità curativa si alimenta, allora, proprionell’abbandono delle (in)certezze della scienza medica,che rimane importante paradigma di sfondo, verso“poussé liriche”, essenza dell’arte terapeutica, nelle qualiil filtro diagnostico delle verità e dei dogmi medici vienetemporaneamente a cadere permettendo l’incontro tra il
MICHELE CAPARARO
guaritore e il malato sul terreno comune dell’infinitudinedell’esistenza.
Nel caso della relazione medico-paziente questa infini-tudine (l’impossibile di Derrida) diviene duplice: vi è (l’im-possibile) conoscenza dell’altro come unica invenzionepossibile di apertura all’avvenire; e vi è la promessa impos-sibile: la classica iconografia del medico che strappa il ma-lato dalle mani ossute della morte fissa in una immaginequesta promessa.
Il lirismo appare dunque una tensione verso il mondopre-sociale e pre-linguistico di Castoriadis, un ritorno alcorpo, attraverso le vibrazioni delle corde di una lira in cuiil canto che le accompagna si sottrae alla sua valenza lin-guistica per divenire esperienza fisica, esigenza incontrolla-bile d’espressione, totalità dell’essere, che faticosamentetraduciamo in parole.
In questo spazio temporale tra presenza e rappresenta-zione (l’infinitudine di tutte le possibilità) abbiamo la pos-sibilità di reinventarci e talvolta lo facciamo uscendo dalseminato, delirando. Ma qual è la sottile connessione trade-lirio e lirismo suggerita nel titolo del capitolo? Durantele conversazioni con alcuni pazienti ho avuto la sensazione,talvolta, di percepire qualcosa come una tempesta, un ura-gano che li avvolgeva: agitazione, parole sconnesse, frasiveloci e troncate, un discontinuo fremito del corpo. Questaimmagine metaforica è stata illuminata da queste parole diun folle salvato dall’arte e dalle amicizie
Scartando ora tutte le stupide definizioni e tutti i confusi ver-balismi dei professori, io vi dichiaro che il lirismo è la facoltàrarissima di inebbriarsi della vita e di inebbriarla di noi stessi:la facoltà di cambiare in vino l’acqua torbida della vita che ciavvolge e ci attraversa. La facoltà di colorare il mondo coi co-lori specialissimi del nostro io mutevole.Ora supponete che un amico vostro dotato di questa facoltàlirica si trovi in una zona di vita intensa (rivoluzione, guerra,naufragio, terremoto ecc.) e venga, immediatamente dopo, anarrarvi le impressioni avute. Sapete che cosa farà istintiva-mente questo vostro amico lirico e commosso?...
STORIE UMANE DI (NEURO)SCIENZA E SISTEMI DI CURA
Egli comincerà col distruggere brutalmente la sintassi nel par-lare. Non perderà tempo a costruire i periodi. S’infischieràdella punteggiatura e dell’aggettivazione. Disprezzerà ognicesellatura e sfumatura di linguaggio, e in fretta vi getterà af-fannosamente nei nervi le sue sensazioni visive, auditive, ol-fattive, le sue fulminee riflessioni secondo la loro corrente in-calzante. L’irruenza del vapore-emozione farà saltare il tubodel periodo, le valvole della punteggiatura e i bulloni regolaridell’aggettivazione. Manate di parole essenziali senza alcunordine convenzionale. Unica preoccupazione del narratore:rendere tutte le vibrazioni del suo io.Se questo narratore dotato di lirismo avrà inoltre una mentepopolata di idee generali, involontariamente allaccerà le suesensazioni coll’universo intero conosciuto o intuito da lui. Eper dare il valore esatto e le proporzioni della vita che havissuta, lancierà delle immense reti di analogie sul mondo(Marinetti 1913).
Questo “narratore dotato di lirismo” non avrebbe diffi-coltà a ricevere una diagnosi di schizofrenia nel de-lirantetentativo di esprimere “il valore esatto e le proporzioni del-la vita che ha vissuta”.
Wittgenstein ha più volte portato le sue riflessioni suquello iato tra l’esperienza vissuta e la sua descrizione lin-guistica. Ma è proprio questo il nostro limite biologico.Per un sistema vivente, nel proprio dominio fenomenico,una storia è solo una storia di perturbazioni alle quali rea-gisce (ma questa è già una distinzione linguistica di un os-servatore), cercando di mantenere la propria organizzazio-ne – le specifiche relazioni di componenti che lo identifi-cano – variandone la struttura ovvero le componenti effet-tive. Il sistema nervoso è un reticolo chiuso (nel senso chele regole che lo governano sono autoreferenziali) di intera-zioni neuronali e organizza se stesso in modo da garantirela conservazione dinamica dell’equilibrio dell’organismo.Ciò significa che scopo, finalità, intenzione non hannonulla a che fare con un sistema vivente come sistema strut-turalmente determinato. L’essere nel mondo di un corpo,in questo senso, è biologicamente afinalistico, in un gioco
MICHELE CAPARARO
di contingenze e necessità. La sua flessibilità risiede nellaridondanza (più del necessario) e nella degenerazione (dif-ferente dal necessario) che apre campi di possibilità infini-ti e contingenti. L’encefalo è quindi un organo isolato ed èsolo la condizione di possibilità (Maturana, Varela 1980)per l’emergere dei processi cognitivi nel cui dominio lin-guistico (e solo in esso) prima inventiamo noi stessi, l’altroe l’ambiente, poi possiamo tentare di comprenderli senzamai conoscerli. Per questo cercare la coscienza nei neuro-ni è come cercare l’identità nazionale nelle molecole checompongono il tessuto della bandiera tricolore.
Questa visione relativamente recente frutto dell’intera-zione tra biologia, antropologia, anatomia cerebrale e teo-rie neurofisiologiche non riesce a far breccia nel noccioloduro della modernità. Le ragioni, potremmo dire, sono piùpolitiche che culturali.
Quale visione dell’uomo e dei suoi sistemi organizzativiemerge, infatti, da questo tipo di cervello biologicamenteafinalistico, imprevedibile, dis-ordinato e de-generato?
Sembra di ripercorrere una storia già nota, quella dellanarrazione antropologica secondo l’evoluzionismo classicoche propone una teleologia nella quale l’uomo è al verticedella piramide evolutiva, messa in crisi da Gould con l’ipo-tesi dell’exaptation. L’oscuramento di tale ipotesi dovuto alsuccesso politico del neodarwinismo inizia a vacillare e soloora cominciamo a comprenderne la portata rivoluzionaria.Senza teleonomia e senza gradualismo filetico, i concetti dipredicibilità, necessità, controllo e sicurezza vengono mi-nati alle loro fondamenta e chi trae più privilegi sociali edeconomici dalla modernità reagisce con furore per difende-re quelli che considera dati di fatto conquistati dalla scien-za dell’uomo.
Ma sempre più pensatori fuori dal solco iniziano a per-seguire con forza l’idea batesoniana che
l’attuale maniera di essere uomini, (contro l’ambiente, controaltri uomini in una promessa di controllo totale) non è l’unica,“è concepibile che la si possa cambiare (Bateson 1972, p. 514).
STORIE UMANE DI (NEURO)SCIENZA E SISTEMI DI CURA
I coni d’ombra e il peyote
Risalire linearmente a come si è arrivati a tale risultatoche, senza apparenti soluzioni di continuità, muove da ungiusnaturalismo nato agli albori della nostra civiltà occi-dentale, sarebbe una ricerca fine a se stessa e comunquemeno interessante del chiedersi quali biforcazioni episte-mologiche si siano verificate durante questo percorso,quali catastrofi (nell’accezione di René Thom) lo abbianoaccompagnato e quali “forze” contingenti e storicizzateabbiano sospinto un Ordine Sociale Naturale fondantetutte le scienze
Ancora più interessante è indagare quelli che Wu Ming4
chiama i coni d’ombra della Storia, prodotti (di scarto!)ineliminabili dell’investigazione razionale di un processostorico che procede per catastrofi e discontinuità; ovvero iprodotti dell’intersezione tra storia e mitologia. Per WuMing questi coni d’ombra rappresentano il momento in cuila Storia è ancora storie possibili e sarebbe potuta andarein un’altra direzione. Credo che in questa visione risalti ilprofondo valore conoscitivo in senso epistemologico dellabiforcazione in sé, in qualsiasi campo del sapere, più anco-ra delle possibilità e delle conseguenze che ne sarebberopotute derivare.
Cito ancora il metodo di indagine di Wu Ming che gio-ca con la Storia: dopo un’estenuante ricerca di innumere-voli fonti, scritti, documenti, filmati, testimonianze, i parte-cipanti alla ricerca si lasciano andare a un brainstormingdurante il quale esperiscono una sorta di allucinazione(“Historical research is like peyote5 for us”) che dura setti-mane, al termine delle quali cominciano a scrivere romanzistorici (Snafu 2002, p. 4).
Sembra un vero e proprio delirio storiografico o megliouna storia degenerata. Degenerazione nella quale prevaleperò il valore intensivo di approfondimento (nel sensospiegato da Barbetta nel saggio precedente) come condi-zione di possibilità, presenza di alternative in senso anti-funzionalista e mitopoietico.
MICHELE CAPARARO
Questo non-metodo si potrebbe definire una vera e pro-pria indagine epistemologica riflessiva, consapevole dell’i-nevitabile perturbazione che produce il gestoconoscitivo/generativo ma soprattutto exattiva ovvero cheutilizza in maniera afinalistica gli oggetti concettuali che sisprigionano casualmente da una ricerca (in questo casostorica) de-lirante che illumina i “coni d’ombra” e compo-ne un bricolage inatteso ma non inattendibile.
Questo modo di fare storia rientra in una tendenza at-tuale che coinvolge tutti i campi del sapere e che si struttu-ra intorno al recupero della corporeità e del vissuto perso-nale (storie minori) in senso fenomenologico. Questo ritor-no alla narrazione come metodo d’indagine del mondo edell’uomo nel mondo ripropone un modello in cui l’istitu-zione corporea della scienza fatta di edifici, strumenti, emi-cicli, aule, riviste e pubblicazioni torni, anche grazie ainuovi media, a permettere alle idee di confrontarsi in unintreccio di ipotesi scientificamente de-liranti che amplificae autolimita tale produzione istituente sino a costruire unanarrazione scientifica libera, pubblicamente condivisa e so-cialmente utile. Oggi i grandi e meno grandi laboratori diricerca sono dotati di un ufficio brevetti, con una schiera diconsulenti legali, finanziari, economici ecc.
Le scoperte scientifiche si annunciano prima in confe-renza stampa che nelle sedi accademiche dove rischiereb-bero di essere discusse. Un rischio reale, che muove equili-bri di potere ed economici perché, come sostiene Mullis(1998, p. 120), premio Nobel per la chimica,
probabilmente il progresso scientifico più importante del XX
secolo è il fatto che l’economia ha rimpiazzato la curiosità co-me forza motrice della ricerca scientifica.
Inoltre, la constatazione che l’intervallo di tempo trauna scoperta scientifica e la sua applicazione di mercatosta sempre più riducendosi in molti settori di ricerca (bio-tecnologie, chimica, fisica, farmacologia, genetica, ecc.)porta a una secretazione, in nome della proprietà intellet-
STORIE UMANE DI (NEURO)SCIENZA E SISTEMI DI CURA
tuale (copyright), di tutto il processo retrostante di studi,procedimenti, risultati e soprattutto dubbi e ambiguitàche impedisce letteralmente una discussione scientificacritica evitando di ritardare l’immissione di prodotti sulmercato.
Mi sembra intuitivo che la scienza sia intrinsecamenteun processo aperto che deve costantemente mettere in di-scussione non solo i risultati delle proprie ricerche ma an-che i fondamenti che le sottendono.
La scienza – afferma Varela – in modo forse più lampante diquanto si verifica in qualsiasi altro campo, è una danza checrea, nel senso che è la propria visione di se stessa a plasmareciò che costituisce gli oggetti e le spiegazioni valide (Ceruti1989, p. 7).
Ogni società tende a confermare e riprodurre se stessacome un organismo autopoietico. Ogni deviazione dell’im-maginario costituito è ricondotta entro la struttura autoe-quilibrantesi. Sono le incursioni nell’immaginario costi-tuente che perturbano tale equilibrio generando nuovecreazioni. Ciò che produce creatività porta all’autonomia, el’autonomia fondata sulla creatività poggia le sue basi di re-sponsabilità sull’effimero e non sull’universale; per questopone le condizioni di un’etica laica, attraverso una raziona-lità riflessiva in cui le regole generali vengono continua-mente ridiscusse attraverso le regole personali.
È indubbio che la ricerca scientifica si avvale di un me-todo sperimentale che porta, attraverso l’oggettivazionedel mondo, ad applicazioni (tecnologia) la cui efficacia èpalesemente insuperata.
Ma la Scienza, anche nella sua accezione religiosa, do-vrebbe essere riconosciuta scienza dell’uomo per l’uomo,ovvero scienza sociale: nel senso naturalistico-religioso loè nelle sue finalità mentre la struttura portante è di carat-tere metafisico; nel senso anti-naturalistico e storicizzatolo è anche nelle sue fondamenta mitopoietiche.
Le scienze sono, comunque, scienze sociali.
MICHELE CAPARARO
Antropomorfismo neuronale
Bisogna ancora costruire nel nostro encefaloun’immagine dell’uomo, un’idea che sia comeun modello che possiamo contemplare e che siaddica al suo avvenire (Changeaux 1983, p.330).
Le neuroscienze cercano di rispondere alla domanda:che cosa ci facciamo noi nell’universo?
Le neuroscienze si fondano su due assunti dominanti:1. I circuiti e i programmi cerebrali sono la sede di tutti
i fenomeni cognitivi e rappresentano all’interno del cervel-lo le informazioni provenienti dal mondo esterno.
2. Questi circuiti e programmi si sono evoluti come ipiù adatti rappresentanti del mondo abitato da esseri vi-venti (ovvero garantiscono al meglio possibile in terminiadattivi un isomorfismo tra realtà e rappresentazione)(Hayward, Varela, a cura, 1992).
Senza entrare nel merito di una discussione ontologicasull’esistenza o meno di una realtà esterna da percepire, amio parere queste due premesse hanno una caratteristicacomune cruciale: sono causalmente unidirezionali.
La scienza cerca il senso dell’esistenza dell’uomo e l’ori-gine della coscienza dentro il cervello, ma non si accorgeche l’isomorfismo applicato è sempre ricorsivo.
L’uomo indaga le strutture e i processi neuronali attra-verso un linguaggio metaforico coerente con i diversi para-digmi dominanti in un determinato periodo storico: l’ideadi Pneuma dell’antica Grecia, poi le teorie umorali legateai movimenti dei fluidi e del loro equilibrio, l’organismocome orologio nell’universo newtoniano, il concetto diazione/reazione con la scoperta dell’arco riflesso del siste-ma nervoso, quindi il cervello come meccanismo elettrico aflussi di energia e ancora l’immagine della rete di neuronicon le teorie dei sistemi e poi della complessità, fino allarecente metafora musicale del cervello come orchestra conle sue sintonie, sincronie e sinfonie.
STORIE UMANE DI (NEURO)SCIENZA E SISTEMI DI CURA
Ogni epoca storica si ritrova in un cervello che la ri-specchia dal punto di vista dei paradigmi scientifici vigentie dell’ordinamento sociale che le è proprio.
I neuroni nascono, migrano, si riuniscono in gruppi,lottano, competono, vincono, cooperano, scelgono, danza-no, suonano, muoiono, si suicidano (apoptosi) proprio co-me gli esseri umani in una società. Questo antropomorfi-smo neuronale è la semiotica implicita e per lo più inconsa-pevole delle neuroscienze.
Il primo evento regressivo accade in prossimità del momentoin cui i neuroni di ogni popolazione cominciano a formareconnessioni entro i propri rispettivi campi di proiezione: que-sta fase è caratterizzata dalla morte selettiva di una significati-va proporzione (circa il 50%) della popolazione iniziale dicellule (Asbury, McKhan 1992, p. 8).
Il tono di questo enunciato, preso dall’introduzione di unautorevole trattato di clinica neurobiologica, se ricontestualiz-zato ha un evidente respiro storico-sociale: vi sono popolazio-ni che migrano, si incontrano, si connettono e proiettano indeterminati campi e una percentuale elevata di esse muore.
La scienza, consapevole di non poter fare a meno dimetafore, le rende così implicite da scordare talvolta la loronatura parziale e ricombinatoria nel parlare di qualcosa at-traverso qualcos’altro. Questo è il senso attraverso il qualeio interpreto l’affermazione di Changeaux in epigrafe. Ab-biamo già costruito nel nostro cervello un’immagine, nondell’uomo ma di intere popolazioni (di neuroni) in evolu-zione che convivono e interagiscono.
Così come tutto il sapere occidentale ruota attorno alladottrina dell’io (l’individuo come oggetto primo di studio),le neuroscienze fondano la struttura di indagine del cervel-lo sulla dottrina del neurone. In breve tale dottrina (riscon-trabile in qualsiasi manuale di neurologia) sostiene che laparte nobile del sistema nervoso sia costituita dai neuroni;le altre cellule che lo costituiscono (cellule della glia so-prattutto) offrono un supporto strutturale e metabolico,
MICHELE CAPARARO
riempiendo tutto lo spazio non occupato dai neuroni, co-stituendo l’impalcatura del parenchima. Questa visione ari-stocratica del tessuto cerebrale che distingue, in primis, tracellule nobili e cellule che occupano lo spazio rimanente,costruisce di per sé una precisa gerarchia di valori che mipare arduo attribuire alla natura della materia cerebrale.Questo pregiudizio socio-scientifico è ancora forte e quasisempre inconsapevole nonostante recenti ricerche di labo-ratorio evidenzino, per esempio, un ruolo fondamentaledelle cosiddette cellule di supporto (neuroglia) non solonella modulazione ma anche nella trasmissione stessa(ephatic conduction) dell’impulso nervoso (Fields, Ste-vens-Graham 2002).
Nelle popolazioni “occupanti lo spazio rimanente delcervello” (nove volte più numerose dei neuroni) si comin-ciano a rilevare i primi segnali di insofferenza: a quandouna presa della Bastiglia nelle neuroscienze?
Nelle ricerche correnti in campo neuroscientifico al di-segno divino si è sostituito il pensiero populazionista, nelquale popolazioni di neuroni sono sottoposte alla selezionenaturale, neo-divinità incontestabile. Ma Gould, ancorauna volta, ci mette in guardia da un’interpretazione diDarwin che, certo, ora ammette l’elemento aleatorio dell’e-voluzione, ma fatica ad accettare l’implicazione più scon-volgente che il concetto di exaptation mette in gioco (spes-so dimenticata dai ricercatori che lo utilizzano nello studiodell’evoluzione del sistema nervoso) ovvero l’assenza diuna progressione, di un processo costante di ottimizzazio-ne. L’essere umano con il suo meraviglioso cervello non è ilmeglio di nulla, semplicemente è. Le conseguenze in cam-po etico sarebbero incalcolabili se, come sostiene Ricoeur,dovessimo accettare l’idea di Gould che l’evoluzione nonsolo è aleatoria ma non presenta alcuna progressività, nes-suna ascesa, nessun processo migliorativo, “significa la ro-vina dell’idea stessa di discendenza, nel senso di ‘venire da’progressivamente” (Changeaux, Ricoeur 1998, p. 182).
Gould, quindi, non rimette in discussione solamente iltermine evoluzione ma scardina in profondità in maniera
STORIE UMANE DI (NEURO)SCIENZA E SISTEMI DI CURA
drammaticamente scientifica il Mito dell’Uomo che pro-gredisce, nato dalla relazione corpo-cosmo, come scriveMircea Eliade, riportando un’antica citazione:
Il Santissimo ha creato il mondo come embrione. Proprio co-me l’embrione cresce a partire dall’ombelico, così Dio ha ini-ziato a creare il mondo dall’ombelico e di là esso si è espansoin tutte le direzioni (Eliade 1949, p. 32).
e si tratta di un dio molto attuale, se accettiamo di ricono-scerlo nel destino evolutivo dell’uomo verso la perfezio-ne.
Quindi è il nostro sguardo retrospettivo sulla Naturache, in un’esplosione di forme di vita, seleziona a posteriorisolo la linea di discendenza dell’uomo, definendo una tas-sonomia di forme generative e de-generative, che costrui-sce un senso e una norma al nostro esserci e al nostro dive-nire. Cosa potrebbe significare quindi una visione dell’uo-mo come essere aleatorio e contingente, per esempio nelcampo degli studi sulla manipolazione genetica animale evegetale o in quello della sperimentazione su animali vivi?
E allora Edelman (1987) dovrebbe ripensare la teoriadel darwinismo neurale attraverso questi nuovi paradigmientro i quali egli stesso, insieme alle sue popolazioni neuro-nali, non rappresenta più l’eccellenza (come premio No-bel) entro la specie più evoluta (come essere umano) che lanatura possa esprimere, ma soltanto una delle tante storiedei vincitori: ancora oggi, ogni volta che usiamo il termine“adattamento”, nelle accademie come nelle piazze, presup-poniamo una lotta di potere che “tende a trasformare lacompetizione fra narrazioni in una narrazione della compe-tizione” (Bencivenga 1997, p. 33).
Se sappiamo guardare alla struttura organica più raffi-nata e complessa nell’universo conosciuto quale è l’encefa-lo, solo attraverso schemi di competizione e cooperazione,di guerra e alleanze, allora è implicito che la guerra portaalla prevalenza del vincitore, del sopravvissuto, il miglioreal vertice della catena evolutiva.
MICHELE CAPARARO
Nel cervello noi possiamo vedere solo distinzioni cheappartengono alle possibilità del nostro dominio linguisti-co perché il dominio biologico è pleroma, per usare un ter-mine junghiano ripreso da Bateson, che lo definisce “ilmondo in cui gli eventi sono causati da forze e urti e nelquale non vi sono ‘distinzioni’, o, come direi io, ‘differen-ze’”(Bateson 1972, p. 473).
Ogni neuroscienziato dovrebbe considerare attenta-mente il proprio lavoro continuo di “distinzione” bateso-niana dal pleroma, dovrebbe usare la filosofia come terapiadel linguaggio (Wittgenstein), in un continuo lavoro con-trappuntistico che ne sveli ambiguità, limiti e implicazioni(Contessi 2003).
Neuromorfismo tecnologico
Dissertare sull’affascinante questione del rapporto men-te/corpo è un’attività degna di una vita di studi. Ma se di-stolgo lo sguardo, anche solo per un attimo, dal monitor sucui sto scrivendo e osservo intorno e fuori da me (fuori dal-la mia riflessione) vedo esseri viventi e cose che interagisco-no secondo un modello sociale e culturale in cui io stessosono inevitabilmente immerso. Ciò che penso è frutto dellamia storia e della storia delle mie relazioni con gli altri e conl’ambiente. È possibile esimersi dal prendere in considera-zione il contesto attuale nel quale ogni riflessione avviene?
La nostra epoca è forgiata sull’idea che il progresso èimplicitamente un concetto positivo. E che l’evoluzione siaun processo di ottimizzazione (Lewontin 2000).
Lo sviluppo scientifico vede nel processo di aggiungereconoscenza a conoscenza già un valore in sé che nasce dalprincipio indiscutibile del maggiore = migliore.
Quale soluzione ci viene propagandata per migliorare lavita di ogni individuo?
Per aumentare la conoscenza di noi stessi e del mondoche ci circonda, secondo un ormai logoro concetto di be-nessere esclusivamente economico, dobbiamo incrementa-
STORIE UMANE DI (NEURO)SCIENZA E SISTEMI DI CURA
re la ricerca finalizzata alla produzione, al consumo, al pro-fitto, con una logica giustificativa palesemente autoreferen-ziale. In tale ottica le teorie scientifiche sono principalmen-te, come ogni altra teoria proposta nell’attuale civiltà occi-dentale, un prodotto commerciale.
Ciò che determina il successo dei prodotti scientifici nonè tanto quanto sono utili, ma quanti utili possono garantire.
Quanti utili può garantire una teoria tecno-scientificache ricerca nel gene la predicibilità assoluta e lineare dieventi futuri?
Quanti utili può garantire, al contrario, una teoriascientifica che sostiene che l’espressione fenotipica e quellagenotipica di ogni essere vivente si costituiscono in un’inte-razione, determinata da alcuni vincoli, ma caratterizzatadalla unicità di ogni storia individuale e imprevedibile,analizzabile solo in termini probabilistici?
L’unico campo di ricerca che esula nelle sue teorizzazio-ni da una mera questione di profitto è quello militare. Lalogica del controllo prevale su quella del profitto. Ma sonodue logiche che si alimentano l’una dell’altra. La ricadutaconcettuale e pragmatica sulla società civile dello sviluppostrategico e tecnologico militare è così pervasiva da non es-sere ormai più percepita come strutturante un modello so-ciale concepito come naturalmente ordinato: fondato sulcontrollo e sul profitto. Noi combattiamo le nostre batta-glie per farci una posizione così come usiamo tranquilla-mente il forno a microonde6.
Mentre è chiara la logica che muove l’apparato econo-mico-militare, meno intuitivo è che ciò vale anche per l’ap-parato medico-scientifico: entrambi adoratori del controllo.
Michel Foucault, in una conversazione con MichellePerrot che introduce il Panopticon di Bentham, sostieneche alla fine del XVIII secolo sia nata l’igiene sociale e in no-me della pulizia e della salute siano stati effettuati continuicontrolli sulla popolazione. Per Foucault i medici, a queltempo, erano degli specialisti dello spazio (clima, terreno,densità di popolazione, reti idriche e fognarie, mattatoi, ci-miteri, ecc.). Insieme ai militari sono stati i primi ammini-
MICHELE CAPARARO
stratori dello spazio collettivo. In seguito, le mutazioni eco-nomiche iniziate in quel periodo storico,
hanno reso necessario fare circolare gli effetti del potere, at-traverso dei canali sempre più stretti, fino agli stessi individui,fino ai loro corpi, ai loro gesti, a ciascuna delle loro azioniquotidiane (Bentham 1838-43, p. 13).
In quest’epoca caratterizzata da surfisti concettuali sul-l’onda del nuovo millennio, il ritorno alla narrazione, chepermea sempre più ogni campo del sapere umano, va lettocome un recupero di una visione locale, contingente, irri-ducibile a una teoria universale, che è sempre pratica dipotere: un ritorno al corpo, immerso nel suo contesto am-bientale e relazionale, come creatore di senso. Nell’epocadel computer, creatura del novello Frankenstein, cui gri-diamo, dopo aver dato corrente elettrica, “Dai Vita! DaiVita alla mia creatura!” (Brooks 1974), siamo arrivati apensare che la creazione di nuovi supporti di silicio per lamente renda il corpo supporto troppo complesso e in findei conti superato dalla macchina tecnologica come ogget-to di studio. Longo (2000, pp. 111-112) definisce questoprocesso come estroflessione cognitiva che
consiste nella rappresentazione esterna del cervello umano,mediante supporti materiali modulati, di quelli che si chiama-no variamente concetti, pensieri, idee, conoscenze, informa-zioni e via dicendo. L’estroflessione consente di percepire leconoscenze come oggetti, su cui è dunque possibile operarecon metodi e strumenti che non sono più soltanto mentali(interni). (…) Il calcolatore consente dunque di estroflettere(almeno in parte) non solo le conoscenze ma anche le capa-cità di elaborazione delle conoscenze.
L’aspetto interessante di questa rappresentazione com-putazionale del cervello, oltre le implicazioni legate all’eratecnologica per le quali rimando i lettori al testo dell’auto-re, è che l’analogia tra concetti, pensieri, idee che dir si vo-glia e gli oggetti anticipa di molto l’introduzione del com-
STORIE UMANE DI (NEURO)SCIENZA E SISTEMI DI CURA
puter ma appartiene alla struttura metaforica del nostrostesso pensiero concettuale che trae elementi dall’esperien-za percettiva. Lakoff e Johnson (1980) sostengono che leidee sono trattate come oggetti perché l’uomo cerca di co-gliere le astrazioni attraverso ciò che gli appare più concre-to. Le metafore attivamente costruiscono narrazioni coe-renti attraverso un processo di simulazione di un evento fi-sico percepito attraverso una struttura corporea che ne de-termina i vincoli biologici. Noi vediamo nel nostro ambien-te oggetti che si muovono, si accumulano, si dividono, siframmentano, appaiono improvvisamente, contengono al-tri oggetti e ne sono contenuti e così via. Il corpo è vissutocome un contenitore di fenomeni complessi che produco-no salute o malattia. E il cervello è un contenitore che pro-duce oggetti informazionali in tutti i modi possibili chepermette la dicotomia dentro/fuori. È evidente che se con-sideriamo le idee come tali oggetti abbiamo costruito un si-stema metaforico che ci permette di manipolarle. Il proble-ma sorge quando estremizziamo questa analogia fino a so-vrapporre due elementi divisi dal come se e reifichiamo leidee. Se allora le idee diventano oggetti, cerchiamo qualchealtro oggetto, oltre al cervello, che le contenga e costruia-mo un contenitore che mimi la loro elaborazione (compu-ter). Dobbiamo però sempre tenere in considerazione che isupporti interagiscono con il supportato e lo rendono pe-culiare; in questo senso per Macluhan il media è il messag-gio, come sottolinea Longo, e quindi la mente che possia-mo supporre emergere da una rete di computer sarà co-munque irriducibile alla mente che emerge da un corpoche nasce, si sviluppa e muore. Inoltre non possiamo tace-re la ricorsività a più livelli di tale costruzione concettualein cui una metafora (un’idea!) per manipolare le idee co-struisce una visione del funzionamento cerebrale che gene-ra un’altra metafora (computazionale) con la quale inda-ghiamo la prima.
Se prendiamo seriamente in considerazione questo con-tinuo rimando ad altro, questa semiosi illimitata (Pierce),che nasce dalla decostruzione dei codici di significato, ci si
MICHELE CAPARARO
pone di fronte una delicata questione: se ogni segno riman-da ad altri segni possibili ogni narrazione è lecita e priva diogni possibilità di stabilire “dei criteri individuino la neces-saria separazione tra le spiegazioni aberranti e le corretteinterpretazioni” (Fabbri 1998, p. 14).
Paolo Fabbri propone una svolta semiotica con un ri-torno a una “razionalità tradizionale” (ib.) consapevole delsuo impianto metaforico di continuo rimando di significa-zione a qualcosa di altro. In questo senso Fabbri critica l’i-dea costruttivista e dice che “non è possibile, come si erapensato, scomporre il linguaggio” – il mondo – “in unitàsemiotiche minime, per poi ricomporle e attribuire il signi-ficato al testo di cui fanno parte” (p. 20). La svolta semioti-ca, evita, nel campo della cura e della ricerca scientifica,quella dissoluzione della persona (Gadamer 1993) in fram-menti minimi da ricomporre analiticamente e costruiscenella contingenza quei criteri di validazione necessari peruna “corretta spiegazione” (p. 21) ma sempre all’interno di
universi di senso particolari dentro cui ricostruire specificheorganizzazioni di senso, di funzionamento di significato, sen-za con questo vantare la pretesa di ricostruire, almeno perora, generalizzazioni valide in ultima istanza (ib.).
Questa presa di coscienza accomuna le neuroscienze ei sistemi di cura nell’accettazione dell’altro come unicaesperienza possibile di conoscenza e nello stesso tempoproprio perché comprende l’altro si rivela esperienza im-possibile. È questo continuo oscillare tra possibile e im-possibile l’unico spazio di scienza e di cura che generasenso e tenta domande di possibilità alle risposte impossi-bili. Queste domande di possibilità vengono enunciate“come se” io fossi l’altro, come se fossi nel corpo dell’in-terlocutore. Nello stesso modo il nostro pensiero concet-tuale è strutturato in modo che ogni concetto è “come se”fosse un altro concetto. Lo scarto che sempre esiste, l’irri-ducibilità che differenzia me dall’altro e un concetto da unaltro è lo spazio dell’etica. Spazio che contiene ancora tut-
STORIE UMANE DI (NEURO)SCIENZA E SISTEMI DI CURA
te le possibilità, tutte le ramificazioni pensabili e non, incui non c’è logica né determinismo in cui il tempo non è,perché non si è ancora prodotta l’irreversibilità di ogniscelta, non c’è ancora narrazione, c’è presenza, l’immedia-to. La svolta semiotica quindi è un faro che può esserepuntato sui coni d’ombra della Scienza.
Purtroppo la visione scientista dominante confermauna visione della Scienza come istituzione eteronoma,“che afferma di se stessa di non essere opera umana” (Ca-storiadis 1990, p. 38), lasciando intendere un’origine ex-tra-sociale e a-storica, quindi non mitica ma religiosa. Sitratta, dunque, di un’epifania, di un incessante parzialedisvelamento del Reale attraverso tecno-protesi percettivesempre più sofisticate. Un viaggio nell’invisibile del sem-pre più piccolo e del sempre più grande con lo sguardorivolto ossessivamente alle lenti del microscopio e del te-lescopio. Quindi l’incontro del Mito con le storie che fan-no la Storia, dal quale si generano coni d’ombra, è esclusoa priori nel momento in cui produce il paradosso scienti-sta: la Scienza è Religione che mina, per la sua stessa ten-sione verso la verità, i valori di cui pretende di farsi fon-datrice.
È a questo livello di riflessione che dobbiamo chiederciquale teoria rigorosamente scientifica e necessariamente re-lativa della cura e delle neuroscienze dobbiamo abbraccia-re e con quali finalità.
Una teoria scientifica sul funzionamento del sistemanervoso è una metafora fondamentale che influenzaprofondamente le tendenze politiche e sociali attraversouna specifica visione dell’uomo e quindi non è possibileevitare di porsi il problema della sua influenza sulla convi-venza intraspecifica e interspecifica degli uomini e di tuttigli esseri viventi.
Vorrei a questo punto tentare di specificare il miopunto di vista su un’annosa diatriba che poggia, a mio pa-rere su un fraintendimento concettuale. Nozick, filosofoanalitico, nel capitolo Chi vuole il relativismo? del suo ul-timo libro (Nozick 2001) spiega come la preferenza filo-
MICHELE CAPARARO
sofica per l’assolutismo o il relativismo sarebbe di naturaderivata. La visione di un fatto oggettivo viene vissuta co-me risorsa o come vincolo in relazione al fatto che l’osser-vatore ottenga o meno gli obiettivi desiderati secondo ipropri valori e le proprie credenze. Nozick, quindi, sug-gerisce che il relativista assuma una posizione politica nel-la quale esprime insoddisfazione per “le cose come stan-no”. Questa idea è sicuramente condivisibile se si precisache tale posizione, definita da Karl Mannheim (1936) cir-ca settant’anni prima “utopica”, poggia su fondamenta ri-gorosamente scientifiche e non su qualche vaga forma dipost-modernismo. Il sociologo ungherese, proprio per li-berarsi dalle accuse di relativismo sterile che gli venneromosse da tutti i fronti della cultura istituzionalizzata, in-trodusse la distinzione tra relativismo e relazionismo. Secol primo termine si intende l’assenza di criteri controlla-bili di verifica in sede scientifica, allora questa tendenzautopica non è relativistica. Essa afferma, infatti, non giàl’inesistenza di criteri invarianti, bensì che essi non sianoassoluti in quanto si danno solo in rapporto (relazioni-smo) a determinati indici:
Come il fatto che ogni misura nello spazio dipende dalla na-tura della luce non significa che le nostre misure siano arbi-trarie, quanto piuttosto che sono valide in relazione alla luce,così è il relazionismo, e non già il relativismo e l’arbitrarietà inesso implicita, che si applica alle nostre discussioni. Il relazio-nismo non significa che manchino criteri di unità nella di-scussione. Secondo esso, tuttavia, è proprio della natura dicerte affermazioni il non poter venir formulate in assoluto,ma solo in termini della prospettiva posta da una determinatasituazione (p. 81).
In quest’ottica ogni persona che lavora con la scienza enella scienza ha la possibilità di scegliere, in ogni atto, seperseguire i propri studi dentro il contesto di una scienzadella scoperta o dentro una scienza del dominio, perché gliscopi sono diametralmente opposti e incidono in manieradeterminante sulla teoria e sulle scoperte stesse.
STORIE UMANE DI (NEURO)SCIENZA E SISTEMI DI CURA
Romeo amputato: ovvero del “maggiore” e del “minore”
Si può parlare a una nazione intera in nomedel pubblico, eppure il pubblico è meno diun’unica, per quanto umile persona reale(Kierkegaard 1916, p. 22).
Immaginate una camera spoglia, una squallida pensionein un posto qualunque. Un uomo a torso nudo si guardanello specchio. Febbricitante, fatica a reggersi in piedi, maprima di crollare esausto, per un attimo osserva la propriamano seguire sul fianco una lunga ferita lineare con i lembigonfi e arrossati, rozzamente cucita con filo da sutura.Qualche ora prima gli è stato asportato un rene in cambiodi denaro e con sé ha qualche migliaio di dollari e una con-fezione di antibiotici.
Che cosa pensa dei medici, della medicina, del progres-so scientifico?
Che cosa pensa delle astrazioni simbolico-concettuali lecui applicazioni tecnologiche hanno permesso che i suoiorgani divenissero merce con un prezzo di mercato?
In fondo egli rappresenta una delle conseguenze, unasempre più frequente storia minore, del progresso tecnolo-gico della medicina e delle scienze biologiche. Un medio-cre professionista, un ottimo antibiotico, non c’è nemmenobisogno di una sala chirurgica per effettuare l’intervento,basta una camera d’albergo.
Quest’uomo rappresenta l’antitesi del pubblico cheKierkegaard definiva, in tempi non sospetti di dominio ra-dio-televisivo, un fantasma astratto e livellatore che è tutti enessuno, frutto della congiunzione tra l’astrazione dellastampa e l’apatia riflessiva di un’epoca. Ogni essere umanoappartiene al pubblico ogni qualvolta è ciò che non è, ovve-ro quando manca di concrezione, di corporeità (Kierke-gaard 1846). La malattia, il dolore, le ferite del corpo ricon-ducono ogni individuo dal pubblico al sé, rendendolo con-sapevole della lacerante astrazione in cui è immerso nella suanormalità a cui è stato religiosamente educato o sottomesso.
MICHELE CAPARARO
Ogni storia personale, storia minore, dunque, è intrin-secamente costituente (de-generativa) rinegoziando in con-tinuazione il nostro senso di identità con ciò che siamo pergli altri, che siamo stati educati a considerare appuntoastratta opinione pubblica.
La secretazione degli altri possibili sé a favore di un séunitario, dominante e socialmente accettabile è il giogo delpotere della Storia costituita sull’idea di identità.
Pakman (2003) in un bellissimo scritto si chiede
Che tipo di organismi siamo noi per i quali questo locus del-l’identità è così importante? La risposta: noi siamo organismiche hanno la possibilità di vivere nel presente e di costruirerappresentazioni. Il sé è nato nello spazio tra presenza e rap-presentazione.
Ed è in questo spazio, che costituisce i coni d’ombradelle storie minori, che ognuno di noi ha la possibilità direinventarsi attraverso storie di de-generazione, di bugie,segreti, fraintendimenti e sé molteplici e contraddittori.
L’incessante gioco di risonanze tra Storia mitopoieticae storie mitolitiche è un circolo ricorsivo di variazionecontinua. Variazione che è un caleidoscopio minoritariodel divenire (di ognuno) che continuamente esce dallarappresentazione del sé maggioritario (di nessuno), pro-dotto istituzionale che impone coerenza e prevedibilitàper essere considerato autentico e congruente con il ri-co-noscimento sociale. È necessario alienare il nostro sé mag-giore a favore dei compositi sé minori per ricomporre unapropria visione autonoma del mondo. Lo spazio della rap-presentazione è ormai completamente invaso dall’immagi-nario televisivo che detta regole, bisogni e comportamentiadeguati: siamo oltre la società dello spettacolo di De-bord, siamo lo Spettacolo.
Quando Carmelo Bene ha messo in scena lo spettacolodello Spettacolo, con re balbuzienti e personaggi che si(de)costruiscono nel tempo della presenza proprio perchéla rappresentazione è morta, ha suscitato critiche e consen-
STORIE UMANE DI (NEURO)SCIENZA E SISTEMI DI CURA
si di spettatori già morti che solo la malattia, la carne dolo-rante potrebbe risvegliare.
Un esempio straordinario di teatro costituente. Il teatrodi Bene è un microcosmo in evoluzione in cui ciò che pre-vale è l’alternativa, la variazione continua, del maggiore edel minore. Sembra un’espressione reale di ciò che gli evo-luzionisti oggi chiamano exaptation.
Deleuze definisce il teatro di Carmelo Bene, commen-tando il suo Romeo e Giulietta, un teatro per sottrazione,per amputazione.
Ma l’amputazione del potere risulta quasi sempre in-comprensibile, sempre destabilizzante, folle addirittura. Lamaggior parte delle persone passa la vita a ricercare o com-battere il potere all’interno di paradigmi che lo conferma-no e che esse stesse contribuiscono ad alimentare. Così chilo brama ne ricava un’idea di potere entro un ordine natu-rale, chi lo combatte ne sente comunque l’ineluttabilità.
È come se ci fossero due operazioni opposte. Da un lato sieleva a “maggiore”: di un pensiero si fa una dottrina, di unmodo di vivere si fa una cultura, di un avvenimento si fa Sto-ria. Si pretende così di riconoscere e ammirare, ma, in effetti,si normalizza. Succede lo stesso per i contadini delle Puglie,secondo Carmelo Bene: si può dar loro teatro, cinema e persi-no televisione. Non si tratta di rimpiangere il vecchio buontempo, ma di essere sgomenti di fronte all’operazione che su-biscono, l’innesto, il trapianto fatto alle loro spalle per nor-malizzarli. Sono divenuti maggiori. Allora, operazione peroperazione, chirurgia contro chirurgia, si può concepire l’in-verso: in che modo “minorare” (termine usato dai matemati-ci), in che modo imporre un trattamento minore o di minora-zione, per sprigionare dei divenire contro la Storia, delle vitecontro la cultura, dei pensieri contro la dottrina, delle grazieo delle disgrazie contro il dogma? (Deleuze 1979, p. 91).
Che sia questo il paradosso finale? Sarà la minorazione, la malattia a salvare l’uomo?O forse sarà il riconoscimento della dignità delle storie
non umane a darci una speranza?
MICHELE CAPARARO
Un ultimo pensiero di Bencivenga, le cui citazioni inquesto saggio provengono da un unico libro che considerocrudo, intenso e politicamente scorretto
Il significato del mettere storie al centro dell’essere, la sfidamostruosa evocata da questa mossa (mostruosa come la smor-fia di uno scimpanzé: è il vostro stesso viso a essere distorto)consiste al contrario precisamente nel porsi il compito (im-possibile) di pensare storie non umane: storie che i primatidicono con le mani e gli elettroni con lo spin. E consiste nelripensare le storie umane in modo che quel che hanno in co-mune con le storie non umane ne diventi il nucleo essenziale(Bencivenga 1997, p. 73).
Voglio concludere questo saggio de-lirando sul pensierodi Wittgenstein, sostenendo che ciò che ho scritto non èquello che intendevo dire, perché ciò che si vuole dire nonpuò essere detto, ma ciò che si è detto diviene ciò che sivoleva dire.
1 La Alcor è un istituto di crionica che attualmente conserva in azoto li-quido a -196° C 37 corpi di persone decedute nella certezza che in futuro iprogressi della scienza riusciranno in una vera e propria resurrezione. NegliUSA esiste un movimento crionico che fa riferimento a numerosi istituti del ge-nere. La conservazione della sola testa costa 50.000 dollari, di tutto il corpo125.000 dollari.
2 In questo saggio utilizzerò spesso le parole “uomo” e “essere umano” insenso intercambiabile. Questo perché sono figlio della mia cultura e lo sentocome un termine meno tecnicistico e più diffuso nel linguaggio di tutti i gior-ni. Sono consapevole che tale termine deriva da una visione maschile che ten-de, con un certo senso del ridicolo, all’ermafroditismo quando parla di originidell’uomo. È, invero, utopico pensare di utilizzare un solo termine al posto diun altro per uscire da questo androcentrismo diffuso.
3 Dal film Hannibal di Ridley Scott, Dino De Laurentiis, USA 2001.4 Wu Ming è un laboratorio di design letterario, all’opera su diversi me-
dia e per diverse committenze. Il marchio Wu Ming è gestito da un collettivo di agitatori della scrittu-
ra, costituitosi in impresa indipendente di “servizi narrativi”. L’accezioneche diamo al termine è la più vasta immaginabile, fino a coprire attività diraccordo tra letteratura e nuovi media. (da http://www.wumingfounda-tion.com/)
STORIE UMANE DI (NEURO)SCIENZA E SISTEMI DI CURA
5 Fungo allucinogeno utilizzato a scopi rituali dalle popolazioni indigenedel Messico.
6 Il forno a micro-onde è stato presentanto nel 1946 dalla Raytheon Co.,azienda che ha strette relazioni con l’apparato militare statunitense. Attual-mente impegnata nel supporto tecnologico al progetto dello Scudo Stellare diBush & Co, la Raytheon Co. è presente attivamente per quanto riguarda i si-stemi radar e di rilevamento nella guerra in Afghanistan e in quella in Iraq.
MICHELE CAPARARO
Bibliografia
Nel testo, l’anno che accompagna i rinvii bibliografici secondo il sistema au-tore-data è sempre quello dell’edizione in lingua originale, mentre i rimandiai numeri di pagina si riferiscono alla traduzione italiana, qualora in biblio-grafia se ne faccia esplicito riferimento.
AA.VV., 1900, Darwin, and after Darwin, London, Longmans,Green and Co., 2 voll.
Adams, D. L., Horton, J. C., 2003, Capricious Expression of Cor-tical Columns in the Primate Brain, «Nature Neuroscience»,febbraio, 6 (2), pp. 113-114.
Adorno, T. W., et al., a cura, 1950, The Autoritarian Personality,American Jewish Committee; trad it. 1973, La personalità au-toritaria, Milano, Comunità.
Ainsworth, M. D. S., 1967, Infancy in Uganda: Infant Care andthe Growth of Love, Baltimore, John Hopkins UniversityPress.
Almada, V. C., Santos, R. S., 1995, Parental Care in the Rocky In-tertidal: A Case of Adaptation and Exaptation in Mediterra-nean and Atlantic Blennies, «Revs. in Fish Biology and Fishe-ries», 5, pp. 23-37.
American Psychiatric Association, 1994, Diagnostic and StatisticalManual of Mental Desorder, DSM-IV.
American Psychiatric Association, 2000, Diagnostic and StatisticalManual of Mental Desorder - Text Revision, DSM-IV-TR.
American Psychiatric Association, 2002, Cultural Assessment inClinical Psychiatry; trad. it. 2004, Psichiatria culturale: un’in-troduzione, Milano, Raffaello Cortina.
Anderson, P. W., Arrow, K. J., Pines, D., a cura, 1987, The Eco-nomy as an Evolving Complex System, Redwood City (Ca.),Addison Wesley.
Anderson, R., Cissna, K. N., 1997, The Martin Buber - Carl Ro-gers Dialogue. A new transcript with commentary, Albany,State University of New York Press.
Arendt, H., 1929, Liebesbegriff bei Augustin, Berlin, Julius Sprin-ger; trad. it. 2001, Il concetto d’amore in Agostino, Milano, SE.
Arendt, H., 1958, The Human Condition, Chicago, The Univer-sity of Chicago; trad. it. 1964, Vita Activa, Milano, Bompiani.
Aristotele, 1831, Immanuelis Bekkeri edidit Accademia Regia Bo-russica, Berolini, apud Georgium Reimerum.
Aristotele, 2002, Problemi, a cura di M. F. Ferrini, con testo afronte, Milano, Bompiani.
Arnold, E. N., 1994, “Investigating the Origins of Performance Ad-vantage: Adaptation, Exaptation and Lineage Effects”, in Phylo-genetics and Ecology, London, The Linnean Society of London.
Asbury, A. K., McKhan, G. M., McDonald, W. I., et al., 1992, Di-sease of The Nervous System. Clinical Neurobiology, Phila-delphia, W. B. Saunders Company.
Averill, J., 1984, “The Acquisition of Emotions DuringAdulthood”, in C. Malatesta, C. Izard, a cura, Emotion inAdult Development, London, Sage.
Bachtin, M., 1965, Tvorcestvo Fransua Rable i narodnajakul’turasrednevekov’ja i Renessansa; trad. it. 1979, L’opera di Rabelaise la cultura popolare, Torino, Einaudi.
Bachtin, M., 1979, Estetica slovesnogo tvorcestva, Izdatel’stvo«Iskusstvo»; trad. it. 1988, L’autore e l’eroe, Torino, Einaudi.
Bachtin, M., 1981, The Dialogic Imagination, Austin, Universityof Texas Press.
Bakker, R. T., 1975, Dinosaur renaissance, «Scientific American»,aprile, pp. 58-78; trad. it. 1975, La rivincita dei dinosauri, «LeScienze», 84.
Bakker, R. T., Galton, P. M., 1974, Dinosaur Monophyly and aNew Class of Vertebrates, «Nature», 248, pp. 168-172.
Barash, D. P., 1977, Sociobiology and Human Behavior, NewYork, Elsevier.
Barbetta, P., 1998, “Forme del delirio e metodi etnografici in psico-terapia”, in M. Ceruti, G. Lo Verso, a cura, Epistemologia epsicoterapia, Milano, Raffaello Cortina.
Barbetta, P., 2003, Il segno dei tre: Caino, Pierre Rivière e Raskòl-nikov. Analisi del discorso intorno alla violenza tra midrash ediagnosi, «Arcipelago - Rivista di Studi Letterari dell’Univer-sità di Bergamo», n. 2, pp. 71-88.
Barbetta, P., 2004, The Name of the Deceiver: Foucaldian Rea-dings on MCM (anagram of CMM), «Human Systems», in corsodi stampa.
Barbetta, P., a cura, 2003, Le radici culturali della diagnosi, Roma,Meltemi.
BIBLIOGRAFIA
Barnard, N. D., Kaufman, S. R., 1997, Animal Research is Waste-ful and Misleading, «Scientific American», febbraio, pp. 80-82.
Barrow, J., Tipler, F. J., 1986, The Anthropic Cosmological Princi-ple, Oxford-New York, Oxford University Press; trad. it.2002, Il principio antropico, Milano, Adelphi.
Bateson, G., 1958, Naven, Stanford, Board of Trustees of the Le-land Stanford Junior University; trad. it. 1988, Naven, Torino,Einaudi.
Bateson, G., 1972, Steps to an Ecology of Mind, San Francisco,Chandler Publishing Company; trad. it. 1977, Verso un’ecolo-gia della Mente, Milano, Adelphi.
Bateson, P., 1982, Preference for cousins in japanes quail, «Natu-re», 295, pp. 236-237.
Bateson, P., Martin, P., 1999, Design for a Life, New York, Simon& Schuster; trad. it. 2002, Progetto per una vita, Bari, Edizio-ni Dedalo.
Bencivenga, E., 1997, A Theory of Language and Mind, Berkeley-Los Angeles-London, University of California Press; trad. it.2001, Teoria del Linguaggio e della Mente, Torino, Bollati Bo-ringhieri.
Bene, C., Deleuze, G., 2002, Sovrapposizioni, Macerata, Quodilibet.Bentham, J., 1838-43, The Works of Jeremy Bentham, a cura di
John Bowing, Edinborough, Tait, vol. IV; trad. it. 1983, Pa-nopticon, ovvero la Casa d’Ispezione, a cura di M. Foucault,M. Perrot, Venezia, Marsilio.
Bleuler, E., 1950, Dementia Praecox, or the Gorup of Schizophre-nias, New York, International University Press.
Blumenbach, J. F., 1830, Manuale di storia naturale, Milano, Fontana.Boughali, M., 1988, Sociologie des maladies mentales au Maroc,
Casablanca, Afrique Orient.Bowlby, J., 1988, A Secure Base, New York, Basic Books; trad. it.
1988, Una base sicura, Milano, Raffaello Cortina.Boyle, M., 1991, Schizophrenia, a Scientific Delusion?, London-
New York, Routledge; trad. it. 1994, Schizofrenia. Un delirioscientifico?, Roma, Astrolabio.
Branham, R. J., Pearce, B. W., 1985, Between text and context:Toward a rethoric of contextual reconstruction, «QuarterlyJournal of Speech», 71.
Briggs, D. E. G., 1983, “Affinities and Early Evolution of the Crusta-cea. The Evidence of the Cambrian Fossils”, in F. R. Schram, a cu-ra, Crustacean Phylogeny, Rotterdam, A. A. Balkema, pp. 1-22.
BIBLIOGRAFIA
Briggs, D. E. G., Whittington, H. B., 1985, Modes of Life of Arthro-pods from the Burgess Shale, British Columbia, «Transactions ofthe Royal Society of Edinburgh», Edinburgh, 76, pp. 149-160.
Brockman, J., 1995, The Third Culture, New York, BrockmanPubl.; trad. it. 1995, La terza cultura, Milano, Garzanti.
Brooks, M., 1974, Frankenstein Junior, Produzione Fox, USA.Burr, V., 1995, An Introduction to Social Constructionism, Lon-
don, Routledge.Canetti, E., 1960, Masse und Macht, Hamburg, Claassen Verlag;
trad. it. 1997, Massa e Potere, Milano, Adelphi.Capararo, M., 2003, “Il discorso medico sulla diagnosi”, in Bar-
betta, a cura, 2003.Carassiti, A. M., 1997, Dizionario etimologico, Genova, Odysseus.Castoriadis, C., 1975, L’Institution Imaginaire de la Société, Paris,
Éditions du Seuil; trad. it. 1995, L’Istituzione Immaginariadella Società, Torino, Bollati Boringhieri.
Castoriadis, C., 1990, Le Monde Morcelé, Figures du Pensable,Paris, Éditions du Seuil; trad. it. 2001, La Rivoluzione demo-cratica. Teoria e progetto dell’autogoverno, Milano, Elèuthe-ra.
Catton, W. R., 1998, Darwin, Durkheim and Mutualism, «Advan-ces in Human Ecology», vol. 7, JAI Press Inc., pp. 89-138.
Cecchin, G., 1987, Hypothesizing, Circularity, and Neutrality Revisi-ted: An Invitation to Curiosity, «Family Process.», 26, 405-413.
Ceruti, M., 1986, Una variante epistemologica dei modelli evoluti-vi, «Metamorfosi», n. 2, 39-59.
Ceruti, M., 1989, La danza che crea, Milano, Feltrinelli.Changeaux, J. P., 1983, L’Homme Neuronal, Paris, Fayard; trad.
it. 1998, L’Uomo Neuronale, Milano, Feltrinelli.Changeaux, J. P., Ricoeur, P., 1998, La Nature et la Règle, Paris,
Éditions Odile Jacob; trad. it. 1999, La Natura e la Regola,Milano, Raffaello Cortina Editore.
Chatterjee, S., 1997, The Beginning of Avian Flight, «Proc. Sym-posium Sponsored by Arizona State University», pp. 311-335.
Chiaretti, G., Barbetta, P., 2000, L’ascolto polifonico, Milano, Angeli.Cioran, E. M., 1934, Pe Culmile Disperarii, Bucuresti; trad. it.
1998, Al Culmine della Disperazione, Milano Adelphi.Coates, M. I., Clack, J. A., 1990, Polydactyly in the earliest known
tetrapod limbs, «Nature», 347, pp. 66-69. Coddington, J. A., 1988, Cladistic Tests for Adaptational Hypothe-
ses, «Cladistic», 4, pp. 3-22.
BIBLIOGRAFIA
Contessi, R., 2003, La forma del linguaggio: natura ed etica nellafilosofia di Wittgenstein, Roma, Meltemi Editore.
Cronen, V., 1991, “Coordinated Management of Meaning Theoryand Postenlightenment Ethics”, in K. J. Greenberg, a cura,Conversations on Communication Ethics, (N.J.), Ablex.
Cronen, V., Johnson, K., Lannaman, J., 1982, Paradoxes, doublebinds and reflexive loops: an alternative theoretical perspective,«Family Process», 21.
Damasio, A., 1994, Descartes’Error, New York, Avon Books; trad.it. 1995, L’errore di Cartesio, Milano, Adelphi.
Darnton, J., 1996, Neanderthal, New York, Mass Market Publ.;trad. it. 1997, Neanderthal, Milano, Rizzoli.
Darwin, C., 1859, On the Origin of Species by Means of NaturalSelection or the Preservation of Favored Races in the Struggleof Life; 6a ed. 1872, London, Murray; trad. it. 1967, L’originedelle specie, Torino, Bollati Boringhieri.
Darwin, C., 18772, The Various Contrivances by which Orchids areFertilised by Insects, London, Murray; trad. it. 1883, I diversiapparecchi per mezzo dei quali le orchidee vengono fecondatedagli insetti, Torino, Utet.
Davis, D. D., 1964, The Giant Panda: a morphological study ofevolutionary mechanisms, «Fieldiana Memoirs Zoology», 3,pp. 1-339.
Dawkins, R., 1976, The Selfish Gene, New York, Oxford Univer-sity Press; trad. it. 1982, Il gene egoista, Bologna, Zanichelli.
Dawkins, R., 1986, The Blind Watchmaker, London, Longman;trad. it. 1990, L’orologiaio cieco, Milano, Rizzoli.
Dawkins, R., 2003, A Devil’s Chaplain, New York, HoughtonMifflin; trad. it. 2004, Il cappellano del diavolo, Milano, Corti-na Editore.
Deacon, T., 1997, The Symbolic Species, New York, Norton; trad.it. 2001, La specie simbolica, Roma, Fioriti Editore.
Deleuze, G., 1979, Un manifeste de Moins, Les Éditions de Mi-nuit; trad. it. 2002, in Bene, Deleuze 2002.
Deleuze, G., 1993, Critique et clinique, Paris, Les Éditions de Mi-nuit; trad. it. 1996, Critica e clinica, Milano, Raffaello Cortina.
Deleuze, G., Guattari, F., 1972, L’Anti-Oedipe, Paris, Les Édi-tions de Minuit; trad. it. 1975, L’anti-Edipo, Torino, Einaudi.
Deleuze, G., Guattari, F., 1980, Mille plateaux. Capitalisme e schi-zophrénie, Paris, Les Éditions de Minuit; trad. it. 1997, Rizo-ma, Roma, Castelvecchi.
BIBLIOGRAFIA
Dennett, D., 1995, Darwin Dangerous Idea, New York, Simonand Schuster; trad. it. 1997, L’idea pericolosa di Darwin, Tori-no, Bollati Boringhieri.
Dizard, J. E., Gadlin, H., 1990, The Minimal Family, Amherst(Mass.), The University of Massachusetts Press.
Doane, J. A., Diamond, D., 1994, Affect and Attachment in theFamily, New York, Basic Books; trad. it. 1995, Affetti e attac-camento nella famiglia, Milano, Raffaello Cortina.
Dollo, L., 1892, Sur l’origine de la nageoire caudale des ichthyo-saures, «Procès-Verbaux de la Société Belge de Géologie».
Dollo, L., 1893, Les lois de l’évolution, «Bullettins de la SociétéBelge de Géologie, de Paléontologie et d’Hydrologie», vol.vii.
Doolittle, W. F., Sapienza, C., 1980, Selfish Gene, the phenotypeparadigm and genome evolution, «Nature», 284, pp. 601-603.
Dyson, F., 1979, Disturbing the Universe, New York, Harper &Row; trad. it. 1981, Turbare l’universo, Torino, Bollati Borin-ghieri.
Eble, G. T., 1999, On the Dual Nature of Chance in EvolutionaryBiology and Paleobiology, «Paleobiology», 25, pp. 75-87.
Edelman, G., 1987, Neural Darwinism: The Theory of NeuronalGroup Selection, Basic Books; trad. it. 1995, Darwinismo neu-ronale: La teoria della selezione dei gruppi neuronali, Torino,Einaudi.
Edelman, G. M., Tononi, G., 2000, A Universe of Consciousness.How Matter Becomes Imagination, New York, Basic Books;trad. it. 2002, Un universo di coscienza, Torino, Einaudi.
Ehremberg, A., 1998, La fatigue d’être soi. Depression et société,Paris, Odile Jacob; trad. it. 1999, La fatica di essere se stessi,Torino, Einaudi.
Eibl-Eibesfeldt, I., 1970, Liebe und Hass, München, Piper & co.;trad. it. 1971, Amore e odio, Milano, Adelphi.
Ekman, P., Friesen, W., 1975, Unmasking the Face, EnglewoodCliffs (N.J.), Prentice Hall.
Eldredge, N., 1995, Reinventing Darwin, New York, Wiley andSons; trad. it. 1999, Ripensare Darwin, Torino, Einaudi.
Eldredge, N., 1999, The Pattern of Evolution, New York, Free-man; trad. it. 2002, Le trame dell’evoluzione, Milano, CortinaEditore.
Eldredge, N., 2004, Why We Do It. Rethinking Sex and the Selfi-sh Gene, New York, Norton.
BIBLIOGRAFIA
Eldredge, N., Tattersall, I., 1982, The Myths of Human Evolution,New York, Columbia University Press; trad. it. 1984, I mitidell’evoluzione umana, Torino, Bollati Boringhieri.
Eliade, M., 1949, Le Mythe de l’Éternel Retour - Archétipes etRépétition, Paris, Gallimard; trad. it. 1968, Il Mito dell’EternoRitorno, Roma, Edizioni Borla.
Eysenck, H. J., 1977, Crime and Personality, London, Paladin.Fabbri, P., 1998, La svolta semiotica, Bari, Laterza.Falk, D., 1992, Braindance, New York, Henry Holt and C.Fields, R. D., Stevens-Graham, B., 2002, New Insights into Neu-
ron-Glia Communication, «Science», ottobre, 18, 298, pp.556-562.
Fort, G. A., 1871, Anatomia descrittiva e dissezione, Milano, Gae-tano Brigola, Editore-librajo.
Foucault, M., 1954, Maladie mentale et psychologie, Paris, PUF;trad. it. 1997, Malattia mentale e psicologia, Milano, RaffaelloCortina.
Foucault, M., 1963, Naissance de la Clinique. Une Archéologie duRegard Médical, Paris, PUF; trad. it. 1969, Nascita della Clini-ca. Il ruolo della medicina nella costituzione delle scienze uma-ne, Torino, Einaudi.
Foucault, M., 1972, Histoire de la folie à l’âge classique, Paris,Gallimard; trad. it. 19815, Storia della follia nell’età classica,Milano, Rizzoli.
Freud, S., 1943, “Psychoanalytische Bamerkungen ueber einemautobiographisch beschreibenen Fall von Paranoia (Dementiaparanoides)”, in Gesammelte Werke, VIII; trad. it. 1991, Casiclinici, Torino, Boringhieri.
Friedan, B., 1963, The Feminine Mystique, New York, Norton.Gadamer, H. G., 1993, Uber die Verborgenheit der Gesundheit,
Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag; trad. it. 1994, Dove sinasconde la salute, Milano, Raffaello Cortina.
Gamble, C., 1994, Timewalkers. The Prehistory of Global Coloni-zation, Cambridge (Mass.), Harvard University Press.
Geertz, C., 1975, “From the native’s point of view”: On the Natureof Anthropological Understanding, «American Scientist», n. 63.
Geertz, C., 1987, Thick description, «Aut Aut», n. 217-218, pp.151-176.
Gell-Mann, M., 1995, The Quark and the Jaguar, New York,Freeman; trad. it. 1996, Il quark e il giaguaro, Torino, BollatiBoringhieri.
BIBLIOGRAFIA
Ghiselin, M., 1969, The Triumph of Darwinian Method, Berkeley,University of California Press.
Goodwin, B., 1994, How the Leopard Changed Its Spots: the Evo-lution of Complexity, New York, Simon and Schuster.
Gordimer, N., 1995, Writing and Being; trad. it. 1996, Scrivere edessere, Milano, Feltrinelli.
Gould, S. J., 1977a, Ever Since Darwin, New York, W. W. Nor-ton; trad. it. 1984, Questa idea della vita, Roma, Editori Riu-niti.
Gould, S. J., 1977b, Ontogeny and Phylogeny, Cambridge(Mass.), Harvard University Press.
Gould, S. J., 1980, The Panda’s Thumb, New York, W. W. Nor-ton; trad. it. 1983, Il pollice del panda, Roma, Editori Riuniti.
Gould, S. J., 1983, Hen’s Teeth and Horse’s Toes, New York, W.W. Norton; trad. it. 1984, Quando i cavalli avevano le dita,Milano, Feltrinelli.
Gould, S. J., 1985, The Flamingo’s Smile, New York, W. W. Nor-ton; trad. it. 1987, Il sorriso del fenicottero, Milano, Feltrinelli.
Gould, S. J., 1987a, An Urchin in the Storm. Essays about Booksand Ideas, New York, W. W. Norton; trad. it. 1991, Un riccionella tempesta, Milano, Feltrinelli.
Gould, S. J., 1987b, Time’s Arrow, Time’s Cycle. Myth and Me-taphor in the Discovery of Geological Time, Cambridge(Mass.), Harvard University Press; trad. it. 1989, La frecciadel tempo, il ciclo del tempo, Milano, Feltrinelli.
Gould, S. J., 1989, Wonderful Life. The Burgess Shale and the Na-ture of History, New York, W.W. Norton; trad. it. 1990, La vi-ta meravigliosa, Milano, Feltrinelli.
Gould, S. J., 1991a, Bully for Brontosaurus, New York, W. W.Norton; trad. it. 1994 (parti 6-10), Risplendi grande lucciola,Milano, Feltrinelli.
Gould, S. J., 1991b, Bully for Brontosaurus, New York, W. W.Norton; trad. it. 1992 (parti 1-5), Bravo Brontosauro, Milano,Feltrinelli.
Gould, S. J., 1993, Eight Little Piggies, New York, W. W. Norton;trad. it. 1994, Otto piccoli porcellini, Milano, Bompiani.
Gould, S. J., 1996, Full House, New York, Three Rivers Press;trad. it. 1997, Gli alberi non crescono fino in cielo, Milano,Mondadori.
Gould, S. J., 1997, Dinosaur in a Haystack, New York, HarmonyBooks.
BIBLIOGRAFIA
Gould, S. J., 1998, Leonardo’s Mountain of Clams and the Diet ofWorms, New York, Harmony Books; trad. it. 2004, I fossili diLeonardo e il pony di Sofia, Milano, il Saggiatore.
Gould, S. J., 2002a, I Have Landed, New York, Harmony Books. Gould, S. J., 2002b, The Structure of Evolutionary Theory,
Cambridge (Mass.), Harvard University Press; trad. it.2003, La struttura della teoria dell’evoluzione, Torino, Codi-ce Edizioni.
Gould, S. J., 2003, The Hedgehog, the Fox and the Magister’s Pox,New York, Harmony Books.
Gould, S. J., Lewontin, R. C., 1979, The Spandrels of San Marcoand the Panglossian Paradigm: a Critique of the AdaptationistProgramme, «Proc. R. Soc. London», B, 205, pp. 581-98;trad. it. 2002, I pennacchi di San Marco e il paradigma di Pan-gloss: critica al programma adattazionista, Torino, Einaudi.
Gould, S. J., Lloyd, E., 1999, Individuality and Adaptation AcrossLevels of Selection, «Proc. of Nat. Acad. Set. USA», 96, pp.11.904-11.909.
Gould, S. J., Raup, D., Sepkoski, J., Schopf, T., Simberloff, D.,1977, The Shape of Evolution: a Comparison of Real and Ran-dom Clades, «Paleobiology», 3, pp. 23-40.
Gould, S. J., Vrba, E., 1982, Exaptation, a Missing Term in theScience of Form, «Paleobiology», 8 (1), pp. 4-15.
Greenblatt, S., 1991, Marvelous Possessions, Oxford, Clarendon;trad. it. 1994, Meraviglia e possesso, Bologna, il Mulino.
Haley, J., 1959, An Interactional Description of Schizophrenia,«Pshychiatry», vol. 22, n. 4, 321-332.
Harlow, H. F., 1958, The Nature of Love, «American Psychologi-st», 13, pp. 673-685.
Harré, R., a cura, 1986, The Social Construction of Emotions,Oxford, Basil Blackwell.
Hayward, J. W., Varela, F. J., a cura, 1992, Gentle Bridges: Con-versations with the Dalai Lama on the Sciences of Mind, Bo-ston, Shambhala Publications; trad. it. 1998, Ponti sottili.Conversazioni del Dalai Lama sulla scienza della mente, Vicen-za, Neri Pozza Editore.
Heelas, P., 1986, “Emotion Talk across Cultures”, in R. Harré, acura, 1986.
Hendriks, W., Leunissen, J., Nevo, E., Bloemendal, H., de Jong,W. W., 1987, The Lens Protein alpha-A-crystallin of the BlindMole Rat Spalax ehrenbergi: Evolutionary Change and Func-
BIBLIOGRAFIA
tional Constraints, «Proceedings of the National Academy ofSciences», 84, pp. 5.320-5.324.
Holland, J., 1992, Adaptation in Natural and Artificial Systems,Cambridge (Mass.), Mit Press.
Hopson, J. A., 1977, Relative Brain Size and Behavior in Archo-saurian Reptiles, «Annual Review of Ecology and Systema-tics», 8, pp. 429-448.
Horkheimer, M., 1999, Critical Theory, New York, The Conti-nuum Publishing Company.
Houston, A. I., 1997, Are the Spandrels of San Marco Really Pan-glossian Pendentives?, «Trends Ecol. Evol.», 12, p. 125.
Hull, D. L., Ruse, M., a cura, 1998, The Philosophy of Biology,Oxford, Oxford University Press.
Humphrey, N., 1987, The Uses of Consciousness, New York,American Museum of Natural History Library.
Humphrey, N., 1993, A History of the Mind. Evolution and theBirth of Consciousness, New York, Simon and Schuster; trad.it. 1998, Una storia della mente, Torino, Instar Libri.
Huxley, A., 1946, Science, Liberty and Peace, New York-Lon-don; trad. it. 2002, Scienza, Libertà e Pace, Edizioni Medusa.
Huxley, J., 1932, Problems of Relative Growth, London, Mac-Veagh; rist. 1972, Dover, Paperback.
Hymes, D., 1967, “On communicative competence”, in R. Huxley,E. Ingram, a cura, Mechanisms of Language Development,London, Centre for Advanced Study in the DevelopmentalScience and CIBA Foundation.
Jablonski, N. G., Chaplin, G., 1999, Chimp Cultural Diversity,«Science», 285, pp. 836-837.
Jacob, F., 1970, La logique du vivant. Une histoire de l’hérédité,Paris, Éditions Gallimard; trad. it. 1971, La logica del vivente,Torino, Einaudi.
Jacob, F., 1978, Evoluzione e bricolage, Torino, Einaudi.Jacob, F., 1981, Les jeux des possibles, Paris, Seuil; trad. it. 1983,
Il gioco dei possibili, Milano, Mondadori.Jakobson, R., 1976, Ein Blick auf Die Aussicht von Hoelderlin,
Berlin, Suhrkamp; trad. it. 1979, Hoelderlin, l’arte della paro-la, Genova, Il Melangolo.
Jaspers, K., 1948, “Allgemeine Psychopathologie”, cit. in J. Staro-binski, 1999, Action et Réaction. Vie et Aventures d’unCouple, Paris, Éditions de Seuil; trad. it. 2001, Azione e rea-zione: vita e avventura di una coppia, Torino, Einaudi.
BIBLIOGRAFIA
Jenzen, D. H., 1976, Why Bamboos wait so long to flower, «An-nual Review of Ecology and Systematics».
Joyce, J., 1937, Ulysses, London, The Bodley Head; trad. it. 1960,Ulisse, Milano, Mondadori.
Jung, C. G., 1907, Ueber die Psychologie der Dementia praecox:ein Versuch; trad. it. 1971, “Psicologia della dementia prae-cox”, in Opere, Torino, Boringhieri, vol. 3.
Kauffman, S., 1993, The Origins of Order, Oxford-New York,Oxford University Press.
Kauffman, S., 1995, At Home in the Universe, Oxford-NewYork, Oxford University Press; trad. it. 2001, A casa nell’uni-verso, Roma, Editori Riuniti.
Kauffman, S., 2000, Investigations, New York, Oxford UniversityPress.
Kermode, F., 1967, The Sense of an Ending, New York, OxfordUniversity Press.
Kermode, F., 1979, The Genesis of Secrecy, Cambridge, Cambrid-ge University Press.
Ketterson, E. D., Nolan Jr., V., 1999, Exaptation, Adaptation, andConstraint: a Hormonal Perspective, «American Naturalist»,153, S4-S25.
Kierkegaard, S., 1916, Kritik der Gegenwart, Jena, Eugen Diede-richs; trad. it. 1994, Due Epoche, Viterbo, Stampa alternativa.
Kimura, M., 1983, The Neutral Theory of Molecular Evolution,Cambridge, Cambridge University Press.
Kingsolver, J. G., Koehl, M. A. R., 1985, Aerodynamics, Thermo-regulation, and the Evolutionary Change, «Evolution», 39, pp.488-504.
Koestler, A., 1979, The Case of the Midwife Toad, New York,Random House; trad. it. 1979, Il caso del rospo ostetrico, Mi-lano, Jaca Book.
Kristeva, J., 2001, Hannah Arendt, New York, Columbia Univer-sity Press.
Lacan, J., 1991, Le séminaire. Livre XVII. L’envers de la Psychoa-nalyse, Paris, Seuil; trad. it. 2001, Il seminario, libro XVII, Ilrovescio della psicoanalisi, Torino, Einaudi.
Lakoff, G., Johnson, M., 1980, Metaphors We Live By, Chicago,University of Chicago Press; trad. it. 1998, Metafora e VitaQuotidiana, Milano, Bompiani.
Latouche, S., 2001, L’invenzione dell’economia, Bologna, AriannaEditrice.
BIBLIOGRAFIA
Levi, P., 1957, Se questo è un uomo, Torino, Einaudi.Lévi-Strauss, C., 1962, Le pensée sauvage, Paris, Plon; trad. it.
1964, Il pensiero selvaggio, Milano, il Saggiatore.Lewin, R., 1997, Patterns in Evolution. The New Molecular View,
New York, Scientific American Library.Lewis-Fernandez, R., Kleinman, A., 1995, Cultural Psychiatry.
Theoretical, Clinical, and Research Issues, «Psychiatric Clinicsof North America», settembre, 18 (3), pp. 433-448.
Lewontin, R. C., 1977, “Adattamento”, in Enciclopedia Einaudi,Torino, vol. 1, pp. 198-214.
Lewontin, R. C., 1978, “L’adattamento”, in V. Parisi, L. Rossi, acura, 1985, Adattamento Biologico, Quaderni di «Le Scien-ze», n. 27, pp. 3-13.
Lewontin, R. C., 1991, Biologia come ideologia. La dottrina delDna, Torino, Bollati Boringhieri.
Lewontin, R. C., 1998, Gene, organismo e ambiente, Roma-Bari,Laterza.
Lewontin, R. C., 2000, It Ain’t Necessarily So: The Dream of theHuman Genome and Other Illusions, New York, New YorkReview of Books; trad. it. 2002, Il sogno del genoma umano ealtre illusioni della scienza, Roma-Bari, Laterza.
Lieberman, Ph., 1991, Uniquely Human, Cambridge (Mass.),Harvard University Press.
Lloyd, M., Dybus, H. S., 1966, The Periodical Cicada Problem,«Evolution», 20, pp. 133, 49.
Longo, O. G., 2000, Il nuovo golem: come il computer cambia lanostra cultura, Bari, Laterza.
Lull, R. S., 1924, Organic Evolution, New York, Macmillan. Luria, S. E., Gould, S. J., Singer, S., 1981, A View of Life, (Ca.),
The Benjamin - Cummings Co.; trad. it. 1984, Una visionedella vita. Introduzione alla biologia, Bologna, Zanichelli.
MacArthur, R., Wilson, E. O., 1967, The Theory of Island Biogeo-graphy, Princeton, Princeton University Press.
Mannheim, K., 1936, Ideology and Utopia, New York, HarcourtBrace Jovanovich; trad. it. 1999, Ideologia e Utopia, Bologna,il Mulino.
Marinetti, T. F., 1913, Distruzione della sintassi, immaginazio-ne senza fili, parole in libertà, Manifesto Futurista, 11 mag-gio.
Markey, T., 1997, The Problem of Runic Origins, preprint, Tucson(Ariz.)
BIBLIOGRAFIA
Maturana, H. R., Varela, F. J., 1980, Autopoiesis and Cognition. TheRealization of the Living; trad. it. 1985, Autocoscienza e realtà.La realizzazione del vivente, Milano, Raffaello Cortina Editore.
Mayr, E., 1991, One long Argument. Charles Darwin and the Ge-nesis of Modern Evolutionary Thought, Cambridge (Mass.),Harvard University Press; trad. it. 1994, Un lungo ragiona-mento. Genesi e sviluppo del pensiero darwiniano, Torino,Bollati Boringhieri.
Merleau-Ponty, M., 1964, Le Visible et l’Invisible, Paris, ÉditionGallimard; trad. it. 1999, Il visibile e l’invisibile, Milano,Bompiani.
Monod, J., 1970, Le hasard et la nécessité, Paris, Éditions duSeuil; trad. it. 1970, Il caso e la necessità, Milano, Mondadori;rist. 1997.
Montgomery, M. K., McFall-Ngai, M. J., 1992, The Muscle-deri-ved Lens of a Squid bioluminescent organ, «J. Biol. Chem.»,267, pp. 20.999-21.003.
Morin, E., 1973, Le paradigme perdu: la nature humaine, Paris,Éditions du Seuil; trad. it. 1974, Il paradigma perduto, Mila-no, Bompiani.
Morris, D. B., 1990, “The Marquis de Sade and the Discourses ofPain: Literature and Medecine at the Revolution”, in G. S.Rousseau, a cura, The Languages of Psyche, Berkeley, Univer-sity of Clifornia Press.
Mullis, K., Dancing Naked in the Mind Field, New York,Pantheon; trad. it. 2003, Ballando nudi nel campo della mente,Milano, Baldini&Castoldi.
Nagel, T., 1974, What is Like to Be a Bat?, «Philosophical Re-view», n. 83, pp. 435-450.
Nietzsche, F., 1887, On the Genealogy of Morals; nuova ed. 1967,New York, Vintage Books; trad. it. 1998, Genealogia dellamorale, Milano, Fabbri.
Nozick, R., 2001, Invariances: The Structure of The ObjectiveWorld, Cambridge (Mass.), Harvard University Press; trad. it.2003, Invarianze: la struttura del mondo oggettivo, Roma, Fazi.
Ong, W., 1977, Interfasces of the Word, Ithaca, Cornell UniversityPress.
Orgel, L. E., Crick, F. H. C., 1980, Selfish Dna: the Ultimate Pa-rasite, «Nature», 284, pp. 604-607.
Ostrom, J., 1979, Bird Flight: How Did It Begin?, «AmericanScientist», 67, pp. 46-56.
BIBLIOGRAFIA
Oyama, S., 2000a, The Ontogeny of Information. DevelopmentalSystems and Evolution, Durham (N.C.), Duke UniversityPress.
Oyama, S., 2000b, Evolution’s Eye, Durham (N.C.), Duke Uni-versity Press; trad. it. 2004, L’occhio dell’evoluzione, Roma,Fioriti Editore.
Pakman, M., 2003, “Poetica e micropolitica nelle pratiche di salutementale: I margini invisibili”, in P. Barbetta, P. Benini, R. Na-clerio, a cura, Diagnosi della diagnosi. Ricerca critico-interpre-tativa e categorie diagnostiche, Milano, Guerini.
Pakman, M., 2004, “The Misleading Self: in Search of an ElusiveCharacter in Life Composition”, in Psicologie e Identità, Attidel Convegno, Bergamo, Bergamo University Press, in corsodi stampa.
Paris, J., 1996, Social Factors in the Personality Disorder, Cam-bridge, Cambridge University Press; trad. it. 1997, Contestosociale e disturbi di personalità, Milano, Raffaello Cortina.
Parodi, A., 2002, Storie della Medicina, Torino, Ed. Comunità.Parsons, T., 1951, The Social System, New York, Free press.Pearce, B. W., 1993, Comunicazione e condizione umana, Milano,
Franco Angeli.Pievani, T., 2002, Homo sapiens e altre catastrofi. Per un’archeolo-
gia della globalizzazione, Roma, Meltemi Editore.Pievani, T., 2003, Rhapsodic Evolution: Essay on Exaptation and
Evolutionary Pluralism, «World Futures. The Journal of Ge-neral Evolution», vol. 59, n. 2, pp. 63-81.
Pievani, T., 2004, The Contingent Subject. A Radical Theory ofEmergence in Developmental Processes, «Journal of EuropeanPsychoanalysis», in corso di stampa.
Pigliucci, M., 2001, Phenotypic Plasticity: Beyond Nature andNurture, New York, Johns Hopkins University Press.
Platone, Fedro; trad. it. 1998, a cura di L. Robin, con testo a fron-te, Milano, Mondadori.
Queller, D. C., 1995, The Spaniels of St. Marx and the PanglossianParadox, «Quart. Rev. Biol.», 70, pp. 485-489.
Raup, D., Gould, S. J., 1974, Stochastic Simulation and Evolutionof Morphology, towards a Nomothetic Paleontology, «Systema-tic Zoology», 23, pp. 305-322.
Raup, D., Gould, S. J., Schopf, T., Simberloff, D., 1973, Stocha-stic Models of Phylogeny and the Evolution of Diversity,«Journal of Geology», 81, pp. 525-542.
BIBLIOGRAFIA
Resta, C., 2003, L’evento dell’Altro: Etica e Politica in JacquesDerrida, Torino, Bollati Boringhieri.
Ridley, Mark, 1996, Evolution, Cambridge (Mass.), Blackwell.Ridley, Matt, 1993, The Red Queen. Sex and the Evolution of Hu-
man Nature, London, Viking Books; trad. it. 2003, La reginarossa. Sesso ed evoluzione, Torino, Instar Libri.
Riedl, R., 1978, Order in Living Organisms, Chichester, John Wi-ley & Sons.
Rose, S., 1997, Lifelines, New York, Penguin Books; trad. it.2001, Linee di vita. Oltre il determinismo, Milano, Garzanti.
Roy, K., 1996, The Roles of Mass-Extinction and Biotic Interactionin Large-Scale Replacements, «Paleobiology», 22, pp. 436-452.
Ruesch, J., Bateson, G., 1951, Communication. The Social Matrixof Psychiatry, New York, Norton.
Ruse, M., 1986, Taking Darwin Seriously, New York, BasicBlackwell.
Sass, L. A., 1992, Madness and Modernism, Cambridge (Mass.),Harvard University Press.
Scarry, E., 1985, The Body in Pain, New York, Oxford UniversityPress.
Schilpp, P. A., a cura, 1955, Albert Einstein als Philosoph und Na-turforscher, Stuttgart, Kohlhammer; trad. it. 1958, Albert Ein-stein scienziato e filosofo, Milano, Einaudi.
Schreber, D. P., 1955, Memoirs of my Nervous Illness, New York,NYRB.
Selvini Palazzoli, M., Boscolo, L., Checchin, G., Prata, G., 2003,Paradosso e controparadosso, Milano, Raffaello Cortina.
Selzer, J., a cura, 1993, Understanding Scientific Prose, Madison(Wis.), University of Wisconsin Press.
Shakespeare, W., 1603-1606, “The Tragedy of King Lear”, in TheComplete Works, 1988, Oxford, Clarendon; trad. it. 1956, acura di C. V. Ludovici, Re Lear, Torino, Einaudi.
Skoyles, J. R., 1999, Neural Plasticity and Exaptation, AmericanPsychologist, 54, pp. 438-439.
Skoyles, J., Sagan, D., 2002, Up from Dragons. The Evolution ofHuman Intelligence, London, McGraw-Hill; trad. it. 2003, Ildrago nello specchio. L’evoluzione dell’intelligenza umana dalBig Bang al terzo millennio, Milano, Sironi Editore.
Sluzki, C. E., Ransom, D. C., 1976, Double Bind. The Foundationof Communicational Approach to the Family, New York, Grune& Stratton; trad. it. 1979, Il doppio legame, Roma, Astrolabio.
BIBLIOGRAFIA
Smit, A. F. A., 1999, Interspersed Repeats and Other Moments ofTransposable Elements in Mammalian Genomes, «CurrentOpinion Genet. Develop.», 9, pp. 657-663.
Snafu, 2002, Wu-ming: 54 Re: Inter:view, «Oyes», make-worldpaper#2, novembre, p. 4.
Sroufe, L. A., 1996, Emotional Development, London, Cambrid-ge University Press; trad. it. 2000, Lo sviluppo delle emozioni,Milano, Raffaello Cortina.
Stanley, S. M., 1981, The New Evolutionary Timetable. Fossils,Genes and the Origin of Species, New York, Basic Books;trad. it. 1982, L’evoluzione dell’evoluzione. Un nuovo calenda-rio per l’origine delle specie, Milano, Mondadori.
Sterelny, K., 2001, Dawkins vs Gould: Survival of the Fittest, NewYork, Totem Books; trad. it. 2004, La sopravvivenza del piùadatto. Dawkins contro Gould, Milano, Cortina Editore.
Stone, L., 1977, Family Sex and Marriag: England 1500-1800,London, Harper Collins; trad. it. 1983, Famiglia, sesso e ma-trimonio in Inghilterra tra Cinque e Ottocento, Torino, Einau-di.
Tattersall, I., 1993, The Human Odyssey, Upper Saddle River(N.J.), Prentice Hall.
Tattersall, I., 1998, Becoming Humans: Evolution and HumanUniqueness, New York, Harcourt Brace; trad. it. 1998, Il cam-mino dell’uomo. Perché siamo diversi dagli altri animali, Mila-no, Garzanti.
Tattersall, I., 2002, The Monkey in the Mirror. Essays on the Scien-ce of What Makes Us Human, New York, Harcourt; trad. it.2003, La scimmia allo specchio, Roma, Meltemi editore.
Thompson, D’Arcy W., 1917, On Growth and Form, Cambridge,Cambridge University Press; trad. it. parz. 1969, Crescita eforma, Torino, Boringhieri.
Thompson, E., Palacios, A., Varela, F. J., 1992, Ways of Coloring:Comparative Color Vision as a Case Study in Cognitive Science,«Beh. Brain Scien.», 15, pp. 1-45.
Van Valen, L., 1973, A New Evolutionary Law, «EvolutionaryTheory», 7, pp. 93-106.
Vavilov, N. I., 1922, The Law of Homologous Series in Variation,«Journal of Genetics», 12, pp. 47-89.
Vrba, E. S., 1983, Macroevolutionary Trends: New Perspectives onthe Role of Adaptation and Incidental Effect, «Science», 22,pp. 387-389.
BIBLIOGRAFIA
Vrba, E. S., 1984, “Patterns in the fossil record and evolutionaryprocesses”, in M. W. Ho, P. T. Saunders, a cura, Beyond Neo-Darwinism. An introduction to the new evolutionaryparadigm, pp. 115-142.
Vrba, E., Gould, S. J., 1986, The hierarchical expansion of sortingand selection: sorting and selection cannot be equated, «Paleo-biology», 12.
Weiner, A. M., Maizels, N., 1999, A Deadly Double Life, «Scien-ce», 284, pp. 63-64.
Wheeler, P. E., 1988, Stand tall and stay cool, «New Scientist», n.1.612, pp. 62-65.
Whorf, B. L., 1956, Language, Thought, and Reality, Cambridge(Mass.), The Mit Press.
Williams, G. C., 1966, Adaptation and Natural Selection: A Criti-que of Some Current Evolutionary Thought, Princeton, Prin-ceton University Press.
Wilson, E. O., 1971, The Insect Societes, Cambridge (Mass.),Harvard University Press; trad. it. 1976, La società degli inset-ti, Torino, Einaudi.
Wilson, E. O., 1975, Sociobiology, the New Synthesis, Cambridge(Mass.), Harvard University Press; trad. it. 1979, Sociobiolo-gia: la nuova sintesi, Bologna, Zanichelli.
Wittgenstein, L., 1953, Philosophical Investigations, London,Blackwell; trad it. 1967, Ricerche filosofiche, Torino, Einau-di.
Wittgenstein, L., 1959, Tractatus logico-philosophicus, London,Basil Blackwell; trad. it. 1961, Tractatus logico-philosophicus,Torino, Einaudi.
Wolfson, L., 1970, Le schizo et les langues, Paris, Gallimard.Wolfson, L., 1984, Ma mère, musicienne, est morte de maladie
maligne mardi à minuit au mileu du mois de mai mille977 auMemorial à Manhattan; trad. it. 1987, Mia madre, musicista, èmorta…, Milano, SE.
Yates, F., 1964, Giordano Bruno and the Hermetic Tradition, Lon-don, Rotledge & Kegan; trad. it. 1969, Giordano Bruno e latradizione ermetica, Roma, Laterza.
Yates, F., 1966, The Art of Memory, London, Routledge & Ke-gan; trad. it. 1972, L’arte della memoria, Torino, Einaudi.
BIBLIOGRAFIA
Stampato per conto della casa editrice Melteminel mese di aprile 2004
presso Arti Grafiche La Moderna, RomaImpaginazione Studio Agostini



































































































































































































































































































![Monni, S. (2013) “ Oltre il velo di Maya: il ruolo delle idee e delle Istituzioni” [in Italian].](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63225731050768990e0fd043/monni-s-2013-oltre-il-velo-di-maya-il-ruolo-delle-idee-e-delle-istituzioni.jpg)