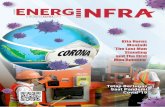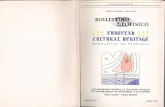"Rose vermiglie infra la neve". Analisi intertestuale di un microtema lirico
Transcript of "Rose vermiglie infra la neve". Analisi intertestuale di un microtema lirico
Studi Medievali e Moderniarte letteratura storiaAnno IX - Fascicolo II - N. 18/2005
Direttore.Gianni Oliva.
Comitato scientifico:Maria Careri, Iole Carlettini, Maria Grazia Del Fuoco, Maria Luigia Fobelli, Valeria Giannantonio, Paola Montefoschi, Vito Moretti, Gianni Oliva, Roberto Paciocco, Luigi Pellegrini, Alessandro Tornei.
Redazione.Antonio Appignani, Maria Cristina Ricciardi.
Segreteria amministrativa-.Antonia De Luca.Periodico semestrale - del Dipartimento di Studi Medievali e Moderni Università «G. D ’Annunzio» Via Pescara, 66013 Chieti Scalo - Tel. 0871 355 65 21 - 355 65 24 - 355 65 25, fax 0871 56 30 19
E- maih [email protected] - [email protected] Abbonamento annuo: per l’Italia € 40,00; per l’estero € 50,00 Costo di un fascicolo: per l’Italia € 25,00; per l’estero € 30,00
Spedizione in abbonamento postale art. 2 comma 20/b legge 662/96 filiale di Napoli
ISSN 1593-0947Autorizzazione n. 4/96del Tribunale di ChietiIscritta al Registro Nazionale della Stampain data 29-07-1985 al n. 1635
Direttore Responsabile.Alfredo Giuliani.
Finito di stampare nel mese di gennaio 2006presso la litografia GraficarteVia Castel Belvedere, 221 - marano (Na)
La L offredo E d ito re N apoli S pa è az ienda certificata del sistem a di qualità aziendale in confo rm ità ai canoni d elle norm e U N I E N IS O 9001.
C ertiC arG rafC ertine az km»Cartari«,Cartotecnica. Granai
© 2005 by LOFFREDO EDITORE S.P.A.Via Consalvo, 99 H (Reo S. Luigi is. D) 80126 Napoli http://www.loffi-edo.it E-mail: [email protected]
Studi Medievali e Moderni IX - 2/2005
SAGGI
5 E. G ia c h e ry Michelangiolismo di Giovanni Paolo II
13 L. VITACOLONNAMemoria, interpretazione e narrazione. Appunti di lavoro
31 M . C im in i
«Rose vermiglie infra la neve»: analisi intertestuale di un microtema lirico
55 V. G ia n n a n t o n io
La riscrittura dell’antico e dellAbruzzo nella Fiaccola sotto il moggio
77 M . G iam m arco
In viaggio per l ’oltre. LAbruzzo di Savinio
95 G. Sc a lessa
La riscrittura del Medioevo nell’opera di Franco Scataglini
119 E. S a s s oNews from nowhere di William Morris: tempo, temporalità e storia
141 A. M u s ia r iPrimus et novissimus. Considerazioni sul Fregio delle Profezie in S. Giovanni Evangelista a Parma
171 G . C urzi
Un crocifisso trecentesco a Chieti Scalo
CARTE INED ITE
181 V. M o r e t t i
Gabriele D ’Annunzio ed Enrico Seccia. Con lettere inedite
219 E. D i C arlo
Alfredo Luciani. Profilo bio-bibliografico
NOTE E DISCUSSIONI
237 M . M enna
Un convegno a Caen su Alvaro
239 RECENSIONI
257 LIBRI RICEVUTI
263 NOTIZIARIO, a cura di F. P a g l i c c i a
M a r io C im in i
“ROSE VERMIGLIE INFRA LA NEVE”:ANALISI INTERTESTUALE DI UN MICROTEMA LIRICO1
«Percepire il testo [poetico] come risultato della trasformazione di un intertesto - ha scritto Michael Riffaterre - equivale a percepirlo come il gioco verbale estremo, vale a dire, come letterario»2; vista da tale angolo prospettico 1’“esperienza della letterarietà” è imprescindibile in primo luogo da un generico momento “ricezionale”, ma anche e soprattutto da una specifica competenza del lettore, quella che interagendo con la cosiddetta “enciclopedia” personale gli consente di mettere in opera i meccanismi di inferenza logico-culturale e ricercare un senso - non necessariamente mimetico-reali- stico - nel testo scalando la catena delle obliquità semantiche, dei transferts di significato che costituiscono le marche distintive del discorso poetico.
Decenni di letture strutturaliste e semiotiche ci hanno ormai abituato a vedere il testo poetico come un sistema dinamico risultante da complesse stratificazioni linguistiche e culturali che agiscono sia a livello sintagmatico che paradigmatico; in quanto prodotto di una pluricodificazione, esso è indubbiamente configurabile come un insieme di altri testi (nell’accezione più ampia della parola):
l’ipersegno letterario, — come nota Angelo Marchese — in altri termini, è per sua natura relazionale: le isotopie che lo solcano orizzontalmente e verticalmente non sono strutture di senso chiuse dentro il testo, ma itinerari aperti alla realtà
1 Un nucleo essenziale di questo saggio è stato presentato al Convegno Nazionale di Studi, Le fo rm e della poesia , Siena, 22-24 settembre 2004. Ringrazio il prof. Davide Aquilano che ha amichevolmente discusso con me l’impostazione della ricerca.
2 M. RIFFATERRE, Semiotica della poesia [1978], tr. it., Bologna, Il Mulino, 1983, p. 82. Molte delle suggestioni metodologiche che fanno da sfondo a questo saggio derivano dall’impostazione di Riffaterre così come enucleata nel testo appena citato e nel volume La produzione d el testo [1979], tr. it., Bologna, Il Mulino, 1989.
SmM 2/2005
31
MARIO CIMINI
extratestuale e, in prima istanza alle altre opere del sistema letterario, eventualmente tramite le codificazioni dei generi e degli istituti deputati (lingua poetica, metrica, ecc.)3.
In realtà, anche il lettore specialistico - nella fattispecie, il critico - spesso non è esente da squilibri che lo portano ora a privilegiare la prospettiva sintagmatica sottolineando l’assoluta immanenza del testo, la sua inaggirabile auto- referenzialità e autosufficienza, ora a focalizzare l’attenzione sulla dimensione paradigmatica per cui l’operazione ermenèutica si risolve in un’alquanto asettica ricerca di fonti o di quelli che in gergo qualcuno definisce “pre-testi”.
Se, dunque, è innegabile che ogni oggetto di ricerca determina certi tratti relativi alla metodologia della ricerca stessa, nel caso dell’indagine intertestuale applicata al testo poetico non si può trascurare il fatto che essa non costituisce altro che un parziale strumento a disposizione del lettore per sondare la profondità e lo spessore dei significati. In altri termini è comunque necessaria una implementazione con approcci di diversa natura affinché la ricostruzione della “memoria poetica” non si trasformi in sterile esercizio di erudizione fine a se stessa. Illuminanti parole ha scritto a questo riguardo Gian Biagio Conte:
Il filologo, nel suo approccio al testo - si legge in un libro, Memoria dei poeti e sistema letterario, che è ormai diventato un classico della teoresi sull’interte- stualità — può anche scomporlo, può sezionarlo in verticale o almeno sondarlo nello spazio che sta sotto la superficie compatta e tenace: visto “da di sotto”, vale a dire dal punto di vista della cultura, esso non si presenta più come la scacchiera ad incastri orizzontali (contestuali) delle parole serrate nella misura metrico- ritmica, bensì pullula nella sua profondità di radicazioni filamentose che distendono, entro il fluido della cultura storica, una rete (peculiare per quel contesto) di richiami associati, di reminiscenze, imitazioni, allusioni. Questi reticoli del senso sono la cultura attuata, funzionalizzata: e perché essa trovi motivazione poetica, occorre appunto che si manifesti come orientata, vale a dire coerentemente dotata di significato dallo stesso organismo che essa alimenta e in cui si articola, cioè dal sistema letterario in cui si attua. Ogni operazione di seria critica filologica consiste in fondo nel ricostruire la mappa delle connessioni di senso, nel rintracciare, intenzionandola al contesto, la carta orografica delle connotazioni molteplici, strette tutte in una solidarietà implicita ed obbligata verso il contesto4.
3 A. MARCHESE, L’officina della poesia, Milano, Mondadori, 1985, p. 111.4 G. B. CONTE, Memoria dei p o eti e sistema letterario. Catullo, Virgilio, Ovidio, Lucano, Torino,
Einaudi, 1985, pp. 26-27.Sm M 2/2005
32
“r o s e v e r m ig l ie in f r a l a n e v e ” : a n a l is i in t e r t e s t u a l e d i u n m ic r o t e m a l ir ic o
La ricerca di un senso nelle cose e nelle parole, come sottolinea con insistenza Conte, non può dunque non costituire, in accezione oggettiva o soggettiva che sia, il fine ultimo di una pratica della ricezione che superi il facile impressionismo del momento, ma anche la pseudo-scientificità di una maniera meramente classificatoria, statistica, archeologica. Solo in questi termini, credo, si può inverare quel ruolo attivo del lettore che, dalle lontane provocazioni del Sartre di Q u’est-ce qu e c ’est la littéra tu ref’, resta per buona parte ancora da definire.
Non intendo tediare ulteriormente chi mi legge con sottili ed aride disquisizioni di metodo su una questione che, tra l’altro, ha originato un’abbondantissima letteratura critica6: basti l’aver posto il problema e dato l’abbrivio ad una prospettiva che farà da sfondo alle cose che dirò da ora in poi.
Tornando a Riffaterre non è fuor di luogo osservare che la «percezione del testo come trasformazione di un intertesto» sia stata, negli ultimi tempi, enormemente corroborata dalla possibilità di disporre dei testi letterari in versione digitale. L’identificazione della rete di rapporti e influenze tra i testi, sia essa di natura topologica che più strettamente linguistico-strutturale, è obiettivamente divenuta una sorta di attività ludica che sembra aver relegato in un passato lontanissimo certi sistemi dell’analitica letteraria che hanno assorbito le energie di generazioni di studiosi (penso, con un pizzico di costernazione, agli infaticabili costruttori di concordanze...). In verità siamo di fronte ad una specie di rivoluzione copernicana che da un lato ha sfaldato i contorni della “testualità” tradizionale aprendo gli orizzonti della iperte- stualità propriamente detta (non in senso genettiano)7 e dall’altro, retrospettivamente, sembra aver dato corpo al fantasma di quella che, più di trent’an
5 Com’è noto, il saggio risale al 1947; venne poi ripubblicato in Situations II, Paris, Gallimard, 1948 (cfr. la traduzione italiana, Che cose la letteratura?, Milano, Il Saggiatore, 1995).
6 Varia ed articolata è la letteratura critica sul tema deU’intertestualità; limitiamo le citazioni ad alcuni studi di riferimento: cfr. almeno J. KRISTEVA, Semeiotiche. Ricerche p er una semanalisi [1969], tr. it., Milano, Feltrinelli, 1978; A. POPOVlfi, Testo e metatesto. Tipologia dei rapporti intertestuali com e oggetto delle ricerche della scienza della letteratura [1973], in La semiotica nei paesi slavi. Programmi, problemi, analisi, tr. it., a c. di C. Prevignano, Milano, Feltrinelli, 1979; M. C orti, Principi della comunicazione letteraria, Milano, Bompiani, 1976; C. SEGRE, Intertestuale-interdiscorsivo. Appunti p er una fen o menologia delle fon ti, in La parola ritrovata. Fonti ed analisi letteraria, a c. di C. Di Girolamo e I. Paccagnella, Palermo, Sellerio, 1982.
7 Come noto, per GENETTE (Palinsesti [1982], Torino, Einaudi, 1997, pp. 7-8) l’ipertestualità è sostanzialmente sinonimo di transtestualità e designa in maniera generica il fatto che un testo rinvii ad un altro testo; con lo sviluppo degli elaboratori elettronici il temine invece ha assunto un significato specifico, quello cioè di un testo composto di blocchi di parole, immagini o suoni, connessi elettronicamente secondo percorsi molteplici (cfr., per esempio, G. P. LANDOW, L’ipertesto: tecnologie digitali e critica letteraria, tr. it. a cura di P. Ferri, Milano, B. Mondadori, 1998).
SmM 2/2005
33
MARIO CIMINI
ni fa, Harold Bloom definiva anxiety o fin flu en ce , l ’angoscia dell’influenza letteraria (che, quando vissuta troppo supinamente da un autore, ne decreterebbe, secondo lo studioso americano, l’automatica esclusione dal canone letterario stesso)8. Sorgono, di conseguenza, nuove questioni che - penso - solo con il passare del tempo potranno essere debitamente decantate.
Per ora e in questa sede a noi interessa la possibilità di avvalerci di motori logici per la ricerca testuale che ci permettono di porre, in maniera rapida e pressoché esaustiva all’interno di una determinata tradizione, le basi euristiche per una lettura notevole sotto il profilo ermenèutico dei testi poetici. Le implicazioni teoriche e pratiche di una simile metodologia d’indagine possono invero essere molteplici, non esclusa la probabilità di focalizzare iconicamente i momenti “generativo-trasformazionali” di determinate strutture topiche e soprattutto di risolvere in chiave semantica certe “non-grammati- calità” del linguaggio poetico. A questo punto è d’obbligo procedere con qualche esemplificazione al fine di dissipare — almeno in parte, si spera — le brume di un discorso inguaribilmente teorico.
E osservazione sin troppo ovvia che il canone della bellezza femminile nella tradizione lirica italiana, dalle origini fino a buona parte del Seicento, si fondi su un’accurata selezione delle parti anatomiche della donna: poetabili sono il viso, con annesse chiome (ma con categorica esclusione di naso e orecchie), il seno, le mani, al limite, il piede9. È innegabile che dietro tale selezione si celino ragioni culturali e antropologiche Lato sensu, forse anche influssi di codici più propriamente figurativi e iconografici10, ma è altrettan
8 «La storia della poesia - scriveva lo studioso americano (L’angoscia d ell’influenza. Una teoria della poesia [1973], tr. it., Milano, Feltrinelli, 1983, p. 13) - [ ...] deve essere considerata indistinguibile dall’influenza poetica, poiché i poeti forti costruiscono tale storia travisandosi l’un l’altro in modo da liberare un nuovo spazio alla propria immaginazione». I “talenti deboli” invece, non farebbero altro che ripercorre solo sentieri già battuti.
9 Sebbene, metodologicamente, gli studi su questo ambito tematico rinviino all’archetipo di Ernst Robert CURTIUS, Letteratura europea e Medio evo latino (1948, tr. it. a cura di R. Antonelli, Firenze, La Nuova Italia, 1992), non è fuor di luogo ricordare che la vera autorità di riferimento per le indagini sul canone della bellezza femminile nella letteratura italiana è Giovanni Pozzi, di cui vanno ricordati almeno La rosa in mano a l professore, Friburgo, Edizioni Universitarie, 1974, e Codici, stereotipi, topoi e fon ti letterarie, in Intorno a l codice. Atti d el III convegno d e ll’associazione italiana d i studi semiotici, Pavia, 26- 27 settembre 1975, Firenze, La Nuova Italia, 1976, pp. 37-76. In particolare Pozzi individua due sottocanoni della bellezza femminile (principalmente nella tradizione petrarchista): uno che definisce “breve” (perché rigorosamente limitato alla parte superiore del corpo femminile, dalla testa al seno), l’altro, “lungo”, che finisce per includere anche le altre parti del corpo, ma che storicamente ebbe una incidenza assai limitata nella tradizione lirica.
10 Cfr. sull’argomento il saggio di G. POZZI, Il ritratto della donna nella poesia d'inizio Cinquecento e la pittura d i Giorgione, in Id., Sull’orlo d el visibile parlare, M ilano, Adelphi, 1993, pp. 145-171.
Sm M 2/2005
34
“ROSE VERMIGLIE INFRA LA NEVE” : ANALISI INTERTESTUALE DI UN MICROTEMA LIRICO
to incontrovertibile che siamo di fronte ad un’azione modellizzante, o meglio automodellizante, che si realizza in ambito strettamente letterario fino alla costituzione di veri e propri clichés. Non diversamente si può osservare come i modi della rappresentazione dei particolari anatomici cristallizzi ben presto - di sicuro a partire da Petrarca, anticipiamo — in una serie di figurazioni che riconducono, in primo luogo attraverso certi tropi, alle medesime aree semantiche in cui il cromatismo gioca un ruolo capitale, costituendone una sorta di denominatore comune: i capelli saranno invariabilmente biondi (per le brune e le rosse non c’è speranza...)» l’incarnato, dal volto al seno, così come i denti, saranno costantemente bianchi, le ciglia nere, le labbra rosse, ecc. Anche i procedimenti di metaforizzazione finiscono per sistematizzarsi entro un range che contempla un numero abbastanza limitato di possibilità espressive: per il biondo la traslazione semantica di maggiore impatto statistico sarà rappresentata dall’oro (meno pregnante e diffuso sarà l’uso di sole, più indicato per significare lo splendore degli occhi), per il rosso il poeta avrà a disposizione rubini, porpora, o al limite rose, ma pur sempre porporine, per il nero l’ebano, per il bianco il repertorio dei “figuranti” è, di norma, circo- scritto ad elementi come latte, avorio, gigli e neve11. Se proviamo, con l’ausilio di un motore di ricerca testuale, a restringere il campo d’osservazione su quest’ultima tipologia di figurazione, in particolare a quei procedimenti metaforici che coinvolgono il termine “neve” come emblema (scartando dunque gli usi in accezione mimetico-realistica), non abbiamo difficoltà a constatare che la tradizione lirica ne ha ampiamente sfruttato le due possibili declinazioni semantiche, da un lato quella che riconduce all’area climatica del freddo (sinonimo dunque di ghiaccio, gelo e rigore invernale, contrario di calore, in rapporto al quale passa spesso a significare qualcosa di inconsistente ed effimero: “come neve al sole.. . ” è comparazione stereotipa in ambito lirico), dall’altra quella che rinvia all’area cromatica del bianco . Tenendo
11 L’azione “modellizzante” esercitata da Petrarca in questo ambito è ben sottolineata da Pozzi ( ivi, pp. 148-149): «Egli contrasse il canone perentoriamente e lo strutturò secondo rigide corrispondenze interne; infatti: 1. ridusse il numero dei membri nominati ad alcune parti scelte del viso (capelli, occhi, guance, bocca) più una parte anatomica selezionata fra collo, seno, mano; 2. accentuò l’uso di metafore ben definite, preferendole all’impiego del nome proprio designante i membri elogiati; 3. ridusse il numero delle motivazioni all’alternativa di splendore e colore e per quest’ultimo ai tre dati di giallo, rosso e bianco; con rarissime eccezioni (nero per le ciglia una volta sola); 4. ridusse il numero dei comparanti alla sola rosa per il rosso, ad oro ed ambra per il giallo, lasciando invece un più ampio ventaglio di possibilità per il bianco [ .. .] . La conseguenza più vistosa dell’iniziativa petrarchesca scaturì dalla riduzione dei membri annessi all’elenco».
12 Anche sulla “canonizzazione” del bianco-neve come distintivo della bellezza femminile nella tradizione lirica esiste una vera e propria letteratura critica (per i cui estremi rinvio ai citati interventi di Pozzi): mi limito a ricordare due saggi che mi sembrano degni di nota: M. Feo, Pallida no, ma p iù che
SmM 2/2005
35
MARIO CIMINI
fermo l’obiettivo della nostra indagine raffiniamo la ricerca e attraverso una opportuna generazione dei contesti (ovviamente del termine “neve”) giungiamo a individuare una serie di materiali lirici in cui è costante l ’impiego di una metafora nivale per significare una delle qualità preminenti del viso della donna amata; ne riportiamo le occorrenze a nostro avviso più significative:
G u id o G u in iz z e l l i , P oesie3 [1 ]
Vedut’ho la lucente stella diana viso de *neve* colorato in grana, occhi lucenti gai e pien’ d’amore; non credo che nel mondo sia cristiana si piena di biltate e di valore. - 7.5
C in o d a P is t o ia , Poesie14 [1 ]
Oimè, lasso, quelle trezze bionde Oimè, ’1 fresco ed adorno e rilucente viso, oimè lo dolce risoper lo qual si vedea la bianca *neve*fra le rose vermiglie d’ogni tempo; - 123.10
F r a n c e s c o P e t r a r c a , Canzoniere5 [24]
Io canterei d ’amor sì novamenteet le rose vermiglie infra la *neve*mover da l’òra, et discovrir l’avorioche fa di marmo chi da presso ’1 guarda - 131.9
neve bianca, in “Giornale storico della letteratura italiana”, n. 152, 1975, pp. 321-361, e Q. M. HOPE, Snow-imagery in love-poetry, in “Arcadia. Zeitschrift fìir vergleichende Literaturwissenschaft”, n. 13, 1978, pp. 1-23.
13 In corrispondenza dei titoli citiamo le edizioni di riferimento; per Guinizzelli: Poeti d el Duecento, II, a c. di G. Contini, Milano-Napoli, Ricciardi, 1960. Il numero entro parentesi quadre a fianco del titolo fa riferimento alle occorrenze del temine “neve” nell’opera dello scrittore in questione. I numeri riportati a fine citazione si riferiscono rispettivamente a: collocazione del testo nell’opera e numero del verso in cui compare il termine “neve”.
14 Poeti d e l Dolce stil nuovo, a cura di M. Marti, Firenze, Le Monnier, • 1969.15 F. PETRARCA, Canzoniere, a cura di M. Santagata, Milano, Mondadori, 1996.
SmM 2/2005
36
“r o s e v e r m ig l ie in f r a l a n e v e ” : a n a l is i in t e r t e s t u a l e d i u n m ic r o t e m a l ir ic o
0 d ’ardente vertute ornata et calda o fiamma, o rose sparse in dolce falda di viva 'neve*, in ch’io mi specchio et tergo; o piacer onde l’ali al bel viso ergo, - 146.6
Quel sempre acerbo et onorato giorno La testa òr fino, et calda *neve* il volto, hebeno i cigli, et gli occhi eran due stelle, onde Amor l’arco non tendeva in fallo; perle et rose vermiglie, ove l’accolto dolor formava ardenti voci et belle; - 157.9
G iovanni Boccaccio , Amorosa v ision e6 [2]
Il suo viso come *neve* mo’ messa parea, nel qual mescolata rossezza aveva convenevolmente ad essa. - XV.22
G iu sto d e ’ C o n ti, Canzoniere1 7 [3]
Chi vuol veder la *neve* et latte inseme Chi vuol veder la *neve* et latte inseme misti con rose et fior bianchi et vermigli mira il viso a costei quand’alza i cigli - 206.1
A ntonio T ebaldi (il Tebaldeo), Rime* [28]
Dui vivi soli, or fino, hebeno raro vermigli fior’ che al giel mai non mancaro,*neve* al sol salda, perle senza mende,parlar che muta in marmo chi l’intenderiso che il mar tranquillo e il cielo fa chiaro - 325 (estrav.).6
16 G. BOCCACCIO, Amorosa visione, a cura di V. Branca, in Tutte le opere d i G. Boccaccio, III, Milano, Mondadori, 1974.
17 G. DE’ CONTI, Canzoniere, a cura di L. Vitetti, Lanciano, Carabba, 1933.18 A. T ebaldi (Tebaldeo), Rime, a cura di T. Basile e J. J. Marchand, Modena, Franco Cosimo
Panini, 1992.SmM 2/2005
37
MARIO CIMINI
M atteo M aria Boiardo, Amorum lib rP [12]
Io non scio se son p iù quel ch ’io solea veduto ho zigli e rose e le viole tra *neve* e giazi a la stagion più rea.
Io vidi in quel bel viso primavera de erbetta adorna e de ogni gentil fiore vermiglia tutta, d’or, candida e nera. - 48.4
Quando ebbe il mondo mai tal maraviglia?Fiamma di rose in bianca *neve* viva, auro che ’1 sol de la sua luce priva un foco che nel spirto sol se impiglia candide perle e purpura vermiglia, - 49.2
Non p iù losanghe, non, che p iù non credo Già me mostrasti, ed or pur me ne avedo, rose de verno e *neve* al caldo sole: - 113.6
Da’ p iù belli occh i e dal p iù dolce risoda’ crin che mostrar d’auro e da un tal visoche rose se mostrava e *neve* pura,da una celeste e angelica figurache avrebbe un tronco, un marmo, un fer conquisopartir, lasso me, puote? Ed ancor vivo - 163.6
Ludovico A riosto, Rime20 [4]
La bella donna mia d ’un sì bel fu o co La bella donna mia d’un sì bel fuoco, e di sì bella *neve* ha il viso adorno,
Tal è proprio a veder quell’amorosa fiamma che nel bel viso si sparge, ond’ella con soave riso si va di sue bellezze inamorando; qual è a veder, qualor vermiglia rosa
19 M. M. Boiardo, Opere volgari, a cura di P. V. Mengaldo, Bari, Laterza, 1962.20 L. ARIOSTO, Opere minori, a cura di C. Segre, Milano-Napoli, Ricciardi, 1954.
SmM 2/2005
38
“ROSE VERMIGLIE INFRA LA NEVE” : ANALISI INTERTESTUALE DI UN MICROTEMA LIRICO
E bianca è sì come n’appare, quando nel bel seren più limpido la luna sovra l’onda tranquilla coi bei tremanti soi raggi scintilla. - 54.2
P ie t r o B e m b o , Rime2' [1 1 ]
Crin d ’oro crespo e d ’ambra tersa e pura Crin d’oro crespo e d’ambra tersa e pura, ch’a l’aura su la *neve* ondeggi e vole, - 5.2
Poi ch ’ogn i ardir circoscrisse Amorech’io spererei de la pietate ancoraveder tinta la *neve* di quel volto,che ’1 mio sì spesso bagna e discolora - 7.10
Viva mia *neve* e caro e dolce fo coViva mia *neve* e caro e dolce foco,vedete com’io agghiaccio e com’io avampo - 28.1
Se ’n d ir la vostra angelica bellezza Se ’n dir la vostra angelica bellezza,*neve*, or, perle, rubin, due stelle, un sole, subietto abonda e mancano parole - 71.2
G ia n G io r g io T r is s in o , Rime11 [1 ]
So che tropp’alto aspironé gigli o *neve* han bianco sì perfettocom’ella ha ’1 viso e 1 pettoin cui qualche rossezza vi si posa,che par in latte una vermiglia rosa - 59.42
F r a n c e s c o B e r n i , R im e0 [2 ]
Sonetto alla sua donnaciglie di *neve* e quelle, ond’io m’accoro,
21 Prose e rime di Pietro Bembo, a cura di C. Dionisotti, Torino, Utet, 1966.22 G. TRISSINO, Rime 1529, a cura di A. Quondam, Vicenza, Neri-Pozza, 1981.23 F. BERNI, Rime, a cura di D. Romei, Milano, Mursia, 1985.
SmM 2/2005
39
MARIO O M IN I
dita e man dolcemente grosse e corte; labra di latte, bocca ampia celeste; -31.7
A n n ib a l C a r o , Traduzione d e ll’“Eneide,24
Stava a questa richiesta in sé Vulcano ritroso anzi che no: quando Ciprigna con la tiepida *neve* e col viv’ostro de le sue braccia al collo gli si avvinse, e strinselo e baciollo. — Libro V ili, 595
L u ig i T a n s il l o , Canzoniere25 [1 4 ]
Qual benigna mia stella O man più d’altra vaga
non sia a’ begli occhi grevech’io baci quest’avorio e questa *neve*.
Non son le guancie queste, ove Venere sparsedi sua man gli amaranti e i gelsomini, - 1, canz.8.13
le guancie ove d’accordo ogn’or si vedesplender la fiamma e biancheggiar la *neve*; - IV, stanze 3.100
Quand’ardono le campagne, e non riceve Perché men grave sia l’immenso ardore a le rose del volto ed a la *neve*, - V, son. 117.4
M a t t e o B a n d e l l o , R im e6 [2 1 ]
Cantar il biondo, crespo crine e quella la guancia, ch’ostro e *neve* rassomiglia, - 6.7
Madonna, i bei vostr’occh i ch i rimira
24 Versione d e ll’Eneide di Annibal Caro, a cura di A. Pompeati, Torino, Utet, 1954.25 L. TANSILLO, Canzoniere, a cura di E. Pèrcopo e T. R. Toscano, Napoli, Liguori, 1996.26 M. BANDELLO, Rime, a cura di M. Danzi, Modena, Panini, 1989.
SmM 2/2005
40
“ROSE VERMIGLIE INFRA LA NEVE” : ANALISI INTERTESTUALE DI UN MICROTEMA LIRICO
e quelle guancie fatte di mistura d’ostro e di *neve*, il paradiso mira. - 5 1 . 4
Dal p iù leggiadro e amorosetto viso da’ coralli e da *neve* calda e fresca u’ perle orientali scopre un riso - 10 7 .7
Rose vermiglie, nate sulla *neve*Rose vermiglie, nate sulla *neve*,chiome d’or terso inannellate e sparte, - 108.1
Né sopra colli star p iù bianca neve come del viso scopre la chiara alba, ligustri mostra con vermigli fiori
e vince di candor la fresca *neve* - 2 2 0 (estrav.). 16
Torquato Tasso , R im e7 [33]
Loda la bellezza de la sua donna o le rose fiorir tra *neve* e brine; - 17 .4
In morte d i bella donnaQual *neve* che su’ colli ameni fiocchiera de la mia donna il volto tinto - 428 .1
La man, ch ’avvolta entro odorate spogliee ch’ignuda arrossir fa poi la *neve*mentre a lei di bianchezza il pregio toglie, - 677 .3
Vaghi amorosi spiriti fra i raggi e le favillee fra le vive *nevi* e l’ostro e l’oro; - 1279 .4
A donna Eleonora d e’ M edici Gonzagadi fuor, perle, rubini, avorio ed oroe rose sparte in bianca e viva *neve*, - 1348 .33
27 T. Tasso , Opere, I-II, a cura di B. Maier, Milano, Rizzoli, 1963.SmM 2/2005
41
MARIO CIMINI
G a b r ie l l o C h ia b r e r a , Scherz i8 [1 ]
Bella guancia, che disdori *Nevi* candide cosparte con bella arteinfra porpora sì bella, - Lib.2, 7.19
G ia m b a t t ist a M a r in o , Rime am orose9 [3 ]
Alla bocca della sua donnaO tra la *neve* d’un bel viso nate sotto duo soli, e non caduche rose, cui non so se Natura o se Beltate d’orientali porpore compose - 7.1
Al signor Ambrogio Figino dipintore famosissimoPuò ben uom de la *neve* il bel candoree del foco il vermiglio in tela espressoritrar, ma non il gelo e non l’ardore, - 34.9 (anche in Galeria)
G ia m b a t t ist a M a r in o , Adone50 [4 1 ]
Un rossor dal candor non ben distinto varia la guancia e la confonde e mesce.Il ligustro di porpora è dipinto, là dove manca l’un, l’altra s’accresce.Or vinto il giglio è dala rosa, or vinto l’ostro appar dal’avorio, or fugge, or esce.Ala *neve* colà la fiamma cede,qui la grana col latte inun si vede - Canto 2.113
Nela fronte purissima biancheggiasenza rossore alcun semplice latte,ma nele guance ove ’1 candor rosseggia,con la *neve* la grana inun combatte;e la mistura è tal che si pareggia,quasi d’avorio e porpora sien fatte;ma con due d’or in or picciole fossesuole un riso gentil farle più rosse - Canto 16.79
28 G. CHIABRERA, Maniere, Scherzi e Canzonette morali, a cura di G. Roboni, Parma, Guanda, 1998.29 G. B. M arino, Rime amorose, a cura di O. Besomi e A. Martini, Modena, Panini, 1987.30 G. B. MARINO, Tutte le opere d i G. B. Marino, a cura di G. Pozzi, Milano, Mondadori, 1976.
SmM 2/2005
42
“ROSE VERMIGLIE INFRA LA NEVE” : ANALISI INTERTESTUALE DI UN MICROTEMA LIRICO
A a . V v . Poesie d ell’età b a r o c c i [1 2 ]
G ir o l a m o F o n t a n e l l a
Pompe di leggiadria, spoglie adorateite per custodir quell’animate*nevi*, quelle d’amor candide rose: - 2.6
Poiché in cima riposto a l regio onoreTosto in pallido cangia il bel vermiglio,e ne la guancia delicata e puracome *neve* fioccata appare il giglio - 34.303
M a r c e l l o G io v a n n e t t i
Qualor Cilla vezzosa i lum i gira Direi valli di gigli in campo alpino, direi cave di *nevi* in mezzo ai fiori quelle fosse sul volto almo e divino - 2.10
S c ip io n e E r r ic o
Sorge nobil città, che altera siede Clizia ha d’ostro le guance: un puro latte in faccia ha sol la delicata Irene;Silvia per tutto le sue *nevi* intatte tempestate di rose intorno tiene; - 7.75
C ir o D i P e rs
Veggio, veggio, Nicea, le tue vezzose Veggio, veggio, Nicea, le tue vezzose guancie obliar le porpore native, che, quasi timidette e fuggitive vansi tra i gigli ad occultar le rose.Le *nevi*, ove le fiamme Amor nascose, son de la lor vaghezza in parte prive - 7.5
31 Lirici marinisti, a cura di B. Croce, Bari, Laterza, 1910.SmM 2/2005
43
MARIO O M IN I
Oblia la fronte, o Lidia, i suoi candori Non può far d’aurei fregi il manto adorno, non le *nevi* mentite o gli ostri finti ricorrer dietro un sol passato giorno - 9.10
T orquato A ccetto, Rime amorose,2 [5]
/’ vidi i l bel crin d ’oro, e fu i contento E vidi rose e gigli, o fiamma e *neve* nel chiaro volto ben confuse e sparse. - 36.9
Già da una superficiale ricognizione di questo materiale grezzo è possibile trarre una prima considerazione: quasi mai il colore della bellezza riferito al viso (diverso sarà il discorso per il collo o il seno) è un candore integrale e assoluto, semmai i poeti giocano molto sulle nuances, in particolare su quelle che contemplano delicate dissolvenze di tinte rosate su fondo bianco. L’osservazione “in vitro” di tale fenomeno, a questo punto, non può più essere neutra: in altri termini, non siamo di fronte alla semplice ricorsività di un significante (per quanto impiegato nel significato di figurato retorico), ma constatiamo la formazione e il riuso non estemporaneo di un nesso espressivo dotato di indubbie valenze connotative. Il meccanismo di trasformazione che ne determina la ricodifica in contesti poetici più o meno variati non occulta le marche distintive del nucleo originario che dunque si configura come un vero e proprio tòpos in grado di attraversare indenne una lunghissima tradizione lirica.
Se si eccettuano gli isolati - ma comunque significativi - antecedenti di Guinizzelli e Cino da Pistoia, il punto di partenza di questa tradizione - e non sarà una mirabolante scoperta - è rappresentato da Petrarca: il codificatore del linguaggio lirico volgare, con quella straniante ed inverosimile immagine di “rose vermiglie infra la neve”, sembra creare dal nulla il cliché, l’ipogramma, l ’ipotesto33 di quella che sarebbe divenuta una maniera stereotipa per parlare poeticamente del viso di una donna. Ma sarà realmente così? Ci insospettisce soprattutto il fatto che già in Petrarca l’immagine si costituisca come non-gram m atica lità , come segno poetico insomma che rinvia ad una profondità paradigmatica e dunque presuppone un lettore “esperto”, in
32 T. Accetto , Rime amorose, a cura di S. Nigro, Torino, Einaudi, 1987.33 Usiamo questo termine nell’accezione di Genette (Palinsesti cit., pp. 7-8) secondo cui esso desi
gna un testo anteriore che viene richiamato in un testo dato.SmM 2/2005
44
“ROSE VERMIGLIE INFRA LA NEVE” : ANALISI INTERTESTUALE DI UN MICROTEMA LIRICO
grado di decodificarla sulla base di una enciclopedia di riferimento. Sarà quindi il caso di proseguire la ricerca aH’interno di questa enciclopedia che dobbiamo immaginare estesa in almeno due direzioni, quella della tradizione classica e quella delle più recenti e notevoli esperienze poetiche romanze nella letteratura oitanica e occitanica.
Rinuncio a tediare chi mi ascolta con i problemi relativi all’impostazione pratica di questo sondaggio (che in primo luogo dovrà tener conto di questioni di traduzione da una lingua all’altra e dovrà anche riferirsi alle serie aggettivali derivate dai termini-cardine o afferenti alle loro aree semantiche): mi limito a presentare quelli che mi paiono esserne i risultati maggiormente degni di nota. Nell’ambito della poesia latina constatiamo una sintomatica concentrazione di lo c i p o e t i c i a sfondo cromatico niveo-rosato in Ovidio (sebbene attestazioni isolate non manchino in poeti che lo precedettero come Tibullo — fonte di Ovidio? — e in altri, come Draconzio o Ennodio, del V secolo, che evidentemente, anche a notevole distanza di tempo risentono del suo modello); in Amores, III, 3 è contenuto il seguente distico:
Candida, candorem roseo suffusa rubore, ante fu it: niveo lu cet in ore rubor.
(Candida d’un candor tutto soffuso d’una tinta rosata era dapprima; nel niveo volto splendono le rose.Trad. d i Guido Vitali)
E sono versi riferiti al volto di una bella “spergiura” che, nonostante il tradimento, conserva intatte le marche della sua avvenenza.
In Heroides, 20, 119-120 il poeta, invece, esorcizza, lo sfiorire della bellezza in questi termini:
Serventur vultus ad nostra incendia nati quique subest niveo levis in ore rubor.
(Sia preservato quel volto nato per farmi infiammare, e quel dolce rossore che affiora sul tuo viso di neve.Trad. di Gianpiero Rosati)
In M etamorphoses, 3, 422-423 l’attenzione è puntata sul volto efebico di Narciso che, nella celebre fonte, ammira
SmM 2/2005
45
MARIO O M IN I
Inpubesque genas et eburnea colla decusque oris et in niveo mixtum candore ruborem
( . . . l ’impuberi guance e le rosselabbra ed il collo d’avorio e il candore vermiglio del volto Trad. di Ferruccio Bernini!)
Nell’economia del nostro discorso il luogo di maggior pregnanza è rappresentato senza dubbio dal distico degli Amores sia per la sua esemplarità e incisività sul piano retorico-strutturale (tra l’altro la nuan ce è sottolineata con un efficace procedimento di redup licano variata), sia perché, come un vero e proprio palinsesto, contiene tutti gli elementi del tòpos che avrebbe originato.
Prima di qualsiasi altra considerazione esauriamo la nostra indagine orientandola verso le letterature romanze di area francese, nel cui ambito non è diffìcile imbattersi in almeno una reinterpretazione dell’architesto ovidiano: si tratta di un passo piuttosto celebre del P erciva lle di Chrétien de Troyes in cui il cavaliere-protagonista si ferma a contemplare le sfumature vermiglie di tre gocce di sangue lasciate sulla neve da un’oca ferita, visione che ricordandogli l’incarnato del volto della donna amata lo trattiene a lungo, quasi immemore di sé, nel luogo della scoperta.
Lajante fu. navree e l col, si seigna trois gotes de sane, qui espandirent sor le blanc, si sanbla naturai color.
Quant Percevaus vit defolee la n o ifsor quoi la ja n te ju t et le sane qui antor parut, si s’apoia desor sa lance p or esgarder cele sanblance: qui li sans et la nois ansanble la fresche color li resanble qui ert an la fa ce s’amie, si panse tant que i l s’oblie; qu’autresi estoit an son visli vermauz sor le blanc assis con cez trois gotes de sane fu ren t qui sor la blanche n o i f parurent.
SmM 2/2005
46
“ROSE VERMIGLIE INFRA LA NEVE”: ANALISI INTERTESTUALE DI UN MICROTEMA LIRICO
(L’oca era stata ferita nel collo e n’eran cadute tre gocce di sangue che s’erano allargate sopra il bianco sì che pareva color d’incarnato.
Quando Percivalle vide segnata la neve su cui l’oca aveva posato e il sangue che intorno appariva, sostò, poggiato alla lancia, per contemplare quella sembianza: ché il sangue mischiato alla neveil colorito fresco gli somiglia ch’era sul viso della sua amica; e tanto entra in pensiero che s’oblia; perché non altrimenti nel suo visoil vermiglio sul bianco s’assideva, com’eran quelle tre gocce di sangue che apparivano sulla neve bianca.Trad. d i Aurelio Roncaglia)34
Lasciando da parte la complessa questione dell’interpretazione di questo passo, - basti in tal senso il rinvio al saggio di Reto R. Bezzola, P erceva l e t les gou ttes d e san g su r la n eigé35 - a noi interessa sottolineare il meccanismo di ripresa e attualizzazione semica messo in opera da Chrétien de Troyes di quello che evidentemente è già un cliché, confortati in questo dalle parole di Aurelio Roncaglia che a tal proposito scrive: «Un topos letterario tradizionale nelle descrizioni della bellezza femminile (Ovidio: « in n iv eo m ixtum can dore ruborem ») ritrova la nativa verginità del proprio stupore in un vecchio motivo di fiaba radicato nel folclore universale (la principessa che ha sul voltoi colori del sangue e della neve); e nella sintesi, un simbolismo intuitivo si riempie d’un significato di raffinatezza cortese»36. Né desta meraviglia il richiamo al poeta latino in un frangente storico, come il XII secolo - non a caso definito aetas ov id iana - che segna il recupero dell’Ovidio erotico dopo secoli di prevalente od esclusivo influsso dell’Ovidio “metamorfico”.
34 Per il testo rimandiamo a A. Roncaglia, Antologia delle letterature m edievali d ’oc e d ’oïl, Roma, Edizioni Accademia, 1973, pp. 260-263.
35 Cfr. R. R. BEZZOLA, Le sens de l ’aventure et de lam our (Chrétien de Troyes), Paris, La Jeune Parque, 1946, pp. 19-32.
36 A. RONCAGLIA, I romanzi d i Chrétien d e Troyes, in ID., Antologia delle letterature medievali d ’oc e d ’o ïl cit., p. 213.
Sm M 2/2005
47
MARIO CIMINI
Difficile dire, ad ogni modo, se la rielaborazione petrarchesca del tòpos scaturisca dalla tradizione romanza (in cui sono da includere, ovviamente, Guinizzelli e Cino) o attinga direttamente alla fonte latina. La considerazione di un assodato rapporto filologico con i classici da parte del poeta aretino, unitamente all’osservazione di innegabili calchi allusivi (come il latinismo “óra” presente nel sonetto CXXXI) deporrebbe a favore di un rinvio non mediato ad Ovidio37. Ma siamo pur sempre nel campo delle ipotesi. Sta di fatto che l’ipogramma ovidiano traslitterato, attualizzato e quindi fissato come dimensione modulare nella lirica volgare italiana da Petrarca, entra a far parte, alla stregua di una formula ready-m ade , di un repertorio tematico- stilistico a cui avrebbero attinto generazioni di poeti per alludere alla bellezza della donna. Non è fuor di luogo osservare che questo specifico caso, metonimico ovviamente del più vasto e generico sistema dell’intertestualità, ci riconduce ad una delle leggi fondamentali di determinazione della “signi- ficanza” poetica che, usando le parole di Riffaterre, possiamo così abbozzare: «la produzione del segno poetico risulta determinata da una d erivaz ion e ip o gram m atica : una pa ro la o lo cuz ion e e poeticizza ta quando si rifer isce a (o, se si tratta d i una locuzione, si m odella su) un gruppo verba le p reesisten te»; formulazione indubbiamente parziale che andrebbe integrata almeno con un corollario di richiamo alla tensione dialettica del sistema letterario: «Perché in un testo sia attivata la poeticità, il segno riferentesi ad un ipogramma deve costituire una va rian te della matrice di quel testo. In caso contrario, il segno poetico funzionerà soltanto come lessema stilisticamente marcato»38.
A questo punto resta da chiedersi: quale prospettiva di analisi della sequenza intertestuale che abbiamo individuato può essere quella non diciamo più corretta, ma criticamente produttiva? A seconda che si privilegi uno degli specifici elementi del sistema letterario - l’autore, l’opera, il lettore - potremmo avere tre distinte direzioni interpretative, indubbiamente convergenti, ma anche dotate di implicazioni assiologiche e ideologiche di natura conflittuale. Incentrare il discorso solo sugli autori e sul loro rapporto all’interno di una determinata tradizione letteraria ci porterebbe senza dubbio sulle secche di una vera e propria psicocritica, attenta alle motivazioni psicologiche dell’atto creativo sulla base di una dinamica emulativo-riproduttiva dei modelli, ma inevitabilmente costretta ad emettere sentenze di condanna
37 Nella lista dei suoi libri preferiti (“libri peculiares”) Petrarca includeva, tra gli autori antichi, Ovidio, ma “presertim in maiori”, ossia, soprattutto nel suo poema principale, le Metamorfosi (cfr. V. PACCA, Petrarca, Bari, Laterza, 1998, p. 45). Del resto, come si è già visto, l’ipogramma in questione compare sia negli Amores che nelle Metamorphoses.
8 M. Riffaterre, Semiotica della poesia cit., p. 55.SmM 2/2005
48
“rose vermiglie infra la neve”: analisi intertestuale di un microtema lirico
o assoluzione: è il metodo fatto proprio dal citato Harold Bloom39 per il quale la creazione poetica si riassume in un angoscioso tentativo di liberarsi da un’influenza, di superare certi clich és per affermare la propria originalità (da qui, in considerazione della difficoltà di emanciparsi dal già detto, la riduzione della storia letteraria a pochissimi momenti-monumenti). Nel nostro specifico caso saremmo addirittura indotti a trarre delle conclusioni tutto sommato banali, del tipo: lo stereotipo cromatico riferito al volto femminile - così come, per estensione, tanti altri stereotipi - vive a lungo nella tradizione del petrarchismo; in questo vasto ambito s’incontrano personalità (“minori”, secondo una vecchia nomenclatura critica) che mostrano di essere schiacciate dal modello che riproducono in maniera più o meno pedissequa, altre che invece (e saranno i “maggiori”) riescono a rivitalizzare quello stesso modello occultandone i segni di derivazione dall’architesto e presentandone i tratti distintivi come cosa affatto nuova ed originale. Se quindi si riduce il meccanismo della memoria poetica ad un mero impulso emulativo, «la produzione del testo resta affidata ad un rapporto di (due) soggettività, con le inevitabili implicazioni di intenzionalismo, spesso insufficienti a dare un’idea corretta del processo letterario, centrate come sono sulla volontà personale degli autori confrontati e non sulla realtà strutturale dei testi»40.
Affrontare la questione da una prevalente prospettiva testologica e rice- zionale significa, d’altra parte, conferire rilievo all’opera come struttura funzionale che prevede, alla stessa stregua di qualsiasi attività connessa con una manipolazione della lingua, l’assorbimento e la rielaborazione di una quantità indefinita di altri testi e, nel contempo, postula l’esistenza di un lettore capace di ricostruire la rete di interconnessione che lega un testo ad un altro:
l’intertestualità, allora, lungi dall’essere un curioso effetto d’eco - scrive sempre Conte - definisce la condizione stessa della leggibilità letteraria. Di fatto non si colgono il senso e la struttura di un’opera se non in rapporto a dei modelli, essi stessi ricavati da una lunga serie di testi di cui sono in qualche modo l’invariante. Rispetto a questi modelli di fondo, il testo letterario entra sempre in un rapporto di realizzazione, di trasformazione o di trasgressione. Fuori di questo sistema l’opera poetica è impensabile: la sua percezione presuppone una competenza nella decifrazione del linguaggio letterario, che ha come condizione la pratica di una molteplicità di testi»41.
39 Cfr. H. B loom , op. cit.40 G. B. C onte, op. cit., pp. 114-115.41 Ibidem, pp. 116-117.
SmM 2/2005
49
MARIO CIMINI
È il caso di notare che siamo di fronte ad un isomorfismo tra testo, cultura e psicologia della percezione che si riassume in uno schema fondamentalmente reticolare.
Applicato al nostro caso questo meccanismo permette di pensare alla tipologia di un lettore caratterizzato da un particolare orizzonte d’attesa ed anche da una memoria poetica che gli consente di decodificare la transtestualità, di entrare con cognizione di causa nel gioco dialettico della letterarietà, di risolvere con l’attribuzione di un senso persino certe non-grammaticalità dell’espressione (come quelle che rimandano all’improbabile fioritura di rose nella neve o a incendi che si sviluppano nel ghiaccio). Ma nel bagaglio culturale di questo lettore ideale non mancherà altresì una coscienza teorica relativa ad una serie di parametri paratestuali (che gli permettono, ad esempio, l’identificazione del genere) e a certe leggi non scritte di evoluzione-trasformazione testuale. Quali possono essere queste norme che presiedono alla metamorfosi di un tòpos come quello da noi identificato? Vediamo di enuclearne alcune attraverso l’analisi del materiale a nostra disposizione.
Il grado zero di una evoluzione potrebbe consistere nella sua negazione, nella stasi appunto: a questo livello appartiene sicuramente la citazione diretta che per quanto sottoposta a riattualizzazione semica in nuovi contesti conserva in maniera inconfondibile i tratti dell’ipotesto: nella fattispecie le «rose vermiglie, nate sulla neve» di Bandello, o le «rose sparte in bianca e viva neve» di Tasso rimandano “di peso” alle «rose vermiglie infra la neve» o alle «rose sparse in dolce falda di viva neve» di Petrarca. Citazione, ad ogni modo, non significa plagio, semmai è sinonimo di arte allusiva, secondo la felice espressione coniata da Pasquali42.
Categoria ben più ampia ed articolata della ripresa “testuale” è quella che potremmo definire della dislocazione: prevede la disgregazione del nucleo centrale dello stereotipo con transcodifica e riconversione per lo più parziale dei suoi elementi costitutivi. Non di rado, per esempio, le “rose vermiglie” da metafora riferita al volto passano ad indicare una qualità cromatica delle labbra (cfr. Cino da Pistoia o il sonetto CLVII di Petrarca), così come “neve” nell’accezione metaforico-antonomastica di bianco è suscettibile di riconversione al fine di significare il candore dei denti (già in Cino). Spostamenti deittici si osservano tra le modalità di alludere ai singoli referenti: l’“ore” che in Ovidio costituisce una sineddoche di volto, translitterato in “óra” da Petrarca, riassume il valore basilare di “bocca”. In più di un caso il tòpos è
42 G. PASQUALI, Arte allusiva, in ID., Stravaganze quarte e supreme, Venezia, Neri Pozza, 1951, pp. 11- 20.
SmM 2/2005
50
“ROSE VERMIGLIE INFRA LA NEVE”: ANALISI INTERTESTUALE DI UN MICROTEMA LIRICO
addirittura impiegato con riferimento ad un volto maschile: un «gran signore di mirabile aspetto», il cui viso «come neve mo’ messa / parea, nel qual mescolata rossezza / aveva convenevolmente ad essa» compare nel canto XV dell 'Amorosa vision e di Boccaccio; tratti non dissimili sono attribuiti a Cupidoro, principe d’Epiro, n e ll’A done di Giambattista Marino. Una particolare forma di dislocazione del catalogo cromatico caratterizza il travestimento burlesco e la parodia: è il caso del celebre sonetto di Berni, C hiom e d ’argen to fin o , ir te e attorte, parodia del bembiano Crin d ’oro crespo e d ’am bra tersa e pura , in cui gli effetti antifrastici sono perseguiti per lo più attraverso uno spostamento d’attribuzione delle metafore cromatiche: il “d’oro” dei capelli riferito al viso indica una marca di bruttezza (e sottintende ancora una volta un codice storicamente determinato, per noi quella tinta abbronzata ha tutt’altro significato...), la “neve” del volto applicata alle ciglia sottolinea la vecchiezza della donna, ecc. La resa comica dipende ovviamente dalla capacità del lettore di “avvertire il contrario” e dunque dalla sua perizia nel comparare il rovesciamento con un piano positivo di riferimento, ossia nel proiettare il testo parodico su un intertesto di altro segno.
Altra modalità di evoluzione e sviluppo del tòpos è quella che risponde alle esigenze di varia tio e am p lifica tio degli elementi strutturali di base: è un processo progressivo sotto il profilo diacronico che giunge alla sua apoteosi — e non poteva essere diversamente - in Marino e nei poeti del Seicento. Ma in un ambito non sospetto sottolineerei il caso di un Ariosto, capace di diluirelo stereotipo in due volute ritmico-figurative di ampia portata («La bella donna mia d’un sì bel fuoco, / e di sì bella neve ha il viso adorno, I . . . I Tal è proprio a veder quell’amorosa / fiamma che nel bel viso / si sparge, ond’el- la con soave riso / si va di sue bellezze inamorando; / qual è a veder, qualor vermiglia rosa I . . . I E bianca è sì come n’appare, quando / nel bel seren più limpido la luna / sovra Fonda tranquilla / coi bei tremanti soi raggi scintilla») . Non sono solo necessità onomasiologiche a guidare la ricerca del poeta verso il reperimento di nuove forme per esprimere gli stessi concetti (alla metafora floreale della rosa si affiancheranno quelle ignee, la porpora, spesso nella variante arcaica dell’ostro, ecc.), ma spesso è la volontà di conferire al dettato poetico un valore aggiunto che possa catturare l’attenzione del lettore: se già in Giusto de’ Conti, l’accumulo dei particolari cromatici rispetto al modello petrarchesco è evidente (per cui nella sua poesia compaiono «neve e latte inseme / misti con rose et fior bianchi», ma anche Boiardo affastella «zigli e rose e le viole / tra neve e giazi»), l’effetto di massima ridondanza è raggiunto da Marino, in grado di confezionare ben otto versi sulle sfumature candido-rosate del volto di Venere: «Un rossor dal candor non ben distin-
SmM 2/2005
51
MARIO CIMINI
to / Varia la guancia e la confonde e mesce. / Il ligustro di porpora è dipinto, / là dove manca l’un, l’altra s’accresce. / Or vinto il giglio è dala rosa, or vinto / l’ostro appar dal’avorio, or fugge, or esce. / Ala neve colà la fiamma cede, / qui la grana col latte inun si vede»43. Sembra che da autentico lettore “rampinesco” quale si definiva, Marino abbia presente l’intera tradizione del tòpo?, da au cto r il suo obiettivo, però, non è la selezione e la sintesi ma la rifunzionalizzazione allusiva di tutto il dicibile, portando alla luce, una dopo l’altra, analiticamente, le analogie che collegano le espansioni alle metafore iniziali (e sarà anche un’applicazione del concetto di “metafora di proporzione” teorizzato dal Tesauro nel C annocch ia le a r is to te lico" ) .
Non è questa la sede per avventurarsi nei meandri delle possibili — e sono invero numerose — implicazioni di questo discorso: l’esempio di Marino ci fornisce tuttavia il destro per un paio di considerazioni finalmente conclusive. L’utilizzo che il poeta dell’A done fa dello stereotipo su cui ci siamo soffermati è ad un tempo indice della sua forza di persistenza ed espansione ma anche di una sua relativa labilità: in primo luogo constatiamo la capacità di un microtesto, nato e cresciuto nell’alveo della tradizione lirica, di travalicare i confini del genere di più stretta pertinenza per saldarsi in contesti più o meno limitrofi, nella fattispecie il poema. Anche un Annibai Caro, del resto, nella sua liberissima traduzione àe\Y Eneide, non trova disdicevole associare “tiepida neve” e “viv’ostro” per significare l’incarnato delle braccia di Venere, operando un’autentica violenza nei confronti del testo latino45. Da altri punti di vista, tuttavia, quello stesso microtesto sperimenta un destino di intermittenza e caducità: Marino e i poeti del Seicento ne dilatano sì le potenzialità espressive, reinterpretandolo alla luce di una poetica straniante, ma ne decretano nello stesso tempo il decadimento, quasi che, nel massimo della sua vitalità, venisse improvvisamente meno la sua funzione storica incarnata per un lungo arco di secoli. Non a caso, dopo il Seicento, sono rarissime le attestazioni di luoghi poetici riconducibili a quello stereotipo: il sistema metaforico incentrato sull’elemento “neve” come emblema di bellezza muliebre
43 II motivo è svolto, con un identico numero di versi ma con alcuni variazioni strutturali e tematiche, anche nel canto XVI dell 'Adone (ottava 79): questa volta la descrizione si riferisce, però, a Cupidoro.
44 Cfr. E. TESAURO, Cannocchiale aristotelico, Torino, Zavatta, 1670, pp. 305-341.4<i In particolare, è notevole il fatto che il Caro inserisca nella traduzione («Ciprigna / con la tiepi
da neve e col viv’ostro / de le sue braccia al collo gli si avvinse, / e strinselo e baciollo») la nota cromatica deH’“ostro”, elemento che non compare nei corrispondenti versi latini che recitano come segue: «Dixerat et niveis hinc atque hinc diva lacertis / cunctantem amplexu molli fovet» (Eneide, 1. VTII, w . 387-388): dalla tradizione lirica l’immagine, in ragione della sua emblematicità, è dunque approdata ad un contesto epico.
SmM 2/2005
52
“ROSE VERMIGLIE INFRA LA NEVE” : ANALISI INTERTESTUALE DI UN MICROTEMA LIRICO
lascia spazio ad utilizzi in accezione realistica o, nei poeti di fine Ottocento e inizi Novecento, a procedimenti di diversa pregnanza simbolica (il poeta che forse più di tutti attinge in maniera più o meno ortodossa dalla tradizione che abbiamo ripercorso è D’Annunzio46, uno scrittore altrettanto “rampine- sco” di Marino).
Di quel topos semmai si intravedono le disjecta m em bra , i lacerti, nei contesti più disparati: l’estenuazione della tradizione petrarchista è senza dubbio, sul piano storico, il fenomeno che meglio rende ragione di un tale processo di diffrazione e, dunque, da un’ottica più propriamente strutturale si può osservare che l’intertestualità non è un sistema chiuso, vive di sinergie con il più generale sistema della cultura e della sua evoluzione diacronica.
Il fatto che comunque qualcosa sopravviva, sebbene in forme e contesti variabili, è sintomatico; ci riporta all’idea suggestiva che qualsiasi testo funziona un po’ come una nevrosi: il rimosso è destinato a far breccia e a riemergere dove meno ce lo aspettiamo, secondo modalità spesso imponderabili. Nostro è il problema di capire.
46 Cfr. versi come questi (contenuti in Mattinata della Chimera)'. «E neve e rose ed oro / il mattin fresco mesce».
SmM 2/2005