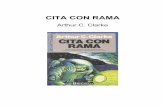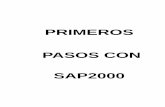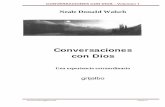Risorgimento con eroi. Il Garibaldi di Bianciardi
Transcript of Risorgimento con eroi. Il Garibaldi di Bianciardi
Simone Casini
Risorgimento con eroiIl Garibaldi di Luciano Bianciardi
Non vi è dubbio che il libro su Garibaldi sia una delle opere mi-nori, e forse la minore, tra quelle di Bianciardi. Si tratta del restodi un lavoro commissionato, destinato a un pubblico giovanile,nel quale lo scrittore riutilizza in larga misura temi, materiali epagine già elaborati nei due precedenti libri storici - Da Quarto aTorino e Dàghela avanti un passo! - senza per questo attivare, senon in minima parte, quello straordinario travaso intertestuale chelega unitariamente, come un fenomeno carsico, le fonti memo-rialistiche ottocentesche, i propri testi storici e i romanzi La bat-taglia soda e Aprire il fuoco. Il Garibaldi, almeno in apparenza,si presenta come un’opera più stanca e frettolosa, frutto di fati-che più redazionali che autoriali, riscattata al di là dei suoi meritiper il fatto di essere l’ultima e postuma pubblicazione.
Tuttavia non è per dovere d’ufficio che il Garibaldi ci sembrameritevole di ben altre considerazioni, sia in rapporto a fattoriestrinseci come la scelta del soggetto e l’uscita postuma, sia peralcuni caratteri interni. In ogni caso, non può essere sottovalutatala circolarità a suo modo perfetta che chiude la carriera di Bian-ciardi con un libro per ragazzi sull’“eroe” delle sue prime lettureda ragazzo. Si direbbe ancora un episodio carsico, forse meno in-tenzionale degli altri, se non fosse che il soggetto non riemerge maaccompagna lo scrittore negli anni come una lunga fedeltà.
Prenderemo in esame dapprima la figura di Garibaldi nella ri-flessione di Bianciardi; quindi il posto che il libro del ’72 occupa nelpercorso intellettuale e letterario dello scrittore; infine cercheremo,attraverso l’analisi del testo, di riconoscerne i tratti peculiari.
Dalla vita agra a Garibaldi
Una sera dei tardi anni Sessanta, Giovanni Arpino glielo dissesenza tanti complimenti: “Ma si può sapere cosa te ne frega a tedi Garibaldi?”1. È una domanda che registra perfettamente l’in-
31
comprensione degli amici e del pubblico verso quel tema risorgi-mentale che negli ultimi anni era divenuto pressoché esclusivo2.Come mai - dopo le grandi opere autobiografiche sul lavoro cul-turale, sull’integrazione e sulla vita agra che avevano centrato coneccezionale tempismo e precisione le contraddizioni della nuovaciviltà industriale italiana - come mai, quasi abdicando o rinne-gandosi, Bianciardi si era messo a scrivere solo di Cinque gior-nate, di Calatafimi, di Custoza? “Ma si può sapere cosa te ne fregaa te di Garibaldi”?
Arpino avrà certamente saputo o sospettato che l’epopea ri-sorgimentale per l’autore de La vita agra non era affatto unoscherzo ma stava operando uno straordinario cortocircuito tra pas-sato e presente. Ma da amico, coglieva soprattutto e con preoc-cupazione un altro aspetto, che anche a noi sembra evidente: checioè, nel percorso intellettuale e letterario di Bianciardi, la pro-duzione risorgimentale rappresenta comunque un ripiegamento,una regressione, un esilio volontario dal presente in un sogno tuttosommato libresco (e siano pure i libri dei memorialisti garibal-dini). Da amico - forse con insofferenza, ma anche con affetto -Arpino vi vedeva giustamente un segno di regressione, di fuga, difallimento. La produzione risorgimentale di Bianciardi coincideinfatti con gli anni più cupi della sua esistenza.
“Ma si può sapere che cosa te ne frega a te di Garibaldi?”. Cer-tamente, risponde Pino Corrias, “era soprattutto un legame con lasua infanzia”, con quel regalo che il padre gli aveva fatto per gliotto anni, I Mille di Giuseppe Bandi: “storia letta e riletta fino aimpararla a memoria”, “un ricordarsi per sempre ragazzino gros-setano che rilegge le stesse pagine, la stessa storia e sogna i gari-baldini nella cameretta di casa sua”3.
E tuttavia vi è un significato più profondo, più conseguente epiù adulto in questa mossa regressiva, in questa ombrosa e in-spiegabile abdicazione dal presente, un significato che sotto certiaspetti coincide con la ricerca di una possibile via d’uscita.
Risorgimento come luogo di esilio
Il Risorgimento, nella storia italiana, non è un periodo comegli altri: è per eccellenza il momento della speranza e dell’utopia,
32
BIANCIARDI, OTTOCENTO COME NOVECENTO
l’unico momento in cui le contraddizioni e i contrasti si manife-starono insieme a una loro possibile soluzione, un momento incui erano ancora aperte possibilità che nel giro di pochi anni, unadopo l’altra, si chiusero rapidamente. È l’atto originario in cui lostato prende forma dalle grandi questioni del passato, le rinnovae le riformula. È quindi anche il momento delle grandi delusioni,della smobilitazione e dell’esilio. Tornare al Risorgimento - nonsolo per Bianciardi - è dunque il modo per ripensare a un’Italia di-versa, a una storia che sarebbe potuta essere e non è stata.
L’esilio volontario di Bianciardi nel passato risorgimentale, chein Aprire il fuoco assume una geniale forma narrativa, è in questosenso un’intuizione straordinaria, potente, davvero poetica, per lalogica segreta e la profonda disperazione che lo anima. Così in-teso, il Risorgimento non è tanto o non è solo una fuga dal pre-sente, come intendeva Arpino, ma è anche una possibilità nuovadi illuminare la profondità storica del presente italiano.
Ma Garibaldi? “cosa te ne frega a te di Garibaldi”? Tutto il Ri-sorgimento per Bianciardi ruota intorno alla figura di Garibaldi.Con questo non si vuole certo cancellare il significato esemplareche lo scrittore assegna ad altri momenti (le Cinque Giornate, Cu-stoza) e ad altri protagonisti, anzi agli altri “mille” eroi e agli altrimille episodi recuperati dalle pagine dei memorialisti. Ma è evi-dente l’assoluta centralità di Garibaldi, in quanto è lui a determinarela polarizzazione del Risorgimento, rappresentandone la polaritàpositiva e utopica, laddove quella negativa o distopica è costituitada “Custoza” (che va intesa come l’assenza o meglio l’emargina-zione di Garibaldi) o dal “diabolico conte” di Cavour, che è in que-sto senso l’antagonista, l’anti-Garibaldi, la soluzione “diplomatica”che sfrutta, combatte e vanifica la soluzione “popolare”.
La Angelini in questo senso ha parlato addirittura di una vi-sione “manichea”4. A noi pare piuttosto che la riflessione di Bian-ciardi precorra il ritorno a Garibaldi al quale assistiamo oggi, inquanto nodo centrale del dibattito non solo storiografico ma anchepolitico, quel “contenzioso” sempre aperto - come lo ha definitoMario Isnenghi - che coagula tuttora intorno al nome di Garibaldi,e non a quello di Mazzini o di Cavour o di Vittorio Emanuele.
33
CONVEGNO
Dicono male di Garibaldi grandi e piccoli leghisti. Dicono male diGaribaldi al Meeting estivo di Comunione e Liberazione a Rimini. Quelliche oggi si proclamano moderati o riformisti non ce l’hanno proprio inmente. E il revisionismo più colto risale a lui per stigmatizzare quelloche chiama il “Brigatismo senza fine”. È venuto il momento di dir benedi Garibaldi.5
Certo, il “contenzioso”, negli anni Sessanta, verteva su altripunti rispetto a quelli cui fa riferimento Isnenghi. Lega, Comu-nione e Liberazione, brigatismo e revisionismo erano ancora dilà da venire. Ma le parole di Isnenghi ricordano quelle di Bian-ciardi quando scrive che: “Garibaldi nel nostro Risorgimento rap-presenta l’elemento popolare: a lui va tutta la simpatia di chiscrive, una simpatia che potrà sembrare partigiana, e lo è”6. È gra-zie a Garibaldi, insomma, che il Risorgimento non può lasciare in-differenti, costringe a prender posizione e chiama ancora araccolta garibaldini e partigiani. Non figura della concordia na-zionale, dunque, ma di una spaccatura profonda e irrisolta.
Secondo questo modo di sentire e di intendere, Garibaldi cata-lizza le forze migliori del Risorgimento, ne rappresenta il mo-mento felice, l’inveramento della storia unitaria, la soluzionepossibile e già quasi raggiunta, le speranze e le istanze più nobili.All’appello rispondono prontamente i “volontari” - fenomeno de-cisivo del Risorgimento - come Bandi, come Nievo, come Chec-chi, come tanti altri. Giustamente Bianciardi sottolinea come sitratti “di uno degli eserciti più colti che la storia ricordi”7, pienodi studenti, medici, ingegneri, poeti, scrittori. Manca in effetti lapartecipazione popolare, mancano i contadini, e tuttavia, dopo lapresa di Palermo, i Mille divennero in pochi giorni i cinquantamiladi quell’Esercito Meridionale che Cavour si affrettò a smobilitare.Garibaldi insomma non è l’eroe solitario e individualista, ma ilcentro e l’occasione di un Risorgimento vagheggiato ma in parteanche realizzato come momento corale.
Insomma non sarebbe sufficiente né corretto circoscrivere il si-gnificato che Garibaldi ha per Bianciardi a quello di un fantasmadell’infanzia. È semmai una fedeltà voluta e ribadita negli anni, unafigura di Garibaldi cresce nel tempo cambiando aspetto e significatovia via che si approfondiscono la riflessione e l’esperienza.
34
BIANCIARDI, OTTOCENTO COME NOVECENTO
Per seguire l’evoluzione della figura dell’eroe nella riflessionedi Bianciardi, occorre indicare alcuni episodi salienti. Dapprima,Garibaldi è in modo pressoché esclusivo l’eroe della spedizione inSicilia, avvicinato attraverso i memorialisti. Tale è nell’edizionede I Mille di Bandi annotata da Bianciardi nel 1955, e nel primo,più serio e approfondito tra i saggi storici, Da Quarto a Torino -Breve storia della spedizione dei Mille, del 1960. Poi il quadro siallarga e si storicizza, e la spedizione dei Mille diviene allora ilcentro di eventi più grandi, aprendosi a significati sempre piùesemplari e profondi. Dàghela avanti un passo! racconta sì l’epo-pea risorgimentale nel suo complesso, ma sin dal titolo dichiaral’intenzione - cito ancora la premessa - di voler dare “grande spa-zio alla figura di Giuseppe Garibaldi e alla sua impresa più bella,la liberazione del Sud”.
Ma quando la piena risorgimentale tracima dalle pagine storicheper fecondare in chiave ormai metastorica e allegorica l’invenzioneromanzesca, Garibaldi e i Mille non sono più al centro del quadro,ma lo hanno lasciato vuoto. La battaglia soda, com’è noto, si apresull’addio di Garibaldi ai suoi soldati durante l’assedio di Capua esulla sua partenza per Caprera, mentre al centro del racconto saràla sconfitta di Custoza. Aprire il fuoco racconta il fallimento delleCinque Giornate, un fallimento dovuto a “infantilismo rivoluzio-nario”: ma se ci fosse stato un “rivoluzionario adulto” come Gari-baldi, come Stalin, come Guevara - scrive nel suo delirio l’esiliatodi Nesci - le cose sarebbero andate diversamente.
Nei romanzi, insomma, Garibaldi è il grande assente, il centrovuoto. La memoria e l’attesa di Garibaldi dominano l’immaginariodel Bianciardi romanziere. E l’assenza/presenza di ciò che è statocostituisce il segno distintivo della memorialistica. Va sottolineatoil fatto che la figura di Garibaldi per Bianciardi è sin dall’inizio in-scindibile dalla memorialistica garibaldina, che approfondisce finoa diventarne un vero specialista: dalla memorialistica, come ve-dremo, deriva non solo episodi poco conosciuti e alternativi a certastoriografia ufficiale, ma anche l’atteggiamento di fondo, il tonodella voce e numerosi tratti del genere.
Se il carattere postumo del volume su Garibaldi fu casuale,non lo è comunque a posteriori, chiude circolarmente, quasi uncongedo consapevole, la vicenda di Bianciardi. Si rilegga in que-
35
CONVEGNO
sta chiave l’ultimo capitolo del libro, dove il congedo dell’eroe èin qualche modo anche il congedo dello scrittore.
“Un’altra biografia su Garibaldi...?”
Dopo quanto si è detto circa l’importanza di Garibaldi nella ri-flessione storiografica e metastorica di Bianciardi, ci aspette-remmo nel libro su Garibaldi un’opera maggiore, che assumefinalmente a soggetto un centro focale e originario della propriaispirazione. Invece non lo è o lo è solo in parte. Non certo per in-sufficiente consapevolezza né per sentimento di inferiorità rispettoal tema. Bianciardi - lo abbiamo visto - era certamente in condi-zione di scrivere un suo originale Garibaldi, e anche se non in-tendeva competere con i biografi-testimoni né con gli storici dimestiere, dal punto di vista storico-documentario aveva un suopunto di forza solido e originale, la familiarità ormai di lunga datacon la memorialistica garibaldina.
Forse, paradossalmente, non era questo il suo tema, e abbiamodetto perché. Garibaldi è il motore dell’azione, il centro del vor-tice, il punto d’incontro di forze diverse, lo sfondo grandioso deisingoli episodi, la presenza-assenza necessaria al discorso, manon il protagonista. Tendenzialmente il Bianciardi risorgimentalemira a opere corali, secondo il modello memorialistico, in un qua-dro popolato da tanti protagonisti veri e fittizi: dai Mille in DaQuarto a Torino ai tanti patrioti di Daghela avanti un passo!, dagliorfani di Garibaldi in La battaglia soda ai milanesi di Aprire ilfuoco. La focalizzazione è sugli episodi, non sui personaggi. Ilprimo piano biografico è invece un’operazione molto diversa, lon-tana dai modi dell’ispirazione di Bianciardi e della memoriali-stica. La biografia è un genere storiografico dalle convenzioniprecise che lascia margini stretti all’invenzione e al giudizio.
Una biografia di Garibaldi, in particolare, deve fare i conti conun formidabile numero di concorrenti. Anche limitandoci alle bio-grafie in senso proprio - quelle che raccontano integralmente la vitadell’eroe dalla nascita alla morte - ne contiamo più di cento, un veroe proprio sottogenere che impone temi, episodi, passaggi e con-fronti obbligati. Si va dalle biografie ‘storiche’ di compagni comeGiambattista Cuneo, l’amico degli anni sudamericani e forse di Ta-
36
BIANCIARDI, OTTOCENTO COME NOVECENTO
garong8; a quelle di fedeli garibaldini come Giuseppe Guerzoni,uno dei volontari del 1860, poi segretario a Caprera9; e di testimonicome Jessie White Mario10 e Vittorio Vecchi alias Jack La Bolina,figlio del proprietario della villa di Quarto11; a quelle fondamentalidi storici come George Macaulay Trevelyan12 e di Gustavo Sacer-dote13; a quelle di uomini politici come Pietro Nenni14, per arrivarea quelle degli anni di Bianciardi, apparse per il centenario dei Mille,come il Garibaldi di Denis Mack Smith15, e quello di Indro Mon-tanelli16. Ma l’elenco sarebbe assai più lungo.
Del resto, la biografia bianciardiana non va misurata sulla tra-dizione maggiore che abbiamo accennato, quanto sulla letteraturaper ragazzi cui Mondadori intendeva destinarla. A Bianciardi noninteressava né competeva scrivere un’opera storica su Garibaldi,quanto portare a termine il compito che si era prefissato: far co-noscere il più possibile ai giovani il Risorgimento, farli innamo-rare di quelle vicende così come lui si era innamorato da ragazzodelle pagine del Bandi. Probabilmente è questo il compito che siera fissato e che riesce nonostante tutto a portare a termine.
In questo ambito era ancora più diffusa un’immagine insoppor-tabilmente retorica, sentimentale, conformista, acritica dell’Eroedei Due Mondi. Successo e ristampe, per esempio, riscuotevano inquegli anni il Garibaldi di Giulia Liburdi (1961) o il Romanzo diGaribaldi di Luigi Ugolini (1958). Come vedremo, Bianciardi rin-nova in modo davvero notevole il genere, riformulando e arric-chendone le convenzioni grazie al modello della predilettamemorialistica garibaldina, della quale per esperienza personaleconosceva bene le potenzialità pedagogiche e civili.
Il programma divulgativo e pedagogico bianciardiano era statoformulato con intelligenza storiografica, con consapevolezza ci-vile e con dovizia di argomenti nella pagina conclusiva di Dà-ghela avanti un passo!:
A ciascuno il suo bel monumento, tutti ben alti sul loro piedistallo, danon poterli toccare con le nostre mani. E sarà fin troppo facile far credereche il Risorgimento sia stato possibile grazie all’opera concorde di questiuomini… La verità, come abbiamo visto, è un’altra. La verità è che fraquesti uomini non vi fu concordia, ma avversione e odio, discrepanza e ir-resolutezza. La verità è che il Risorgimento fece l’Italia quale poi ce la
37
CONVEGNO
siamo trovata noi italiani, lacerata e divisa. Divisa fra italiani ricchi e ita-liani poveri. Fra italiani del nord e italiani del sud. Fra italiani dotti e ita-liani analfabeti. Tutte divisioni che oggi noialtri italiani faticosamentepenosamente stiamo cercando di colmare. Ma per far questo dobbiamosapere la verità su come l’Italia fu fatta. Dobbiamo insomma studiare sulserio la storia di quel “miracolo” che fu il nostro Risorgimento.17
In forma impoverita e un po’ stanca il programma è sostan-zialmente lo stesso nella conclusione del Garibaldi del 1972. Sipuò supporre che lo scrittore non abbia avuto il tempo di prepa-rare una premessa al nuovo volume.
E subito gli fecero il monumento, lo misero, a cavallo o senza, incima a un piedistallo, decisi a non farlo più scendere. Ancora oggi, permolta gente, il Garibaldi della leggenda torna più comodo del Garibaldidella realtà. Noi, modestamente, abbiamo cercato di farlo scendere dalpiedistallo, di ritrovarlo uomo.18
L’obiettivo dei due libri di divulgazione storica può articolarsiquindi in tre punti.
In primo luogo, vi è la polemica contro la “leggenda” e la tra-dizione retorica, che aveva posto i protagonisti del Risorgimento suun ambiguo “piedistallo”. Tale polemica caratterizza le maggioribiografie garibaldine degli anni Cinquanta e Sessanta, che hannovalore più divulgativo che storico-scientifico. Per esempio Mon-tanelli scrive nella sua premessa: “Il nostro scopo era soltantoquello di avvicinare al grande pubblico un uomo che per un secoloè rimasto, anche per colpa o volontà sua, allo stato di monumento”.Ma mentre la critica della tradizione eroica e monumentale si tra-duce, in Montanelli e più ancora in Mack Smith, in un atteggia-mento spesso riduttivo, talora ironico e addirittura denigratorio neiconfronti dell’“uomo”, in Bianciardi questo non succede, l’“eroe”non è alternativo all’“uomo”, il rispetto non viene meno per il pro-posito “di farlo scendere dal piedistallo, di ritrovarlo uomo”. Sonoesemplari in questo senso i due capitoli più privati, il primo sul-l’infanzia, non privo di umorismo, e l’ultimo sulla vecchiaia e lamorte, denso di amarezza e malinconia.
38
BIANCIARDI, OTTOCENTO COME NOVECENTO
In secondo luogo, vi è un giudizio di tipo storico e critico, sulquale poggia la riflessione propriamente storiografica di Bianciardigià nelle opere precedenti. Secondo il programma di Dàghela avantiun passo!, è falsa la rappresentazione del Risorgimento come “mi-racolo”, come opera concorde dei suoi protagonisti maggiori e dellevarie anime d’Italia: l’unità del paese nacque invece in mezzo e aopera di irriducibili discordie, di ambiguità, inganni e arroganzeumilianti, dei quali Garibaldi è con Mazzini la vittima più illustre,e certo la più clamorosa. Anche nel libro del ’72 vediamo all’operaquesto giudizio. Se vengono sfumati - com’è ovvio - i contrasti conMazzini, sono invece strutturali nel racconto, pur nei limiti e neimodi di un libro per ragazzi, quelli con La Farina, con La Marmorae con Cavour, regolarmente definito “il diabolico conte”.
In terzo luogo, vige più forte che mai l’invito pedagogico rivoltoai giovani a “studiare sul serio la storia di quel miracolo che fu il Ri-sorgimento” al fine di capire il nostro presente. La pedagogia diBianciardi si traduce immediatamente nell’impegno a raccontare ilRisorgimento come un Salgari, perché “il Risorgimento è una fac-cenda che appassiona e avvince, e persino diverte”.
Garibaldi “straniero in patria”. Fonti e documenti
L’attacco del Garibaldi è assai felice. Si comincia con un do-cumento secondo la migliore tradizione della storiografia e delromanzo storico, e attraverso il documento - l’elenco ufficiale deiMille pubblicato nel 1878 dal neonato stato italiano - si pervienesubito a un giudizio che illustra i motivi programmatici del libro.
Il documento non fa una grinza: se voi avete la pazienza di andarvi acercare l’elenco ufficiale dei volontari sbarcati a Marsala (a cura del mi-nistero della guerra, in Torino, anno 1878) noterete subito che i famosiMille furono, per la precisione, milleottantotto, più una donna, tale Ro-salia Montmasson. Di ciascuno si dà [nell’elenco ufficiale], tra le altrecose, luogo di nascita e nazionalità: ci troviamo per esempio ungheresi[...] Ci troviamo tredici trentini, allora sudditi austriaci. Ci troviamo unfrancese, Garibaldi Giuseppe del fu Domenico, nato a Nizza il 12 luglio1807. [...] E veramente Nizza, quando Garibaldi ci nacque, era da qual-che anno nelle manine rapaci di Napoleone primo [...] è anche vero che
39
CONVEGNO
nel 1859, prima che cominciasse la spedizione di Sicilia, il Piemontel’aveva ceduta, daccapo e definitivamente, stavolta, all’altro Napoleone,il Piccolo, il Terzo. Un regalo questo, che Garibaldi mai più perdonò alconte di Cavour, il quale lo aveva reso “straniero in patria”.19
Programmatici e strutturali sono dunque i contrasti tra Gari-baldi e Cavour, tra Garibaldi e i funzionari piemontesi che miranoa neutralizzarlo ed emarginarlo, fino alla grottesca registrazioneanagrafica del 1878 che trasforma il campione dell’unità italianain un francese.
Non è una trovata d’occasione. L’incipit del Garibaldi ricordaanzi le strategie intertestuali del miglior Bianciardi: il documentodel 1878 era già stato utilizzato dallo scrittore due volte. Anzi-tutto nel primo lavoro storiografico, Da Quarto a Torino, dove sinoti il diverso atteggiamento dello storico (“non sapremo mai conprecisione quanti furono”) rispetto a quello del narratore salga-riano (“furono per la precisione milleottantotto”):
Purtroppo non sapremo mai con precisione quanti furono esattamentei Mille [...] Oltre gli ungheresi, l’elenco ufficiale degli sbarcati a Marsalaregistra altri stranieri: quattordici trentini, un americano (Menotti Gari-baldi) e un francese (il generale medesimo, nizzardo). Nel 1861, quandofu compilato il primo elenco, la storia dei Mille era già finita nelle manidei burocrati.20
Ma assai più interessante era stata l’utilizzazione del docu-mento ne La battaglia soda. Troppo grottesca ed esemplare era laregistrazione burocratica di un “Garibaldi francese” per non darluogo a un vero e proprio episodio, del quale è protagonista nien-temeno che Giuseppe Bandi, già fonte autorevole e adesso con-trofigura dello scrittore e personaggio-narratore del romanzo.Bandi, nel terzo capitolo de La battaglia soda, si trova a Torino,all’indomani della smobilitazione dell’Esercito Meridionale gari-baldino e del suo ingaggio nell’esercito regolare, “a comandare lasquadra di scribacchini” incaricata di redigere appunto “l’elencodegli sbarcati a Marsala”21. E quella che avrebbe dovuto esserequestione di pochi giorni, diviene il primo episodio di distorsionedella verità storica ad opera di funzionari ottusi e di ambigue vo-lontà politiche:
40
BIANCIARDI, OTTOCENTO COME NOVECENTO
Quando poi il comando volle che Giuseppe Garibaldi figurasse comefrancese, essendo Nizza città oggi sita in territorio francese, e ciò per letresche del Conte di Cavour, che avea fatto il nostro vecchio, nemicis-simo di Luigi Napoleone e dei francesi codini, straniero in patria, la rab-bia mia fu lì lì per traboccare, e non so come riescii a tenermi in cristiper non mandare a quel paese l’elenco dei Mille, lo stanzone della ca-serma Cernaia coi miei quaranta grattacarte e il generale Fanti in per-sona, con il suo codazzo spocchioso di lustrissimi signori generali.22
L’inizio del Garibaldi sembra dunque annunciare anche quelcaleidoscopio intertestuale che Bianciardi ha creato nelle opereprecedenti. Ma, se non erro, non si trovano altri casi analoghi aquesto o a quelli di Dàghela avanti un passo!, dove Bianciardiarrivava a citare se stesso come testimone. Nel Garibaldi non ri-corre il Bandi fittizio di La battaglia soda (passano anzi sotto si-lenzio i momenti forti di quel romanzo, come l’addio di Capua ela guerra del 1866), mentre è più volte ricordato il vero e imman-cabile Bandi de I Mille, cui spetta anzi l’onore, mediante cita-zione, di raccontare Calatafimi.
Le citazioni sono peraltro rare, nel Garibaldi, e provengono dafonti storiche e memorialistiche come Jessie White Mario e Giu-seppe Cesare Abba, mentre sono generici ma significativi i rimandia “biografi meticolosi” (per esempio: “I suoi biografi meticolosifanno salire a sedici il numero delle persone da lui soccorse”) e a“storici militari” (“Affermano alcuni storici militari”),23 quali PieroPieri e Antonio Pollio, che Bianciardi ben conosceva.
I dialoghi
La fisionomia narrativa ed espressiva del volume su Garibaldiha però il suo tratto più caratteristico nella sceneggiatura per dia-loghi, che lo distingue decisamente anche dai due precedenti librisul tema risorgimentale. Il racconto è arricchito e addirittura in-farcito di dialoghi fittizi - una trentina - che sono privi di valorestorico e documentario, ma proprio per questo presentano altrimotivi di interesse, di ordine letterario e ideologico.
Il dialogo fittizio è naturalmente un espediente narrativo assaidiffuso nella letteratura per ragazzi, in quanto conferisce vivacità
41
CONVEGNO
e immediatezza al racconto, e unisce utile dulci. Ma l’uso che nefa Bianciardi, pur non distaccandosi dalle convenzioni del genereper ragazzi, va considerato alla luce anche di altri modelli narra-tivi e altri possibili significati. Non è fuori luogo ricercare pro-prio in questi dialoghi, che costituiscono per così dire un corpusriconoscibile e parzialmente autonomo del racconto, le tracce diuna lettura originale, sia pure in chiave pedagogica, della figura diGaribaldi. Qui infatti c’è invenzione, ed è anzi l’ultima scritturadi invenzione dello scrittore.
Più che le analoghe pubblicazioni per ragazzi, Bianciardi ha inmente anche per questo aspetto il modello della memorialisticarisorgimentale, ricchissimo di dialoghi vivaci ed esemplari neisuoi esponenti maggiori come Bandi e Abba. Infatti la stessaspinta a sceneggiare il racconto riportando in diretta le battute deiprotagonisti dei grandi eventi storici già fermentava in Da Quartoa Torino e in Dàghela avanti un passo!, frenata però - com’èovvio - dal criterio storico, che circoscrive la scelta alla sola do-cumentazione proposta dai memorialisti e altre fonti. Per esempio,in Da Quarto a Torino, Bianciardi riporta da Bandi il dialogo traGaribaldi e il trombettiere nell’imminenza della battaglia di Ca-latafimi, e da Abba il celebre dialogo del volontario garibaldinocol siciliano frate Carmelo, straordinario documento che manife-sta precocemente quella distanza e quell’incomprensione tra leattese dei contadini e l’idealismo risorgimentale dei volontari, cheavrà il suo primo drammatico scontro nell’episodio di Bronte eche prefigura, più in generale, il fenomeno del brigantaggio e la“questione meridionale”. Bianciardi lo ripropone infatti anche inDàghela avanti un passo!. Nel Garibaldi troviamo l’uno e l’altro,il dialogo tra Garibaldi e il trombettiere, e quello tra Abba e ilfrate siciliano.
Sul modello di questi due dialoghi non fittizi, Bianciardi inventatutti gli altri, con grande intuito storico e molta sensibilità didattica.“Finzione congetturale”, la chiamerebbe Emanuela Scarano se-condo le categorie elaborate intorno al rapporto tra storia e fin-zione, non troppo diversa, dal punto di vista teorico, dal modelloillustre delle orazioni fittizie della storiografia umanistica24. “Glidisse pressappoco così”, scrive per esempio il narratore introdu-cendo il bel dialogo tra Garibaldi e il presidente riograndense Bento
42
BIANCIARDI, OTTOCENTO COME NOVECENTO
Gonçalves. Non si tratta infatti di riscrivere e alterare la storia, nédi proporre una “antistoria”, ma più modestamente di illustrarla, diimmaginarla, di riempirla di colori, contenuti e movenze umane.
Non è possibile in questa sede esaminare adeguatamente il cor-pus dialogico del Garibaldi25. Se ne veda un esempio. Mentre glistorici si arrovellano da sempre sull’identità del misterioso ita-liano che nel porto di Taganrog sul Mar Nero, nel 1833, parlò perprimo al giovane marinaio di Mazzini e della Giovine Italia, iden-tificandolo senza troppi argomenti in Giambattista Cuneo, Bian-ciardi ha invece lo scoop, e riporta il dialogo tra i due,introducendo così alcuni temi fondamentali:
Questo appunto spiegò Cuneo al giovane capitano di mare.“Una lettera al re? chiese un po’ perplesso. Ma non m’avete detto or
ora che questo Mazzini è repubblicano?”“Repubblicano sì, ma prima di tutto vuole l’Italia indipendente e
unita, capito? Poi, da cosa nasce cosa.”“E il re? Cosa ha risposto il re?”“Quello? Ha dato ordine che arrestino Mazzini, se si azzarda a entrare
nel suo stato. Ecco cosa ha risposto.”“E non può essere” riprese Garibaldi sorridendo, “che Mazzini que-
sta lettera l’abbia scritta apposta per farsi dire di no, e così dimostrare atutti che questo re è nemico dell’unità italiana?”
“Può darsi, certo” rispose Cuneo. “Vedo che cominciate a capirecome è fatta la politica. Tanto più che questa lettera non l’ha ricevuta ilre soltanto. L’abbiamo stampata e circola in centinaia di copie.”
“La vorrò leggere, di sicuro. Ma ditemi, caro Cuneo, questo Mazziniè nella Carboneria, vero?”
“C’era, e per questo lo incarcerarono a Savona. E proprio nel carcereha meditato sulle cose d’Italia, e ha deciso di fondare una società nuova,chiamandola la Giovine Italia”
“Come nome suona meglio. A fare il carbonaro ci si tinge il nome dinero. Giovine Italia è un nome più bello”.
“E non soltanto il nome è più bello, vedete. La Carboneria era unafaccenda troppo ristretta, di aristocratici, con troppo mistero, troppo ri-tuale. La Giovine Italia si rivolge a tutto il popolo, perché l’unità d’Ita-lia non sarà una cosa seria se non l’avrà fatta il popolo. [...]”.26
43
CONVEGNO
Non è difficile avvertire in opera, in pagine come questa, il du-plice proposito di “mostrare l’uomo” prima dell’eroe e di spie-gare ai ragazzi il Risorgimento, con indicazioni apodittiche mariassuntive ed efficaci (“l’unità d’Italia non sarà una cosa seria senon l’avrà fatta il popolo”…). Vi riconosciamo anche quell’entu-siasmo narrativo che è proprio dei memorialisti garibaldini neimomenti migliori, e si può immaginare che scrivere, riscrivere oinventare pagine simili fosse per il Bianciardi degli ultimi anni unrifugio contro il montare della disperazione, o una delle sue forme.
Del resto colpiscono anche i silenzi, in un libro tanto ricco diparti dialogate. Alcuni celebri incontri, politicamente troppo im-pegnativi e controversi, nei quali l’invenzione avrebbe alterato ilsignificato degli eventi, vengono discretamente elusi dallo scrit-tore, come l’incontro con Mazzini nel 1832 dopo Taganrog (“nes-suno dei due ne parla nelle proprie memorie, se nonbrevissimamente”), o quello con Cavour nel 1858 (“gli disse nonsi sa bene cosa”).
Celeberrimo, ed eloquente nel suo laconismo, l’incontro traGaribaldi e Vittorio Emanuele a Teano, già tratto da fonti memo-rialistiche. Il re “almeno come carattere somiglia un poco a Gari-baldi”, aveva osservato Bianciardi27, il quale registra con una certasimpatia le argute risposte del sovrano agli sfoghi di Garibaldi perla vendita di Nizza (“lui straniero in patria? e io che mi chiamoSavoia?”); ma il gelido saluto di Teano sta tutto in due battute:“Salute al re d’Italia. - Come state, generale? - Non sapevano cosadirsi. Cavalcarono per un tratto fianco a fianco [...] Giunti che fu-rono a un ponticello, si divisero.”
L’epilogo dell’episodio, che può considerarsi omologo al rac-conto dell’addio di Garibaldi ai suoi soldati in La battaglia sodae parimenti tratto da fonti memorialistiche, vede Garibaldi fer-marsi a una taverna, prendere un sorso d’acqua e sputarlo, conuna frase emblematica (“Nel fosso deve esserci una bestia mortada tempo”). Eravamo stati “spremuti come limoni”, commenta ilBandi nelle sue memorie.
44
BIANCIARDI, OTTOCENTO COME NOVECENTO
Garibaldi e la guerra
Dal punto di vista dei motivi ricorrenti e strutturali della bio-grafia, uno degli aspetti più significativi è l’attenzione tecnica allevicende militari e l’apologia delle capacità tattiche e strategichedel generale Garibaldi, di contro ai frequenti giudizi riduttivi e po-lemici dei tanti rivali e avversari. Descrizioni di battaglie e note ditecnica militare fanno parte da sempre del repertorio della lettera-tura per ragazzi, ma anche in questo caso la convenzione di generesi intreccia con gli interessi specifici dello scrittore, centrali, com’ènoto, in romanzi come La vita agra e Aprire il fuoco. Dopo i me-morialisti, si può dire che le predilezioni del Bianciardi risorgi-mentale si orientino verso la lettura degli storici militari comeAlberto Pollio, fonte precipua di La battaglia soda28, e come PieroPieri, del quale nel ’65 era uscita l’importante Storia militare delRisorgimento, che probabilmente lo scrittore grossetano poté uti-lizzare. Le scelte militari infatti non sono solo questioni tecniche,ma riflettono fondamentali opzioni politiche e contengono inso-spettabili implicazioni ideologiche, come ben sapevano gli uominidel Risorgimento. Non è secondaria, per esempio, l’opposizionetra una guerra condotta da volontari e una da truppe regolari: alcontrario, è qui in gioco la partita decisiva sul nascente statoitaliano.
Garibaldi è imbattibile come capo partigiano, alla guida ditruppe volontarie impegnate in azioni di guerriglia, capaci di scio-gliersi e riunirsi con estrema velocità, di sfruttare al meglio le si-tuazioni spesso avverse, di piombare di sorpresa sul nemico, dilanciarsi con prontezza e coraggio, come nelle celebri cariche allabaionetta, e tutto ciò è possibile perché Garibaldi combatte comeha imparato in Sudamerica, “senza rispettare le regole, come lehanno imparate i militari di professione nelle scuole di guerra e suilibri, gli stessi in tutto il mondo.”29 Ma le polemiche degli avver-sari politici e le gelosie dei militari di professione, com’è noto, ten-tarono di ridurre l’opera di Garibaldi a una serie di eventi fortunatie a un modo di combattere fondato sull’audacia ma privo di effet-tive capacità militari. Bianciardi - come del resto tutta la storio-grafia militare - è invece di tutt’altro parere. Ce lo mostra spesso inatto di osservare con estrema cura il territorio col suo cannocchiale,
45
CONVEGNO
o di ammirare sinceramente e senza soggezione la “bellezza” dellemanovre di un nemico ben addestrato, come l’esercito napoletanoe tanto più l’esercito prussiano del 1870 (“io vidi in quel giornonemici, come mai avevo veduto migliori”)30, o mentre progetta concura le mosse da fare.
E nel confronto coi generaloni piemontesi, la bilancia pendesempre a suo favore, come la storia stessa dimostra. Nonostantegli ostacoli di ogni genere creati dai suoi falsi alleati, Garibaldi di-mostra in numerose battaglie campali (Calatafimi, Volturno, Bez-zecca, Digione) grandi capacità militari in senso tradizionale.Garibaldi non fu mai sconfitto, mentre i vari Lamarmora e Cial-dini lo furono pressoché regolarmente. La battaglia del Volturno- scrive Bianciardi - “dimostrava una volta per sempre che Gari-baldi non era solamente un guerrigliero audace, geniale e fortu-nato. No, Garibaldi era capace di condurre e vincere anche unabattaglia campale in piena regola, come quelle che si studiano suimanuali di storia”31. Al contrario Custoza, condotta dal generaleLa Marmora, è “una battaglia che fu poi studiata in tutte le scuolemilitari d’Europa come modello di ciò che non si deve fare pervincere. Fu insomma un condensato di errori”32.
Custoza, come abbiamo accennato, assume valore tristementeparadigmatico, per tutte le “Custoza” che infiorettano la storiadell’Italia unita, e non solo quelle militari, che furono parecchie.Di fronte al disastro, all’incompetenza di chi dovrebbe esserecompetente e responsabile, all’umiliazione, allo sperpero dellesperanze altrui, e al vile telegramma in cui La Marmora chiedeanche a lui di ritirarsi, Garibaldi risponde col sublime e laconico“Obbedisco”. È la sola scelta possibile, quella del silenzio. “Ob-bedire a La Marmora, all’uomo che aveva fatto l’impossibile pertenerlo in disparte, che gli aveva assegnato gli scarti dell’equi-paggiamento, che quattro anni prima, all’Aspromonte, aveva or-dinato di fermarlo ad ogni costo… Garibaldi tornò subito aCaprera, ruminando il suo sdegno. L’anno dopo disubbidirà”33.
Un buon padre
È evidente, in quanto abbiamo detto, che la vicenda di Gari-baldi assume un carattere esemplare e paradigmatico, e vari epi-
46
BIANCIARDI, OTTOCENTO COME NOVECENTO
sodi, come Custoza, prendono un significato implicitamente sim-bolico. La scelta antiretorica di Bianciardi di “mostrare l’uomo”contro le celebrazioni ambigue dell’eroe e della concordia risor-gimentale, inclina a sua volta verso una specifica retorica, quelladel risorgimento tradito e delle speranze deluse. Ma si tratta inogni caso di una lettura assai più vicina e coerente agli eventi, ealla stessa vicenda dell’uomo Garibaldi nel suo ritiro, inevitabil-mente simile a un esilio, di Caprera.
Abbiamo accennato al carattere di congedo malinconico chesegna l’ultimo capitolo del libro, Tramonto dell’eroe. Rispetto alleturbolenti vicende dei capitoli precedenti, pieni d’azione, colpisceper contrasto questo Garibaldi alle prese con le preoccupazioniper i figli, per un’economia oculata, per la fedeltà ai propri idealicontro la piena montante dei compromessi, delle rimozioni e dellevenalità della nuova Italia. In particolare Bianciardi sottolinea congrande sensibilità il sentimento paterno e patriarcale del grandevecchio, commosso alla morte precoce della piccola Rosita, at-tento alla situazione professionale ed economica dei figli ormaigrandi di Anita, e premuroso per il futuro di quelli ancora giovanidi Francesca. “Sempre aveva amato i suoi figli, ma tempo e mododi star con loro, se non sul campo di battaglia, ne aveva avuto sem-pre molto poco. Adesso si godeva la compagnia di Clelia e diManlio, e si andava dimostrando padre tenerissimo: addirittura lilasciava dormire nel suo letto”.
Dopo tante lotte e tante speranze, in fin dei conti Garibaldi la-scia il mondo com’era: “La borghesia era dovunque saldamenteinstallata al potere, gli aristocratici facevano bella cornice; il po-polo sgobbava come sempre”34. Con molta delicatezza Bianciardisegue il suo eroe negli ultimi giorni, in quelle lacrime versate du-rante l’ultima festa, nel rifiuto ostinato di prebende ministerialiper sé, nelle sue ultime uscite “imbacuccato” e immobilizzato dal-l’artrite, nella commozione a rivedere il mare dalla finestra aper-tagli appositamente nella camera, nelle ultime affettuose paroleper le sue bambine.
E non si può fare a meno di pensare che questo congedo di Ga-ribaldi, curiosamente, coincide anche col congedo di Bianciardi.
47
CONVEGNO
1 Cfr. Pino Corrias, Vita agra di un anarchico. Luciano Bianciardi a Milano,Milano, Baldini e Castoldi, 1993, p. 23.
2 Così anche Maria Clotilde Angelini: “L’interesse di Bianciardi per il Ri-sorgimento e in particolare per Garibaldi è andato nel corso degli anni crescendoa tal punto che l’autore ha progressivamente spostato la sua tematica sino a farlaruotare attorno a un vero e proprio mito risorgimentale” (Maria Clotilde Ange-lini, Bianciardi, Firenze, La Nuova Italia, p. 78).
3 P. Corrias, Vita agra di un anarchico, cit., p. 23.4 M. C. Angelini, Bianciardi, cit., p. 82.5 Mario Isnenghi, Garibaldi fu ferito. Storia e mito di un rivoluzionario di-
sciplinato, Roma, Donzelli, 2007, p. 3.6 Luciano Bianciardi, Dàghela avanti un passo! (1969), in L. Bianciardi,
L’antimeridiano. Opere complete, a cura di Luciana Bianciardi, Massimo Cop-pola e Alberto Piccinini, vol. I: Saggi e romanzi, racconti, diari giovanili, Mi-lano, Isbn Edizioni, 2005, p. 1118 (d’ora in avanti semplicemente Dàghelaavanti un passo!).
7 Luciano Bianciardi, Da Quarto a Torino. Breve storia della spedizione deiMille (1960), in L. Bianciardi, L’antimeridiano, cit., p. 304.
8 Giovanni Battista Cuneo, Biografia di Giuseppe Garibaldi, Torino, Fory eDalmazzo, 1850; ristampata nel 1932 (Livorno, Giusti) e nel 1974 (Milano, Mur-sia).
9 Giuseppe Guerzoni, Garibaldi, Barbera, Firenze, 1882, 2 voll., più volte ri-stampata.
10 Jessie White Mario, Giuseppe Garibaldi e i suoi tempi, Milano, Treves,1884.
11 Augusto Vittorio Vecchi, La vita e le geste di Giuseppe Garibaldi, Bologna,Zanichelli, 1910.
12 George Macaulay Trevelyan, Garibaldi e la difesa della Repubbblica Ro-mana, Bologna, Zanichelli 1909, Garibaldi e i Mille, ivi, 1910, e Garibaldi e laformazione dell’Italia, ivi, 1913.
13 Gustavo Sacerdote, La vita di Giuseppe Garibaldi, Rizzoli, 1933.14 Pietro Nenni, Garibaldi, 1930, Milano-Roma, L’Avanti, 1961; ristampa
Milano, SugarCo, 1982.15 Denis Mack Smith, Garibaldi. Una grande vita in breve, 1957, ed. it. 1959,
Lerici 1966, Laterza 1970, 1982.16 Indro Montanelli - Marco Nozza, Garibaldi, Rizzoli, 1962, 1982, 2007.17 Dàghela avanti un passo!, cit., p. 1306.18 Luciano Bianciardi, Garibaldi, Milano, Mondadori, 1972, ora in L’anti-
meridiano, cit., p. 1542.19 Garibaldi, cit., p. 1437.20 Luciano Bianciardi, Da Quarto a Torino. Breve storia della spedizione dei
Mille (1960), in L. Bianciardi, L’antimeridiano, cit., 305, 306)
48
BIANCIARDI, OTTOCENTO COME NOVECENTO
21 La battaglia soda, in L’antimeridiano, cit., p. 766.22 La battaglia soda, p. 768.23 Garibaldi, cit.,p. 1439, p. 1412.24 Cfr. Emanuella Scarano, La voce dello storico. A proposito di un genere let-
terario, Napoli, Liguori, 2004, pp. 84-86.25 Riportiamo l’elenco sommario dei principali dialoghi del volume, con in-
dicazione del numero di pagina dall’edizione in L’antimeridiano: 1. dialogo tramamma Rosa e “Pae Domenico” (1439-40); 2. Garibaldi e Cuneo a Taganrog(1442-43); 3. Garibaldi e il sergente “assentatore” della marina piemontese(1444); 4. incontro con gli esuli genovesi a Rio de Janeiro nel 1836 (1447); 5.Garibaldi e il presidente della repubblica riograndense Bento Gonçales (1449-50); 6. Garibaldi e il prete, al battesimo di Menotti (1452-53); 7. Voci nella Mon-tevideo assediata (1455); 8. Garibaldi e Carlo Alberto, Garibaldi e il ministropiemontese Ricci nel 1848 (1460-61); 9. Voci nel 1848 a Livorno e altrove (1463-64); 10. Garibaldi interviene all’Assemblea Nazionale a Roma nel 1849 (1465);11. discussioni nella Roma assediata (1468); 12. Garibaldi e Roselli (1468); 13.la discussione al Comando Supremo sul destino della Repubblica Romana(1470-71); 14. Garibaldi e il console americano, e altri (1472-73); 15. Garibaldie il capo della polizia di Chiavari (1476); 16. Voci di italiani a New York (1478);17. Garibaldi e i visitatori di Caprera (1481-82); 18. discussioni a Villa Spinolasulla spedizione in Sicilia (1488); 19. Garibaldi e il trombettiere a Calatafimi, daBandi (1496); 20. Eber e le indicazioni per la presa di Palermo (1499); 21. il vo-lontario e frate Carmelo, da Abba (1504); 22. Teano (1511); 23. Sirtori e Bixiosulla liquidazione dell’esercito volontario (1511-12); 24. lo scontro tra Garibaldie Cavour nel parlamento di Torino (1515); 25. la sparatoria e l’arresto in Aspro-monte (1518-19); 26. Garibaldi e il colonnello Porcelli sulla guerra in Galizia(1523); 27. Garibaldi e Gusmaroli per l’evasione da Caprera (1533-34); 28. Gari-baldi e il notaio durante l’assedio di Digione (1540); 29. le ultime parole (1547-48).
26 Garibaldi, pp. 1442-1443.27 Garibaldi, p. 1479.28 Cfr. Stefano Giannini, Bianciardi e il Risorgimento, in “Il Gabellino”, a.
VIII, n. 13, giugno 2006, pp. 9-1129 Garibaldi, p. 1467.30 Garibaldi, p. 1539 (citazione dalle Memorie di Garibaldi).31 Garibaldi, p. 1510.32 Garibaldi, p. 1525.33 Garibaldi, pp. 1529-30.34 Garibaldi, p. 1542.
49
CONVEGNO
Antonella de Nicola
Dinamiche traduttorie nella storiadi Dàghela avanti un passo!
[…] in questa breve storia del Risorgi-mento si è dato sempre grande spazio allafigura di Giuseppe Garibaldi, e alla suaimpresa più bella, la liberazione del Sud.Garibaldi, nel nostro Risorgimento, rap-presenta l’elemento popolare: a lui vatutta la simpatia di chi scrive, una simpa-tia che potrà sembrare partigiana, e lo è.1
Introduzione
Tra gli scritti di natura storiografica2, per i quali si intende la tri-logia che comprende opere come Da Quarto a Torino. Breve sto-ria dei Mille (Feltrinelli, 1960)3, Garibaldi (1967, stampatopostumo presso Mondadori, 1972) e Dàghela avanti un passo!(Bietti, 1969), quest’ultimo occupa un posto particolare per dueordini di motivi:a differenza degli altri due, tale libro viene espli-citamente dedicato al figlio Marcello, denotando così un intentosia di carattere personale, sia di carattere più ampiamente peda-gogico4; si tratta di un testo scritto nel 1969, a due anni dalla mortedell’autore, che nello stesso periodo dava alle stampe il romanzostorico Aprire il fuoco e il diario Viaggio in Barberia.
Queste due ultime si caratterizzano nel contesto della produzionebianciardiana come opere di natura prettamente ‘traduttoria’, nelsenso che si distinguono soprattutto per meccanismi di traduzione in-tralinguistica (Aprire il fuoco) e intersemiotica (Viaggio in Barbe-ria)5 che l’autore espresse ai livelli più estremi. Nello specifico, si fadiretto riferimento a quelle dinamiche di trasposizione storica (lanota commistione di narrazione di eventi storici e di episodi auto-biografici dello scrittore, già in nuce ne La battaglia soda e ulte-riormente sviluppata in Aprire il fuoco), e di un trans-ducere che in
51
termini strettamente linguistici condussero Bianciardi a formulareun pastiche straordinariamente funambolico e sperimentale. Riccodi autocitazioni e riferimenti intertestuali, tale pastiche si evidenziain Viaggio in Barberia attraverso l’elaborazione di un linguaggio‘misto’, e si avvale di segni verbali e iconici6 che arricchiscono ilgià corposo tessuto sintattico tipico dell’ultima produzione bian-ciardiana. Se nel diario della spedizione in nord-Africa il testo sor-prende per la struttura trans-gender della sua narrazione (si trattainfatti di un estroso mélange di memoriale, discettazione storiogra-fica e saggio filo-antropologico), e se Aprire il fuoco consegna quellacuriosa esuberanza di elementi paratestuali che spesso provoca nellettore un deciso sentimento di perplessità7, in Daghela avanti unpasso! troviamo un testo a metà tra i due. Anche in esso, infatti, ladinamica traduttoria è fortemente presente: a una fluida esposizionedi eventi storici, riguardanti per l’appunto il nostro Risorgimento, siaffiancano riflessioni personali e storiografiche che riportano so-vente la Storia (con l’iniziale maiuscola) sul piano di una storia co-mune di uomini comuni, con una conseguente neutralizzazione dellecronotopie in gioco. Altresì si assiste a una insolita commistione,giustificata dall’intento pedagogico del testo, di ampi e puntuali re-soconti corredati da un apparato iconografico di indubbia attrattiva.Con assoluta coerenza, le illustrazioni presenti nel testo originariodel 1969 mantengono lo stesso registro diafasico sostenuto dal lin-guaggio del testo stesso: un’apparente informalità della narrazionecela la dotta conoscenza dei fatti, e la preferenza data alla caricaturae al bozzetto (rispetto per esempio al dipinto o alla rappresentazioneautoriale di eventi risorgimentali) rende conto della scelta tipologicaeffettuata da Bianciardi. Non erudita descrizione di episodi della no-stra Storia, bensì racconto degli uomini che la fecero:
[…] Carlo Cattaneo si sbagliava. O meglio: fu vero, come poi si vide,che i ragazzi presero il sopravvento, e che le cinque famose giornate mi-lanesi, se le guardiamo con l’occhio razionale del senso comune, furonouna gloriosa ‘ragazzata’. Cattaneo sbagliava quando diceva che gli uo-mini, i grandi, in questi casi debbono andarsene a casa. Tutte le rivolu-zioni del mondo non prenderebbero mai l’avvio se i primi a muoversinon fossero i ragazzi. Sta agli uomini andargli dietro, poi. Furono ra-gazzi, nel 1917, le prime vittime della fucileria zarista: furono ragazzi,
52
BIANCIARDI, OTTOCENTO COME NOVECENTO
scugnizzi, quelli che nel ’43 diedero l’avvio alla cacciata dei tedeschi daNapoli; e sempre ragazzi, anzi monellacci, quelli che nel ‘56 a Buda-pest si avventarono con in mano una bottiglia di benzina contro i carriarmati sovietici. Allo stesso modo fu numerosa, a volte determinante, lapartecipazione dei ragazzi alla battaglia delle Cinque Giornate. Sentia-mocela raccontare da uno di questi, che poi da grande la volle ricordaree la scrisse. Aveva sedici anni, era di famiglia nobile e si chiamava Gio-vanni Visconti Venosta.8
Il riferimento specifico al “piccolo rivoluzionario”9 rimanda di-rettamente alla narrazione di Aprire il fuoco, laddove proprio le me-morie del Visconti Venosta (Ricordi di gioventù. Cose vedute osapute. 1847-1860, Milano, Cogliati, 1904), fungono da sottotestoall’intero romanzo. Le stesse riflessioni sull’elemento di ‘umanità’,di caratterizzazione dal basso dell’epica risorgimentale, ricorrononegli altri due scritti di stampo storiografico. Ciò che cambia stanella prospettiva della narrazione, che da una visione d’insieme dellaSpedizione dei Mille in Da Quarto a Torino, varia in quella di tipomonografico di Garibaldi, e infine in quella decisamente polifonicadi Daghela avanti un passo!. Dei tre scritti, fra l’altro, l’ultimo sidistingue per un ulteriore elemento di coralità, di convergenza divoci e di raffigurazioni, che lo avvicinano, una volta ancora, allacomposita struttura evidenziata anche in Viaggio in Barberia10.
Per quanto concerne gli aspetti intrinseci di Daghela avanti unpasso! che accomunano diacronicamente tale opera alle altre dellostesso genere, e sincronicamente ad altre ad essa coeve, vale lapena avanzare un’altra considerazione: al di là di quel che è statofinora osservato (soprattutto a riguardo di dinamiche intralingui-stiche e ipertestuali degli ultimi scritti bianciardiani), per unaesaustiva analisi degli elementi pre-testuali che compongono latrama della terza opera di carattere storiografico, non si può pre-scindere dai seguenti dati:
a. Bianciardi era, e lo fu fino alla fine, un infaticabile traduttore.Dalla strenua attività di traduzione che svolse in gran misura dal-l’inglese, egli sviluppò un approccio, che potremmo definire ditipo ‘traduttorio’, alla stesura di opere create di prima mano. Se cisi affida a tale tesi, si può facilmente spiegare la grande capacità,
53
CONVEGNO
potenziata nel corso degli anni (dal suo primo romanzo Il lavoroculturale [Feltrinelli, 1957] fino ad Aprire il fuoco), di riuscire aformulare un linguaggio che oltrepassasse qualsiasi barriera di stilee di genere. Soprattutto si può comprendere meglio il meccanismodi ‘distanziazione’ che caratterizza il traduttore (in rapporto al-l’autore da tradurre) e lo pone in stretta relazione all’approccioadottato dallo storico, nel momento in cui questi si proietta in unpassato che non gli appartiene11, e che anzi recupera e ricostruiscegrazie alle voci e testimonianze di chi lo ha vissuto direttamente;
b. come già menzionato, Bianciardi scriveva di storia partendodal ‘basso’, ossia dal riesame delle vicende risorgimentali attra-verso la conoscenza delle singole vite degli eroi ‘quotidiani’ che ef-fettivamente resero il Risorgimento un periodo di episodi mai statiprima più “festosi, concitati, coloriti, persino un poco matti”12. Laconoscenza di questi uomini, però, nonostante il tono scanzonatocon cui venivano ritratti, era puntuale, precisa, da intellettuale pie-namente in possesso di tutti i dati necessari per esporre con stra-ordinaria dovizia di particolari le piccole grandi gesta checonsegnarono tali uomini alla Storia. Un siffatto rigore, che nontraspare dal registro linguistico volutamente ‘disimpegnato’, è in-vece palese attraverso il serissimo e costante interesse nella storiadel nostro paese – interesse che non fu mai né improvviso né tantomeno improvvisato (come magari immaginarono i numerosi lettoride La vita agra – gli stessi detrattori poi de La battaglia soda), ac-compagnando anzi lo scrittore durante tutto il corso della sua esi-stenza.
Tali dati, se rapportati a quanto è stato sottolineato per Daghelaavanti un passo!, avvalorano la convinzione, oggi largamente con-divisa, che nell’interpretazione degli scritti bianciardiani non siamai possibile scindere la stesura di un’opera da quella di un’altra,e che anzi spesso eventuali elementi estrinsecamente compositividi queste non appaiono tanto evidenti a una prima analisi se non at-traverso l’individuazione di alcuni exemplum significativi, comela quasi parallela traduzione di John Barleycorn di Jack London,e la presentazione a L’opera completa di Fattori (per i “Classicidell’arte” stampati dalla Rizzoli), entrambi pubblicati nel 1970.
54
BIANCIARDI, OTTOCENTO COME NOVECENTO
Da Jack London a Luciano BianciardiUna storia e una canzone
Parafrasando il titolo di un saggio recentemente dato alle stampeda Luciana Bianciardi13, e che raccoglie quattro articoli di argo-mento letterario scritti dal padre della curatrice, si può tracciare unpercorso artistico e biografico ben definito che collega la storia,anzi, le storie di John Barleycorn e di Daghela avanti un passo!.
Il primo è un testo che fu per la prima volta pubblicato da Jack[John Griffith] London (San Francisco 1876 – Glen Ellen 1916)per conto della Century nel 1913, soli tre anni prima della mortedell’autore. Le due opere dunque posseggono il comune dato ana-grafico che entrambe furono date alle stampe alla fine della vitadei rispettivi scrittori, e condividono la genesi del loro titolo: JohnBarleycorn trasse ispirazione da una ballata popolare che citava ilnome di Barleycorn come personificazione del whisky14, mentreDaghela avanti un passo!
è ricavato dai versi di una canzoncina, uscita a Milano nel 1859, chepur senza vincere alcun festival ebbe un successo enorme. La canzonesi chiamava ‘La Bella Gigogin’, era molto graziosa, fresca. La canzonenon aveva alcun significato politico, eppure i milanesi vollero avvertirein quel ‘daghela avanti un passo’ del ritornello una specie di invito amarciare, a muoversi, ad andare avanti. […] La intonarono i Cacciatoridelle Alpi nelle battaglie del ’59, la ripresero i garibaldini durante la spe-dizione in Sicilia. Anzi, fu proprio questo l’inno –ufficioso– dei Mille.15
Indubbiamente il ricorso alla ballata popolare e alla canzone ri-sorgimentale tradiscono l’intenzione di ricorrere a una narrazionedal tono volutamente colloquiale, dal registro linguistico ricco diespressioni gergali e di enunciati che, sia nel caso del racconto au-tobiografico di London, sia nel saggio storiografico di Bianciardi, sirivolgono in modo evidente all’ordinary man o al giovane scolarocurioso di conoscere la storia del proprio paese. In tal senso entrambigli autori palesano un atteggiamento fuori dal coro, dalla concla-mata intellighenzia e dalla retorica della cultura di appartenenza: sipensi ad esempio al consenso altalenante riscosso dal successo delleopere di London16, e all’altrettanto incostante approvazione e stima
55
CONVEGNO
ricevuta dai critici contemporanei di Bianciardi. Nel caso di questiultimi, tra l’altro, va ribadito l’ampio riconoscimento accordato a Lavita agra, così come il dissenso mostrato all’uscita dei romanzi sto-rici del ’64 e del ’69. Il Bianciardi scanzonato e maudit de La vitaagra infatti mal si confaceva con l’autore colto, se pur ugualmenteironico, de La battaglia soda. Anzi, la stampa del secondo testo fuinterpretata come un’improvvisa e imprevista inversione di tendenzastilistica, un segno di “caduta della vitalità”17 emersa invece con lastesura della riconosciuta autobiografia en travesti (i suoi primi treromanzi). Nello specifico, il 1964, anno del trasferimento dello scrit-tore toscano da Milano a Rapallo, fu ravvisato come l’inizio di uninesorabile periodo di decadenza e di frantumazione delle istanzeoriginarie, per cui “l’accoglienza del nuovo romanzo è assai menocalorosa, e la fase eccitata ed effervescente del successo de La vitaagra è comunque finita”18. Secondo Ferretti, quindi, il 1964 corri-sponde anche al momento in cui prendono forza “tutti i motivi didebolezza, passività, cedimento, e in generale tutte le ragioni del di-sagio, intollerabilità, invivibilità di Milano”19; e se allunghiamo losguardo al 1969, troviamo un atteggiamento critico nei confronti diBianciardi ancora più esasperato. La storia dell’autore, la sua storiapersonale, viene incorporata nella Storia di formazione del modernostato italiano, creando un impasto che allora fu decisamente respinto,e che oggi invece viene rivalutato secondo parametri oggettivamentepiù scevri dai condizionamenti politico-culturali dell’epoca.
Dinamiche tali (l’atteggiamento dello scrittore e quello dei suoicritici più severi) conducono attualmente alla necessità di una ri-lettura dell’opera di narrativa di carattere storico dell’autore Bian-ciardi, così come a una analisi più rigorosa delle sue opere dinatura storiografica. In effetti le vicende personali, o meglio, lemotivazioni profonde che spingevano Bianciardi a raccontare laStoria –secondo il suo stile e le sue modalità– emergono anchedal parallelo approccio alla traduzione di testi come John Barley-corn, per l’appunto, di cui, come già rilevato, condivideva sceltestilistiche e sollecitazioni fortemente autobiografiche.
Il testo, come già accennato, gli fu commissionato dalla casaeditrice Bietti, e il lavoro di traduttore svolto da Bianciardi non silimitò all’accumulo di “carte su carte di ribaltatura”, ma siespresse in un’opera che lo coinvolse anche nel suo statuto di in-
56
BIANCIARDI, OTTOCENTO COME NOVECENTO
tellettuale20, come testimoniato anche dalla pregevole consegnadel testo in lingua italiana. Ciò risulta evidente già dall’incipit delromanzo21, la cui versione originale confrontiamo con quella con-segnata in italiano:
JACK LONDONIt all came to me one election day. It was on a warm Californiaafternoon, and I had ridden down into the Valley of the Moon fromthe ranch to the little village to vote Yes and No to a host of pro-posed amendments to the Constitution of the State of California.Because of the warmth of the day I had had several drinks beforecasting my ballot, and diverse drinks after casting it. Then I hadridden up through the vine-clad hills and rolling pastures of theranch, and arrived at the farm-house in time for another drink andsupper.
“How did you vote on the suffrage amendment?” Charmian asked.“I voted for it.”
She uttered an exclamation of surprise. For, be it known, in myyounger days, despite my ardent democracy, I had been opposedto woman suffrage. In my later and more tolerant years I had beenunenthusiastic in my acceptance of it as an inevitable social phe-nomenon22.
LUCIANO BIANCIARDIMi successe tutto un giorno di elezioni. Era un caldo pomeriggiocaliforniano, e a cavallo io avevo traversato la Valle della Luna perandare dalla fattoria al piccolo villaggio a votare Sì oppure No a unsacco di emendamenti proposti alla Costituzione della California.Data la calura della giornata, mi feci diverse bevute prima di dareil mio voto e diverse altre dopo aver votato.
Poi, sempre a cavallo avevo ripreso la mia strada attraverso i vi-gneti e i pascoli della fattoria arrivando a casa giusto in tempo perbere ancora e cenare.
“Come hai votato sull’emendamento al suffragio?” chiese Charmian.
57
CONVEGNO
“Ho votato a favore”.
Fece un’esclamazione di sorpresa. Infatti, sia ben noto, ai mieiverdi anni, nonostante la mia fervida democrazia, mi ero oppostoal voto alle donne. Quando gli anni mi crebbero e si fecero piùtolleranti, la mia accettazione ebbe meno entusiasmo, come di-nanzi a un fenomeno sociale inevitabile23.
L’ambientazione storica fornita da London offre una corniceappena visibile nel racconto: seguiranno infatti ben poche infor-mazioni relative al periodo in cui si svolgono i fatti, narrati da unio che non renderà mai noto il proprio nome. Vengono invece se-gnalate dettagliatamente tutte le annotazioni riguardanti le disav-venture, le vicende socio-politiche, e le trasformazioni dei costumidegli anni cui si riferisce l’autore, che induce il lettore a una vi-sione introspettiva degli eventi, come fossero seguiti dalla pro-spettiva privilegiata di un voyeur d’interni. Mai un discorsooggettivo, bensì un susseguirsi di pensieri, riflessioni e resocontiche hanno come protagonista effettivo Barleycorn, ossia l’alcol. Èquesto un altro elemento che accomuna sul piano personale la sto-ria di London con quella di Bianciardi: entrambi chiusero la pro-pria esistenza nell’autodistruzione, nell’alcol, come testimoniatoanche da alcuni brevi riferimenti in Aprire il fuoco. Verso la con-clusione del romanzo, infatti, dopo un dialogo serrato con la “pa-drona di casa”, il protagonista dichiara: “[...] io me ne vado a fareil riposino, con il grappino sul comodino”24: l’alcol ritorna spessoall’interno del testo, così come avvenne nell’ultimo, sfortunato,periodo della vita dello scrittore. A tale proposito, vale la pena ri-portare la preziosa ricostruzione ad opera di Alvaro Bertani25 del-l’ultimo periodo vissuto dallo scrittore toscano, quando
a Rapallo, pur circondato dai fantasmi del passato e del presente, sof-focato dai rimorsi e abbattuto dai sensi di colpa, Bianciardi non scorda illavoro di ‘ribaltatura’. Mette mano a un altro volume, l’VIII, della Storiadel mondo di Duchè, per Del Duca, e traduce Travels with Charley di JohnSteinbeck che esce con il titolo Viaggio con Charley per Rizzoli, nella col-lana Romanzi Italiani e Stranieri. Non per combattere, ma solo per so-pravvivere, mentre lavora, beve, mentre pensa, beve, mentre lascia che il
58
BIANCIARDI, OTTOCENTO COME NOVECENTO
tempo gli trascorra addosso, beve. Troppo, come rammenta e confermaMario Acquarone quando va a trovarlo a Rapallo. Troppo, come sostieneanche Furio Cavallini, l’amico pittore. Luciano beve per trovare un po’ dipace con se stesso, ma il suo tormento non può essere cancellato dall’al-col, la consapevolezza d’aver perduto le sue radici, di non riconoscere ad-dirittura come sua la sua città sono sensazioni talmente forti che nessunagrappa, nessun whisky può tenere lontano26.
Per tornare all’incipit del romanzo dell’autore americano, ci sonoda sottolineare un paio di passaggi che rendono conto delle sceltetraduttive operate dall’autore toscano: innanzitutto la soluzione dioptare per una maggiore letterarietà delle espressioni utilizzate daLondon. “A cavallo io avevo traversato” (con il sintagma verbale inposizione cataforica) invece di un più anodino ‘avevo cavalcato giù’per l’enunciato “I had ridden down”. Stessa letterarietà nella sceltadi “miei verdi anni” per “my younger years”, e soprattutto il pe-riodo “Quando gli anni mi crebbero e si fecero più tolleranti, la miaaccettazione ebbe meno entusiasmo, come dinanzi a un fenomenosociale inevitabile”, che risulta obiettivamente una splendida riela-borazione di “In my later and more tolerant years I had been unen-thusiastic in my acceptance of it as an inevitable socialphenomenon” - periodo che si sarebbe potuto rendere, più letteral-mente, come ‘Durante i più indulgenti anni che seguirono, persi ilmio entusiasmo nell’accettazione di esso [il suffragio per il votoalle donne] come di un inevitabile fenomeno sociale’. Ciò denotaquindi l’atteggiamento, alquanto costante nell’attività di traduzionesvolta da Bianciardi, di rendere con un italiano esteticamente più ri-cercato espressioni che invece in inglese risultano decisamente piùneutrali27. Da evidenziare inoltre la soluzione optata per “ranch”,che il traduttore ha qui reso con il parallelo italiano “fattoria”, lad-dove avrebbe potuto lasciare la parola inglese in originale, conse-gnando al lettore segni distintivi dell’ambientazione del romanzo.L’atteggiamento fortemente ‘addomesticante’28 assunto da Bian-ciardi testimonia l’approccio fagocitante che egli aveva nei con-fronti dei testi da tradurre: come ricordato da Maria Jatosti,
Luciano aveva una personalità forte. Lui era lui. Anche gli autori ori-ginari alla fine diventavano lui, non succedeva mai il contrario. La simbiosi
59
CONVEGNO
è avvenuta solo nel caso clamoroso di Miller. Ma per il resto, lui ci met-teva di suo. Alienato sì, esule, ma nel senso […] di dover uscire da sé perentrare in un’altra situazione, un’altra lingua, un’altra cultura, un altromodo di esprimersi, di vedere le cose, e rientrare, recuperarsi integro, conuno sforzo continuo che alla fine lo logorava. Terminate le otto ore quoti-diane – quattro al mattino, quattro al pomeriggio – era imbambolato, quasisvuotato. In realtà non staccava mai. Continuava a rimuginare su una pa-rola, una soluzione che non l’aveva convinto... Era sempre con la testa sullavoro, sempre, anche quando aveva smesso non finiva mai29.
Indubbiamente le scelte operative attuate dal traduttore Bian-ciardi erano ponderate, tese a una ‘familiarizzazione’ dei concetti,che, se pur espressi attraverso la consegna non sempre fedele dei re-lativi enunciati, risultano limpidi nello stile e fluidi nella scorrevo-lezza della narrazione. Tutto ciò a vantaggio di una letteraturaspesso offerta al lettore in forma esteticamente più raffinata diquanto non fosse per mano diretta del rispettivo autore. Le even-tuali ‘mancanze’, omissioni di termini invece presenti nella ver-sione originale, vanno interpretate via via o come banali distrazioni,o come scelta di rendere il testo maggiormente fruibile, come nelcaso di “Constitution of the State of California”, tradotto sempli-cemente come “Costituzione della California”. Vi sono comunquealtri lapsus rilevabili nella traduzione, come emerge dal brano chesegue:
JACK LONDONThe jute mills failed of its agreement to increase my pay to a dollarand a quarter a day, and I, a free-born American boy whose direct an-cestors had fought in all the wars from the old pre-Revolutionary In-dian wars down, exercised my sovereign right of free contract byquitting the job.
I was still resolved to settle down, and I looked about me. Onething was clear. Unskilled labour didn’t pay. I must learn a trade,and I decided on electricity. […] I was a practical man in a prac-tical world. Also, I still believed in the old myths which were theheritage of the American boy when I was a boy. (Chapter XX)
60
BIANCIARDI, OTTOCENTO COME NOVECENTO
LUCIANO BIANCIARDILa fabbrica di juta non rispettò l’accordo di aumentarmi la paga aun dollaro e un quarto, e io, ragazzo americano, nato libero, i cui di-retti antenati avevano combattuto in tutte le guerre, dalle vecchiebattaglie contro gli indiani, prima della rivoluzione, in poi, eserci-tai il mio diritto di libero contraente abbandonando il posto.
Ero ancor deciso a trovarmi un posto stabile e per questo mi guar-dai intorno. Il lavoro non specializzato non rendeva. Dovevo im-parare un mestiere, e mi decisi per l’elettricità. [...] Ero un uomopratico, in un mondo pratico. Inoltre credevo ancora nei vecchimiti che erano l’eredità del ragazzo americano, quando ero ra-gazzo. (p.103)
Il testo selezionato è interessante soprattutto perché offre l’op-portunità di chiarire l’atteggiamento di Bianciardi nei confrontidel romanzo: vengono infatti operate delle dislocazioni sintattichemirate a porre in evidenza il côté personale, intimo, del racconto,piuttosto che quello sociale e cronachistico fornito da London.Con tale motivazione, quindi, si può spiegare la resa di “a dollarand a quarter a day” con un sintetizzato “un dollaro un quarto”,omettendo la traduzione di ‘al giorno’ che avrebbe restituito lascansione spazio-temporale con cui il protagonista riceve la paga,appunto, giornaliera. La quale paga, inoltre, lo induce poi ad ap-pellarsi al diritto “sovereign” (sovrano) di assumere il ruolo di li-bero “contraente” (ottima la scelta del lemma da parte diBianciardi) e quindi di cercare sempre un nuovo impiego. Cu-riosa, in tale senso, la traduzione di “I was still resolved to settledown, and I looked about me. One thing was clear“ con “Eroancor deciso a trovarmi un posto stabile e per questo mi guardaiintorno”, in cui non soltanto viene ignorato un intero periodo(“One thing was clear”, ossia ‘una cosa mi era chiara‘), ma la de-cisione che il narratore fosse alla costante ricerca di un lavoroviene presentata, marcatamente, come una diretta conseguenzadel fatto che egli fosse un libero contraente e dunque un individuopienamente in possesso della facoltà di decidere della propria vita.Tale convinzione è suffragata dalla scelta di tradurre il paragrafoappena precedente (che in qualche modo funge da premessa a ciò
61
CONVEGNO
che segue) “I, a free-born American boy whose direct ancestorshad fought in all the wars” in “io, ragazzo americano, nato libero,i cui diretti antenati avevano combattuto in tutte le guerre”, doveun neutrale “free-born” viene staccato dal suo sintagma, posto inposizione incidentale, e quindi messo in evidenza in modo daemergere nella sua piena accezione semantica.
Un’ultima considerazione va annotata a margine di uno degliultimi passaggi del romanzo: siamo all’inizio del capitolo XXVII(i capitoli sono trentanove), ormai il protagonista comincia a ot-tenere successo come scrittore, e fra le sue pagine possiamo ri-trovare parole già incontrate ne La vita agra di Bianciardi:
JACK LONDONAs I succeeded with my writing, my standard of living rose and myhorizon broadened. I confined myself to writing and typing a thou-sand words a day, including Sundays and holidays; and I still stud-ied hard, but not so hard as formerly. I allowed myself five andone-half hours of actual sleep. I added this half-hour because I wascompelled. [...] There were tired nights, bodily, when I slept sixhours; and on occasion of very severe exercise I actually slept sevenhours. But such sleep orgies were not frequent. There was so muchto learn, so much to be done, that I felt wicked when I slept sevenhours. And I blessed the man who invented alarm clocks. (Chapter XXVII)
LUCIANO BIANCIARDICon il successo delle cose che scrivevo, migliorò il mio livello divita e mi si allargò l’orizzonte. Mi limitavo a scrivere e poi a bat-tere a macchina un migliaio di parole al giorno, comprese le do-meniche e le altre feste; e continuavo a studiare sodo, ma noncome prima. Mi permettevo cinque ore e mezzo di sonno effet-tivo. Questa mezz’ora in più me la permisi perché ci fui costretto.[...] In certe notti di stanchezza corporea io dormivo anche sei ore;e in qualche raro caso di moto assai intenso, arrivai alle sette ore.Ma non erano frequenti simili orge di sonno. C’erano tante cose daimparare, tante cose da fare, che mi sentivo in colpa a dormiresette ore. E benedivo l’inventore delle sveglie. (p. 128, passim)
62
BIANCIARDI, OTTOCENTO COME NOVECENTO
Ciò che colpisce il lettore è che, malgrado affinità evidenti tra ilromanzo di London e quello di Bianciardi, qui lo scrittore toscanonon è stato completamente fedele alla versione originale, e ha op-tato per delle evidenti forzature, segni inequivocabili dell’approc-cio all’espressione di tematiche comuni: “I confined myself”pertanto diventa “Mi limitavo” e certamente non si tratta di una tra-duzione errata, purtuttavia non risulta pienamente soddisfacente.Bianciardi avrebbe potuto rendere l’enunciato con un più letterale‘mi rinchiusi a scrivere’ o addirittura ‘mi confinai a scrivere’, il cheavrebbe tra l’altro corrisposto alla parallela condizione che vivevalo scrittore toscano proprio negli ultimi anni di vita, contempora-neamente alla stesura del testo di London30. Traducendo invece “milimitavo a scrivere” consegna l’immagine di un protagonista che‘si limita’, ossia viene meno a un’istanza superiore, a una sorta dirichiesta dall’alto (che potremmo definire etica) – laddove la vi-sione proposta dall’autore scozzese era, ancora una volta, di di-mensione spazio-temporale, nella riduzione dei confini territoriali(per i quali l’accezione territoriale può anche essere concepita intermini introspettivi) in cui egli esercitava la sua attività. Tale in-terpretazione viene corroborata dalla curiosa resa di “ I felt wickedwhen I slept seven hours” con “mi sentivo in colpa a dormire setteore”, in cui l’aggettivo “wicked” corrisponde a ‘sciagurato’, nel si-gnificato che può essere attribuito a colui che sa di sprecare sven-turatamente preziose ore di lavoro. La consegna di Bianciardi, chetraduce “mi sentivo in colpa”, disvela una precisa interpretazionedel momento del sonno, avvertito non come momento di rilassa-mento e di stacco dalla veglia, ma come rinuncia (deprecabile) allanecessità ‘superiore’ cui abbiamo accennato – una necessità eticache di fatto induce lo scrittore a mantenere una tabella di marcia(le sei ore giornaliere di London, le otto di Bianciardi) inderogabilee insopprimibile. Il traduttore, pertanto, sottraendosi al lavoro quo-tidiano, ‘si sente in colpa’, e ciò richiama direttamente le numerosetestimonianze che sono state lasciate da coloro che sono stati alfianco di Bianciardi nell’ultima fase della sua esistenza.
Da tali considerazioni possiamo giungere alla conclusione che,rispetto alla quasi contemporanea stesura di Daghela avanti unpasso!, la traduzione del testo di John Barleycorn conferma l’ap-
63
CONVEGNO
proccio adottato dallo scrittore toscano rispetto al tema della sto-ria, intesa sia come Storia di una nazione (l’Italia) sia come sto-ria di un uomo (London): in entrambi i casi gli eventi documentarivengono sopraffatti dagli accadimenti privati, per cui se nel vo-lume storiografico il Risorgimento viene narrato come sostanzialesuccessione di fatti relativi a singoli individui, nel romanzo auto-biografico di London le vicende personali del protagonista sonospogliate di qualsiasi sovrastruttura sociale (nonostante il testo siafortemente connotativo della realtà americana di inizio ’900), eogni riferimento a circostanze analogamente vissute dal tradut-tore viene interpretato in termini soggettivi, con marcatura diespressioni che sono quindi rese in modo ‘addomesticato’, deci-samente proprio. Ciò rende testimonianza dell’appropriazione deltesto che, pur non manifestando il medesimo, felice rapporto sim-biotico che Bianciardi stabilì con le opere di Miller, comunquepalesa la visione dell’autore maremmano, la sua cifra stilistica, eil suo particolare modo di intendere la propria storia e la storiadel mondo.
Il poeta della fatica31 umana.Giovanni Fattori interpretato da Bianciardi
Luciano Bianciardi si occupò della presentazione dell’operadi Giovanni Fattori nel 1970, in occasione della collana “Classicidell’Arte” (n. 42) curata da Bruno della Chiesa per la Rizzoli.Non si tratta dell’unico contributo fornito da Bianciardi in campoartistico: aveva già infatti collaborato con la Raccolta del“Drago”, un’antologia di 14 brani letterari corredata di apparatolitografico (Milano, 1963), così come a un’esposizione di FurioCavallini (Forte dei Marmi, Libreria Internazionale, 25 luglio-7agosto 1966; e Suzzara, Galleria Ristorante Ferrari, 21 marzo-3aprile 1970), di Ettore Sardo (Rapallo, Galleria “Motivi d’arte”,1-20 marzo 1969) e di Luigi Grande e Ugo Sanguineti (Chiavari,Bottega d’arte Giardino, 14-29 giugno 1969; e Chiavari, Galle-ria d’arte Contemporanea Sabbadini, 1970)32.
Ma l’introduzione all’opera di Fattori (Livorno, 1825 – Fi-renze 1908) assume un significato del tutto singolare, in quantoappare come recupero di quel distintivo senso della storia in-
64
BIANCIARDI, OTTOCENTO COME NOVECENTO
tesa da Bianciardi che le illustrazioni inserite nel testo origina-rio di Daghela avanti un passo! trasmettono solo in parte. Laparticolare sintonia, che lo scrittore toscano esplicitò nei con-fronti del corregionale Fattori, fornì al Nostro la possibilità dicompletare la visione che egli aveva del Risorgimento – periodoche, nell’edizione del testo storiografico bianciardiano del 1969,è commentato da riproduzioni di litografie, schizzi, disegni,spesso caricature non autografe, per cui gli autori rimangonoanonimi e raccolti sotto il nome di “Foto Alinari”, “Museo delRisorgimento”, e soprattutto di “Stampa popolare”. È pertantoun commento iconografico che sottolinea il tono leggero, scan-zonato, ‘basso’ della narrazione storica, e ciò che emerge è ilritratto di uomini spesso caricaturizzati, eroi ridotti a bozzetti,come nel Disegno satirico allusivo al violento discorso di Ga-ribaldi in Parlamento il 18 aprile 186133, in cui Garibaldi è raf-figurato satiricamente durante un discorso tenuto in Parlamentoil 18 aprile 1861.
Si tratta di una visione della Storia raccontata dalle sue frangeplebee, dai suoi eroi svestiti degli abiti altisonanti dati dai loronomi. Il tono è sarcastico, dissacratorio, laddove invece, nei di-pinti di Fattori, la Storia riacquista tutta la sua drammaticità, e re-indossa quella foggia tragica che le è propria. Rimane una storiadi uomini: stavolta però essi sono individui semplici, contadinidisperati, che vengono ritratti nei momenti più banali e allo stessotempo nefasti della loro esistenza. Ne è chiaro esempio il quadrointitolato Assalto alla Madonna della Scoperta, posto in rela-zione e a confronto con Il Quadrato di Villafranca34.
La comparazione tra i due dipinti serve a Bianciardi a sempli-ficare il diverso atteggiamento che sovente si palesa nei confrontidella Storia:
Fattori fu un uomo troppo schietto per non avvertire subito che labella avventura aveva fatto l’Italia unita, ma non di certo fiera e lieta. Seripensò al Risorgimento (ci ripensò forse per tutta la vita), stavolta fucon animo deluso e sconsolato. Se l’Assalto alla Madonna della Sco-perta serba qualche filo retorico, qualche squillo di tromba in più, il qua-dro di Villafranca dice chiaro quanto sia diverso stavolta Fattori. […] Siintende subito che gli entusiasmi del Cinquantanove sono andati delusi,
65
CONVEGNO
che stavolta la battaglia è un doloroso fatto di sangue, che i fantaccini del49° sono contadini e artigiani, con quelle facce popolane che ostentano.Uno è stramazzato al suolo, né di lui si cura l’ufficiale al pezzo, il qualeordina il fuoco abbassando la sua sciabola così elegante. Gli artigliericon la borsa a tracolla riportano il cannone in batteria, sulle grandi ruotedi legno, e hanno gesti che paiono di falegnami, o di muratori, esperti dasempre a usare la livella35.
Da tale passaggio si comprende come, grazie al rapporto sim-biotico che Bianciardi riuscì a stabilire con l’opera di Fattori, eglifu capace di sottolineare il valore dell’arte del pittore, prima rea-lista poi macchiaiolo e tra i principali precursori dell’Impressio-nismo italiano. Un rapporto de facto fondato su una comuneorigine maremmana (se pur appartenenti a poli diversi della Ma-remma: quella settentrionale nel caso di Fattori, centrale nel casodi Bianciardi), su una comune visione del Risorgimento, e di con-seguenza sulla medesima attenzione alle sofferenze del popolo,inquadrato nel ridimensionamento della retorica tipica di una certaStoria. Lo scrittore infatti nota come, nei dipinti del conterraneo,
sono tutti di spalle: i soldati francesi del Cinquantanove, coi loro zainiaffardellati e gli alti chepì, gli italiani al campo dopo la battaglia di Ma-genta, […] Sono visti di spalle i garibaldini di Capua, son viste di spalle levedette dei cavalleggeri in avanscoperta, e tutto quanto l’assalto alla Ma-donna della Scoperta è visto da dietro.
E questo perché Fattori entra nella battaglia con umiltà, come uomodi retrovia. […] Il fatto eroico pare che proprio non gli interessi, gli bastaraccontare la fatica, l’ansia, il sudore, la paura, tutto ciò che si coglie seal fronte si arriva da dietro. I suoi soldati non sono più dei prodi, no,sono faticatori, contadini, artigiani, analfabeti, gente che ci lascia la pellee già sconta il sacrificio della vita con una vita stentata e agra.36
Il ricorso all’aggettivo ‘agro’, che nel testo compare ben trevolte37, non è casuale, e Bianciardi lo spiega asserendo che “si dicecosì perche questa è una parola che piacque tanto a Fattori, e difattice la ripete abbastanza spesso, nei suoi scritti autobiografici e nellesue lettere. Poi naturalmente vien fuori qualche contemporaneo chese l’appropria per farci bella figura”38: l’autocitazione è ovvia, e
66
BIANCIARDI, OTTOCENTO COME NOVECENTO
l’ironico ammiccamento al “contemporaneo” che si appropria diun aggettivo non suo testimonia il tentativo di non volersi prenderetroppo sul serio, di sminuire, lui per primo, quel solido atteggia-mento di deferenza e rigore nel trattare temi ‘alti’. Insinua qualcheinterrogativo, pertanto, la riflessione che ‘agro’ sia ricorrente negliscritti di Fattori: il che lascerebbe supporre che Bianciardi, autoredella presentazione all’opera del pittore nel 1970, ma già autore deLa vita agra nel 1962, fosse un profondo e ‘antico’ conoscitore dellafigura e delle opere (letterarie) di Fattori, tanto da sottrarre una pa-rola ben frequente nelle lettere di quest’ultimo.
Tale considerazione, di conseguenza, riporta in superficie l’ele-mento che unisce l’intera produzione bianciardiana: un sottile filoautoreferenziale che funge da collante tra i romanzi autobiografici,quelli storici, i racconti, i saggi storiografici, gli articoli giornalistici,tutti confluiscono in un serbatoio comune, una sorta di vivaio in cuinascono e si sviluppano pensieri che si ritrovano in opere succes-sive, attraverso rielaborazioni di concetti già espressi, che a loro voltasi rincorrono via via autocitandosi, con tono beffardo e con un lieveriso di scherno. Descrivere la figura di Fattori, allora, implica de-scrivere se stesso, la propria storia e i paesaggi cari all’infanzia:
Si veda il Riposo dell’Ottantasette. Lontano, ecco l’azzurro della ma-rina, le arse stoppie sabbiose della spiaggia maremmana, il carro rosso(quel rosso non aveva intenzioni cromatiche, nel lavoro del carraio, erapuro e semplice minio per difendere il legno dalla corrosione). Si è toltoil giogo ai buoi, il timone è alto. Le bestie allungano il collo e paiono re-spirare meglio, l’uomo sta seduto a terra, stavolta alla loro ombra, lemani sulle cosce. Si stanno riposando in tre, ed il riposo è comune, comecomune è stato il travaglio. Non si vedono gli occhi dell’uomo, ma sivede l’occhio del primo bue: rassegnato e grato di questo riposo.39
Il paesaggio della maremma viene richiamato, quasi inaspetta-tamente, anche nelle numerose traduzioni cui Bianciardi lavorònegli ultimi anni, come ad esempio in Il segno rosso del coraggio(The Red Badge of the Courage – An Episode of the American CivilWar, 1895) di Stephen Crane, romanzo che Bianciardi tradusse perle Edizioni del Velaccio nel 1964 (stesso anno dell’uscita de La bat-taglia soda), e che più di altri evidenzia la cifra del traduttore im-
67
CONVEGNO
merso nel cuore della storia40. Da un passaggio significativo deltesto, infatti, “the retiring fogs revealed an army stretched out on thehills, resting”41 diventa “le nebbie ritirandosi svelarono un esercitodisteso sulle colline, a riposo”42, e, in particolare,
As the landscape changed from brown to green, the army awakened,and began to tremble with eagerness at the noise of rumors. […] A river,amber-tinted in the shadow of its bands, purled at the army’s feet; andat night, when the stream had become of a sorrowful blackness, onecould see across it the red, eye-like gleam of hostile camp fires set int thelow brows of distant hills43
viene consegnato dallo scrittore toscano, già edotto sulla visionerisorgimentale offerta dagli intensi dipinti di Fattori, come segue:
Col mutare del paesaggio dal bruno al verde l’esercito si svegliò ecominciò a tremare d’ansia al diffondersi delle notizie. […] Un fiume,color d’ambra all’oscuro delle sue rive, scorreva ai piedi dell’esercito; eda notte, quando la corrente era diventata d’una penosa scurezza, scor-gevi sull’altra riva il rosso, occhiuto chiarore dei fuochi da campo nemicisul basso ciglio delle colline lontane.44
Leggere la traduzione di Crane è come leggere possibili de-scrizioni di battaglie raccontate dallo stesso Bianciardi. Sotto que-sto profilo, quindi, Il segno rosso del coraggio (soprattutto neipassaggi qui selezionati) permise allo scrittore toscano di soffer-marsi maggiormente su quelle affinità e concordanze tra storiad’America e storia d’Italia, tra paesaggi craniani e paesaggi carial suo passato di lettore adolescente del Bandi. Le colline ameri-cane sono allora le stesse di Maremma, e il rosso del coraggio chefunge da simbolo al racconto di Crane è lo stesso rosso che os-serviamo nei ritratti di Fattori45.
L’uso del colore nell’artista livornese – uso che diviene semprepiù distintivo nel passaggio da un’adesione a istanze romantichefino ad altre decisamente impressionistiche – si accompagna aduna significazione precisa attribuita ai protagonisti dei dipinti,siano essi soldati, contadini e/o animali. E a proposito di questi ul-timi, Bianciardi – che, curiosamente, aveva appena lavorato alla
68
BIANCIARDI, OTTOCENTO COME NOVECENTO
traduzione di Viaggio con Charley. Per le strade d’America: Unuomo, un cane, una roulotte (Travels with Charley – In Search ofAmerica, 1962)46 di John Steinbeck – aggiunge una riflessionemolto puntuale nell’interpretazione della splendida tela intitolataLo staffato, in cui osserva, aggettivandolo come “non lieto”, che
Il cavallo ha rotto la cavezza e galoppa via come una furia, ma il ca-valiere è rimasto impigliato nella staffa, e adesso si trascina lugubre-mente per terra, e forse è già morto. È un quadro molto insolito nellasterminata produzione di Giovanni Fattori (più di mille opere, di cui nonsi ha ancora un catalogo completo e ben ordinato).47
Con grande acume, lo scrittore rileva la prospettiva che il pit-tore ha adottato nella raffigurazione, spostando il punto di vistadal cavaliere, esangue, ormai un corpo senza vita, all’energiaesuberante, dirompente del cavallo, che ora esprime in pieno l‘ir-ruenza delle forze della natura. Bianciardi, inoltre, procede os-servando come il dipinto si presenti oltremodo “insolito” nellastesura, per “quelle pennellate lunghe, che variano dal grigio alviola”, ma soprattutto perché “stavolta la bestia è sentita e rap -presentata come una forza ostile, quasi delittuosa”48.
L’impressione che si ricava dalle parole dello scrittore toscano èche, illustrando l’opera di Fattori, in realtà illustri la propria opera:sostenendo infatti che il pittore “ha veramente amato gli infelici”49,di fatto sostiene il sentimento e il punto di vista espressi negli scrittistoriografici, ossia che i miseri contadini, i muratori, i falegnamisono stati i veri protagonisti della Storia. E nel concludere la pre-sentazione ai dipinti dell’artista livornese, Bianciardi termina conuna considerazione che, in fondo, suona null’altro che una proie-zione di sé. Laddove infatti cita un pensiero dello stesso Fattori,egli sembra citare se stesso, soprattutto in una visione della propriavita a ritroso, in una retrospettiva che lui, a pochi mesi dalla morte,verosimilmente stava attuando – riandando con la memoria a Gros-seto, alla Maremma in cui forse sarebbe dovuto tornare definitiva-mente, per lasciare alle spalle Rapallo e soprattutto le fatue illusionidi Milano50. Le ultime parole dedicate a Fattori paiono allora for-temente emblematiche, e indicative di quel che forse avrebbe voluto
69
CONVEGNO
fosse detto di sé, Bianciardi, scrittore, traduttore, giornalista, sag-gista, narratore di storie risorgimentali:
ha amato i bambini e ha amato gli animali. Li amò con la pas-sione schietta di cui è capace un toscano della costa, con l’onestàche non gli diede di certo né lauti guadagni né titoli di onorificenza.‘Ho amato la gioventù, perché quella ha avuto per me l’illusionedei miei giovani anni’. Certo, l’illusione del Risorgimento, e la de-lusione che ne seguì. Fattori non emigrò a Parigi, non diventò un pit-tore alla moda, ma valse più lui da solo che qualche gruppo diimpressionisti che ai suoi tempi andarono per la maggiore e feceroil bello e il cattivo tempo. A Parigi ci andò da turista, e ne fu subitostufo. Doveva tornare alla sua Maremma. E questa ci pare la le-zione grande e umile che di lui ci deve restare51.
70
BIANCIARDI, OTTOCENTO COME NOVECENTO
1 L. Bianciardi, Daghela avanti un passo, Milano, Bietti, 1969, p. 9.2 Le opere di natura storiografica vanno distinte da quelle creative di am-
bientazione storica (La battaglia soda e Aprire il fuoco, pubblicate rispettiva-mente nel 1962 e 1969 dalla casa editrice Rizzoli). Per un’ampia trattazionedell’argomento si veda C. Varotti, Bianciardi riscrittore del Risorgimento, in Laparola e il racconto. Scritti su Luciano Bianciardi, a cura di C. Varotti, Bologna,Bonomia University Press, 2005, pp. 111-127; nonché il capitolo intitolato “Esi-lio e storia” in A. De Nicola, La fatica di un uomo solo. Sondaggi nell’opera diLuciano Bianciardi traduttore, Firenze, SEF, 2006, pp. 85-138.
3 Il libro gli fu commissionato da Feltrinelli in occasione del centenario del-l’unità d’Italia (rif. I. Gambacorti, Luciano Bianciardi. Bibliografia 1948-1998,Firenze, SEF, 2001, p. 14).
4 Si confronti la prefazione al testo a cura dell’autore stesso, il quale recita:“Diciamolo francamente: questo libro io lo scrissi per i ragazzi della scuolamedia. […] Ma il primo che lo lesse fu mio figlio Marcellino, di dieci anni,quinta elementare. Mi disse: ‘Sei più bravo di Salgari’. Dentro di me inorgogliicome un tacchino a giugno (il mese più lontano dalle feste natalizie), ma ebbianche la modestia di spiegare al bambino che il merito era tutto del Risorgi-mento, e che le storie vere son sempre più belle, più appassionanti, di quelle in-ventate. Resta il fatto che il libro, anche in questa edizione adulta, è semprededicata a lui, a Marcellino. Per edizione adulta si intende quella in cui ho rein-serito certi brevi brani che era parsi troppo crudi per dei ragazzi, ai quali comesi sa debetur maxima reverentia, ma sarà poi vero?”, in Daghela avanti un passo,cit., pp. 7-8, passim. Per quanto concerne in particolare la natura pedagogica dellibro, va sottolineato come Bianciardi fosse sempre stato vicino al mondo sco-lastico, curando delle antologie destinate alla scuola media come Azimut, Lostrale d’oro, L’avvenire e Pagine e idee, tutte ideate in collaborazione con Re-nata Luraschi (le prime due) e con Luraschi e Sergio Musitelli (le ultime due),pubblicate, per l’appunto, da Bietti, la stessa casa editrice di Daghela avanti unpasso!, nel 1969.
5 A tale proposito, si rimanda la definizione di “traduzione intralinguistica” e“traduzione intersemiotica” alla definizione fornita da Roman Jakobson nel suoSaggi di linguistica generale ([Essais de linguistique générale], traduzione a curadi Luigi Heilmann, Milano, Feltrinelli, 1966), di cui fornisce un ampio appro-fondimento Umberto Eco in Dire quasi la stessa cosa, Milano, Bompiani, 2003.
6 Da rilevare quanto l’elemento fotografico sia fortemente presente in Viag-gio in Barberia. Tale segno connota una variante all’interno del linguaggio bian-ciardiano, introducendo una tipologia comunicativa complementare e nellostesso tempo alternativa a quella verbale. Le fotografie, solo in parte concordatecon il fotografo della spedizione in Barberia, Ovidio Ricci, trovano una pienaesplicitazione espressiva nella presenza delle didascalie, autentiche trait-d’uniondell’intero volume. Per una più approfondita trattazione dell’argomento, si con-
71
CONVEGNO
fronti il capitolo “Viaggio” in La fatica di un uomo solo. Sondaggi nell’opera diLuciano Bianciardi traduttore, cit., pp. 138-169.
7 Si pensi al congruo numero di critiche negative che il testo attirò alla suapubblicazione. Soltanto negli ultimi anni sembra essersi moderato l’atteggia-mento da parte degli studiosi e dei critici di Bianciardi, iquali, proprio alla let-tura di Aprire il fuoco stanno dedicando revisioni ed analisi approfondite chemettano in evidenza i punti di forza del romanzo, il suo carattere prettamentesperimentale e innovativo.
8 L. Bianciardi, Daghela avanti un passo!, cit., pp. 22-23, passim.9 Ivi, p. 23.10 Come testimonianza di quanto sostenuto, vale la pena rammentare l’inci-
pit del diario: “Non mi fu mai detto, ma credo che fosse questa l’ipotesi lavora-tiva, nella mente di chi decise e propose la spedizione: prendere cinque personepoco meno che normali, caricarle a Tripoli sopra una vettura perfettamente eu-ropea, comandar loro di raggiungere, a bordo di quella vettura, i margini del Sa-hara, ripercorrere la costa berbera fino ad Algeri, forse fino a Tunisi e quiabbandonare il veicolo e riguadagnare la penisola con altro mezzo. Viatico, unacerta somma di danaro, per il resto arrangiatevi. Anzi, se ne siete capaci, poi ciracconterete, a parole e a immagini, quello che avete visto. Cinque, poco menoche normali, e vediamo subito perché, cominciando dal tallone di Achille, valea dire da chi sta raccontando la faccenda”, da Viaggio in Barberia, in L. Bian-ciardi, L’Antimeridiano. Opere complete – Volume primo, a cura di L. Bian-ciardi, M. Coppola e A. Piccinini, Milano, Isbn Edizioni e Excogita Editore,2005, p. 1311 (i caratteri in neretto sono nostri).
11 A tale proposito, si confrontino le tesi di Paul Ricoeur in P. Ricoeur, La tra-duzione. Una sfida etica, a cura di D. Jervolino, traduzione di I. Bartoletti e M.Gasbarrone, Brescia, Morcelliana, 2001.
12 L. Bianciardi, Daghela avanti un passo!, cit., p. 9.13 Rif. L. Bianciardi, Un volo e una canzone, Milano, Excogita Editore, 2002.14 Da ‘barley’ (orzo) e ‘corn’ (grano), dalla cui “fermentazione si possono
distillare tutti i tipi di onesti o meno onesti whisky che si bevono qual e là per ibar del mondo”: cfr. G. Lombardi in “Introduzione” a J. London, John Barley-corn, Milano, Guanda, 1980, p. 8.
15 L. Bianciardi, Daghela avanti un passo!, cit., p. 8, passim.16 A tale proposito, va ricordato come per anni London sia stato spesso desti-
nato ad un pubblico di lettori adolescenti. Opere come Il richiamo della foresta(The Call of the Wild, 1903) e Zanna bianca (White Fang, 1906), solo per citarele più celebri, furono spesso oggetto di riduzioni editoriali e inserite in collane perragazzi. Soltanto con l’uscita di Martin Eden (1913, lo stesso anno di John Bar-leycorn, col quale condivide l’imprinting autobiografico) London fu riconosciutonel pieno statuto di scrittore, divenendo anzi antesignano delle generazioni suc-cessive, da Henry Miller ai Beatniks (Jack Kerouak, Norman Mailer, …).
72
BIANCIARDI, OTTOCENTO COME NOVECENTO
17 G.C. Ferretti, La morte irridente, Milano, Lecce, Piero Manni, 2000, p. 104.18 Ibidem.19 Ibidem.20 A supporto di quanto scritto, vale la pena riportare la testimonianza di
Maria Jatosti, compagna dello scrittore negli ultimi diciotto anni: alla domandase e quali sollecitazioni gli scrittori da tradurre provocassero in Bianciardi un at-teggiamento di deferenza, Jatosti riponde: “Della beat generation Kerouac, na-turalmente. Di Steinbeck ha tradotto un paio di libri, ma non lo considerava frai maggiori. Sicuramente London. Somerset Maugham? No, non direi che loamasse in particolare, no” (da ‘Appendice’ in A. De Nicola, La fatica di un uomosolo, cit., p. 198):
21 Usiamo la definizione di romanzo per convenzione, ma va sottolineatocome il testo di fatto venga considerato un “nonfiction work” secondo l’elencoconsegnato dalla sezione “writings” nel sito ufficiale dedicato a London: cfr.http://london.sonoma.edu
22 Tutti i passaggi del testo sono stati tratti dalla Jack London Online Col-lection, nella sezione “Writings”, reperibile presso il sito web http://london.so-noma.edu/Writings/JohnBarleycorn/. Qui, come nei brani successivi, i caratteriin corsivo sono nostri. Per l’individuazione dell’estratto selezionato, citeremo ilnumero del capitolo.
23 Jack London, John Barleycorn, Milano, Guanda, 1980, p. 19. Qui, comenei brani successivi, i caratteri in corsivo sono nostri.
24 L. Bianciardi, Aprire il fuoco, a cura di E. Bianciardi, Milano, Excogita,2001 [1969], p. 225.
25 Cfr. A. Bertani, Da Grosseto a Milano. La vita breve di Luciano Bian-ciardi, Milano, Excogita, 2007.
26 Ivi, pp. 163-164, passim. Bertani continua la sua ricostruzione affermandoche “il dualismo che ha sempre convissuto nel suo io, e che lui è sempre riuscitoa tenere faticosamente a bada, scaricandolo addosso ai personaggi dei suoi ro-manzi , adesso è esploso dando corpo e sostanza al doppio essere di Luciano,quel doppio essere che, impossibile da dominare, lo porterà al conflitto decisivocon se stesso, all’ablazione della sua esistenza” (p. 164).
27 Si tratta di un atteggiamento rilevato in particolare per la traduzione dei dueTropici milleriani.
28 Per ‘addomesticante’ si intende una traduzione volta a rendere familiariconcetti ed immagini che non appartengono alla presunta enciclopedia di cono-scenze del lettore. Molto probabilmente oggi Bianciardi avrebbe optato per con-servare il lemma “ranch” nella sua versione originaria, in modo da consegnarela rappresentazione più ‘estraniante’ fornita da London (ranch inteso ovviamentecome tipica fattoria americana). Per un’esaustiva trattazione dell’atteggiamentoaddomesticante vs estraniante del traduttore, si veda l’ottimo L’invisibilità deltraduttore di L. Venuti [The Translator Invisibility], trad di M. Guglielmi, Roma,
73
CONVEGNO
Armando Editore, 1999.29 M. Jatosti, ‘Appendice’ in A. De Nicola, La fatica di un uomo solo, cit., p.
203, passim. La scrittrice rammenta inoltre le modalità di approccio che Bian-ciardi assumeva nei confronti dei testi da tradurre: “Prima dava un’occhiata allibro... La sera a letto ne leggeva un po’ di pagine, quelle che avrebbe tradotto ilgiorno dopo... Sì, faceva così, e poi si metteva alla macchina, e andava... Correg-geva pochissimo: una volta che aveva trovato la soluzione, che l’aveva scritta, eraquella. Raramente la cambiava. Raramente ribatteva qualche pagina. Non facevamai una prima copia da correggere e copiare. Questo spiega la grande mole di la-voro che riusciva a fare. La velocità. Però aveva le sue pignolerie, la sua nevrosi.Se non aveva terminato la ‘razione’ che si era autoimposto, non si muoveva dal suoangolo, il più riparato della casa, dietro il tramezzo che lo isolava dagli altri. Ca-scasse il mondo, lui non smetteva. E se gli capitava di dover uscire o se veniva atrovarci qualcuno ne era infastidito perché gli aveva sottratto del tempo... Invecedi dieci aveva tradotto nove, otto pagine e il giorno dopo gli sarebbe toccato farneuna o due in più. […] Maniacale. Il tempo era scandito sul suo lavoro e tutta la gior-nata ruotava attorno a questo ritmo: la sveglia, il caffè, la passeggiata, il giornale,quattro ore a tavolino, poi mangiare, il riposo pomeridiano, il caffè, il secondoblocco di lavoro, la cena, la tivù e a letto” (pp. 203-204, passim).
30 Si confronti la testimonianza riportata anche nel presente contributo daMaria Jatosti (rif. nota n. 25).
31 L’uso del termine “fatica” è significativo poiché rimanda direttamente aun’espressione utilizzata da Bianciardi in Il lavoro del traduttore, a proposito diciò che egli considerava la sua vera attività professionale. Egli infatti recita: “Ilmio lavoro è e rimane un lavoro da artigiano, un lavoro minuto, oscuro e scien-tifico, sempre approssimativo. A parte la macchina che – dicono – traduce dalrusso in americano, e che pare meravigliosa, il resto è fatica di un uomo solo alleprese con un libro straniero, davanti ai tasti di una macchina, con una pila difogli bianchi che faticosamente, uno dopo l’altro, si anneriscono” (rif. M.C. An-gelini, Luciano Bianciardi, Firenze, La Nuova Italia, 1980, p. 74).
32 Rif. ‘Scritti ed edizioni d’arte’ in I. Gambacorti, Luciano Bianciardi. Bi-bliografia 1948-1998, cit., pp. 160-161.
33 Illustrazione presente tra la p. 272 e 273 in L. Bianciardi, Daghela avantiun passo!, cit.
34 L‘assalto alla Madonna della Scoperta (Livorno, Museo Fattoriano[n.103]. Assieme [cm. 175X410]); Il Quadrato di Villafranca (Firenze, Galleriad’Arte Moderna [n. 296]. Assieme [cm. 300x550]). Cfr. L’opera completa diFattori, presentazione di L.Bianciardi, apparati critici e filologici di B. DellaChiesa, Milano, Rizzoli Editore, 1970, tav. XX-XXI.
35 L. Bianciardi, Il poeta della fatica umana, in L’opera completa di Fattori,cit., p. 5, passim.
36 L. Bianciardi, Il poeta della fatica umana, cit., p. 6, passim.
74
BIANCIARDI, OTTOCENTO COME NOVECENTO
37 Oltre al brano citato, infatti, l’aggettivo è riutilizzato in altri due casi: aproposito dello spirito di osservazione manifestato da Fattori, Bianciardi sostieneche spesso il pittore “si volse sempre di più allo studio e alla rappresentazionedella sofferenza umile[...]. Proprio così: basta guardare in faccia uno dei suoibutteri […]. La vita del buttero era per davvero stentata e ‘agra’ come ce la mo-stra Fattori” (p. 7, passim), e ancora, in uno dei passaggi finali della presenta-zione, lo scrittore recita: “Può darsi che qualche volta l’umore ‘agro’ di Fattoripassi il limite” (p. 8). Da notare che ogni volta il lemma ricorre virgolettato,come a marcare un’autocitazione consapevole, un implicito inferenziale che ta-citamente unisce l’autore al lettore del testo.
38 L. Bianciardi, Il poeta della fatica umana, cit., p. 6.39 Ivi, p. 7. Riposo (Milano, Brera [n. 403]. Assieme [cm. 88X179]). Cfr.
L’opera completa di Fattori, cit., tav. XLIV-XLV.40 Curioso è notare la contaminazione di elementi tipici della narrativa bian-
ciardiana nell’opera di traduzione, la cui analisi permette di ravvisare una natu-rale commistione di aspetti interpretativi propri del Bianciardi narratore. Se poiin tale prospettiva inseriamo il nuovo dato che, conoscendo Fattori (che gliavrebbe ispirato l’uso precipuo dell’aggettivo ‘agro’), Bianciardi già avesse innuce quella particolare visione della storia che leggiamo nei suoi romanzi e negliscritti di materia storica, comprendiamo anche meglio la peculiare tendenza a in-teressarsi ai medesimi temi trattati nelle relative traduzioni.
41 S. Crane, The Red Badge of Courage – An Episode of the American CivilWar, New York, The Modern Library, 1951, p.1.
42 S. Crane, Il segno rosso del coraggio, Milano, Mondadori, 1966, p. 9.43 S. Crane, The Red Badge of Courage – An Episode of the American Civil
War, cit., pp. 1-2, passim.44 S. Crane, l segno rosso del coraggio, cit., p. 9, passim.45 A tale riguardo, vale la pena rammentare un’acuta osservazione di Maria
Stella, la quale, a proposito della disamina di un testo di Conrad tradotto da Bian-ciardi, La Tremolino (estratto da The Mirror of the Sea – A Personal Record,1925) per un’antologia intitolata Avventure e viaggi di mare – Giornali di bordo,relazioni, memorie, a cura di G. Dossena e M. Spagnol (Milano, Feltrinelli,1959), sottolinea come lo scrittore toscano introduca “la memoria esplicita delpaesaggio toscano”, consegnando espressioni come “a wet morass” con “unamaremma paludosa”, e “the stagnant waters of a marsh” con “acque stagnanti dimaremma” (rif. M. Stella, Luciano Bianciardi e il viaggio del traduttore, in L.Bianciardi, Carte su carte di ribaltatura – Luciano Bianciardi traduttore, Fi-renze, Giunti, 2000, p. 24, passim).
46 La traduzione venne data alle stampe da Rizzoli nel 1969. Il libro, di ma-trice autobiografica, era scritto in prima persona e narrava le avventure del pro-tagonista con Charley, un cane.
47 L. Bianciardi, Il poeta della fatica umana, cit., p. 8.
75
CONVEGNO
48 Ibidem. Lo staffato (Firenze, Galleria d’Arte Moderna [n. 324]. Assieme[cm. 90X130]). Cfr. L’opera completa di Fattori, cit., tav. XXVII.
49 L. Bianciardi, Il poeta della fatica umana, cit., p. 8.50 Ne sono testimonianza ancora le osservazioni di Bertani, il quale sostiene
che, dopo il successo di Aprire il fuoco, Bianciardi viene invitato a Grosseto,proprio alla Biblioteca Chelliana, “luogo per lui famigliare e denso di ricordi”(p. 162), e lì “avviene l’incontro – si potrebbe dire ufficiale – con i due figli avutida Adria, Ettore e Luciana, che era solito vedere di sfuggita, una volta l’anno.[…] Cenano tutti e tre insieme nel più rinomato ristorante di Grosseto, sullapiazza del Duomo; parlano a lungo e lui d’un tratto si accorge che questi due ra-gazzi, alla fin fine, non li conosce affatto. È una scoperta lacerante, che lasceràil segno anche quando Luciano, partito da Grosseto e terminato il giro di pre-sentazioni, tornerà nel suo eremo di Rapallo. D’improvviso cresce e deflagra ilconflitto interno, le sue radici maremmane tornato di prepotenza a pretendere diesser ascoltate, le voci dei badilanti risuonano nelle sue orecchie e le anime diquei quarantatré amici minatori gli tormentano il sonno. È un incubo che non loabbandonerà più” (p. 163, passim).
51 L. Bianciardi, Il poeta della fatica umana, cit., p. 8.
76
BIANCIARDI, OTTOCENTO COME NOVECENTO
Maria Antonietta Grignani
Aprire il fuoco: esilio della storia, esilio della scrittura.
La delusione di Bianciardi, inurbato a Milano, è il tema chegoverna La vita agra: il dominio del denaro, la spersonalizzazionedella metropoli, la lotta quotidiana per la sopravvivenza, la tri-stezza della vita dentro un contesto urbano inquinato e frenetico,producono solitudine nel protagonista narratore che si oppone allalegge dell’integrazione e del profitto. “Tutti i difetti dell’industriamoderna e tutti i difetti del partito comunista si mischiavano a for-mare un casino credo unico al mondo”, commenterà poi Bian-ciardi1. Presto licenziato dalla Feltrinelli, traduce per sopravvivere,ma intanto osserva, commenta, torna con il pensiero e con la scrit-tura alle illusioni dei suoi anni grossetani. Nasce dalla memorianel 1957 Il lavoro culturale, un libro che dovrebbe essere propo-sto nelle scuole per la lucidità con cui giudica la voglia di cam-biare dei giovani e il freno dei benpensanti, i tentativi di proporretemi innovativi da parte dei ragazzi di sinistra e invece la cappa dipiombo calata da esperti o ideologi votati alla propaganda del Par-tito Comunista.
Ecco la parodia del codice linguistico e gestuale adottato in con-ferenze e dibattiti, in forma seriosa e pseudo-didascalica, che giàmostra l’orecchio assoluto di Bianciardi per gli stereotipi della pa-rola in quanto ideologema, cioè spia rivelatrice degli stereotipi delpensare e del comportarsi. Un illustre critico cinematografico ve-nuto da Roma rintuzza ogni progetto di analisi formale su Ladri dibiciclette di De Sica con argomenti rozzamente contenutisticicome questo: “A noi Ladri di biciclette interessa solo nella misurain cui riesce a porre in forma popolare un problema d’importanzanazionale. Nel caso specifico, il problema della disoccupazione”.Donde la sua critica al film, perché non aggiornato sulle lotte sin-dacali delle categorie operaie moderne (I, 235). Il sintagma “nellamisura in cui”, espressione che si penserebbe inaugurata o almenodiffusa dal Sessantotto mentre proviene dai dibattiti degli anni Cin-quanta, è ripreso più in là con il fraseggio che accompagna la pa-rola cruciale problema, di cui il narratore illustra il codice verbale:
77
il problema “si pone o si solleva, indifferentemente”; dal problemasi apre un dibattito, ovviamente ampio e approfondito; dal dibat-tito “scaturiscono, oppure emergono o anche, più semplicemente,escono, alcune indicazioni”, nonché “tutta una serie di iniziative,utili, naturalmente, ma di massima, suscettibili cioè di elabora-zione”. Concreto è definito sempre il problema, peraltro mai ri-solto ma al più superato, oppure di colpo scopertosi inane, giacchésovente si afferma che “il problema è un altro”. Ed ecco i gesti:gesto circolare delle due mani per il problema ampio; con strofi-namento dei due pollici contro le altre dita per concreto; mentre ilsintagma nella misura in cui va accompagnato dalla mano sinistra“piegata a spatola”, che “scava in un mucchietto di sabbia imma-ginaria posta di fronte a chi parla” (cap. 6). Rivelatrice la testimo-nianza di Mario Spagnol (riportata in Corrias, p. 83):
Ecco, Luciano aveva un occhio speciale, un occhio e un orecchio percogliere proprio quelle che erano, direi, le deformazioni professionalinel linguaggio e negli atteggiamenti. Soprattutto il linguaggio, se nonera naturale e spontaneo, lui lo avvertiva subito, come una stonatura. Lachiacchiera intellettuale, che poi avrebbe dominato l’Italia per almenodue decenni, era proprio una delle sue bestie nere.
Data la vocazione metalinguistica, anche il citazionismo è uncarattere distintivo, ma si tratta di citazioni letterarie della tradi-zione ‘etica’, da Parini a Manzoni a Leopardi, solidali cioè con uncontesto ancora intessuto di illusioni (Bruni).
Costituiscono il sottofondo e i cartoni preparatori de La vitaagra (1962), che è una sorta di rovescio milanese del felliniano Ladolce vita uscito giusto due anni prima, molti articoli stampati sulContemporaneo, nella rubrica Lo specchio degli altri tenuta nel1955-56 sull’Unità e interventi paralleli sull’Avanti!. Questi arti-coli configurano i tipi moderni del fotoreporter, delle segretariemilanesi e del ragioniere, guardano con sospetto le attività quar-tarie (il neologismo era nato nell’articolo “I quartari” del 1959),ossia i compiti di pubblicitari, designer, addetti alle pubbliche re-lazioni, ricercatori motivazionali dal gergo incomprensibile. LaLettera da Milano, al primo impatto con la metropoli nel 1955, di-segna il profilo di chi era andato al nord per combattere le colpe
78
BIANCIARDI, OTTOCENTO COME NOVECENTO
che avevano prodotto la tragedia dei minatori di Ribolla, “a con-tatto con il nemico” (la Montecatini e il suo torracchione). E in-vece no, niente operai nel cuore della città, ma solo ragionieri, incompleto grigio, camicia bianca, cravatta azzurra, “la faccia sca-vata sotto le occhiaie da un solco diritto che raggiunge gli angolidella bocca”, schiavi inconsapevoli della Milano “che non pro-duce nulla, ma vende e baratta”2. Niente intellettuali come gruppo,d’altronde, giacché “l’intellettuale diventa un pezzo dell’apparatoburocratico commerciale, diventa un ragioniere” (II, 700-705).
Il libro si aggira tra autobiografia trasposta, saggismo, digres-sioni, citazioni più o meno occulte, parodie letterarie, inclusione dibrani di traduzioni proprie, osservazioni linguistiche su varianti re-gionali italiane in convivenza coatta. Configura cioè non più la stra-tegia ottimistica di “allargamento” verso nuovi ceti e registrilinguistici che era scaturita dal Neorealismo, ma una diversa “stra-tegia di scavo” comico-drammatico nelle contraddizioni della nuovasocietà, che lo avvicinano alla narrativa allucinata di Mastronardi eal Volponi di Memoriale (per il concetto di strategia di scavo cfr.Segre, pp. 39-40). “Proverò a riscrivere tutta la vita non dico lostesso libro, ma la stessa pagina, scavando come un tarlo scava unazampa di tavolino”, dice il narratore tra celia e confessione (I, 583).
Dall’anarchismo, dalla conoscenza di prose della Beat Gener-ation e di Miller, Bianciardi ricava suggestioni precocissime, tracui un’utopia di sabotaggio all’attivismo metropolitano, interes-sante per l’altezza cronologica in cui si pone e presaga della modadi Marcuse, che verrà diffusa più tardi dal Sessantotto. Ai capitoliquarto e decimo immagina infatti una rivoluzione fatta di rinun-cia all’economia di mercato per un’economia del donativo, cheporrebbe fine ai bisogni artificiali, in una società di individui nonpiù schiavi del lavoro e della famiglia, dove “i rapporti sessuali sa-ranno liberi, indiscriminati, ininterrotti e frequenti, anzi continui”.
Antiromanzo di evidente novità strutturale sulla crisi di un sog-getto che non vuole farsi integrare nel sistema affluente, La vitaagra sancisce la “solenne incazzatura, scritta in prima personasingolare” del narrante, eterno provinciale cui non importano piùle tranches de vie bensì la vita fatta a pezzi, parcellizzata da quelsistema affannoso e spersonalizzante che oggi conosciamo neidettagli (lettera 1 marzo 1962 in Terrosi, p. 34). Ma la storia di un
79
CONVEGNO
progetto dinamitardo trapassa nel diario del traduttore e con que-sto indica il doppio scacco, politico e strutturale, tipico della “nar-rativa senza romanzo”3. Basta guardare le definizioni date allafatica del tradurre per capire l’angoscia dell’addetto a questo la-voro, un impegno che comporta artigianato minuto e capacità dipassare continuamente da stile a stile, insomma una “fatica fisicae psicologica da sterratore”, dato che “i movimenti di terra il tra-duttore li fa con la vanga e la barella, come i terrazzieri delle mieparti quando lavorano al fossone” (Il lavoro del traduttore, II, 873-76). Donde i sinonimi forti ribaltare / ribaltatura ne La vita agra,che all’inizio dell’ottavo capitolo offre un ricalco in chiave eruditae quasi pedante, con prelievo integrale di molti passi del “dal-mata”, dalla voce Tradurre (volgarizzare, voltare) del Dizionariodei sinonimi del Tommaseo.
Dai cartoni degli scritti giornalistici Bianciardi ricava e fa par-lare un personaggio a valenza insieme testimoniale e grottesca,sovrimprimendogli un biografismo autoriale che favorisce la com-ponente saggistica, lo sfondamento dei confini di genere e lamessa in rilievo della relazione tra artificio e realtà. Tragico e co-mico convivono entro l’abbraccio mortale della psicopatologiadella vita metropolitana.
Il libro è anche sintomo di una saturazione culturale, a metà trail gaddismo di matrice italiana e l’influsso dei due Tropici di Mil-ler appena tradotti. Da Gadda Bianciardi riprende la vocazionemetanarrativa, la pratica del code mixing, l’attenzione ironica pervarie parlate e gerghi di mestiere, che s’incrociano, non in tran-quilla polifonia ma in collisione tra gli inurbati e i milanesi. DaMiller accoglie il “tornado stilistico e psicologico” che lo avevacoinvolto nel tradurre, lo stile sboccato, il lessico sessuale e sca-tologico, l’affollarsi dei cataloghi, il divorzio tra sostanza e formacausato da sfiducia nella letteratura, l’intemperanza arrabbiata, larivolta anarchica contro l’imperativo del denaro, la metropoli mo-derna, la tecnologia incipiente. È lo stesso Bianciardi nel 1971 adichiarare a Enzo Tortora le proprie ascendenze:
I miei maestri si chiamano così: Giovanni Verga, catanese. Seguoinvano le sue tracce da quando avevo diciotto anni. Carlo EmilioGadda, milanese come te e come me, tuttora insuperato. Henry Miller,
80
BIANCIARDI, OTTOCENTO COME NOVECENTO
detto anche Enrico Molinari, da New York, che ebbi la fortuna di tra-durre e di conoscere personalmente. Ora abita a Big Sur, e qualchevolta mi spedisce una cartolina firmando col suo nome italiano di miainvenzione4.
L’antologia Narratori della “generazione alienata”. Beat ge-neration and Angry young men, tradotta per Guanda nel 1961 econtenente testi di Norman Mailer, Kerouac, Donleavy, gli tra-smette tempestivamente la lezione dei primi due movimenti diprotesta, americano e inglese, non a caso partiti all’interno deidue paesi dall’economia capitalista più avanzata, mentre in Italiala spinta allo sviluppo era in quegli anni più forte della presa di co-scienza del consumismo e per questo anche i più avvertiti riflet-tevano o scommettevano sul tema letteratura e industria senza larabbia e la negazione degli anglo-americani.
Italo Calvino, nella conferenza del 1962 Beatniks, “arrab-biati”, eccetera, definisce sì invasioni barbariche quelle degli og-getti che “abbiamo creduto di possedere e che ci possiedono”,insomma dello sviluppo produttivo di cui si sta diventandoschiavi, ma non incoraggia al nichilismo della Beat Generation(Calvino, pp. 75-81). Dalle pagine del Menabò Vittorini e redat-tori lamentano lo scarso adeguamento alla moderna civiltà indu-striale nelle tecniche di scrittura italiane, rinnovate solo in parte esenza una vera presa di coscienza dei cambiamenti e dei riflessipsicologici che ne derivano. Al contrario, il potenziale disgregantedel modello anglo-americano nella prefazione ai Narratori della“generazione alienata” è avvertito da Bianciardi con luciditàpiena, quando osserva che nelle opere di quella generazione “nonc’è cumulo di esperienze, non c’è conoscenza. Infatti ciascun mo-mento è scisso dal rapporto col successivo, sta come un’isola disensazione avvertita, e subito scompare senza lasciare traccia”.Una tale consapevolezza della fine del vettore esperienziale staalla base di tutta la narrativa a venire di Bianciardi, fatta di frat-ture, di negazione del futuro, magari alla luce di un passato tradito.
Una celebre digressione metanarrativa de La vita agra (I, 582-83) ricorda le irrisioni della letteratura per bene di Henry Miller,
81
CONVEGNO
maestro dei giovani della Beat Generation e campione di umori-smo cupamente irriverente quando detta:
Questo non è un libro. È un libello, calunnia, diffamazione […] è uninsulto prolungato, uno scaracchio in faccia, un calcio alla Divinità, al-l’Uomo, al Destino, al Tempo, all’Amore, alla Bellezza … A quel chevi pare. Canterò per voi, forse stonando un po’ ma canterò. Canterò men-tre crepate, danzerò sulla vostra sporca carogna […]5.
Come Miller, Bianciardi dissemina le proprie pagine di enu-merazioni caotiche, con nomi propri prelevati senza dichiararlodagli autori tradotti: valga per tutti la serie “Mona-Mara-June e lanana della Cosmociccic Telegraph Company”, con le donneMona, Mara e la Cosmococcic dedotte rispettivamente da Tropicodel Cancro e Tropico del Capricorno, mentre June era la compa-gna degli anni parigini di Miller (I, 682).
Quanto all’inserzione di toponimi e brani di traduzioni, si va daUna favola di Faulkner (I, 718) a Zenzero di James Patrick Don-leavy tradotto nel 1959, il cui protagonista Sebastian è convocatoquasi fosse un compagno di esperienza reale di chi narra, entrambicollocati illusionisticamente in vetta a Kilrock (I, 681). Negli im-mediati dintorni, con ampio ricorso a nomi di luogo, si cita ancheda Brendan Behan, di cui Bianciardi nel 1960 aveva proposto intraduzione il Ragazzo del Borstal: l’autore è criptato-svelato nelsuo nome in gaelico “Breandan O’ Beachain” e qualche parola ingaelico spiazza ulteriormente il lettore (I, 680-81). Molto impor-tante quest’ultimo libro, perché mette in scena un ragazzo che dal-l’Irlanda approda in Inghilterra con una valigia piena di bombecontro il potere usurpatore, proprio come il narratore bianciardiano,salito da Grosseto a Milano con l’intenzione di fare un attentato al“torracchione” della Montecatini. Lo spaesamento che ne deriva,l’intossicazione identificativa legata alle molte ore quotidiane di ri-baltatura, sono commentati laddove la pratica del collage si insinuacome se il vissuto biografico fosse divorato dal profilo autobiogra-fico di una scrittura esiliata dall’invadenza degli autori tradotti, alpunto da travestire in inglese paesaggi e località appenniniche delgrossetano (esemplificazione in Grignani, p. 13) .
82
BIANCIARDI, OTTOCENTO COME NOVECENTO
Attraverso le riscritture Bianciardi crea un doppio falso movi-mento, di convergenza e di presa di distanza tra vita e scrittura, alloscopo di produrre un proprio sosia comico e bachtinianamente sco-ronante (Guerricchio, p. 73), procedendo sempre più verso il mo-nologo informale di un io assediato da firme altrui, fatto a pezzi daun babelico incrocio di lingue e paesaggi, in cui la compattezza psi-chica si sfalda e riflette, come uno specchio rotto, pensieri pensatio ricevuti, parole e letture introiettate o addirittura subite.
Già i conflitti tra la variante materna del toscano e il milanese‘straniero’ sono spia di un itinerario orientato verso lo spaesa-mento. Il toscano si manifesta senza soluzione di continuità, dalleforme più accettate della norma ‘nazionale’ a quelle più ‘verna-colari’ della zona di Grosseto (ramaiolo, chetare, berciare, gar-bare, scialbare, ma anche arronzare, stracanarsi ‘affaticarsimolto’, tafanare ‘disturbare, perseguitare’). Il milanese apparequasi incomprensibile nei “rabbuffi gutturali del bigliettaio” deltram, è percepito estraneo nelle diverse denominazioni dei tagli dicarne e nella sottile distinzione tra i dané che si spendono e lagrana che si guadagna. La babele di dialetti regionali o locali chesi incrociano nella grande città è la faccia visibile del disordinatomelting pot sociale e antropologico che Milano stava vivendo inquegli anni di inurbamento. Ma è sintomatico che la variante to-scana rivesta un suo ruolo di ancoraggio identitario e civile, perquanto non certo puristico, in asse con un orgoglio secolare nelquale Bianciardi si riconoscerà anche nei romanzi successivi Labattaglia soda e Aprire il fuoco.
Esuberanza linguistica, dismisura e digressioni fanno saltare ilfilo narrativo principale, tenuto insieme dalle isotopie tematichee formali della polemica per i gesti e gli stili di vita milanesi, of-ferti in stereotipi ripetuti. Le ragazze vestite di nero alla moda pa-rigina, con i capelli appiccicosi e i “piedi sporchi di melletta” chebazzicano intorno all’Accademia di Brera e ai bar degli artisti,sono designate in sintagmi ricorrenti; le segretarie d’azienda ter-ree, secche, con quei tacchi a spillo che provocano un ritmico vi-brare di gote nella camminata convulsa, si trasformano in unacaricatura priva di individualità, diventano vibratrici di gote op-pure taccheggiatrici vibratili aziendali. La procedura dell’eti-chetta tipizzante si ritroverà anche in Aprire il fuoco, dove il
83
CONVEGNO
giudice sarà “il mascherato di toga” e un avvocato che somiglia aGramsci e si occupa di energia nucleare assume il cartellino di“nucleare gramsciano” (I, 966-67).
Il successo seguito all’uscita de La vita agra avrebbe sugge-rito a qualunque scrittore ambizioso di insistere sulla propria fi-gura di ‘arrabbiato’, sul tema della satira del ‘miracolo’economico senza anima. Bianciardi invece si inquieta che i mila-nesi lo blandiscano, lo invitino nei salotti e gli propongano con-ferenze, cioè riassorbano cinicamente il potenziale polemico dellibro. A successo raggiunto Luciano torna al suo amore per i fattidel Risorgimento che lo appassionavano fin da ragazzo e si eranotravasati nel 1960 in Da Quarto a Torino; mette mano a ciò chedefinisce “un grosso tentativo, anche linguistico” (Terrosi, p. 44)di rifarsi a fatti storici e darli in una veste popolare, quasi a con-trastare il troppo pieno di cultura aggiornata che aveva intessutola vita di traduttore e le pagine sue precedenti. Ulteriore e variatosperimentalismo di secondo grado è La battaglia soda (1964), cheriprende con affetto e in parte ricalca lo stile de I Mille. Da Ge-nova a Capua del memorialista ottocentesco Giuseppe Bandi, so-vrapponendo all’autore storico la proiezione dello stessoBianciardi, che si finge un quarantaduenne ex-garibaldino delusoe intento a scrivere le memorie dalla presa di Capua del 1860 alladisfatta di Custoza del 1866.
Bianciardi imita l’andamento toscaneggiante di Bandi nel les-sico e nelle forme (dee, doveasi, facea), nei proverbi e nei dettiche anche a lui erano forse familiari dall’infanzia grossetana,come negli esempi seguenti: “a fatica mi bastò il fiato per direpippo sopra la candela e già dormivo”, “vagellavo su pei peri dalgran febbrone”, ecc. Oltre al disegno di conservare la patina ot-tocentesca, rispunta qui il mito del fiorentino e cioè della varianteche contribuì alla formazione della coscienza unitaria degli ita-liani, l’idea di una sua eccellenza rispetto alle lamentose e orribilifavelle piemontesi, che verrà declinata ancora, tra il serio e il fa-ceto, dal protagonista di Aprire il fuoco in veste di pedagogo: “eradavvero un balsamo la parlata dei fiorentini, nobili borghesi edartigiani, i quali per secoli tennero a scuola i grandissimi nostriscrittori di prose e di versi” (I, 796).
84
BIANCIARDI, OTTOCENTO COME NOVECENTO
Garantita la fedeltà ai fatti storici percorsi da Bandi, nella ri-scrittura certi personaggi minori sono in realtà gli amici nove-centeschi Carlo Ripa di Meana, “il giovane letterato cremonese”Giampaolo Dossena, i musicisti o attori Franco Nebbia e WalterChiari, quasi a annunciare per implicito certe corrispondenze conl’attualità italiana, che ripete a distanza di un secolo ragioni esventure del Risorgimento; pratica, questa, che diventa strutturalenell’assetto dis-cronico di Aprire il fuoco. L’intento principale del-l’autore, dunque, non è linguaiolo né semplicemente nostalgico,è quello di contrastare la rimozione della storia che fece l’Italia,raccordando il Risorgimento garibaldino, tradito dall’esercito pie-montese, al futuro tradimento degli ideali libertari usciti dalla Re-sistenza, come chiarì lui stesso nella segnalazione che accompagnail libro: “la delusione di allora è anche una verifica della delu-sione nostra, una specie di controllo nel passato, per ritrovarvi inostri errori, le nostre speranze”.
Intanto, stanco della vita metropolitana, si era trasferito a Ra-pallo, pur continuando a scrivere articoli e a tradurre per l’edito-ria di Milano. Qui in Liguria nasce l’ultimo romanzo Aprire ilfuoco, scritto durante il fatidico Sessantotto e pubblicato nel 1969.L’autore lavora tra attualità del contesto - o del malumore suo - eun fantasioso straniamento delle Cinque Giornate milanesi del1848, trasferite estrosamente al 1959; unisce i temi autobiogra-fici de La vita agra e quelli storico-civili de La battaglia soda inuna sorta di testamento, che esaspera anche le procedure compo-sitive e linguistiche.
La storia, in prima persona, è quella di un attivista della rivoltafantomatica del 1959, costretto dalla persecuzione politica a unesilio volontario nella libera repubblica marinara di Nesci, citta-dina ligure che gli offre il vantaggio dell’extraterritorialità e tra-veste Rapallo con un nome anche toscanamente allusivo: fare ilnesci vale ‘fare lo gnorri’. Da qui l’ex patriota percorre i giornidello sciopero del fumo, della rivolta e del suo fallimento in unaanalessi che occupa i capitoli centrali. È possibile che l’idea diconiugare esilio presente e memorie di un passato di lotta sia statarafforzata dal libro di Richard Brautigan, Il generale immagina-rio (A Confederate General from Big Sur), uscito in traduzione
85
CONVEGNO
solo nel 1972 con presentazione dello stesso Bianciardi, in cui loscambio di lettere tra due amici, uno a San Francisco, l’altro riti-ratosi nella piacevole località di Big Sur, inscena la fuga dalla cittàe il mito-ricordo della guerra civile americana.
Ovunque, ma soprattutto nei quattro capitoli iniziali e negli ultimidue che fanno da cornice, l’autobiografismo è invasivo, ma si trattaquasi sempre di allusioni di secondo grado, a una vita già travasatae fissata negli scritti. Questa forma di ripetizione e di andirivieni trapassato testuale e presente del racconto disturba la convenzione dilettura e fornisce un ruolo dispotico alla voce narrante, che si rivolgespesso a chi legge, ma lo delude punto per punto, smembrando, dis-simulando e intersecando i codici semantici di riferimento. Il piaceredella lettura si pone dunque a due livelli: quello superficiale domi-nato dalle varie strategie del comico e quello più profondo, regalatosoltanto al lettore assiduo di Bianciardi.
Basta un esempio-limite per chiarire il problema di decodificache questo libro pone intensamente e che è valso all’ultimo Bian-ciardi l’accusa di fallimento comunicativo e di obscurisme (si ve-dano Rinaldi, 55-60 e gli ultimi capitoli di Ferretti). Nell’ultimocapitolo dall’esilio di Nesci sorge una allusione oscura alla perico-losità di accostarsi al deschetto del ciabattino: “Ognuno diventi unSocrate, in piazza, ne’ trivii, al deschetto del ciabattino. Ah, no, dot-tore, qui non ci siamo, lo so io quello che costa accostarsi al de-schetto del ciabattino”(I, 1109). A chi si domandi che c’entra uncalzolaio con il locale contesto di dialoghi e polemiche rispetto alleteorie rivoluzionarie della Guerra di guerriglia del “dottor” CheGuevara e agli scritti del suo “diretto progenitore” Carlo Pisacanemessi lì bellamente fianco a fianco, una risposta sensata la può daresoltanto un episodio secondario de La battaglia soda, cap. 10, conl’inganno giocato da un ciabattino disonesto ai danni della fondinae delle calzature del protagonista, ex garibaldino (I, 871-75)6.
E presenti, anche se in misura minore rispetto a La vita agra,sono i temi, alienanti e mai esplicitati nelle loro ‘fonti’ autoriali,del diuturno ribaltamento e battonaggio. Il secondo capitolo de-scrive il lavoro di traduzione in corso su L’ultimo avventuriero diHarold Robbins così alluso in perifrasi abbastanza astrusa, quale“storia di Gato Gordo al Corteguay, un paese sudamericano moltopoco noto, che trae il suo nome dal conquistatore Cortez”. L’ul-
86
BIANCIARDI, OTTOCENTO COME NOVECENTO
timo capitolo, d’altronde, commenta la fatica di tradurre di JohnBarth il libro The sot-weed Factor, un titolo non rispettato ma resocon Il coltivatore del Maryland, ricordato come “storia di Ebene-zer Cooke poeta e laureato del Maryland” (I, 1101), un libro diben altra ambientazione, che però allo sciopero del tabacco delleCinque Giornate regala, in straniamento totale, un equivalente nel-l’inglese desueto di Barth (I, 1016):
Non si deve a questo punto credere che tutti i milanesi fossero d’ac-cordo sullo sciopero del tabacco (the sot-weed strike, lo trovo definito inun testo americano), sciopero che come abbiamo veduto fu deciso lanotte di Capodanno in casa Porzio.
Nei furtivi viaggi in treno alla volta di Milano, dove non siferma a dormire per paura dell’arresto, l’esule in tenuta mimeticada ragioniere (abito grigio, camicia bianca, ma la cravatta la in-dossa solo in viaggio all’avvicinarsi del territorio nemico) metteroba pesante dentro la valigia, e non soltanto per le sudate “cartesu carte di ribaltatura”, ma, per sua confessione, pesante anche
perché c’è dentro l’alienazione quotidiana, la frustrazione, il passa-porto per Mombello, l’abbelinamento, l’imbischerimento, la rimozione,il transfert, il crampo traslatorio, la sindrome, la nausea mediana, l’ap-percezione deviata, la deformazione professionale, la minchioneria altruiche m’imminchiona.(I, 979)
Il tutto squadernato tra l’enumerazione a catalogo caotico conmacchie disfemiche (abbelinamento, minchioneria) e la figura eti-mologica (“minchioneria altrui che m’imminchiona”, strategie re-toriche abituali in Bianciardi.
Dunque i raccordi più insistiti tra la cornice e la fantastoria cen-trale risiedono nelle presunte ragioni dell’esilio a Nesci, dovute aprocessi ‘politici’ pendenti a Milano, forieri di eventuale arrestose l’esule avesse l’ingenuità di farsi riconoscere. Qui stratagemmidella fabula e ire personali dell’autore si uniscono in un pastichecomico di contemporaneo e storico, pubblico e privato. Una veraossessione polemica riveste il nome (innominato) dell’editore Va-lentino Bompiani, che aveva fatto causa davvero dopo l’uscita de
87
CONVEGNO
La vita agra e de La battaglia soda, di una ventina di eteronimiingiuriosi e osceni, declinati in dialetti e lingue diversi con feroceuniverbazione per tutto il corso del libro (duca Delasorca, Da-purchiacca, Delagnocca, Dusucunnu, Delamona, Delatopa, Du-belin, Ducon, e così via), fino all’enunciato in ricalco letterario ein code mixing (I, 1087):
Mi venivano fatti pensieri in rima baciata, come sempre mi accadequando il cervello si mette a lavorare da solo, a ruota libera, e il pensareaccresce il duolo, signor duca Delafiga, che stavolta scapi minga, mi teciapi e peu te côpi … Ma a questo punto la rima non mi venne […].
Donde fuga e occultamento di beni mobili da sottrarre al se-questro, con inganno di identità alla dogana lombardo-ligure, dap-poiché il soggetto per non farsi riconoscere dice di parlare “purogaelico, lingua studiata da me anni addietro”, con un altro rinviostraniante a La vita agra, ove un inserto in gaelico era posto inomaggio all’irlandese Brendan Behan. I procedimenti legali, chetalvolta Bianciardi patì davvero per ragioni di censura o di guaieditoriali, sono qui trasposti nel clima della rivolta civile mila-nese, con invenzione di titolari di studi legali, immessi a coppie eindicati, tra imprecazione e scherno, come Berimme e Beramme,Bachiorre e Tramanacco, oppure Zibidì e Zibidè, questi ultimi duericalcati in accezione sessual-gergale dai biblici Zebedei. La re-pulsione anarchica per le istituzioni repressive trasforma un giu-dice nell’austriacante Krauti, una portinaia delatrice nel cognomee nome Balenghi Balenga, dedotto da un epiteto ingiurioso bennoto ai milanesi. Ma realtà e scrittura si intricano ancor peggioquando colui che racconta dice di essere stato convocato dall’im-perial regia giustizia per avere mangiato una fiorentina in una trat-toria del centro di Milano. L’implicito rinvio questa volta va alracconto La solita zuppa del 1965, un divertimento parodico su unmondo alla rovescia, dove il sesso è esibito senza pudore e lagente, al contrario, si deve nascondere per mangiare (I, 975-77per il romanzo e 1679-97 per il racconto)7.
Dal quinto al tredicesimo capitolo viene seguita la falsariga deicapitoli, dal secondo all’ottavo, dei Ricordi di gioventù. Cose ve-
88
BIANCIARDI, OTTOCENTO COME NOVECENTO
dute o sapute 1847-1860 di Giovanni Visconti Venosta, testimo-nianza in prima persona, venata di umorismo, del clima morale epolitico dell’insurrezione delle Cinque Giornate, pubblicata nel1904. Bianciardi modifica di un secolo abbondante il tempo, im-mettendo, accanto a figure ottocentesche come Cesare Correnti,l’austriaco Radetzky, Carlo Cattaneo e Pio IX, molti protagonistie amici della vita culturale milanese conosciuta direttamente, daGiorgio Bocca a Domenico Porzio, da Carlo Ripa di Meana a Ca-milla Cederna: oltre a Hitler e Togliatti e fino alla sovrapposizionedi papa Giovanni XXIII a Pio IX. Cosa che per i nomi propri avevafatto con civetteria discreta ne La battaglia soda, ma senza la si-stematica caparbietà di Aprire il fuoco, dove l’intarsio tra passatoe presente ibrida la fonte, i fatti, i rinvii agli autori, alle suppellet-tili e ai costumi di due mondi e due tempi sovrimpressi, con ana-cronismo a doppia direzione. Al contrario di quanto accade nellepagine della cornice, che risultano segnate da intenti parodici ine-quivocabili, qui il bersaglio della riscrittura non è affatto l’ipotestodi Visconti Venosta, che costituisce al contrario una voce sotto-stante in dialettica positiva con quella che narra, bensì l’inerziaetico-politica contemporanea, immemore dei gran fatti del passato.
Ricordi di gioventù, testo di sfondo una volta di più non di-chiarato, è rispettato nell’andamento sequenziale dei fatti. Il nar-ratore si raffigura pedagogo di un giovinetto di nome Giovanni(Visconti Venosta, ma lo sappiamo col senno del poi!) e perciò loinserisce in una serie di azioni di guerriglia urbana condotte in-sieme a lui, maestro, contro gli Austriaci. Questo gli permette dicitare un lungo brano dei Ricordi sugli incendi della notte del 23marzo 1848 procurati dal fuoco austriaco, fingendo che si trattidi un diario scritto successivamente dall’ex-pupillo Giovanni, maancora inedito, e inframmezzando il riporto letterale con questestrizzate d’occhio al lettore sagace: “come ebbe poi a scrivere bel-lamente il mio scolaro Giovanni, e io non saprei dirlo meglio dilui”; “Giovanni rammenta nel suo diario, e a me piacerebbe ve-derlo stampato, magari fuori d’Italia” (I, 1075-77). In molti passiil lavoro di ri-creazione consiste nel sostituire sinonimi e minimevariazioni al testo di riferimento, per esempio nel dosaggio di di-scorsi indiretti e diretti, mentre altrove si procede di sintesi.
89
CONVEGNO
Bianciardi tiene a base una patina linguistica desueta e sintatti-camente proba, adatta al primo corno della doppia temporalitàmessa in gioco, 1848 insomma e non 1959: pel / pei, bargello, gen-darmi, protomedico, la grida, aio, pupillo, giovanetto, la prole, fa-vella, giulebbe, busse, donne belle e desiate, scoteva, il fatto si èche, dare la baia, con suvvi l’immagine. Ma la punteggia, questabase ottocentesca, di incursioni nel parlato novecentesco più infor-male o addirittura sboccato, nonché di certi dialettalismi lombardie termini toscani, estranei a Visconti Venosta. Lombardismi: nobi-luomini del lela, terre ballerine e terrone, le battone ‘prostitute’,bambata ‘sciocchezza’, fanigottoni ‘fannulloni’, dané, magutti‘muratori’, pirla ‘sciocco’, i rukketé ‘protettori’, con la –k- messain auge nel milanese di Gadda. Toscanismi: capecchioni ‘pessimielementi’, bischero, rena, compicciare ‘concludere’, diacciare, na-fantare ‘darsi da fare’, berciare, le busse. Senza contare la grotte-sca parlata del presentatore televisivo, romanesca pure perpronuncia (“Gari amigi bbonasera. Ci droviamo ner zalone delefe-ste annesso al deadro dele viddorie in Roma”) e gli insulti romane-schi della bella Giuditta (“’sti zozzi di tedeschi”, e così via).
Altrettanto significative sono però le dilatazioni di molti passidei Ricordi. Tutti gli episodi collettivi della “gioconda folliaeroica”, rivoltosa dal basso e senza capi militari, vengono am-pliati: lo sciopero del fumo è dilatato in due capitoli laddove lafonte era più rapida, l’idea prima dello sciopero è ambientata nellafesta di Capodanno (ma in casa di Domenico Porzio, amico di Lu-ciano e ai tempi funzionario editoriale!); i tafferugli successivi, lacostruzione delle barricate, il tentativo di presa del Broletto daparte di una folla senza più distinzioni di casta sociale sono enfa-tizzati8. Va da sé che la caduta di ogni remora sessuale e del ‘co-mune sentimento del pudore’ al cap. 11 sia farina del sacco diBianciardi, del tutto in linea con l’utopia copulatoria de La vitaagra e con l’ammirazione per le teorie di Marcuse. Trovatelli ecioè milanesissimi martinitti, allievi e professori di Brera, fornai,gentildonne, popolane nell’euforia della rivolta dal basso si dedi-cano a vigorosi liberissimi amori: “Era un vero quarantotto, anzimeglio un cinquantanove”, postilla sornione il narratore, giocandotra frase proverbiale e invenzione9. Nel frattempo abbada a con-trappuntare quel tanto di maniera ottocentesca, non priva di af-
90
BIANCIARDI, OTTOCENTO COME NOVECENTO
fettuosa pedanteria linguistica, con nomi, autori, testi, tecniche eoggetti d’uso novecenteschi, talora appena mascherati, molto piùspesso inseriti senza mediazione: dalla televisione alle lampadeal neon, dai gas lacrimogeni alla musica elettronica.
Il doppio ordine è un dispositivo a orologeria di effetto stra-niante per le temporalità intersecate. Mentre sembra garantirel’aderenza proba alla precisione storica, il narratore afferma cheil popolo milanese nel 1959, stanco delle vessazioni del “governoaustriaco, un tempo salutato da non pochi con sollievo perché po-neva termine alla dittatura fascista” (I, 1023), nella rivolta feceuso abbondante di bottiglie Molotov (anzi Scriabin dal vero nomedel loro inventore), tra auto e barricate mobili, costruite con “tra-versine di ferro, tubi Innocenti, profilati a T” e con l’ausilio es-senziale di “una fila di almeno dodici autobus dell’ATM, quasitutti col cartello della circolare interna” (I, 1068). Oltre alle Mo-lotov, si legge, un aiuto sarebbe stato fornito dalla cattura di quat-tro armi anticarro Piat di fabbricazione inglese, quelle stesse chefecero le meraviglie durante l’operazione di Arnhem, “anche senon bastarono a salvare gli airborns dalla soverchiante massa te-desca” (I, 1063). La fonte di tanto aggiornata competenza bellicaè ancora una volta un’opera tradotta e non esplicitata qui, Il fla-gello della svastica di E.F.L. Russell, approntata da Bianciardiper Feltrinelli nel 1955, con il resoconto della battaglia di Arnhemdel 1943, che finì male per gli inglesi.
Al capitolo 5 il pedagogo intento a citare e postillare passi diDante, Tasso, Metastasio e Manzoni, a un certo punto recita ai pu-pilli Agro inverno di Francesco Lattes, cioè di Franco Fortini (I, 991):
un buon esempio di poesia civile, tale cioè da esprimere il sentimentopoetico dell’autore non già nel vuoto, ma nel contesto e nel rapporto suocon una determinata società. […] Dove infatti può pensarsi un invernoagro, se non a Milano?
L’interrogativa retorica finale, con l’aggettivo agro in accezionesemantica toscana anche in Fortini, suona commento al titolo dellibro più famoso di Bianciardi stesso. In un tale terremoto crono-logico e linguistico di nuovo brilla l’amore per la variante toscananella sua qualità fondativa e unitaria per l’Italia; norma perdente
91
CONVEGNO
nella Milano del 1959, ove invano il maestro tenta di insegnare airagazzi che il pasto di metà giornata si chiama desinare e non co-lazione, mentre deve rassegnarsi che il cappotto venga chiamatoalla francese paletò e il cacio sia sempre e solo formaggio.
Quanto al pensiero politico e alle discussioni che precedono larivolta, gli slittamenti cronotopici sono infiniti. Ai fautori diun’Italia una, libera e repubblicana viene attribuita ad emblema“la cosiddetta linea emme, cioè la lettera iniziale dei nomi dei teo-rici a cui essa parte si rifaceva, e cioè il Mazzini, il Marx, il Mao,il Min e il Marcuse”. Ai sostenitori di una guerra di popolo perbande soccorrono contemporaneamente l’autorità “del Pisacane,del dottor Guevara”; mentre chi predica la resistenza passiva sirifà nientemeno che a Gandhi e ad Aldo Capitini. In polemica conun amico, colui che narra sostiene che Dante “fu obbiettivamenteun innovatore”, ma si sente contestare così: “Tu parli come sefossi il Lukacs. Spiegati meglio!” (I, 1050).
La vocazione mistilingue di Bianciardi si scatena: tessere te-desche (Polizei, das Zuchthaus, Herr Doktor, Kreditbank, es wahralles verboten); enunciati in un italiano storpiato da barzelletta inbocca agli austriaci, allo scopo di mantenere l’isotopia pseudo-storica: “Dunkve kvesta bizikletta? Di ke kolore era, la biziklettarubata? Kvanto era lungo telaio? Kvanto grosse rote?”; la casaeditrice Feltrinelli si fa ditta austriaca Filz und Filzelein, con in-terpretazione semantica del nome proprio (feltro-filz). Il fuoco difila giocato su diverse lingue punta anche sul latino del giure edecclesiastico, in solidum, quid sit justitia, institutus personae, urbiet orbi, descendat super vos et maneat semper; ma non mancaquando sia il caso di darci un esempio del latino di chi non lo sa,dato che gli orfanelli di Nesci ai funerali con il Requiem “reci-tano la perpetua Lucia Dei” (I, 937)10.
Per colmo di spiazzamento non si nega una bibliografia ingleseper la ‘rivoluzione’ milanese, silenziata dalla stampa italiana conla classica damnatio memoriae. Come si è detto sopra, lo scioperodel tabacco è anche indicato come the sot-weed strike, mentrel’oscuramento dei fatti milanesi da parte della storiografia italianasarebbe compensato dalla pubblicistica anglosassone! (I, 1088).
92
BIANCIARDI, OTTOCENTO COME NOVECENTO
Diciamolo. Per il carattere cifrato del riuso delle fonti e delleallusioni a fatti e scritti propri, il romanzo potrebbe essere giudi-cato (e da alcuni lo è stato) un estremo esito manieristico, ripeti-tivo e alquanto a chiave rispetto alle procedure per così dire piùfresche de La vita agra. Ma bisogna tenere conto che fu scrittonel 1968, quando la protesta studentesca sembrava preludere auna rinascita rivoluzionaria e il raccordo con certi episodi del Ri-sorgimento, da sempre cari a Bianciardi e già presi in carico ne Labattaglia soda, voleva atteggiarsi a suggerimento di strategia diazione permanente (imperativi categorici: non ricostituire nuoveistituzioni di governo, ma tenere fermo il movimento dal basso,non occupare le Università e altri luoghi simbolici, ma le banche,vere cattedrali del mondo finanziario, occupare e zittire la televi-sione); voleva anche mettere in guardia dalla repressione, cheavrebbe profittato di ogni errore. Sarà un caso, ma è bene ricor-darlo: la strategia della tensione è iniziata in Italia, poco dopol’uscita di questo libro, con i fatti milanesi di Piazza Fontana. Ilche conferisce tempestività e quasi forza profetica all’anarchismoprotestatario di Aprire il fuoco.
Del resto già molti anni prima Bianciardi nell’articolo “Rivo-luzione a Milano” (1956) fingeva di ammirare il senso ambro-siano dell’ubbidienza - rispetto degli orari, riserbo nei tram,decoro nell’abbigliamento – ma in realtà del perbenismo mila-nese satireggiava il rigore, incitando alla disobbedienza i citta-dini, divenuti marziani saltabeccanti da un marciapiede all’altro,disposti a far l’amore all’alba del lunedì, notoriamente primogiorno di lavoro della settimana, e concludendo con questa ipotesispericolata e anarchica di rivoluzione (II, 800):
Mi occorrono mille uomini spregiudicati, decisi, ben addestrati. Milleuomini disposti a scendere dal tram in corsa, a passare col rosso, a can-tare nei giorni feriali, a far capannello nelle vie del centro.
Un commento a posteriori è invece “E se la rivoluzione fossegià scoppiata?” dello stesso 1969, dove le occupazioni di edificie le contestazioni alla prima della Scala da parte degli studenti ri-portano alla mente dell’articolista, che non a caso si autodefinisce
93
CONVEGNO
un Marcusalemme, la rivoluzione di Milano del 1848, per l’ap-punto trasposta da poco nella rivolta milanese del 1959 (II, 1544).
Nel nucleo fantastorico centrale la citazione letteraria, al di làdegli inserti ‘pedagogici’, è appena stilizzata, mette cioè in motouna memoria senza parodizzarla, in asse con il referto e il climapositivo della rivolta, se l’eroica cittadinanza milanese la dome-nica leopardianamente “va a passeggio, e mira ed è mirata e incor s’allegra” e più in là “ciascuno se ne andò alla sua mensa,fosse questa parca o sontuosa, di olio o di lardo” (I, 1017 e 1019).Sintomatico questo atteggiamento, del tutto diverso dal taglio pa-rodico che governa i capitoli di cornice, successivi si fa per direalla repressione ‘austriaca’.
Invece nell’esilio di Nesci si squaderna senza pietà la parodialetteraria che degrada il nobile in meschino, l’autorità di testi il-lustri nello sberleffo nichilistico della contestazione, modificandoe irridendo passi ben noti dei poeti, con un uso beffardo della me-moria letteraria. Il bersaglio della parodia, che è sempre atto cri-tico nei confronti del testo parodiato, è anche la letteratura, nellasua doppia valenza di memorabilità condivisa e di resa attuale al-l’insignificanza. Il testo ospitante menziona e carnevalizza, con-sapevole della messa a nudo della convenzionalità condensata neicitati (cfr. Hutcheon e Tynjanov).
Al limite del virtuosismo, la passeggiata iniziale sul lungomare,condotta al tempo presente come quasi tutta la cornice, tematizzail “diverso esilio” del protagonista a confronto-scontro con quellodi A Zacinto del Foscolo. Evidente la sproporzione tra il fosco-liano e omerico Ulisse, lontano da Itaca, e il rivoluzionario man-cato a Rapallo, una dismisura che si ribatte dopo qualche paginanell’analogia tra le “palme che io tendo, deluse, a voi, amici” e ilfamoso “ma io deluse a voi le palme tendo” del sonetto fosco-liano in morte del fratello Giovanni. Nell’ultimo capitolo, con rac-cordo ciclico rispetto all’inizio del libro e accostamento tonaleancor più dissacrante tra alto e basso, è sollecitato di nuovo A Za-cinto: “Oh, non mai toccherò le sacre sponde! Tra poco il miocorpo, non più fanciulletto, giacerà sul Permaflex”. Sarà un casoche Ugo Foscolo risulti uno dei bersagli più attivi, esattamentecome lo fu per lo scrittore italiano del Novecento più amato da
94
BIANCIARDI, OTTOCENTO COME NOVECENTO
Bianciardi, quel Carlo Emilio Gadda che in molti passi e soprat-tutto in Il guerriero, l’amazzone, lo spirito della poesia nel versoimmortale del Foscolo si accanì contro l’autore dei Sepolcri. Nel-l’ultimo capitolo, d’altronde, la polemica colpisce San Martinodel vate Carducci sulla stessa base razionalistica con cui Gaddanella Cognizione del dolore coglieva in difetto di nozioni geogra-fiche l’autore della Canzone di Legnano: “se tu m’inquadri nellasoggettiva del cacciatore gli stormi d’uccelli, me li devi poi rac-contare come un possibile bottino, e non com’esuli pensieri. Dicobene? Gli esuli pensieri li abbiamo tutti noi due nel capoccione”.
Ma torniamo alla cornice nescitana. L’occhio capta i relitti get-tati sul bagnasciuga dalle onde invernali, simboli di deiezioni cao-tiche, ma è la mente ad associare spesso per puri richiami delsignificante, se le “morte stagioni” dell’Infinito leopardiano nonsono più le ‘epoche lontane’ ma le stagioni in senso meteorologicoe turistico, il “tepidario lustrante” di Caffé a Rapallo di Montale siaddice all’obitorio e non ai ritrovi eleganti cari a Camillo Sbarbaroe commemorati dalla poesia montaliana. Il monologante, nella pas-seggiata, fa il contrario di Proust e Svevo, è un io opaco tutto estro-flesso, che registra, scompone e rivomita, proprio come il mare coni relitti buttati alla rinfusa sulla spiaggia: il pescesega conduce al-l’excursus sull’autoerotismo e sulla svolta edonistica della civiltà;la razza, intesa come pesce (con la –z- sonora) evoca la razza conla consonante sorda e il connesso razzismo; la testudo di mare ri-porta la testudo come formazione militare e perfino la Tartuca con-trada di Siena, in un gioco al massacro che non rinuncia a nessunaprocedura distruttiva, dall’enumerazione caotica alla figura etimo-logica, dal calembour al montaggio di materiali eterogenei11.
In questa passeggiata-sproloquio piena di segmenti dialettaliliguri che creano un fantasma di conversazione, i pezzi forti sonole enumerazioni parodiche, che convogliano in uno stesso effettoannientante oggetti, nemici personali, opere musicali e personaggiletterari, richiamati per ecolalia e rifiutati in blocco dalla delu-sione agra dell’esule:
Dunque io li sbatto fuori, Metello e Bube, Lolita, la signora Chatterley eil signor Goldfinger, l’Italia dei secoli bui, gli italiani in generale, in partico-
95
CONVEGNO
lare i milanesi, i bolognesi, i genovesi, sempre a tavola si capisce, e poi Dia-bolik, Menelik, Angelik, Feltrinellik […]12
Alla fine della famosa passeggiata, su un andamento di fila-strocca Bianciardi tra l’altro liquida, senza nominarne gli autori edissimulando con il carattere minuscolo le opere messe in fila persomiglianza di titoli, La luna è tramontata di Steinbeck, La lunae i falò di Pavese, La luna e sei soldi di Somerset Maugham, Il redella pioggia di Bellow, da lui tradotto per Feltrinelli nel 1959, Ilre deve morire di Renault, tradotto per Bompiani nel 1959, Cioc-colato a colazione di Moore, L’onda dell’incrociatore di Qua-rantotti Gambini. Vale la pena citare per esteso questo outing dirifiuto della letteratura, che mai prima in Bianciardi si era mani-festato in forma così disperante (I, 940):
Cincin tre fiaschi di vin, anzi di pane e vin, una la luna, la luna è tra-montata, la luna e i falò, la luna e sei soldi, due il bue, tre un bacino allafiglia del re, il re, s’intende, della pioggia, oppure quello che deve mo-rire, quattro la spazzatura del gatto, il gatto con gli stivali in edizionecartonata e plasticata, da regalare per la Befana, cinque lo cioccolato acolazione, sei l’incrociatore Potiomkin, oppure meglio l’onda dell’in-crociatore con la sua brava quarantanovesima gambina […].
Se così fosse per l’intero libro, se ne dedurrebbe una dose mas-siccia di qualunquismo bitinicco, arrabbiato e milleriano, la liqui-dazione totale di ogni valore. L’autore invece, mentre in aperturabutta dalla porta la letteratura, la fa rientrare dalla finestra quandol’applicazione a oggetti polemici pressanti la possa attivare comemezzo di contrasto. Nella Milano corrotta dal consumismo, doveora “i sudditi marciano inquadrati e coperti” da incrementi del red-dito incoraggianti, e tutti si dedicano al consumo, tutti si commuo-vono davanti ai prodotti e assimilano quotidianamente i messaggidella pubblicità televisiva, Bianciardi sottolinea gli espedienti ba-nali dei pubblicitari, rime stucchevoli in “ino, oppure one, le rime inato, eto, ito, oto, uto, tutti participi passati, bella forza, poi tutte quellerime baciate in are, ere, ire, tutti verbi all’infinito”, frasi che diven-tano proverbiali in forza di sottrazione semantica. E cita allora lapoesia perfetta, non vaticinante di Giorgio Caproni e provoca alla
96
BIANCIARDI, OTTOCENTO COME NOVECENTO
competizione i gentili pubblicitari: “Provatevi a scrivere anima miava’ in fretta, prendi la bicicletta, queste sì che sono rime meritorie eazzardose”, da Ultima preghiera dei Versi livornesi13, la cui prota-gonista Anna Picchi viene ricordata in una sorta di ubi sunt all’ini-zio dello stesso capitolo di chiusura: “Dove sarà più, Anna Picchi?”.
Non si dimentichi che nel 1961 Bianciardi aveva tradotto i saggidi Ritorno al mondo nuovo di Aldous Huxley, una ripresa del BraveNew World contro la propaganda pubblicitaria e il benessere cheopacizza. Tra Marcuse e Huxley stanno molti spunti polemici degliscritti giornalistici, che contestano l’ottenebramento del ritornellopropagandistico e la censura o l’informazione manipolata della TV,il cui potere dittatoriale suggerisce in Aprire il fuoco il sabotaggioe la definitiva chiusura degli studi milanesi di Corso Sempione.Dopo le banche, “il secondo impeto si farà contro la televisione[…]. E anche in questo caso niente occupazione permanente […].No, la televisione va spenta”. Se diamo un’occhiata alle varie ru-briche tenute su Le Ore, ABC, Playmen e alla serie rubricata “Te-lebianciardi” già sull’Avanti!, ci troviamo lo scontento per lo scarsoimpegno civile ed educativo del servizio pubblico e soprattutto cri-tiche al linguaggio di questo “convitato di vetro” che si insinua nellecase e atrofizza il senso critico, invettive paragonabili a quelle coevedi Pasolini contro la neolingua italiana omologata dal triangolo in-dustriale, dalla politica e dai perbenismi della TV, con le parole rea-listiche da evitare (coscia, amante), il gusto dell’espressione astrattae burocratica, insomma una lingua gracile, povera e imbastarditaanche dalla cattiva pronuncia e da innaturali scansioni delle paroleda parte degli annunciatori14.
Il sosia autoriale che regge Aprire il fuoco, mentre sembra solofar fuori ogni credibilità narrativa, tra giochi delle criptocitazioni eframmentazione del percepito, lavora in realtà sul cardine dialet-tico della parodia, cioè sulla convivenza di due atteggiamenti op-posti in compresenza e dialogo perpetuo. Da un lato la critica versouno sviluppo senza progresso, presagio di una civiltà di automi pas-sivi e omologati; dall’altro l’istanza etica di dare comunque un con-tributo all’oroscopo del futuro, un contributo nascosto entro lamaschera amara e comica di una parola in esilio. Per questo Aprireil fuoco è, a mio parere, un libro di straziante attualità, assoluta-mente da rivalutare.
97
CONVEGNO
Bibliografia:
ANGELINI:M.C. Angelini, Bianciardi e Visconti Venosta, in Studi per Eliana Cardone,
a c. di G. Arbizzoni e M. Bruscia, Università di Urbino, 1989, pp. 327-46.BACIGALUPO:M. Bacigalupo, Henry Miller in Italia: i “Tropici” di Bianciardi, in Carte su
carte di ribaltatura. Luciano Bianciardi traduttore, a c. di L. Bianciardi, Fi-renze, Giunti, 2000, pp. 114-28.
BIANCIARDI:L. Bianciardi, L’antimeridiano. Opere complete, Vol. I e II, Milano, ExCo-
gita ISBN Edizioni, 2005-2008 (i rinvii delle citazioni sono a I oppure II, se-guiti dalla pagina).
BRUNI:A. Bruni, Il lavoro culturale, in Luciano Bianciardi tra neocapitalismo e con-
testazione, a c. di V. Abati, N. Bianchi, A. Bruni, A. Turbanti, Roma, EditoriRiuniti, 1992, pp. 45-67.
CALVINO:I. Calvino, Una pietra sopra. Discorsi di letteratura e società, Torino, Ei-
naudi, 1980.COMPAGNON:A. Compagnon, La seconde main ou le travail de la citation, Paris, Seuil, 1979.CORRIAS:P. Corrias, Vita agra di un anarchico. Luciano Bianciardi a Milano, Milano,
Baldini & Castoldi, 1993.FERRETTI:G. Ferretti, La morte irridente. Ritratto critico di Bianciardi, uomo, giorna-
lista, traduttore e scrittore, Lecce, Manni, 2000.GADDA:C.E. Gadda, Tendo al mio fine, in Il castello di Udine (1934), Torino, Ei-
naudi, 1975.GRIGNANI:M.A. Grignani, «Aprire il fuoco»: epilogo di una scrittura in esilio, in il verri,
n. 37, giugno 2008, pp. 5-30.GUERRICCHIO:La vita agra, in Luciano Bianciardi tra neocapitalismo e contestazione, cit.,
pp. 69-87.HUTCHEON:L. Hutcheon, L’estensione pragmatica della parodia, in Dialettiche della pa-
rodia, a c. di M. Bonafin, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 1997, pp. 75-96.RINALDI:R. Rinaldi, Bianciardi: Approssimazion ad una letteratura perversa, in Id.,
Il romanzo come deformazione. Anatomia ed eredità gaddiana in Mastronardi,Bianciardi, Testori, Arbasino, Milano, Mursia, 1985, pp. 31-62.
SEGRE:C. Segre, Punto di vista, polifonia ed espressionismo nel romanzo italiano
(1940-1970), in Id., Intrecci di voci. La polifonia nella letteratura del Nove-
98
BIANCIARDI, OTTOCENTO COME NOVECENTO
cento, Torino, Einaudi, 1991, pp. 27-44.TERROSI:M. Terrosi, Bianciardi com’era. (Lettere di Luciano Bianciardi ad un amico
grossetano), Grosseto, Il paese reale, 1974.TYNJANOV:Ju.N. Tynjanov, Sulla parodia, in Dialettiche della parodia, cit., pp. 25-47.
1 Lettera a Galardino Rabiti, riportata da M.C. Angelini, Bianciardi, Firenze,La Nuova Italia, 1980, p. 7.
2 La ripresa nel romanzo, come spesso nel riuso che Bianciardi fa dei propriscritti, è quasi letterale: “la faccia del ragioniere in camicia bianca, con gli occhistanchi di sonno già alle otto del mattino, talvolta i baffetti, sempre due solchiprofondi che partono da sotto le occhiaie bluastre e arrivano agli angoli dellabocca […]” (I, 652).
3 Cfr. L. Baldacci, “Narrativa senza romanzo” (1963), in Trasferte. Narratoristranieri del Novecento, Milano, Rizzoli, 2001, pp. 283-92, dove un accenno aLa vita agra è inserito nel più vasto quadro europeo di crisi (Mann, Musil) del“rapporto tra il narratore e gli strumenti della narrazione o la sua stessa narra-zione in atto che si pone, a un dato momento, come altro dalla coscienza e dalmondo intenzionale e, finalmente, segna lo scacco di quel mondo medesimo” (p.284).
4 “Dialogo con Tortora”, II, 1708.5 Per la traduzione di Bianciardi e la prima ricezione di Miller in Italia si
veda Bacigalupo.6 Un autobiografismo perverso, allusivo alle opere precedenti e soprattutto a
La vita agra, segna l’intero libro: il narratore dice di essere imputato a Milano peravere pensato di attentare al torracchione, menziona sue minute abitudini quoti-diane nelle analogie o differenze rispetto a un allora che si legge soltanto ne Lavita agra, certo il romanzo più noto. Al cap. quarto l’esule immagina di esserestato denunciato per linguaggio licenzioso, rifacendosi in realtà senza dirlo al rac-conto Il peripatetico del 1961, dove si salutavano le rotondità posteriori di certeragazze, ben in vista nello sguancio di una finestra, con un “Buon giorno, cu-lini!” (per il racconto cfr. I, 1595). Questo il commento: “Il pretesto lo sanno tutti:quei tali culini a cui diedi il buongiorno un lontano dì del 1961. Pensa un pococosa sono andati a scovare, a quale appiglio si sono tenuti” (I, 977). Ulteriore im-plicazione con un proprio racconto si legge nell’ultimo capitolo per l’accenno al-l’occhio di vetro di una macchina fotografica made in Japan, munita di self timer,con cui il narratore inquilino e la padrona di casa riprendono le proprie esibizionisessuali. Il complesso di Loth, coevo alla stesura del romanzo, si aggira sulla pa-tologia, tra voyeurismo e esibizionismo, di un musicista che si appassiona a fotoerotiche appunto “con l’autoscatto. Lo chiamano self-timer, che si potrebbe tra-durre, ma sarebbe brutto, auto-tempeggiatore” (I, 1807-13).
99
CONVEGNO
7 Per Il peripatetico cfr. la nota precedente.8 In Angelini schedatura ampia e raffronto tra i due testi.9 E più avanti: “Dottore, dottore, che giornate! Avevo temuto per lei, con tutto
questo quarantotto che era capitato a Milano” (I, 1072).10 G.L. Beccaria, Sicuterat. Il latino di chi non lo sa: Bibbia e liturgia nel-
l’italiano e nei dialetti, Milano, Garzanti, 1999, pp. 40 e 71.11 Di “io opaco” parlano giustamente M. Coppola e A. Piccinini nell’intro-
duzione al primo volume dell’Antimeridiano.12 Il mare espelle, insieme a bottiglie, scarpe, preservativi, bambolotti senza
le braccia, gatti morti, polpette di alga, turaccioli, “una rara edizione dei poeti ga-lanti del Settecento, come per esempio il Rolli, il Metastasio, l’abate Casti, ilFrugoni, il Crudeli, il Savioli, il Bertola, il Vittorelli, tutti quanti a cura di G.Carducci, vate maremmano (…)” Sul lungomare, sopra le statue dei musicisti,prendono quota a piramide in cielo i personaggi delle opere “igari, castrati, tu-bercolotiche, italiane in Algeri, lombardi alla prima crociata, angioloni, mignatte,mori, madonne, liuti, lance, scimitarre, barboni, tette, trombe, bandiere, scettri,cavalli, zingarelle, briganti, paggi, ricchioni (che in dialetto significa bulici)” (I,932-34).
13 La citazione, approssimativa, è di: “Anima mia, fa’ in fretta. / Ti presto labicicletta”.
14 Ecco i programmi che non ‘finiscono’ ma terminano e per conversoavranno inizio, i mesi primaverili ridotti a mesi preestivi, i malati sostituiti daipazienti o degenti, la particella affermativa camuffata in esatto (“Neo-italiano fa-cile”, in ABC, 14 agosto 1966); cfr. anche “Censura e protesta”,” Le pause sba-gliate”, “Vedere la lingua” (II, 1359, 1214-16, 1624-26), dove l’amore per lanitidezza dell’italiano va di pari passo con l’amore per una pronuncia corretta.Una scelta della critica televisiva è in Il convitato di vetro. “Telebianciardi”,Milano, ExCogita, 2007, prefazione di P. Pasi.
100
BIANCIARDI, OTTOCENTO COME NOVECENTO
Paolo Maccari
Un intruso nel sessantotto:il Risorgimento di Bianciardi in Aprire il fuoco
Scorrendo l’opera di Bianciardi, colpiscono il disaccordo la-cerante tra i suoi personaggi e il proprio tempo, che emerge cometema e motore principale, e la frequenza con cui, in varie guise, sievoca e utilizza un Risorgimento amato e maneggiato con singo-lare perizia; colpiscono al punto da imporre questo interrogativo:Bianciardi è stato un uomo dell’Ottocento in quanto a strutturamentale, a modi di reazione di fronte alla realtà?
Sappiamo che la sfasatura temporale tra carattere e ambiente haspesso elargito ai nostri scrittori fruttuose nevrosi; al limite, esplo-sive schizofrenie.
Chi non ebbe nessun dubbio nel dichiararsi nato in un temposbagliato, e fedele al secolo di cui vide soltanto gli ultimi setteanni, è uno degli autori stimati tra i più grandi del Novecento: quelCarlo Emilio Gadda che visse come un perenne shock il dinami-smo caotico dei suoi anni. Il continuo rimando manzoniano, peril nevroticissimo gran lombardo, appare come un rimpianto e unrimorso. E, come è noto, si tratta di un caso tutt’altro che isolato.
Non so se il Novecento sia stato, rispetto ad altri, un secoloparticolarmente inospitale: certo ha avuto il triste privilegio disperimentare forme nuove e inusitate di tormento, di paura e di in-certezza, assegnando agli intellettuali che lo hanno attraversatoun compito impari quando ha chiesto loro di interpretarlo in presadiretta. La nostalgia del passato, di un passato, non coincide, neimigliori, con la dimensione idillica e consolatoria dell’infanzia,bensì con una dimensione dell’essere meno insidiata dal dubbio,che più risponda, sempre nei migliori, a una domanda di massi-malismo etico, se vogliamo di moralità assoluta, che nella granmacina del cosiddetto secolo breve si è scontornata in un’imma-gine fluttuante, dai margini sfuggenti.
A questo riguardo, per avvicinarmi un po’ di più alla domandainiziale, e insieme svilupparla secondo una direttrice di ricercaaperta ad altre implicazioni, vorrei citare una poesia di Giovanni
101
CONVEGNO
Raboni, composta sul finire degli anni cinquanta (lo specifico per-ché siamo in epoca bianciardiana e siamo oltretutto a Milano):
Una volta1
Di gente ricca soloCoi bachi e le filande credoNon ci sia più nessuno: ma una voltanel Comasco o a Bergamo, da doveviene la mia famiglia,molte fortune si contavano a gelsio con quante ragazze venivano a filarei bozzoli scottati per ammazzare le farfallenelle fredde officine. Se pensoa chi è la gente ricca adesso, a cosagli costa il capitale, alla faticache fa per arrivare dove creded’essere molto in alto,mi convinco che tutto si complica, anche il male.Una volta le colpe dei padronierano così semplici: chi sfruttail prossimo e lo paga troppo poconon può far peggio. Ma adesso, chi saràche sbaglia? chi vuol troppo, chi approfittadella povera gente?Forse ogni cosa è proprio da rifare,l’ingiustizia è nell’aria. Il padroned’oggi, il consiglio d’amministrazioneo il gruppo di maggioranza, è un peccatoreun po’ troppo sui generis per me…
Tutto si complica, anche il male; e ancora: l’ingiustizia è nel-l’aria (l’aria di Milano in pieno boom). Non credo di dover giu-stificare questa lunga citazione, tanti sono gli elementi chel’avvicinano alla sensibilità di Bianciardi e ai suoi pronunciamentisulla società contemporanea. Ciò che mi interessa peraltro sotto-lineare è quanto sia funzionale al giovane Raboni istituire, pro-prio su un piano politico di piena transitività, un raffronto tra due
102
momenti storici divisi non tanto da un maggior o minor male, dauna maggiore o minore sofferenza: piuttosto, da chiarezza e op-portunità di comprensione morale degli schieramenti assai di-verse. Raboni si riferisce al mondo contadino d’inizio Novecento,o giù di lì: a lui nato nel ’32 si offriva questa opzione di cultura edi ottica, trattandosi di un tempo abbastanza lontano per non es-sere venato di nostalgia esistenziale e insieme abbastanza vicinoda prestarsi ai racconti di chi lo ha sperimentato.
Ora, il rimpianto di Raboni risulta una presa di distanza che sipone anche come polemica anti-culturale: il bianco o nero di al-lora si è perduto nelle brume delle sottili disquisizioni ideologichedel dopoguerra. La polemica contro una cultura che sembra com-plicarsi per autoalimentarsi è affine a quella di Bianciardi, ma te-nendo conto di questo fondamentale distinguo. Il venticinquenneRaboni di fine anni cinquanta non ha conosciuto se non bambinoil terremoto della guerra, della Liberazione, del Dopoguerra. Lasua buonafede e la sua ansia di linearità politica giungono, e nonse ne può fargliene una colpa, après coup.
Bianciardi invece ha vissuto e patito una feroce disillusione: sela Resistenza è stata valutata da molti come il completamento del-l’avventura risorgimentale, occorre rilevare che per moltissimialtri ne fu il tradimento, una vittoria mutilata, questa sì, che hacreato un compromesso, non ancora storico, che frustra gli entu-siasmi e le energie dei giovani migliori.
Una disillusione da cui tanti nostri scrittori non hanno saputoriprendersi e rimotivarsi. Non è il caso di Bianciardi, e quantun-que i suoi libri precedenti lo avessero ampiamente dimostrato, conAprire il fuoco2 ne abbiamo una straordinaria conferma. Dire,come mi verrebbe fatto, che è il libro della sua compiuta maturità,suona probabilmente ingiusto rispetto a La vita agra3 o a L’inte-grazione4: soprattutto aumenta il rimpianto per la morte precocedi un talento al momento della sua pienezza espressiva.
In ogni caso, questo testo inclassificabile, che non si sa comechiamare – romanzo, pamphlet politico, confessione in maschera,utopia retrospettiva, modernissimo pastiche, e chissà cos’altro –testimonia non solo delle doti rarissime dello stilista (non in ac-
103
cezione entre deux guerre, beninteso), ma anche della felicità diuna narrazione che segna al contempo il massimo di amarezza.
Quando discorre delle diverse fazioni unite intorno al fine co-mune di cacciare l’oppressore, nella Milano del 1959-1848, Bian-ciardi ha gioco facile, ma non per questo meno ardito esuggestivo, nell’istituire una rassegna cronologicamente diso-rientante che aggredisce con la satira le idee ricevute, i confor-mismi, i cinismi e le ipocrisie che caratterizzano l’Italia daldopoguerra fino agli anni sessanta. Gioco facile, e affascinante.C’era chi avrebbe voluto che “gli italiani si federassero sotto l’altaguida spirituale del Sommo Pontefice”; altri concordi lungo “lacosiddetta linea emme, cioè la lettera iniziale dei nomi dei teoricia cui essa in parte si rifaceva, e cioè il Mazzini, il Marx, il Mao,il Min, il Marcuse”; qualcuno “voleva la guerra regia sotto il mo-narca Tentenna, e magari con l’aiuto dei Francesi”; altri ancora
come i seguaci del Togliatti, giuravano che a fare l’Italia si sarebbe ar-rivati con la semplice scheda elettorale, gradualmente e progressiva-mente […]. Affermavano inoltre costoro che si potevano trovare i modidell’alleanza con il clero – e qui, vorrei sottolineare, altro che anni ses-santa: siamo al 2008 – ora che alla guida c’era quel sant’uomo di papaGiovanni XXIII, e difatti tu li vedevi spesso frequentare le sagrestie,prendere parte alla via crucis, battezzare solennemente la prole, battersidi continuo il petto a contrizione dei propri peccati, salmodiare digiu-nando al venerdì, ma era tutta fatica sprecata perché il clero li sbeffeg-giava regolarmente. C’erano di quelli che chiedevano la guerra perbande, e a sostegno citavano l’autorità del Bianco, del Pisacane, del dot-tor Guevara, e del Giap. Si doveva, secondo questi ultimi, armare furti-vamente la plebe, suddividerla in ordinati scaglioni, ciascuno col suocapo, spargerla per la città e per il contado […]. Altri ancora andavanopredicando la resistenza passiva e la non violenza e citavano a confermail mahatma Gandhi e il professor Capitini: rifiutarsi di pagare le impo-ste, smettere di fumare, abbandonare i posti di lavoro per dedicarsi sol-tanto ai piaceri della carne […]. Venivano costoro chiamati irivoluzionari del non, ma a me sembrava che intanto predicassero benee razzolassero, come suol dirsi, male, perché li vedevo laboriosissimi, ri-spettosi degli orari, faticatori anche al sabato sera. (pp. 108-109)
104
BIANCIARDI, OTTOCENTO COME NOVECENTO
Ora, quel che colpisce è che l’elencazione, caotica davvero, diBianciardi non risparmia nessuno, per tutti ha una sferzata. In altreparole, il variegato panorama di schieramenti gli suscita, secondovarie gradazioni, uno stesso modo di ripulsa. Ciò che manca, chegli manca, io credo, è, di nuovo, una misura di chiarezza e di se-rietà: Bianciardi non crede allo spasso della rivoluzione e ha inprofonda antipatia la moda della rivoluzione, il passatempo dellarivoluzione come palliativo per la coscienza di una società che ri-mane ingiusta e, nell’intimo, contenta di esserlo. La guerra e laResistenza sembravano aver illimpidito il contesto, rese leggibilile varie posizioni. Invece tutto, nuovamente, s’intorbida, e il ne-mico può avanzare silenzioso e poi protervo. La nostalgia del pas-sato, che si inserisce in questo quadro, non corrisponde affatto,come per altri, a rifugio nel passato, a sdegnoso disinteresse peril tempo proprio.
Il suo Risorgimento è un indice di reazione al presente. E se peresempio assumiamo a riscontro l’archetipo leopardiano, subito lamente correrà a una lettura progressiva della Ginestra; forse, pe-raltro, sarebbe più opportuno citare il battagliero fustigatore deibenpensanti che risponde a un’intera cultura con la Palinodia. Alladomanda iniziale, se Bianciardi sia da considerare, in quanto astruttura del ragionamento e a ideali un uomo dell’Ottocento, ri-sponderei dunque di no: poiché il suo sguardo è troppo prensile elucido e partecipe. Il suo tempo l’ha vissuto fino in fondo con unapassione che esclude il disinteresse di certi scrittori serrati nel-l’inattualità come in un confortevole liquido amniotico. Bianciardinon ha vagheggiato il Risorgimento per sfuggire alle brutture dellasua epoca, bensì come arma, come acido, come denuncia.
Aggiungo che, così come ho parlato di nostalgia di un determi-nato passato, si può parlare di nostalgia di un determinato futuro.
Bianciardi ha nostalgia del futuro che spettò in sorte di sperareai Mille, o agli uomini delle Cinque giornate, quando il fine erachiaro e raggiungibile, prima della delusione, del disincanto, diuna consapevolezza etico-politica che per forza ricaccia l’individuodentro se stesso. L’iracondo Bianciardi prova intimamente rabbianon solo, o non tanto, verso i nemici; piuttosto verso chi non seppe,per un difetto di fede, sconfessare il prevedibile, la scontata scon-fitta. L’intelligenza con il nemico, che tra l’altro è il titolo di una
105
CONVEGNO
poesia di Giovanni Giudici di anni vicini, è una costante del libro,e uno dei motivi più forti di polemica e di scoramento:
Per esempio, se mi esce subito il re è un pessimo segno, vuol dire chel’oppressore ci sta addosso peggio che mai, che non ci sono buone spe-ranze di liberarsi dal giogo straniero, che i fratelli ancora patiscono epatiranno, o all’opposto, che forse non patiscono più, che ci si sono abi-tuati, o, peggio ancora, che magari ci si ingrassano, sotto l’oppressore,ci vanno a cena insieme, con l’oppressore. (p. 50)
Aprire il fuoco, s’è detto, ha il pregio di non risparmiare nes-suno; pregio ancora maggiore perché al contempo, in questa sortadi summa della cultura contemporanea italiana, vista attraversouno sguardo ironico ma anche fortemente negativo, convoca ognitipo d’intellettuale, con un’apertura d’interessi che non risulta innessun altro dei suoi libri: narratori e poeti, musicisti e pittori, so-ciologi e giornalisti, politici e cantanti. Alcuni riferimenti sonopieni di senso, per esempio quello a Franco Fortini e alla sua poe-sia civile, altri invece si inquadrano nella logica di un puro e scan-zonato divertissement, come quello a Piero Chiara5. Siamo cioè difronte a uno stile comico, talvolta in accezione comune, ma piùche altro in quella dantesca di molteplicità di registri.
Naturalmente, attingendo a piene mani alla vicenda delle cin-que giornate milanesi, Bianciardi non ha scordato lo stile risorgi-mentale de La battaglia soda. Esemplificare è quasi inutile, speciedopo il puntualissimo intervento di Maria Antonietta Grignani:mi limiterò a segnalare, tra gli innumerevoli macro, un tipico mi-croevento stilistico come l’inversione classicistico-nobilitante: “ri-masti che fummo soli” (p. 94).
A questo proposito, vorrei soffermarmi brevemente sul primocapitolo, caratterizzato da un scrittura quasi automatica, joyciana,un vero pezzo di bravura, gremito fin dalla prima pagina di rife-rimenti risorgimentali: intenderlo come un momento staccato, in-coerente rispetto al resto del romanzo, a mio avviso non è esatto.Si tratta di pagine di ouverture, che intonano modernamente,quindi facendo perno sull’arte della dissonanza e della divaga-zione, la narrazione piana – almeno in apparenza – che seguirà.Occorre inoltre rilevarne il valore strutturale e dimostrativo. Il
106
BIANCIARDI, OTTOCENTO COME NOVECENTO
testo s’inaugura, nel presente di chi scrive, con un cortocircuitomentale, che è per l’appunto quello causato dallo stato attuale del-l’io. Tornando invece in un passato di speranze e di azione, lo stilesi depura, ritrova la sua razionalità. Come a dire che Bianciardi,metaforicamente, non sceglie uno stile ma ne è scelto; la scelta,per specificare meglio, è demandata alle reazioni emotive del sog-getto di fronte al presente o al ricordo del passato: due dimensioniopposte: disinganno e obnubilamento autodistruttivo nel primocaso, speranza e massima espressione delle proprie potenzialitàdi analisi e di azione nel secondo.
Inoltre, se ne La battaglia soda Bianciardi aderiva completa-mente a un esercizio mimetico, qui domina appunto il pastiche,temporale oltreché linguistico, a cui ben si accorda un’aperturaestrema, che suggerisce di leggere estremisticamente anche il pro-seguo del libro. Le parti più connotate in senso tradizionale vannovalutate senza ingenuità: sono anch’esse componenti di un mec-canismo complesso e necessario. Ancora, non stimo corretto par-lare, in merito a questo capitolo, di monologo interiore, bensì didialogo interiore: ed ecco di nuovo una prova della sua necessitàall’interno del libro. Come sempre nel Bianciardi più acceso, ilpensiero si configura in maniera antagonista, dialogica ovverodialettica: è un pensiero che cerca lo scontro, che ha bisogno diun’antitesi per liberare tutta la sua forza eversiva. Basti controllarequante opinioni, quanti pareri, fin dal primo rigo, chiama in causaper costruire la trama delle sue riflessioni. Infine, è un capitologremito di segnali di sconfitta, di ripiegamento rabbioso, di fine:il sentimento primario, cioè, che anima l’intera narrazione.
Quando poi lo scrittore si impegnerà nella descrizione degliscontri tra austriaci e milanesi, ci troveremo dinanzi a un bellis-simo esempio di stile americano, quasi cinematografico, incal-zante, con movimenti di camera, per così dire, vivaci e veloci: unritmo inusitato rispetto ai placidi scorrimenti delle trame roman-zesche tradizionali.
Allo scoppio del ’68, Bianciardi aveva tutte le carte in regolaper apparire un precursore. Per meglio dire, ne era un precursore,uno dei più acuti e incisivi. Si pensi solo al tema sessuale, a qualetrattamento, questo tema, era sottoposto anche nelle file della si-
107
CONVEGNO
nistra negli anni ’50 e ’60. Il fatto è che le profezie di questo pro-feta inascoltato sembrano frutto esclusivo di una personale arrab-biatura. Non sembrano capaci di astrazione, di ordinarsi secondouna norma rigorosa, scientifica. Bianciardi non solo non è un so-ciologo, ma non ha mai finto di essere un romanziere dalle sa-lienze sociologiche professionali. Per di più, la sua prosa, i suoisfoghi, hanno sì elementi didattici, ma risulta soverchiante il va-lore di testimonianza individuale. Ciononostante, o forse proprioper questo, occorre riconoscere che aveva visto giusto, che avevacentrato grazie alla sua cultura e al suo intuito i motivi maggioridella deriva contemporanea.
Rileggere oggi Aprire il fuoco alla luce del ’68 è un esperi-mento fruttuoso: si pensi a quale suggestione potesse avere per isessantottini una descrizione in questi termini dell’insurrezionedel 1848-1959: “Non fu dunque, come poi si disse dagli studiosistranieri, un ragionamento da strateghi, ma una fantasia che chia-merei quasi poetica quella che ci portò tutti a fare massa versoPorta Vittoria” (p. 185). Poesia, fantasia al potere, libertà sessuale:sono temi che Bianciardi non mutua dai più giovani, come i piùgiovani, che avevano altri e altrimenti discutibili, talvolta, punti diriferimento, non prendono da Bianciardi: eppure coincidono.
Lo scrittore grossetano avrebbe dunque potuto essere, non invirtù di Aprire il fuoco, che esce successivamente, ma già grazieai suoi libri degli anni ’50-’60, un faro di quegli anni.
È vero tuttavia che una differenza di cultura che si traduce ne-cessariamente in visione del mondo, rende problematico l’incon-tro, oltre alle cause elencate sopra. Restiamo ad Aprire il fuoco,terminato, stando all’autore, nel marzo di quell’anno fatidico.
Che ci fa il Risorgimento tra il Dottor Guevara, Bob Dylan,Marcuse? Il Risorgimento su cui fa perno la superfetazione reto-rica del peggior nazionalismo italiano e che viene sbandierato aogni pubblica cerimonia di quello Stato che i giovani voglionoabbattere e ricostruire dalle fondamenta? Si tratta non solo di unanacronismo ma quasi di una provocazione, di un gesto di rea-zione: anche perché suggerisce e auspica una continuità a chifonda la propria filosofia sulla discontinuità, su una rottura vio-lenta della cultura dei padri. La quale, è inutile rilevarlo, proprionel Risorgimento trovava una sua base ideologica ineliminabile.
108
BIANCIARDI, OTTOCENTO COME NOVECENTO
Nel ’68, inutile nasconderselo, il Risorgimento è un intruso, unospite poco gradito.
E come avrebbero, o avranno, reagito gli studenti di allora, difronte alle lezioni che l’aio Bianciardi impartisce ai suoi pupilli?I suoi modi d’insegnamento lo ritraggono come un pedagogo bril-lante e divertente, ma inguaribilmente vecchio stampo. Addirit-tura, horribile dictu, non rinnega, e anzi incoraggia, la praticamnenonica.
Forse non sarebbe andata a genio neppure la giusta valutazionedella Storia della colonna infame: per Manzoni non tirava unabuona aria, sebbene questo fosse un libro carissimo ai poeti dellalinea lombarda, da Risi, che ci ha fatto pure un film, in poi (poetiin molti casi inseritisi più o meno abusivamente nel ’68). Il grandelibro di Manzoni si scaglia contro lo stato di barbarie della societàseicentesca (ma pensava anche alla sua contemporaneità, e forsea uno stato perenne dell’uomo). Così come Bianciardi si scagliacontro quella che reputa la nuova barbarie, il nuovo soggioga-mento delle masse: quello del boom. Ma sarebbe bastato, se ne sa-rebbero accorti gli studenti di allora?
Del resto, mentre i giovani non avrebbero capito, o non capi-vano, o comunque non ascoltavano Bianciardi quanto ascoltavanoaltri intellettuali, da parte sua Bianciardi, che pure plaude alla ri-volta, non risparmia il sarcasmo di fronte alle incipienti manife-stazioni di lotta: ecco un passaggio che, allora, poteva urticare lasensibilità di tante anime belle:
Bisognerà riconoscere senz’altro che questi moti spontanei, studen-teschi, operai, contadini, potranno anche costituire un sostegno alla ri-voluzione reale. Se non altro questi moti gioveranno a distrarre la Polizeidal nostro impeto risolutivo, quando lo scateneremo. Non a caso questispontanei manifestatori amano richiamarsi al Dottor Ernesto Guevara, eio consiglio loro di rileggersi il Carlo Pisacane, che è anche più bravo:hanno riconosciuto a naso, nel martire argentino, un loro predecessoree un maestro d’infantilismo rivoluzionario. (p. 210)
Carlo Pisacane anteposto a il Che: inaccettabile bestemmia.
109
CONVEGNO
Ma per Bianciardi, in questo libro sessantottino avant lettre enonostante il sessantotto, il Risorgimento, come già detto, è unostrumento necessario.
C’è un brano, al termine del nono capitolo che a mio avviso èeloquentissimo nel denunciare i termini di una possibile adesione:“Noi milanesi avevamo dimostrato gran voglia di batterci e grandeardimento” (p. 158). “Noi milanesi”: chi abbia letto La vita agranon si capacita: Bianciardi milanese! Il terrorista in pectore che èsalito nella capitale del Nord per vendicare con l’esplosivo gli as-sassinati dal capitalismo, il non integrato e non integrabile sputatofuori dal sistema che avrebbe voluto cambiare, l’osservatore finee feroce di una città che si sente progredire mentre si disumanizza;insomma, quel Bianciardi che aveva assunto Milano a sineddo-che di una società sempre più detestabile, ecco che si mescola inuna incredibile prima persona plurale: “noi milanesi”. Come è ac-caduto? Grazie, io credo, a due movimenti temporali opposti ep-pure concordi: uno verso il recupero del passato e uno, tramitel’utopia, di proiezione nel futuro. Il noi riguarda cioè, da un lato,i milanesi, vecchi di 111 anni, delle Cinque giornate, eroici, in-terclassisti ed esemplari, e dall’altro i milanesi (ma se Milano è,come è, una sineddoche dell’Italia, gli italiani) finalmente disin-gannati in merito alle lusinghe della nuova economia e dell’ap-parente equità sociale. Questo duplice movimento è alla basedell’intero romanzo e di gran parte dell’opera di Bianciardi. Lanervosità stilistica e la necessità del pastiche derivano da una tri-ste constatazione: entrambe le direttrici di adesione menano a unvicolo cieco, a una virtualità morta. Il passato non torna, e l’uto-pia non poggia su una realtà in grado di alimentarla. Il grande im-putato, questa volta sì di tutta la scrittura bianciardiana, cioè ilpresente, è inchiodato da prove schiaccianti a un verdetto di col-pevolezza, incatenato, sembra di poter desumere, dal “sillogismodel fucile scarico” (p. 183).
Il quale sillogismo, secondo cui il fucile scarico spaventa sia ilmiratore che il mirato - il secondo perché ignaro del bluff del-l’avversario, il primo temendo che il bluff sia scoperto - funzionaquasi sempre nelle fasi rivoluzionarie: le due parti, l’autorità e gliinsorti, tendono a sopravvalutarsi e a diffidare; infine vince la con-servazione, vecchia o nuova, vince ciò che è noto, per quanto ri-
110
BIANCIARDI, OTTOCENTO COME NOVECENTO
pugnante. La libertà, secondo Bianciardi, è un onore e un onereche non tutti, specie nella nostra società, sanno sopportare: megliouna parodia, una finzione di libertà, che il rischio di possederlaveramente. Quando la rivoluzione implode in un’altra forma dipotere sembra ritornare l’insegnamento sconcertante del GrandeInquisitore dostoevskiano: l’uomo va preservato dalla libertà, vasalvato da se stesso. La schiavitù e l’oppressione sono medica-menti contro le vertigini della libera scelta. L’insurrezione, fa diree dice Bianciardi, “non dovrebbe finire mai”: più di ogni altra, èquesta la sua utopia: senza una costante incandescenza, senza undisordine che non si placa e sclerotizza in una forma, il consorziocivile tende a raffreddare se stesso e a ricreare le disuguaglianze:le cellule cancerose dell’ingiustizia si riproducono più veloce-mente di quelle sane. È una visione, questa, che ha un fondo tra-gicamente antiumanistico che non raggiunge tuttavia le spoglierive del nichilismo. Bianciardi non sa abbandonare la speranza,anche quando è morta. Ne rimane, nel suo romanzo estremo, unbaluginio appena visibile, una flebile luminescenza che non sispegne. Il suo pensiero resta dialettico, oppositivo, e abbisognadi un polo, magari remoto, magari quasi impercettibile, positivo.Nella fattispecie, la resistenza diventa una questione privata. Ilfiacco e smemorante ménage casalingo attenua le trafitture dellarealtà, acquieta la rabbia, tampona i sanguinamenti di una co-scienza inquieta: rimane, resiste appunto, qualcosa come una di-sponibilità a credere, una speranza che la speranza sconfessi ilsuo abbattimento. Ne è figura efficiente quella che inquadra il pro-tagonista alla finestra, intento a osservare il gabellino presso cuisi dovrebbero presentare “i suoi”, per riprendere la lotta. Losguardo, lanciato non a caso da lontano, al gabellino, è dunqueun aperto simbolo di speranza e di aspettazione. Speranza e aspet-tazione, tuttavia, che somigliano sinistramente a quelle di Kafkao del Deserto dei tartari. Il cerchio si chiude nell’ultimo capitolo,che ritrae nei suoi due estremi, all’inizio e alla fine, il protagoni-sta assorto nella visione del gabellino deserto. Sempre più scolo-rita, più lisa la speranza, l’ostinazione a scrutare nel binocolocontinua ad avere un suo significato e una sua nobiltà: quello diuna disperata, individuale, vana e umanissima resistenza.
111
CONVEGNO
1 Giovanni Raboni, Una volta, in Le case della Vetra, Milano, Mondadori,1966; ora in ID., L’opera poetica, a cura e con un saggio introduttivo di RodolfoZucco e uno scritto di Andrea Zanzotto, Milano, Mondadori, 2006, p. 34.
2 Luciano Bianciardi, Aprire il fuoco, Milano, Rizzoli, 1969; tutte le citazioniprovengono dalla ristampa riproposta, con introduzione di Ettore Bianciardi, daExCogita, Milano, 2001. Ci limitiamo pertanto a specificare tra parentesi il nu-mero di pagina.
3 ID., La vita agra, ivi, 1962.4 ID., L’integrazione, ivi, 1960.5 Piero Chiara viene evocato nel quarto capitolo in un inserto appunto di puro
divertimento“Non ho ancora capito per quale motivo, se la consumazione av-venne in quella via milanese, io sia stato giudicato altrove, e cioè in una minorecittà lombarda chiamata Varese, che va tuttora famosa per ospitare nel suo parcocittadino una quercia centenaria dalle forme palesemente oscene, come ebbe afarmi notare il Chiara, antico cancelliere di quella corte regia e imperiale” (p.84); di Fortini, cui il nome viene leggermente modificato in Francesco Lattes,sono citati dal protagonista alcuni versi durante una lezione ai suoi pupilli. Nellostesso frangente, compare anche un brano poetico pasoliniano, senza che peral-tro se ne dica l’autore (pp. 102-103): le citazioni si compongono in un omaggioalla poesia civile di due intellettuali che, con modalità diversissime se non anti-tetiche, portavano avanti un discorso improntato a un’intransigenza che, inquanto tale, non poteva non avvincere Bianciardi, al di là delle singole opinionie dei diversi pronunciamenti.
112
BIANCIARDI, OTTOCENTO COME NOVECENTO
Marco Manotta
Le memorie garibaldine di un allievo di Pierre MenardA proposito de La battaglia soda
Nell’ipotetico volume che si prefiggesse di trarre un bilancio cri-tico della sopravvivenza del mito regressivo dell’Ottocento nellacoscienza di diversi grandi scrittori italiani del secolo breve appenatrascorso (da Croce a Brancati a Malaparte ad Alvaro a Longanesia Pasolini a Tomasi di Lampedusa ecc…), non potrebbe mancare uncapitolo dedicato a un intellettuale che ha consumato la nostalgiacome ulteriore via impraticabile, quasi per assurdo si vorrebbe dire,offerta alla ridefinizione di un ruolo sociale per degli operatori cul-turali che vedono metabolizzate le istanze di contestazione, critica,ricerca e proposta in un sistema di continuo riciclo e perpetuazionedell’esistente. Occorreva una sana dose di cinismo metodologicoper non farsi scoraggiare dalle caustiche considerazioni di coloroche fin dai primi anni Venti elaboravano il contro-mito dello StupideXIXe siècle – dal titolo del celebre pamphlet di Léon Daudet; tale ci-nismo deve essere per forza in circolo quando, per fare un esempio,con candore ariostesco, appesantito tuttavia dall’apparente scom-parsa del filtro ironico, si può arrivare a celebrare ‘la gran bontà deicavalieri antiqui’ – così Bianciardi in Daghela avanti un passo!:“Le guerre dell’Ottocento non furono mai massacri totali, ed eb-bero anzi un certo piglio cavalleresco, ormai perduto da un pezzo”1.Ma in realtà la situazione, che parrebbe frutto di un provinciale e,direbbe Nietzsche, antiquario culto letterario del passato, si com-plica poiché, per riprendere il titolo del presente Convegno, l’Otto-cento di Bianciardi non è affatto un anti-Novecento, ma piuttosto lospecchio in cui il Novecento, italiano, può trovare impresse le stim-mate della propria crisi2.
Bianciardi non era certo uomo sistematico e incline a filosofeg-giare sulla Storia sulla base di teorie di progresso o di declino: laproposta di riappropriazione critica della storia del nostro Risorgi-mento rampolla dalla passione culturale e civile, nutrita dal saporeun po’ antiquario, torno a dire, che si sorbiva fra i giovani cultori distoria locale di Kansas City; da una dimensione provinciale, perife-
113
CONVEGNO
rica, parte un’interrogazione su senso e direzione del processo uni-tario che si rivela incomprensibile per gli amici metropolitani di Mi-lano3. In fondo, l’amore per il Risorgimento nasceva dalla precoceinfatuazione per Garibaldi, avvicinato attraverso lo schermo memo-rialistico dell’amato conterraneo Giuseppe Bandi4. All’accusa di pro-vincialismo occorreva replicare con la realizzazione di un inattualeprogetto di ricostruzione storica e letteraria che potesse rivendicarela leopardiana valenza di ‘discorso sullo stato presente del costumedegli italiani’. E certamente non era sufficiente curare edizioni e ri-stampe di memorialistica garibaldina, né limitarsi alla pur nobileopera di divulgazione storica5: occorreva misurarsi col circuito dellaproduzione letteraria high brow, in cui si trovava predisposto, se-gnato da una vicenda bisecolare di alterne fortune, il canale espres-sivo del romanzo storico. Sainte-Beuve, francamente impaziente perla fuga di Flaubert nel ‘deserto della Tebaide’, dove lo aveva cacciatola nausea per la vita moderna, aveva criticato senza mezzi terminil’opzione diegetica estetizzante storicamente reazionaria diSalammbò: “Che cosa m’importa della lotta tra Tunisi e Cartagine?Se mi si parla della lotta tra Cartagine e Roma, allora sono attento eprofondamente interessato. Nella lotta fra Roma e Cartagine è ingioco tutta la civiltà futura; anche la nostra ne dipende”6. E si ascolticome Bianciardi presenta, nel carton cino-segnalibro, il proprio ro-manzo storico del 1964: “sarebbe un grosso torto leggere questolibro come un ‘pastiche’ sfottitorio sul Risorgimento. Difatti la de-lusione di allora è anche una verifica della delusione nostra, una spe-cie di controllo nel passato, per ritrovarvi i nostri errori e le nostresperanze. A Custoza siamo stati sconfitti anche noi”7.
Si tratta di comprendere come una tale operazione di scavo me-moriale potesse realizzare il programma civilmente ambizioso cheinnervava la scorza ludica e documentaria della diegesi. Poiché èevidente, come è stato notato, che non è possibile per puro ottimi-smo della volontà insufflare energia vitale, in pieno Novecento, inun narratore ormai divenuto inattendibile, e in una narrazione sto-rica che ha perso credibilità, a sanzione dell’avvenuto divorzio conla controparte storiografica – l’accoppiamento giudizioso di storiae invenzione (ma si pensi alle perplessità di Manzoni) aveva in-vece coonestato la fiducia ottocentesca che il genere potesse get-tare lume sulle zone lasciate in ombra dalla storia ufficiale8. Non
114
BIANCIARDI, OTTOCENTO COME NOVECENTO
sarà un caso che, per usare categorie lukacsiane, dopo la crisi delromanzo storico nell’età dell’imperialismo, approdato in Italia aesiti ‘antistorici’9 nei capolavori di De Roberto e Pirandello, sul fi-nire degli anni Cinquanta si assista a un’ondata di riflusso che ca-valca l’inaspettato successo di un’opera che nobilita la tradizioneottocentesca, intrisa di nostalgia per i valori veicolati dalla perentaaristocrazia postrisorgimentale. Col romanzo di Tomasi di Lam-pedusa, del 1959, la cui lettura, come ricorda Bianciardi ne L’in-tegrazione, aveva suscitato belle discussioni tra gli amici toscaniinurbati a Milano10, si inaugura una stagione di ripensamento nar-rativo di alcuni episodi salienti del processo che aveva portato auna unificazione sbilanciata, i cui negativi effetti si potevano per-cepire nel progressivo aggravamento della questione meridionale.Del 1959 è anche Caccia all’uomo di Roberto Roversi, ambientatodurante il regno di Gioacchino Murat; al 1963 risale Le armi gliamori di Emilio Tadini, sulla sfortunata spedizione rivoluzionariadi Carlo Pisacane; sempre del 1963 è Il consiglio d’Egitto di Leo-nardo Sciascia, che mette al centro la Sicilia del periodo riforma-tore tardo settecentesco11. L’apparizione di La battaglia soda nonè quindi fuori contesto, si può anzi ulteriormente giovare, per ren-dere meno arbitrario il proposito di recuperare alla narrativa storicauna funzione conoscitiva e parenetica, della coeva problematizza-zione della natura della conoscenza storica, che aveva riavvicinato,su base retorica, scrittura letteraria e scrittura storiografica, e,aprendo alla microstoria, aveva esteso il regesto delle fonti docu-mentarie utilizzabili12. L’opzione sarà allora quella di puntare sul-l’evidenza assertoria di un racconto dal valore testimoniale, cheutilizzi il richiamo all’esperienza vissuta del narratore (Bandi nelcaso specifico) in senso retoricamente persuasivo, grazie alla so-vrapposizione, non esplicitata come sarà in Aprire il fuoco ma solosentimentale, con la vicenda biografica dell’autore (Bianciardi), asuo tempo combattente e reduce durante gli anni della secondaguerra mondiale – esperienza raccontata da Bianciardi nei Diari diguerra del 1944-194613. Il narratore de La battaglia soda tiene aprecisare, allorché il racconto si inarca nella rievocazione dellabattaglia di Custoza, che non vuole dare al suo lettore “altro chequanto sentirono le mie orecchie e videro i miei occhi in quella in-fausta giornata”14. Un secolo prima, Giuseppe Bandi, a ingresso
115
CONVEGNO
della sua più nota impresa memorialistica, aveva legato l’autocer-tificazione di narratore al “proposito di non raccontare se nonquello che vidi ed udii; e tu capirai bene che io non potevo averocchi ed orecchi per vedere ed udir tutto”15. Se un narratore ideo-logicamente debole deve porre a garanzia di veridicità del raccontoil richiamo all’esperienza autobiografica, e in funzione oltretuttonon esemplare, come mirabilmente poteva ancora fare qualcheanno prima Ippolito Nievo16, il suo omologo del XX secolo riscat-terà nell’imitazione quella posizione debole, traducendo l’auto-biografia in letteratura, e ricavando da questa simulata compro-missione esistenziale la posizione assiologica forte per chiamare agiudizio quella Storia che risultava illeggibile agli occhi del pri-vato a cui sfuggiva il nesso tra particolare e universale17.
Richiamiamo alla memoria il programma di adempimento di unapassione narrativa, a lungo coltivata, espresso da Bianciardi in unanota pagina de La vita agra: “Vi darò la narrativa integrale – ma ladefinizione, attenti, è provvisoria – dove il narratore è coinvolto nelsuo narrare proprio in quanto narratore, e il lettore nel suo leggerein quanto lettore, e tutti e due coinvolti insieme in quanto uominivivi e contribuenti e cittadini e congedati dell’esercito, insomma in-teri”18. Se non si tratta di un esplicito annuncio del progetto in corsodi quel particolarissimo romanzo storico, pare sensato tuttavia pre-sumere che all’interno di quelle coordinate potesse inscriversil’osmosi tra le funzioni di narratore e di lettore che genera infine laloro complicazione e sovrapposizione (si noti il fatto che narratoree lettore sono entrambi congedati dall’esercito); ‘lettore’ è Bian-ciardi che rilegge Bandi fino ad appropriarsi della sua funzione au-toriale19: La battaglia soda è anche il racconto di una coinvolgenteesperienza di lettura che genera un risultato in certa misura più ra-dicale di quello ottenuto attraverso l’esplicita schizofrenia temporaledi Aprire il fuoco, poiché la schizofrenia è celata dietro la squader-nata empatia e immedesimazione; ma si osservi cosa accade amonte dell’effacement di tale dicotomia: Bianciardi percorre le dolcicolline che cingono la piana di Custoza, e ne ricava un sentimentodi pacificazione antifrastico, “perché soltanto la fantasia può risu-scitare il rischio che da dietro quella cresta compaiano le giacchebianche degli imperiali, comandati da quel fenomeno dell’arci-duca Alberto, miope come una talpa ma grande stratega”. E la
fantasia, forse incautamente evocata, compie il suo dovere,come si evince tre righe sotto:
Eccolo qua, il ponte: proprio a me dettero l’ordine di farlo saltare, e iodisobbedii; anzi, ripresi Valeggio, radunai i dispersi, li riportai ancora alfuoco, sul Mamaor, sul Monte Vento, e la battaglia per me ricominciava,se a un certo punto Nino Bixio non m’avesse mandato a prendere per lefalde della giubba da un suo colonnello. «Matto», mi disse poi, «smetti laspada e riprendi la penna, che è quello il mestier tuo.»20
Questa prosa è del 1964, e quindi ci rivela la dinamica dell’im-maginazione al lavoro per il romanzo, che poi Bianciardi accarez-zerà con esibita e forse fin troppo corriva compiacenza, allorchéinserirà all’interno della successiva epopea risorgimentale in terzapersona di Daghela avanti un passo! brani testimoniali ricavati dalromanzo e attribuiti “ad uno che c’era davvero”, in almeno tre casi21.Più interessante, invece, prendere atto di come si sviluppa l’opzionediegetica de La battaglia soda, per esempio attraverso il reiteratouso di quegli incisi con funzione analettica di richiamo a un tra-scorso che si trova nelle pagine dei Mille di Bandi, innestando dun-que il moderno romanzo storico in quello memoriale del reducegaribaldino: “come ho già spiegato, il lettore ricorderà, ecc…”, ri-ferimenti sul filo di una apparentemente non problematica conti-nuità autobiografica, dal momento che La battaglia soda dichiara findal principio, dalla presa di Capua con cui termina I Mille, la pro-pria natura di ideale proseguimento delle memorie di Bandi22. Ma iproblemi, seppure mascherati dal filtro di quella che pare una lu-dica ricreazione fantastica, permangono da un punto di vista narra-tivo, dal momento che la soggettività dissociata non riesce a farperdere completamente le proprie tracce: per esempio, se in riferi-mento a un’ipotetica impresa mazziniana il narratore conclude: “Perparte mia, non lo credetti allora e non lo credo neanche adesso”23,l’effetto attualizzante dell’avverbio è complicato dal fatto che pos-sono sovrapporsi il presente della ricreata scrittura memoriale (al-cuni anni dopo gli eventi narrati) e il presente dell’attività dimistificazione (1964). È Bandi narratore o Bianciardi autore che an-cora “adesso” non crede a quello specifico intervento di Mazzini?Entrano in gioco poi, sempre per confondere le carte, le coincidenze
117
biografiche già rilevate dalla Angelini nella sua pionieristica mono-grafia su Bianciardi24; ma potrà essere suggestivo rilevare come,forse solo per un innocente scherzo onomastico del destino, il rap-porto fra Bandi e Bianciardi si rafforzi sul filo di una anagramma-tica incorporazione del primo nome nel secondo (BiANciarDI).Anche la prosa di Bandi, a parte il colorito toscano e le espressionigergali, subisce in qualche punto un’operazione di riscrittura chepotrebbe essere verificata collazionando, per esempio, le descrizionidel bombardamento su Capua, esibita parafrasi da parte del narra-tore moderno che solo esteriormente si potrebbe attribuire a un gustoper il pastiche:
A noi, che per la prima volta assistevamo allo spettacolo d’una cittàbombardata, parve che a Sebastopoli non si fosse fatta maggiore gaz-zarra; ma in sostanza il bombardamento di Capua non fu se non moltochiasso per nulla e poche buche spalancò e pochissimi morti vi cacciòdentro, e si contarono sulle dita i tetti che ne furono sprofondati e le mu-raglie che ne furon rotte. Le nostre bombe, per la più parte, sospinte dalvento, che soffiava forte, caddero nel fiume, a tergo della città, e soloquando la cupola del duomo fu rotta in due punti, il popolo spaurito andòa piangere dall’arcivescovo, e questi supplicò il generale comandanteche avesse compassione e non si ostinasse in un’inutile difesa.
(I Mille, cit., p. 237)Come già dissi, a noi che non s’era mai goduto lo spettacolo d’una
città bombardata, parve che a Sebastopoli non si fosse fatta maggior gaz-zarra, ma stringi stringi l’assedio di Capua fu povera cosa. Imprecisi lapiù parte dei colpi, pochi furono i tetti sfondati e le muraglie rotte, equando una bomba aprì la cupola del duomo, monsignor arcivescovo inpersona corse dal comandante della piazza e lo supplicò che smettessequell’inutile distruzione.
(La battaglia soda, in Ant I, p. 742)25
Si presenta invece – uso un esempio un po’ fuori contesto perspiegarmi – un caso simile alla consonanza ideologica, senti-mentale e corale che aveva condotto qualche decennio prima PieroJahier a rielaborare un’antologia di canti alpini in funzione dellapropria pronuncia poetica (Canti di soldati, 1919 e 1920).
118
BIANCIARDI, OTTOCENTO COME NOVECENTO
Se vogliamo, fra il narratore dei Mille e quello de La battagliasoda corre una differenza, che si potrà giudicare anche ovvia, con-cernente il grado di autocoscienza letteraria, molto più matura, adonta delle affettazioni di modestia, nel moderno scrittore: ma que-sto transito dalla cronaca alla storia è frutto, oltre che del dia-framma temporale, del preciso ancorché burbero mandato di NinoBixio – abbiamo già avuto modo di ascoltarlo –, che Bianciardirende in qualche misura consapevole della necessità di suscitaredall’interno quella figura di interprete dell’epopea garibaldina chesfortunatamente non poté essere Ippolito Nievo, e che di certo nonavrebbe potuto essere il reale Giuseppe Bandi, per quanto dotatodi buona memoria e di freschezza e vivacità di scrittura26.
Corre ovviamente una cospicua differenza anche fra il tono anti-retorico della prosa di Bandi, frutto di generoso dilettantismo, e iltono antiretorico studiato della prosa di Bianciardi: l’abbassamentocomico dell’epopea risorgimentale – comico inteso nel senso dellaclassica dottrina degli stili – non poteva essere conseguito se nonponendosi a una certa distanza dall’entusiasmo ingenuo degli attoricoinvolti nella gloriosa vicenda. Si potrebbe dire che Bianciardi, ar-rivando buon terzo, attacchi la fortezza tradizionale dell’oleografiastorica – il mito del Risorgimento – dopo che analoghe zaffate diantiretorico e caustico realismo avevano ridato spessore di vita e disofferenza vissuta alla guerra in trincea grazie ad Emilio Lussu ealla guerra partigiana grazie a Beppe Fenoglio27. Tante potrebberoessere le citazioni al riguardo, ma sia sufficiente ricordare, per il suotono anche nobilmente e ferocemente didascalico, come il valoreeroico e il gesto cortese di una morte inutile (quella del generale Vil-larey) sia incastonato nel simultaneo lavoro scatologico di puliziadel selciato dalle brutture lasciate da cavalli e muli da parte di unasquadra di truppe ausiliarie28 – e come non ricordare l’abnegazionedi Garibaldi, nell’omonimo racconto biografico, che non esita acombattere, contro le astratte e cortesi regole che si apprendono allascuola di guerra, seppure afflitto da una fastidiosa diarrea29? Tantopiù pregevole si rivela tale scelta anti-estetizzante, quanto più era ra-dicato, all’interno di un esercito composto per almeno la metà da in-tellettuali e scrittori, il piacere per la bella pagina celebrativa eamplificatoria di cui si propone a esemplare modello vitando la re-
119
CONVEGNO
torica insurrezionale puramente letteraria di Alexandre Dumas, fra-cassone e scomodo compagno di strada dell’impresa dei Mille30.
Occorre riconoscere che l’abbassamento realistico non pregiu-dica il gusto per l’intarsio letterario, che connota la prosa de Labattaglia soda in maniera ben più esibita rispetto all’amato anti-grafo risorgimentale dei Mille, senza con ciò indulgere in quellepreziosità alessandrine che sarebbero state fuori posto sulla pa-gina superficialmente erudita di un Bandi. A partire dal titolostesso e dall’epigrafe, recuperati dall’Arte della guerra di Ma-chiavelli. Sarà il caso a questo punto dichiararne il senso, a costodi correre il rischio di apparire banali e didascalici. Leggiamol’epigrafe machiavelliana: “Questi sono i modi che si possono te-nere da una battaglia, quando dee passare, sola, pei luoghi so-spetti. Ma la battaglia soda, senza corna e senza piazza, èmeglio”31, vale a dire – parafraso – Queste sono le condizioni tat-tiche che deve osservare una divisione, o meglio una coorte,quando deve passare sola, come avanguardia, per luoghi repu-tati insicuri. Ma la coorte compatta, massiccia, senza ali chesporgano in avanti rispetto alla parte centrale della fronte, esenza il vacuo in cui d’ordinario vanno collocati i carri, il capi-tano e la bandiera, costituisce strategicamente una forza d’urtomigliore. L’epigrafe illustra le ragioni militari della sconfitta diCustoza, che appaiono chiarissime nella discussione malaugura-tamente antiveggente fra i capitani Colorni e San Martin, due sem-plici ufficiali subalterni dunque. San Martin rileva la superioritàdi numero dell’esercito piemontese rispetto a quello imperiale:
«L’alleanza con la Prussia fu tanta manna, e raramente ci capiterà piùdi affrontare il nostro secolare nemico così soverchianti di numero. Senoi dunque muoveremo a massa…» «Tu vedi che questo per l’appuntonon accade» l’interruppe Colorni. «Perché si è diviso l’esercito in dueparti di forza quasi uguale? Perché non s’è mantenuto il grosso là dovesi era deciso di picchiare sodo, lasciando sull’altro fiume quelle truppeche bastassero per una pur sostenuta dimostrazione?» E a questo puntoavrei voluto interpormi [dichiara retrospettivamente la voce narrante],per dire che la divisione non era stata fatta pensando alle necessità dellaguerra, ma invece per appagare le ambizioni dei due nostri generali piùgrossi e più lustri e più vogliosi di comandare32.
120
BIANCIARDI, OTTOCENTO COME NOVECENTO
Sulla presenza di Machiavelli nel romanzo come referenteideologico-letterario occorrerebbe andare più a fondo, anche per-ché si tratta di influenza complicata dalla valutazione estrema-mente positiva, e non poteva essere diversamente, dell’operato diGiovanni dalle Bande Nere, posto in linea di continuità direttacon Garibaldi per le virtù del coraggio, della destrezza militare edella sagacia pratica nel condurre le imprese di guerra33 – si po-trebbe ricordare che nella dedicatoria di una novella di MatteoBandello (la XL del I Libro) il giovane condottiero di casa Medicirisolverà con poco sforzo e molta esperienza un problema prag-matico di schieramento di truppe che si era rivelato insolubile peril Machiavelli teorico dell’arte della guerra34. Ma lasciamo il se-gretario fiorentino, e rileviamo, senza commentare, la cospicua esbandierata presenza di Dante35, alcuni inserti boccacceschi, fo-scoliani e manzoniani, un possibile riferimento a Sterne – PierCoccoluto Ferrigni era soprannominato Yorick36 – per l’episodiodella beffa subita a opera del calzolaio Copraccari e della procacefiglia Carlotta (viene in mente l’incontro di Yorick a Parigi in unamerceria con la bella cortese padrona e il marito condiscendente,concluso con l’acquisto di un paio di guanti)37. Vale la pena disoffermarsi su Leopardi, di cui il narratore de La battaglia sodamostra di possedere una conoscenza non disprezzabile. Per esem-pio sa che Pisa, “piacque tanto al maggior poeta del nostro se-colo, da scriverne come sapeva lui in una bella lettera alla suaamata sorella Paolina”38. Si tratta della lettera datata 12 novembre1827 a Paolina, che il narratore fittizio de La battaglia sodaavrebbe in effetti potuto leggere all’interno della raccolta episto-lare curata da Prospero Viani e riedita a Napoli nel 1860. A coo-nestare ulteriormente la verisimiglianza della narrazione,un’osservazione anche sul celebre motto di Menandro – è “desti-nato a morire giovane quello che gli dei hanno troppo caro”39 –,di cui il narratore fittizio ricreato da Bianciardi, autentico amantedi Leopardi, potrebbe essersi ricordato per averlo letto posto aepigrafe del canto Amore e morte. Il recupero pseudo-erudito,anche se la presente lettura potrebbe peccare di eccessiva sotti-gliezza, si dimostrerebbe dunque consentaneo a un mondo ideo-logico, sentimentale, storico che un autore del XX secolo intendericreare attraverso una vigile trasfusione simpatetica40.
121
CONVEGNO
Nel cartoncino-segnalibro allegato alla prima edizione del ro-manzo Bianciardi concedeva: “Non negherò che all’ironia del pro-tagonista si sovrappone talvolta l’ironia dell’autore”41, certificandoquindi la resistenza dell’anacronismo che costituisce il quid pro-prium del discorso letterario. Cerco di spiegarmi attraverso le pa-role di Goethe: “ogni poesia dà luogo a veri e propri anacronismi.Ogni passato che noi rievochiamo per presentarlo ai nostri con-temporanei alla nostra maniera deve necessariamente attribuireall’antico una raffinatezza più alta di quella che aveva”42. Ana-cronismo e asincronia costituiscono le stimmate della dimensionetemporale e finita del discorso letterario, e La battaglia soda, nellasua apparente ingenua pretesa di schiacciare le distanze non fache verificare l’impossibile coincidenza delle parole già speri-mentata nel Don Chisciotte riscritto da Pierre Menard. In questoracconto Borges sfida gli scrittori a usare “la tecnica dell’anacro-nismo deliberato”43. Non so se Bianciardi avesse letto il raccontodi Borges; ma Menard è davvero un po’ Bianciardi, poiché, aldilàdella riscrittura del Chisciotte, l’erudito biografo di questo stra-vagante scrittore ci informa che tra le opere realizzate da Menardc’era anche un virtuosistico e combinatorio Les problèmes d’unproblème44. Anche questo titolo, autentico pane per i denti diBianciardi, che si dedica all’ironica ed eroica impresa di metterea punto un metalinguaggio all’inizio del VI capitolo de Il lavoroculturale: “Cominciamo subito, perciò, con il nocciolo della que-stione, con il termine problema”45. In tal modo il lavoro di Bian-ciardi riparte, come infinita messa a punto di una prospettiva chenon potrà mai arrivare all’appiattimento delle differenze, la-sciando così aperta la domanda sul senso del decorso storico.
122
BIANCIARDI, OTTOCENTO COME NOVECENTO
1 Luciano Bianciardi, Daghela avanti un passo! (1969), in Id., L’antimeri-diano. Opere complete, a cura di Luciana Bianciardi, Massimo Coppola e Al-berto Piccinini, 2 voll. (vol. I, Saggi e romanzi, racconti, diari giovanili, vol. II,Scritti giornalistici), Milano, ExCogita, 2005, vol. I, p. 1190 (d’ora innanzi ab-breviato con Ant I e Ant II).
2 “Scrivendo un romanzo sul Risorgimento tradito, Bianciardi vuole tornarealle origini della contemporaneità italiana. Tornare al passato per meglio capireil presente” (Emilio Tadini, Introduzione a Luciano Bianciardi, La battagliasoda, Milano, Bompiani, 20032, p. VII).
3 Cfr. Pino Corrias, Vita agra di un anarchico, Milano, Baldini & Castoldi,1993, p. 31: “Ma si può sapere cosa te ne frega a te di Garibaldi?”, sbottava Gio-vanni Arpino. A questi amici Bianciardi rispondeva, forse accalorandosi, con leparole riportate ne L’integrazione: “Per esempio io gli dicevo che sarebbe statobene cercare vecchie memorie garibaldine, e studiarle. Gli dicevo che in fondoè ingiusto che in Italia i giovani conoscano meglio la guerra civile americana, ela guerra contro gli indiani, che non il nostro Risorgimento. Gli dicevo che certifatti della nostra storia ottocentesca, e le imprese garibaldine prima di tutto, me-ritavano d’essere conosciute, popolarizzate, tradotte magari in film, perché ol-tretutto erano avventurosissime, e pittoresche” (Ant I, p. 517).
4 Nato a Gavorrano (Grosseto) nel 1834. Terminati gli studi classici a Lucca,si addottora in giurisprudenza presso l’università di Siena. Processato e arrestatoin un paio di occasioni per la sua militanza mazziniana, conosce Garibaldi men-tre presta servizio nelle file dell’esercito toscano. Segue il Generale nell’impresadei Mille, comportandosi con particolare valore a Calatafimi, dove viene grave-mente ferito, e a Milazzo. Nominato maggiore dell’esercito meridionale il 1°novembre 1860, vede bloccata la sua carriera nell’esercito italiano dai contrasticon le gerarchie militari dovuti alla sua natura irrequieta e alle sue tendenze re-pubblicane e radicali. Dopo essersi nuovamente distinto sul campo a Custoza, la-scia l’esercito e l’insoffribile disciplina militare nel 1868. Ripresa l’attività digiornalista, viene chiamato alla direzione della neonata Gazzetta livornese. Nelcorso degli anni la sua posizione politica evolve verso posizioni di destra, finoad appoggiare la politica dell’ex compagno d’armi Crispi. Polemico contro glianarchici, proprio da un anarchico viene assassinato a Livorno il 1° luglio 1894.Come letterato, si dedica alla stesura di romanzi storici, epigono del corregionaleGuerrazzi. Trova la misura della sua vena narrativa inserendosi con profitto nelfilone della memorialistica garibaldina aperto dalle rievocazioni di Giulio CesareAbba. I Mille, in cui si coniugano evidenza sentimentale del ricordo e toscanafreschezza espressiva, viene pubblicato a puntate dal 1886 sul Messaggero e sulTelegrafo, in tre serie successive: Da Genova a Marsala, Da Marsala a Palermo,Da Palermo a Capua.
5 Che annovera, oltre a Daghela avanti un passo!, titoli come Da Quarto aTorino. Breve storia della spedizione dei Mille (1960) e la biografia Garibaldi
123
CONVEGNO
(1972). Da rammentare, a proposito del compulsato romanzo di Bandi, che Bian-ciardi ne curò un’edizione uscita nel 1955 presso l’editore Parenti di Firenze, escrisse una Prefazione per un’edizione pubblicata dal Club degli Editori nel 1961(cfr. Carlo Varotti, “Bianciardi riscrittore del Risorgimento”, in La parola e ilracconto. Scritti su Luciano Bianciardi, a cura di Carlo Varotti, Bologna, Bo-nonia University Press, 2005, pp. 116-117).
6 Sul confronto dialettico fra lo scrittore di Rouen e l’influente critico si vedaGyörgy Lukáks, Il romanzo storico (1937-1957), Introduzione di Cesare Cases,Torino, Einaudi, 1965, pp. 247-250.
7 Cfr. Maria Clotilde Angelini, Luciano Bianciardi, Firenze, La Nuova Italia,1980, p. 86.
8 Cfr. Margherita Ganeri, Il romanzo storico in Italia. Il dibattito critico dalleorigini al postmoderno, Lecce, Manni, 1999, pp. 33-37.
9 Come negazione della concezione positiva del progresso storico, e dellastessa conoscibilità di un ordo rerum storico.
10 Cfr. Ant I, p. 550.11 Cfr. Gigliola De Donato, Gli archivi del silenzio. La tradizione del romanzo
storico italiano, Fasano (BR), Schena, 1995, pp. 55-58.12 Cfr., ivi, pp. 80-81, le riflessioni di storici come Lucien Febvre, Marc
Bloch, Paul Veyne.13 “Nostalgia, affetti familiari, attaccamento alla propria casa e alle proprie ori-
gini non sono soltanto un dato puramente ‘romanzesco’, ma più concretamenteriportano ad una reale esperienza dell’autore, reduce dalla guerra nel 1945” (M.C.Angelini, Luciano Bianciardi, cit., p. 87).
14 Ant I, p. 894.15 Giuseppe Bandi, I Mille, Prefazione di Stefano Canzio, Milano, Edizioni
vie nuove, 1962, p. 11.16 “L’attività privata d’un uomo che non fu né tanto avara da trincierarsi in se
stessa contro le miserie comuni, né tanto stoica da opporsi deliberatamente adesse, né tanto sapiente e superba da trascurarle disprezzandole, mi pare debba inalcun modo riflettere l’attività comune e nazionale che l’assorbe; come il caderd’una goccia rappresenta la direzione della pioggia” (Ippolito Nievo, Le Confes-sioni d’un Italiano, a cura di Marcella Gorla, Milano, Mondadori, 2006, pp. 4-5).
17 Non è questione di distanza prospettica, che nemmeno al racconto di Bandi,vergato un ventennio dopo gli eventi, mancava: ma della transcodificazione del-l’esperienza in una coerente dimensione letteraria che, per usare vecchie cate-gorie formaliste, corre parallela alla serie storica e la illumina dall’esterno –forse uno dei motivi che spiega la sorprendente recuperata fortuna del romanzostorico a Novecento inoltrato.
18 Ant I, p. 582.19 Così Bianciardi presenta il volume Da Quarto a Torino: “Questo libro è de-
dicato al ricordo di mio padre perché fu lui, quando io avevo appena gli anni per
124
BIANCIARDI, OTTOCENTO COME NOVECENTO
saper leggere, che mi mise in mano il libro dei Mille. «L’ha scritto un nostropaesano», mi spiegò. […] Spero di averci messo un po’ di quell’entusiasmo ot-tocentesco, quasi che fossi stato anch’io della partita, accanto al mio conterra-neo Giuseppe Bandi” (Ant I, pp. 2064-2065).
20 Ant II, pp. 1191-1193 (“Ritorno a Custoza”, La Donna, gennaio 1964); cfr.ivi (La battaglia soda), p. 914.
21 A proposito del bombardamento di Capua, della prima seduta del Parlamentounitario, del colloquio col diplomatico prussiano von Bernhardi (Ant I, rispettiva-mente alle pp. 1254, 1264, 1279). Addirittura, lo storico di Daghela avanti unpasso! non si farà scrupolo di correggere una maliziosa e ingenerosa ipotesi delmemorialista de La battaglia soda a proposito delle cause della morte di Cavour(cfr. Ant I, p. 1266).
22 Siamo al secondo capoverso del romanzo: “A quei tempi, come ho già spie-gato, io comandavo un battaglione della brigata Basilicata, general ClementeCorte, primo reggimento” (Ant I, p. 739); cfr. ivi, con la medesima funzione, gliincisi analettici alle pp. 740, 744, 783, 797, 799, 822.
23 Ant I, p. 820.24 A parte puntuali riscontri fantastico-biografici, quella che va rilevata è la
coincidenza ideologico-sentimentale fra i due narratori: “Nostalgia, affetti fami-liari, attaccamento alla propria casa e alle proprie origini non sono soltanto un datopuramente ‘romanzesco’, ma più concretamente riportano ad una reale esperienzadell’autore, reduce dalla guerra nel 1945” (C. Angelini, Luciano Bianciardi, cit.,p. 87). Tuttavia, si tratta pur sempre di una strategia retorica di appropriazione del-l’esperienza altrui, di un discorso per ‘prosopopea’ – si confronti l’allure tragico-mica con cui viene condotto il racconto del bombardamento su Capua da partedelle milizie piemontesi (Ant I, p. 742 e infra), con la relazione scabra, iperreali-stica, vagamente allucinata e autenticamente vissuta del bombardamento su Fog-gia da parte dell’aviazione alleata (Ant I, p. 1979).
25 Varrà la pena di ricordare che la pagina di Bandi sul bombardamento diCapua era stata già citata per esteso, seppur adespota (“scrive uno che ci fu”), al-l’interno dell’XI capitolo di Da Quarto a Torino. Breve storia della spedizionedei Mille (Ant I, p. 446). In Daghela avanti un passo! il richiamo all’autorità deltestimone metterà in gioco, come già notato, non più, o non soltanto, il Bandi sto-rico de I mille, ma il Bandi reinventato de La battaglia soda – con una compli-cazione dei livelli di lettura prodotta dalla possibilità, che ci suggerisceBianciardi, di leggere come corpus coerente, non composto di pièces detachées,la sua complessa epopea risorgimentale che si chiude col Garibaldi postumo.
26 Si noti che di seguito all’invito di Bixio (“Non aveva dunque tutti i torti NinoBixio, quando mi consigliava a smettere la sciabola e a pigliare la penna” [Ant I,p. 916]), il narratore de La battaglia soda rivela che il primo germe dell’impresamemoriale è costituito dalle impressioni scritte a caldo sulla battaglia di Custoza,successivamente rielaborate ed inserite nel contesto più ampio dell’epopea gari-
125
CONVEGNO
baldina e risorgimentale: “Un po’ per ingannare la noia di que’ bivacchi, un po’ persfogare la rabbia infinita mia e dei miei compagni, decisi di seguire l’avviso diNino Bixio, e presi a scrivere, così alla brava […] le impressioni mie sulla gior-nata di Custoza” (ivi, pp. 915-916). In questo fittizio apparato genetico della me-moria che si fa scrittura è implicito un perentorio giudizio storico sul senso delprocesso unitario nazionale.
27 Vent’anni dopo i fatti d’arme, alla maniera di Bandi e di tutti i narratoriche restringono in prima battuta l’orizzonte del giudizio storico all’ottica dimi-diata ma puntuale della testimonianza, così Lussu aprirà la rievocazione del-l’anno in trincea: “Io non ho raccontato che quello che ho visto e mi hamaggiormente colpito. Non alla fantasia ho fatto appello, ma alla mia memoria”(Emilio Lussu, Un anno sull’Altipiano, Torino, Einaudi, 2000, p. 9).
28 Cfr. Ant I, p. 895.29 Cfr. ivi (Garibaldi), p. 1462. Il programma di umanizzazione dell’eroismo
garibaldino, e di demistificazione dei luoghi comuni dell’oleografia risorgi-mentale, dispiegato lungo la serie dei volumi dedicati da Bianciardi al Risorgi-mento, interessa i morti di Crimea, la ragione dei camiciotti rossi, la battaglia diCalatafimi, l’impavido attacco con la baionetta innestata, ovviamente l’incontrodi Teano, il grido “Roma o morte!”, la morte di Cavour (cfr. Ant I, rispettiva-mente alle pp. 1178, 1455, 338, 1190, 1252, 1268, 1515).
30 Indimenticabile in Daghela avanti un passo! la descrizione dell’approdoin Sicilia da parte della schiera dei Mille: “Della Sicilia avevano letto qualcosasui libri: la terra dei Vespri, la dimora di Vulcano, l’antro del Ciclope. Perché eratutta gente che leggeva. E scriveva […]. Ma per adesso, della Sicilia ignoravanotutto, ne avevano notizie vaghe e molto letterarie, oltre che sbagliate” (Ant I,1197).
31 Ant. I, p. 737. L’epigrafe è tratta, con leggere variazioni, dal II libro dell’Artedella guerra (Fabrizio Colonna risponde a Cosimo Rucellai): cfr. Niccolò Ma-chiavelli, L’arte della guerra. Scritti politici minori, a cura di Jean-Jacques Mar-chand, Denis Fichard e Giorgio Masi, Roma, Salerno, 2001, p. 115 (EdizioneNazionale delle Opere I/3).
32 Ant I, p. 880.33 “Per mia parte, ero ben contento di lasciare a questi lustrissimi signori uffi-
ziali la fatua gloria delle parate, e mi bastava a star lieto la buona coscienza d’aversempre fatto il mio dovere […] e sorte sommamente fortunata la dimestichezzache ebbi in quei mesi con il più grand’uomo dei nostri tempi, con un condottierod’armati che nella storia d’Italia ebbe pari a sé il solo Giovanni dalle BandeNere” (Ant I, p. 742).
34 La polemica contro l’astrattezza dei regolamenti militari e dei manualid’addestramento innerva la riflessione di Bianciardi sul Risorgimento; il narra-tore de La battaglia soda non può soffrire, per esempio, che “il fatto d’arme diMilazzo” venga ridimensionato da alcuni ufficiali d’accademia perché “non fu
126
BIANCIARDI, OTTOCENTO COME NOVECENTO
condotto secondo le buone regole della guerra moderna” (Ant I, p. 774; cfr.anche ivi, p. 1131).
35 Segnaliamo solo che il colto e letterato capitano Dossena coglie l’occa-sione per pregiare l’accuratezza topografica delle descrizioni di Dante: “Si po-trebbe quasi andare in battaglia con un dantino in tasca, sicuri di trovarlo piùpreciso di mille carte topografiche” (Ant I, pp. 884-885); altrove (in Aprire ilfuoco), invece, sarà proprio Garibaldi, “vecchio lupo di mare”, ad assicurare che“padre Dante non se n’intendeva gran che, di oceanografia” (Ant I, p. 935).
36 Cfr. Ant I, p. 829.37 Cfr. Ant I, pp. 872-874, e i capitoli XXXII-XXXIV del Viaggio sentimen-
tale lungo la Francia e l’Italia di Lawrence Sterne.38 Ant I, p. 830.39 Ivi, p. 864.40 L’acribia documentaria nel ricreare un mondo storico coerente si può mi-
surare anche attraverso dettagli narrativi apparentemente anodini; per esempio,il narratore ci informa che la fedele ordinanza, per ingannare la noia, “leggiuc-chiava la storia di Genoveffa di Brabante” (Ant I, p. 841): si tratta di una leggendasacra assai apprezzata all’epoca, più volte stampata nel corso del XIX secolo, so-prattutto in area toscana, dall’editore Sborgi di Volterra, nella sua collezione distampe popolari.
41 Cit. in C. Angelini, Luciano Bianciardi, cit., p. 86.42 Cit. in G. Lukács, Il romanzo storico, cit., p. 69.43 Jorge Luis Borges, Pierre Menard, autore del “Chisciotte”, in Id., Fin-
zioni, trad. it. di Franco Lucentini, Torino, Einaudi, 1995, p. 46.44 Cfr. ivi, p. 38.45 Ant I, p. 254.
127
CONVEGNO
Jole Soldateschi
La bella avventura che partì da Quarto
Da Quarto a Torino. Breve storia della spedizione dei Mille siapre con una dedica significativa, Al ricordo di mio padre, e nelrisvolto di copertina propone la dichiarazione ancora più esplicitadi un doppio debito:
Questo libro è dedicato al ricordo di mio padre perché fu lui, quandoio avevo appena gli anni per saper leggere, che mi mise in mano il librodei Mille. «L’ha scritto un nostro compaesano», mi spiegò. Infatti l’au-tore, Giuseppe Bandi, era nato a Gavorrano, un paese di minatori a pochichilometri da casa nostra. Da allora credo che non sia passata stagionesenza che io ragazzo rileggessi quelle pagine, illustrate col gusto veri-stico di fine secolo dal Della Valle. Guardavo i ritratti di Bixio, di Sir-tori, di Medici, di Türr, del colonnello Bosco (baffuto e con gli occhicattivi, perché borbonico), leggevo quella storia straordinariamente vi-vace, che mi appassionava più dei romanzi di Salgari e delle avventuredegli indiani. Quella per me fu una fortuna, perché nel libro c’era unastoria vera, e la più bella forse per un ragazzo italiano.
Ê un modo discreto e affettuoso per sottolineare che l’epopeagaribaldina ha costituito “un elemento culturale ben vivo, attua-lizzato del resto dalla lotta antifascista”1, nella temperie familiaree regionale in cui Bianciardi si è formato e ha influenzato la sceltadi uno spazio di indagine storica e di invenzione letteraria che simanifesta precocemente e avrà lungo corso nella sua carriera diintellettuale e di narratore.
Già nel 1952, sulla Gazzetta di Livorno del 4 maggio, infatti,Bianciardi aveva pubblicato un articolo breve, “La diversioneZambianchi”, sulla “sciagurata” spedizione inviata da Garibaldi,dopo lo sbarco di Talamone, a compiere azioni di disturbo all’in-terno dello stato pontificio; ha poi ripreso l’argomento nel gennaiodel 1960 su Historia (n.26) con un altro articolo più ampio, “Lastrana missione dello ‘scellerato’ Zambianchi”, che anticipa le pa-gine inserite all’interno di Da Quarto a Torino. La ricostruzione
129
CONVEGNO
dell’episodio è basata su fonti documentarie e storiografiche2; maBianciardi attribuisce la scoperta del “vero senso” di quell’episo-dio controverso e oscuro alle poche righe che ad esso dedica Giu-seppe Bandi ne I Mille. Da Genova a Capua3, proprio quel libroche il padre gli aveva messo in mano da ragazzo e che è stato de-finito da Croce “tra i libri di memorie garibaldine, uno dei piùlimpidi nel racconto e uno dei più persuasivi nel sentimento chelo anima”4. Non può stupire, quindi, che per I Mille Bianciardicuri le note (dettagliatissime e ricche di informazioni sui perso-naggi, anche minori, dell’impresa) quando nel 1955 Parenti ne ri-propone (a cura di Arnaldo Frateili) l’edizione Salani del 1902 escriva una Prefazione quando nel 1961 il Club degli Editori lo ri-pubblica. D’altra parte, all’interno del circuito autobiografico chesottende il suo progetto narrativo, ne L’integrazione affida pro-prio a una delle sue due proiezioni, Luciano Bianchi, la propostadi recuperare editorialmente le memorie garibaldine come ricettaper il consolidamento dell’identità nazionale, in stretto pendantcon la serie di inchieste sulla società italiana contemporanea sol-lecitate dal fratello Marcello, anche lui inserito nella “grossa ini-ziativa” culturale della casa editrice Feltrinelli:
Per esempio io gli dicevo che sarebbe stato bene cercare vecchie me-morie garibaldine, e studiarle. Gli dicevo che in fondo è ingiusto che inItalia i giovani conoscano meglio la guerra civile americana, e la guerracontro gli indiani, che non il nostro Risorgimento. Gli dicevo che certifatti della nostra storia ottocentesca, e le imprese garibaldine prima ditutto, meritavano d’essere conosciute, popolarizzate, tradotte magari infilm, perché oltre tutto erano avventurosissime, e pittoresche. «Possi-bile», gli dicevo, «che i nostri ragazzi sappiano chi è il generale Custered ignorino non dico chi fosse Antonio Mosto, ma addirittura non sap-piano nemmeno dell’esistenza di un Türr, di un Dezza, di un Sirtori, ge-nerali coi fiocchi, pei tempi loro. Altro che Custer!»5.
È logica conseguenza allora che, a ridosso della stesura de L’in-tegrazione (che però uscirà per Bompiani nel giugno del 1960),Feltrinelli, in occasione delle celebrazioni del centenario dellaspedizione dei Mille, commissioni proprio a Bianciardi un sag-gio che ricostruisca la storia di quella eroica vicenda. In alcune let-
130
BIANCIARDI, OTTOCENTO COME NOVECENTO
tere a Mario Terrosi si ricava il cammino compositivo ed editorialedi Da Quarto: il 1° agosto 1959 l’impegno è stato preso, il 15 di-cembre 1959 il libro è stato scritto (in un mese) e consegnato, il23 maggio 1960 è stato pubblicato e forse, si augura lo scrittore“è in vetrina anche a Grosseto”6.
Nel momento in cui si accinge a scrivere un’opera divulgativa,Bianciardi muove dall’idea di raccontare la verità su fatti che “lastoriografia ufficiale (quella che per successivi filtri si è travasatanei libri delle scuole, e cioè l’unica che per l’italiano medio contiqualcosa)” ha semplificato, rappresentando “il Risorgimentocome una specie di miracolo, non soltanto politico e militare, maanche psicologico: tante forze, tante idee, tanti uomini diversiavrebbero consapevolmente confluito in un unico intento patriot-tico. Cavour, Mazzini, Garibaldi, Vittorio Emanuele, e persino PioIX, tutti a braccetto, concordi nel proposito di fare l’Italia unagrande libera”7. Questa interpretazione guiderà sempre la sua let-tura di quei fatti, sia quando questi sono fondante materiale nar-rativo che quando sono occasioni liminari dei suoi articoli digiornale e persino delle sue rubriche televisive e sportive. Tra lemolte possibili citazioni, mi limito a ricordare un brano apparsoil 1° febbraio 1971 su AZ, “Il Risorgimento non è stato una qua-driglia”, che si configura come una sorta di autocommento retro-spettivo del proprio percorso di narratore storico. L’articolo nascecome recensione al film televisivo di Castellani e Lunari, Le cin-que giornate di Milano, che hanno il merito di aver scosso didosso alla gente “la retorica del Risorgimento oleografico, quellache vuole tutti a braccetto, Garibaldi, Mazzini, Cavour, VittorioEmanuele II e persino Pio IX, quattro persone che, nella realtà siodiavano come pochi altri cristiani (si fa per dire!) al mondo. Oggiil pubblico ragiona, vede il Risorgimento come la preistoria dellanostra condizione d’oggi, va a cercare le cause dei nostri disastri,vuole sapere, si chiede, per l’appunto, chi fosse in realtà Carlo Pi-sacane, e guarda la televisione […]”8.
Bianciardi qui attribuisce alla sensibilità dei due autori e del pub-blico quello che è stato il suo intento già nell’operazione di DaQuarto e che ancora di più lo è stato al momento della scrittura deLa battaglia soda, cioè far capire agli italiani che quell’epoca fu, inrealtà, “spesso convulsa, contraddittoria, a volte meschina: anche
131
CONVEGNO
piena d’errori dei quali siamo figli”9. Vedere quegli errori è, dun-que, riflettere sul presente: così, raccontando “una storia ambien-tata nel passato della nazione, al momento della sua fondazione”avventurosa, egli intende contribuire “a ristabilire i lineamenti diuna identità italiana originaria”10 che si forma e consolida attraversocontraddizioni che saranno determinanti per il futuro del paese.Tutta la sua narrazione dell’impresa dei Mille è costruita secondouna struttura che Maria Clotilde Angelini ha definito “manichea”11
perché è attraversata dall’idea di una contrapposizione tra “l’ener-gia essenzialmente democratica che si fa sentire in modo addirit-tura emblematico” nell’azione di Garibaldi12 e la cautela delconservatorismo monarchico incarnato da Cavour, attivamente ostilealla spedizione attraverso comportamenti ambigui e opportunisticiche vanno dal tentativo iniziale di sabotaggio a quello di controllodei successi militari in Sicilia, infine, dopo la liberazione di Napoli,all’invio delle truppe piemontesi a invadere lo Stato pontificio perbloccare la marcia delle camicie rosse. Ed è questa ultima mano-vra, “il più grande esempio del genio politico” del “diabolico conte”,a sancire la sconfitta dell’eroe dei due Mondi proprio “all’indomanidel grande trionfo”13: la conquista rivoluzionaria, infatti, viene in-terrotta dall’approvazione del decreto di annessione tramite plebi-scito dell’Italia meridionale allo Stato Sabaudo.
L’apologia della figura di Garibaldi e il giudizio estremamentenegativo che pende sulla figura di Cavour derivano dall’ottica par-tigiana insita già nel titolo (che rievoca quello famoso di GiuseppeCesare Abba, Da Quarto al Volturno. Noterelle d’uno dei Mille14,sottolineando però la piemontesizzazione dei risultati dell’impresagaribaldina) e dichiarata apertamente nella presentazione del libroche “non è certo spassionato, e forse nemmeno obbiettivo: in-somma io sto dalla parte di Garibaldi, non di Cavour, anche se poiebbe ragione il secondo…”. Così Bianciardi allo stesso tempo ri-vendica una posizione ideologica e giustifica la scelta “di rac-contare in breve la bella avventura che partì da Quarto, senzaalcuna specifica preparazione di storico (perché storico nonsono)”. Eppure, pur raccontando con passione, non rinuncia a unprogetto di “revisione critica dei miti risorgimentali” che colle-gano il suo lavoro a una già consolidata tradizione (letteraria estoriografica) destinata a trovare, una volta “esaurita la liturgia
celebrativa”, un nuovo e vigoroso sviluppo negli anni immedia-tamente successivi a Italia ’6115 . Certo, come rilevava MicheleRago, in una recensione al libro in L’Unità del 5 giugno 1960,Bianciardi si preoccupa soprattutto di correggere gli equivoci ac-cumulati “nei piccoli dogmi […] venduti a scuola”, già smasche-rati da tempo in sede scientifica ma resistenti nell’immaginariopopolare. Tuttavia non può sfuggire che l’interpretazione delloscontro tra quei due titanici protagonisti sembra prendere posi-zione a favore delle tesi di Denis Mack Smith contenute nei duevolumi che apparvero, con effetto dirompente, in traduzione ita-liana nel 1958 e nel 1959, Garibaldi e Cavour nel 1860 e Gari-baldi: una grande vita in breve. Né può sfuggire che la centralitàassegnata alla irrisolta questione meridionale nelle riflessioni con-clusive del volume (che presentano osservazioni rapide ma pre-gnanti sulla rinuncia a una riforma agraria da parte del nuovogoverno e sul problema del brigantaggio male affrontato e non ri-solto16) sembra inserire il libro nel solco dell’interpretazionegramsciana del Risorgimento come “rivoluzione mancata” e sem-bra avviare la possibilità di quel parallelo tra “deviazione del Ri-sorgimento” e “deviazione della Resistenza”, tra situazioneitaliana immediatamente post-unitaria e situazione italiana a pochianni dalla fine della guerra di Liberazione di cui ha parlato Tadinia proposito de La battaglia soda17. Questo è il paragrafo con cuitermina Da Quarto:
Parve a molti un miracolo quello che si compiva a Torino nella pri-mavera del ’61: ventidue milioni di italiani improvvisamente uniti in unsol regno. E miracolo fu veramente, ma insieme tremendo equivoco, checosterà agli italiani cento anni di dolorosissima storia: la guerra dei bri-ganti, le sommosse del ’66, l’immagine radicata nel popolo dello stato op-pressore, quello che esige le tasse e chiama a far la guerra, l’analfabetismomai sconfitto, mezzo milione di emigranti che ogni anno lasceranno que-sta ‘porca Italia’, l’unità più volte messa in pericolo ad ogni crisi nazio-nale, il razzismo interno che sempre ha serpeggiato sottile nel costumenostro, la mafia, la miseria. Son tutte cose che oggi si riassumono condue parole: ‘questione meridionale’; è un eufemismo che piace ai socio-logi, perché non dice la tragedia a cui soltanto allude. A tale ‘questione’noi non abbiamo ancora saputo dare una risposta, e son passati cento anni
133
da quando essa cominciò; da quando in Torino si proclamava solenne-mente l’Italia unita18.
È questa un’ipotesi di antistoria del Risorgimento che ha mo-delli letterari importanti, basti pensare a Verga, De Roberto e Pi-randello; e soprattutto ha in quel momento l’eco recentissima dellediscussioni suscitate dalla pubblicazione nel 1958 (ancora per Fel-trinelli) del romanzo di un altro scrittore meridionale: Il Gatto-pardo. Rispetto a Tomasi di Lampedusa, di cui condivide ilgiudizio di fallimento dell’utopia garibaldina, tuttavia, Bianciarditenta una sorta di recupero dell’aura epica di quello che resta unmomento straordinario di azione rivoluzionaria. Così, fondendouna situazione affettiva con una prospettiva ideologica e secondoil modo in cui il Risorgimento è entrato da subito per lui a far partedi un immaginario insieme storico e letterario, per proporre la suastoria della spedizione dei Mille utilizza come fonti documentarieprivilegiate le cronache dei memorialisti, che gli offrono il donodella verità del racconto e insieme l’entusiasmo della militanza. È,del resto, un’operazione autorizzata da un importante saggio sto-riografico, Garibaldi e i Mille (apparso in traduzione italiana nel1910 a Bologna per l’editore Zanichelli) di George Macaulay Tre-velyan, non casualmente citato in una nota di carattere bibliogra-fico apposta a Da Quarto e non di rado presente tra le righe deltesto, per certe informazioni minuziose di carattere politico e so-prattutto militare che assecondano l’interesse di Bianciardi per idettagli tecnico-strategici delle operazioni di guerra. Il saggio, in-fatti, è costruito attraverso accurate ricerche negli archivi inglesi enelle biblioteche italiane, ma anche, e secondo un progetto meto-dologico rivendicato apertamente dall’autore, attraverso “lo sfrut-tamento sistematico delle fonti orali, cioè delle interviste con itestimoni oculari dei fatti, che nel 1907 erano ancora molti”19 e at-traverso le narrazioni scritte dei volontari. Ed è, ancora di più,un’operazione sollecitata da Giani Stuparich, il quale, pubblicandonel 1948 l’ampio repertorio antologico di Scrittori garibaldini,nella Prefazione al volume sottolineava, dei testi presentati, la co-mune funzione di antitodoto alla retorica, all’esagerazione, con lequali la letteratura subito dopo l’unità aveva trasformato la realtàeroica in epopea ed elevato il fatto umano a mito:
134
BIANCIARDI, OTTOCENTO COME NOVECENTO
La semplicità epica di Garibaldi si offuscò negli atteggiamenti d’uneroe falsato; il sentimento diventò sentimentalismo, la poesia intima deifatti garibaldini esteriore oratoria. Nessun poeta ci salvò la vera essenzadi quel periodo eroico né si salvò; non parlo della schiera troppo nume-rosa dei minori e dei minimi, ma neppure nessuno dei grandi, né Car-ducci, né D’Annunzio, né Pascarella, né Pascoli.
[…]Bisognava che le terribili bufere di quest’ultimo trentennio di storia eu-
ropea, anzi mondiale, in cui fummo coinvolti, passassero sui boschi e suigiardini della nostra tarda letteratura patriottica, perché alberi di magnaapparenza ne fossero d’un colpo sradicati e aiuole cancellate e piante epianticelle buttate all’aria, con tutte le boriose e lustreggianti foglie, in unpovero trascurabile mucchio. Ma ecco, sul paesaggio crudelmente dira-dato, quando avremmo creduto di scorgere il deserto, ecco alzarsi qua elà, superstiti e belli d’una loro casta e tranquilla bellezza, alcuni arbustiancor vivi e freschi nei rami e nelle foglie, suggestivi. E in questa sug-gestione ritrovammo ciò che pensavamo d’aver perduto: la concreta epi-cità, la poesia dei fatti garibaldini e del loro ispiratore.
Erano le pagine di diario dei volontari, scritte lì per lì, sul taccuino chesi prendeva in fretta dalla tasca, tra un’azione e l’altra, ‘nelle notti in-sonni, a punti di luna’, per annotarvi le cose memorabili; erano i ricorditrascritti dopo venti anni dalla mente che li aveva conservati nella lorogiusta luce. Modesti come i loro autori, quasi vergognosi d’uscire inpubblico20.
Nella scelta allestita da Stuparich compaiono: Quel che vidi equel che intesi di Nino Costa, Da San Martino a Mentana. Ricordidi un volontario, di Giulio Adamoli, I Mille di Giuseppe Bandi, leMemorie di un garibaldino di Eugenio Checchi, Con Garibaldialle porte di Roma di Anton Giulio Barrili, le Impressioni di unvolontario all’esercito dei Vosgi di Achille Bizzoni. Bianciardi uti-lizza come testi di riferimento quelli il cui racconto coincide conla cronologia affrontata in Da Quarto: dunque I Mille e i ricordi diAdamoli. Di molti altri attesta l’avvenuta consultazione nella giàricordata nota bibliografica: tra questi, il Giornale della spedizionedi Sicilia di Ippolito Nievo e le Noterelle di Giuseppe Cesare Abba,ai quali aggiungerei La Camicia rossa di Alberto Mario21. Al di làdei diversi risultati letterari raggiunti, gli scrittori dei diari e delle
135
CONVEGNO
memorie conservano la “visione autentica” dei tempi e del climadelle grandi azioni che vennero compiute, perché le narrano dal didentro mentre esse accadono, annotando in tempo reale “le cosememorabili” sul taccuino, e si impegnano a raccontare solo quelche videro e sentirono in una sorta di patto autobiografico col let-tore, cui restano fedeli anche quando trascrivono i loro ricordi dopovent’anni e più22. Nelle loro pagine troviamo, così, “episodi spessoritenuti minori o trascurati dalla vulgata garibaldina”23: esempi dieroismo dei grandi ma anche di uomini semisconosciuti e insiemele miserie della vita militare, i dissidi tra i capi, gli atti di violenzagratuita di alcuni di loro, anche la casualità a volte della gloria.Questo avviene soprattutto ne I Mille, che mantengono, al mo-mento della rielaborazione dei taccuini originari, ventisei annidopo la conclusione della spedizione, l’impronta di immediatezzadella scrittura in diretta che sfugge a qualsiasi tipo di falsificazioneideologica o letteraria. Mi riferisco in particolare alla pagina fa-mosa (non a caso riassunta da Bianciardi)24 nella quale, con lapragmatica lucidità di chi è abituato al combattimento, Bandismonta la leggenda di una delle frasi più celebrate dalle storie ri-sorgimentali, che sarebbe stata pronunciata da Garibaldi nel mo-mento culminante della battaglia di Calatafimi, “Nino, qui si fal’Italia o si muore”:
Ma è fama che in quel momento disperato, Nino Bixio dicesse a Ga-ribaldi: «Generale, ritiriamoci!». Ed è fama che Garibaldi rispondesse aBixio: «Ma dove ritirarci? …». Quelle parole non giunsero a’ miei orec-chi, e io debbo registrarle sulla fede degli altri, senza però mettere in dub-bio che fossero pronunziate veramente, perché così la domanda come larisposta mi paiono naturalissime ed adattate quanto mai alle strettezzeangosciose di quell’ora25.
Ma mi riferisco anche ai luoghi sparsi dove vengono sottoli-neate l’astensione da un qualsiasi impegno da parte del governopiemontese nei confronti della spedizione, l’ambigua soluzione deiplebisciti, l’ostilità violenta e reciproca di Garibaldi e Cavour, le di-vergenze tra Garibaldi e Mazzini, sino alla discordia26. Queste an-notazioni27 veicolano proprio quella lettura antiretorica di cui ha
136
BIANCIARDI, OTTOCENTO COME NOVECENTO
parlato Stuparich e che abbiamo visto essere l’ottica dominanteche Da Quarto si propone.
D’altra parte nelle cronache di Bandi e dei suoi compagni diviaggio Bianciardi trova (e riproduce nella sua) la figura di un “Ga-ribaldi indimenticabile”28, fissato “in aspetti, sempre uguali, arric-chiti via via di particolari e sfumature nuovi”29. L’eroe leggendariosuscita rispetto per la sua audacia e la sua competenza militare edevozione per le sue qualità morali. Compie imprese miracolosedurante le quali è assistito dall’abilità e dal coraggio ma anche dauna fortuna fatale; è dotato di un fascino che travolge i suoi uominima anche le folle che lo acclamano quando “bello e raggiante” at-traversa le strade e le piazze delle città conquistate; è il “cavaliere”della libertà capace però di “obbedienza alla volontà d’un solo”, ilsuo re; è, insomma, un soldato e un capo “degno de’ tempi eroici diGrecia e di Roma” al quale è giusto dedicare un monumento carta-ceo in attesa di uno scultore che lo modelli “dritto come sta SanGiorgio effigiato da Donatello”30. Se da un lato c’è già la statua,dall’altro c’è anche, però, l’uomo nella sua “quotidiana vicenda”31.Bandi addirittura, che “ebbe la singolare ventura” di trovarsi al suofianco “quasi di continuo, da Quarto al Volturno”32, ha fatto di que-sta prospettiva privilegiata lo strumento principale per studiarlo“nella intimità della casa” e per “paragonare quest’uomo straordi-nario, veduto e ammirato dalla gente sul suo cavallo da battaglia ein mezzo alle schiere” con “l’uomo, che, posate le armi, e depostele insegne del comando, si rivelava nelle sue vere e semplici sem-bianze agli occhi dei familiari”33. Anche questo è il Garibaldi chepassa nelle pagine di Da Quarto: mentre mangia cacio e baccelli,mentre prende il suo caffè e fuma il suo sigaro, mentre sbucciaun’arancia e la distribuisce ai plenipotenziari borbonici, mentredorme all’addiaccio e si risveglia coi dolori dell’artrite, mentre si ci-menta in versi guerreschi poco apprezzati dai suoi soldati che scel-gono come inno la più popolare “Bella Gigogin”, mentre cede allavanità di fronte all’ammirazione fanatica dei popolani. È un eroe in“maniche di camicia”, le cui debolezze sono comunque confermadella dignità e dell’autenticità della sua indole e sono insieme oc-casione di rinnovargli l’amore incondizionato che si deve a un padrevenerato. Per Bianciardi, insomma, come per le sue fonti, Garibaldiresta comunque intoccabile, tanto da fargli sottovalutare le respon-
137
CONVEGNO
sabilità della sua direzione politica e di quella di alcuni dei suoi luo-gotenenti. Il riferimento ovvio è ai fatti sanguinosi di Bronte (il cuiracconto viene affidato, in apertura del capitolo ottavo, alla ripro-duzione di una pagina famosa della novella Libertà di Verga) cheper il Dittatore appaiono “un puro e semplice intralcio, imprevistoe per lui incomprensibile” e per Bixio una “missione maledetta”,inadatta a un uomo della sua natura, ma resa inevitabile dalla ne-cessità di mantenere l’ordine sociale nell’isola appena liberata34. Eresta grande, di una grandezza che nel segno della rinuncia lo assi-mila a certi personaggi classici, anche nel momento della umilianteliquidazione del suo esercito, subito dopo il bombardamento diCapua35, e della sua partenza per l’esilio volontario di Caprera(anche in questo caso ritratto sulla falsariga delle pagine di Bandiche, con un tasso ovviamente più elevato di emotività, riproducedal vivo la tristezza malinconica dell’ora ma anche la dignità se-rena della vittima dell’intrigo politico):
La mattina dell’8 presentarono solennemente al re i risultati del ple-biscito, e Garibaldi colse quest’ultima occasione per ripetere la pre-ghiera: accettassero i suoi ‘figlioli’ nell’esercito regio, ma nemmeno inquesto fu accontentato: la commissione già cominciava a fare lo‘spurgo’. Allora se ne tornò al suo alberguccio verso il mare, l’HotelGran Brettagna.
[…]Col figlio a pochi altri vegliarono fino a notte al Gran Brettagna:
erano le due quando fecero venire tre carrozzelle di piazza che li me-nassero al porto. Aspettarono giorno a bordo dello Washington, poi sa-lirono in una lancia e andarono a trovare l’ammiraglio Mundy. A bordodello Hannibal egli li ricevette proprio nella sala dove a Palermo s’eranoincontrati con i parlamentari borbonici. Conversarono a lungo, poi Ga-ribaldi firmò il registro dei visitatori e prese congedo. I marinai inglesiavevano le lacrime agli occhi, e quando lo Washington levò le ancore, fu-rono le salve dei loro cannoni a dargli l’ultimo addio.
Andavano a Caprera: compagni di viaggio gli furono il figlio Me-notti, il segretario Basso, Froscianti e Gusmaroli, l’ex parroco. Con séGaribaldi portava un sacco di sementi, qualche libbra di caffè e di zuc-chero, una balla di stoccafissi, una cassa di maccheroni e poche migliaiadi lire “risparmiate, senza che ei lo sapesse, da chi gli teneva i conti.”36
138
BIANCIARDI, OTTOCENTO COME NOVECENTO
E allora possiamo fare un passo avanti e affermare che quellecronache, quei diari offrono qualcosa di più di un repertorio già fe-licemente confezionato di fatti e impressioni, sia pure prezioso.Forniscono la possibilità di una identificazione con l’ottica nar-rativa di chi li scrisse. Non a caso nel già citato risvolto di coper-tina Bianciardi si augura di aver messo nel suo racconto della“bella avventura che partì da Quarto […] un po’ di quell’entusia-smo ottocentesco, quasi che fossi stato anch’io della partita, ac-canto al mio conterraneo Giuseppe Bandi, dietro al ‘grandevecchio’ e a Bixio, che cento anni fa aveva esattamente gli annimiei”, sottolineando così nelle sue fonti e invocando per sé un at-teggiamento ideologico e sentimentale e insieme un atteggia-mento narrativo. Sia ora presentando Da Quarto che più tardipresentando Daghela avanti un passo! insiste infatti sulla qualitàromanzesca di quelle storie straordinariamente vivaci, più appas-sionanti “dei romanzi di Salgari e delle avventure degli indiani”37.L’aura di “meravigliosa avventura”, frutto di una stagione indivi-duale e collettiva di giovinezza gioiosa e operosa, è d’altra partesottesa alla scrittura di tutti i memorialisti garibaldini. Lo ha rile-vato Gaetano Mariani a proposito, tra gli altri, di Nievo (“Ma ilvolto che vien fuori dalle pagine che il poeta ci ha lasciato sullaspedizione dei Mille è, sì, il volto pensoso del giovane che ha sullespalle un grosso impegno e vuole assolverlo nel miglior modopossibile, ma è anche il volto sorridente dell’eroe che affronta unameravigliosa avventura”) e dello stesso Bandi (che, “forse piùd’ogni altro scrittore garibaldino, conservò per tutta la vita la no-stalgia dei giorni gloriosi in cui egli, ufficiale dell’esercito rego-lare, aveva abbandonato il suo reggimento per seguir Garibaldi inSicilia”); lo ha affermato Giorgio De Rienzo a proposito di Abba(“Il ‘sogno siciliano’ di Abba sta in questa nostalgia di un’alle-grezza perduta, di un’operosità istintiva smarrita, che non patteg-gia con le ragioni squallide del mondo, che si pone fuori delleragioni del mondo, che trova in se stessa, autonomamente, le pro-prie ragioni. E la decorazione di Abba ha appunto questo signifi-cato, di fissare per sempre, quasi con ‘parole trapunte a caratterigrandi d’oro’, un sogno perduto, di imbalsamare una stagione divita splendida”)38. E quest’aura resta sottesa alla lettura che Bian-ciardi dà della vicenda risorgimentale ogni volta che tornerà ad
139
CONVEGNO
occuparsene (ribadita con una serie di riprese tipiche del suo si-stema intracitazionale)39: anche quando, nelle sperimentazioni trastoria e invenzione de La battaglia soda e di Aprire il fuoco, de-clinerà sempre più dolorosamente all’insegna del mito storico ilproprio mito personale. Ma non spetta a me occuparmi di questo.Ciò che mi spetta, invece, è segnalare che già in Da Quarto vienemessa a fuoco la possibilità, da parte del narratore, di farsi testi-mone-cronista interno della Storia (quella con la esse maiuscolaintendo), se non ancora attore, come accadrà nei due romanzi ap-pena citati, attraverso il calco delle pagine dei memorialisti, so-prattutto di quelle de I Mille, che funzionano come un sottotestosul quale rivivere e quindi riscrivere una storia (e questa volta conla esse minuscola).
Quando il materiale delle cronache e dei diari ottocenteschi,attraverso il montaggio delle citazioni virgolettate o il riassuntomimetico di esse, sostiene la narrazione, essa assume un tono po-polaresco che alterna e fonde accenti epici, drammatici e comico-realistici. Così il viaggio per mare è il cammino verso e attraversol’ignoto contrappuntato dal ricordo degli affetti lasciati a casa edalle speranze di gloria, ma è anche il quotidiano e ridicolo con-fronto con “il capogiro e gli stomacucci” che non risparmianonessuno dei futuri eroi. Così la terra di Sicilia ci viene presentatamitica e lontana attraverso le fantasie letterarie che i volontari ela-borano prima dello sbarco, poi assolata e brulla, scarsamente po-polata di gente che parla una lingua “turca” e mostra una cautelache sfiora la diffidenza nell’accogliere i liberatori. Cosi la guerraappare per come è davvero: l’occasione fortemente voluta per ilriscatto nazionale e per la messa alla prova del coraggio indivi-duale sino al sacrificio di sé; ma anche una sequenza infinita di di-sagi che devono essere sopportati con la disciplinata abitudine allafatica e alla sopravvivenza e con la capacità di sdrammatizzarli.Basti pensare alla descrizione della battaglia di Calatafimi, con-dotta sulla falsariga del Bandi, dove il succedersi delle scene,quasi cinematografiche, l’avanzata, il primo fuoco, l’attacco, loscontro cruento, danno vita a “un quadro grandioso ed emozio-nante”40; ma anche al racconto della marcia verso Palermo deiprimi Mille che in “una notte da tregenda” avanzano sotto la piog-
140
BIANCIARDI, OTTOCENTO COME NOVECENTO
gia, “alla cieca su sentieri fangosi, fradici fino alle ossa”41, alleprese con i cannoni che sprofondano nella melma e con l’istericaviolenza di qualche comandante (“In quella gran confusione NinoBixio perse la testa, infastidito dal continuo nitrire di un cavallo,si mise a gridare che il nemico avrebbe sentito, e finalmente trasseil revolver e ammazzò la povera bestia”42); e, infine, alla scenadell’ingresso in Palermo che viene introdotta con un brano di unalettera “quasi festosa”43 del volontario Ippolito Nievo. Vale la penariportare più estesamente (rispetto alla citazione contenuta in DaQuarto) questo testo ormai famoso, nel quale coesistono “la spon-tanea capacità d’entusiasmo e l’indipendenza del giudizio”44, ildesiderio di comunicazione sentimentale e la vocazione narrativa:
I Picciotti […] fuggivano d’ogni banda: dentro pareva una città dimorti; non altra rivoluzione, che sul tardi qualche scampanio. E noi soli,ottocento al più, sparsi in uno spazio grande quanto Milano, occupatisenz’ordine, senza direzione (come ordinare e dirigere il niente?) allaconquista d’una città contro venticinquemila uomini di truppa regolare,bella, ben montata, che farebbe la delizia del Ministro La Marmora! Fi-gurati che sorpresa per noi straccioni! - Io era vestito come quando par-tii da Milano; mostrava fuori dei calzoni quello che comunemente nonsi osa mostrar mai al pubblico, e portava addosso uno schioppettone checonsumava quattro capsule per tirare un colpo - per compenso aveva unpane infilato nella baionetta, un bel fiore di aloè sul cappello, e una ma-gnifica coperta da letto sulle spalle alla Pollione. - Confesso che era bel-lino - Il Generale era stupendo anch’esso. - Egli restò sempre in manichedi camicia: aveva sopra di me il solo vantaggio che i suoi calzoni inveceche rotti erano rappezzati. Entrò in Palermo con quaranta uomini, con-quistò Piazza Bologna con trenta, e credo che fosse solo o tutt’al più incompagnia di suo figlio quando pose il piede in Palazzo Pretorio. - Noiintanto correvamo per vicoli per contrade per piazze due qua, uno làcome le pecore, in cerca dei Napoletani per farli sloggiare, e dei Paler-mitani per far loro fare la rivoluzione o almeno qualche barricata45.
L’ambivalenza della scrittura investe anche la raffigurazionedei personaggi dell’avventura: in parte l’abbiamo accennato a pro-posito dello stesso Garibaldi, ma ancora di più funziona su tutti glialtri uomini della spedizione che non hanno il carisma inattacca-
141
CONVEGNO
bile del Dittatore e vengono spesso ritratti attraverso un realismoabbassato che sfrutta le risorse dell’ironia indulgente per costruirepiccoli ritratti pittoreschi ai limiti della caricatura. Mi limito a ci-tare la presentazione dei Cacciatori delle Alpi al momento del-l’imbarco a Quarto:
I Mille non ebbero mai, almeno fino a Palermo, una divisa, né eb-bero gradi o galloni gli ufficiali. Ognuno vestiva a suo piacimento, por-tava cioè i panni che aveva indosso arruolandosi: Sirtori portava lapalandrana nera e il cilindro in testa, Crispi un soprabito stretto e logoro;Carini il berretto all’inglese, con tesa sia davanti che didietro; IgnazioCalona, un siciliano sessantacinquenne, rivoltoso nel ’20, combattentenel ’49 e nel ’59, nonostante la rischiosa sua carriera e l’età avanzata,non rinunciava all’abito rosso, al cappellone nero alla Rubens, con tantodi penna di struzzo. I tre sacerdoti avevano adattata la tonaca, pur senzamai togliersela, alle necessità dell’avventura46 .
Certo, se gli scrittori garibaldini non hanno avuto l’ambizionedi fornire quadri completi di un’epoca, d’una vicenda complessa,ma semplicemente quella di collegare, “dalla memoria e da vec-chie annotazioni, cose da loro vissute”47, Bianciardi nella sua“cronaca” si impegna anche in un’analisi politico-sociale che atratti cade “in una polemica non sempre sostenuta con rigore eneppure con troppa coerenza narrativa”48. Ma sono proprio il rap-porto simpatetico instaurato con il materiale letterario ottocente-sco e la capacità di riprodurne al vivo i fatti e l’atmosfera checonferiscono al suo lavoro quelle “impennate improvvise”49,quella felicità del racconto che, a mio avviso, lo definiscono e lodistinguono da altri lavori di storiografia divulgativa.
142
BIANCIARDI, OTTOCENTO COME NOVECENTO
1 V.Abati, Bianciardi nostro coetaneo, in il gabellino, n.11, giugno 2005,Dossier 12, p.17.
2 Cfr. l’ampia trascrizione, che commentata ironicamente occupa buona partedell’articolo, del resoconto dello scontro con i pontifici apparso nella sezione“Cronaca contemporanea”, Roma, 25 maggio 1860 della Civiltà Cattolica, Announdecimo, vol.VI della Serie quarta, 1860 (l’articolo compare ora in L.Bian-ciardi, L’antimeridiano. Tutte le opere, a cura di Luciana Bianciardi, MassimoCoppola e Alberto Piccinini, vol.II: Scritti giornalistici, Milano, ExCogita Edi-tore, 2008, pp.33-36). Cfr. anche i due volumi Garibaldi, Firenze 1882, di Giu-seppe Guerzoni che fu aggregato alla spedizione dello Zambianchi prima diraggiungere i Mille a Milazzo.
3 I Mille furono pubblicati in appendice sul Messaggero di Roma e sul Telegrafodi Livorno nel 1886; dopo la morte dell’autore furono raccolti in volume nel 1902dall’editore Salani di Firenze. La scoperta del “vero senso” della spedizione Zam-bianchi è dichiarata da Bianciardi nella sua Prefazione, in G.Bandi, I Mille. Da Ge-nova a Capua, Milano, Club degli Editori, 1961, p.X. Riportiamo, infine, la paginadi Bandi dedicata all’episodio: “Fin da quando concepì l’idea della mirabile suaimpresa della liberazione del mezzodì d’Italia, Garibaldi ebbe sempre fisso il pen-siero della necessità di aiutarsi col dar faccende al papa, sia per impedire a questidi dar man forte al Borbone, sia per assalire vantaggiosamente anche alle spalle, perla parte de’ domini pontifici, il nemico che con tanta audacia andava assalendo difronte. Così, non appena sbarcato nel golfo di Talamone, lanciò oltre i confini delloStato della Chiesa la banda dello Zambianchi, sperando che la poca favilla potessesuscitare qualche gran fiamma, e che i popoli insofferenti del turpe giogo de’ pretisalutassero colle armi in mano il vessillo liberatore che si spiegava in suo nome. Ilsuccesso non coronò quell’impresa, e io non dirò le ragioni per cui fallì, essendo fa-cile ad ognuno il comprendere come uno scarso manipolo, guidato da un capo dipoca o punta riputazione ed inetto per soprappiù, fosse a tutt’altro buono che ad in-coraggiare le popolazioni, atterrite dal recente esempio di Perugia debellata, ed in-certe se le camicie rosse dello Zambianchi fossero veramente l’avanguardiadell’esercito di re Vittorio” (pp.257-258 dell’edizione 1961 da cui provengono tuttele successive citazioni).
4 B.Croce, Letteratura garibaldina, in La letteratura della nuova Italia,vol.VI, Bari, Laterza, 1940, p.8.
5 L.Bianciardi, L’integrazione, Milano, Bompiani, 1960, in L.Bianciardi,L’antimeridiano. Tutte le opere, a cura di Luciana Bianciardi, Massimo Cop-pola e Alberto Piccinini, vol.I: Saggi e romanzi, racconti, diari giovanili, Milano,ExCogita Editore, 2005, p.517.
6. Citiamo più ampiamente le lettere perché ci offrono un flash dissacrante suimeccanismi dell’industria culturale e, soprattutto, perché presentano all’origineun’autovalutazione sulla buona qualità del proprio lavoro di risorgimentalista de-stinata a ripetersi almeno a proposito de La battaglia soda (Milano, Rizzoli, 1964):
143
CONVEGNO
1° agosto 1959: “L’ Integrazione l’ho consegnata a Feltrinelli, avvertendolo ancheche nel libretto si parla di lui. Sennò lui non se ne sarebbe nemmeno accorto, grevecom’è. Ora devo fare un lavoro sulla spedizione dei Mille, poi tradurre la solita va-langa di roba” (p.29); 15 dicembre 1959: “Con Feltrinelli mi son comportato pro-prio così. Volevano un libro sulla spedizione dei Mille, e me lo han chiesto. Hodetto loro che mi dessero almeno quattro mesi di stipendio per fare le ricerche escriverlo. Tutti d’accordo; ho scritto il libro, che è subito sembrato bellissimo, e cheuscirà ad anno nuovo…” (p.51-52); 23 maggio 1960: “Nel frattempo è uscito unaltro libro mio, che forse è in vetrina anche a Grosseto. Si tratta di una storia sullaspedizione dei Mille, e s’intitola Da Quarto a Torino. Anche quello lo consegnaifinito il 1° dicembre, e lo scrissi in un mese. A metà di aprile non era andato an-cora in tipografia. Passandoselo da un ufficio all’altro si era smarrito, e nessuno loritrovava. Ho dovuto da solo fare le illustrazioni e le cartine, scrivermi il risvoltopubblicitario, farmi una recensione sotto falso nome. Volevano persino che an-dassi al museo a farmi fotografare accanto a un cimelio garibaldino; ma questo nonl’ho tollerato. (Se ti capita fra le mani quel libro leggilo, perché dicono che siabello)” (pp.53-54) (in M. Terrosi, Bianciardi com’era. Lettere di Luciano Bian-ciardi ad un amico grossetano, Grosseto, Il Paese Reale, 1974).
7 L.Bianciardi, Da Quarto a Torino. Breve storia della spedizione dei Mille,in L’antimeridiano, vol.I, cit., p.287.
8 In L’antimeridiano, vol.II, cit., p.1813. Cfr. anche dall’Epilogo di Daghelaavanti un passo!, il secondo saggio divulgativo sulla storia del Risorgimentopubblicato nel 1969 a Milano per Bietti: “Occupata Roma, il Risorgimento fi-niva. E gli italiani cominciavano a innalzare monumenti ai ‘padri della Patria’,che uno alla volta abbandonavano questa nostra penisola tribolata e ‘miraco-lata’. […] A ciascuno il suo bel monumento, tutti ben alti sul loro piedistallo, danon poterli toccare con le nostre mani. E sarà fin troppo facile far credere che ilRisorgimento sia stato possibile grazie all’opera concorde di questi uomini, egrazie allo ‘stellone’ d’Italia. La verità, come abbiamo visto, è un’altra. La ve-rità è che fra questi uomini spesso non vi fu concordia, ma avversione e odio, di-screpanza e irresolutezza» (in L’antimeridiano, vol.I, cit., p.1306). Cfr., infine,dalla rubrica “Televisione” in Le Ore: “…Di liete voglie sante”, 8 agosto 1963:“[…] nelle puntate scorse si è visto un signore anziano e malfermo presentarsia rispondere a domande sul Risorgimento (ed era il Risorgimento delle scuole,quello che presenta Mazzini e Cavour, Garibaldi e Pio IX tutti d’accordo, a brac-cetto, per fare l’Italia unita)”; “Vigili su se stessi oltre che sul nemico”, 7 mag-gio 1964: “A un poeta, Alfonso Gatto, il compito di celebrare l’anniversario dellaLiberazione: giustissimo, perché solo attraverso i modi della poesia si è certi dipoter celebrare evitando le secche della retorica. Il rischio c’è, palese, e noi cicademmo cento anni or sono, quando si fece un mazzo d’ogni pianta, e si arrivòall’oleografia vieta: Garibaldi, Mazzini, Cavour, Vittorio Emanuele, Pio IX, chenel mondo di là giocano a carte e brindano alle fortune d’Italia. Bastava e avan-
144
BIANCIARDI, OTTOCENTO COME NOVECENTO
zava per liquidare il Risorgimento, quello vero, nella tradizione popolare” (inL’antimeridiano, vol.II, cit., rispettivamente pp.910 e 956).
9 E.Tortora, “Bianciardi ha scritto le prime righe del suo nuovo romanzo sto-rico”, in La Nazione, 10 agosto 1963.
10 E.Tadini, Introduzione, in L.Bianciardi, La battaglia soda, Milano, Bom-piani, 2003, p.V.
11 M.C.Angelini, Bianciardi, Firenze, La nuova Italia, 1980, p.82.12 E.Tadini, Introduzione, cit., p.VI.13 Da Quarto a Torino, cit., p.410.14 Con questo titolo definitivo il volume apparve a Bologna per Zanichelli
nel 1891; in prima edizione e con il titolo Noterelle d’uno dei Mille edite dopovent’anni, ivi, 1880.
15 A.Nozzoli, Anna Banti e il Risorgimento senza eroi, in Voci di un secolo. DaD’Annunzio a Cristina Campo, Roma, Bulzoni, 2000, p.392. Anna Nozzoli ri-corda anche gli “aggiornamenti e rettifiche di non poco conto” “alla vulgata ri-sorgimentale più tipicamente scolastica” apportati, già nel decennio precedente, dadue lavori di sintesi come L’antistoria d’Italia di Fabio Cusin, del 1948, o Italia,nascita di una nazione “di uno storico non professionale come Mario Schettini, del1959” (ibid., p.393).
16 Cfr., all’interno del capitolo XII, le pp.456-457: “Il governo di Garibaldiera stato ben lungi dal risolvere o addirittura dal porsi la questione sociale, que-sto è vero; ma quello dei piemontesi, nel suo astratto e sciocco rigore nella suadeliberata incomprensione dei bisogni di quel popolo, favoriva scopertamente ivecchi ceti possidenti (senza però nemmeno guadagnarsene l’appoggio) oppurecreava un nuovo ceto di funzionari ottusi e sgraditi ai governati. Così la rivoltasociale si aggravava e si complicava per il colore politico reazionario che as-sunse. La mancata conquista di Roma lasciava alle spalle del Napoletano un’ot-tima base di appoggio per la guerriglia, che ormai si stava organizzando. DalQuirinale Francesco II e i suoi generali […] potevano alimentare e dirigere laguerra delle bande, una guerra che durerà quattro anni. […] la guerra più oscura,più feroce e più sanguinosa che mai fin allora avesse sostenuto un esercito italiano”.
17 E.Tadini, Introduzione, cit., pp.VI-VII.18 Da Quarto a Torino, cit., pp.457-458. Cfr. anche nell’Epilogo di Daghela
avanti un passo!, cit., p.1306: “La verità è che il Risorgimento fece l’Italia qualepoi ce la siam trovata noi italiani, lacerata e divisa. Divisa fra italiani ricchi e ita-liani poveri. Fra italiani del nord e italiani del sud. Fra italiani dotti e italianianalfabeti. Tutte divisioni che oggi noialtri italiani, faticosamente, penosamente,stiamo cercando di colmare. Ma per far questo dobbiamo sapere la verità sucome l’Italia fu fatta”. E, per la resistenza di questa lettura, cfr., ancora, “Il Ri-sorgimento non è stato una quadriglia”, in AZ, 1° febbraio 1971: “Di lì nacqueil filo conduttore dell’Unità d’Italia: unità conseguita attraverso la conquistaregia dei sovrani piemontesi, la dabbenaggine di Garibaldi, il generoso sacrifi-
145
CONVEGNO
cio di Carlo Pisacane e dei fratelli Bandiera, giù giù fino alla più cruenta e la piùcrudele fra le guerre del nostro Risorgimento, una guerra di cui a scuola non cidicono nulla: la guerra dei briganti. Che fu, sia pure in scala minore, l’equiva-lente della contemporanea guerra di secessione nordamericana. Le plebi del Me-ridione, liberate da Garibaldi, e poi sottomesse da Vittorio Emanuele, nonaccettarono l’occupazione italiana, come non avevano accettato quella angioinae quella aragonese, e cominciarono la rivolta. Li chiamavano briganti perchénon accettavano il governo forzoso dei settanta battaglioni (lo racconta d’Aze-glio) tenuti fermi dal Piemonte nel Meridione assoggettato. In realtà erano pa-trioti, che difendevano la propria libertà e il proprio diritto a non pagare la tassasulla farina e a non fare il soldato con le mostrine del Re” (in L’antimeridiano,vol.II, cit., pp.1815-1816).
19 W. Maturi, Interpretazioni del Risorgimento. Lezioni di storia della sto-riografia, Prefazione di Ernesto Sestan, Aggiornamento bibliografico di Rosa-rio Romeo, Torino, Einaudi, 1962, p.576.
20 G.Stuparich, Prefazione, in Scrittori garibaldini, a cura di Giani Stupa-rich, Milano, Garzanti, 1948, pp.XVI-XVIII.
21 Queste le prime edizioni in volume: Quel che vidi e quel che intesi, Milano1927; Da San Martino a Mentana. Ricordi di un volontario, Milano 1892; Me-morie di un garibaldino, Milano 1888 (col titolo Memorie alla casalinga di ungaribaldino, Livorno 1866); Con Garibaldi alle porte di Roma, Milano 1895;Impressioni di un volontario all’esercito dei Vosgi, Milano 1874; La Camiciarossa, Torino 1870 (prima a puntate nel 1869 sulla Rivista contemporanea). IlGiornale della spedizione di Sicilia apparve sul Supplemento n.196 del Pun-golo (giugno 1860); poi, col titolo Diario della spedizione dal 5 al 28 maggioin I.Nievo, Opere, a cura di Sergio Romagnoli, Milano-Napoli, Ricciardi, 1952;ora nell’Appendice a I.Nievo, Lettere garibaldine, a cura e con Prefazione diAndreina Ciceri, Torino, Einaudi, 1961. Per le Noterelle cfr. la nota 14 e per IMille cfr. la nota 3.
22 Cfr. G.Stuparich, Prefazione, cit., p.XXVII: “Non scrivono storia, non ri-fanno su alcuni elementi di fatto quadri completi di un’epoca, d’una vicendacomplessa, ma semplicemente riproducono e collegano, dalla memoria e da vec-chie annotazioni, cose da loro vissute. ‘Quel che vidi e quel che intesi’ intitolaaddirittura il Costa il suo libro di ricordi. Il Bandi, rivolgendosi all’amico che loha indotto a narrargli la campagna di Sicilia, dice: ‘vuoi ch’io ti racconti quel chevidero i miei occhi e udirono i miei orecchi’; e il Barrili: ‘ma badate, non è lastoria delle operazioni che io faccio, sono i ricordi miei che metto in carta, le miesensazioni che esprimo’. E così anche il Checchi: ‘Nelle notti insonni, passatesu in Lombardia e nelle aspre giogaie del Tirolo, pigliavo nota a punti di luna diquello che avevamo armeggiato nel giorno: e ora rileggendo quelle note m’èparso che se ne potesse cavare un costrutto’. E il Bizzoni butta giù, giorno pergiorno, le sue ‘povere impressioni’. E tutti, come Giulio Adamoli, pensano che
146
BIANCIARDI, OTTOCENTO COME NOVECENTO
‘niente più della verità, di tutta quanta la verità, nei suoi minuti particolari, valgaa dare intero il carattere sincero d’un momento storico’”.
23 S. Giannini, Bianciardi ed il Risorgimento, in il gabellino, n.13, giugno2006, Dossier 14, p.9.
24 Da Quarto a Torino, cit., p.338.25 G.Bandi, I Mille, cit., p. 162.26 Ibid., p.295: “Ma purtroppo Garibaldi e Mazzini non solo non furono un sol
uomo, ma furono quasi sempre discordi, né potrei assicurare che si volessero scam-bievolmente quel gran bene che molti credono. […] vero è che ogni qualvolta ac-cadde che la somma delle cose richiedesse necessaria al bene della patria laconcordia di questi due uomini, Mazzini pigliò ombra di Garibaldi, e Garibaldi siguardò da Mazzini, come da un consigliere pericoloso e quasi da un emulo fatale.In una parola, ciascun di essi ebbe forse paura dover correre il risico di sacrificareall’altro qualche raggio della sua gloria e d’apparir secondo accanto a lui”; ibid.,p.343: “Del Cavour non era possibile parlargliene [a Garibaldi] senza vederlo pi-gliar fuoco; come non c’era caso di rammentare una faccenda dove avesse mano,anche in lontananza, il Cavour, nella qual faccenda non si avesse a supporre, a ve-dere, e a toccare eziandio, un nido scellerato di tradimenti e di guai”.
27 Completate, in misura molto più limitata, da quelle ricavate da altre fonti.Cfr., a proposito della vera scena “goffa e impacciata” dell’incontro di Teano (DaQuarto a Torino, cit., p. 445), i ricordi di Alberto Mario: “La situazione era epica:suolo campano e Capua a poca ora; grandi ombre di consoli romani e di Annibale;incontro degli eserciti di Castelfidardo e di Maddaloni; vigilia della battaglia; con-tatto della camicia rossa e della porpora […]. Garibaldi gli cavalcava alla sinistra,e a venti passi di distanza il quartiere generale garibaldino alla rinfusa col sardo.Ma a poco a poco le due parti si separarono, respinta ciascuna al proprio centro digravità; in una riga le umili camicie rosse, nell’altra a parallela superbe assise lu-centi d’oro, d’argento, di croci e di gran cordoni. […] In tanto strepito d’armi e cor-ruscare di spallini e ondeggiare di cimieri, i contadini accorrevano attoniti adacclamare Garibaldi. […] Vittorio Emanuele spinse il cavallo al galoppo. Tutti noigli si galoppò dietro […]. Per buona sorte il re, oltrepassati i villani, si rimise alpasso, rassettò la tunica, raddrizzò il berretto, asciugò il sudore e riatteggiossi de-corosamente. Al ponte d’un torrentello che tocca Teano, Garibaldi fece di cap-pello al re; questi proseguì sulla strada suburbana, quegli passò il ponte, esepararonsi l’un l’altro ad angolo retto” (La camicia rossa, in Antologia di scrit-tori garibaldini, a cura di Gaetano Mariani, Bologna, Cappelli, 1960, pp.290-292).Cfr. anche i ricordi di Giuseppe Cesare Abba che nella rappresentazione agiogra-fica dell’evento, destinata, questa sì, a costituirsi come modello, insinua un con-trocanto di perplessa malinconia: “ Mi venne quasi buio per un istante; ma poteivedere Garibaldi e Vittorio darsi la mano, e udire il saluto immortale: ‘Salute al red’Italia!’. Eravamo a mezza mattinata. Il Dittatore parlava a fronte scoperta, il Restazzonava il collo del suo bellissimo storno, che si piegava a quelle carezze come
147
CONVEGNO
una sultana. Forse nella mente del Generale passava un pensiero mesto. E mestodavvero mi parve quando il Re spronò via, ed Egli si mise alla sinistra di lui, edietro di loro la diversa e numerosa cavalcata. Ma Seid, il suo cavallo che lo portònella guerra, sentiva forse in groppa meno forte il leone, e sbuffava, e si lanciavadi lato, come avesse voluto portarlo nel deserto, nelle Pampas, lontano da queltrionfo di grandi” (Da Quarto al Volturno. Noterelle d’uno dei Mille, con Intro-duzione di Giorgio De Rienzo, Milano, Mondadori, 1997, p.170).
28 G.Stuparich, Prefazione, cit., p.XLVII.29 G.Mariani, Bozzettismo epico degli scrittori garibaldini, introduzione in
Antologia di scrittori garibaldini, cit., p.7.30 Le citazioni provengono da G.Bandi, I Mille, cit., pp.339, 341, 160.31 G.Mariani, Bozzettismo epico degli scrittori garibaldini, cit., p.11.32 L.Bianciardi, Prefazione, cit., p.X.33 G.Bandi, I Mille, cit., p.338.34 “Il governo palermitano era ormai schierato dalla parte dei ‘cappelli’; Cri-
spi, ministro dell’interno, era deciso a ristabilire il rispetto ‘della proprietà edella vita’; e i volontari garibaldini non riuscivano a vedere, in quelle sommossedisordinate e stravolte, altro che episodi di brigantaggio, di ferocia e di sangue,anche se, più ancora forse di Bixio, si rammaricavano dolorosamente di doverfare la parte dei carabinieri” (Da Quarto a Torino, cit., p.396; dalla stessa paginaprovengono le due citazioni nel testo). A proposito dell’atteggiamento dei vo-lontari è esemplare il racconto che nelle Noterelle Abba fornisce proprio dei fattidi Bronte, avviandone una versione mistificata per lungo tempo esemplare nellepagine di divulgazione storiografica. Per quanto riguarda poi l’analisi pragma-tica cui Bianciardi sembra qui limitarsi, occorre sottolineare che, qualche pa-gina prima, nel capitolo sesto, ricordando altri episodi minori ma non menocruenti di repressione delle lotte contadine, li ha sinteticamente ma lucidamenteattribuiti alla incapacità (o “scarsa volontà”) da parte del governo provvisorio diaffrontare la questione sociale: “Alla sopravvenuta libertà non si accompagnava,per i contadini, la fine del feudalesimo e la spartizione delle terre. Il decreto del2 giugno doveva restare lettera morta: i grossi proprietari si opponevano, il go-verno aveva scarsa possibilità (in qualche caso scarsa volontà) di tradurlo in pra-tica, ed in generale dava la precedenza ai problemi della guerra in corso” (DaQuarto a Torino, cit., p.378).
35 Cfr., almeno, G.C.Abba, Da Quarto al Volturno, cit., pp. 171-172: “Ieri ilDittatore non andò a colazione col Re. Disse d’averla già fatta. Ma poi mangiòpane e cacio conversando nel portico d’una chiesetta, circondato dai suoi amici,mesto, raccolto, rassegnato. A che rassegnato? Ora si ripasserà il Volturno, si ri-tornerà nei nostri campi o chi sa dove; certo non saremo più alla testa, ci mette-ranno alla coda. […] Il giorno dei Santi, poi quello dei Morti, poi quello dellemedaglie a noi, terza festa nella malinconia della stagione. […] Noi davamospalle alla Reggia, aspettando. A un certo punto il Dittatore si alzò, e venne verso
148
BIANCIARDI, OTTOCENTO COME NOVECENTO
noi dicendo con la sua voce limpida ed alta: ‘Soldati dell’ indipendenza italiana,Veterani benché giovani dell’esercito liberatore, vi consegno le medaglie che ilMunicipio di Palermo decretò per voi. Comincieremo dai morti, i nostrimorti…’[…] Quando toccò a noi, si andò chiamati ad uno ad uno dinanzi al seg-gio, dove una giovinetta, alzandosi sulla punta dei piedi, ci metteva la medagliasul petto, e intanto guardava di sotto in su con due grandi occhi gioiosi. Chi fossenon so, né chiesi di lei. Che giova il nome? Udii il Generale che volgendosi a unadama vicino a lui, diceva: ‘Vede? Quelle faccie le conosco tutte, le vedrò finchévivrò’. Intanto le bande suonavano, e quella dei Granatieri pareva dicesse: Basta,ora basta, andate!”.
36 Da Quarto a Torino, cit., pp.449-450. E cfr. G.Bandi, I Mille, cit., pp.336-337: “Vidi Garibaldi pochi momenti innanzi che partisse; era calmo e sorridentesecondo il solito, ma qualche suo detto rivelò ciò che ognun di noi sentiva incuor suo: lasciava Napoli contento di sé stesso e di noi, ma tutt’altro che soddi-sfatto del modo con cui l’avean trattato coloro che erano onnipotenti presso il re,e che potevano chiamarsi i nuovi padroni. In quell’ora memoranda, egli m’ap-parve più grande che mai: Garibaldi, tornato povero e privo d’ogni autorità, si-mile ai grandi del tempo antico, umili dopo i trionfi e contenti della propriagloria, era più nobile e più ammirando del dittatore e del capo d’un esercito, inmezzo alle pompe della potenza e agli applausi della folla, devota sempre al soleche più risplende. Lo vedemmo imbarcare e rimanemmo a contemplarlo con gliocchi pieni di lacrime: ritto sulla barca, ed agitante il fazzoletto per salutarci an-cora, mentre la robusta voga di sei marinai lo allontanava dalla spiaggia. […] Ilpiroscafo che lo accolse per trasportarlo in Caprera si chiamava Washington, eparve che il destino volesse affratellati que’ due nomi gloriosi. Il Washington fusalutato dalle salve del naviglio da guerra inglese ancorato nel golfo; ma le naviregie italiane non fecero mostra di accorgersi della partenza dell’uomo che avevaliberata mezza Italia”. Cfr. anche, per la coincidenza di sentimenti all’interno diun timbro più cronachistico, A.Mario, La camicia rossa, cit., p.293: “Alle duedopo mezzanotte del 7 novembre tre carrozze da nolo si arrestarono al portonedell’albergo della ‘Bretagna’ in Napoli. Alle due e un quarto chiudevasi lo spor-tello della prima, e via con Garibaldi, Menotti e Basso, Missori, Nullo, Canzio,Trecchi, Zasio ed io, dietro nell’altre due. All’approdo di Santa Lucia entrammoin una lancia che ci aspettava, e in qualche minuto scorgevansi le vaporose formedella Sirena, immemore e assopita nell’amplesso del nuovo amante. Eppure noncorsero che due mesi dalla notte del 7 settembre, notte di deliranti affetti pel li-beratore. Ora egli, glorioso e sereno, s’involava al freddo aere dell’oblio, colmodesto corteo di pochi amici, a lui devoti ancora più nelle infedeltà della for-tuna. Dal ponte del Washington egli disse addio a Napoli e a noi, e soggiunse:«A rivederci sulla via di Roma! »”.
37 Cfr. dal risvolto di copertina di Da Quarto a Torino, già citato in apertura diquesto intervento; e cfr. dalla Prefazione al lettore adulto, in Daghela avanti un
149
CONVEGNO
BIANCIARDI, OTTOCENTO COME NOVECENTO
150
passo!, cit., p.1117: “[…] il Risorgimento è una faccenda che appassiona e av-vince, e persino diverte. Io questo già lo sapevo, altrimenti non avrei accettato diraccontarlo, perché le storie noiose non piacciono nemmeno a me. Ma il primoche lo lesse fu mio figlio Marcellino, di dieci anni, quinta elementare. Mi disse:«Sei più bravo di Salgari». Dentro di me inorgoglii come un tacchino a giugno (ilmese più lontano dalle feste natalizie), ma ebbi anche la modestia di spiegare albambino che il merito era tutto del Risorgimento, e che le storie vere son semprepiù belle, più appassionanti di quelle inventate”. È da rilevare, tra l’altro, la coin-cidenza con alcune parole (e con il giudizio complessivo) di Stuparich: “[…] ilBandi è tutto scoperto, la sua maniera è spesso quella del romanzo popolare, nellaspontaneità dei suoi dialoghi e nei colori delle avventure (mi chiedo quanto abbiapreso da lui Emilio Salgari, senza arrivargli nemmeno alla scapola) […]” (Prefa-zione, cit., p.XLII).
38 G.Mariani, in Antologia di scrittori garibaldini, cit., p.295 e p. 119; G.DeRienzo, Introduzione, in G.C.Abba, Da Quarto al Volturno, cit., p.12).
39 Cfr. ancora dalla Prefazione al lettore adulto in Daghela avanti un passo,cit., p.1118: “Non furono anni tristi, men che mai noiosi; anzi non ci sono nellanostra storia episodi più eroicamente festosi, concitati, coloriti, persino un pocomatti, di quelli che vedremo fra poco […]. E proprio la fantasia giovò molto avincere parecchie di quelle battaglie, specialmente quando furono battaglie po-polari e popolane”. E, ancora, nel già citato “Il Risorgimento non è stato unaquadriglia”: “Cosa furono dunque le cinque giornate milanesi? Storicamente fu-rono un episodio marginale (seppur clamoroso) di una rivoluzione europea. […]Ma soprattutto, se vogliamo anticipare un’espressione inventata, ai giorni no-stri, del maggio francese, fu l’immaginazione a prendere il potere. I milanesi, cheuna volta ogni secolo mettono in moto la fantasia, quella volta si superarono”.(pp. 1813-1814).
40 G.Stuparich, Introduzione, cit., p.XLV.41 Da Quarto a Torino, cit., p.346.42 Ibid. E cfr. G.C. Abba, Da Quarto al Volturno, cit., pp.66-67: “Colla prima
oscurità, cominciò la pioggia a darci nel viso i suoi goccioloni grossi e impetuosi:parevano chicchi di grandine che ci si spezzasse sulle guance. Il vento era freddo;dinanzi a noi, la terra e l’aria furono presto come a entrare in gola a un lupo. […]Ci avanzammo alla meglio, tastando la terra cogli schioppi, come una processionedi ciechi. […] E la pioggia non cessava. Eravamo fradici fino alla pelle; e il ventocolle sue buffe portava dalla testa della colonna un nitrito, che pareva uno scherno.Verso mezzanotte si udì un colpo d’arma da fuoco, che scosse tutti sino all’ul-timo della fila. […] Che cosa era stato quel colpo? Trovammo un cavallo distesomorto sul margine del sentiero, e si disse che era di Bixio: il quale irato, perchécoi nitriti poteva scoprirci al nemico, gli aveva scaricata nel cranio la sua pistola”.
43 Da Quarto a Torino, cit., p.349.44 A.Ciceri, Prefazione, in I.Nievo, Lettere garibaldine, cit., p.XXIX.
45 Lettera a Bice Melzi Gobio, da Palermo, 24 giugno 1860, in Lettere gari-baldine, cit., p. 18. La lettera era già stata pubblicata da Dino Mantovani in Ilpoeta soldato, Milano, Treves, 1899, pp. 354-357.
46 Da Quarto a Torino, cit., p.305. È la rielaborazione di una pagina de I Milledi Bandi (p.63) che, in questo come in molti altri possibili esempi di bozzetto de-scrittivo, è il modello privilegiato del narratore di Da Quarto proprio per la cifradi una scrittura diseroicizzata in lui più insistita che negli altri memorialisti ga-ribaldini: “Naturalmente questo diseroicizzamento acquista proporzioni e toni di-versi nei vari scrittori: sia Abba che Bandi, ad esempio, diseroicizzano certefigure e certe situazioni, ma il primo non scenderebbe mai ai particolari che ilsecondo si cura di metter bene in luce: Bandi può descriverci Garibaldi nella piùsconcertante intimità o parlarci, con una certa aria di pettegolezzo, delle rivalitàche esistono tra i generali che sono con l’eroe; Abba – anche se fosse stato al cor-rente di simili questioni – non le avrebbe mai messe sulla carta: il suo può es-sere sì un Garibaldi alla buona, anche in pantofole, se vogliamo, ma è sempre unre, e sia pure un re pastore” (G.Mariani, Bozzettismo epico degli scrittori gari-baldini, cit., pp.21-22).
47 Cfr. la nota 22.48 M.Rago, in L’Unità, 21 giugno 1960.49 R.Rinaldi, Bianciardi: approssimazioni ad una letteratura perversa, in Il
romanzo come deformazione, Milano, Mursia, 1985, p.50. Questa è la citazioneper esteso: “le pagine migliori, le impennate improvvise che nascono dal gri-giore, in Da Quarto a Torino, parlano di intellettuali e letterati: notando la loroprevalenza nel primo nucleo della spedizione, elencando (con evidente gioia bi-bliografica) il gran numero di libri nati da quell’esperienza, ricordando le fan-tasie letterarie sulla terra di Sicilia ancora mitica e lontana. Le stravaganze diDumas al seguito dei Mille a Palermo, il suo affascinante istrionismo, la suafolle contemplazione ‘letteraria’ delle battaglie dal ponte della sua nave, stimo-lano e attirano la scrittura dell’autore. Bianciardi non fa altro che parlare di sestesso, del suo ghetto specialistico, della sua nave ancorata in rada”. Anche Ri-naldi, dunque, sottolinea la “narratività” di questa prima sintesi risorgimentaleche sottopone però ad un giudizio fortemente limitativo per quanto riguarda l’im-pegno di rivisitazione storiografica. La priorità assegnata alla “forma aneddo-tica”, agli “effetti più facili”, alla “psicologia spicciola”, al “gusto della battuta”sono il risultato di un processo secondo il quale la “storia viene considerata purafabula, usata come strumento di racconto”, “materia con cui giocare, un campoin cui muoversi per sentire il fascino vuoto della letteratura”, arrivando a “dis-simulare (quasi con vergogna) ricerche accurate e vaste documentazioni, sottoun luccichio di specchi, arazzi, oleografie”(p.49).
CONVEGNO
151
153
CONVEGNO
Moderatore: Paolo Brera
Partecipano:
Marco Bellotto
Leandro Piantini
Maurizio Puppo
Beppe Sebaste
TAVOLA ROTONDA
Sabato,15 novembre 2008 ore 16.00La lezione di Bianciardi
Paolo BreraIl ruolo del moderatore è un ruolo strano. Un po’ come quello
del domatore, perché qui ci sono alcune bestie feroci molto pre-parate e bisogna impedire, rallentandole, che dicano troppo introppo poco tempo.
In questa sala sono presenti persone che in qualche modo hannoavuto a che fare anche indirettamente con Bianciardi, e lo hannovisto come un maestro: essi si sono ispirati a Bianciardi e almenoun paio di loro lo ha detto apertamente e lo ripeterà anche oggi.
A chi vogliamo dare la parola? C’è qualche volontario? Prego.
Maurizio PuppoCome diceva il moderatore, qui siamo tutti molto preparati…
spero di non abbassare la media. Sono molto contento di essere qui,e c’è una ragione specifica: ho avuto la sventatezza di scrivere unlibro, diciamo così, e questo libro è stato scritto avendo come puntodi riferimento La vita agra di Luciano Bianciardi; il libro tuttavianon parla esplicitamente di Bianciardi né lo cita direttamente,quindi il fatto che io sia stato chiamato qui chiude un po’ il cer-chio… per me significa molto dal punto di vista personale, ed èforse la migliore soddisfazione che potessi avere. Bianciardi nonamava essere definito maestro, a un lettore che gli chiedeva dei pa-reri su alcuni personaggi diceva: “non sono mica un professore”,anche se da giovane fu un professore, e molto bravo.
Bianciardi era un passaggio obbligato per me e il libro che hoscritto, Bandiere Blucerchiate, parla di un uomo che lavora, af-fronta, in maniera sintetica, il disagio di fronte all’arrivismo, al con-formismo, a determinate situazioni quali la soppressione el’abolizione della lingua italiana, in patria, dove usano un finto in-glese, al posto dell’italiano. Bianciardi era un passaggio obbligatoanche per ragioni biografiche: erano anni di profonde trasforma-zioni sociali, gli anni ’60, il boom economico, l’avvento del neo-capitalismo, che portava beneficio alla classe operaia e che avevacompreso bene la lezione di Gianburrasca, solo un popolo affamatofa la rivoluzione. Tutto bene insomma, l’Italia cresceva, anche glioperai finalmente potevano accedere al benessere, ma c’era qual-cosa che non funzionava e Bianciardi era perfetto per dare parola aquesto disagio, che elaborava attraverso due categorie: ideologia e
linguaggio. L’ideologia anarchica di un sistema basato sul consensoe non sull’autorità, e il linguaggio, una formidabile macchina lin-guistica, quella di Bianciardi, che doveva molto alla sua origine to-scana, alla sua cultura e all’esperienza milanese. Il linguaggio diBianciardi e la sua irresistibile descrizione del mondo neocapitali-sta era ed è un imprescindibile punto di riferimento per chi volessescrivere oggi, con parole adattate ai tempi, il disagio di fronte allacretineria, se mi consentite il termine, di fronte al dominio assolutodi un unico modello, capitalistico, e al prevalere di un linguaggiouniformato, contaminato con il finto inglese tecnologico, che con-sidero un braccio dannato della lingua.
Paolo BreraMolto bene. Puppo ha illustrato una prima modalità di lettura
dell’esperienza di Bianciardi, che era anche la più importante, per-ché nonostante la sua passione per il Risorgimento voleva anchecriticare il mondo che aveva davanti, sotto vari aspetti. C’è qualcu-n’altro che vuole riprendere da questo punto e andare avanti?
Beppe SebasteInizio presentando il mio ultimo libro che si chiama Panchine, in
cui è citato Bianciardi sia con dichiarazioni esplicite sia con riferi-menti impliciti che pervadono il testo, scritto proprio dove lui rac-conta di essere stato arrestato, nella Milano degli affari e del lavoro.Lo cito quando rifletto sul fatto che, oggi, sedersi su una panchina èil reato più grave che si possa commettere, perché si diventa invisi-bili, e poi da lì sviluppo un discorso variegato, estetico e sociale maanche poetico: una luminescenza delle panchine, diciamo, comeluogo-protesta contro il negozio. Il mio tributo poetico, morale o po-litico nei confronti di Luciano Bianciardi è nella libertà narrativa…fare un libro sulle panchine non è scontato. C’è chi ha definito que-sto libro il più libero che abbiano letto: una conquista che potrei vo-lentieri attribuire all’insieme delle opere di Bianciardi, sempreimprevedibile, che sapeva stupire lettori ed editori, i quali volevanosempre che ripetesse il successo dell’opera precedente (di cui eranostati diffidenti) e lui invece cambiava in maniera imprevedibile; que-sta libertà complessiva è uno dei più grandi insegnamenti che ha po-tuto darci e che ho colto come ispirazione. Ero adolescente, avevo
156
l’età che ha ora mio figlio, volevo scrivere ma non sapevo né cosané come. Siamo nella prima metà degli anni ’70, io vado spesso inun parco dove adesso è vietato leggere sui prati, avevo due libri, unoera Jukebox all’idrogeno, di Ginsberg, poesie e l’altro era La vitaagra di Bianciardi, non so quale mi abbia regalato più entusiasmo.Io, che volevo scrivere ma non sapevo né cosa né come, seppi im-mediatamente cosa e come. Potevo scrivere di tutto su tutto, com-presa la mia soggettività e le mie esperienze, perché l’ostacolo dichi scrive è l’autocensura: pensare che le esperienze, immaginarie oreali, non siano degne di essere narrate; questa è una paura che per-siste nella vita di uno scrittore. In una frase si potrebbe dire che l’in-segnamento di Luciano Bianciardi è stato quello di allargare il miosenso della narratività.
Paolo BreraFocalizziamo l’attenzione, se permettete, su un punto impor-
tante: l’adolescenza. Luciano Bianciardi è stato per tutta la suavita un adolescente, la sua critica era corrosiva e ciò ha avuto ungrandissimo effetto su tutti coloro che erano adolescenti in queglianni, come anche Sebaste. Se vogliamo andare avanti su questopunto, darei la parola a Bellotto.
Marco BellottoCiascuno di noi è arrivato a Bianciardi secondo un percorso per-
sonale, anche se il mio non è molto differente da quello di Puppo eSebaste: molte delle cose che hanno detto finora sono da me pie-namente condivisibili. Per quanto riguarda il mio percorso, stavoscrivendo un romanzo in cui inventavo il personaggio di uno scrit-tore del ventesimo secolo, uno scrittore importante, di successo ,immaginando cosa sarebbe accaduto se questo personaggio fossevissuto nella vita politica, sociale e narrativa della seconda metà delsecolo scorso; volevo creare una sorta di sincronia: lo scrittore do-veva essere nato nell’anno di nascita di mio padre, volevo raccon-tare quel preciso momento storico. Feci arrivare questo scrittore aMilano, e decisi che pubblicasse per Feltrinelli; volevo che unamico lo introducesse come scrittore, e studiando la redazione diFeltrinelli in quel periodo, pensai a Bianciardi. Non ero sicuro sedovesse lavorare in Feltrinelli oppure no; poi mi capitò fra le mani
157
TAVOLA ROTONDA
Il fuorigioco mi sta antipatico e decisi che quell’uomo doveva es-sere l’amico del protagonista del mio libro, che si chiama Mantarro.Tale personaggio ha avuto una formazione religiosa ed è diventatocomunista e mi piaceva far rispecchiare questa figura, innamoratadel sacro, nello scrittore più dissacrante della storia italiana del ven-tesimo secolo, la cui carica dissacratoria, a tratti anche in modo ado-lescenziale, faceva da contralto al mio personaggio. In seguito vileggerò un piccolo brano in cui cerco di spiegare che cosa speravodi ottenere, non so se ce l’ho fatta… ma per raccontare un mondocome quello della Milano degli anni ’60/’70 mi piaceva utilizzareuna figura bipolare. Per me Bianciardi è un personaggio appunto bi-polare, dotato di una straordinaria lucidità nel leggere la modernità.La frase: “un quarto d‘ora di celebrità ce lo avranno tutti in futuro”l’ha detta prima Bianciardi di Andy Warhol; questa grande atten-zione per l’attualità, questa sensibilità, questo intuito da rabdo-mante, coniugato a un grande amore per il secolo precedente (in unperiodo storico in cui in pochi in Italia parlavano del Risorgimento),questa sua tempra anarchica, questa volontà di essere un grande au-tore, ma non un professore, ne ha fatto un uomo straordinariamentelibero come essere umano prima che come intellettuale.
Paolo BreraMi sembra giusto parlare con un po’ di tensione nella voce, per-
ché bisogna rendere omaggio a Bianciardi che non era un noioso,ma era uno che si divertiva, pure nella sofferenza, perché vedevala realtà per quella che era e non poteva porvi rimedio. Diamo laparola a Leandro Piantini.
Leandro PiantiniNel bel romanzo di Marco Bellotto volevo sottolineare il tema
dell’amicizia che nasce tra lo scrittore Livio Mantarro e LucianoBianciardi: Don Livio lo chiama Bianciardi, perché è cattolico, èschivo, e così per bene, che poi diventerà un prete, sì, ma comu-nista; infatti tra i due nascerà una profonda amicizia, Bianciardinutrirà un profondo rispetto per questa persona così diversa dalui… Mantarro, il personaggio, dice una cosa importante, dice cheper lui il decennio della purezza, gli anni ’60, contrapposti aglianni ’70 anni successivi al terrorismo, finisce il 14 novembre del
158
LA LEZIONE DI BIANCIARDI
1971, con la morte di Bianciardi. È stata un’ intuizione molto fe-lice aver creato questo personaggio. Felice è anche la figura diFeltrinelli che compare in un atteggiamento satirico.
In questi giorni è stato organizzato un bel convegno, che ha di-mostrato una cosa secondo me implicita in ciò che hanno dettogli scrittori che mi hanno preceduto, cioè che Bianciardi è uno deipochi scrittori importanti del secondo ’900 , che sono stati letti, e,insomma, è diventato un piccolo classico. Questo convegno è statoimportante per l’interpretazione letteraria dei professori, chehanno sottolineato vari aspetti e problematiche di tale interpreta-zione; le analisi sono state così approfondite, così ravvicinate,anche sugli aspetti linguistici, culturali e storici; è stato analiz-zato ciò che per il grande pubblico è ancora da scoprire nell’operadi Bianciardi, cioè le sue narrazioni risorgimentali, un piccoloclassico.
Ho sentito Luciana Bianciardi accennare a indagini poco one-ste, chiacchiere infondate che possono esserci state intorno a Bian-ciardi; in effetti basta entrare sui blog in Internet per trovare moltecose su di lui: per esempio, un cantante milanese, Francesco Bian-coni, ha scritto un testo - Un romantico a Milano - che si riferisceproprio a Bianciardi; ci sono molti argomenti trattati dai lettori chelo riguardano, ed è uno dei pochi scrittori di quegli anni che conti-nua a essere letto e che ancora alimenta la ricerca letteraria, comedimostra ciò che stiamo dicendo stasera; questo perché è stato unoscrittore, seppur di breve durata, un ventennio tra gli anni ’40 e lafine degli anni ’60, che ha vissuto pienamente e in un modo singo-lare che per i narratori di oggi è difficile ritrovare. Intanto Bian-ciardi non è solo un grande scrittore ma anche un intellettuale,secondo una modalità che era tipica di quella generazione nata nel-l’immediato dopoguerra, che ha vissuto in provincia e che ha vis-suto nel clima della Repubblica e della rinata democrazia italiana,con quel fervore di ricerca e di innovazione, quei viaggi nelle altreletterature, la americana su tutte. Bianciardi tuttavia lo ha vissuto inun modo originale e personale e non poteva essere che così: perchéaveva la tempra dell’uomo che non poteva non seguire una propriavocazione, spesso dannosa per lui stesso, autodistruttiva per certiversi; questa tensione verso la realtà, questo interesse verso la so-cietà si accompagnavano in lui a capacità di scrittura naturali che
159
TAVOLA ROTONDA
LA LEZIONE DI BIANCIARDI
160
appaiono anche ai lettori di oggi nella loro vivacità e irripetibilità,che oggi non sembrano appartenere più a nessuno.
Bianciardi ha portato molte novità nel linguaggio letterario a par-tire dalla sua esperienza giornalistica sulla Gazzetta di Livorno, checircolava nella zona tirrenica bassa e che non arrivava neanche aFirenze… se noi oggi leggiamo quegli articoli è perché sono di unoscrittore vero, che sa raccontare la realtà, i tipi curiosi, da un puntodi vista tutto suo. Un esempio: “per fortuna la mia città non vive laMontecatinizzazione, Perché gli arredi urbani che nell’anno ’52l’amministrazione comunale ha scelto per Grosseto, gli evitano didiventare un oggetto, un giardino adatto ai forestieri e ai villeggianticome Montecatini in quegli anni. Bianciardi non è mai uno scrittoreovvio e noioso, in nessuno dei propri articoli, per non parlare delleopere più impegnative citate nel convegno; questa sua lingua to-scana - ma senza essere un linguaiolo, senza usare il vernacolo -questa sua facilità e limpidezza di scrittura, credo sia la sua qualitàprincipale, e, oltre a una poetica originale, aveva delle cose ben pre-cise da dire. Che, per quanto riguarda la seconda fase della sua scrit-tura, questo convegno ha messo ampiamente in luce: Bianciardiinnamorato di Garibaldi e del Risorgimento, dell’eroismo, della mi-tologia popolare di quel periodo storico, in un momento in cui è ilsolo ad occuparsene. Il suo spirito anticonformistico non è casualee i suoi libri non sono solo il risultato della sua stravaganza, maerano qualcosa che egli aveva sentito il bisogno di raccontare fa-cendo emergere un altro aspetto della sua personalità. Probabil-mente egli aveva esaurito con La vita agra la scritturaautobiografica, che poi riprenderà in Aprire il fuoco, sentendo il bi-sogno di dar sfogo a una vena narrativa piena, che non avevaespresso nel cosiddetto trittico dei romanzi autobiografici, che pos-sono considerarsi narrativa senza romanzo, perfettamente intonataalle modalità stilistiche degli anni ’60 fino ai cosiddetti nipotini diGadda, simile in questo a Mastronardi e ad altri scrittori molto ori-ginali di quegli anni; nell’epopea risorgimentale egli ha dato fondoa questa sua vena narrativa, una narrativa più facile, abbordabile edivulgativa, in cui poteva esprimere questa voglia di raccontare inmodo disteso un mondo avventuroso e un mondo di eroi, perchéGaribaldi è un eroe: in questo c’è la sua storia e un retaggio dellasua terra, perché in Maremma era vivo, come spiegò Eugenio Pam-
TAVOLA ROTONDA
161
paloni, suo amico grossetano, il mito risorgimentale, là, i seguaci diMazzini e Garibaldi erano molto più frequenti che in altre zone.
Volevo concludere dicendo che secondo me Bianciardi è unoscrittore che deve essere letto, cioè dobbiamo mettere i giovani incondizioni di leggerlo, dobbiamo recuperare i suoi libri e ripubbli-carli in forme nuove, più accessibili: c’è per esempio una raccoltadi articoli giornalistici usciti per Baldini&Castoldi dal titolo Chieseescatollo e nessuno raddoppiò che ha il grave difetto di non avereun indice. Io pensavo non solo alla ripubblicazione delle opere diBianciardi ma anche a degli articoli giornalistici suddivisi magariper temi, in pubblicazioni più economiche, come per esempio rac-cogliere gli articoli usciti sul Guerin Sportivo per ordine cronolo-gico e tematico.
Paolo BreraVorrei aggiungere una piccola considerazione: uno scrittore è
scrittore non solo quando scrive opere ponderose, ma anche quandoscrive sui giornali interventi brevi. Essere scrittore è una dote chesi ha dentro: paradossalmente, anche una lista della spesa può di-ventare un esempio di scrittura e di approfondimento.
Ora è venuto fuori un tema molto importante: il Risorgimento.Quest’uomo dell’Italia centrale che, invece di andare a Roma, stra-namente, va a Milano; arriva a Milano e rimane disgustato da moltecose e se la prende con tutto. Giustamente, perché vive una vita chenegli ultimi anni non è stata bella – è stata agra – e scrive cose fon-damentali. Dov’è la speranza, se c’è? Da dove viene? Da un’espe-rienza precedente che abbiamo vissuto tutti noi in Italia, cioè ilRisorgimento. Poi Bianciardi prende questa bella speranza del Ri-sorgimento e la mette nella satira: c’è un libro, che ho letto duevolte, e che sottolinea molto questo aspetto, Aprire il fuoco: nellibro comparivano intellettuali della Milano del tempo di Bianciardiinsieme a quelli milanesi delle Cinque Giornate, e in questo polve-rone il risultato era veramente graffiante. C’è qualcuno che vuoleaggiungere altro?
Marco BellottoDirò una cosa brevissima che sottolinea le capacità di rabdo-
mante di Bianciardi: la sua passione per il Risorgimento è straordi-
LA LEZIONE DI BIANCIARDI
162
naria, soprattutto in un periodo come questo attuale; senza fare po-lemica, pensiamo a come si siano messi in crisi alcuni dei valori ri-sorgimentali che dovevano essere una conquista irrinunciabile, edei punti di non ritorno, della nostra società come la laicità dellostato... già questo fatto è straordinario: il valore del coraggio, la de-mocraticità, il senso patriottico che aveva Bianciardi. Pensiamo aquanto e a come siamo stati tutti i giorni colpiti dal tentativo, asso-lutamente scoperto e palese, di eliminare i valori illuministico/ri-sorgimentali che sono stati alla base dello Stato in cui viviamo.Anche di questa attualità , Bianciardi non sarebbe stato molto con-tento, e ciò dà un motivo di qualità ulteriore.
Maurizio PuppoPer quanto riguarda la passione risorgimentale di Bianciardi,
credo fosse sì un’ossessione personale dovuta a particolari vi-cende biografiche ma anche al bisogno che ogni cittadino ha dimiti fondatori del proprio paese, e l’Italia ne ha pochi; miti comela Roma Antica, ideale corrotto dal fascismo, la Resistenza, che inqualche modo non era condivisa dal paese intero, e rimaneva ilRisorgimento; credo che Bianciardi avesse, a livello inconscio,l’esigenza di portare in Italia un valore edificante, un percorsocollettivo. Gli anni ’60, di cui narra Bianciardi ne La vita agra, fe-cero un po’ da spartiacque per la società italiana, perché in queltempo c’erano gli operai, i contadini, i borghesi che morivano difame perché dopo il dopoguerra dal ‘48 al ‘55 avviene un incre-mento economico per le classi operaie per questo si propende alcomunismo. Gli anni ’60 poi hanno un senso straordinario per ilpaese: non sono contro la modernizzazione, penso che il pro-gresso economico del paese fosse un passaggio fondamentale, mail problema è che non era gestito in modo intelligente con un va-lore collettivo, gli anni ’60 sono diventati un momento in cui si èpassati da un percorso individuale a uno collettivo. In quel pe-riodo molte persone cattoliche, che emigravano dal sud al norddiventavano comunisti, non perché avessero letto Marx, ma pro-prio perché seguivano questo percorso collettivo negli anni 70 sipassa ad ognuno, c’è un individualismo che, portato all’estremo,porta all’evasione fiscale, alla corsa al consumismo.
TAVOLA ROTONDA
163
Paolo BreraGli anni ’60 sono stati citati anche prima parlando di Bianciardi:
la libertà sessuale, lo spirito libertario che lo contraddistingue, sonotutte cose che emergono dagli anni ’60, il ’68 in particolare.
Abbiamo ora una chicca: Gino e Michele hanno scritto un pezzoper noi… volevano venire, ma hanno spiegato che c’è stata una ca-tastrofe atomica, insomma non ci sono, però hanno inviato un con-tributo scritto, che ci leggerà Luciana Bianciardi.
Luciana BianciardiGino e Michele sono dei bianciardiani accaniti, li avevamo in-
vitati e fino a qualche giorno fa dovevano venire, poi hanno avutodegli impegni improrogabili e non hanno potuto partecipare. Que-sto intervento inizia con: «Noi milanesi…» ci sarà da ridere lettodalla mia voce... l’intervento si chiama L’insospettabile milanesitàdi Luciano Bianciardi, di Gino e Michele.
[Lettura dell’intervento]
Paolo BreraCome hanno giustamente detto Gino e Michele, e dico “Mi-
chele” con la «e» stretta perché non è vero che noi milanesi par-liamo con le «e» tutte aperte, le mettiamo da altre parti secondoregole molto precise.
Luciana BianciardiNon è vero che parlate secondo regole precise: mettete la «e»
chiusa quando va aperta e aperta quando va chiusa.
Paolo BreraInfatti, se ti riferisci all’italiano standard è vero. Ma in lingua lo-
cale e anche nell’italiano regionale milanese la regola c’è, a diffe-renza dell’italiano standard, ed è molto precisa: se una «e» accentataè seguita da due consonanti, a Milano si pronuncia aperta, conpoche eccezioni. Io non stravedo per l’accento milanese, e infattisfrutto sempre i miei amici toscani come dizionari umani, per sa-pere come devono essere gli accenti in italiano standard. Su duecose però li prendo in castagna: innanzitutto «Foscolo», che si pro-
nuncia con la «o» chiusa perché deriva da «fusculus» latino. La se-conda è la parola «léttera» che non si deve pronunciare con la «è»aperta, perché deriva dal latino «littera». Comunque io sono mila-nese non di seconda generazione, e non di terza, ma di “genera-zione meno uno” perché me ne sto andando a Nizza… a Nizza unavolta c’era un solo italiano, che era Giuseppe Garibaldi; gli altri al99% hanno votato per la Francia quando gliel’hanno chiesto al re-ferendum, mentre a noi in Lombardia non ci hanno affatto chiestose volevamo unirci al Piemonte, hanno avuto paura. Non so perchéqui in Toscana abbiate votato per l’unione, visto che la Toscana eraben governata. Comunque ormai è fatta, siamo qui, siamo italiani:e allora bisogna dire perché Foscolo, anche lui italiano, personag-gio coraggioso, se l’era presa con Milano. La chiamava “Panerò-poli”; la pànnera in milanese è la panna (le due «n» si pronuncianocome una sola), e di panna se ne usava tanta a Milano. A Foscolo,che veniva dalle isole ioniche, questo non garbava per niente, luivoleva l’olio d’oliva. Ma il vero motivo per cui se la prese tanto conla città fu un altro. Scrisse e fece mettere in scena una commedia.Bene, nella commedia c’era Aiace Telamonio che veniva dall’isoladi Salamina, Grecia, e arringando le sue truppe diceva: «O sala-mini!» Dare a qualcuno del salame a Milano vuol dire dargli dellostupido. Il teatro crollò per le risate e Foscolo se la legò al dito, tan-t’è vero che quando i milanesi linciarono Prina, ministro delle Fi-nanze che tassava molto, lui lo difese con la spada; e lì avevaragione, perché non si uccide la gente anche se ti ha tassato un po’troppo… comunque i milanesi sono esseri umani e non vanno messinei campi di concentramento.
Ad ogni modo Gino e Michele hanno nominato il ’68: c’è qual-cuno che vuole parlare del rapporto tra Luciano Bianciardi e il ’68?C’è un volontario?
Beppe SebasteVolevo dire delle cose: si è parlato di Milano e del Risorgimento;
Milano è un laboratorio di italiano, è la Milano di Bianciardi in Ita-lia ne La vita agra scrisse, parlando della tecnologia e del progresso:«tra vent’anni l’Italia sarà ridotta come Milano…»; in effetti ci sirifà al concetto pasoliniano della parola profezia: vuol dire avere ildono dell’attenzione ai segni del presente, e in effetti in Italia mai
164
LA LEZIONE DI BIANCIARDI
TAVOLA ROTONDA
165
come oggi, in un regime tecnico, mediatico, pubblicitario, impron-tato con questa storia della ‘Milano da bere’ rappresenta l’Italia e larappresenta in un dato modo, io non sono un esperto di Risorgi-mento, né della produzione bianciardiana sul Risorgimento, ma mitrovo d’accordo con ciò che ha detto Puppo: di questo disperatotentativo di fare storia per portare l’attenzione sui valori, non so seBianciardi avesse immaginato tutto quello che ha scritto di unmondo ridotto a un supermercato, quasi come poi più tardi alla finedegli anni ’70 avvenne, una moderna versione del castello di Atlantedi Ariosto, come una chimera in cui ti perdi e di cui non sai trovarel’uscita, non so se Bianciardi avrebbe potuto prevedere che la con-temporaneità che noi gli diamo quella che fa avverare, tutto quelloche ha detto con ironia, ma con anche grande saggezza, è anche unmondo che non esiste più, è un’altra definizione temporale del pre-sente, è, come in una metafora da lui usata, una televisione che nonviene mai spenta, e nega la possibilità del passaggio di una memo-ria e soprattutto di un futuro perché l’unico eventuale futuro è quellodi questo presente. Volevo dire che tutto quello che è stato dettoprima sulle qualità di Bianciardi. tutto ciò che di lui fa un maestro,passa attraverso la sua scelta di essere scrittore, Narratore, perchèla consapevolezza di quel senso narrativo dell’esistenza è molto im-portante in ogni articolo… lui che è stato sempre al di fuori da quelmeccanismo di giornalizzazione degli scrittori del tempo, lui è sem-pre stato un narratore, una persona che sa vedere gli interstizi dellecose, sa raccontare e fa pensare e interpretare il mondo.
Un altro tema che, secondo me, è tutt’uno con questa consape-volezza narrativa, è il tema della precarietà; è straordinario comelui parlasse dei precari alla fine degli anni ’50, lui parlava del ter-ziario e del quartario; nella precarietà la flessibilità è esattamentequesto: non è tanto lavorare part-time o non avere abbastanza soldie non avere una possibilità di un senso narrativo dell’esistenza, è undestino che riguarda sia l’ultimo lavoratore del call center, che ilgrande manager industriale, la cui testa sarà prima o poi tagliata.Questa incapacità di poter avere il senso della propria esistenza enon avere la possibilità di riconoscerla se ti volti indietro. I nostrigenitori avevano questo senso dell’esistenza ,è la metafora narrativadella nostra esistenza. la precarietà vuol dire che fra generazioni di-verse non si sa trasmettere il senso di qualcosa a lungo termine e in-
fatti politicamente le proteste sono questa le cose inutili senza lequali la vita non ha senso. Bianciardi è anche il maestro di tuttoquesto, è la paura che tutto ciò potesse avvenire, Bianciardi èun’onda anomala.
Un’altra cosa che vorrei dire a Luciana: il senso della narrativaè pur sempre trasmettere; per esempio, un giorno ero a Messina eho visto un liceo occupato, a cui gli studenti avevano cambiatonome, era stato attaccato uno striscione con su scritto Liceo Lu-ciano Bianciardi, ma non era vero, era stato fatto dagli studenti,avevano fatto una targa del tutto verosimile, una grande insegnaanche dispendiosa, e quindi nella loro occupazione creativa e di-dattica hanno evidentemente pensato che tutto ciò poteva avve-nire...( da riascoltare non si capisce sentire luciana)
Luciana BianciardiVolevo aggiungere che in televisione hanno realizzato una fic-
tion ambientata in un liceo chiamato Luciano Bianciardi, questoper sottolineare che , paradossalmente, più nella fiction viene fattoconoscere Luciano Bianciardi agli studenti che nella realtà
Beppe SebasteIo credo che nella realtà non si possa fingere ed è giusto che sia
così ,lui ha fatto un lavoro di destrutturazione,come fanno i mae-stri al contrario dei professori ,ed è impossibile che un professoresia un maestro, così quanto una scuola possa intitolarsi LucianoBianciardi, uno scrittore anarchico, non definito.
Maurizio PuppoIntanto sentito la parola profetico: io personalmente lascerei i
profeti alle religioni rivelate, anche se ho capito il senso. Durantela mia preparazione al convegno leggevo qualche articolo e holetto una bella recensione su Bianciardi in cui c’era scritto:” Bian-ciardi un grande conoscitore perché scoprì la mise comica di MikeBuongiorno in anticipo su Fiorello..” Bianciardi ha grandi meritima questo non l’aveva mai considerato nessuno.
Su Bianciardi e il 68, mi ricordo che Bianciardi partecipò, quasitrascinato per i capelli, ad una manifestazione a Genova e lì lesse unvolantino degli studenti contestatari e disse:’’ Ma come fanno que-sti ragazzi a fare la rivoluzione che non sanno neanche l’italiano ?’
166
LA LEZIONE DI BIANCIARDI
Personalmente avverto un senso di estraneità per quello che è ilmondo bianciardiano che è un mondo estremamente italiano
Paolo BreraIn quel momento lui però entra in contraddizione con se stesso,
perché tutti sanno che Garibaldi non conosceva l’italiano, parlavamolto meglio il francese. Per non parlare di Manzoni che si fa-ceva scrivere i testi dei suoi interventi in Parlamento da un collegaparlamentare fiorentino. Ecco, questi sono due grandi italiani chenon sapevano l’italiano.
Maurizio PuppoContinuando volevo sottolineare appunto questo senso di estra-
neità con quello che era il mondo Bianciardiano un mondo checonteneva le stesse istanze declinate su un piano diverso , di mo-dernizzazione e edonistica che era quella ne La vita agra a cuiBianciardi si dedicava quando diceva che la battaglia per il di-vorzio è una battaglia di retroguardia che infatti va contro il ma-trimonio e, in un certo senso dice la stessa cosa, in modo diverso,che diceva Pasolini : che l’Italia è un paese retrogrado per i diritticivili come il divorzio, il problema è che noi ci attacchiamo a que-ste conquiste. non perché cresciamo ma perché facciamo parte diuna società edonistica. perché buttiamo via dei valori retrogradi eli sostituiamo con niente che non sia il vuoto: a me pare che ladiffidenza di Bianciardi verso il ’68 fosse questa. di Bianciardi edel ‘68 con il suo pensiero risorgimentale e per niente sessantot-tino. Bianciardi era un adolescente gioioso, il 68 era un tentativodi diventare adulti da parte degli studenti ed in Bianciardi con que-sta caratteristica pinocchiesca di adolescente. il suo mestiere èquello di non farti fregare dalla fata turchina che rappresenta la ra-zionalità, la precisione, cose che pesano a chi vuole restare uneterno adolescente. Anche il rapporto con Feltrinelli ed i vari edi-tori entrò in crisi con Montanelli, perché Bianciardi scriveva que-sto libro contro Milano e dice meriterebbe di essere cacciato acalci in culo. Nonostante gli venisse offerto molto denaro per scri-vere articoli e Montanelli in un certo senso, rappresentasse la fataturchina che gli suggeriva di diventare grande e pensare al fu-turo,lui si rifiutò come un adolescente.
167
TAVOLA ROTONDA
LA LEZIONE DI BIANCIARDI
168
Forse, in questo senso, il Risorgimento per lui era un tempoantico, un’età magica, mentre il ‘68 rappresentava già la moder-nità e quindi una crescita, qualcosa che lui non voleva, Bianciardinon voleva diventare grande.
Paolo BreraGrazie. Sono state dette alcune cose su cui veramente bisogna
pensare perché chi ha vissuto il ‘68 sa che incredibile caleido-scopio fosse.
Mi sembra che non abbiamo ancora parlato troppo di Bian-ciardi come poeta, cioè di aspetti che non sono immediatamentesatirici e neppure legati a qualche ideale, ma che riguardano in-vece l’interiorità della persona. C’è qualcuno che vuole presentarequesto aspetto?
Leandro PiantiniIl poetico in Bianciardi è la sua narratività; non è poeta in senso
letterario, non ha scritto poesie, ma la poesia è ciò che esiste nellasua narrativa.
Paolo BreraMi pare che il punto sia che se qualcuno vuole dire cose razio-
nali scrive un saggio, se invece dipinge un quadro o scrive un ro-manzo allora non deve più essere solo razionale, perché la realtànon si presta ad essere interamente descritta in termini razionali.Ci sono anche aspetti contraddittori, che sono quelli che l’artista,il poeta riesce a restituirci; quando, ne La vita agra, nei raccontiche sono stati raccolti, Bianciardi parla di persone, non è intera-mente coerente con quella che è la sua visione delle cose, ma selo fosse non sarebbe più uno scrittore, un poeta: questo eral’aspetto che mi piaceva venisse messo in rilievo.
Leandro PiantiniBianciardi, Quando riesce come scrittore, a narrare i momenti
più belli, come per esempio quando racconta, nelle pagine ag-giunte a Il lavoro culturale, il ritorno a Cansas City, è un momentodi grande poesia; Grosseto come Kansas City, questo è uno deigrandi esempi che si possono fare: i suoi ritratti, la parte finale
TAVOLA ROTONDA
169
della La vita altra, è un gran pezzo di poesia: con questo senso didisfacimento. di disperazione e di fine delle illusioni, che si con-clude con queste 6 ore di sonno ed in questo sonno, egli non c’èpiù. Questo è uno dei momenti più duri di questo suo pessimi-smo, Bianciardi è uno scrittore vero, per esempio c’è una defini-zione: La vita agra, un libro cupo e disperato; io non sonod’accordo, magari c’è un pessimismo di fondo, ma è un libro che,in certi momenti mi ha divertito, e questo perché Questo autore saraccontare il neocapitalismo, la situazione sociale il rapporto tralui e Anna, la loro povertà, il loro amore, il loro erotismo scate-nato, lo sa raccontare in un quadro di narrato, di racconto originaleche fino a quel momento nessuno aveva ancora fatto. Perché Bian-ciardi è uno scrittore umorale, ma è anche uno scrittore che sapevabene quello che faceva , che mentre scriveva si rendeva conto chestava inserendosi in un filone nuovo. che non aveva più niente ache fare con i racconti del neorealismo degli anni 60, di esserenuovo, di fare qualcosa di simile a Enrico Molinari o Miller, Ma-stronardi, avendo sempre il nume Gadda di fronte: era consape-vole di ciò che faceva , era uno scrittore anche capace di farecritica su se stesso, alternando anche dei momenti di abbandonoin cui è più poeta adolescente, insomma un autore che ha unagamma molto variegata, da vero scrittore innovativo.
Marco BellottoA proposito di questa narratività di Bianciardi, sulla sua poeti-
cità: il fatto che per esempio su molti punti, Il lavoro culturalevenga definito un pamphlet, non è una definizione che ritengoesatta; in realtà, un libro come questo è difficile da definire in ca-tegorie prestabilite, da analizzare, è in definitiva un oggetto mi-sterioso. Volevo parlare a proposito della sua capacità innovativae narrativa, dimostrata anche negli articoli giornalistici, perchè infondo Bianciardi si accorse di affrontare un problema che in Ame-rica era già molto sentito: quello di un nuovo giornalismo ( newjournalism) o delle tracce che aveva lasciato un libro come A san-gue freddo negli Stati Uniti: questa mescolanza tra autobiografia,saggio e narrazione, questa capacità di scrivere articoli giornali-stici utilizzando strumenti della narrativa; su questo Bianciardi ri-solve il problema: ogni articolo che fa, ogni libro che scrive con
LA LEZIONE DI BIANCIARDI
170
una naturalezza da grande anarchico, da grande sperimentatore,senza porsi il problema delle categorie; in questo Bianciardi si ri-conferma grande narratore e grande sperimentatore.
Paolo BreraCredo che qui stiamo facendo un dibattito un po’ troppo strut-
turato e forse non rendiamo onore alla memoria di Luciano Bian-ciardi che era prima di tutto un membro del Partito d’Azione, unpartito della Resistenza con tendenze più libertarie che anarchi-che. Destrutturiamoci! Noi siamo qui su questo palco, parliamo,ma vorremmo un contributo da parte dei partecipanti in sala oltreche a noi che a questo convegno facciamo da oratori.
Intervento del pubblico Mario Serafini (Santini?)In qualità di cugino, volevo dire che, di tutto ciò che è stato
detto, si dimentica una cosa importente: la disperazione. Io sonostato testimone, quando lui è ritornato a Grosseto da Milano, diquello che il suo cuore ricominciava a ad affrontare queste solu-zioni che lui non aveva studiato prima; era fuggito da Grosseto eaveva abbandonato quello che era la sua terra e naturalmente tuttoquesto si era ribadito in quello che era il suo comportamento, ilsuo ripensamento milanese, e quindi quando tornava desideravasapere cosa succedeva . Non sono stato un grande cugino di Lu-ciano, perchè avevamo due temperamenti e idee diversi, l’ho ca-pito soltanto in seguito. Ricordo, quando una volta andando aPisa, perché studiavo là con lui, mi raccontava tutte le sue cose emi metteva anche in grado di conoscere tutto quello che riguar-dava i poeti come Quasimodo, Montale che io conoscevo, ma nonapprofonditamente; e mi ricordo che una volta, questo rientra nel-l’ambito della caratteristica di Luciano, mi disse:’ Domani ti portouna mia poesia ermetica.’ me la portò, credo che io sia l’unico aconoscerla: si mise nel sedile davanti del treno e mi disse:’ titolo:fascismo svolgimento: cartone. Tela. Mostra del tessile. Strage.che mi sembrò che fosse poco ermetica.. in cinque parole mi dissetutto quello che aveva scritto; questo era Luciano. Credo che Lu-ciano non si possa considerare un insegnante ma un maestro.Quando lui veniva a Grosseto mi cercava perché ero l’unico chepoteva metterlo a contatto con la famiglia; io sono stato l’unico
TAVOLA ROTONDA
171
che ha scritto a Maria Iatosti quando in casa mia tutti erano con-tro ciò che stava facendo e che solo io forse avevo capito, quindicercavo di migliorare la situazione. Ricordo che insieme si parlavadi quello che avveniva sulla scala del Duomo:’ perché vedi Mario,ci si può mettere anche a sedere qui su questi gradini ma te li im-magini senesi se dovessero essere d’accordo con noi, ci vorrebbeuna sedia a loro per sedersi qui con noi.!’ Il discorso, quello diKansas City, è nato tra noi, perché Grosseto in quel’epoca era , se-condo l’accezione che potevamo avere una città periferica, in-somma Grosseto divenne Kansas City; anche questo è stato undiscorso di cui tanti si appropriarono tutti in quegli anni. Per con-cludere, volevo dire che Luciano per me era un maestro, e non uninsegnante, perché non insegnava niente. Io l’ho visto a Castel delPiano fare il resoconto di una partita come se non avesse mai vistouna partita di calcio, come se non sapesse chi era l’arbitro, tuttociò per dire quale stile unico aveva Bianciardi questo è il mio con-tributo, Grazie.
Paolo BreraCi sono altri interventi?
Intervento del pubblicoSono un lettore di Bianciardi ed un grossetano: io credo che non
facciamo un buon servizio a Bianciardi se non spieghiamo che, que-sta situazione di eterna adolescenza non è altro che, come ancheLeopardi, un non essere allineati con le visioni dominanti politicheletterarie del periodo; ma non si coglie l’elemento, cioè quelle chesono le idee. È mia abitudine, cercare di capire cosa produce unoscrittore, e credo lui non fosse allineato, non abbia fatto parte dellafase storica in cui ha vissuto, delle due grandi chiese: quella catto-lica e quella comunista: ci teneva a differenziarsi. Non era allineatonemmeno alla ricostruzione storica precedente, credo che fosse que-sto il suo valore: mi sembra fosse stato detto, rispetto alla sua rico-struzione del Risorgimento, che lui aderiva alla corrente antiretoricarispetto al riorgimento, quindi l’Italia è stata fatta sotto l’insegna didemocrazia moderata il modo in cui Bianciardi recupera l’ereditàrisorgimentale nella corrente popolarem quella che è stata sconfittastorica della parte radicale del Risorgimento, quella di Cattaneo
LA LEZIONE DI BIANCIARDI
172
quella sconfitta di cui noi è oggi ancora portiamo le conseguenze daquesto punto di vista anche il modo e la scelta dello stile narrativodi Bianciardi è particolare lui ha inventato un modo di narrare moltooriginale tra inchiesta, ricordiamoci dei Minatori di Maremma librocon cui esordisce, il saggio e la narrativa. Non è un caso che diventioggigiorno un autore attuale: Lui muore in un’epoca in cui lo scri-vere legato alla realtà finisce, ed inizia il postmoderno ma oggi tuttoquesto è finito perchè la crisi economica irrompe nella vita di cia-scuno di noi in maniera drammatica e si riflette anche sui gusti let-terari, non a caso uno dei libri più letti oggi è Gomorra, un’inchiestariproposta in chiave narrativa dell’attualità. Bianciardi, come Leo-pardi, è sempre attuale perché rappresenta un punto di vista criticorispetto al reale e non solo non è allineato, non è riconducibile aduna delle correnti dominanti. Secondo me, inoltre, l’adolescenza èun concetto acquisito nella società occidentale, non è un qualcosadi naturale proprio perché in questa situazione di crisi economicanon possiamo essere indipendenti; ciò non vuol dire che non siamoadulti, anche a me spesso dicono che sono ancora un adolescenteperché non ho rinnegato il ’68, hanno per me importantissimo, pro-prio perché rappresenta la mia giovinezza , gli anni dei grandiamori, e non vedo perché dovrei pentirmene. secondo me l’adole-scenza non è un concetto che appartiene all’interpretazione di Lu-ciano Bianciardi.
Maurizio PuppoVolevo intervenire perché mi sento chiamato in causa dal ter-
mine utilizzato di adolescenza, sono d’accordo sul fatto l’adole-scenza non esiste in alcuni luoghi non occidentali, ma, parlandodi adolescenza, che questa è la mia visione di Bianciardi e, misembra, anche se non l’ho conosciuto, forse oggi di incontrarlo esono contento che sia esistito un personaggio del genere in Italia,che abitasse in lui, soprattutto ne La vita agra, un rifiuto del sensodel limite, un grandissimo desiderio di ritrovare il ventre maternoe queste non sono cose critiche, sul suo valore letterario, o sullesue vicende autobiografiche, sono percezioni mie discutibili dellaua opera . Bianciardi, in qualche modo, ne La vita agra lo dicevaparlava. Del babbo, in alcuni luoghi c’era un odore misto di ta-bacco questo odore di babbo e lui diceva:’ io non ce l’ho’ eppure
TAVOLA ROTONDA
173
aveva moglie e famiglia ma non sentiva di avere quell’ odore, sem-brava in qualche modo una confessione esplicita del desiderio edella sofferenza di esser diventato grande, dopodiché se lei haaltre opinioni personali rispetto alla propria esperienza è un altrodiscorso. Se le dicono che è rimasto adolescente, perché non si èpentito dei lavori che aveva 18 anni, si sbagliano di grosso.
Beppe SebasteVolevo dire che sono molto contento, e che avrei voluto citar
prima a proposito dell’invito a parlare della poesia di Bianciardi;perché ne I minatori della maremma, che è la prima opera di Bian-ciardi, ma che è anche una delle più innovative. È importantissimoparlarne, perché c’è qualcosa di cui oggi se ne riconosce l’attualità.Ciò che la letteratura, in ritardo rispetto alle arti e al cinema, stacompiendo: cioè accorgersi che è molto più libero e ricco della fic-tion il documentario, in mancanza di una forma migliore che ancoranon si trova. Cioè quell’inserzione tra il recupero della memoria lastoria presente, la testimonianza quel territorio che compone quelloche si chiama la letteratura civile, in cui si nominano o si scrivonodelle citazioni dei documenti reali su d i nomi veri, si fanno bio-grafie su testimoni tutto ciò che nelle arti è presente da più decenni:in particolare questo fare biografie, questo dare un nome ai morti èuna velleità dell’arte contemporanea,per esempio Kandinsky e lesue opere monumentali (da rivedere 188’). Questo libro di Bian-ciardi è una delle opere più intense più cariche di insegnamenti checi ha lasciato, da leggere e rileggere assolutamente. Concludo di-cendo che oggi si sta cercando di orientare le narrativa verso qual-cosa che assomiglia molto a quest’opera di Bianciardi.
Leandro PiantiniA proposito di questa opera, io l’ho letta una decina di anni fa
e mi fece una grande impressione, in quel momento mi sembravala opera più grande di Bianciardi. Mi aveva colpito in particolarmodo la tematica di cui ancora non si è parlato in questo conve-gno riguardante, la tragedia Ribolla. Tutto parte da qui: questaesperienza terribile, traumatica, che Bianciardi visse come sefosse morto un suo parente, come se fosse morto suo padre o suofratello. Questa esperienza è stata per Bianciardi qualcosa di così
LA LEZIONE DI BIANCIARDI
174
grande, che segnò una svolta nella sua vita, ma anche nel territo-rio e nell’economia della maremma: la fine dell’attività mineraria.Io ammirai di questo libro anche l’ assoluta scientificità con cuiera stato scritto, l’obiettività: sembrava un saggio di quella che sichiama una microstoria esemplare, raccontando una fetta di re-altà molto lunga, facendo i nomi cognomi e biografie, con unascioltezza da grande scrittore.
Jole SoldateschiSarò breve. Io sono purtroppo un’insegnante e non un maestro
come alcuni dei miei colleghi presenti e come tale sono attenta adele precisazioni: volevo riallacciarmi a qualcosa che è stato chie-sto dal moderatore, Brera: Bianciardi e il ’68, come lo vive. Se-condo me il tema era quello del Risorgimento. Bianciardi era unpersonaggio ambivalente; da un lato il Risorgimento per Bianciardiera il luogo del trionfo della fantasia dell’immaginazione della gio-vinezza operosa e, come per tutti i posti garibaldini il rimpianto diun’immaginazione perduta: per cui dall’altro vive il ‘68 come spe-ranza di un ritorno dell’immaginazone. In seguito il Risorgimentoè diventa quasi un mito. La vita di Bianciardi è stata anche dispe-razione e quindi Risorgimento si coniuga all‘insegna di essere unmito che non ritorna, un mito del passato: quindi da una parte c’eraun tentativo di riattivare il Risorgimento come immaginazione alpotere e dall’altro, sembra ci sia un articolo di Bianciardi dove sidice :’questi capi, capetti in testa al movimento studentesco mi sem-bra che si stiano preparando un posto in Parlamento per il futuro’ .Il 68 è anche il luogo di una avanguardia ideologica politica chenon coinvolge le masse il popolo e la gente che lavora, come d’al-tra parte il Risorgimento di Bianciardi non è quello di Pisacane eMazzini o dei fratelli Bandiera che manda allo sbando a far morirela gente. Quindi c’è questa doppia visione del Risorgimento chepuò rispondere a ciò che può essere stato il ‘68 per Bianciardi.
intervento del pubblicoVorrei fare un intervento bipartisan per quanto riguarda la mila-
nesità e la maremmanità, in quanto figlio di tre generazioni milanesie sono nato in maremma e battezzato a Firenze. In questo momentovorrei fare un intervento e mi scuserete se tendo a raffreddare la di-
TAVOLA ROTONDA
175
scussione, su alcune digressioni sull’organizzazione di questo con-vegno: mi rivolgo anche all’Assessore alla cultura: una decina dipersone hanno valorosamente organizzato un convegno e lo hannoben gestito, ma naturalmente i convegni hanno la grande impor-tanza di porre degli studiosi a contatto fra loro affinché possanoconfrontare delle idee però essendo in genere aperte al pubblicohanno anche la funzione di coinvolgere la cittadinanza sugli argo-menti dibattuti. Io ho fatto una media della partecipazione della cit-tadinanza grossetana a queste giornate, e la media è stata quella dicirca 40 persone: dipenderà da tante cose, ma mi rivolgo a quelloche dice l’Assessore: non c’è cultura senza scuola: ma non credoche ci sia scuola che produca teste ben fatte senza interesse cultu-rale e mi pare che questo nella nostra città sia molto scarso. Ciònon conta solo per i convegni ma conta per il teatro, per la musica,la letteraturae la poesia questa è una situazione che dipende proba-bilmente dal fatto che non è mai stata data notizia sui giornali, èquesta la dice lunga sul giornalismo grossetano, quindi la prima do-manda che pongo è questa: potete dare una risposta su come mai iè cambiato così poco dai tempi in cui parlava Bianciardi ad oggi?
Paolo BreraCredo che stiamo andando fuori strada; una partecipazione di
40/50 persone non è assolutamente scarsa, in quanto milanese,posso dire che questa partecipazione non è affatto bassa. La stessacosa fatta a Milano avrebbe portato 20 persone.
Intervento del pubblicoProbabilmente a Milano di conferenze come queste ce ne sono
circa 18 al mese, mentre a Grosseto ce ne sono una ogni 18 anni,comunque non voglio creare polemiche.
Lucia MatergiVolevo evidenziare di come spesso i punti di vista siano diversi;
infatti io quando sono entrata a questo convegno mi sono sentitamolto soddisfatta e ho detto :’ che bellezza che in una stanza chepuò contenere fino a 100 persone, la metà dei posti siano occupati!’io non dico che sia un’ottima cosa ma è molto al di là della mediafisiologica, e questo testimonia anche l’interesse, che poi davanti a
LA LEZIONE DI BIANCIARDI
176
queste a situazioni di questo genere non ci sia una pubblico abba-stanza vasto io non me ne voglio compiacere come grossetana anzimi dispiace, però penso anche che questo sia un convegno che portaall’attenzione un aspetto di un intellettuale molto specifico e cosìdeve essere. Stamattina salutando il convegno mi ero anche moltocompiaciuta di questa angolatura che è stata data: un convegno chenon parla di Bianciardi, ma parla di un Bianciardi; e questo è già unsegno di una crescita culturale. Scegliere di fare il punto su unaspetto. In effetti mi sono meravigliata che oggi non si non si siaparlato di tutto, ma che è stato detto qualcosa d’importante suun’apsetto particolare: ‘800 come ‘900: di questo si doveva parlare.MI sembra un argomento che sia statio inoltre abbastanza concluso,e ci auguriamo che il pubblico possa crescere: in qualche modoGrosseto è come Milano ecco perché 800 come 900. È importanteanche accettare i tipi di spaziature in cui si possono prevedere ancheun certo tipo è una certa quantità di pubblico, senza rammaricarsi,senza dire sempre che noi siamo bravi e quanto sono qualunquistiquelli che vanno a comprare il gelato al sabato pomeriggio. Perchéanche questo è uno degli aspetti specifici della provincia.
Massimiliano MarcucciVolevo dire che durante il corso di questo convegno abbiamo
distribuito più di 100 cartelline quindi vuol dire che sono più di100 le persone che sono venute qua ad ascoltare il convegno,senza calcolare coloro che non hanno preso la cartellina
Intervento del pubblicoConcludo dicendo che vedo che in questo luogo sono ben rap-
presentate le categorie degli autori delle istituzioni, dele eccellenzecome il signor prefetto il presidente del tribunale, ma lasciamo per-dere, volevo dire che io ho avuto la forte suggestione quando si è ac-cennato l’altro giorno a quel piccolo saggio di Baldacci l’ultimodella serie di pubblicazioni che fece sulla nazione, intitolato: ‘800come i muri. Mi ricordo che il saggio mi ha suggerito quest’ideacome se Bianciardi vedesse l’800 in generale e il Risorgimento inparticolare; come una metafora della realtà che permettesse diuscire dall’incoerenza e dalla contrdditorietà del presente di frontead avvenimenti che non sono né contraddittori né incoerenti, ma
TAVOLA ROTONDA
177
comprensibili. Luigi Baldacci, che conoscevo personalmente in gio-ventù, parla della conduzione artistica e letteraria musicale dell’800che, a differenza di quella contemporanea, è fruibile senza media-zione critica. se ci pensiamo bene l’arte che non è fruibile se noncon mediazione critica, e tutto ciò mi dà una sensazione di incoe-renza: è innegabile però che oggigiorno sentire o guardare un qua-dro senza mediazione critica sia impossibile.Di conseguenza pensoche Bianciardi avesse questa sensazione, la sensazione di trovarsi difronte ad un mondo, a un’epoca che per la sua contraddittorietà eraincomprensibile, e volersi rifare ad un passato recente, il Risorgi-mento, dove la meccanica dei rapporti politici era più chiara, perfarsi un’idea anche del presente.
Maurizio PuppoSi parlava del rapporto personale che ognuno di noi ha con
Bianciardi: perché questo autore c’interessava, ci piaceva, perchéè sopravvissuto all’oblio. Pasolini per esempio ha una visione delmondo pessimistica, la sua vita è al limite, invece Bianciardi perme è un amico. Un intellettuale che ha studiato e si è laureato, acui però piacciono anche le donne e il calcio: questo aspetto lu-dico di Bianciardi, giocoso, come i suoi articoli sul Guerin Spor-tivo: quel senso di fragilità e di autoironia. Io non so di prescisocosa sia la poesia, ma non avevo mai visto questa capacità di iro-nizzare su se stessi, sulle proprie relazioni; per me Bianciardi è so-prattutto un compagno di giochi uno con cui si può parlare ditutto, dalla letteratura al calcio.
Paolo BreraSuggerirei di leggere alcuni brani dei libri scritti dagli autori
qui presenti.
Marco BellottoLeggo un brano breve del mio libro gli imitatori che parla del-
l’inizio dell’amicizia tra il mio protagonista che si chiama LivioMantarro e Bianciardi.
Maurizio Puppo
LA LEZIONE DI BIANCIARDI
178
Leggo un brano del mio libro ‘’Bandiere Blucerchiate” in rife-rimento alla ricezione di lettere minatorie...
Paolo BreraVorrei parlare del momento in cui Bianciardi parlava dell’italo-
inglese o dell’anglo-italiano di cui si lamentava. La tendenza èinarrestabile. Va di pari passo con la caduta dell’italiano versol’abisso.
Intervento del pubblicoSi è parlato di Bianciardi poeta. Ho letto recentemente La Vita
Agra e ne sono rimasto molto colpito. Ho capito la solitudine diBianciardi: perché alla fine del libro dice:’ io sono un bravo cri-stiano?’ la sua visione poetica secondo me era uscita di totalmentedalla politica, perché sapeva che ci sarebbe stato questo totalita-rismo economico da cui sarebbe stato sopraffatto. Questo è se-condo me è per certi versi come un sentimento dignitoso, perchéBianciardi era un conoscitore. Secondo me La vita Agra non èstato compreso fino in fondo, nel suo valore di classico. QuestoLibro può stare bene accanto a grandi testi come quelli di Emer-son. Bianciardi si è ben inserito nella storia italiana, ne prova do-lore, perché l’umanità viene sopraffatta dalle forze politiche, siala destra nella sinistra. Concludo dicendo che forse questo suo di-ritto umano questa sua consapevolezza ,solo oggi può essere com-presa nella sua totalità.
Intervento del pubblicoBuona sera io faccio parte del Gruppo Esperantista Italiano e
mi sono avvicinata da poco a Bianciardi grazie alcuni amici gros-setani. Ho avuto la fortuna di sentire questi approfondimenti chenon conoscevo, però volevo evidenziare una possibilità di diffu-sione di Bianciardi: abbiamo presentato in occasione del con-gresso esperantista a Grosseto, una traduzione di Bianciardi inesperanto, questo perché grazie anche a queste traduzioni è pos-sibile che questo autore e le sue opere possano essere conosciutein tutto il mondo grazie a questa lingua.
Luciana Bianciardi
TAVOLA ROTONDA
179
Ringrazio tutti quanti Puppo Bellotto Brera Piantini Sebasteringrazio il pubblico perché in fondo è stato un bellissimo dibat-tito, grazie a tutti alla prossima.
LA LEZIONE DI BIANCIARDI
180
Nell’ottobre del 2005 stavo scrivendo il mio secondo romanzo,quello che diventerà “gli Imitatori” pubblicato da Marsilio nel mag-gio 2008. Ero arrivato al punto in cui il protagonista, Livio Man-tarro, esordisce come scrittore per Feltrinelli – l’anno è il 1963 – eva a vivere a Milano, la capitale culturale dell’epoca (e non solo).In quel frangente del romanzo, Mantarro è un giovane ingenuo dapoco fuggito da un seminario cattolico, uno scrittore provenienteda una provincia povera economicamente e culturalmente, e cheapproda in una metropoli di cui non capisce nulla. Ogni avveni-mento, ogni incontro, costituisce per lui una novità assoluta.
Fin dall’inizio pensavo a un amico per lui, un Virgilio che loaccompagnasse in questo viaggio nell’altra dimensione. Un amicoche doveva essere meno giovane, più esperto della vita (e di Mi-lano), che fungesse da contrappunto per un personaggio comeMantarro, uomo provvisto di senso del sacro sia religiosamenteche politicamente. Insomma, mentre costruivo questo personag-gio dissacrante e libero tanto quanto Mantarro è un “imitatore”, miaccorsi che inconsciamente stavo descrivendo proprio Bianciardi.Di più: forse era stato proprio Bianciardi a suggerirmi l’idea diquesto doppio in chiaroscuro.
Vi era una sola incongruenza: Bianciardi in quegli anni si eraritirato da Milano a Sant’Anna di Rapallo. Pertanto mi presi la li-cenza narrativa di farlo ritornare a Milano; scrissi “era tornato aMilano perché a Sant’Anna era triste e gli veniva da bere. A Mi-lano beveva lo stesso, ma stava un po’ meglio, diceva”.
All’epoca io avevo letto soltanto due libri di Bianciardi: “Il la-voro culturale” e “La vita agra”, e poco altro su di lui. Mi dedi-cai perciò per un paio di mesi a una conoscenza più approfonditadell’uomo, leggendo tutto quello che mi capitava. Riuscii anchea parlare con alcune persone che lo avevano conosciuto in vita(mi prendo la libertà di non fare il nome di queste ultime).
Poi, improvvisamente, interruppi questo approfondimento. Vo-levo che una parte di Bianciardi mi fosse totalmente sconosciuta,altrimenti rischiavo di farne una lettura troppo biografica, troppostorica. Speravo di riuscire a colmare la distanza che ci separavacon intuito da romanziere (sempre ammesso che io lo pos-sieda…). Lo stesso anche per ciò che attiene i suoi gusti letterari,le sue opinione politiche: non volevo sapere troppo.
TAVOLA ROTONDA
181
E così è nato il personaggio Bianciardi, che oramai io rischiodi sovrapporre a Luciano Bianciardi qual era, qual è stato.
Per spiegarmi meglio inserisco ora una pagina del mio ro-manzo.
“Bianciardi metteva i soprannomi a tutti e così Mantarro ungiorno gli chiese se poteva chiamarlo Orso, perché gli ricordavaun orso che aveva visto in un circo. Bianciardi aveva riso e gliaveva detto non si chiede il permesso per mettere un soprannome,lo si mette e basta. Mantarro disse ah, e allora Bianciardi gli disseche poteva chiamarlo come cazzo voleva lui.
Bianciardi bestemmiava, ma una mattina, mentre prendevanoil caffè, si voltò all’improvviso e squadrò Mantarro.
- Di’ la verità, don Livio. Ti dà fastidio che io bestemmi.E Mantarro disse che sì, le bestemmie gli davano un po’ fasti-
dio, ma non le tue, Orso, e questa frase la disse con timidezza, eallora Bianciardi disse in tua presenza non bestemmierò più.
Una sera, una sera di cattivo umore, Bianciardi lo aggredì. - Tulo sai cosa penso del tuo cazzo di libro, perché non mi dici nientesui libri che ho scritto io? – Forse aveva bevuto troppo.
Mantarro disse che La vita agra gli era piaciuto molto; ancheIl lavoro culturale gli era piaciuto, però gli era sembrato che pren-desse in giro il Partito.
Bianciardi scoppiò a ridere, ma era come se piangesse. - Seicome tutti i preti spretati, Don Livio. – Si fermò per soffiarsi ilnaso e togliere le lacrime. - Bisogna temervi, voi cattolici delusi,ma bisognava temervi anche quando eravate illusi. – Adesso ri-deva e basta, era sicuramente ubriaco. – Però tu mi stai simpaticolo stesso don Livio, perché almeno sei un puro. Un puro di cuore,cos’è che diceva quell’accidenti di Gesù Cristo sui puri di cuore?
Bianciardi gli dava lezioni di vita e di letteratura italiana.Bianciardi diceva che gli scrittori erano tutti presuntuosi - quasinessuno davvero ambizioso - tutti adoratori della dea puttana delsuccesso, tutti permalosi, tutti pazzi per la fica. Tutti comunisti,ciascuno a modo suo, tutti pronti a parlare male del Partito insua assenza, nessuno capace di farne a meno. Il Partito era sem-pre con te: non ti faceva sentire inutile, non ti faceva sentire solo,c’era sempre qualcuno a Milano o da qualche altra parte pronto
LA LEZIONE DI BIANCIARDI
182
a discutere con te all’infinito. Il Partito: paura dell’esclusione,perdita del senso della realtà.
Bianciardi diceva che gli scrittori italiani, a parte qualcuno,erano tutti mediocri. Che l’unico vero artista italiano era Fellini,per Otto e mezzo, non per La dolce vita, La dolce vita era troppodidascalico. E che Fellini stava sul cazzo agli scrittori perché asuperarli era un minchione, uno che non sapeva nulla di lettera-tura e che se ne sbatteva del realismo. E che Fellini era statol’unico a capire che la cosa migliore di un uomo sono le storie cheracconta e non la Storia che l’ha forgiato, e che se a un uomo to-glievi il suo tempo restava qualcosa di meglio. Insomma gli scrit-tori italiani erano tutti dei sei, sei e mezzo, e Fellini si era dato dasolo il voto che meritava.
A Bianciardi quelli del Gruppo 63 facevano schifo. - Non riu-sciranno a mettere assieme un romanzo che sia uno, ci mettol’uccello. Forse qualche poesia, qualche racconto, ma neancheun romanzo come si deve. Finora comunque non ci sono andatineanche vicini, e siccome non sono capaci si sono messi a ti-rare merda su Bassani e Cassola. Dovrebbero sciacquarsi labocca prima di parlare di Carlo. Avrebbero tirato merda anchesu Moravia, sono sicuro, Moravia scrive con una lingua che lorose la sognano e invece dicono che gli fa cagare, però quellavolta a Palermo mentre loro stavano dicendo tutte le loro ma-donne gli arriva Moravia in sala, lo sai quello che è successo,vero don Livio?
Mantarro annuì, ma non la sapeva.A Bianciardi facevano schifo Stalin, Lenin e Togliatti. - Hanno
fatto più danni loro al comunismo che i nazisti, i fascisti, e gliamericani messi assieme. Sei d’accordo anche tu, vero don Livio?
Mantarro annuì, ma era confuso.A Bianciardi Chruš•ëv piaceva. – Ha fatto casino con l’Un-
gheria e con Pasternak, ma perché è una testa calda. Se il comu-nismo si salverà sarà merito suo. Mi capisci, don Livio, vero?
Mantarro annuì ma era sempre più confuso.A Bianciardi piacevano Sciascia e Gadda. – Del Novecento
italiano resteranno Gadda e quello nuovo, Sciascia. E una decinadi altri libri, poi basta. Gadda si è inventato un cazzo di lingua,e Sciascia ha un motore… La scena del giorno della civetta in cui
TAVOLA ROTONDA
183
si incontrano il carabiniere e il mafioso… quella dei pigliainculoe dei quaraquaqua, ti fa venire i brividi. Che poi è strano chesiano sempre i conservatori quelli che scrivono meglio, hannouna prosa con le palle… Sei d’accordo, vero don Livio?
Mantarro sorrise e annuì. Gadda e Sciascia, fossero conser-vatori o meno, piacevano anche a lui.”
Non occorre essere un grande esperto di Luciano Bianciardiper capire che mi sono preso una grande – forse eccessiva – li-bertà nel descrivere umori e simpatie del mio personaggio.
Però ci sono almeno diversi motivi per cui sono orgoglioso delmio lavoro, pur nei suoi limiti.
Innanzitutto, ho continuato a leggere pagine di e su Bianciardianche dopo terminato il romanzo, e ho scoperto che alcune dellecose che mi ero inventato – per esempio alcune delle opinioni let-terarie contenute nel brano che ho appena inserito – erano dav-vero sue. Ad esempio, l’anno scorso ho letto la raccolta degliarticoli che lui scrisse per il Guerin Sportivo, intitolata “Il fuori-gioco mi sta antipatico”; ebbene, vi ho trovato molte opinioni che,abbastanza miracolosamente, avevo attribuito del tutto arbitraria-mente al mio personaggio.
Poi, e questo mi fa immenso piacere, molti di coloro che hannoletto il romanzo si sono interessati alla sua figura. Mi hanno fattodomande su chi fosse stato veramente. Una settimana fa ho avutola gradita sorpresa di trovare, a casa di una cara amica, una copiade “La vita agra” sottolineata in alcuni punti.
Infine alcuni critici hanno notato che il personaggio di Bian-ciardi è riuscito meglio del personaggio di Mantarro. Bella forza- ho scritto a uno di loro - ti sembra che la letteratura italiana degliultimi anni abbia prodotto un solo personaggio più interessantedi quanto è stato interessante il “vero” Luciano Bianciardi?
E poi c’è un ultimo aspetto, che per me è importante, ancheperché si riferisce non tanto allo scrittore, quanto all’uomo.
Il titolo del mio romanzo allude alla situazione in cui versiamotutti noi, in qualunque luogo, in qualunque epoca, in qualunquecondizione ci troviamo a vivere. Chi può dire di essere veramentese stesso, e non invece il prodotto del luogo, dell’epoca, della con-dizione in cui è nato? Chi di noi è davvero, senza artifici e senzadipendenze, l’originale se stesso?
LA LEZIONE DI BIANCIARDI
184
È una domanda difficilissima, cui ciascuno di noi fatica a ri-spondere. E questo perché ciascuno di noi è per moltissimi versiun “prodotto”, cui forse si riesce a dare un tocco, un minimo toccodi personalità. Per questo amo moltissimo i “precursori”, quelliche cioè riescono ad anticipare i tempi, direi a vivere nel tempoche si sono scelti.
Ebbene, Bianciardi non soltanto è un precursore (lo è, certa-mente). Bianciardi è stato – anche e soprattutto - un uomo origi-nale, un uomo libero che ha pagato a caro prezzo scelte contrarieai suoi tempi (e ai suoi luoghi) che ha pagato per il fatto di volereessere se stesso, con i suoi talenti, le sue opinioni, anche i suoidifetti.
Per concludere: non so se il “personaggio Bianciardi” de “GliImitatori” sia davvero un omaggio riuscito. So però che è un tri-buto, un atto di riconoscenza per uno scrittore, e un uomo, che miha insegnato moltissimo.
Marco Bellotto
TAVOLA ROTONDA
185
L’insospettabile milanesità di Luciano Bianciardi
Noi milanesi non ammettiamo quasi mai di amare Milano.Anzi, per lo più ne parliamo male, così come si pretende per certegrandi passioni che non si vogliono svelare. Ma a un milaneseMilano è indispensabile come una malattia a cui ci si affeziona.
Già, ma chi sono i milanesi? Non certo quelli che vantano unpedigree di più generazioni, ormai ridotti al lumicino. I milanesi,come accade nel destino delle grandi aree urbane, sono coloro cheper scelta o per necessità sono andati a popolare una metropoli in-gigantendola e arricchendola di culture e linguaggi, non solo ver-bali, anche lontani. I milanesi sono un popolo di ex emigranti, diimmigrati di prima, di seconda, di terza generazione. Per questo,soprattutto, della loro città parlano male, in loro si avverte quasi uninconscio altrove d’origine, un luogo migliore – campagna, sud, estdell’Italia o del mondo – che è sempre meglio, magari per storia,certamente per natura, di quell’agglomerato di vita frettolosa, insa-lubre e molto contradditoria che è il capoluogo lombardo.
Luciano Bianciardi è stato tra questi milanesi non-milanesi ilpiù arguto, sofisticato, brutale, profondo critico implacabile dellacittà che abitava. I nostri antenati più prossimi chiamavano bona-riamente questo genere di milanesi “ariosi” cioè quella parte diimmigrati in cerca di spazi e fortuna, i pagnottanti. Gente preva-lentemente colta o abile che intuiva che la nostra città poteva/do-veva essere il luogo più propizio per la propria crescita culturalee affermazione economica.
Bianciardi arrivò in città in un momento entusiasmante e alcontempo drammatico di Milano: il pre-boom e boom economico.
Ne visse ai margini (ma non del tutto) quelle spinte, anche que-gli entusiasmi, quelle enormi contraddizioni che la esaltarono manello stesso tempo la limitarono, incuneandola in una strada ob-bligata dalla quale Milano non è più riuscita ad affrancarsi.
Non sappiamo collocare (e sinceramente in questo contesto maanche in assoluto ci interessa molto poco) Luciano Bianciardi inuna specifica area di pensiero ideologico. Anarchico, forse; anar-chista, più probabilmente. O molto più semplicemente, e a noipiace così, lucido disadattato e vivace ribelle a quel nuovo che
LA LEZIONE DI BIANCIARDI
186
avanzando in modo disordinato spegneva sul nascere gli entusia-smi delle menti più scettiche e tormentate come la sua. E irresi-stibile quanto pressante “provocatore”.
C’è una straordinaria leggenda metropolitana sul conto dell’in-tellettuale Bianciardi inserito nelle grandi contraddizioni che la Mi-lano del dopoguerra viveva tra nuovo capitalismo e nuova coscienzapolitica. Redattore e consulente di prima grandezza di una formi-dabile casa editrice della città, l’insofferente quanto geniale gio-vane Luciano, figlio di Maremma, partecipava ai summit editorialiindossando abiti dimessi e forse anche un po’ volutamente rivolu-zionari”. Un giorno entra l’editore, che era anche la proprietà, conun perfetto cappotto cammello che appende all’attaccapanni.L’uomo, intellettuale e imprenditore di sinistra e ideologicamentemolto collocato, parte con una dissertazione sulla necessità di strin-gere i tempi del processo rivoluzionario, sostenendo più o menoche la parità dei diritti era prossima e l’uguaglianza necessaria. Ter-mina il cappello politico e sta per iniziare la riunione vera e propria.
Bianciardi si alza, si dirige verso l’attaccapanni, infila il lussuosocappotto dell’editore e se ne esce sottolineando che il processoegualitario è iniziato. Da quel giorno quel cappotto cammello fuuno dei marchi inseparabili di Bianciardi. Provocatore, d’accordo,ma molto di più, naturalmente.
Sempre in bilico tra la critica profonda della micro e della macrorealtà che lo circondava e il rigore dell’intellettuale in cerca di nuovientusiasmi anche professionali, Bianciardi ci ha regalato e conti-nuerà a regalare in futuro a quella Milano che lo ha accolto e re-spinto, ricambiata della stessa moneta, la più lucida delle analisicritiche che mai siano state fatte di questa città. Non è stato il solonella storia di Milano: per uno Stendhal particolarmente benevolo cifu ad esempio un Foscolo asperrimo che dipingeva i milanesi comegente dal “cuore castrato e grasso” e con “fibre del cervello cornee”.Eppure Foscolo, come Stendhal e come lo stesso Bianciardi visseroMilano a sprazzi ma sempre intensamente ne furono protagonisti avolte esaltanti, a volte distratti. Tutti sono appartenuti alla grandeschiera di coloro che hanno contribuito, nelle sfaccettature più va-riegate, alla crescita e alla Cultura delle culture di questa città.
Non siamo del tutto d’accordo con coloro che dipingono Lu-ciano Bianciardi principalmente come uno dei grandi detrattori tout
TAVOLA ROTONDA
187
court di Milano. La sua raffinata sensibilità lo eleva di grado. Chisi limita a denigrare spesso demonizza e impone. Il pensiero nega-tivo a prescindere, previsto dalle critiche senza via di scampo, de-paupera ogni cultura, sovrasta senza anima. Ben più alta è stata lacritica di Luciano Bianciardi a una città emblema di un nuovo si-stema. Troviamo dei passi nella letteratura bianciardiana anchemolto piatti e diretti, ma crediamo siano in minoranza. Per esempioin questa lettera in cui dice a un amico: “I milanesi, credimi, sonocoglioni come poca gente al mondo. La gente qui è allineata, co-perta e bacchettata dal capitale nordico, e cammina sulla rotaia, in-quadrata e rigida e non se ne lamentano, anzi credono di esserecontenti”. Ben più alti, ironici, premonitori e tutto sommato “aperti”sono i tanti scritti di questo grande Maestro su quel mondo che lorespingeva ma che cediamo in fondo lo attraeva fino a consumarloanche fisicamente. Basti pensare alla descrizione del bottegone; chicome noi lesse quelle pagine in prima gioventù se le è portate den-tro per tutta la vita. Ancora ci è difficile nella nostra “quotidianitàscandita a settimane” non ricordarcene quando ci rechiamo a farela spesa negli Iper che dell’antesignano bottegone rappresentano losviluppo estremo fino a quasi diventarne l’antitesi. In questi qua-rant’anni i supermercati hanno quasi doppiato loro stessi in un in-credibile salto mortale… Oggi è forse più umano avere civilmentea che fare con una cassiera in un centro commerciale che essereserviti dal panettiere “Non solo pizza” che hai sotto casa…
Ma pensare anche alla descrizione della Milano frettolosa deitram e delle segretarie perfette che parlano con le vocali aperte eche coltivano il loro microscopico potere leccando francobolli. Finoaddirittura alle analisi argute del linguaggio parlato in un genialescritto da Rapallo per L’ Europeo del ’66. Bianciardi se ne esce condelle sottilissime intuizioni semantiche, là dove ad esempio fa ilverso ai milanesi che dicono paletò invece di cappotto, o aver pre-mura col significato di non aver tempo ma con la sottile inconsciatemuta presenza di qualcuno che preme alle spalle. La vita? il suc-cesso? i soldi?, ci chiediamo noi. Una città – dice – dove il bigliet-taio invita a portarsi avanti perché chi sale preme. “Ma tutta quantala città premeva: dentro gli uffici, all’ingresso del cinema, dentro iristoranti, anche l’aria premeva, era tesa, vibrante, un poco febbri-citante, come certe influenzette di mezza stagione che smuovono il
LA LEZIONE DI BIANCIARDI
188
sangue e non danno tregua, e tu ti senti stanco senza aver mosso pa-glia.” Milano per Bianciardi non sopporta le cose piccole. “Chiediun etto di formaggio e te ne danno due. Lascio? Ma senz’altro, cimancherebbe…”. E ancora, quando nello stesso articolo descrive ledifferenze tra Milano e la sua Maremma, là dove i toscani coltiva-vano ancora i culto dei morti mentre a Milano i funerali “erano piùo meno dei rapidi traslochi dall’abitazione dell’estinto all’estremadimora”. A Milano bisogna star bene, esser in forma: “Come va? Titrovo bene.” Ottimismo obbligato. Bisogna essere sani per poter la-vorare e “Buon lavoro” è la migliore forma di saluto.
Ci rendiamo conto che le citazioni, per quanto possano essere go-dibili perché riportano alla consapevolezza delle sensibilità conta-giose di questo grande scrittore, sono però poca cosa, anche riduttivee fuorvianti, soprattutto rispetto a ciò che intendiamo trasmetterecon questo intervento. E cioè che il pagnottante Luciano Bianciardi,così autoesclusosi da Milano da divenirne uno dei simboli, fa parteintegrante e profonda della storia della nostra città. Il suo contributocritico non ha limitato il ruolo primario anche culturale che Milanodetiene nel paese, ma anzi ne ha arricchito la crescita. Può sembrareun controsenso ma questa grande metropoli provinciale, piena dicontraddizioni e di paura di guardarsi dentro, anche grazie a grandisuoi “forzati abitatori” come Luciano Bianciardi può sforzarsi oggicon maggior lucidità nel cercare se stessa e finalmente darsi un’iden-tità. Si tratta naturalmente di un’ identità sempre in movimento,come è d’obbligo per ogni coacervo di culture.
Occorre che Milano abbia finalmente il coraggio di prendere erestituire con maggior consapevolezza, cosa che ha fatto spessomale e balbettando, ciò che la sua variegata popolazione le offre.Milano ha l’obbligo di distribuire ai propri cittadini, ma anche almondo, non solo brand, immagini sofisticate, aritmetiche, borsi-stiche, luoghi comuni calcistici o vinciani, ma prima di tutto ladignità di una grande cultura consapevole del proprio essere com-posita. Ci piacerebbe pensare che Bianciardi una volta tanto sisbagliasse quando scriveva che: “ A Milano, ogni 100 anni, per 5giornate si fa una rivoluzione. Poi la mettono al museo.“
Gino&Michele
TAVOLA ROTONDA
189
Luciano Bianciardi e noi.
Se rileggo ancora una volta La Vita Agra resto ammirato dallabellezza della scrittura e magari mi domando: ma dove avrà impa-rato Bianciardi a scrivere così bene, con tanta eleganza e originalità?Ogni frase è pensata, elaborata magari inconsciamente, e fa trape-lare echi di letture, citazioni palesi o mascherate. Insomma Bian-ciardi aveva un gusto letterario e una bravura stilistica straordinarie.Ma allora queste qualità erano diffuse in Italia. Era il 1962, altritempi.
Lo scrittore grossetano lo comprendiamo forse meglio oggi diallora. È così vivo, così privo di difetti e di ovvietà ma dubito chepossa essere un modello da imitare. Egli possedeva una mente euno sguardo così spontaneamente critici e disincantati nei con-fronti della realtà, una qualità che oggi è andata perduta. Che laletteratura possa trasformare la società, la vita, è un’illusione cheormai non seduce più gli scrittori.
Egli era per costituzione uno scrittore “contro”, con un fortissimointeresse per la Realtà senza tuttavia essere neorealista, il suo spiritocritico era naturale e innato così come la sua passione civile. E ilclima che si respirava allora spingeva a questo. E infatti non era solo,si pensi ai suoi coetanei Calvino, Cassola, Volponi, Pasolini. I suoi treromanzi – Il lavoro culturale, L’integrazione, La vita agra- sono in-comprensibili al di fuori della circolazione di idee, delle rivendica-zioni sociali, della fiducia nel ruolo rivoluzionario dello scrittore, tuttecose che in quegli anni fortunati per la letteratura erano merce cor-rente. Oggi sappiamo che quelle condizioni non esistono più.
Eppure egli è tra i pochi scrittori degli anni sessanta che conti-nuano ad essere letti e amati dai giovani, forse perché essi sen-tono che Bianciardi aveva qualcosa di essenziale nel suopatrimonio di scrittore che oggi ci manca…
La sua scrittura riusciva a rendere vivide e brillanti le cose cheraccontava, anche se si trattava di articoli di giornale. Anzi eglicome giornalista fu perfetto, a cominciare dalle prime collabora-zioni a La Gazzetta di Livorno nei primi anni cinquanta.
LA LEZIONE DI BIANCIARDI
190
Del resto anche storicamente fu uno scrittore significativo, de-nunciò il consumismo prima di Pasolini così come la Mutazioneantropologica avvenuta nella società italiana.
Ma al di sopra dello stile egli aveva un compito che voleva per-seguire, e lo fece con coerenza. Veramente, come scrisse all’amicoTerrosi, La vita agra era stata scritta come “la storia di una so-lenne incazzatura”. Visse in prima persona il trauma dell’indu-strializzazione improvvisa e caotica degli anni cinquanta esessanta, registrò il risvolto negativo del boom economico, lo sra-dicamento di milioni di contadini divenuti da un giorno all’altrooperai di fabbrica, e con ciò la perdita di tradizioni e di riti co-munitari che esistevano da secoli. E nel quadro catastrofico e di-sfattista che fa della Milano del boom c’era forse –mascheratasotto l’ironia ed il sarcasmo- anche l’eco di antiche utopie palin-genetiche, insieme all’influenza del radicalismo degli scrittori be-atnick americani. Insomma egli non condivideva né l’ottimismodegli apologeti del capitalismo né la fiducia marxista nel ruolo ri-voluzionario del lavoro operaio e della vita di fabbrica.
Col passare del tempo la sua figura si impone sempre più. Bian-ciardi è diventato un modello da seguire anche se a me la sua le-zione sembra unica, inimitabile.
Gli va riconosciuto il merito di essere stato coerente nel perse-guire soprattutto nei Tre libri un suo discorso sulla società e sul-l’alienazione prodotta dall’industria e dall’industria culturale, adanno dei valori e degli stili di vita della provincia.
Partì dal dolore provato per i 43 morti della strage di Ribolla,e cercò di far capire a tutti le ragioni economiche di quella strageannunziata di proletari delle miniere la cui sorte ormai sembravanon interessare più nessuno. E volle gridare il proprio dolore, loschifo per una società che se ne fregava delle vite umane e mi-rava solo al profitto. Tali gli sembrano nei suoi libri i milanesi cheha conosciuto: incarogniti, egoisti, infelici, privi di spirito di so-lidarietà e di amore per i ceti socialmente più deboli.
La sua opera è una delle manifestazioni più forti dei danni edei disastri prodotti dal neocapitalismo, il rovescio della meda-glia dell’euforia e dell’ottimismo che avevano accompagnato nelnostro paese l’esplosione del decollo industriale.
LA LEZIONE DI BIANCIARDI
192
IL MIRACOLO BALORDO
Ho conosciuto la vita agra di Bianciardi da adolescente, attra-verso la lampada magica del film di Lizzani interpretato dall’at-tore agrodolce per eccellenza Ugo Tognazzi. La lettura del libro(di cui il film costituiva un, pur felice, tradimento; ma questo al-lora non potevo saperlo) venne dopo, verso i miei vent’anni, ametà dei famigerati anni Ottanta. Cioè in quel momento storicoche, a mio modo di vedere, ha completato e sancito la mutazione,probabilmente irreversibile, dei caratteri sociali e culturali del no-stro paese; orientandoli verso quel modello edonistico, sfrenata-mente consumista e orgogliosamente arrivista, che ben sappiamo.
Immerso com’ero nel clima di quell’epoca, che ovviamente co-stituiva per me la globalità della mia (poca) esperienza, del libronon seppi cogliere altro che la prodigiosa qualità linguistica, inparticolare nel suo aspetto più beffardamente irrituale. Rispettoalle letture della mia giovinezza, beatissime ma orientate in sensomolto scolastico, Bianciardi scriveva in tutt’altro modo e in tut-t’altra lingua. Il suo italiano suonava alle mie orecchie deliziosa-mente, quasi scandalosamente colto e saporito, ma anchesorprendentemente accessibile, amico, inclusivo; perché privo diquella presunzione di magistero, di quell’intenzione normativa eprescrittiva, sulle lettere e sulla vita, che avvertivo in altri autorie che mi incuteva talvolta un senso di soggezione, di disagio o diatroce mia inadeguatezza.
Qui, pareva invece che l’autore, Bianciardi Luciano, si rivol-gesse direttamente a me e proprio a me, ignaro lettore. E non perspiegare o rifare il mondo daccapo; ma per raccontarmi la sua sto-ria, il suo modo irripetibile di guardare le cose. Senza la pretesadi dare lezioni magistrali, né a me né a nessun altro. Il meravi-glioso toscaneggiare della vita agra mi spalancava le porte di unacultura sterminata, che certo non possedevo allora (e neppureadesso, se è per questo); riuscendo però allo stesso tempo a farlascendere dalla cattedra, questa cultura, da ogni cattedra possibile;a spogliarla di ogni retorica più o meno trombonesca.
Persino nelle pagine iniziali del romanzo, dedicate a una dottadissertazione filologica che deve aver scoraggiato più di un lettore,
TAVOLA ROTONDA
193
trovai subito, più che uno sfoggio di erudizione, una sorta di irresi-stibile esercizio umoristico. Bianciardi parlava della “rotacizzazionedella dentale intervocalica”1 (suscitando in me, va pur detto, un at-timo di breve ma intenso sgomento); aggiungendo però, immedia-tamente dopo, quel “che grazie al cielo non è più un mistero pernessuno”2 capace di colmare ogni distanza con un abbraccio affet-tuoso, con un’assoluzione fraterna e sorridente di ogni mia pur cla-morosa ignoranza dei fatti. Insomma, per farla breve: l’eccezionalità,in senso letterale, del registro linguistico fu in buona sostanza tuttoquel che colsi in quella prima, giovanile lettura. Ma di tutto il resto,cioè dello spaccato sociale, del ritratto memorabile di un’Italia coltain un passaggio decisivo, della satira sul conformismo montante etrionfante, non me ne diedi per inteso, né tanto né poco.
Poi, passò molto tempo. I bimbi crebbero e le mamme (maanche i papà e persino chi scrive, a dire il vero) s’imbiancarono.L’Italia porse la chioma e tutto quanto il resto alle magnifiche sorti(e progressive) della modernizzazione ad ogni costo. Nacque la te-levisione commerciale e cominciò a svolgere, con l’efficienza chele deve essere senza dubbio riconosciuta, il suo alto ruolo di Min-culpop tecnologico, contendendo al Vaticano il ruolo di guida po-litica, morale e spirituale del paese (l’esito della tenzone è tuttoraincerto, e un’entente cordiale, più che possibile, probabile). Lefamose lucciolette pasoliniane (che già negli anni Settanta se lapassavano così così) scomparvero del tutto, e per di più lo fecero,alla lettera, sotto i miei occhi. Infatti, le magiche luci che avevanoaccompagnato le serate della mia infanzia, spiate da una finestraaffacciata sul limitar della campagna, furono rimpiazzate dai ri-flettori delle automobili di un moderno parcheggio. La costru-zione del quale parcheggio fu accolta con indubbio giubilo da tuttigli abitanti del quartiere. Effettivamente, da un certo punto di vistamacro-economico, le lucciole fin lì a cosa diavolo erano servite?A ben poco, se non a popolare i miei sogni di bambino (cosa dinessuna importanza, lo si capisce), o a rallegrar qualche coppiettaappartata nell’oscurità (presumibilmente già allegra per contosuo). Nulla di più. E quanto alla teoria dello sviluppo sostenibile(che in teoria aspirerebbe a conciliare, appunto, le sunnominatelucciole con le necessarie lanterne), quella era ancora di là da ve-nire. Morale della favola: ci tenemmo stretti il parcheggio e ri-
LA LEZIONE DI BIANCIARDI
194
nunciammo alle lucciole. Nulla di male. Il guaio è che con noi lofece l’Italia intera, e lo fece all’unisono, come si amava dire du-rante il Ventennio. Fu la prosecuzione, non so se con altri mezzi,della progressiva cementificazione e implacabile trasformazione,iniziata a metà degli anni Cinquanta, del paesaggio italico e deicervelli umani in esso contenuti. “Tutto scompare”, aveva scrittoin quegli anni Roberto Roversi, “e avanzano i palazzi. Case nonancora finite e già in rovina”.3
The rest is history. All’antica, diffusa povertà continuò a su-bentrare un crescente, pur se fortemente diseguale, benessere, chefinalmente permise alle classi popolari condizioni di vita più con-fortevoli e dignitose. Alle fortissime radicalizzazioni politiche cheavevano contrassegnato, nel bene e nel male, quasi tutta la storiadell’Italia post-risorgimentale subentrò progressivamente un’ideo-logia unica: quella del percorso individuale e dell’arrivismo con-formista. L’idea che ai bisogni individuali si possano dare rispostecollettive fu più o meno messa in soffitta, buona per essere rosic-chiata dai topi (topi che peraltro, a differenza delle lucciole, co-nobbero in quegli anni una forte crescita demografica nelle areemetropolitane, in quanto consumatori di avanzi divenuti nel frat-tempo sempre più ricchi e appetitosi. Il destino, come si vede, èspesso davvero cinico e baro, nemico delle lucciole e amico deiroditori). In poche parole: divenne largamente maggioritaria l’idea(parafrasando, alla rovescia, Don Milani) che il problema deglialtri non ci riguardi proprio per nulla.
Immerso in codesta immensità, come dicevo poc’anzi, il tempofuggì: anche per me (proprio come per voi) irreparabile. Gli anniOttanta, quelli della “Milano da bere” conobbero la loro fine e cisi incamminò con gli stivali delle sette leghe verso il famoso Due-mila. Il libro, La vita agra, lo ricomprai proprio poco prima dellafine del millennio (nel frattempo, la copia della mia prima letturaera infatti andata dispersa in chissà quali lidi). Lo sistemai dili-gentemente nella mia biblioteca e se ne restò per qualche tempoal suo posto, silente, e agro, sugli scaffali.
Ora, bisogna sapere (si fa per dire, è una frase fatta) che io col-tivo un’insana teoria, che spesso suscita un imbarazzato sgomentonei miei interlocutori. Io sostengo che i libri, a restare per lungotempo nello stesso posto, mai letti o quantomeno (e questi sono i
TAVOLA ROTONDA
195
casi fortunati) non più riletti, si annoino mortalmente. E chequindi essi trovino, in capo a svariati tentativi, una misteriosa ma-niera di comunicare con i loro compagni di sventura. Soprattutto–è ovvio– con i volumi adiacenti.
Questo fatto (oltre a farmi talvolta dubitare della mia completasalute mentale) mi induce a scegliere con particolare cura il mioprivato ordinamento bibliotecario. In particolare, mi astengo dal-l’accostare autori di cui mi sia nota, o di cui io sospetti, la reci-proca idiosincrasia. Qualche esempio. Evitare, ove possibile,l’accostamento di una qualsiasi produzione di Edoardo Sangui-neti a un volume di Carlo Cassola; malgrado l’eccellente rapportopersonale che vi fu tra i due, vi assicuro che le discussioni lette-rarie (inudibili a noi esseri umani) sarebbero aspre, le posizioni in-conciliabili, il malcontento generale. Il volume di Cassola non lafinirebbe più di rinfacciare al nostro Sanguineti quella sua perfi-dissima boutade sulle Liale del ’63. Io li amo entrambi, e di dif-ferente amore, Cassola e Sanguineti; e proprio per questo li piazzoscrupolosamente a distanza di sicurezza. Non voglio risse, nel miolocale.
Allo stesso modo, mai accostare Bianciardi a un Bevilacqua(ammesso che dobbiate proprio possedere un libro di quest’ul-timo. Un regalo di Natale, forse?). Contrariamente a quel che sipotrebbe pensare, ho avuto grandi soddisfazioni, personalmente,dall’accostamento tra Montale e d’Annunzio (soprattutto l’Al-cyone, è chiaro). Se poi invece in casa avete un Baricco... ebbene,in questo caso il problema non è a chi accostarlo; il problema,come si diceva una volta, è a monte.
Torniamo però al punto. Il fatto è che la mia nuova vita agra,III Edizione Bompiani “I grandi tascabili”, ottobre 1998, finì ungiorno per ritrovarsi incastrata tra due volumi di storia contem-poranea italiana a me particolarmente cari: la Storia del miracoloitaliano, centrato sul lustro 1958-1963, e Il paese mancato, che necostituiva il séguito, ideale e cronologico; entrambi editi da Don-zelli e a opera di Guido Crainz. Mi parve da subito una scelta giu-diziosa e potenzialmente feconda. Il libro bianciardiano si ponevainfatti proprio allo snodo storico tra il cosiddetto “miracolo” equell’evoluzione successiva degli eventi della storia italiana, finoagli anni Ottanta, il cui risultato sarebbe stato appunto, nella fe-
LA LEZIONE DI BIANCIARDI
196
lice definizione di Crainz, un “paese mancato”. Cioè, in poche pa-role, un paese la cui forte evoluzione economica non si era ac-compagnata ad un’analoga crescita dello spirito civico e delrispetto del bene comune. In quell’ideale gioco del Monopoli cheè la storia, da sudditi (delle potenze straniere, del Re, del Duce, delVaticano), gli italiani si erano trasformati direttamente in consu-matori, saltando a pié pari la casella dei “cittadini” e smarrendoper strada gran parte della loro identità folclorica e popolare.
Da qui, prese le mosse la mia rilettura del testo bianciardiano,questa volta su presupposti completamente diversi: la vita agra -finalmente l’avevo capito anch’io - mi avrebbe fornito le paroleesatte per comprendere sia il mondo in cui ero nato, l’Italia del“miracolo”, sia quello in cui ero divenuto adulto, cioè quel “paesemancato” segnato dalla progressiva disumanizzazione dei rap-porti, dalla dimenticanza di sé e del proprio passato, e da troppeambizioni sbagliate. O, per dirla altrimenti, da quella sorta di “mu-tazione antropologica” così descritta da Pier Paolo Pasolini:
I “ceti medi” sono radicalmente – direi antropologicamente –cambiati: i loro valori positivi non sono più i valori sanfedisti e cle-ricali ma sono i valori [...] dell’ideologia edonistica del consumo edella conseguente tolleranza modernistica di tipo americano. È statolo stesso Potere (sic) – attraverso lo sviluppo della produzione dibeni superflui, l’imposizione della smania del consumo, la moda,l’informazione (soprattutto, in maniera imponente, la televisione) –a creare tali valori, gettando a mare cinicamente i valori tradizionalie la Chiesa stessa, che ne era il simbolo4.
Bianciardi raccontava splendidamente, certo in modo così di-verso da quello pasoliniano, il modo in cui erano maturati i pre-supposti di questa mutazione, di cui ero allo stesso tempo figlio,beneficiario, esponente, complice e vittima. Consentendomi dicapire meglio il tempo dell’oggi e tutto il contesto storico e socialedella mia vicenda personale, biografica. La vita agra divenne così,per molto tempo, il mio livre de chevet, o la mia Bibbia laica, percosì dire; e accompagnò in questo modo la genesi del mio testo,Un poeta in fabbrica, in cui mescolavo ad alcuni elementi auto-biografici una sorta di riflessione ad alta voce sull’ossessione del
TAVOLA ROTONDA
197
progresso, e sul più aggiornato (e operante) dei fanatismi: quelloche vuole crocifiggere le nostre vite e ogni nostra residua umanitàsul Golgota dello sviluppo economico; arderle sul rogo innalzatoal dio-lavoro; schiacciarle sotto il tallone di ferro del ciclo pro-duzione-consumo-riposo. Intimamente, nell’atto stesso della scrit-tura lo sapevo bene: il mio libro altro non era che un maldestrotentativo di pagare un debito che avevo contratto con Bianciardi,che aveva fornito a me, e credo a molti altri della mia generazione,le parole giuste per comprendere meglio i miei disagi, le mie in-certezze, le mie disillusioni; e per spostarli dal piano meramentebiografico-lamentevole-diaristico a quello del contesto storico esociale che li aveva prodotti. Un salto che non sarei mai stato ingrado di fare da solo.
È per questo, insomma, è per tutto questo che sono particolar-mente sensibile al piacere e all’onore che mi è stato fatto, quandosono stato invitato, con mia assoluta sorpresa, a partecipare al bian-ciardian convegno. Si trattava della conclusione ideale (anche per-ché del tutto inattesa) di una lunga marcia. Eh sì, perché anch’io,parafrasando Montale, insieme a Bianciardi avevo sceso almeno unmilione di scale; e grande è stata ed è ancora la mia sorpresa nelconstatare che, anche se ora lui non c’è più, non è il vuoto ad ac-compagnarmi, ad accompagnarci, ad ogni scalino. Forse è propriovero; i libri parlano tra loro, e qualche volta, caritatevolmente ven-gono in nostro soccorso. Almeno, così è stato per me.
Maurizio Puppo
1 Luciano Bianciardi, La vita agra, Milano, Rizzoli, 1998 (1a°ed. 1962),p. 166.2 Ibidem3 Roberto Roversi, Periferia, in “Officina”, 1956, 6.4 Pier Paolo Pasolini, Gli italiani non sono più quelli, in “Il Corrieredella Sera”, 10 giugno 1974, ora in Scritti corsari, Milano, Garzanti,2002, p.40.
LA LEZIONE DI BIANCIARDI
Finito di stampare ilm mese dida
BIANCIARDI, OTTOCENTO COME NOVECENTO
200
Indice