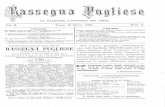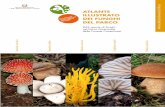Rassegna funghi tossigeni di interesse enologico
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Rassegna funghi tossigeni di interesse enologico
Il problema relativo alla presenza di micotossine nel vino è stato solleva-to per la prima volta nel 1996, allorché in seguito a un’indagine condottain Svizzera, fu segnalata una significativa concentrazione di ocratossina A(OTA) su diversi vini da tavola e succhi d’uva. Da allora, sono state con-dotte numerose ricerche miranti sia all’individuazione dei funghi respon-sabili di tali contaminazioni in campo e durante la lavorazione, sia allamessa a punto di metodi di analisi affidabili per la rilevazione della pre-senza di OTA e di altre micotossine nel vino e in diverse bevande fer-mentate. A parte l’OTA, le segnalazioni della presenza di altre micotossi-ne nel vino e nei succhi d’uva sono state fin’ora sporadiche, riconducibi-li essenzialmente alla patulina, alla citrinina e alla tricotecina. Di conse-guenza, il presente capitolo, è dedicato quasi essenzialmente alla tratta-zione del problema delle ocratossine e in particolare dell’OTA.
2.1 Ocratossina A
2.1.1 Aspetti tossicologiciIsolata per la prima volta in colture di Aspergillus ochraceus Wilhelm,l’OTA è stata successivamente individuata nel filtrato colturale di nume-rose specie di Aspergillus e Penicillium. L’OTA è ormai considerata uncomune contaminante in numerosi alimenti destinati al consumo umano eanimale. Oltre che nel vino, l’OTA è stata rinvenuta con una certa fre-quenza nei cereali, negli ortaggi, nella frutta secca, nelle carni, nel caffè(in particolare nel caffè istantaneo), nella birra e in numerose altre bevan-de comprese le tisane.
Numerosi casi di ocratossicosi sono stati descritti su animali monoga-strici (suini e pollame) alimentati con mangimi a base di cereali contami-nati, mentre la maggiore resistenza degli animali poligastrici (bovini e
I funghi tossigeniQuirico Migheli1,2, Salvatorica Serra2 e Lucia Maddau2
CAPITOLO 2
1 Centro interdisciplinare per lo sviluppo della ricerca biotecnologica e per lo studio dellabiodiversità della Sardegna e dell’area mediterranea; 2 Dipartimento di Protezione dellePiante, Università degli Studi di Sassari.
02_microb._vino 20-05-2005 10:11 Pagina 1
ovini) è legata al fatto che l’OTA viene inattivata dalla flora ruminale. Sitratta di patologie renali che comportano degenerazione dei tubuli prossi-mali seguita da fibrosi interstiziale e degenerazione glomerulale. La sinto-matologia è caratterizzata da maggior consumo di acqua, aumento delvolume urinario e uremia e il quadro anatomo-patologico da reni pallidi eipertrofici con evidente fibrosi corticale. Sull’uomo la presenza di con-centrazioni anomale di OTA nel cibo e nel sangue è stata associata a unamalattia nota come “nefropatia tubulo-interstiziale cronica dei Balcani”.Questa malattia endemica, segnalata circa 30 anni fa tra le popolazioni divillaggi isolati nei Balcani (Bulgaria e Croazia), si manifesta con lesionirenali e tumori a carico del tratto urinario superiore, beta-microglobulinu-ria e colorazione itterica del palmo della mano e della pianta del piede.Oltre ad avere effetti cancerogeni, l’OTA presenta proprietà immunode-pressive, teratogeniche e genotossiche quando somministrata ad animalidi laboratorio ed è stata pertanto inclusa dall’International Agency forResearch on Cancer (IARC) nel gruppo 2B dei composti potenzialmentecancerogeni per l’uomo.
Nel corso dell’ultimo decennio, le segnalazioni della presenza di OTAnell’uva, nei succhi d’uva, nei mosti e nel vino si sono susseguite concadenza sempre più allarmante, suscitando la consapevolezza che l’assun-zione di alimenti contaminati da OTA rappresenti un rischio da non sotto-valutare, in particolar modo per i consumatori di vini rossi, vini da desserte uva passa (Battilani et al., 2003).
2.1.2 Struttura chimicaDa un punto di vista chimico, l’ocratossina A, (R)-N-[5-cloro-3,4-diidro-8-idrossi-3-metil-1-oxo-1H-2-benzo-piran-7-yl)carbonil]-L-fenilalanina, èun pentachetide ciclico costituito da una di-idrocumarina legata a una feni-lalanina (fig. 2.1). Nella molecola sono presenti due gruppi funzionaliionizzabili, il gruppo carbossilico (–COOH) della fenilalanina e il gruppoidrossifenolico, che in condizioni fisiologiche possono esistere nella formadissociata e non, e conferiscono alla tossina deboli proprietà acide. Lacostante di dissociazione (pKa) del gruppo carbossilico è di 4,4 mentre peril gruppo –OH è di circa 7,5.
L’ocratossina A è una sostanza solida cristallina, incolore che emettefluorescenza blu sotto luce ultravioletta. Per idrolisi acida di OTA si forma
2 MICROBIOLOGIA DEL VINO ISBN 88-408-1329-2
Figura 2.1 Formula di struttura dell’ocratossina A (R = Cl)
02_microb._vino 20-05-2005 10:11 Pagina 2
fenilalanina e ocratossina α (fig. 2.2), un lattone acido otticamente attivo,non tossico. OTA è degradata da esterasi di origine microbica, con forma-zione degli stessi prodotti ottenuti per idrolisi acida.
2.1.3 Funghi produttori di ocratossina ANumerose specie fungine appartenenti ai generi Aspergillus e Penicilliumsono ritenute responsabili dell’accumulo di OTA nelle derrate alimentari.L’OTA deriva il proprio nome dalla specie A. ochraceus, dai cui filtrati col-turali è stata isolata per la prima volta, mentre nel genere Penicillium èsoprattutto P. verrucosum Dierckx a essere stato associato alla produzionedella micotossina. Quest’ultima specie produce OTA in climi freddi e tem-perati ed è stata segnalata quasi esclusivamente sui cereali e i loro deriva-ti, mentre A. ochraceus è più comune nel climi caldi e tropicali soprattut-to su alimenti conservati.
La correlazione tra la presenza di OTA negli alimenti, così come dialtre micotossine, e le specie fungine potenzialmente ocratossinogene daessi isolate è piuttosto difficile. Ciò a causa di problemi relativi alle moda-lità di campionamento e di caratterizzazione della micoflora presente inuna particolare derrata. Di solito il campionamento è casuale e prevede ilprelievo di una piccola quantità di materiale da una partita non di rado digrosse dimensioni. Ciò può comportare una sottostima dell’effettiva con-taminazione e l’incompletezza della composizione qualitativa della comu-nità microbica. Inoltre, la micotossina può essere stata prodotta anterior-mente all’epoca di campionamento e la specie produttrice non più rileva-bile. Infine, le capacità tossigene di una determinata specie microbica ven-gono saggiate in vitro su appositi substrati di coltura in condizioni spessocompletamente differenti da quanto avviene in natura sulla derrata conta-minata.
Così, P. verrucosum e A. ochraceus vengono isolati sporadicamente inmolti alimenti in cui l’accumulo di OTA risulta associato ad altre specie.È il caso dei cereali prodotti o conservati nelle aree interessate dalla cita-ta nefropatia endemica dei Balcani, frequentemente contaminati da isolati
ISBN 88-408-1321-7 FATTORI CHE CONTROLLANO LO SVILUPPO MICROBICO NEGLI ALIMENTI 3
Figura 2.2 Formula di struttura dell’ocratossina α
02_microb._vino 20-05-2005 10:11 Pagina 3
di P. aurantiogriseum Dierckx e P. griseofulvum Dierckx, o del caffè con-taminato da A. carbonarius (Bain.) Thom e A. niger van Tieghem, tutti iso-lati che hanno mostrato la capacità di produrre OTA. Oltre alle specie cita-te sono considerati potenziali produttori di OTA altre specie di Aspergilluse del suo teleomorfo Eurotium.
Per quanto riguarda il vino i dati pubblicati fanno ritenere che la con-taminazione avvenga sull’uva già in vigneto e che le specie imputate dellaproduzione di OTA siano Aspergillus della sezione Nigri e in particolareA. carbonarius e A. niger. Nonostante A. niger sia la specie più diffusa epiù numerosa, le percentuali di isolati produttori di OTA riportate in lette-ratura sono piuttosto basse, mentre sono decisamente superiori per A. car-bonarius. Anche A. ochraceus viene isolato da uva, ma sporadicamente ein quantità limitate. Perciò, nonostante la percentuale di ceppi ocratossi-nogeni sia spesso pari al 100%, la sua importanza su questa matrice è piut-tosto scarsa.
2.1.4 Aspetti epidemiologici dei funghi tossigeniI funghi dei generi Aspergillus e Penicillium sono ubiquitari e saprofiti,poco esigenti dal punto di vista nutrizionale: possono crescere in quasi tuttigli ambienti e in un ampio spettro di condizioni fisico-chimiche.Colonizzano una grande varietà di habitat, ma sono più comuni comesaprofiti nel terreno, nelle derrate e negli alimenti conservati e nei residuidi vegetazione. Esiste anche un numero ridotto di specie parassite su inset-ti, piante e animali, incluso l’uomo. Penicillium è uno dei patogeni piùdistruttivi sulla frutta, in grado di causare danni anche a temperature direfrigerazione. Entrambi i generi possono produrre, oltre a OTA, altre peri-colose micotossine.
Mentre è discutibile se sia economicamente più importante l’uno o l’al-tro genere, Penicillium è sicuramente il più vario in termini di numero dispecie e tipi di habitat colonizzati. Aspergillus manca del numero di spe-cie e della diversità del genere Penicillium, ma compensa con l’abilità dicrescere a temperature più elevate o in ambienti meno umidi. Inoltre, lespecie di Aspergillus crescono più rapidamente e producono spore più resi-stenti alla luce e alle sostanze chimiche. È corretto asserire che Aspergillusdomina nei tropici mentre Penicillium è più comune nelle zone temperate.
Il recente ritrovamento di OTA nel vino ha allarmato notevolmente ipaesi produttori. Se, infatti, la presenza di OTA in alimenti come cereali,cacao, caffè, e anche nella birra, può essere dovuta a proliferazioni ecces-sive dei contaminanti fungini indotte da inadeguate condizioni di stoccag-gio, sulle quali si può intervenire con relativa facilità, la contaminazioneriscontrata nei vini fa supporre che il problema insorga direttamente invigneto e richieda quindi un accurato accertamento delle fonti di contami-nazione e dei fattori che la favoriscono. Gli studi in proposito sono anco-ra in fase iniziale e le informazioni relative limitate. Per quanto riguarda lasituazione presente in Italia, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestaliha promosso da alcuni anni un progetto finalizzato dal titolo: “Studio dellecause che portano alla presenza di contaminanti micotici nelle uve e neivini”, i cui risultati, al momento, sono stati pubblicati solo in minima parte.
Aspergillus e Penicillium spp. si ritrovano piuttosto frequentemente sul-l’uva soprattutto durante la fase di maturazione, dall’invaiatura in avanti.
4 MICROBIOLOGIA DEL VINO ISBN 88-408-1329-2
02_microb._vino 20-05-2005 10:11 Pagina 4
Solitamente il loro ruolo è quello di saprofiti: la presenza di sintomi di mar-ciume sul grappolo è sporadica e raramente segnalata. Tali marciumi fannoparte dei cosiddetti “marciumi secondari” e sono causati principalmenteda A. niger e A. aculeatus. È più probabile che si manifestino quando,durante gli stadi fenologici più avanzati di sviluppo, si verificano abbon-danti precipitazioni che determinano forti idratazioni della bacca e di con-seguenza l’insorgenza di lesioni.
In ogni caso, anche in assenza di sintomi visibili, le popolazioni diAspergillus della sezione Nigri sembrano predominare nei vigneti delleregioni con clima mediterraneo, caratterizzati da temperature elevate escarsa piovosità. In effetti, anche nei Paesi dell’Europa meridionale, lepopolazioni di Penicillium isolate da uva prevalgono nelle zone con climapiù continentale o atlantico, per esempio in Italia settentrionale e Portogallooccidentale, rispettivamente. Tuttavia, studi recenti hanno messo in evi-denza che anche in alcuni vigneti della Sardegna, regione a clima tipica-mente mediterraneo, le popolazioni predominanti sono quelle diPenicillium spp..
L’entità delle popolazioni dei generi Aspergillus e Penicillium apparecondizionata da diversi aspetti colturali e climatici non sempre facilmenteindividuabili. Uno di quelli presi in considerazione è lo stadio fenologico.Non sempre le popolazioni di questi funghi tendono ad aumentare con lamaturazione dell’uva, come ci si potrebbe aspettare. A volte le concentra-zioni maggiori si rilevano prima dell’epoca di vendemmia, il che lasciaintendere che il contenuto zuccherino degli acini abbia un’importanzasecondaria rispetto ad altri fattori. Da indagini condotte in Sardegna, i datiraccolti confermano che l’entità delle popolazioni dei due generi varia inmodo irregolare da un campionamento all’altro nello stesso vigneto.Inoltre, è emerso che l’entità delle popolazioni risulta inferiore sulle culti-var più precoci, probabilmente a causa della loro minore permanenza incampo, e che l’andamento climatico dell’annata sembra essere moltoimportante. Periodi estivo-autunnali freschi e piovosi preludono all’isola-mento di una minore quantità di individui. Ciò può avere diverse cause: uncerto dilavamento delle uve, e quindi dei conidi presenti su esse, ma ancheil maggiore sviluppo dei marciumi principali del grappolo e in particolaredel marciume acido. I lieviti agenti di quest’ultima alterazione sembrereb-bero avere un effetto inibente sullo sviluppo delle muffe. L’effetto del climaè apparso strettamente correlato con quello di altre caratteristiche agrono-miche e colturali dei vigneti (portinnesto, forma di allevamento, tipo d’ir-rigazione ecc.), ma si tratta di interazioni complesse, difficilmente quanti-ficabili.
Oltre alle caratteristiche agronomiche e colturali dei vigneti e all’anda-mento climatico dell’annata, risulta molto importante anche la presenza dialtre alterazioni sul grappolo. In particolare, è stato rilevato che la presen-za di danni da tignola incrementa notevolmente la popolazione di speciepotenzialmente ocratossinogene.
È ormai chiaro che l’OTA viene prodotta sulle bacche prima della rac-colta, anche in una fase precoce di maturazione. La correlazione tra la pre-senza di OTA in un determinato campione e la presenza nello stesso di iso-lati produttori della tossina appare chiara quando gli isolati ocratossinoge-ni sono numerosi. Non così quando la loro presenza è sporadica.
ISBN 88-408-1329-2 I FUNGHI TOSSIGENI 5
02_microb._vino 20-05-2005 10:11 Pagina 5
Nell’indagine condotta in Sardegna su 14 vigneti l’OTA è stata rilevatasolamente in due campioni di acini su 44 (770 e 140 ng/kg) e in uno di vinosu 11 (170 ng/L) ottenuti da alcuni dei vigneti monitorati. I campioni divino positivi non corrispondevano a quelli di acini e per entrambi non c’èstata correlazione con gli isolati ocratossinogeni, che peraltro rappresenta-vano solo lo 0,7%.
Con molta probabilità l’OTA riscontrata nei vini deriva in buona parteda quella prodotta sull’uva in vigneto. Non si può però escludere un ulte-riore incremento nel periodo in cui l’uva raccolta viene ammassata, tra-sportata in cantina e lasciata sui carri in attesa della pigiatura, ma ciò puòavvenire solo se le bacche sono già contaminate. Contaminazioni prove-nienti dai materiali utilizzati per la raccolta e la pigiatura avrebbero, vero-similmente, un’importanza limitata. In ogni caso, nel vino, l’OTA si formaprima della fermentazione alcolica. Un’indagine condotta nel 2000 su oltre400 campioni di vino e su oltre 450 segnalazioni disponibili in letteraturaha messo in evidenza come l’OTA sia rinvenuta molto più frequentemen-te nei vini rossi (54%) rispetto ai vini rosé (40%) e ai vini bianchi (25%).Anche la concentrazione di OTA è significativamente più elevata nei vinirossi (22-1153 ng/L) rispetto ai vini rosé (119 ng/L) o bianchi (12-108ng/L). Questa situazione può essere spiegata dalle differenze nel processodi vinificazione: è noto, infatti, che per la preparazione dei vini bianchil’uva viene immediatamente pressata, mentre per la preparazione dei vinirossi l’uva viene lasciata macerare per diversi giorni e durante questa fasesi ha il maggior sviluppo dei funghi tossigeni e quindi la massima produ-zione di micotossina. Un altro dato di interesse riguarda la minore percen-tuale di contaminazione da OTA nei vini provenienti dalle aree geografi-che più settentrionali rispetto a quelli provenienti dalle aree mediterranee(per i vini rossi, per esempio, il 12% e il 95%, rispettivamente). In taliambienti le condizioni climatiche sono molto più favorevoli allo sviluppodelle specie ocratossinogene e in particolare alle specie di Aspergillus dellasezione Nigri. Uno studio riguardante 56 campioni di vini italiani (38 rossi,8 rosé, 9 bianchi e 1 vino da dessert) ha messo in evidenza elevate conta-minazioni da OTA (variabili da 10 a 7600 ng/L), con una maggior inci-denza nei vini rossi. L’OTA è stata, inoltre, rinvenuta in una cospicua per-centuale di vini rossi (14 campioni su 96, con concentrazioni fino a 3200ng/L) e di vini bianchi da dessert (6 campioni su 15, con concentrazionifino a 3800 ng/L) prodotti in alcune regioni meridionali italiane. La situa-zione messa in luce in Spagna non appare certo più rassicurante: la gran-de maggioranza dei campioni di vino analizzati conteneva elevate concen-trazioni di OTA (92, 91 e 65% dei vini rossi, rosé e bianchi, con concen-trazioni medie pari a 54, 31 e 20 ng/L; 74, 83 e 94% dei campioni di sherry,vino frizzante e vino da dessert, con concentrazioni medie di 40, 12 e 1000ng/L). Altre contaminazioni sono state segnalate in vini provenienti dadiverse regioni mediterranee: un caso eclatante riguarda 30 campioni divino del Marocco, per i quali è stato evidenziato nel 2001 che tutti eranocontaminati da OTA, con concentrazioni fino a 3200 ng/L!
2.1.5 Metodi di identificazione tradizionaliI generi Aspergillus e Penicillium sono funghi mitosporici appartenenti allaclasse Hyphomycetes famiglia Mucedinaceae con corrispondenti sessuati
6 MICROBIOLOGIA DEL VINO ISBN 88-408-1329-2
02_microb._vino 20-05-2005 10:11 Pagina 6
nella divisione Ascomycota ordine Eurotiales famiglia Trichocomaceae. Idue generi si distinguono facilmente all’osservazione microscopica, men-tre più difficile è l’identificazione delle specie all’interno di ciascuno diessi. I metodi classici per l’identificazione delle specie di Aspergillus ePenicillium passano attraverso l’esame di vari aspetti morfologici. Gli iso-lati vengono coltivati su substrati particolari per periodi di tempo stabiliti(tab. 2.1) ed esaminati macroscopicamente, per le dimensioni e il coloredella colonia, e microscopicamente, per le caratteristiche del conidioforo,dei conidi ed eventualmente di altre strutture. Le indicazioni fornite in que-sto paragrafo sono tratte dal manuale di Pitt e Hocking (1999).
2.2.5.1Genere AspergillusTale genere è caratterizzato da un conidioforo (fig. 2.3) provvisto di unostelo piuttosto grosso e lungo, con l’apice allargato a formare una vesci-cola solitamente sferica, ma allungata in alcune specie. Sulla vescicola, perl’intera superficie o in parte, sono inserite le cellule conidiogene, le fiali-di, disposte a palizzata (specie uniseriate). In alcuni casi tra la vescicola ele fialidi è inserita un’altra serie di cellule, le metule (specie biseriate). Siale metule che le fialidi si formano simultaneamente. I conidi sono unicel-lulari e portati in catenelle. Nel complesso il conidioforo ricorda un asper-sorio, in latino aspergillum, da cui deriva il nome del genere.
Alcune specie si riproducono sessualmente. I teleomorfi, caratterizzatida aschi disposti in modo disordinato entro cleistoteci (ascocarpi privi di
ISBN 88-408-1329-2 I FUNGHI TOSSIGENI 7
Figura 2.3 Conidioforo di Aspergillus: monoseriato (a sinistra) e biseriato (adestra).
02_microb._vino 20-05-2005 10:11 Pagina 7
8 MICROBIOLOGIA DEL VINO ISBN 88-408-1329-2
Tab
ella
2.1
Con
fron
to d
ei m
etod
i di a
nalis
i pub
blic
ati p
er la
det
erm
inaz
ione
di O
TA n
el v
ino
Rif
erim
ento
bib
liogr
afic
oSo
lven
te
Cle
an u
pSe
para
zion
eFa
se m
obile
Col
onna
LO
DT
rR
ecup
eri
di e
stra
zion
eR
ivel
azio
ne(µ
g/L
)(m
in.)
%
Zim
mer
li e
Dic
k (1
996)
Clo
rofo
rmio
IAC
HPL
C/F
LM
etan
olo
/ Aci
do a
cetic
oSp
heri
sorb
OD
S10,
005
574
-91
glac
iale
9%
(18
:7 v
/v)
(250
mm
×4,
6 i.d
.; 5
µm)
Osp
ital e
t al
. (19
98)
Tolu
ene
SPE
Si
HPL
C/F
L(S
odio
ace
tato
4m
M :
RP
180,
0173
-90,
7A
cido
ace
tico;
19:
1)/ A
ceto
nitr
ile (
52 :
48)
Tate
o et
al.
(200
0)C
loro
form
io–
HPL
C/F
LA
ceto
nitr
ile /
Acq
ua/
RP
Am
mid
e C
160,
013
94-1
09A
cido
ace
tico
(33,
2: 6
6,0:
0,8
)(2
50 x
4,6
mm
; 5µm
)V
isco
nti e
t al
(199
9) .
–IA
CH
PLC
/FL
Ace
toni
trile
/ A
cqua
/R
PD
isco
very
C18
0,01
688
-103
Aci
do a
cetic
o (9
9:99
:2)
(150
mm
x 4
,6m
m i.
d.; 5
µm
)M
ajer
us e
t al
. (20
00)
Tolu
ene
SPE
C18
HPL
C/F
LA
ceto
nitr
ile /
Acq
ua /
Supe
rsph
er 1
00 R
P18
0,01
––
Aci
do a
cetic
o (4
5:54
:1)
Jorn
et e
t al
. (20
00)
–SP
E C
18H
PLC
/FL
(Sod
io a
ceta
to 4
mM
:Sp
heri
sorb
OD
S 2
RP
180,
05<
15
> 8
0A
cido
ace
tico;
19:
1) /
(250
mm
x 4
,6 i.
d. m
m)
Ace
toni
trile
(52
: 48
)O
ttene
der
et a
l. (2
000)
–IA
CH
PLC
/FL
Ace
toni
trile
/Acq
ua/
Supe
rsph
er 1
00 R
P0,
01–
86A
cido
ace
tico
(45:
54:1
)18
; 5 µ
mM
arka
ki e
t al
. (20
01)
Clo
rofo
rmio
IAC
HPL
C/F
LA
cqua
/ A
ceto
nitr
ile /
Lic
hros
pher
e0,
002
9,5
91,3
-96,
6A
cido
ace
tico
(500
+50
0+20
)10
0 R
PC
18So
leas
et
al. (
2001
)–
SPE
C18
HPL
C/D
AD
(H2O
– H
3PO
43
mM
, 0,0
2 %
) /
Nuc
leos
il C
180,
0519
,283
-94
(Ace
toni
trile
– H
3PO
4;
(250
mm
×4,
6 m
mi.d
.;3
mM
, 0,0
2%)
5µm
)el
uizi
one
a gr
adie
nte
Sole
as e
t al
. (20
01)
Dic
loro
met
ano
–G
C/M
S0,
169
-75
Der
ivat
izza
zion
e Z
ölln
er e
t al
. (20
02)
–SP
E C
18H
PLC
/MS-
MS
Met
anol
o / A
cqua
/C
hrom
olit
Spee
d0,
251,
2510
0,5
Aci
do a
cetic
o (6
8,5:
29:2
,.5 v
/v/v
)R
OD
RP
18D
all’
Ast
a et
al.
(200
4)–
–H
PLC
/FL
Ace
toni
trile
/ (N
H4C
l:NH
3,)
X T
erra
TM
C18
0,5
1893
-96
20 m
M, p
H 9
,8)
(15:
85 v
/v(2
50 m
m x
4,6
mm
, 5 µ
m)
Abb
revi
azio
ni:
LO
D =
lim
ite d
i ri
vela
zion
e; I
AC
= c
olon
na a
d im
mun
oaff
inità
; SP
E =
est
razi
one
in f
ase
solid
a; S
i =
gel
di
silic
e; C
18 =
oct
adec
il; H
PLC
= c
rom
atog
rafi
aliq
uida
ad
alte
pre
staz
ioni
; FL
= r
ivel
ator
e a
fluo
resc
enza
; DA
D =
riv
elat
ore
a se
rie
di d
ioid
i; D
ER
= d
eriv
atiz
zazi
one;
GC
= g
as c
rom
atog
rafi
a; M
S =
spe
ttrom
etri
a di
mas
sa;
Tr
= te
mpo
di r
itenz
ione
.
02_microb._vino 20-05-2005 10:11 Pagina 8
aperture), appartengono ad almeno 8 generi, di cui i più importanti sono:Emericella, Eurotium e Neosartorya.
Si conoscono 6 subgeneri ognuno dei quali racchiude diverse sezioni.La tassonomia corrente riconosce circa 150 specie di cui solo una trentinasono ben definite e prontamente riconoscibili. Accanto a queste specie,che si possono definire centrali, ruotano una serie di varianti, spesso con-siderate anch’esse specie ma talmente rare da essere ininfluenti nella mag-gior parte delle indagini.
Le più importanti specie produttrici di OTA appartengono al SubgenereCircumdati, Sezioni Circumdati e Nigri.
2.2.5.2 Sezione CircumdatiLe specie potenziali produttrici di OTA appartenenti a questa sezione sono:A. albertensis, A. alliaceus, A. auricomus, A. melleus, A. ochraceus, A.ostianus, A. petrakii, A. sclerotiorum e A. sulphureus. Solo A. ochraceus èstato ripetutamente isolato da numerose derrate alimentari di diversa pro-venienza geografica. Le altre sono state ritrovate sporadicamente e non dirado la loro capacità di produrre OTA è stata accertata solo in vitro senzaalcun riscontro in natura.
Le specie della sezione Circumdati hanno conidiofori biseriati convescicola generalmente sferica e steli lisci o rugosi; i conidi assumonocolorazione gialla, camoscio o ocra e hanno pareti lisce o lievemente rugo-se. Molte specie formano sclerozi di colore bianco, giallo, violetto o nero.
2.2.5.3 Sezione NigriLe specie potenziali produttrici di OTA appartenenti a questa sezione sonosolo due: A. carbonarius e A. niger.
Le specie della sezione Nigri hanno conidiofori monoseriati o biseriaticon vescicola sferica e steli a parete liscia; i conidi sono neri o quasi neri.
Gli isolati appartenenti a questo gruppo, nonostante presentino caratte-ristiche micromorfologiche diverse, vengono spesso indicati semplice-mente come A. niger a causa della pigmentazione nera assunta dalle colo-nie e del fatto che A. niger è effettivamente il più comune. In effetti, le dif-ferenze morfologiche che distinguono le specie di questa sezione sono avolte difficili da rilevare, considerando anche la naturale variabilità di cia-scuna di esse. Tra le specie biseriate A. niger si distingue agevolmente soloda A. carbonarius: entrambi hanno conidi rugosi che però nel secondohanno dimensioni notevolmente superiori (3,5-4,5 µm A. niger; 7-10 µmA. carbonarius).
La tassonomia del gruppo Nigri è molto controversa e nel corso degliultimi anni sono state avanzate numerose proposte di revisione basateanche su studi di tipo molecolare.
2.2.5.4 Genere PenicilliumTale genere è caratterizzato da un conidioforo costituito da uno stelo chesorregge le fialidi direttamente o attraverso una serie di ramificazioni costi-tuite da metule e rami (fig. 2.4). In assenza di ramificazioni il conidioforoè detto monoverticillato; se tra fialidi e stelo sono presenti le metule è dettobiverticillato; se tra metule e stelo son presenti i rami è detto terverticilla-to. In alcune specie si possono trovare conidiofori con i ramuli, compresi
ISBN 88-408-1329-2 I FUNGHI TOSSIGENI 9
02_microb._vino 20-05-2005 10:11 Pagina 9
tra metule e rami, a formare quattro verticilli. Il numero di verticilli delconidioforo definisce il subgenere. La produzione delle fialidi non è simul-tanea. I conidi sono unicellulari e portati in catenelle. Nel complesso ilconidioforo ricorda un pennello, in latino penicillium, da cui deriva il nomedel genere.
Alcune specie di Penicillium sono collegate ad ascomiceti dei generiEupenicillium e Talaromyces Il primo produce aschi in cleistoteci, il secon-do all’interno di ife strettamente intrecciate (gimnoteci).
La classificazione delle specie di Penicillium non è facile per i pocoesperti, soprattutto se paragonata a quella di Aspergillus. La spiegazionedi ciò può essere dovuta non solo al maggior numero di specie (oltre 250,forse 300) ma anche al fatto che le caratteristiche prese in considerazionenon sono sempre così distintive o facilmente individuabili. Per esempio, ilcolore dei conidi nella maggior parte dei casi è verde e le distinzioni sibasano sulle varie tonalità che può assumere questo colore. Inoltre, a causadella grande variabilità insita nel genere – secondo alcuni autori si posso-no catalogare almeno 1000 fenotipi – solo il 70-80% degli isolati sonoprontamente identificabili.
Le specie considerate importanti produttrici di OTA appartengono alsubgenere Penicillium.
2.2.5.5 Subgenere PenicilliumLe specie ocratossinogene, oltre a P. verrucosum che è la più importante,
10 MICROBIOLOGIA DEL VINO ISBN 88-408-1329-2
Figura 3.4 Conidioforo di Penicillium: monoverticillato (a sinistra), biverticillato (alcentro), terverticillato (a destra).
02_microb._vino 20-05-2005 10:11 Pagina 10
sono P. aurantiogriseum, P. commune, P. crysogenum, P. griseofulvum e P.expansum.
In questo subgenere sono comprese specie terverticillate, anche se inalcuni casi vengono prodotti conidiofori bi- o quaterverticillati. Esso è con-siderato il subgenere più complesso e il più difficile da un punto di vistatassonomico. Infatti, è il più ricco di specie e le differenze tra esse sonolievi. Alcune sono indubbiamente correlate (per es. P. aurantiogriseum eP. commune) e si possono incontrare isolati con caratteristiche intermedie.Per semplificare in parte il lavoro del classificatore viene utilizzato un ulte-riore substrato, Neutral Creatine Sucrose Agar (CSN), che consente didistinguere le specie che utilizzano prevalentemente sostanze proteiche daquelle che utilizzano carboidrati.
Per migliorare e facilitare la classificazione delle specie di Penicillium,sono stati considerati anche altri tipi di approccio: produzione di metabo-liti secondari e profilo elettroforetico di isoenzimi, ma con risultati alterni.
Da quanto detto appare chiaro che l’identificazione delle specie ocra-tossinogene con i metodi tradizionali comporta difficoltà, spesso di unacerta rilevanza per i non tassonomi. Perciò, è importante poter svilupparesistemi diagnostici in grado di rilevare con precisione e sensibilità la pre-senza di tali specie negli alimenti contaminati. A questo proposito, i meto-di molecolari sono quelli che possono offrire maggiori garanzie.
2.1.6 Metodi diagnostici molecolariPrima di affrontare gli aspetti più applicativi della diagnostica molecolare,è opportuno discutere brevemente come i dati di sequenza di particolariregioni genomiche dei funghi tossigeni abbiano permesso di far luce sualcuni aspetti controversi della loro filogenesi. Come per molti altri grup-pi di organismi, la maggior parte delle sequenze di DNA impiegate a finitassonomici deriva dall’operone nucleare che codifica l’RNA ribosomiale(rRNA). In questa regione, il DNA codificante le subunità 18S e 5.8S neglieucarioti è troppo conservato per poter essere preso in considerazione perscopi tassonomici o diagnostici. Pur essendo dotato di maggior variabilità,anche il dominio codificante la subunità maggiore (26 o 28S) ha un livel-lo di conservazione ancora troppo elevato. Al contrario, alcune porzionidella regione ITS (Internal Transcribed Spacer) dei geni del rRNA nuclea-re presentano una variabilità tale da renderle particolarmente utili neglistudi filogenetici. Inoltre, il fatto che gli ITS si trovino in copia multiplanel genoma (identicamente ripetuti in tandem, con 60-200 copie per geno-ma aploide) fa di questa regione un bersaglio ideale per sistemi di diagno-si molecolare e elevata sensibilità.
In una recente rassegna sulla tassonomia della famiglia Trichoco-maceae, sono state enumerate ben 184 specie del genere Aspergillus e 225specie del genere Penicillium. Gli studi tassonomici classici, basati sullamorfologia e sulla fisiologia di Penicillium e Aspergillus, sono stati suf-fragati dall’analisi dei prodotti del metabolismo secondario (improntemetaboliche) e dei profili isoenzimatici. È stato così dimostrato che cia-scuna specie presenta un profilo metabolico caratteristico che ne rende pos-sibile l’identificazione. I dati di sequenza disponibili (per lo più relativi alleregioni ITS e alla subunità maggiore del rDNA) non sono particolarmen-
ISBN 88-408-1329-2 I FUNGHI TOSSIGENI 11
02_microb._vino 20-05-2005 10:11 Pagina 11
te informativi dal punto di vista filogenetico e non sempre concordano coni dati derivanti dalle impronte metaboliche. Al contrario, le sequenze digeni presenti in singola copia e ricchi di introni, come per esempio il geneBenA (codificante la β-tubulina) o i geni codificanti l’elongation factor 1-α o la calmodulina, hanno permesso di raggruppare gli isolati analizzati inmaniera conforme al concetto di specie basato sulla produzione di mico-tossine. Un’altra tecnica, l’analisi di restrizione delle sequenze di DNAmitocondriale (mtDNA), è stata utilizzata per studiare la variabilità intra-e interspecifica nel genere Aspergillus sezione Circumdati. In particolare,quasi tutti gli isolati di A. ochraceus analizzati sono compresi in due grup-pi ben distinti e nessuno degli isolati compresi nel secondo gruppo è ingrado di produrre OTA.
Tra i sistemi diagnostici molecolari, la reazione a catena della polime-rasi (PCR), con le sue molteplici applicazioni, è senz’altro la tecnica di ele-zione. I geni codificati dal rDNA e le regioni spaziatrici fra essi compreseforniscono un interessante bersaglio per lo sviluppo di primer specifici daimpiegare nella reazione di PCR. Per principio, qualsiasi organismo chepossieda rDNA ripetuti può essere specificamente identificato medianteprimer basati sulle regioni variabili degli spaziatori e si rimanda il lettorea una recente rassegna (Seifert e Lévesque, 2004) per le applicazioni nelcampo della diagnosi molecolare dei funghi tossigeni. Sulla base dellesequenze delle regioni ITS, un gruppo di ricerca spagnolo ha recentemen-te messo a punto una serie di primer specie-specifici utili per identificarele principali specie di Aspergillus appartenenti alla sezione Nigri: A. japo-nicus, A. heteromorphus, A. ellipticus, oltre alle due specie niger e tubi-gensis facenti parte dell’aggregato A. niger, che risultano indistinguibili dalpunto di vista morfologico (González-Salgado et al., 2005).
Oltre che le regioni variabili del rDNA, anche i geni presenti in singo-la copia, come i già citati BenA, EF1-α o la calmodulina, rappresentano unbuon bersaglio per la diagnosi mediante PCR. Recentemente, è stato svi-luppato un sistema di identificazione per A. carbonarius (una specie ocra-tossinogena) e A. japonicus (una specie considerata non produttrice diOTA) mediante PCR che adotta primer specie-specifici disegnati sulla basedella sequenza del gene della calmodulina.
Un approccio alternativo per la progettazione di primer specifici per ifunghi tossigeni consiste nell’utilizzare le sequenze dei geni responsabilidella biosintesi delle micotossine. Questa strategia, pur avendo l’indubbiovantaggio di scegliere come bersaglio proprio quelle sequenze che rendo-no i funghi pericolosi per l’uomo, presenta alcuni aspetti che ne limitanol’applicabilità da un punto di vista meramente diagnostico. Infatti, i genicodificanti gli enzimi che intervengono nel pathway biosintetico dellemicotossine sono di norma raggruppati in cluster di operoni molto grandi,caratteristici dei prodotti del metabolismo secondario. La sequenza di que-sti geni non sempre riflette la filogenesi della specie. Inoltre, isolati nontossigeni appartenenti a specie normalmente tossigene recano spesso copienon funzionali di geni-chiave per la sintesi delle micotossine, come evi-denziato nel caso di A. flavus (una specie produttrice di aflatossine). Percontro, geni del pathway biosintetico dell’OTA e dell’aflatossina sono statiriscontrati in specie non tossigene di Penicillium e di Aspergillus. È chia-ro che, in una tale situazione, risulta rischioso basare un sistema di diagnosi
12 MICROBIOLOGIA DEL VINO ISBN 88-408-1329-2
02_microb._vino 20-05-2005 10:11 Pagina 12
sulla mera presenza delle sequenze di geni del processo biosintetico dellemicotossine, vista la possibilità di riscontrare falsi positivi e amplificazio-ni aspecifiche. Per poter ovviare a questo rischio è stato proposto di basa-re la diagnosi non già sulla amplificazione diretta di sequenze di DNA,bensì sulla amplificazione dei prodotti di trascrizione dei geni tossigeni,utilizzando una tecnica nota con l’acronimo RT-PCR (ReverseTranscriptase PCR). Recentemente, tale tecnica ha permesso di distingue-re con precisione isolati aflatossigeni da isolati non produttori di aflatossi-na in A. flavus e in A. parasiticus. Mentre il pathway biosintetico dell’a-flatossina è quasi perfettamente noto, sia dal punto di vista biochimico chegenetico, nel caso di OTA sono ancora poche le informazioni relative allebasi genetiche della biosintesi. Uno studio condotto sulla specie ocratossi-nogena P. nordicum ha permesso l’isolamento di una serie di sequenze tra-scritte differenzialmente in condizioni inducenti la produzione di OTAmediante la tecnica detta DDRT-PCR (Differential Display ReverseTranscriptase-PCR). Molte di queste sequenze presentano omologia conenzimi potenzialmente coinvolti nella biosintesi dell’OTA, in particolareuna polichetide sintasi, una peptide sintetasi non ribosomiale, una aloge-nasi, una fenilalanina tRNA sintetasi, una metilasi e un frammento che pre-senta omologia con trasportatori ABC. Non appena, anche nel casodell’OTA, saranno stati caratterizzati i geni responsabili della biosintesi,sarà possibile applicare la stessa strategia già descritta per individuare concertezza gli isolati aflatossigeni di Aspergillus spp..
Nel caso in cui non si disponga di informazioni preliminari sul poli-morfismo genetico di un organismo, si possono impiegare con successo par-ticolari tecniche di amplificazione casuale, che permettono di evidenziarerapidamente le eventuali regioni polimorfiche degli acidi nucleici. La piùpopolare tra queste tecniche, nota con l’acronimo RAPD (RandomAmplified Polymorphic DNA), si basa sull’impiego di un solo primer, ingenere di 10 nucleotidi, in grado di amplificare casualmente in corrispon-denza di regioni omologhe nel DNA bersaglio. I prodotti di amplificazione,del tutto imprevedibili nel numero e nel peso molecolare ma, allo stessotempo, ottenibili con una certa ripetitività a parità di condizioni sperimen-tali, possono essere analizzati mediante elettroforesi su gel di agarosio.
Più recentemente, sono state sviluppate altre tecniche, come quella dettaAFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism), che hanno via viasostituito la RAPD, rivelandosi meno aleatorie e meno influenzabili dallecondizioni sperimentali. L’AFLP prevede tre passaggi: la digestione delDNA genomico mediante endonucleasi di restrizione; la ligazione di un“adattatore” a doppio filamento di DNA al rispettivo frammento di restri-zione, di modo che funga da innesco; l’amplificazione del frammento conprimer complementari all’adattatore ligato. Il primer include uno o duenucleotidi addizionali all’estremità 3′ studiati in modo di adattarsi allasequenza del DNA genomico lasciata libera dall’adattatore, al fine di gene-rare una sequenza specifica che corrisponda perfettamente all’adattatore eai nucleotidi adiacenti.
Qualunque sia la sequenza genica dalla quale si parte per la progetta-zione di primer specie-specifici o tossigenicità-specifici, è possibile impie-gare queste sonde molecolari in sistemi cosiddetti di “multiplex PCR” o“PCR multipla”. Questi sistemi non si prestano bene a un’analisi elet-
ISBN 88-408-1329-2 I FUNGHI TOSSIGENI 13
02_microb._vino 20-05-2005 10:11 Pagina 13
troforetica in quanto, all’aumentare delle bande amplificate, aumenta pro-porzionalmente il anche rischio di confondere bande con diversa specifi-cità ma peso molecolare molto simile. Se, però, i prodotti di amplificazio-ne vengono depositati su membrane e successivamente ibridizzati in seriecon sonde specifiche, è possibile identificare a posteriori quali isolati sonostati rilevati dal sistema di PCR. Chiaramente, questa tecnica risulta piut-tosto onerosa in termini di tempo, poiché l’identificazione di ciascun pato-geno richiede l’ibridizzazione con almeno una sonda patogeno-specifica.In alternativa, è possibile immobilizzare su una membrana o su un supportodi vetro le sonde specifiche (una o più per ciascun organismo da identifi-care) e poi far avvenire la reazione di ibridizzazione tra prodotto di PCRmultipla e le sonde in modo da poter individuare molte specie tossigene inuna sola reazione. Questa tecnica, nota nella versione su vetrino come“microarray”, permette di immobilizzare diverse migliaia di sonde sullostesso supporto, creando così dei “DNA chip” dotati di specificità modu-labile. Ad esempio, è stato sviluppato recentemente un microarray che per-mette il riconoscimento di 18 microrganismi impiegabili in attacchi bio-terroristici, tra cui anche alcuni funghi tossigeni, costituito da oltre 50.000sonde oligonucleotidiche immobilizzate su una superficie pari a quella diun vetrino portaoggetti. Un terzo possibile approccio diagnostico per poterrilevare contemporaneamente la presenza di più patogeni è rappresentatodai cosiddetti molecular beacons o sonde TaqMan®. Per “molecular bea-con” si intende una sonda oligonucleotidica con due sequenze comple-mentari, situate ai bordi della sequenza bersaglio-specifica, una molecoladi fluoroforo e una molecola “quencher” agli opposti termini. Quando lamolecola non è ibridata al suo bersaglio, adotta, in soluzione, una confor-mazione a forcina; in tale configurazione il fluoroforo e il quencher ven-gono a trovarsi appaiati, e quest’ultimo assorbe la radiazione del fluorofo-ro sotto forma di calore, altrimenti emessa come radiazione luminosa. Inquesto modo la sonda è incapace di emettere fluorescenza. Quando, inve-ce, la sonda incontra la molecola bersaglio, si forma un ibrido più stabiledella forcina, la cui rigidità e lunghezza precludono l’appaiamento dei ter-minali e il fluoroforo, non più appaiato al quencher, può emettere la radia-zione luminosa, che aumenta fino a 100 volte. Di recente, è stato brevet-tato un sistema basato sull’impiego di molecular beacons che permette l’in-dividuazione di oltre 40 specie fungine e batteriche presenti negli ambien-ti chiusi, tra cui un gruppo di specie affini a P. verrucosum, una specienota per la sua capacità di produrre OTA.
Un database contenente tutte le informazioni relative alle sequenze pri-mer pubblicate in letteratura e utilizzabili per la diagnosi molecolare di fun-ghi fitopatogeni, inclusi numerosi produttori di micotossine, è oggi dispo-nibile on-line sul sito: http://www.sppadbase.com/
Infine, sono stati recentemente sviluppati nuovi biosensori a DNA ditipo elettrochimico o piezoelettrico, in grado di evidenziare l’interazionetra sonde a DNA immobilizzate sulla superficie del sensore (rappresenta-to da un cristallo di quarzo rivestito di oro e sensibilizzato con streptavi-dina) e il DNA del microrganismo patogeno. Grazie a una collaborazionein atto tra le Università di Firenze e di Sassari, un biosensore di questotipo per l’individuazione di funghi tossigeni di interesse agroalimentare èattualmente in fase di messa a punto.
14 MICROBIOLOGIA DEL VINO ISBN 88-408-1329-2
02_microb._vino 20-05-2005 10:11 Pagina 14
2.1.7 Metodi di analisiLa disponibilità di metodi di analisi affidabili, accurati, sensibili e soprat-tutto approvati dagli organismi internazionali è di fondamentale importan-za per poter effettuare un confronto dei dati che provengono da laboratoridiversi, per acquisire informazioni veritiere sui livelli di contaminazione eper stabilire i livelli massimi ammissibili di OTA nel vino.
In generale, l’analisi delle micotossine in prodotti agroalimentari pre-vede una prima fase di estrazione della tossina dalla matrice con un oppor-tuno solvente, una seconda fase di purificazione dell’estratto (clean up) pereliminare gli interferenti dalla matrice e infine una terza fase di rivelazio-ne e determinazione quali-quantitativa mediante un’opportuna tecnica stru-mentale.
In particolare, l’estrazione di OTA da differenti matrici è condotta consolventi organici acidificati in quanto la tossina è presente, in ambienteneutro o alcalino, nella forma dissociata. Poiché circa il 99% di OTA è lega-to alle proteine, è necessario portare a 2,0 il pH della matrice per avere ilrilascio della tossina dalla forma coniugata.
La fase di clean up, indispensabile soprattutto quando si vogliano rag-giungere limiti di rivelazione molto bassi, può essere realizzata mediantela ripartizione liquido-liquido (LLP), condotta trattando l’estratto acquosoo organico con un solvente a esso immiscibile, o l’estrazione in fase soli-da (Solid Phase Extraction o SPE), che permette la contemporanea estra-zione e purificazione del campione dopo adsorbimento in colonna su pic-cole quantità di adsorbente. Nella SPE vengono utilizzate cartucce di fil-trazione Sepak o Bond-elut disponibili in commercio con vari tipi di adsor-benti.Una tipica procedura SPE prevede:
– condizionamento della colonnina;– applicazione del campione liquido in colonna;– lavaggio della colonnina per rimuovere gran parte degli interferenti; – eluizione dell’analita con un solvente organico;– ripresa dell’estratto secco con una piccola quantità di fase mobile.
Poiché l’estrazione in fase solida si basa su interazioni relativamente nonselettive, essa non sempre garantisce risultati soddisfacenti, soprattutto nelcaso di matrici molto complesse.
Negli ultimi anni eccellenti risultati sono stati raggiunti mediante la cro-matografia di immunoaffinità (IAC) che utilizza colonnine con anticorpispecifici, opportunamente immobilizzati a una fase solida, che sfruttano illegame selettivo della tossina all’anticorpo rimuovendo quasi completa-mente gli interferenti, anche nel caso di matrici molto complesse.L’impiego di queste colonnine, oltre a garantire ottime prestazioni in ter-mini di precisione e accuratezza, ha il vantaggio di ridurre notevolmentel’utilizzazione di solventi estremamente pericolosi (es.: clorurati), precau-zione fortemente auspicabile e necessaria per la tutela della salute deglioperatori e la salvaguardia dell’ambiente. Attualmente sono disponibili incommercio tre tipi di colonnine IAC: OCHRATEST (Vicam, USA),OCHRAPREP (Rhone-Diagnostic Technologies, UK) e RIDA OchratoxinA (R-Biopharm, Germania).
ISBN 88-408-1329-2 I FUNGHI TOSSIGENI 15
02_microb._vino 20-05-2005 10:11 Pagina 15
La tecnica analitica più frequentemente utilizzata per rivelare e quanti-ficare la presenza di OTA nelle derrate è la cromatografia liquida ad altaprestazione (HPLC), associata con il rivelatore fluorimetrico. La separa-zione cromatografica è di solito condotta in condizioni isocratiche concolonne in fase inversa RP C18 utilizzando una fase mobile acida.
Benché l’HPLC garantisca un elevata sensibilità e accuratezza, ha ancoroggi lo svantaggio di essere abbastanza costosa e di necessitare di perso-nale specializzato.
Per la conferma della tossina si ricorre alla spettrometria di massa oalla preparazione di derivati funzionali.
Per quantificare la presenza di OTA nei vini sono state proposte diver-se metodologie analitiche che si differenziano soprattutto per tecnica diestrazione, purificazione, concentrazione e rivelazione della tossina (tab.2.2). Si riportano qui di seguito alcune delle procedure analitiche fino aoggi suggerite per la determinazione di OTA nella matrice vino.
Zimmerli e Dick hanno proposto, a esempio, l’estrazione di OTA concloroformio da campioni di vino acidificati con H3PO4 e NaCl. L’estrattocosì ottenuto viene ripreso con un tampone fosfato (PBS) contenente il15% di metanolo e applicato a una colonna IAC, successivamente lavatacon acqua. L’OTA è successivamente eluita con metanolo e l’estratto, dopoallontanamento del solvente, è ripreso con 50 µL di eluente costituito da720 mL di metanolo e 280 mL d’acqua contenente il 9% di acido acetico.Dei 50 µL di soluzione così ottenuti, 20 µL sono utilizzati per l’analisiHPLC, mentre i rimanenti 30 µL sono impegati per ottenere il metilesteredell’OTA, al fine di confermare la presenza della micotossina. Il livelloinferiore di rintracciabilità (LOD) dell’OTA varia nel range tra 0,002 e 0,01
16 MICROBIOLOGIA DEL VINO ISBN 88-408-1329-2
Tabella 2.2 Elementi necessari per la classificazione di Aspergillus spp. e Penicilliumspp. (Pitt e Hocking, 1999).
SUBSTRATI, TEMPERATURE E TEMPI DI INCUBAZIONE
Temperatura Substrato Tempo
25 °C CYA (Czapek Yeast extract Agar) 7 ggMEA (Malt Extract Agar) 7 gg
G25N (25% Glycerol Nitrate Agar) 7 gg37 °C CYA 7 gg5 °C CYA 7 gg
ESAME MACROSCOPICO (a occhio nudo e con l’ausilio di uno stereomicroscopio)
Diametro delle colonie, formazione di microcolonie a 5 °C
Caratteristiche delle colonie: tessitura, densità di sporulazione, disposizionedelle catene di conidi, colore (da valutare alla luce naturale)
ESAME MICROSCOPICO (al microscopio ottico)
Conidioforo: struttura, dimensione di alcune sue parti (fialidi, metule, vesci-cole, stelo), tessitura dello stelo
Conidi: forma, dimensione e tessitura
02_microb._vino 20-05-2005 10:11 Pagina 16
µg/L. La metodologia proposta da Zimmerli e Dick è stata adottata, appor-tando alcune modifiche, da numerosi altri Autori.
Visconti e coll. hanno sviluppato un metodo che consente l’applicazio-ne diretta della matrice sulla colonna. Tale metodo prevede la diluizionedel campione in 10 mL di una soluzione di polietilenglicole (1%) eNaHCO3 (5%). La soluzione è filtrata mediante filtri di microfibra di vetroGF/A (Whatman) e purificata utilizzando le colonnine IAC che vengonoripetutamente lavate prima con una soluzione di NaCl (2,5%) e NaHCO3(0,5%) e successivamente con acqua distillata. OTA è eluita con 2 mL dimetanolo. Dopo evaporazione del solvente, l’estratto è risospeso in 250 µLdi eluente richiesto per l’analisi HPLC. Questa metodologia consente diindividuare livelli di 0,01 µg/L di micotossina. Il metodo è stato validatoper la determinazione di OTA nel vino rosso, vino bianco e birra median-te uno studio interlaboratorio che ha visto la partecipazione di 18 labora-tori europei e americani appartenenti a università e istituzioni pubblicheed è stato recentemente adottato dal Comitato Europeo di Standardiz-zazione come standard europeo, dall’AOAC e dall’OIV come metodo uffi-ciale (Visconti et al., 2001).
Zöllner e coll. hanno messo a punto una metodica che prevede l’utiliz-zazione di colonnine RP18 per l’estrazione in fase solida dell’OTA cheviene poi quantificata in HPLC-MASSA.
Le tecniche finora descritte sono state oggetto di uno studio compara-tivo effettuato da Leitner e coll. (2002) dal quale è emerso che esse si equi-valgono e possono essere usate indifferentemente per effettuare analisi con-frontabili a posteriori.
Ospital e coll. hanno ottenuto risultati soddisfacenti in termini di recu-pero e di sensibilità utilizzando per la purificazione dell’estratto le colon-nine di gel di silice SEP-pak. Tale metodo prevede l’estrazione del cam-pione con toluene e la determinazione in HPLC con rivelatore fluorime-trico.
Recentemente, Dall’Asta e coll. hanno proposto un metodo RP-HPLC-FLD rapido, molto sensibile e riproducibile che prevede l’iniezione diret-ta del campione di vino nel sistema cromatografico senza alcun passaggiodi estrazione e di clean up dei campioni. È stata usata una fase mobile alca-lina costituita da una miscela di NH4Cl (20 mM)-acetonitrile (85:15) a pH9,8. Questo metodo consente di raggiungere il valore di LOD di 0,05 µg/L,che è simile a quello ottenuto dalla purificazione con le colonnine a immu-noaffinità ed eluizione acida. Il metodo è stato validato statisticamente eapplicato direttamente all’analisi di una serie di vini.
Manca a tutt’oggi una metodica ufficiale universalmente accettata dagliorganismi internazionali, ma la disponibilità di metodiche affidabili e pres-soché equivalenti rende meno pressante la questione relativa alla defini-zione di un metodo unico di indagine. È tuttavia innegabile che la deter-minazione di OTA nei vini e nelle uve è piuttosto laboriosa e, nel caso diutilizzo delle colonnine a immunoaffinità, decisamente costosa.
2.1.8 ImmunosaggiBenché le classiche tecniche analitiche (TLC, HPLC, HPLC-MS, GC-MS)utilizzate per la determinazione delle micotossine garantiscano una note-vole sensibilità, specificità e riproducibilità, è particolarmente sentita la
ISBN 88-408-1329-2 I FUNGHI TOSSIGENI 17
02_microb._vino 20-05-2005 10:11 Pagina 17
necessità di disporre di metodi di analisi alternativi che consentano di arri-vare in tempi brevi a risultati attendibili. Ciò permetterebbe di attivare unafase di screening atta a velocizzare il processo di controllo. Tali metodi,infatti, presentano dei problemi in quanto:
– il campione deve essere sottoposto a un processo di purificazione;– è possibile analizzare un numero ridotto di campioni;– i costi di investimento iniziale e di analisi sono ancora rilevanti (su di
essi gravano: ammortamento e manutenzione degli strumenti, costodelle colonne e pre-colonne, costo dei reagenti per cromatografia, costodegli standard ecc.);
– le analisi devono essere effettuate da personale specializzato.
Inoltre, lo sviluppo di metodi più rapidi porterebbe vantaggi non solo dicarattere economico ma anche pratico, dal momento che non tutti i labo-ratori sono provvisti della strumentazione necessaria per effettuare le ana-lisi cromatografiche.
A tale scopo vengono utilizzati i saggi immunologici e immunoenzi-matici, con i quali sono oggi analizzabili le micotossine più importanti perdiffusione e tossicità. Nell’ambito degli immunosaggi, un notevole suc-cesso è stato riscosso dai test ELISA che offrono numerosi vantaggi quali:
– preparazione del campione ridotta alla semplice estrazione con limita-to uso di solventi organici;tempi di analisi ridotti,
– possibilità di saggiare decine di campioni contemporaneamente;investimento strumentale contenuto.
Queste tecniche, per quanto affascinanti e insostituibili quando si voglio-no raggiungere risultati in tempi brevi, sembrano comunque determinareuna sovrastima della micotossina.
Un metodo immunoenzimatico (RIDASCREEN®) è stato utilizzato daCerutti e coll. per l’analisi di OTA in 60 campioni di vino. A tale scopo lasuperficie dei pozzetti della piastra del Kit RIDASCREEN Ochratoxin A®
viene ricoperta con un anticorpo specifico dell’OTA. Addizionando l’en-zima coniugato etichettato Ochratoxin A alle soluzioni standard o ai cam-pioni previamente pipettati in ciascun pozzetto, si instaura una competi-zione fra OTA libera e enzima coniugato. Con la fase di lavaggio l’enzimaconiugato non legato viene rimosso. Si aggiungono, secondo le indicazio-ni del kit, il substrato e il cromogeno; in tali condizioni l’enzima coniuga-to converte il cromogeno incolore in un prodotto blu. Si pipetta il reagen-te di fine reazione e il colore da blu passa a giallo che si misura a 450 nm.L’assorbimento è inversamente proporzionale alla concentrazione di OTAdel campione.
Si segnala, infine, la recente messa a punto di un biosensore immuno-chimico che permette la rilevazione contemporanea di aflatossina B1, zea-ralenone, OTA e deossinivalenolo. Il biosensore sfrutta la possibilità di evi-denziare l’interazione fra proteine (in questo caso la micotossina e l’anti-corpo monoclonale specifico) mediante risonanza plasmonica di superfi-cie, misurando i cambiamenti di massa che avvengono sulla superficie del
18 MICROBIOLOGIA DEL VINO ISBN 88-408-1329-2
02_microb._vino 20-05-2005 10:11 Pagina 18
biosensore in funzione del legame tra molecole immobilizzate su di esso.Il limite di sensibilità per l’OTA, che può essere rilevata in 25 minuti, è di0,1 ng/g di campione.
2.1.9 Valutazione del rischio, prevenzione e lottaCome anzidetto, la OTA può essere considerata come una delle più peri-colose sostanze alimentari cancerogene per i suoi effetti a carico del siste-ma renale. Un’indagine preliminare della Commissione FAO/WHO per ilCodex Alimentarius, basata su dati provenienti da diversi Paesi dell’UnioneEuropea, suggerisce che il vino rosso sia la seconda fonte di esposizionedell’uomo all’OTA, dopo i cereali e prima del caffè e della birra. La suaelevata frequenza nei cibi e nelle bevande e la lunga emivita nel siero spie-gano il fatto che l’OTA sia una delle micotossine più frequentemente rin-venute nel sangue umano in numerosi studi condotti in Europa, Stati Unitie Canada. Nel 1994, la Commissione Europea ha istituito un gruppo dilavoro incaricato di raccogliere informazioni sulla esposizione giornalieradei consumatori europei all’OTA. L’apporto medio giornaliero, sulla basesia della frequenza dei campioni contaminati sia del consumo medio divino, è stato valutato in un primo tempo pari a 1,8 ng/kg di peso corporeo.In funzione delle ripetute segnalazioni di contaminazione da OTA nei vinie in altri alimenti, il WHO/FAO Joint Expert Committee on Food Additives(JEFCA) ha proposto di fissare in 100 ng/kg di peso corporeo la soglia tol-lerabile di apporto settimanale di tossina. Successivamente, il ComitatoScientifico sul Cibo (Scientific Committee on Food) della Unione Europeaha stimato che la soglia giornaliera tollerabile per i consumatori può varia-re, a seconda della metodologia adottata, da 1,2 a 14 ng/kg di peso corpo-reo. Occorre rilevare che il valore più elevato è stato determinato sulla basedella nefrotossicità. Cionondimeno, l’attenzione degli esperti è ora con-centrata sulla potenziale genotossicità della tossina e sui suoi possibilieffetti cancerogeni. Di conseguenza, il Comitato Scientifico sul Cibo hastabilito che sarebbe opportuna un’ulteriore riduzione della soglia tollera-bile di apporto giornaliero di OTA (5 ng/kg di peso corporeo), al fine digarantire una maggiore sicurezza alimentare ai consumatori (Anonimo,1998). Un nuovo gruppo di lavoro istituito dalla Commissione Europea conprovvedimento 1999/143/EC nell’ambito della già citata iniziativa SCOOP(Scientific Co-Operation on Questions Relating to Food) e coordinato daricercatori dell’Istituto Superiore della Sanità, ha recentemente elaboratoun nuovo documento riguardante il rischio connesso al consumo di ali-menti contaminati da OTA (SCOOP, 2002). Dall’esame di quasi 1500 cam-pioni di vino provenienti da 13 Paesi dell’Unione Europea risulta che il50% di essi è contaminato da OTA, in particolare i vini rossi e quelli dadessert. Per quanto riguarda l’esposizione dei consumatori, risulta che inItalia l’apporto medio giornaliero per i consumatori è pari a 1,13-3,52ng/kg di peso corporeo e che la principale fonte di contaminazione è il vino(0,86-2,94 ng/kg di peso corporeo). La soglia appare al di sotto di quellafissata dal Comitato Scientifico sul Cibo nel 1998, ma ciò non esclude cheparticolari categorie di consumatori possano risultare esposte, in alcuniPaesi, a concentrazioni di OTA al di sopra delle massime raccomandate.
L’OTA è in grado di contaminare numerose derrate alimentari che pre-sentano notevoli differenze per quanto concerne la loro composizione e che
ISBN 88-408-1329-2 I FUNGHI TOSSIGENI 19
02_microb._vino 20-05-2005 10:11 Pagina 19
vengono prodotte in regioni geografiche caratterizzate da profonde diffe-renze climatiche. La crescente frequenza con la quale viene riscontrata talecontaminazione ha reso necessario un intervento del legislatore a tuteladella salute del consumatore. A decorrere dal 5 aprile 2002 è entrato invigore il regolamento CE n. 472/2002 (pubblicato nella G.U.C.E.L. 75/18del 16 marzo 2002) che modifica il n. 466/2001 definendo i tenori massi-mi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari. Tra i contami-nanti presi in considerazione, di cui viene prudentemente richiesta unariduzione all’esposizione, ci sono le aflatossine e l’OTA. Tale regolamen-to elenca una serie di derrate quali cereali, chicchi di caffè, cacao e fruttasecca, vino, birra e succo d’uva nei quali l’OTA è stata riscontrata. Il legi-slatore ha stabilito le dosi ammissibili giornaliere in 3 µg/kg per tutti i pro-dotti derivati dai cereali, 5 µg/kg per i cereali non lavorati e 10 µg/kg peri frutti essiccati della vite (tab. 2.3). Per quanto riguarda i tenori massimidi OTA nella frutta secca, nel caffè crudo, torrefatto e nei prodotti deriva-ti, nella birra, nel vino e nel succo d’uva, nel cacao e nei prodotti derivati,la Commissione si è riservata di riesaminare le disposizioni del preceden-te Regolamento. A tutt’oggi, tali limiti non sono stati ancora resi noti. Peril vino si ipotizza, tuttavia, un valore di 2 µg/L.
20 MICROBIOLOGIA DEL VINO ISBN 88-408-1329-2
Tabella 2.3 Tenore massimo ammissibile relativo alla presenza di OTA in prodotti alimentari (regolamento CEn.472/2002 del 12/03/02).
Prodotto Tenore Metodo di Metodomassimo campionamento d’analisi di
ammissibile riferimento(µg/kg o ppb)
2.2. OCRATOSSINA A
2.2.1. Cereali (compreso riso egrano saraceno) e prodottia base di cereali)
2.2.1.1.Cereali non lavorati 5 Direttiva 2002/26/CE Direttiva(compreso riso non lavorato Della Commissione (*) 2002/26/CEe grano saraceno)
2.2.1.2.Tutti i prodotti derivati 3 Direttiva 2002/26/CE Direttivadai cereali (compresi i prodotti 2002/26/CElavorati a base di cerealied i cereali destinati alconsumo umano diretto)
2.2.2. Frutti essiccati della vite 10 Direttiva 2002/26/CE Direttiva(uva passa di Corinto, 2002/26/CEuva passa, uva sultanina)
2.2.3. Caffè crudo e torrefatto e —prodotti a base di caffè,vino, birra, succo d’uva,cacao, prodotti a basedi cacao e spezie
(*) GU L. 75 del 16/03/2002, pag. 38.
02_microb._vino 20-05-2005 10:11 Pagina 20
Un vero e proprio codice di comportamento per la prevenzione della con-taminazione da OTA nel vino non è ancora disponibile. Tuttavia, una seriedi indicazioni miranti ad assicurare la prevenzione o la riduzione della con-taminazione da OTA e altre micotossine nei cereali (Anonimo, 2003) è statarecentemente elaborata dal Codex Alimentarius (http://www.codexalimen-tarius.net), cui è stato attribuito il ruolo di organismo di riferimento a livel-lo internazionale. Un decreto ministeriale emanato nell’aprile 2000 dalMinistero delle Politiche Agricole e Forestali stabilisce le linee guida nellaproduzione vitivinicola per la prevenzione della potenziale contaminazio-ne da micotossine. Le raccomandazioni contenute in tale decreto si riferi-scono soprattutto a una corretta gestione della difesa nei confronti delleprincipali avversità della coltura verso le quali si deve attuare una prontae corretta prevenzione, avendo cura di attuare i trattamenti necessari neitempi e con le modalità previste da una razionale gestione del vigneto.Molto opportunamente si pone l’accento anche sulle pratiche agronomiche,che devono essere tali da evitare un carico eccessivo di produzione omet-tendo eccessive concimazioni, così come irrigazioni troppo frequenti e nonnecessarie. Ciò permette di contenere entro limiti accettabili lo sviluppovegetativo della vite, favorendo l’arieggiamento del grappolo, così da evi-tare il ristagno di umidità indispensabile per lo sviluppo dei funghi poten-ziali produttori di micotossine. Analogamente, si consiglia di eseguire leoperazioni di raccolta nel più breve tempo possibile e di eseguire tempe-stivamente la pigiatura con macchinari e in ambienti igienicamente con-trollati. La produzione di vini passiti viene consigliata solo se si riesce agarantire l’appassimento delle uve in locali con ridotta umidità relativa.
Il riferimento a una corretta difesa nei confronti delle principali avver-sità della coltura può essere interpretato in modo duplice. Data la elevatacapacità saprofitaria dei funghi tossigeni di interesse per il vino, è senz’al-tro consigliabile evitare le lesioni a carico degli acini durante tutta la fasedi maturazione. La lotta contro i fattori biotici e abiotici in grado di pro-vocare ferite (tignola e tignoletta, mal bianco, grandine, pioggia battente,gelate, vento), così come la cura nelle lavorazioni e nella raccolta, hannocertamente un effetto positivo nella prevenzione delle infezioni. D’altrocanto, la distribuzione in campo di prodotti fungicidi può avere effetti bene-fici sulla riduzione delle popolazioni di funghi tossigeni e, di conseguen-za, sulla eventuale contaminazione di micotossine nel prodotto finale.Recenti sperimentazioni hanno messo in evidenza come i trattamenti con-tro Botrytis cinerea Pers. possano avere un buon effetto collaterale controle specie di Aspergillus della sezione Nigri. In particolare si sono dimo-strati efficaci le anilinopirimidine e il fludioxonil, mentre ridotta è stata l’a-zione dei dicarbossimidici. Prove in vitro effettuate ad hoc hanno confer-mato questi risultati e hanno messo in evidenza la totale inefficacia o lascarsa attività di numerosi principi attivi antiperonosporici e antioidici.Tra gli antibotritici, oltre alle già citate anilinopirimidine, è risultato effi-cace anche il folpet. Tuttavia, è bene tener presente che l’esposizione a fat-tori di stress quali, appunto, i fungicidi, soprattutto se applicati in concen-trazioni non ottimali, può indurre nei funghi patogeni un incremento delmetabolismo secondario, inclusa la produzione di micotossine. Questofenomeno è stato messo in evidenza, per esempio, in Fusarium graminea-rum produttori di tricoteceni su cereali contaminati.
ISBN 88-408-1329-2 I FUNGHI TOSSIGENI 21
02_microb._vino 20-05-2005 10:11 Pagina 21
Ove possibile, è opportuno documentare gli eventuali attacchi in campo,le procedure di raccolta, trasporto e conservazione adottate a ogni ciclo pro-duttivo per poter valutare con precisione ogni cambiamento o deviazionerispetto ai protocolli standard. Tutte queste informazioni possono essereestremamente utili per poter comprendere le cause di eventuali contami-nazioni in un’annata particolare e per evitare di ripetere gli stessi errorinelle annate future.
Infine, si rende necessario individuare i punti critici per il controllo dellacontaminazione in base al noto protocollo di HACCP (Hazard AnalysisCritical Control Point). Purtroppo, queste fasi possono essere individuatecon maggiore sicurezza dopo la raccolta (FAO, 2001), mentre sono spes-so impossibili da identificare nelle fasi di produzione che, nel caso del vino,sono quelle più importanti ai fini della contaminazione.
Nell’ambito del V Programma Quadro dell’Unione Europea, è stato rea-lizzato recentemente un progetto dal titolo significativo: “WINE-OCHRARISK - Risk assessment and integrated ochratoxin A management in grapeand wine”, coordinato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore diPiacenza, a cui partecipano 12 gruppi appartenenti a 7 diversi Paesidell’Unione (www.ochra-wine.com), con l’obiettivo di mettere a punto unSistema di Supporto alle Decisioni (DSS) che consenta di organizzare tuttele informazioni disponibili e di guidare gli interventi colturali minimiz-zando il rischio di presenza di OTA nei grappoli. Il cuore del DSS è unmodello previsionale, in grado di prevedere il comportamento del fungo infunzione di tutte le variabili che lo possono influenzare. Una volta messoa punto, il modello dovrà essere validato e a tal fine sono stati individuatidei punti critici di controllo (CCP), rappresentati dalle fasi di inizio invaia-tura e di maturazione, nei quali è necessario valutare lo stato delle bacchee la presenza di funghi ocratossigeni (Battilani, 2003). Il progetto “WINE-OCHRA RISK” ha anche lo scopo di seguire il destino dell’OTA durantela vinificazione. Le fasi considerate sono la pigiatura, la macerazione, lafermentazione alcolica e la fermentazione malo-lattica. È stato così accer-tato che la pigiatura è l’operazione che determina il passaggio dell’OTAnel mosto per almeno l’80%, mentre la macerazione può contribuire per ilrestante 20% nella vinificazione in rosso. Il livello massimo di OTA si ha,quindi, nelle prime fasi di lavorazione delle uve e la micotossina vienesolubilizzata in tempi relativamente rapidi. Gli stadi successivi della lavo-razione, in particolare la fermentazione malo-lattica, portano a una ridu-zione del livello di OTA nei vini rossi. I batteri lattici sono in grado didiminuire la concentrazione della micotossina con cinetiche e con percen-tuali di degradazione differenti, che variano in funzione del ceppo e delcontenuto di OTA inizialmente presente nel mosto.
Tutti gli studi condotti negli ultimi anni sulla presenza di OTA nei vinie nelle uve e sulla valutazione dei rischi connessi alla sua assunzione attra-verso bevande e alimenti contaminati, sottolineano la necessità di armo-nizzare a livello internazionale le procedure di campionamento e i metodidi analisi, nonché l’importanza di razionalizzare la raccolta dei dettaglisulle procedure di manipolazione e di trasformazione degli alimenti arischio. Solo così si potrà realizzare una vera e propria mappatura del“rischio OTA”, mettendo cioè in relazione le procedure di raccolta e di
22 MICROBIOLOGIA DEL VINO ISBN 88-408-1329-2
02_microb._vino 20-05-2005 10:11 Pagina 22
lavorazione con i dati disponibili sull’esposizione di particolari categoriedi consumatori, possibilmente separati per tipo di alimento o per classi dietà.
2.2 Altre tossine
2.2.1 PatulinaLa patulina è uno tra i più comuni metaboliti fungini e può essere prodot-
ta da molte specie di Penicillium, Aspergillus e Byssochlamys.L’esposizione a questa micotossina può determinare casi di tossicità acutao cronica, con effetti mutagenici, cancerogenici e teratogenici. Tra le spe-cie di Penicillium più comuni sulla frutta si deve menzionare il P. expan-sum, piuttosto frequente anche sull’uva e in grado di produrre elevate con-centrazioni di patulina che possono contaminarne i succhi. Tuttavia, pocosi sa del destino di questa micotossina nei mosti destinati alla vinificazio-ne.
2.2.2 CitrininaLa citrinina è prodotta da almeno 14 specie diverse di Penicillium e da 3
specie di Aspergillus. Anche questa micotossina, come la OTA, ha effettideleteri sulla funzionalità renale, cui si aggiungono alterazioni a livellodei mitocondri. È importante sottolineare l’effetto sinergico di OTA e citri-nina quando siano presenti contemporaneamente come contaminanti. In unrecente studio, oltre 30 isolati di P. expansum ottenuti da uva sono stati ana-lizzati per la produzione di citrinina su diversi substrati colturali e tuttihanno dimostrato la capacità di produrre questa micotossina in vitro.
2.2.3 TricoteceniQuesto gruppo composito raccoglie numerose micotossine, prodottesoprattutto da funghi appartenenti al genere Fusarium, responsabili di gravitossicosi del bestiame alimentato con foraggi o mangimi contaminati. Ilfungo fitopatogeno Trichothecium roseum produce in vitro e in vivo i meta-boliti tossici tricotecina, tricotecolone e rosenonolactone. La tricotecina èuna micotossina citotossica ed è in grado di inibire la fermentazione alco-lica in quanto non viene metabolizzata dai lieviti. Oltre a essere tossica, latricotecina, ove sia presente in concentrazioni elevate (> 5 mg/L), può con-ferire al vino un sapore amaro.
2.3 Bibliografia essenziale
Anonimo (1998) «Opinion of the Scientific Committee on Food onOchratoxin A» (expressed on 17 September 1998), CS/CNTM/MYC14final, Annex II to Document XXIV, 2210/98, European Commission,Bruxelles (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scf/out14_en.html)
Anonimo (2003) «Code of practice for the prevention and reduction ofmycotoxin contamination in cereals, including annexes on ochratoxin A,zearalenone, fumonisins and trichothecenes», Codex AlimentariusCommission CAC/RCP 51-2003, pp. 1-8
ISBN 88-408-1329-2 I FUNGHI TOSSIGENI 23
02_microb._vino 20-05-2005 10:11 Pagina 23
Battilani, P., Giorni, P. e Pietri, A. (2003) «Epidemiology of toxin-produ-cing fungi and ochratoxin A occurrence in grape» European Journal ofPlant Pathology, 109, pp. 715-722
FAO (2001) FAO/IAEA training and reference center for food and pestici-de control. Manual on the application of the HACCP system in mycotoxinprevention and control. FAO Food and Nutrition Paper No. 73, Roma,2001
González-Salgado, A., Patiño, B., Vázquez, C. e González-Jaén, M.T.(2005) «Discrimination of Aspergillus niger and other Aspergillus speciesbelonging to section Nigri by PCR assays», FEMS Microbiology Letters,245, pp. 353-361
Leitner, A., Zöllner, P., Paolillo, A., Stroka, J., Papadopoulou-Bouraoui, A.,Jaborek, S., Anklam, E. e Lindner W. (2002) «Comparison of methods forthe determination of ochratoxin A in wine», Analytica Chimica Acta, 453,pp. 33-41
Pitt, J. I. e Hocking, A. D., Fungi and food spoilage, Aspen Publisher, Inc.,Gaithersburg, 1999
SCOOP - Scientific Co-Operation on Questions Relating to Food (2002)«Assessment of dietary intake of ochratoxin A by the population of EUmember states», European Commission, Directorate-General Health andConsumer Protection, 2002 (documento consultabile sul sito: http://euro-pa.eu.int/comm/food/fs/scoop/3.2.7_en.pdf)
Seifert, K. A. e Lévesque, C. A. (2004) «Phylogeny and molecular dia-gnosis of mycotoxigenic fungi», European Journal of Plant Pathology,110, pp. 449-471
Visconti, A., Pascale, M. e Centonze, G. (2001) «Determination of ochra-toxin A in wine and beer by immunoaffinity column cleanup and liquidchromatograpic analysis with fluorometric detection: collaborative study»,Journal of AOAC International, 84, pp. 1818-1827
24 MICROBIOLOGIA DEL VINO ISBN 88-408-1329-2
02_microb._vino 20-05-2005 10:11 Pagina 24