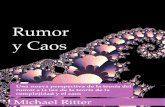Quando la primavera, tra le stagioni, è «la più crudele». Il caos nordafricano come “urgenza...
Transcript of Quando la primavera, tra le stagioni, è «la più crudele». Il caos nordafricano come “urgenza...
di Ciro Sbailò Professore associato di Diritto pubblico comparato
Università Kore di Enna
Quando la primavera, tra le stagioni, è «la più crudele». Il caos
nordafricano come “urgenza costituzionale”
E D I T O R I A L E – 2 S E T T E M B R E 2 0 1 5
2 federalismi.it |n. 16/2015
Quando la primavera, tra le stagioni, è «la più crudele». Il caos nordafricano
come “urgenza costituzionale”
di Ciro Sbailò
Professore associato di Diritto pubblico comparato Università Kore di Enna
1. Il fenomeno della “riespansione islamica” è destinato a interessare, con crescente intensità,
anche la comunità dei giuristi, dopo avere interessato, specialmente a partire dagli attentati dell’11
settembre 2001, i sociologi, gli storici e i politologi.
Quella riespansione costituisce, innanzitutto, un fenomeno demografico: secondo un rapporto
del Pew Research Center (www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections 2010-2050), il
numero delle persone che si autodefiniscono “musulmani”, nei prossimi 35 anni, crescerà a un
tasso del 73%. L’Islam, dunque, anche per effetto dell’ingrossamento e della moltiplicazione dei
flussi migratori, sembrerebbe destinato a diventare la prima religione in diverse metropoli
occidentali. Le ricadute culturali di questo processo demografico risultano ovvie agli occhi di chi
abbia una minima conoscenza della storia islamica o abbia esperienze di rapporti istituzionali con
le comunità musulmane. Siamo di fronte non solo a una religione, ma a una civiltà, dotata di una
propria filosofia di organizzazione dello spazio pubblico e di una costitutiva vis espansiva (v., ad
esempio, A. Cilardo, Il diritto islamico e il sistema giuridico italiano, Napoli, ESI, Napoli 2002 e S.
Ferrari [a cura di], Musulmani in Italia, Bologna, Il Mulino, Bologna, 2000: due testi di cui ci
permettiamo di auspicare una rapida rimessa in circolazione). Si può discutere finché si vuole sul
fatto che “Islam” e “Occidente” siano due concetti molto astratti, con i quali si fa riferimento a
realtà politiche e culturali estremamente complesse e variegate. Fatto sta che una parte non
trascurabile della popolazione mondiale crede a questo dualismo e, senza curarsi eccessivamente
del fatto che città come Vienna o Varsavia siano a est di Nouakchott o Algeri, utilizza
l’espressione “Occidente” per indicare, nel suo complesso, la civiltà euro-americana, spesso in
3 federalismi.it |n. 16/2015
una chiave critica. Certamente, ci sono molti autorevoli intellettuali di origine musulmana che si
battono per il superamento di quel dualismo e per una secolarizzazione del mondo islamico. Ma
in genere queste battaglie riscuotono successo tra quanti già si siano collocati fuori di quella
visione dualistica del mondo e della storia, mentre la stragrande maggioranza dei musulmani si
pone in una chiave agonistica – e in qualche caso antagonistica e persino conflittuale – rispetto ai
valori e alle istituzioni del mondo occidentale.
Non è un fenomeno nuovo. Di nuovo, rispetto al passato, oltre al citato dato demografico, c’è la
particolare criticità della geopolitica occidentale, segnata dall’esigenza di un ripensamento
dell’ordine globale in una chiave “post-vestfaliana”, con un’articolazione di tipo regionale e un
sistema di pesi e contrappesi distribuiti non più solo tra gli stati o i sistemi interstatuali, ma anche
tra culture, popoli, comunità, etnie e religioni, come ci pare abbia, di recente, ampiamente
dimostrato Henry Kissinger (World Order: Reflections on the Character of Nations and the Course of
History, New York, The Penguin Press, 2014). A fronte di questa criticità, si riscontra, nel mondo
islamico, e in particolare tra i giovani dell’Islam d’Occidente, una crescente rivalutazione del
paradigma comunitario islamico. In particolare, le nuove generazioni avvertono in maniera
sempre più debole il legame con le tradizioni nazionali dei padri e dei nonni e tendono a
identificarsi con la ’umma globale, in una prospettiva trans e post-statuale (P. Mandaville,
Transnational Muslim Politics. Reimaigining the umma, London & New York, Routlege, 2001). In
questo milieu, si diffonde e rafforza la convinzione, anche con il supporto di studi e ricerche di
indiscutibile valore scientifico, che i modelli politici europei e americani siano irrimediabilmente
in crisi, non solo perché poveri o del tutto privi di fondamenti etici, ma anche perché non più in
grado di garantire giustizia sociale e rappresentatività democratica.
A sostegno di quest’ultima tesi, non è difficile, per questi studiosi, utilizzare come case study le
riforme economiche di stampo occidentale realizzate nelle società arabe mediterranee, dove le
liberalizzazioni degli anni Ottanta/Novanta hanno incentivato aspettative di mobilità sociale tra i
giovani e nella classe media, ma hanno prodotto risultati per lo più frustranti, per via del mix di
corruzione, autoritarismo e inefficienza che tradizionalmente caratterizza gli apparati pubblici di
quei Paesi. Spesso, tra gli studiosi occidentali, colti di sorpresa dal revival islamico, si sottovaluta
il fatto l’Islam dispone di un proprio patrimonio di dottrine costituzionali e di propri modelli di
sviluppo. Si tratta di dottrine e modelli che risentono, naturalmente, anche dell’incontro tra
esperienze islamiche ed esperienze occidentali, ma che, essenzialmente, nascono nell’ambito di
una visione dello spazio pubblico alternativa a quella euro-americana, di cui si rifiutano
soprattutto l’individualismo e la neutralizzazione delle identità religiose. Certo, non mancano nel
4 federalismi.it |n. 16/2015
mondo islamico, esperienze di statualità secolarizzata. Valga per tutti, per restare all’ambito
sunnita mediterraneo, il caso della Turchia. Ma quando si ha a che fare con Paesi che hanno forti
tradizioni islamiche, un conto è parlare di secolarizzazione delle istituzioni statuali (trattasi di una
scelta “pragmatica”, ricorrente nella storia islamica), altro è parlare della laicizzazione dello spazio
pubblico (nel senso della neutralizzazione dell’identità islamica: si veda A. Ahmed Naʻim, Islam
and the Secular State. Negotiating the future of Shariʻa, Cambridge, MA, Harvard University Press,
2008). La Turchia è e resta un paese islamico, dal punto di vista delle “finalità generali”, come
testimonia anche il costante riemergere della sua vocazione pan-islamica (v., tra i lavori più recenti
ed aggiornati, V.R. Scotti, Il costituzionalismo in Turchia fra identità nazionale e circolazione dei modelli,
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2014), che ne fa un interlocutore fondamentale per i tanti
pensatori islamici, molti dei quali accademici in Occidente, impegnati nell’elaborazione
dell’”alternativa islamica” (Ahmet Davutoğlu, ministro degli Esteri e poi Primo ministro fino al
2015, è, in questo senso, un fondamentale punto di riferimento, quale autore di studi molto noti e
discussi come Alternative Paradigms: The Impact of Islamic and Western Weltanschauungs on Political
Theory [Lanham, University Press of America, 1993]).
Intorno alla riespansione islamica si sta svolgendo, come è già ripetutamente accaduto in passato,
una guerra civile, questa volta su scala globale. La Primavera araba, gli attentati jihadisti in
Occidente e nel Nord Africa, l’acuirsi del conflitto tra sciiti e sunniti, i successi geopolitici del
Califfato nero, le sanguinose rivalità interne all’insorgenza islamica, il tracollo libico: questi ed altri
fenomeni ad essi connessi possono essere letti in maniera unitaria, come segnali di un unico,
complesso e contraddittorio, ma inarrestabile movimento di riespansione del “principio
ordinatore islamico”. Per alcuni milioni di donne e uomini, sparsi in tutto il mondo, la
democrazia costituzionale di tipo occidentale non è affatto senza alternative, anche – e, per certi
versi, soprattutto – dopo il crollo del comunismo. Ciò vale per l’organizzazione dello spazio
pubblico a tutti i livelli, da quello metropolitano a quello globale. Il problema, per quanti si
sentono parte della ’umma globale, non è se l’Islam sia o meno la risposta all’asserita “crisi
dell’Occidente”, ma come vada articolata la risposta. Le posizioni, spesso in conflitto tra loro,
variano da quelle più propense al dialogo e all’integrazione fino a quelle più estremiste e violente,
passando per quelle semplicemente conservatrici (in particolare per quel che riguarda la pietà
religiosa e l’etica familiare), nelle quali sembrerebbe riconoscersi la stragrande maggioranza dei
musulmani. La radicalizzaizone del confronto dell’Occidente viene avvertita come un pericolo da
gran parte dell’opinione pubblica islamica, tanto è vero che molti media arabi, a cominciare da
quelli vicini all’Islam popolare, insistono nel chiamare lo Stato islamico tanẓīmad-dawla al-’islāmiyya,
5 federalismi.it |n. 16/2015
ovvero «l’organizzazione [denominata] “stato islamico”», per sottolineare il fatto che si tratta di
un gruppo terroristico, non di un soggetto politico legittimo. È uno sforzo che la dice lunga sulla
pericolosità dell’insorgenza jihadista.
***
Se è vero che la riespansione islamica è un fenomeno globale, è nella regione mediterranea e, in
particolare per quel che riguarda l’Italia, nell’area nordafricana, che si scarica la gran parte delle
tensioni geopolitiche e culturali di cui sopra. All’indomani dello “Tsunami del Nord Africa”, il 12
febbraio 2011, il Governo italiano dichiarò lo Stato di emergenza. Come si rileva in un report del
CeSPI, «il venir meno degli interlocutori istituzionali» in questi Paesi «ha rappresentato un primo
elemento di difficoltà» (L’impatto delle primavere arabe sui flussi migratori regionali e verso l’Italia, luglio
2012, reperibile su www.parlamento.it). Quell’emergenza, data dall’intreccio tra espansione
islamistica e catastrofe migratoria, è ancora in corso ed è destinata a “stabilizzarsi”, a meno che
non si avvii una ricostruzione del tessuto politico dell’area (v., da ultimo, l’audizione del ministro
dell’Interno davanti alla Commissione migranti della Camera dei Deputati seduta del 29 luglio
2015, attualmente disponibile in forma audio-video al link webtv.camera.it/evento/8254). Ma il
problema della stabilizzazione si presenta estremamente complesso se inserito nel contesto della
guerra civile di cui sopra. Ad esempio, si sa che lo Stato islamico, ormai insediatosi in una parte
centrale del territorio libico, non è militarmente imbattibile. Ma nelle cancellerie occidentali si è
ben consapevoli anche del fatto che qualsiasi operazione militare nei confronti del Califfato nero,
almeno nella fase dei boots on the Ground, debba svolgersi con la partecipazione di Paesi musulmani
di tradizione sunnita, quali, ad esempio, la Turchia e l’Egitto (rinviamo qui al nostro I
costituzionalisti europei e il califfato nero, sul n. 9/2015 di questa rivista). Diversamente, una diffusione
rapida e violenta dell’insorgenza islamista, su scala globale e su scala metropolitana (lo Stato
islamico è ormai un brand di cui si può liberamente disporre), sarebbe molto probabile. Per restare
al caso libico, nessuna soluzione sembra praticabile senza un preventivo accordo tra le principali
componenti politiche e tribali dell’area, a cominciare dall’Islam popolare, che si riconosce nel
governo di Tripoli, appoggiato da Ankara, e dagli ambienti politico-militari post-gheddafiani, che
si riconoscono nel governo di Tobruk, sostenuto dal Cairo.
In generale, la stabilità nell’area non andrebbe cercata attraverso il sostegno delle potenze
occidentali a soluzioni autoritarie, come si è fatto per decenni. Quella Realpolitik corrispondeva
alla logica della guerra fredda, fondata sul paradigma dei “blocchi”, ovvero caratterizzata, per quel
6 federalismi.it |n. 16/2015
che riguarda gli attori in campo e i rapporti tra mezzi e fini, da un gioco di simmetrie ancora di
stampo “vestfaliano”. Ed è proprio dall’esaurimento dell’energia ordinatrice di quel paradigma
che, in ultima analisi, trae forza la riespansione islamica. Schematicamente, potremmo dire che
l’inquadramento, in termini politici, della destabilizzazione di cui sopra, deve cominciare dalla
constatazione di due dati di fatto, da considerarsi due facce della stessa medaglia. Il primo è il
revival islamista globale, che tende a valorizzare l’attualità e l’alternatività della civiltà islamica
rispetto ai modelli democratici occidentali. Il secondo è la crescente dinamicità e irrequietezza
della società civile araba, negativamente segnata dalle passate esperienze di occidentalizzazione
dell’economia e delle istituzioni. Ci sono, dunque, sufficienti ragioni per ritenere che una politica
occidentale favorevole a soluzioni di tipo neoautoritario nell’area mediterranea aprirebbe una
grave ferita nella comunità islamica,a livello mondiale, con conseguenze non prevedibili per la
stabilità dell’area e per la sicurezza dell’Occidente.
***
Se appare chiaro quel che non si deve fare – appoggiare, cioè, soluzioni di stampo autoritario o
autocratico, in nome della lealtà all’Occidente – non appare altrettanto chiaro cosa, invece, si può
e si deve fare. Fin dall’inizio della Primavera araba, tanto nelle istituzioni UE quanto in quelle
italiane s’è posto l’accento sulla necessità di favorire le transizioni democratiche in quei Paesi. Ma
che cosa significhi ciò concretamente è difficile a dirsi. Chi sono gli interlocutori? Quali forze
sociali e soluzioni politico-costituzionali appoggiare?
Su questo fronte, un contributo fondamentale può venire dalla comunità dei giuristi. Ci riferiamo
non ai giusinternazionalisti, il cui coinvolgimento in tali questioni è ovvio e originario, bensì ai
costituzionalisti, poiché è nell’ambito della dottrina costituzionale che il decisore politico cerca –
o, si presume, dovrebbe cercare – la legittimazione del proprio operare. Stiamo parlando di un
lavoro teorico, certamente, che tuttavia presenta già, nell’immediato, i suoi risvolti pratici. Si
tratta, infatti, di superare o, quanto meno, di sottoporre a seria revisione molte delle categorie
interpretative con cui sono state, fino a ieri, ricostruite le vicende politiche del mondo islamico e,
in particolare, del Nord Africa. Ad esempio, come pure ci è capitato su questa rivista di insistere,
non si può pensare di ricostruire un fenomeno come la Primavera araba partendo dal
presupposto che nell’Islam sunnita mediterraneo esista una netta distinzione, di tipo europeo, tra
laici e musulmani (il presidente al-Sīsī non è meno musulmano del predecessore Mursī), o che –
altro esempio – la presenza della šari‘a quale fonte preminente nel sistema giuridico comporti, di
7 federalismi.it |n. 16/2015
per sé, un’islamizzazione della giurisdizione e della legislazione, quando invece può accadere
esattamente il contrario (v. l’Egitto dagli anni Settanta agli anni Novanta).
Qualcosa, in questo senso, pare si stia cominciando a muovere. Sono sempre di più i lavori
scientifici (dalle tesi di dottorato alle monografie) dedicati alle trasformazioni costituzionali in
corso nell’area nordafricana, con un taglio autenticamente critico, in quanto non si riducono a
una lettura formalistica della realtà, attenta ai soli dati legislativi ufficiali e ignara del law in action,
né si risolvono in dettagliati quanto superflui commenti agli innumerevoli report statistici sulle
violazioni dei diritti umani nei Paesi nordafricani.
Si prenda, ad esempio, il volume Political and Constitutional Transitions in North Africa. Actors and
Factors, a cura di Justin O. Frosini e Francesco Biagi (New York, Routledge, 2015). I curatori
hanno scelto di evitare il termine Spring nella titolazione del lavoro, perché, come spiegano nelle
conclusioni, il quadro politico nordafricano è ancora gravemente instabile e carico di incognite. Si
potrebbe osservare che non necessariamente Spring indica una situazione dai colori pastello,
almeno se ricordiamo quel che scrisse il poeta: «April is the cruellest month, breeding / Lilacs out
of the dead land, mixing / Memory and desire, stirring / Dull roots with spring rain» (T. E. Eliot,
The Waste Land, I, 1-4). In effetti, a cosa abbiamo assistito, nel Nord Africa, se non al doloroso
risvegliarsi di «memoria e desiderio»? E quale stagione presenta più incognite della primavera? Ma
la scelta dei curatori sembra avere soprattutto di mira quanti, con troppa enfasi e senza adeguate
verifiche empiriche, di fronte ai sommovimenti politici e sociali che hanno attraversato il Nord
Africa a partire dall’inverno 2010, hanno cominciato a parlare di «risveglio» democratico o
addirittura di «quarta ondata di democratizzazione». Sono spesso gli stessi che, passata l’euforia,
hanno cominciato a parlare di «autunno arabo» o addirittura di «inverno islamista». Per questo, i
curatori hanno preferito l’uso del più neutrale e scientifico termine «transizione», con l’avvertenza
che esso viene sì, usato, per lo più, per indicare il mutamento in senso democratico di un sistema
politico, ma può anche essere utilizzato per indicare il passaggio da un’autocrazia a un’altra.
Ora, se la comprensione di “fattori” risulta fondamentale in una prospettiva di medio e lungo
periodo, nell’immediato è sugli “attori” che sembra necessario focalizzare l’attenzione, per non
correre il rischio di legittimare gli interlocutori sbagliati. In questo senso, è essenziale
comprendere il ruolo fondamentale svolto, nelle società nordafricane, da quello che abbiamo
proposto di definire “Islam popolare”, vale a dire un Islam (sunnita) conservatore sul piano
religioso e moderato su quello politico, ostile sia al terrorismo sia al secolarismo occidentale,
diffidente verso un’eccessiva “statalizzazione dell’Islam” e molto più favorevole
all’“islamizzazione della società”, soprattutto per quel che riguarda l’educazione, la vita familiare e
8 federalismi.it |n. 16/2015
l’assistenza sociale. L’individuazione di questo attore e l’apprezzamento del suo peso
costituzionale, in senso materiale, nelle società dell’Islam mediterraneo può rivelarsi cosa ardua
per chi legge i fenomeni giuspubblicistici esclusivamente con le categorie euro-continentali.
Quando, ad esempio, il movimento al-Nahḍa, il partito della Fratellanza musulmana, divenne
maggioritario in Tunisia nel 2011 (nelle elezioni del 2014 è arrivato secondo), in molti, in
Occidente si aspettavano un colpo di mano per inserire, per la prima volta in Tunisia, la šari‘a
nella costituzione. Al-Nahḍa, certo, fece la proposta, ma poi apparve chiaro che il suo obiettivo
era quello di rafforzare la parlamentarizzazione e il decentramento di un sistema, quale quello
tunisino, fortemente caratterizzato in chiave presidenzialistico-autocratica e centralistica, il che
rappresentava un grosso ostacolo alla realizzazione del progetto di “islamizzazione dal basso” che
caratterizza l’Islam popolare. Come molto bene si spiega nel volume, la critica che il leader di al-
Nahḍa, Rāšid Ghannūšī, fa al modello democratico occidentale non guarda al passato, bensì al
futuro dell’umanità: «His central critique is that the unit of political partecipation is the nation-
state, that boudaries and governments are required to promulgate democracy, tending toward
nationalism and even racism» (D. Pickard, in J. O. Frosini e F. Biagi, Political and Constitutional
Transitions, cit.). Il leader dell’Islam popolare tunisino, dunque, propone un’”alternativa islamica”,
in chiave agonistica e non antagonistica, alla democrazia occidentale e, su questa base, sviluppa la
propria linea politica, che si distingue per duttilità e realismo.
Altro attore di un certo rilievo su cui si stanno accendendo, finalmente, i riflettori della dottrina
europea, è rappresentato dalle Corti, e, in particolare, della Suprema corte costituzionale egiziana.
Registriamo con soddisfazione che cominciano a circolare tra gli studiosi italiani i lavori dei
massimi esperti internazionali del tema, a cominciare da Nathan J. Brown. Fin da Constitutionalism
and Judicial Review in the Arab World (Journal of Democracy, 1998), Brown ci ha fatto comprendere il
peso dei giudici costituzionali in un Paese sunnita, con forti e multiple tradizioni giuridiche, come
l’Egitto. È emblematico, in questo caso, il ruolo svolto dalla Suprema corte dopo la deposizione
del presidente Morsi. Osserva Brown, nel volume curato da Frosini e Biagi, che lo “zenith”
dell’influenza dei giudici costituzionali lo si ha proprio quando nessuno, in Egitto, sembrava
sapere bene quale fosse la Costituzione. In effetti, la Corte ha consentito ai militari di riprendere
il potere, dopo la parentesi del primo presidente non militare eletto, a seguito di libere elezioni,
legittimando un golpe, ma anche evitando che l’Egitto cadesse nel baratro della totale instabilità
economico-sociale e del caos amministrativo.
Per certi versi, potrebbe dirsi che il “caso egiziano” sia uno dei più drammatici esempi di quanto,
nell’affrontare i temi del costituzionalismo islamico, l’applicazione rigida dei paradigmi occidentali
9 federalismi.it |n. 16/2015
possa generare paradossi o fare incorrere in situazioni aporetiche. La riflessione su questo punto
viene stimolata anche dalla lettura delle pagine che, nel volume citato, sono dedicate al caso del
Marocco. Il tentativo di dar vita a una vera democrazia parlamentare, si legge, al momento,
sembrerebbe fallito: il re «regna e governa». D’altra parte, a nessuno sfugge il fatto che il Re, in
questo Paese, abbia avuto una funzione fondamentale nell’evitare derive sia insurrezionali sia
dittatoriali, nonché nel favorire il superamento di antiche discriminazioni politico-culturali nei
confronti delle minoranze etnico-linguistiche, a partire da quella berbera. Un peso non
indifferente, in tal senso, ha avuto, secondo noi, la tradizione giuridica malikita, che colloca il
sovrano in posizione molto particolare, quale Amīr al-Muʾminīn, comandante dei «credenti» (tra i
quali rientrano i cristiani e gli ebrei). Infatti, come, poi, i curatori del volume rilevano, le riforme
realizzate su impulso del sovrano non sono né poche né di scarso rilievo: «In Morocco, the 2011
constitution introduced a number of significant novelties, such as the strengthening of the head
of government’s nd parliament’s poker, a more indipendent judiciary, the strengthening of the
protection of fundmanetal rights, the supremacy of International conventions over domestic
laws, the recognition of Amazigh as an official state language, and the duty of the king to appoint
the head of government from the party that wins the most seats in the elections to the House of
Representatives» (F. Biagi in J. O. Frosini e F. Biagi, Political and Constitutional Transitions, cit.).
Anche in Algeria, da un certo punto di vista, è stata realizzata, come in Marocco, una sorta di
transizione dall’alto (J. P. Entelis, in O. Frosini e F. Biagi, Political and Constitutional Transitions, cit.),
sia pure in un contesto decisamente più drammatico. L’Algeria, infatti, la sua “primavera” (nel
senso di cui sopra) l’ha vissuta negli anni Novanta, quando il Front Islamique du Salut seppe bene
utilizzare le timide aperture del regime, vincendo sia le elezioni regionali sia quelle politiche: il
governo reagì con una dura campagna repressiva che provocò una radicalizzazione del fronte
islamista, all’interno del quale si affermò il Groupe Islamique Armé, responsabile di azioni
particolarmente efferate. Dopo sette anni di guerra civile, nel 1999, si contavano oltre 150.000
morti. Quello stesso anno venne eletto presidente, per la prima volta, un non militare, ʿAbd al-
ʿAzīz Bū Teflīqa, il quale avviò un processo di pacificazione, che, nel tempo, ha dato apprezzabili
risultati, provocando una riconquista dell’egemonia dei moderati nell’ambito del fronte islamico.
Questa è la ragione principale per cui in questo Paese gli effetti dei tumulti scoppiati in Tunisia
sul finire del 2010 si sono fatti sentire in maniera molto debole. D’altra parte, lo stesso pouvoir –
così viene chiamata in Algeria la triade composta dal Presidente, dall’esercito e dal Fronte di
Liberazione nazionale – appare sempre più diviso al proprio interno, il che è da considerarsi,
forse, alla radice dell’incertezza che caratterizza la transizione algerina.
10 federalismi.it |n. 16/2015
Un discorso a parte merita, ovviamente, il caso libico, caratterizzato da un processo di
dissoluzione dell’entità stato-nazionale. Nello scenario libico, per certi versi, sembrano
convergere tutte le tensioni geopolitiche e culturali sviluppatesi intorno alla Primavera araba. Qui
un processo di transizione potrà avviarsi, si legge nel volume, solo grazie a una «robusta
assistenza della comunità internazionale» (K. Mezran ed E. Knechi, in O. Frosini e F. Biagi,
Political and Constitutional Transitions, cit.), la quale, aggiungiamo noi, deve fare ora i conti con la
presenza del Califfato nero, sul suolo libico. È evidente, come s’osservava, che il problema della
transizione libica è diventato a tutti gli effetti una questione interna della ’umma islamica, oltre che
un problema di carattere internazionale: l’espansione dello Stato islamico, infatti, rappresenta la
più pericolosa minaccia per i Paesi arabi impegnati nella transizione democratica.
***
L’identificazione degli “attori” del caos nordafricano va di pari passo con la revisione della
filosofia che ha ispirato fino a ieri la politica europea verso i Paesi dell’Islam mediterraneo. A
ripercorrere gli sviluppi della politica europea nella regione, così come ricostruiti da un recente e,
per molti versi, illuminante, studio di Gustavo Gozzi (Umano, non umano. Intervento umanitario,
colonialismo, «primavere arabe», Bologna, Il Mulino, 2015), si ha la netta impressione che i
responsabili, politici e tecnici, delle istituzioni europee non abbiano mai veramente creduto
nell’esistenza di una società civile arabo-islamica, e si siano affidati alla logica del mero rapporto
tra cancellerie e tra uffici, in nome della stabilità geopolitica e della sicurezza regionale. L’UE non
è stata in grado di dialogare con l’Islam popolare, interpretando il riconoscimento della
«specificità» araba (Dichiarazione di Barcellona adottata durante la Conferenza Euromediterranea
del 27/28 Novembre 1995) come sostanziale accettazione delle soluzioni autocratiche (magari in
nome della loro formale adesione ai valori europei, a partire dalla “laicità” delle istituzioni).
Naturalmente, una politica di aiuti che tenga conto degli effettivi attori presenti sulla scena
pubblica potrebbe rivelarsi molto vantaggiosa per organizzazioni islamico-popolari, quali la
Fratellanza musulmana, che dispongono di solide reti sociali ed economiche. Tuttavia, la società
civile nordafricana è più ampia e articolata di quello che spesso si tende a pensare. In Tunisia, ad
esempio, c’è una solida tradizione associazionistica e sindacale, mentre in Egitto la comunità
copta è attivissima sul piano sociale, economico e mediatico.
A fronte dei passati fallimenti, osserva Gozzi, l’Europa sta cambiando paradigma, prestando una
maggiore attenzione alla società civile nordafricana, riconoscendo «la necessità di offrire più
11 federalismi.it |n. 16/2015
risorse ai suoi vicini» e rafforzando il principio di condizionalità, in base al quale la cooperazione
economica viene subordinata alla realizzazione di una democratizzazione effettiva e non
nominale. Tuttavia, aggiunge, siamo ancora dentro una prospettiva asimmetrica, che vede i Paesi
della sponda Nord in una posizione di preminenza, dove invece essi sono interessati almeno
quanto i Paesi della sponda Sud alla stabilizzazione della situazione nel nord Africa e nel
Mediterraneo. Per questo, nei think tank che operano intorno alle istituzioni di Bruxelles, si sta
facendo strada l’idea di un superamento dello stesso “principio di condizionalità”, per l’adozione
del paradigma dell’“interdipendenza”, caratterizzato dalla individuazione di un set di comuni
interessi dei Paesi che affacciano sul Mediterraneo, a cominciare dalla stabilità (si veda R. Balfour,
New Paradigms for the EU-South Mediterranean: Rethinking Conditionality?, 2012, reperibile in
www.iemed.org). Si tratterebbe, ad esempio, di non continuare a richiedere la “conformità” ai
criteri dei singoli mercati europei, bensì di aprire i mercati europei, specie quelli agricoli, ai
prodotti della sponda sud. Tali proposte, al momento, andrebbero incontro a dure opposizioni da
parte proprio dei Paesi europei mediterranei, che sarebbero i primi a risentire degli effetti critici di
una tale apertura. Ma nel medio e lungo termine non sembrerebbero esservi alternative a un tale
processo.
L’emergenza mediterranea non consente tempi lunghi. La comunità dei giuristi, come abbiamo
visto, sta cominciando a dare un contributo significativo alla revisione critica delle categorie con
cui fino a ieri si sono inquadrate le vicende dell’Islam mediterraneo. In particolare, stanno
venendo contributi significativi sulla situazione nordafricana, alla quale, in quanto studiosi italiani
ed europei, siamo direttamente e immediatamente interessati. Il prossimo passo da fare, anche in
forma di sollecitazione al decisore politico, potrebbe essere quello di approfondire
scientificamente la collocazione delle turbolenze mediterranee nel contesto del fenomeno della
riespansione islamica e, su questa base, elaborare la questione del caos nordafricano in termini di
“urgenza costituzionale”: se la nostra analisi è corretta, in quella questione è in gioco non solo la
stabilità geopolitica dell’area o del nostro sistema sociale, ma anche la credibilità delle istituzioni
democratiche e della nostra tradizione costituzionale, in un mondo nel quale quelle istituzioni e
quella tradizione non godono né di consenso universale né di legittimità indiscussa.