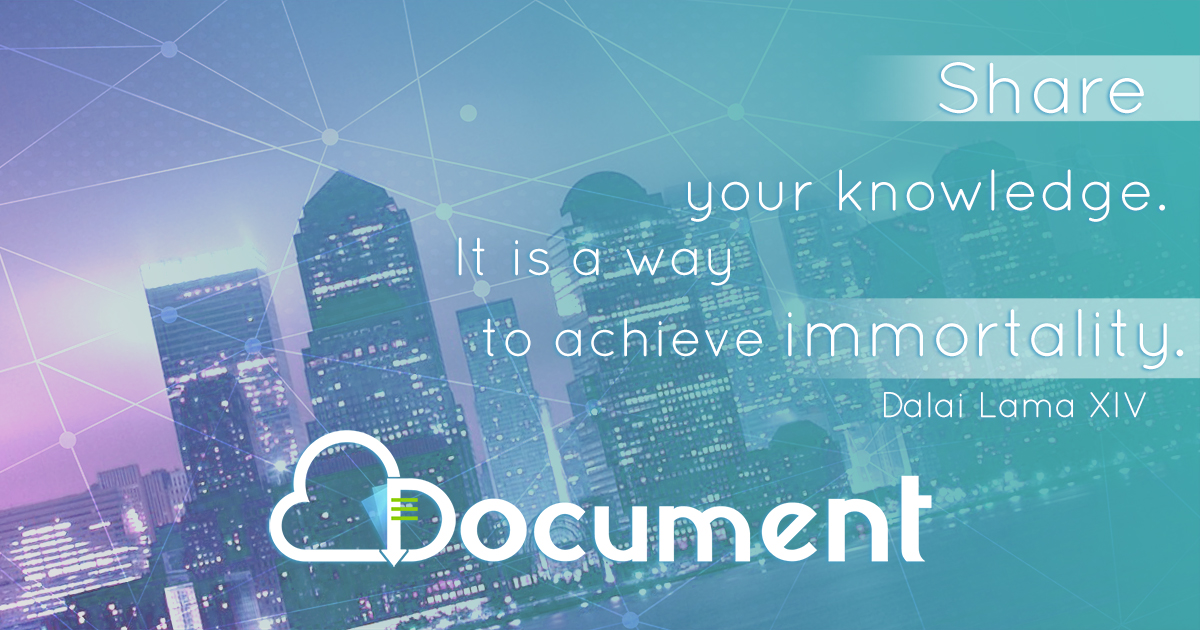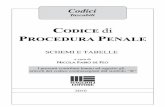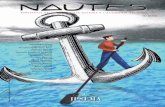Pasciuta - Il diavolo e il diritto: il Processus Satane (XIV sec.)
Prostituzione+e+Diritto+Penale
Transcript of Prostituzione+e+Diritto+Penale
Capitolo 5
PROSTITUZIONE E DIRITTO PENALE
di ALBERTO CADOPPI e DAVIDE BALESTRIERI
SOMMARIO: 1. L. 20 febbraio 1958, n. 75: struttura. – 2. Nozione di “prostituzione” e di “prestazionesessuale” alla luce della recente Giurisprudenza. — 3. Rilevanza penale della lap-dance e dellaweb-cam a luci rosse. — 4. Le singole ipotesi delittuose: classificazione. — 5. Proprietà ed eserciziodi casa di prostituzione, non punibilità della persona che si prostituisce in casa propria eprostituzione di gruppo. — 6. Locazione di locale per l’esercizio di casa di prostituzione. — 7.Tolleranza abituale dell’esercizio della prostituzione. — 8. Reclutamento e agevolazione dellaprostituzione a fine di reclutamento. — 9. Induzione alla prostituzione e lenocinio. — 10.Induzione a recarsi altrove per esercitare la prostituzione. — 11. Attività in associazioni edorganizzazioni nazionali od estere dedite al reclutamento o allo sfruttamento della prostituzione.— 12. Favoreggiamento della prostituzione. — 13. Sfruttamento della prostituzione. — 14.Circostanze aggravanti. — 15. Le singole aggravanti speciali. — 16. Invito al libertinaggio eadescamento. — 17. Misure di sicurezza. — 18. Pene accessorie.
1. L. 20 febbraio 1958, n. 75: struttura.
La L. 20 febbraio 1958, n. 75 porta il titolo « Abolizione della regola-mentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostitu-zione altrui » e contiene disposizioni di vario genere.
Gli artt. 1 e 2 vietano l’esercizio di case di prostituzione nel territorioitaliano e sanciscono la definitiva chiusura delle case di meretricio esistenti.
Gli artt. 3 e 4 contengono la previsione delle nuove fattispecie delit-tuose e delle circostanze aggravanti sostituendo così le disposizioni conte-nute negli artt. 531-536 del codice Rocco.
L’art. 5 sanziona a titolo di illecito amministrativo parte dei fatti giàdisciplinati dall’art. 208 t.u.l.p.s. 1 (invito al libertinaggio e adescamento).
L’art. 6 prevede pene accessorie.Tutte le restanti disposizioni (artt. 7-15) rivestono carattere ammini-
strativo e non formeranno pertanto oggetto della presente trattazione.
2. Nozione di “prostituzione” e di “prestazione sessuale” alla luce dellarecente Giurisprudenza.
Prima di procedere all’analisi delle singole ipotesi delittuose introdotte
1 R.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
1
dalla legge Merlin occorre fornire la definizione tecnico-giuridica di prosti-tuzione. La nozione di prostituzione recepita dalla l. n. 75/1958 si differenziainfatti da quella valevole per il codice Rocco.
Sotto la vigenza del codice Rocco, infatti, la nozione tecnico-giuridica diprostituzione prescindeva dal carattere venale della prestazione sessualeattribuendosi piuttosto carattere prevalente alla « dazione indiscriminatadel proprio corpo a un numero indeterminato di persone » qualificata dalfine di « servire l’altrui libidine ».
In altri termini, mentre la caratteristica peculiare delle condotte incri-minate sotto la vigenza del codice Rocco — induzione, agevolazione ecostrizione della prostituzione — era rappresentata dal fine di servireall’altrui libidine 2, viceversa la nozione di prostituzione recepita dalla leggeMerlin ritorna al concetto classico di « dazione indiscriminata e professio-nale del proprio corpo per fini di lucro » 3 o, detto altrimenti, « offertaindiscriminata e abituale di prestazioni sessuali dietro compenso ».
Qualche ulteriore precisazione si rende necessaria in ordine agli ele-menti costitutivi della definizione appena fornita: a) dazione indiscriminata,b) per fine di lucro e c) professionale.
Così anzitutto, connaturata alla nozione di prostituzione è la dazionedel proprio corpo che deve essere indiscriminata ovvero senza che vi siaalcuna facoltà di scelta del partner il quale pertanto potrà essere indiffe-rentemente uomo o donna, eterosessuale oppure omosessuale 4.
In secondo luogo, parimenti essenziale è che la prestazione sessualeavvenga a fine di lucro: ciò non toglie che l’ammontare della retribuzionepossa essere convenuta tra intermediario e cliente e da quest’ultimo corri-sposta direttamente all’intermediario e non già al soggetto che effettua laprestazione a condizione però che chi si prostituisce aderisca all’accordo 5.
Da ultimo, con riferimento al connotato della professionalità e/o abi-tualità del comportamento, si contrappongono in dottrina due opposti
2 NUVOLONE , Sul concetto di prostituzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1960, 247, osserva al riguardoche « la libidine altrui può essere servita anche al di fuori di ogni rapporto commerciale di dare e diavere, mentre acquista un rilievo decisivo il fatto che la libertà sessuale e l’onore sessuale di una personavengano lesi e piegati ad opera di un terzo per il soddisfacimento di istinti erotici, senza che si instauritra i partecipi dell’atto carnale quella relazione di simpatia che all’atto carnale toglie ogni carattere diturpitudine ».
3 È la definizione fornita da Cass. pen., sez. III, 1.8.1967, n. 734.4 Osserva BONTEMPI, sub art. 3 l. 20 febbraio 1958, n. 75, in Codice penale commentato, parte
speciale, a cura di DOLCINI-MARINUCCI, Milano, Ipsoa, 1999, 5226 ss. che l’indeterminatezza dei destina-tari non viene meno qualora la prostituta si conceda ad una categoria di persone avete certi requisiti.
5 PIOLETTI, voce « Prostituzione », in Digesto IV ed., Disc. pen., X, Torino, Utet, 1995, 276.
IV, 5 La disposizione del corpo
2
orientamenti: parte della dottrina 6 sostiene che il predetto requisito sipresenta assolutamente necessario in considerazione del fatto che unaprestazione puramente episodica farebbe sorgere dubbi in ordine al requi-sito della indiscriminatezza. Viceversa, altra parte della dottrina 7 ritiene cheaffermare l’essenzialità del requisito della professionalità impedirebbe diconsiderare penalmente rilevante il caso della persona che si prostituiscesaltuariamente oppure che compia anche una sola prestazione sessuale,naturalmente dietro compenso.
Per quanto concerne infine il tipo di prestazione sessuale penalmenterilevante, riteniamo opportuno fornire qualche approfondimento anche allaluce della più recente giurisprudenza di legittimità e di merito.
Tradizionalmente, infatti, si pensa alla prostituzione come ad un rap-porto a due tra chi esercita il meretricio ed il cliente il quale necessaria-mente implicherebbe quantomeno un contatto fisico tra i medesimi.
Viceversa, tanto la giurisprudenza di legittimità quanto le Corti dimerito hanno ripetutamente ribadito che l’elemento caratterizzante l’attodi prostituzione non è necessariamente costituito dal contatto fisico tra isoggetti della prestazione, bensì dal fatto che un qualsiasi atto sessualevenga compiuto dietro pagamento di un corrispettivo e risulti finalizzato, invia diretta ed immediata, a soddisfare la libidine di colui che ha chiesto o èdestinatario della prestazione 8.
Imprescindibile si presenta dunque, a questo punto, la ricostruzionedella nozione di atto sessuale rilevante ai fini e per gli effetti della l. n.75/1958.
Deve trattarsi sicuramente di un atto riconducibile alla sfera dellasessualità umana, ma, stando alla più recente giurisprudenza di legittimità« non occorrono né la congiunzione carnale (dovendosi intendere per talequalsiasi forma di compenetrazione tra gli organi genitali di una persona eil corpo di un’altra, così da rendere possibile il coito in qualsiasi formanormale o anormale), né il compimento di atti di libidine (dovendosiintendere per tali, nel senso presupposto dall’ormai abrogata disposizionedell’articolo 521 del c.p., qualsiasi manomissione del corpo altrui, diversadalla congiunzione carnale, suscettibile di eccitare la concupiscenza car-nale), in quanto non è affatto necessario né che vi sia un contatto fisico tra
6 CALVI, voce « Sfruttamento della prostituzione », Padova, Cedam, 1970, 28; LEONE , Delitti diprossenetismo e adescamento, Milano, Giuffrè, 1964, 34.
7 PIOLETTI, op. loc. citt.8 Cass. pen., sez. III, 22.4.2004, n. 25464, in Cass. pen., 2004, 3577, con nota di CATULLO, Sullo
sfruttamento della prostituzione on-line; conforme, tra gli altri, Cass. pen., sez. III, 20.5.1998, n. 7608.
IV, 5Prostituzione e diritto penale
3
i soggetti della prestazione e neppure che richiedente ed esecutore dellaprestazione si trovino nello stesso luogo » 9.
A ben vedere, dunque, tanto in dottrina che in giurisprudenza, siafferma che la nozione di atto sessuale rilevante ai fini della l. n. 75/1958 nonsarebbe dissimile da quella elaborata dalla Supr. Corte in relazione all’art.609-bis del cod. pen. dopo la riforma introdotta dalla l. 15 febbraio 1996, n.66 (Norme contro la violenza sessuale).
Ciò porta a ritenere che per atti sessuali penalmente rilevanti tanto aifini dell’art. 609-bis cod. pen. quanto ai fini della l. n 75/1958 debbanointendersi tutti quelli che coinvolgono comunque la “corporeità sessuale”del soggetto passivo, anche se non sostanziantisi nella congiunzione carnalee, addirittura, anche se non si risolvono in un “contatto corporeo” tra ilsoggetto attivo e quello passivo 10.
Viceversa, non potranno qualificarsi come atti sessuali la sempliceesibizione delle parti intime, l’autoerotismo e il voyeurismo, mentre losaranno anche semplici toccamenti, palpeggiamenti o sfregamenti sulleparti intime della vittima che, in quanto tali, intaccano la sfera dellasessualità fisica della vittima 11.
Resta da aggiungere che il riferimento alla “corporeità sessuale” dellavittima, ai fini della configurabilità di un “atto sessuale”, non andrà intesocome limitato alla sfera genitale in senso stretto, estendendosi, invece, atutte quelle zone del corpo note, secondo la scienza medica, psicologica,antropologica-sociologica, come “erogene”, cioè tali da eccitare e soddi-sfare l’istinto sessuale dell’agente 12.
3. Rilevanza penale della lap-dance e della web-cam a luci rosse.
Alla luce dei summenzionati principi vediamo di riassumere quelli chesono, in giurisprudenza, taluni orientamenti in tema di rilevanza penaledegli spettacoli di lap-dance e di performance sessuali a mezzo internet.
Così anzitutto con riferimento ai locali, peraltro assai diffusi nel nostro
9 Cass. pen., sez. III, 3.6.2004, n. 36157, in Guida dir., 2004, 40, 81, con nota di AMATO, Se la lapdance degenera in prestazioni extra favoreggiamento contro i gestori del locale.
10 Cass. pen., sez. III, 12.2.2004, n. 15464.11 Trib. Bergamo, 7.5.2003, n. 906, in Foro it., 2003, II, 642, con nota di LEINERI, nonché nota di
CERQUA, Quando un atto sessuale diventa atto di prostituzione, in Il Merito, 2004, 6, 58 e ss.12 Sul punto si vd. CADOPPI, sub art. 3 l. 15 febbraio 1996 n. 66, in ID. (a cura di), Commentari delle
norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia, Padova, Cedam, 2002, III ed., (p.?).Contra, FIANDACA, voce « Violenza sessuale », in Enc. dir., Agg. IV, Milano, Giuffè, 2000, 1158.
IV, 5 La disposizione del corpo
4
Paese, in cui si svolgono spettacoli di lap-dance in cui cioè le ballerine siesibiscono seminude davanti ai clienti salvo poi appartarsi con alcuni di essiin stanze del locale separate (c.d. privé) dove, dietro compenso ulteriore,svolgono spettacoli “riservati” che spesso consentono ai fruitori toccamentilascivi su varie parti del corpo, occorre dare atto di un curioso contrastointerpretativo tra la Suprema Corte ed una Corte di merito.
Mentre infatti i giudici del Supremo Collegio 13 hanno ritenuto laconfigurabilità del delitto di favoreggiamento e/o sfruttamento della pro-stituzione (e quindi la configurabilità di “prestazione sessuale”) nell’ipotesidi gestione di un club dove ragazze svolgevano attività di lap danceconsistente nel ballare denudate davanti ai clienti che, in luogo appartato,potevano accarezzarle su parti intime del corpo in cambio di danaro,viceversa, il Tribunale di Bergamo 14, di fronte ad un caso del tutto identicoa quello esaminato dalla Corte di cassazione, ha escluso che nell’ambitodella nozione di prestazione sessuale penalmente rilevante possa ricom-prendersi l’esibizione del corpo da parte di ballerine di lap-dance all’internodi locali notturni con possibilità per il cliente di rapidi toccamenti del lorocorpo (seno, gambe, sedere e via dicendo) e ciò in considerazione dell’at-tuale contesto socio-culturale che negli ultimi anni ha subito un’accentuataevoluzione in senso liberale che ha portato ad accettare a diversi livellimanifestazioni di nudo con connotazioni di tipo erotico.
Uniforme è invece l’orientamento dei giudici di legittimità in tema difruizione di prestazioni sessuali per il tramite di internet.
Ci si riferisce alle condotte di persone che, attraverso una connessioneinternet a valore aggiunto, interagiscono virtualmente tramite una webcamcon le intrattenitrici richiedendo, da parte di queste ultime, il compimentodi comportamenti osceni o di esibizioni sessuali.
Afferma al riguardo la giurisprudenza di legittimità che irrilevante è « ilfatto che chi si prostituisce ed il fruitore della prestazione si trovino inluoghi diversi, allorché gli stessi risultino collegati, tramite internet, invideoconferenza, che consente all’utente della prestazione, non diversa-mente da quanto potrebbe verificarsi nell’ipotesi di contemporanea pre-senza nello stesso luogo, di interagire con chi si prostituisce, in modo dapoter chiedere a questi il compimento di atti sessuali determinati, chevengono effettivamente eseguiti e immediatamente percepiti da colui cheordina la prestazione sessuale a pagamento » 15.
13 Cass. pen., sez. III, 12.2.2003, n. 13039, in Rivista giuridica di polizia, 2003, 627.14 Trib. Bergamo 7.5.2003, n. 906, cit.15 Cass. pen., sez. III, 22.4.2004, n. 25464, in Dir. giust., 2004, 25, 24 ss., con nota di NATALINI,
IV, 5Prostituzione e diritto penale
5
Ipotesi, quest’ultima, del tutto distinta da quella, penalmente irrile-vante, in cui il fruitore della pubblicazione o della rappresentazione restasolo spettatore passivo, senza alcuna possibilità di interagire con i protago-nisti della rappresentazione medesima (es: filmini pornografici e via di-cendo).
4. Le singole ipotesi delittuose: classificazione.
Per ragioni di carattere sistematico prima di procedere all’esame deisingoli delitti previsti e disciplinati dalla l. n. 75/1958 (c.d. legge Merlin) siritiene opportuno così individuarli:
a) Proprietà ed esercizio di casa di prostituzione (art. 3, comma 1°, n. 1);b) Locazione di locale per l’esercizio di casa di prostituzione (art. 3,
comma 1°, n. 2);c) Tolleranza abituale dell’esercizio della prostituzione (art. 3, comma
1°, n. 3);d) Reclutamento e agevolazione della prostituzione a fine di recluta-
mento (art. 3, comma 1°, n. 4);e) Induzione alla prostituzione e lenocinio (art. 3, comma 1°, n. 5);f) Induzione a recarsi altrove per esercitare la prostituzione (art. 3,
comma 1°, n. 6);g) Attività in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dedite al
reclutamento o allo sfruttamento della prostituzione (art. 3, comma 1°, n. 7);h) Favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione (art. 3, comma
1°, n. 8).Procederemo quindi all’analisi delle circostanze aggravanti speciali
contemplate nell’art. 4 l. n. 75/1958.Sempre dal punto di vista interpretativo-sistematico ci si è chiesti, in
dottrina, se con l’art. 3 della l. n. 75/1958 il legislatore abbia intesointrodurre un unico reato oppure una pluralità di fattispecie delittuose ingrado di concorrere tra loro.
La soluzione prevalente in dottrina 16 e giurisprudenza 17 è quella che
Web-cam a luci rosse, per la Cassazione è atto di prostituzione. Nulla rileva che tra i partecipanti non visia congiunzione carnale; conforme, da ultimo, Cass. pen., sez. III, 21.3.2006, n. 15158, in Giur. it., 2007,8-9, 2039, con nota di FERRARI, Sulla prostituzione on-line.
16 VASSALLI, Le norme penali a più fattispecie e l’interpretazione della legge Merlin, in Studi inonore di Francesco Antolisei , III, Milano, Giuffrè, 1960-5, 349; LA CUTE, voce « Prostituzione (dir.vig.) », in Enc. dir., XXXVII, Milano, Giuffrè, 1989, 452: BONTEMPI, sub art. 3 l. 20 febbraio 1958, n. 75,cit., 5228.
IV, 5 La disposizione del corpo
6
descrive la previsione di cui all’art. 3 della l. n. 75/1958 come unico reato afattispecie alternative e ciò sulla base delle seguenti considerazioni: a)previsione di un’unica pena per tutte le ipotesi criminose; b) trasformazionein aggravanti di elementi che prima erano costitutivi di singole figurecriminose; c) funzione sussidiaria assegnata alle due ipotesi previste nell’art.3, comma 1°, n. 8 , cui tutte le altre possono essere ricondotte.
5. Proprietà ed esercizio di casa di prostituzione, non punibilità dellapersona che si prostituisce in casa propria e prostituzione di gruppo.
L’art. 3, comma 1°, n. 1, della l. n. 75/1958 punisce chi sia titolare dellaproprietà o dell’esercizio di una casa di prostituzione, ovvero la controlli, ladiriga, la amministri, oppure partecipi comunque a tali atti.
La norma appena menzionata non fornisce alcuna nozione di casa diprostituzione la cui concreta definizione viene quindi devoluta all’inter-prete.
In via di prima approssimazione si ritiene comunemente che per casa diprostituzione debba intendersi qualsiasi luogo chiuso in cui chiunque puòaccedere per ottenere i servizi di persone (indifferentemente uomini odonne) che ivi si prostituiscono 18.
Si ritiene altresì che la notorietà costituisca un requisito implicito dellacasa di prostituzione ciò in quanto il bene giuridico tutelato, ovverosia lapubblica moralità, potrebbe ritenersi violato o messo in pericolo soltantonel caso in cui siano noti i luoghi in cui la prostituzione si esercita 19.
Sarà necessaria una struttura organizzativa, sia pure semplice e rudi-mentale, presieduta da persona diversa da colei/colui che si prostituisce 20;naturalmente, quanto maggiore sarà l’organizzazione (e il giro d’affari)tanto più la casa di prostituzione sarà dissimulata da strutture di facciata(es: locali notturni, circoli privati, centri estetici ecc.) 21.
17 Cfr., tra le altre, Cass. pen., sez. III, 5.11.1999, n. 2730.18 PIOLETTI, voce « Prostituzione », cit., 279.19 BONTEMPI, op. loc. citt.; conf. PIOLETTI, op. loc. citt., ad avviso del quale il requisito della
notorietà del luogo porta ad escludere la configurabilità del reato in esame nell’attività di chi di voltain volta invia le prostitute presso i clienti.
20 BONTEMPI, op. loc. citt.. Conforme in giurisprudenza, tra gli altri, Cass. pen., sez. III, 19.5.1999,in Dir. pen. proc., 1999, 9, 1132, con nota di CORBETTA, La nozione di “casa di prostituzione”…
21 PIOLETTI, op. loc. citt.
IV, 5Prostituzione e diritto penale
7
Siffatta struttura organizzativa deve presentare carattere permanente el’esercizio della prostituzione deve essere abituale 22.
Ai fini dell’esistenza di una casa di prostituzione sarà sufficiente lapresenza anche di una sola prostituta, la quale non dovrà necessariamenterisiedervi e fatta salva, in caso di presenza di due o più prostitute, l’appli-cabilità dell’aggravante di cui all’art. 4, comma 1°, n. 7 23.
Una volta chiarita la nozione di casa di prostituzione ci occuperemo oradegli elementi costitutivi della fattispecie contemplata nell’art. 3, comma 1°,n. 1, della l. n. 75/1958 ed affronteremo, infine, i problemi relativi allapunibilità o meno della persona che si prostituisce in casa propria nonchéalla punibilità o meno delle condotte di esercizio in comune del meretricio.
La fattispecie disciplinata nell’art. 3, comma 1°, n. 1, della l. n. 75/1958è, anzitutto, un reato proprio dal momento che il soggetto attivo deverivestire una particolare posizione giuridica nei confronti della casa diprostituzione: deve cioè esserne il proprietario, oppure averne l’esercizio, ladirezione, il controllo, l’amministrazione od, infine, la partecipazione.
Riteniamo opportuno fornire qualche precisazione in ordine alle con-dotte che riguardano la proprietà e la partecipazione: con riferimento allaprima, si ritiene comunemente che il termine proprietà non indichi laproprietà dei muri o del locale in cui si trova la casa di prostituzione(situazione peraltro disciplinata dall’art. 3, comma 1°, n. 2), riferendosipiuttosto alla proprietà della struttura organizzativa 24.
Con riguardo, invece, alla condotta di partecipazione alla casa diprostituzione, essa potrà intendersi riferita ai seguenti soggetti: finanzia-tore, cointeressato, usufruttuario, usuraio, detentore, conduttore, comoda-tario, personale di servizio ed, eventualmente, il medico che vi si rechiperiodicamente per effettuare controlli sulla salute delle prostitute 25.
Deve invece escludersi qualsiasi punibilità tanto del cliente quanto dellapersona che si prostituisce.
In ordine all’elemento soggettivo del reato, si ritiene unanimementetrattarsi di dolo generico inteso come consapevolezza e volontà di avere laproprietà, l’esercizio, la gestione di una casa di prostituzione ovvero qualeconsapevolezza e volontà di partecipare alla proprietà, esercizio, ammini-strazione di un locale adibito all’esercizio della prostituzione.
22 BONTEMPI , op. loc. citt.; contra, PIOLETTI, op. loc. citt., il quale osserva come sia nota a tuttil’esistenza di case di prostituzione frequentate, saltuariamente e con opportune cautele, da donne“trasgressive” ma non prostitute di mestiere.
23 BONTEMPI, op. cit., 5229.24 BONTEMPI, op. loc. citt.25 BONTEMPI, op. loc. citt.
IV, 5 La disposizione del corpo
8
Il reato si consuma nel momento in cui si può considerare iniziatal’attività di prostituzione all’interno di un locale chiuso che possegga lecaratteristiche di casa di prostituzione come sopra descritte.
Trattasi di un reato permanente con la conseguente configurabilità deltentativo ogniqualvolta, pur essendo stata allestita la casa, l’esercizio delleattività di prostituzione non abbiano avuto inizio per cause indipendentidalla volontà dell’agente 26.
Ciò posto in ordine alla nozione di casa di prostituzione ed in ordine aisingoli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice, non ci resta cheaffrontare le questioni, tra loro collegate, relative alla punibilità o menodella persona che si prostituisce in casa propria ed alla punibilità o menodelle condotte di esercizio in comune della prostituzione.
Dottrina e giurisprudenza prevalenti sono concordi nell’escludere chesia punibile, ai sensi dell’art. 3, comma 1°, n. 1), della l. n. 75/1958, lapersona che si prostituisce in casa propria.
Ad una conclusione di tal fatta si giunge anzitutto sulla base dellaconsiderazione che verrebbe a mancare in primis uno degli elementi costi-tutivi della fattispecie ovvero la c.d. casa di prostituzione non potendoconsiderarsi tale l’abitazione della donna che si prostituisce per proprioconto 27.
Si rileva inoltre che il reato previsto dall’art. 3, comma 1°, n. 1, dellalegge Merlin « sarebbe configurabile a condizione non solo che la casarisulti organizzata ai fini dell’esercizio della prostituzione, ma che un altropersonaggio, diverso dalla prostituta, agevoli o sfrutti il mestiere di que-sta » 28.
Da ultimo, si osserva che se nessun tipo di sanzione è prevista neiconfronti della donna che viene sorpresa a prostituirsi in un locale gestitoda altri, essendo in questo caso perseguibile penalmente soltanto la con-dotta del proprietario o del gestore del locale medesimo, a maggior ragionenon si potrà ritenere punibile la donna che eserciti il meretricio in casapropria 29.
Naturalmente, del tutto diversa dall’ipotesi appena menzionata, e per-
26 BONTEMPI, op. cit., 5230.27 POTETTI, La casa di prostituzione e l’esercizio in comune del meretricio, in Cass. pen., 2001, 640.
Conforme in giurisprudenza Cass. pen., sez. III, 25.5.1969, (completare, se possibile, con indicazioniCED), secondo la quale, « perché si realizzi l’esercizio di una casa di prostituzione sono necessarielementi, quale una sia pur rudimentale organizzazione da parte di persone diverse dalla prostituta, chenon sono ravvisabili nell’attività della donna che si prostituisca in casa propria ».
28 POTETTI, op. cit., 644.29 LO TORTO, La prostituzione nella propria abitazione, in Riv. pen., 1959, 737.
IV, 5Prostituzione e diritto penale
9
tanto meritevole di sanzione penale, sarà la condotta della donna cheadeschi abitualmente i suoi clienti anche per il tramite di una certa forma di“pubblicità” in ordine alle prestazioni offerte, e poi li conduca nel proprioappartamento al fine di ottenere danaro in cambio di prestazioni sessuali 30.
Veniamo, infine, alla questione relativa alla c.d. prostituzione di gruppoovverosia all’ipotesi in cui due o più persone dedite alla prostituzioneconvivano (o comunque si ritrovino) in uno stesso luogo al fine di esercitareil meretricio in condizioni di maggiore sicurezza rispetto a quella chepotrebbe essere la prostituzione di strada: si rientra oppure no nellafattispecie prevista dall’art. 3, comma 1°, n. 1, della legge Merlin? 31
La soluzione al quesito prospettata in dottrina 32 è la seguente: la c.d.prostituzione di gruppo non sarà penalmente perseguibile nel caso in cui leprostitute siano legate tra loro da un semplice rapporto di coabitazione omeglio di protezione e assistenza reciproca e ciascuna di esse esercitiliberamente e indipendentemente la propria prostituzione.
Viceversa si dovrà ritenere penalmente perseguibile la situazione in cuile prostitute conviventi non siano legate solo da un rapporto c.d. di “mutuosoccorso”, ma si presentino in un certo qual modo strutturalmente orga-nizzate in modo tale da poter individuare, all’interno del gruppo, unsoggetto che, pur prostituendosi anch’esso, rivesta una posizione di premi-nenza o di gerarchia.
6. Locazione di locale per l’esercizio di casa di prostituzione.
L’art. 3, comma 1°, n. 2, della l. n. 75/1958 punisce chiunque, avendo laproprietà o l’amministrazione di una casa o altro locale, li conceda inlocazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione.
La fattispecie in esame rafforza ed integra la tutela penale dell’ipotesiprecedente perché, distinguendo tra la proprietà, l’esercizio, l’amministra-zione o la direzione della “casa”, e la proprietà o l’esercizio dell’edificio odegli locali ove la medesima è installata, afferma la responsabilità del
30 PIOLETTI, voce « Prostituzione », cit., 280.31 La scottante attualità del problema è ben evidenziata da POTETTI, op. cit.., 651, il quale osserva
che « incalzato da mutamenti sociali di vastissime dimensioni, come l’immigrazione massiccia, ilfenomeno della prostituzione subisce anch’esso notevoli trasformazioni. Alla prostituzione in strada (laforma più dura e rischiosa) si affiancano modalità più protette, sollecitate dal bisogno di autodifesa dicoloro che, per scelta o per necessità esercitano il meretricio »; sui rapporti tra criminalità e sesso si vd.altresì VINCIGUERRA, Principi di criminologia, Padova, Cedam, 2005, II ed., 71 ss.
32 POTETTI, op. cit., 645.
IV, 5 La disposizione del corpo
10
proprietario o dell’amministratore di questi ultimi che li abbia concessi inlocazione allo scopo sopra indicato 33.
Esaminiamo i singoli elementi costitutivi del reato: soggetto attivo potràessere chiunque concede in locazione l’immobile in quanto proprietario oamministratore dello stesso. Vi rientrano quindi il comproprietario, l’usu-fruttuario ed il mandatario e potrà concorrervi anche il mediatore che hafavorito la conclusione del contratto 34.
Vi rientra inoltre la sublocazione, ma non il comodato che potrà,eventualmente, integrare la fattispecie di cui al n. 1 dell’art. 3 della l. n.75/1958 oppure l’ipotesi di favoreggiamento di cui al successivo n. 8 seconferito per l’esercizio della casa di prostituzione 35.
In giurisprudenza si è inoltre affermata la necessità che la qualità dilocatario venga svolta da più persone dal momento che, nel caso dilocazione alla sola persona che si prostituisce in casa propria, non sirientrerebbe nell’ipotesi di cui al n. 1 dell’art. 3 della l. n. 75/1958, ma siavrebbe, eventualmente, un’ipotesi di favoreggiamento.
Sotto il profilo oggettivo, non si richiede che l’immobile locato abbiauna particolare struttura potendosi benissimo intendere per “locale” anchela roulotte, il carrozzone, la tenda, l’imbarcazione ecc. 36.
Sotto il profilo soggettivo si ritiene trattarsi di dolo specifico, inteso noncome coscienza e volontà che il locatario ponga in essere un’attività dimeretricio organizzata, bensì come semplice conoscenza della destinazionedell’immobile accertata sulla base di elementi probatori univoci e logica-mente concludenti 37.
Trattasi di un reato istantaneo che si consuma nel momento dellaconclusione del contratto di locazione indipendentemente dalla sua validitàsotto il profilo civilistico e indipendentemente dall’inizio dell’attività diprostituzione. Si dovrà pertanto negare la configurabilità del tentativo 38.
7. Tolleranza abituale dell’esercizio della prostituzione.
L’art. 3, comma 1°, n. 3), della l. n. 75/1958 punisce chiunque, essendoproprietario, gerente o preposto ad un albergo, casa mobiliata, pensione,
33 ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, parte speciale, I, Milano, Giuffrè, 2002, XIV ed., 557.34 PIOLETTI, voce « Prostituzione », cit., 280.35 BONTEMPI, sub art. 3 l. 20 febbraio 1958, n. 75, cit., 5231.36 ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, cit., 557.37 BONTEMPI, op. loc. citt.38 BONTEMPI, op. loc. citt.
IV, 5Prostituzione e diritto penale
11
spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loroannessi e dipendenze, o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzatodal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che,all’interno del locale stesso, si danno alla prostituzione.
La norma in esame rappresenta una sorta di chiusura del cerchiorappresentato dal divieto di esercizio delle case di prostituzione: con il n. 1dell’art. 3 della legge Merlin si punisce infatti la costituzione delle case diprostituzione, con il n. 2 si punisce la cessione in locazione di un locale a talescopo ed, infine, con il n. 3 si vieta che la prostituzione possa svolgersiall’interno di altro pubblico esercizio per la tolleranza e l’acquiescenzadell’esercente.
Perché si configuri l’ipotesi in esame è necessario che esista realmenteun pubblico esercizio il cui titolare o gerente non partecipi in alcun modoall’attività di prostituzione.
In altri termini, il pubblico esercizio fornirà soltanto l’occasione, l’am-biente per l’esercizio nei suoi locali della prostituzione la quale verràabitualmente tollerata dal suo gestore 39.
Trattasi di un reato proprio poiché soggetti attivi sono soltanto quellepersone che, nei confronti del locale, rivestono la qualifica di proprietario,gerente o preposto.
Per preposto dovrà intendersi colui che, in assenza del proprietario,sovrintende alla gestione del locale ad esempio disciplinando l’accesso dellaclientela (portiere d’albergo); non potrà invece considerarsi preposto e nonrisponderà pertanto del delitto in esame, salva l’eventuale configurabilitàdell’ipotesi di favoreggiamento di cui al successivo n. 8, il soggetto cheesplichi mansioni subordinate ed accessorie (es. il cameriere) 40. Viceversa,risponderà ai sensi della fattispecie in esame colui che, in accordo con iltitolare, svolga compiti di cogestione, partecipando agli utili e contribuendoall’accettazione dei clienti, in base ad un rapporto associativo, fattuale ocontrattuale, con il gestore.
È opinione unanime in dottrina 41 che l’elenco dei locali fornito dallanorma sia meramente esemplificativo e non esaustivo come d’altronde sidesume anche dalla formula di chiusura « qualunque locale aperto alpubblico od utilizzato dal pubblico ». Del pari indifferente sarà la circo-stanza che al locale sia stata o meno concessa la licenza d’esercizio 42.
39 PIOLETTI, op. cit., 281.40 BONTEMPI, sub art. 3 l. 20 febbraio 1958, n. 75, cit., 5231.41 ANTOLISEI, op. cit., 558; BONTEMPI, op. cit., 5231; PIOLETTI, op. cit., 281.42 ANTOLISEI, op. loc. citt.
IV, 5 La disposizione del corpo
12
La condotta sarà sostanzialmente omissiva consistendo nel tollerare,permettere, consentire la presenza nel locale di persone che si danno allaprostituzione.
Trattasi inoltre di reato necessariamente abituale laddove l’abitualitàandrà riferita alla tolleranza e non alla presenza nel locale delle persone chesi prostituiscono: in altri termini non si richiede che le persone che siprostituiscono all’interno del locale siano sempre le stesse potendo vice-versa cambiare di volta in volta.
Sempre dal carattere di abitualità deriva che non acquisterà rilevanzapenale il consenso sporadico, saltuario all’utilizzo dei locali, ma si richie-derà che il comportamento omissivo-tollerante cui si accennava poc’anziperduri nel tempo sì da denotare una sorta di reiterazione della permissivitàcolpevole 43.
Dottrina e giurisprudenza prevalenti ritengono inoltre che la locuzione« persone che si danno alla prostituzione » vada intesa come effettivoesercizio della prostituzione nel locale da parte delle persone che si prosti-tuiscono, non essendo sufficiente ad integrare il reato che le stesse frequen-tino il locale al solo fine di attendere e conseguentemente adescare i variclienti 44.
Relativamente all’elemento soggettivo, trattasi di dolo generico consi-stente nella consapevole e volontaria accettazione dell’esercizio della pro-stituzione all’interno del locale.
Il delitto si consuma nel momento in cui si manifesta il requisito dellaabitualità ed il tentativo non sarà configurabile.
8. Reclutamento e agevolazione della prostituzione a fine di reclutamento.
L’art. 3, comma 1°, n. 4, della l. n. 75/1958 punisce chiunque recluti unapersona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine laprostituzione.
Trattasi di reato a fattispecie plurime in quanto sono evidentementedue le condotte contemplate dal legislatore: il reclutamento di una persona
43 Cass. pen., 9.6.1982, in Riv. pen, 1983, 628.44 Osserva al riguardo PIOLETTI, op. cit., 282 che « pertanto, nel caso di una prostituta che si rechi
abitualmente nello stesso albergo con i suoi clienti, qualora le sia consentito l’accesso non si avràtolleranza abituale ma favoreggiamento, e se il prezzo dell’alloggio sarà reiterato per ogni prestazionefornita ai clienti nella stessa giornata concorrerà il delitto di sfruttamento ». Conf. SANTORO, voce« Prostituzione (diritto vigente) », in Noviss. Digesto it., XIV, Torino, Utet, 1967, 231; Contra LA CUTE,voce « Prostituzione (dir. vig.) », cit., 460.
IV, 5Prostituzione e diritto penale
13
al fine di farle esercitare la prostituzione e l’agevolazione di quest’ultima ascopo di reclutamento 45.
Per reclutamento, termine mutuato dal gergo militare, si intende l’atti-vità di colui che ricerca ed ingaggia donne già dedite, o che si voglionodedicare, alla prostituzione, convincendole a svolgere la loro attività pressodeterminati luoghi e sulla base di precise pattuizioni relative tanto alladurata quanto alle modalità di esercizio della prostituzione medesima.
Il reclutamento implica pertanto l’instaurazione di un rapporto di pre-stazione di attività subordinata che, stando ad una certa parte della dottrinae della giurisprudenza, presupporrebbe addirittura l’esistenza di un vero eproprio contratto 46.
Il reato può avere ad oggetto sia persone che già si prostituiscono siapersone non ancora avviate alla prostituzione e non presuppone l’esistenzadi un’organizzazione al cui interno inserire la persona reclutata ciò inquanto l’ipotesi di svolgimento in forma associativa dell’attività di recluta-mento risulta espressamente contemplata dal successivo n. 7 dell’art. 3 dellalegge Merlin.
Si discute in ordine alla necessità o meno, al fine di integrare lafattispecie in esame, che l’agente svolga altresì un’opera di persuasione neiconfronti del soggetto reclutato: lo convinca cioè ad esercitare la prostitu-zione.
Parte della dottrina risponde positivamente al quesito 47, mentre altraparte della dottrina 48 si accontenta di una qualsiasi attività diretta allaricerca della persona disposta a prostituirsi.
Irrilevante, ai fini della sussistenza del reato, sarà invece l’iniziativaassunta dalla persona che poi sarà reclutata 49.
Quanto all’elemento soggettivo trattasi di dolo specifico consistentenella volontà di reclutare per un certo periodo di tempo la persona al finedi esercizio della prostituzione.
Il reato si consuma nel momento in cui avviene il reclutamento senzabisogno che da esso derivi una concreta attività di prostituzione.
Il reato è istantaneo e non si ammette pertanto la configurabilità deltentativo.
45 ANTOLISEI, op. cit., 558.46 Cass. pen., 22.4.1968, (completare con indicazioni CED); LA CUTE, op. cit., 460.47 LA CUTE, op. cit., 461; conf. in giurisprudenza Cass. pen., 9.11.1990, n. 16900, in CED Cass., n.
186080.48 PIOLETTI, voce « Prostituzione », cit., 283; conf. in giurisprudenza Cass. pen., 3.11.1964, (com-
pletare).49 Contra LA CUTE, op. cit., 460.
IV, 5 La disposizione del corpo
14
La seconda fattispecie contemplata dalla norma attiene la condotta diagevolazione.
L’ambigua formulazione della norma ha sollevato un dibattito dottri-nale sul punto: mentre infatti la dottrina prevalente 50 ritiene che il legisla-tore abbia inteso il termine agevolazione nel senso di agevolazione dellaprostituzione di una persona al fine di reclutarla, altra autorevole dottrina 51
sostiene invece che la condotta dell’agevolazione sarebbe analoga a quelladel favoreggiamento ma se ne distinguerebbe in relazione alla diversaqualità dell’oggetto materiale. In altri termini mentre nella condotta diagevolazione ex art. 3, comma 1°, n. 4, della l. n. 75/1958 la condottacriminosa finisce per avere ad oggetto la persona non ancora dedita allaprostituzione, viceversa, nella condotta di favoreggiamento ex art. 3, comma1°, n. 7, della l. n. 75/1958
Sempre in tema di elemento materiale del reato, si osserva che lacondotta di agevolazione « consiste nel procurare, con azioni od omissioni,condizioni favorevoli, appianare difficoltà, togliere ostacoli e comprendenon solo atti positivi, ma anche comportamenti omissivi o tolleranti » 52.
Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà di agevolarel’esercizio della prostituzione con il fine di reclutare la persona ovvero,stando all’opposta tesi dottrinale cui si accennava prima, con il fine di farleesercitare la prostituzione 53.
Il reato è istantaneo e non ammette il tentativo.
9. Induzione alla prostituzione e lenocinio.
L’art. 3, comma 1°, n. 5, della l. n. 75/1958 punisce chiunque induca allaprostituzione una donna di età maggiore, o compia atti di lenocinio, siapersonalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo dellastampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità.
Anche stavolta ci troviamo di fronte a due distinte condotte: l’induzionealla prostituzione da un lato ed il compimento di atti di lenocinio dall’altro.
Per quanto concerne anzitutto l’induzione, si osserva come la norma,parlando di “donna di età maggiore”, circoscrive ingiustificatamente la
50 ANTOLISEI, op. cit., 558; LA CUTE, op. cit., 461.51 MANTOVANI, La nuova disciplina penale della lotta contro lo sfruttamento della prostituzione
altrui, in Riv. it. dir. proc. pen., 1959, 452; SANTORO, voce « Prostituzione (diritto vigente) » cit., 236.52 PIOLETTI, op. loc. citt..53 BONTEMPI, sub art. 3 l. 20 febbraio 1958, n. 75, cit., 5236.
IV, 5Prostituzione e diritto penale
15
punibilità ai soli casi di prostituzione femminile con ciò escludendo per-tanto che il soggetto passivo del reato possa essere un uomo.
In relazione all’età della persona offesa si deve inoltre osservare che,mentre la minore età della vittima dava originariamente luogo all’applica-zione della circostanza aggravante di cui all’art. 4, comma 1°, n. 2 della leggeMerlin, oggi, invece, si configurerà l’ipotesi delittuosa contemplata nell’art.600-bis, comma 1°, cod. pen., come introdotto dalla l. 3 agosto1998, n. 269.
Ciò premesso, veniamo all’analisi dell’elemento materiale del reato ilquale consisterà in qualsiasi attività di persuasione, convincimento, deter-minazione, rafforzamento della decisione della donna sia facendo sorgere inlei per la prima volta l’idea di prostituirsi, sia rafforzandola aggiungendoviulteriori stimoli e motivazioni 54.
Si ritiene inoltre unanimemente che suddetta opera di convincimentodebba avere efficacia causale tale da ritenere che, senza di essa, la donnanon si sarebbe prostituita.
Non si ritiene invece necessario che la donna indotta a prostituirsi nonabbia mai esercitato il meretricio essendo viceversa sufficiente che non lostia praticando nel momento in cui viene svolta l’attività di induzionecolpevole 55.
Mentre in dottrina 56 si ritiene comunemente che l’induzione debbaavere ad oggetto l’attività di prostituzione intesa come stile di vita e non inrelazione ad un singolo rapporto, viceversa più rigorosa al riguardo sipresenta la giurisprudenza 57 laddove ritiene configurabile il delitto diinduzione ex art. 3, comma 1°, n. 5, anche laddove l’attività di persuasionesia stata svolta per superare le resistenze di ordine morale che abbiano poiindotto la donna a prostituirsi anche con una persona soltanto.
Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di indurre unadonna a prostituirsi.
Altro contrasto tra dottrina e giurisprudenza si manifesta in tema dimomento consumativo del reato.
Mentre infatti, ad avviso della dottrina 58, il delitto si consuma conl’inizio dell’attività di prostituzione, viceversa la giurisprudenza 59 ritienesufficiente ad integrare il reato la circostanza che venga posta in essere
54 BONTEMPI, op. cit., 5237; PIOLETTI, voce « Prostituzione », cit., 283.55 BONTEMPI, op. loc. citt.56 LEONE, Delitti di prossenetismo e adescamento, cit., 123.57 Cass. pen., 27.11.1987, in Riv. pen., 1988, 610.58 BONTEMPI, op. cit., 5238; PIOLETTI, op. loc. citt.; LEONE, op. loc. citt.59 Cass. pen., 23.2.1970, (completare).
IV, 5 La disposizione del corpo
16
un’attività diretta a far cessare le resistenze che trattengono la persona dalprostituirsi.
Nessun dubbio in ordine alla configurabilità del tentativo laddove siaderisca alla tesi dottrinale appena menzionata; ciononostante la giuri-sprudenza arriva ad ammettere il tentativo pur individuando il momentoconsumativo nel senso cui prima accennavamo identificandolo ad esempionell’ipotesi in cui si verifichi un solo incontro con il soggetto passivo ciò inquanto l’azione di convincimento non dovrebbe necessariamente sostan-ziarsi in interventi reiterati 60.
La seconda ipotesi delittuosa prevista nell’art. 3, comma 1°, n. 5, dellal. n. 75/1958 è costituita dal divieto di pubblico lenocinio, cioè del compi-mento di atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti alpubblico sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità.
Occorre preliminarmente chiarire il concetto di lenocinio: anche aquesto riguardo si contrappongono infatti due opposti orientamenti dottri-nali e più precisamente un filone più rigoroso che individua una nozionedecisamente ampia di lenocinio inteso come qualsiasi forma di prosseniti-smo diretta alla persuasione od all’incitamento della prostituzione in mododa creare nuovi proseliti o comunque in modo da alimentare il fenomeno 61,in contrapposizione ad una nozione più restrittiva che identifica la nozionedi lenocinio nella semplice attività di collegamento, o di intermediazione,tra la prostituta ed il potenziale cliente che sia compiuta personalmente,cioè a mezzo di comunicazione diretta, in luogo pubblico o aperto alpubblico, oppure indirettamente con il mezzo della stampa 62.
L’attività di intermediazione deve essere caratterizzata dalla pubblicitàdel luogo o del mezzo; ne deriva pertanto che non integrerà la presenteipotesi delittuosa la condotta di colui che fissa telefonicamente gli appun-tamenti per la persona che si prostituisce oppure le procuri i clienti
Inoltre, l’intermediazione deve essere svolta a favore di persone che siprostituiscono individuate ed anche individuabili dai possibili clienti perchéaltrimenti si ricadrebbe in una generica attività di apologia della prostitu-zione 63.
60 BONTEMPI, op. loc. citt.61 PROTETTI-SODANO, Offesa all’onore e al pudore sessuale nella giurisprudenza, Padova, Cedam,
1972.62 PIOLETTI, voce « Prostituzione », cit., 284; LA CUTE, voce « Prostituzione (dir. vig.) », cit., 463.63 Così ad es. Cass. pen., 19.10.2001, n. 44153, in Foro it., 2002, II, 229, ha ritenuto configurabile
la fattispecie delittuosa in commento nel « fatto di chi non si limiti a pubblicizzare, nel territorio italiano,viaggi organizzati in Paesi esteri (nella specie, Thailandia) con generiche prospettive di facili incontrisessuali, ma fornisca le fotografie ed i recapiti telefonici, nel paese di destinazione, delle persone
IV, 5Prostituzione e diritto penale
17
Infine, sempre rimanendo nell’ambito dell’elemento materiale del reato,non è necessario che vi sia un previo accordo con chi si prostituisce né chel’invito venga accolto; sarà invece essenziale un’attività di intermediazioneperché, altrimenti, se l’invito al libertinaggio provenisse dalla stessa personache si prostituisce, si ricadrebbe nell’ipotesi contravvenzionale, peraltrodepenalizzata a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 30 dicembre1999, n. 507 Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzio-natorio, ai sensi dell’articolo 1 della l. 25 giugno 1999, n. 205), contemplatanell’art. 5 della legge Merlin 64.
Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di rivolgerepubblici inviti ad incontri con persone che si prostituiscono ciò in quanto lapubblicità non è condizione obiettiva di punibilità, ma elemento costitutivodel reato 65.
Il delitto si consuma nel momento in cui si conclude l’opera di media-zione o di propaganda ovvero, nel caso di utilizzazione del mezzo dellastampa, con l’inizio della diffusione della stampa medesima o con la suapresa di cognizione da parte anche di un solo destinatario.
Sempre a questo proposito, in considerazione del fatto che la normautilizza il termine “atti”, si discute in dottrina se per integrare l’ipotesidelittuosa in esame sia sufficiente il compimento di un singolo episodio dilenocinio, configurandosi pertanto un reato istantaneo, oppure se sianonecessari più atti dandosi pertanto luogo alla figura del reato permanente oabituale.
La dottrina prevalente 66 propende per la prima delle due soluzioniappena menzionate con la precisazione che il compimento di più atti dilenocinio mantiene unico l’illecito.
Nessun dubbio in ordine alla configurabilità del tentativo: si consideri ades. il caso in cui l’offerta al pubblico della prostituzione altrui venga iniziatama non proseguita perché l’interlocutore rifiuta di stare ad ascoltare,oppure per omessa distribuzione degli stampati cagionata da un disguidopostale o da altro.
(ancorché non compiutamente identificate), indicate come disponibili a prestarsi, dietro pagamento, aisuddetti incontri ».
64 PIOLETTI , op. loc. citt.65 LEONE, Delitti di prossenetismo e adescamento, cit., 144.66 ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, cit., 561; BONTEMPI, sub art. 3 l. 20 febbraio 1958, n. 75, cit.,
5239; LA CUTE, voce « Prostituzione (dir. vig.) » cit., 463; LEONE, op. cit., 145.
IV, 5 La disposizione del corpo
18
10. Induzione a recarsi altrove per esercitare la prostituzione.
L’art. 3, comma 1°, n. 6, della l. n. 75/1958 punisce chiunque induce unapersona a recarsi nel territorio di un altro Stato o, comunque, in luogodiverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi laprostituzione, ovvero si intromette per agevolarne la partenza.
Anche la norma in esame contempla due distinte fattispecie: l’indu-zione di taluno (uomo o donna) a recarsi nel territorio di altro Stato o inluogo diverso da quello della residenza abituale per esercitarvi la prostitu-zione e l’intromissione per agevolarne la partenza.
Essa trova il suo precedente storico nel delitto di tratta contemplatonell’art. 535 del Codice Rocco e con la sua introduzione il legislatore hainteso impedire che, a seguito della chiusura delle “case chiuse” conse-guente all’entrata in vigore della legge Merlin, si potessero aggirarne idivieti tramite il trasferimento della prostituta in luoghi diversi da quelli incui la prostituzione veniva definitivamente proibita.
Nella prima ipotesi (induzione a recarsi altrove per esercitare la pro-stituzione) l’elemento materiale del reato coincide con quello descritto intema di induzione alla prostituzione (ex art. 3, comma 1°, n. 5, con ladifferenza che l’opera di convincimento risulterà finalizzata al trasferimentodella persona nel luogo dove eserciterà la prostituzione senza con ciòindurla in via diretta all’esercizio della prostituzione medesima 67.
Il termine residenza abituale equivale a dimora e si ritiene pertanto indottrina che siano al riguardo irrilevanti le risultanze anagrafiche 68.
Analogamente a quanto avviene per l’induzione alla prostituzione, siritiene necessario che l’opera di convincimento abbia efficacia causale taleda ritenere che, senza di essa, la donna non si sarebbe trasferita altrove.
Nella seconda ipotesi (intromissione per agevolarne la partenza) l’ele-mento materiale del reato potrà ricomprendere tutte quelle condotte (qualiad esempio l’acquisto del biglietto di viaggio, l’accompagnamento al trenoo all’aereo, l’intervento per ottenere il passaporto) che procurano le con-dizioni favorevoli alla partenza secondo il concetto di agevolazione di cuiall’art. 3, comma 1°, n. 4 esaminato in precedenza.
Il dolo è generico e consiste nella volontà di indurre la persona a recarsiin luogo diverso da quello della sua abituale residenza, sia essa interna alloStato o fuori da esso, ovvero nella volontà di agevolarne la partenza con la
67 BONTEMPI, op. cit., 5240.68 ANTOLISEI, op. loc. citt.
IV, 5Prostituzione e diritto penale
19
consapevolezza che tale trasferimento avviene per l’esercizio della prosti-tuzione 69.
Il reato si consuma, quanto alla prima fattispecie, nel momento in cui lapersona si risolve a partire senza che sia necessario che la partenza avvengaeffettivamente 70; viceversa, con riferimento alla seconda ipotesi, quandoviene realizzata la condotta agevolativa finalizzata alla partenza senza chesia necessario, anche in questa ipotesi, che si realizzi in concreto la partenzadi fatto agevolata 71.
Nessun dubbio in ordine alla configurabilità del tentativo e ciò anchenella seconda ipotesi a patto che l’agevolazione consista in più comporta-menti.
Si ritiene che l’ipotesi di cui all’art. 3, comma 1°, n. 6 sia configurabilecome reato unico a fattispecie alternative con la conseguenza che il conte-stuale verificarsi di entrambe le condotte criminose non darà luogo ad unconcorso di reati che potrà viceversa configurarsi in relazione al reato di cuiall’art. 3, comma 8°, della l. n. 39/1990, come modificato dall’art. 12, comma3°, del d.lgs. n. 286/1998 (favoreggiamento all’ingresso clandestino di stra-nieri nel territorio dello Stato).
Ai sensi dell’art. 537 cod. pen. il delitto in esame è punibile anche secommesso all’estero da un cittadino italiano.
11. Attività in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dedite alreclutamento o allo sfruttamento della prostituzione.
L’art. 3, comma 1°, n. 7, della l. n. 75/1958 punisce chiunque esplichiun’attività in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dedite alreclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfrutta-mento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzoagevoli o favorisca l’azione o gli scopi delle predette associazioni odorganizzazioni.
È evidente l’interesse sotteso alla summenzionata ipotesi delittuosa: lanecessità di impedire ogni forma associativa volta al reclutamento o allosfruttamento della prostituzione.
69 PIOLETTI, voce « Prostituzione », cit., 286.70 PIOLETTI, op. loc. citt.; contra Cass. pen., 26.6.1967, in CED Cass., n. 105738, secondo cui « il
reato si consuma con l’arrivo della persona indotta nel luogo designato non con la partenza o larisoluzione alla partenza ».
71 PIOLETTI, op. loc. citt.
IV, 5 La disposizione del corpo
20
Trattasi dunque di una tipica ipotesi di reato associativo in cui vengonopuniti tanto la condotta dell’intraneus ovvero di colui che esplica unaqualsiasi attività all’interno dell’associazione o dell’organizzazione quantoquella dell’extraneus che in qualsiasi modo favorisce o agevola l’azione o gliscopi dell’organizzazione medesima 72 .
Sempre in ordine all’elemento materiale del reato, si osserva in dottrinacome la norma non intenda punire la semplice appartenenza all’associa-zione o all’organizzazione, bensì lo svolgimento, all’interno dell’organizza-zione medesima, di una qualche attività concreta con carattere di abitualitàe di assiduità.
È questo il motivo che ha indotto la dottrina a distinguere la fattispeciein esame dal reato di associazione per delinquere di cui all’art. 416 cod. pen.con il quale potrà pertanto concorrere 73.
Il dolo è generico e consiste nella volontà di esplicare l’attività associa-tiva descritta dalla norma con carattere di abitualità o di porre in essere lecondotte di agevolazione e favoreggiamento, con la consapevolezza dellefinalità dell’associazione od organizzazione 74.
Con riferimento alla condotta dell’intraneus il delitto si consuma nelmomento in cui la stessa condotta si dimostri abituale alla luce dellamolteplicità e continuità dei comportamenti tenuti; con riferimento all’ex-traneus, invece, il delitto si consuma con l’avvenuta agevolazione o favoreg-giamento.
72 BONTEMPI, sub art. 3 l. 20 febbraio 1958, n. 75, cit., 5241.73 Osservano al riguardo MARANI-FRANCESCHETTI , I reati in materia sessuale, in Fatto&Diritto,
collana a cura di CENDON, Milano, Giuffrè, 2006, (p. ?) che « sebbene i termini di organizzazione e diassociazione possano, in linea meramente teorica, coincidere, si afferma che l’elemento materiale delledue tipologie di delitti sia estremamente differente. Mentre per il delitto ex 416 c.p. il fatto costitutivoè rappresentato dal mero associarsi di tre o più persone allo scopo di commettere delitti, quindi senzal’indicazione di una particolare figura delittuosa, il delitto ex art. 3, 2° comma, n. 7 legge 20 febbraio 1958n. 75, si caratterizza per la mancanza di un vero e proprio pactum sceleris, in quanto viene richiesto unvero e proprio apporto collaborativo per l’attuazione delle finalità per le quali l’organizzazione stessa èstata costituita ».
Conforme sul punto la giurisprudenza: cfr. da ultimo Cass. pen., 7.1.2003, n. 21, in CED Cass., n.223024 secondo cui « è possibile il concorso tra il reato di associazione per delinquere finalizzata alcompimento di reati in materia di prostituzione ed il reato di cui all’art. 3, 2° comma, n. 7 della l. 20febbraio 1958 n. 75 […]; e ciò non solo e non tanto perché l’associazione per delinquere abbia comereati-fine anche reati diversi da quelli attinenti alla prostituzione, ma anche e soprattutto perché il citatoart. 3, 2° comma, n. 7 della l. 20 febbraio 1958 n. 75, stando alla sua letterale formulazione, non configuraun vero e proprio reato associativo, ma presuppone piuttosto, l’esistenza di una già costituita organiz-zazione criminosa per quindi individuare come autonome condotte punibili anche quelle che, in unmodo o nell’altro, rechino vantaggio alla medesima organizzazione ».
74 BONTEMPI , sub art. 3 l. 20 febbraio 1958, n. 75, cit., 5241.
IV, 5Prostituzione e diritto penale
21
Ne conseguirà la configurabilità del tentativo soltanto nella secondadelle ipotesi appena menzionate 75.
12. Favoreggiamento della prostituzione.
L’art. 3, comma 1°, n. 8, l. n. 75/1958 punisce chiunque in qualsiasi modofavorisca o sfrutti la prostituzione altrui.
Si tratta della norma di chiusura rispetto alle ipotesi criminose discipli-nate dai numeri precedenti che svolge pertanto la funzione di reprimeretutti quei comportamenti volti a favorire o a sfruttare la prostituzione che,a causa della tecnica legislativa eccessivamente casistica utilizzata dai nn. da1 a 7 dell’art. 3 della legge Merlin, avrebbero potuto sfuggire all’incrimina-zione 76.
Per quanto concerne l’ipotesi di favoreggiamento, l’elemento materialedel reato, potrà concretarsi nei comportamenti più diversi quali ad esempiofissare o ricevere appuntamenti, procurare clienti, fornire la casa, accom-pagnare la prostituta sul luogo di lavoro e così via 77.
Si discute in dottrina in ordine alla necessità o meno che siffatticomportamenti rivestano una decisiva rilevanza causale rispetto al verifi-carsi dell’evento prostituzione; mentre infatti parte della dottrina 78 ritieneche l’attività di favoreggiamento, sia pure in tutte le sue varie sfaccettature,debba porsi quale vera e propria conditio sine qua non rispetto all’eserciziodella prostituzione, viceversa, altra parte della dottrina 79 e la giuri-sprudenza prevalente ritengono che sia sufficiente ad integrare il reato ilsemplice fatto che vengano poste in essere le condizioni più favorevoliperché la prostituzione avvenga.
Presupposto per la configurabilità del reato è che la persona sia giàdedita alla prostituzione 80: da tale considerazione, unita all’osservazioneche prostituirsi non è di per sé reato, deriva la distinzione tra la fattispecie
75 PIOLETTI , voce « Prostituzione », cit., 287; contra LEONE, Delitti di prossenetismo e adescamento,cit., 175, il quale ritiene che il tentativo sia configurabile per entrambe le ipotesi.
76 BONTEMPI , op. cit., 5242.77 ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, cit., 562.78 PAVONCELLO SABATINI, voce « Prostituzione (disposizioni penali in materia di) », in Enc. giur.
Treccani, XXV, Roma, Ed. Enc. It., 1991, (p. ?).79 LA CUTE, voce « Prostituzione (dir. vig.) » cit., 465; LEONE, op. cit., 182; PIOLETTI, op. loc. citt.80 BONTEMPI, op. cit., 5243.
IV, 5 La disposizione del corpo
22
di cui all’art. 3, comma 1°, n. 8, della legge Merlin ed il delitto di favoreg-giamento ex art. 378 cod. pen. 81.
Trattasi di reato eventualmente abituale in quanto per la sua integra-zione sarà sufficiente un solo atto di agevolazione 82.
Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà dell’agente diagevolare, con il suo comportamento, la prostituzione altrui senza cheacquisti efficacia rilevante al riguardo lo scopo di lucro o il fine di servirel’altrui libidine.
Il delitto si consuma nel momento in cui sono poste in essere lecondizioni favorevoli per l’esercizio della prostituzione, mentre irrilevantesarà l’effettivo compimento di atti di prostituzione 83.
Nessun dubbio in ordine alla configurabilità del tentativo che si realiz-zerà tutte le volte in cui la condotta favoreggiatrice non sia portata acompimento per cause estranee alla volontà del colpevole 84.
13. Sfruttamento della prostituzione.
Veniamo quindi alla seconda ipotesi delittuosa prevista dall’art. 3,comma 1°, n. 8, della legge Merlin ovvero quella di chiunque, in qualsiasimodo, sfrutti la prostituzione altrui.
Occorre anzitutto premettere che lo sfruttamento della prostituzionenon era contemplato dal Codice Zanardelli ma è stato introdotto nel nostroordinamento soltanto con il Codice Rocco del 1930 il cui l’art. 534 puniva« chiunque si fa mantenere, anche in parte, da una donna, sfruttando iguadagni che essa ricava dalla sua prostituzione ».
L’art. 534 cod. pen. è stato abrogato dalla legge Merlin e sostituito conla più ampia formulazione contenuta nell’art. 3, comma 1°, n. 8, il quale,come dicevamo, punisce la condotta di chiunque sfrutti la prostituzionealtrui.
Ciò ha determinato un ampliamento dell’ambito di punibilità e solle-vato pertanto un dibattito in seno a dottrina e giurisprudenza: la giuri-
81 Osserva infatti ANTOLISEI, op. loc. citt., che il concetto di favoreggiamento di cui all’art. 378 cod.pen. presuppone la commissione di un reato.
82 PIOLETTI, op. cit., 288; conf. sul punto la prevalente giurisprudenza, vd. infra par. 13; contra, LA
CUTE, op. loc. citt. e MANTOVANI, La nuova disciplina penale della lotta contro lo sfruttamento dellaprostituzione altrui, cit., 465 che parlano invece di reato necessariamente abituale.
83 BONTEMPI, sub art. 3 l. 20 febbraio 1958, n. 75, cit., 5244.84 PIOLETTI, voce « Prostituzione », cit., 288.
IV, 5Prostituzione e diritto penale
23
sprudenza prevalente 85 si è infatti orientata a considerare la fattispecie inesame quale reato istantaneo o eventualmente abituale, in cui cioè si ritienesufficiente ad integrare il reato anche un solo episodio di ricezione didenaro o altra utilità economica naturalmente accompagnato dalla consa-pevolezza che si tratta di denaro proveniente dalla prostituzione altrui esenza pertanto che si ritenga necessario che lo sfruttatore tragga da ciò, invia prevalente, i suoi mezzi di sussistenza .
Viceversa secondo l’orientamento dottrinale prevalente 86, ma minori-tario in giurisprudenza 87, l’art. 3, comma 1°, n. 8, della legge Merlin avrebbeintrodotto un reato necessariamente abituale per la cui integrazione sirichiederebbe un vero e proprio stile di vita parassitario contrassegnatodalla continuità e persistenza della condotta dello sfruttatore il quale da ciòtragga i mezzi necessari per vivere.
Per quanto concerne il coniuge o il convivente della prostituta, eglirisponderà di sfruttamento qualora, pur non svolgendo alcuna attivitàlavorativa che lo giustifichi, mantenga un tenore di vita al di sopra delle suepossibilità 88.
Viceversa, non risponderà del delitto il coniuge che, versando in stato dibisogno, riceva dalla moglie, a titolo di alimenti, i proventi della suaprostituzione, ciò in quanto opererebbe in questo caso la causa di giustifi-cazione prevista dall’art. 51 cod. pen. 89.
Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di sfruttare l’altruiprostituzione con la consapevolezza della provenienza del denaro 90.
Il momento consumativo del reato varierà in relazione alla circostanzache si aderisca alla tesi del reato eventualmente abituale o piuttosto a quelladel reato necessariamente abituale: nel primo caso, il delitto si consuma nelmomento in cui l’agente percepisce i proventi dalla persona che si prosti-
85 Cfr. tra le altre Cass. pen., 11.12.1998, n. 12919, in CED Cass., n. 212362; Cass. pen., 4.5.1984,in Riv. pen. 1985, 607; Cass. pen., 17.2.1982, in Riv. pen. 1983, 229.
86 ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, cit., 563; LA CUTE, voce « Prostituzione (dir. vig.) » cit.,467; LEONE, Delitti di prossenetismo e adescamento, cit., 208; MANTOVANI, La nuova disciplina penale dellalotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui, cit., 468; PAVONCELLO SABATINI, voce « Prostituzione(disposizioni penali in materia di) », cit., 13.
87 Cass. pen., 16.1.1960, in Riv. it. dir. proc. pen., 1960, 978.88 Cass. pen., 26.11.1982, in Cass. pen., 1984, 412.89 LEONE, op. cit., 220; contra la giurisprudenza prevalente che esclude che il dovere di reciproca
assistenza dei coniugi possa collegarsi ad un rapporto penalmente illecito: si vd., tra le altre, Cass. pen.,21.5.1985, in Riv. pen., 1986, 741; Cass. pen., 21.4.1980, in Riv. pen., 1980, 986.
90 Cass. pen., 26.11.1982, in Cass. pen., 1984, 412; contra Cass. pen., 12.6.1975, in CED Cass., n.133371, secondo cui si richiederebbe il dolo specifico consistente nella volontà di trarre vantaggioeconomico dalla prostituzione, mediante partecipazione, totale o parziale, ai guadagni della prostituta.
IV, 5 La disposizione del corpo
24
tuisce, nel secondo caso, non appena si manifesta il requisito dell’abitua-lità 91.
Di conseguenza i fautori della prima tesi riterranno configurabile iltentativo, a differenza dei fautori della seconda.
14. Circostanze aggravanti.
L’art. 4 della l. n. 75/1958 stabilisce che la pena è raddoppiata: 1) se ilfatto è commesso con violenza, minaccia, inganno; 2) se il fatto è commessoai danni di [persona minore degli anni 21 o] 92 di persona in istato diinfermità o minorazione psichica, naturale o provocata; 3) se il colpevole èun ascendente, un affine in linea retta ascendente, il marito, il fratello, o lasorella, il padre o la madre adottivi, il tutore; 4) se al colpevole la personaè stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza,di custodia; 5) se il fatto è commesso ai danni di persone aventi rapporti diservizio domestico o d’impiego; 6) se il fatto è commesso da pubbliciufficiali nell’esercizio delle loro funzioni; 7) se il fatto è commesso ai dannidi più persone; 7-bis) se il fatto è commesso ai danni di una personatossicodipendente.
La norma contempla dunque otto circostanze aggravanti ad effettospeciale, in presenza delle quali la pena è raddoppiata.
Esse concernono la qualità del soggetto attivo (congiunto della vittima:n. 3; suo affidatario: n. 4; pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni:n. 6);
la qualità od il numero delle vittime (persona in stato di infermità ominorazione psichica: n. 2; persona in rapporto di servizio domestico o diimpiego: n. 5; fatto commesso ai danni di più persone: n. 7; fatto commessoai danni di persona tossicodipendente: n. 7-bis);
le modalità della condotta (fatto commesso con violenza, minaccia oinganno: n. 1).
Occorre precisare che l’aggravante del fatto commesso ai danni dipersona minore è stata espressamente abrogata a seguito dell’entrata invigore della l. n. 269/1998 che ha introdotto la fattispecie delittuosa diprostituzione minorile di cui all’art. 600-bis del cod. pen.
Principalmente due sono le questioni interpretative che si sono poste indottrina relativamente alla norma in esame.
91 BONTEMPI, sub art. 3 l. 20 febbraio 1958, n. 75, cit., 5249.92 Le parole tra parentesi sono state soppresse dall’art. 18, l. n. 269/1998.
IV, 5Prostituzione e diritto penale
25
Così anzitutto si è posto il quesito se le ipotesi ivi contemplate debbanoconfigurarsi come vere e proprie circostanze aggravanti oppure se, perlo-meno con riguardo ad alcune di esse, si possa parlare di autonome fattispeciedelittuose analoghe alle corrispondenti figure del Codice Rocco, abrogate aseguito dell’entrata in vigore della legge Merlin: ci si riferisce in particolareal delitto di costrizione alla prostituzione (ex art. 533 cod. pen. abrogato); aldelitto di lenocinio familiare (ex art. 532 cod. pen. abrogato) ed infineall’ipotesi di induzione alla prostituzione di minori e incapaci (ex art. 531cod. pen. abrogato).
La dottrina prevalente propende per la prima delle due soluzioni testémenzionate: in altri termini le ipotesi contemplate nell’art. 4 della leggeMerlin sarebbero tutte circostanze aggravanti applicabili, salvo casi specificidi incompatibilità, a tutte le ipotesi criminose contemplate nel precedenteart. 3 93.
La seconda questione dibattuta in dottrina concerne il problema rela-tivo all’ammissibilità del concorso di circostanze: si pone cioè il problema distabilire se il plurimo verificarsi delle circostanze contemplate nell’art 4della l. n. 75/1958 dia luogo ad un solo aumento di pena oppure alraddoppio di pena per ogni singola aggravante contestata.
La dottrina e la giurisprudenza prevalenti, pur riconoscendo che iconseguenti aumenti di pena raggiungerebbero livelli “impressionanti” 94 edauspicando pertanto una riforma legislativa sul punto, propendono perl’ammissibilità del concorso di circostanze eventualmente attenuato dalgiudizio di comparazione delle circostanze per il tramite del quale ilmagistrato potrà in molti casi temperarne le asprezze 95.
Occorre tuttavia rilevare che la questione, forse più teorica che pratica,non è mai concretamente affiorata in giurisprudenza e ciò sia per l’alter-natività di alcune circostanze e la specialità di altre 96, sia per l’inapplica-
93 BONTEMPI, op. cit., 5254; PIOLETTI, voce « Prostituzione », cit., 290; PROTETTI-SODANO, Offesaall’onore e al pudore sessuale nella giurisprudenza, cit., 342.
94 Osserva ad es. VASSALLI, Le norme penali a più fattispecie e l’interpretazione della legge Merlin,cit., 418 come il limite del triplo del massimo della pena di cui all’art. 66 cod. pen., pari, con riferimentoalle ipotesi delittuose contemplate nell’art. 3 della legge Merlin, a diciotto anni, potrebbe venireraggiunto e superato per effetto del verificarsi di due sole delle aggravanti contemplate nell’art. 4 dellal. n. 75/1958.
95 ANTOLISEI , Manuale di diritto penale, cit., 57096 Così ad es. osserva BONTEMPI, op. cit., 5255, che necessariamente alternative poiché legate ad
un rapporto di specialità dovranno considerarsi le circostanze contemplate ai nn. 3 e 4 dell’art. 4 dellalegge Merlin; analogo discorso per le circostanze contemplate ai nn. 4 e 5 che implicherebbero unamedesima situazione di affidamento sia pure motivato da cause diverse; ed, infine, alternative dovrannoconsiderarsi le circostanze di cui ai nn. 2 e 7-bis in quanto entrambe darebbero rilievo a situazioni diminorata difesa.
IV, 5 La disposizione del corpo
26
bilità di talune circostanze a singole figure delittuose 97 ed, infine, per ilgiudizio di bilanciamento equamente applicato di volta in volta dal giu-dice 98.
15. Le singole aggravanti speciali.
Veniamo quindi all’analisi delle singole aggravanti speciali contemplatenell’art. 4 della l. n. 75/1958:
a) aver commesso il fatto con violenza, minaccia o inganno (art. 4,comma 1°, n. 1).
Per quanto anzitutto concerne le nozioni di violenza, minaccia o in-ganno non si potrà che rimandare ai relativi concetti generali di elabora-zione penalistica.
Vediamo invece di chiarire il problema dei rapporti tra la circostanza inesame e le fattispecie delittuose contemplate nell’art. 3 della legge Merlin.
In dottrina si è affermata la sua incompatibilità con il reato di locazionedi locale per l’esercizio di casa di prostituzione (art. 3, comma 1°, n. 2) e conil reato di tolleranza abituale dell’esercizio della prostituzione (art. 3,comma 1°, n. 3) in conseguenza della natura omissiva di quest’ultimo 99.
Sicuramente compatibile con l’aggravante in questione sarà invece ildelitto di reclutamento a fini di prostituzione (art. 3, comma 1°, n. 4) ciò inquanto nulla esclude che l’ingaggio della prostituta possa avvenire in modoviolento o minaccioso 100: viceversa solo l’inganno e non quindi la violenzae la minaccia potrà ritenersi compatibile con il pubblico lenocinio (art. 3,
97 Osserva sempre BONTEMPI, op. loc. citt., che la circostanza di cui al n. 1 dell’art. 4, legge Merlin,si trova senza dubbio in una situazione di incompatibilità logica con i reati contemplati dall’art. 3,comma 1°, n. 1, dall’art. 3, comma 1°, n. 2 ed infine dall’art. 3, comma 1°, n. 3 della l. n. 75/1958. Cosìcome logicamente incompatibile con i reati di esercizio di casa di prostituzione, di tratta, di favoreg-giamento o sfruttamento della prostituzione, dovrà ritenersi l’aggravante contemplata nell’art. 4, comma1°, n. 7.
98 PIOLETTI, op. cit., 290. Osserva al riguardo ANTOLISEI, op. loc. citt., che tale giudizio dibilanciamento è ora comunque imposto dopo la riforma dell’art. 69, comma 4°, cod. pen. intervenuta pereffetto dell’art. 6 della l. 7 giugno 1974, n. 220 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge11 aprile 1974, n. 99, concernente provvedimenti urgenti sulla giustizia penale).
99 BONTEMPI, sub art. 3 l. 20 febbraio 1958, n. 75, cit., 5256; LEONE, Delitti di prossenetismo eadescamento, cit., 269, lo ritiene altresì incompatibile con il delitto di proprietà ed esercizio di casa diprostituzione (art. 3, comma 1°, n. 1) ciò in quanto l’uso della violenza, minaccia o inganno non attieneall’azione propria del reato ma ne rimane autonoma e dà vita ad un autonomo reato che concorrerà conil primo.
100 LA CUTE, voce « Prostituzione (dir. vig.) », cit., 471.
IV, 5Prostituzione e diritto penale
27
comma 1°, n. 5) poiché la violenza e la minaccia sono in contraddizione conla pubblicità del fatto.
Infine, con riferimento al delitto di favoreggiamento della prostituzione(art. 3, comma 1°, n. 8), si è sostenuto che esso sarà compatibile soltanto conla violenza generica, viceversa laddove la violenza degeneri in lesioni si daràluogo al concorso tra l’art. 3, comma 1°, n. 8 della l. n. 75/1958 e l’art. 582cod. pen. 101.
Si ritiene generalmente ammessa la costituzione di parte civile poiché lafattispecie aggravata, oltre che lesiva della moralità pubblica e del buoncostume, recherà altresì pregiudizio al bene giuridico della libertà indivi-duale.
b) aver commesso il fatto ai danni di persona in stato di infermità ominorazione psichica, naturale o provocata (art. 4, comma 1°, n. 2).
Abbiamo già accennato alla incompatibilità dell’aggravante in que-stione con quella prevista dal successivo n. 7-bis: in entrambi i casi siprevede infatti una situazione di minorata difesa.
Si ritiene inoltre che il grado di infermità psichica che dovrà venire inconsiderazione ai fini dell’applicazione dell’aggravante dovrà corrisponderealmeno al vizio parziale di mente di cui all’art. 89 cod. pen. 102
Incompatibile con l’aggravante in esame dovranno ritenersi inoltre leipotesi delittuose contemplate ai nn. 1, 2 e 3 dell’art. 3 della l. n. 75/1958 ciòin quanto tali reati non sono commessi ai danni delle persone che siprostituiscono 103.
c) fatto commesso dall’ascendente, affine in linea retta ascendente,marito, fratello, sorella, padre e madre adottivi, tutore (art. 4, comma 1°, n.3).
È questa l’aggravante del c.d. lenocinio familiare un tempo contemplatadal Codice Rocco come autonoma figura delittuosa all’art. 532 cod. pen.
L’elencazione contenuta nella norma deve ritenersi tassativa con laconseguenza che non potranno in essa ricomprendersi tutti quei rapportifamiliari o di parentela non previsti dalla stessa.
La norma prevede l’aggravante per il fatto commesso dal marito e nondal coniuge, sicché non sarà applicabile alla moglie che agisca nei confrontidel marito 104.
101 LA CUTE, op. cit., 470.102 BONTEMPI , op. loc. citt.; LA CUTE, op. cit., 471.103 PIOLETTI, voce « Prostituzione », cit., 291; BONTEMPI , op. loc. citt.104 La relativa questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta non fondata da Corte cost.,
27.11.1974, n. 266, in Giust. pen, 1975, I, 39, in quanto proposta in un processo a carico di imputato disesso maschile.
IV, 5 La disposizione del corpo
28
d) fatto commesso da persona alla quale la vittima sia stata affidata perragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia (art. 4, comma1°, n. 4).
Trattasi, anche in questo caso, di trasposizione in forma di aggravantedi una fattispecie che, sotto la vigenza del Codice Rocco, era contemplataquale autonoma figura delittuosa all’art. 531 cod. pen.
L’aggravante in esame ha carattere soggettivo in quanto riguarda irapporti tra il colpevole e l’offeso; non è necessario che il reato siacommesso a causa dell’affidamento o approfittando di esso, mentre saràsufficiente che si verifichi in costanza di esso 105; non potrà concorrere conl’aggravante di cui all’art. 61, n. 11, cod. pen., in quanto si configura specialerispetto ad essa 106.
e) fatto commesso ai danni di persone aventi rapporti di serviziodomestico o d’impiego (art. 4, comma 1°, n. 5).
L’inasprimento della pena trova in questo caso giustificazione nellaparticolare condizione di dipendenza, di assoggettamento, di subordina-zione del soggetto passivo ed ha il suo antecedente normativo nella previ-sione (abrogata) dell’art. 531 cpv. del Codice Rocco.
Essa ha natura soggettiva in quanto è configurabile soltanto in presenzadi un effettivo rapporto di impiego o servizio 107 e si configura anch’essaspeciale rispetto all’aggravante comune di cui all’art. 61 n. 11.
Viene in considerazione esclusivamente il rapporto di impiego di naturaprivata in quanto, in presenza di un pubblico ufficiale, troverà applicazionel’aggravante di cui all’art. 4, comma 1°, n. 6.
f) fatto commesso da pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni(art. 4, comma 1°, n. 6).
Anche questa circostanza ha natura soggettiva e si applica allorquandoricorre un nesso, anche soltanto occasionale, tra il fatto e l’esercizio difunzioni pubbliche, mentre viceversa non occorrerà l’abuso di tali funzionirichiesto dall’art. 61, n. 9, cod. pen. 108.
g) fatto commesso ai danni di più persone (art. 4, comma 1°, n. 7).Non sarà compatibile con le ipotesi delittuose in cui la pluralità di
persone viene in considerazione sia come elemento essenziale del reato checome circostanza del medesimo [ad es. il delitto di cui all’art. 3, comma 1°,
105 BONTEMPI, sub art. 3 l. 20 febbraio 1958, n. 75, cit., 5257; LEONE, Delitti di prossenetismo eadescamento, cit., 297.
106 PIOLETTI, voce « Prostituzione », cit., 292.107 PIOLETTI, op. loc. citt.108 PIOLETTI, op. loc. citt.
IV, 5Prostituzione e diritto penale
29
n. 3 della l. n. 75/1958 (tolleranza abituale dell’esercizio della prostitu-zione)] 109.
Viceversa, la circostanza in esame è stata ritenuta compatibile con ildelitto di proprietà o esercizio di una casa di prostituzione 110 e con il delittodi lenocinio a mezzo stampa 111.
h) fatto commesso ai danni di persona tossicodipendente (art. 4, comma1°, n. 7-bis).
La circostanza in esame è stata introdotta dall’art. 32 della l. n. 27giugno 1990, n. 162 Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psico-trope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipen-denza) e la ratio ad essa sottesa è facilmente comprensibile: ovvero l’esi-genza di impedire che il bisogno di droga induca il soggetto a venderel’ultimo dei beni che ancora gli rimangono: il proprio corpo 112.
16. Invito al libertinaggio e adescamento.
L’art. 5 della l. n. 75/1958 113 contempla due fattispecie contravvenzio-nali oggi depenalizzate a seguito delle modifiche apportate dall’art. 81,comma 1°, del d.lgs. n. 507/1999, il quale ha sostituito l’originaria sanzionedell’arresto fino ad otto giorni cumulato alla sanzione pecuniaria, con lasanzione amministrativa da euro 15 ad euro 92.
La condotta tipica prevista dalla norma prevede due distinte ipotesi:l’invito al libertinaggio eseguito in modo scandaloso o molesto e l’adesca-mento attuato inseguendo le persone per la pubblica via ed invitandole allibertinaggio con atti o parole.
Occorre dunque anzitutto chiarire la nozione di invito che compare in
109 BONTEMPI, op. cit., 5258; conf. sul punto Cass. pen., 10.11.1970, in Giust. pen., 1971, II, 620.110 Cass. pen., 23.11.1967, in CED Cass., n. 106626; contra, in dottrina, PIOLETTI, op. loc. citt.111 Cass. pen., 16.10.1979, in CED Cass., n.144709.112 PIOLETTI, op. loc. citt.113 Art. 5: « Sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da E 15 a E 92 le persone
dell’uno e dell’altro sesso:1) che in luogo pubblico o aperto al pubblico, invitano al libertinaggio in modo scandaloso o
molesto;2) che seguono per via le persone, invitandole con atti o parole al libertinaggio.Le persone colte
in contravvenzione alle disposizioni di cui ai numeri 1 e 2, qualora siano in possesso di regolaridocumenti di identificazione, non possono essere accompagnate all’ufficio di pubblica sicurezza.Lepersone accompagnate all’Ufficio di pubblica sicurezza per infrazioni alle disposizioni della presentelegge non possono essere sottoposte a visita sanitaria. [omissis] ».
IV, 5 La disposizione del corpo
30
entrambe le ipotesi delittuose: esso dovrà intendersi come qualunqueproposta che consista nell’offerta di prestazioni sessuali dietro pagamentoindirizzata direttamente ed inequivocabilmente ad una persona determi-nata 114.
Le modalità di realizzazione del reato saranno, in relazione alla primaipotesi delittuosa, anzitutto la circostanza che l’invito al libertinaggio siesplichi in luogo pubblico o aperto al pubblico e, in secondo luogo, ilcarattere scandaloso o molesto dell’invito.
L’invito sarà scandaloso non tanto per il genere di mercato proposto,quanto piuttosto per le modalità che accompagnano l’invito stesso il qualedovrà contenere un richiamo immediato all’atto sessuale e, in quanto tale,idoneo ad offendere il comune sentimento del pudore dei consociati 115.
L’invito sarà invece molesto quando, in quanto insistente e pressante,sia atto a creare disagio e fastidio alla persona cui viene rivolto 116.
Viceversa in relazione alla seconda ipotesi delittuosa, ovvero l’adesca-mento, essa consisterà nell’inseguire le persone per la strada invitandolecon atti o parole al libertinaggio.
Soggetti attivi in entrambe le ipotesi saranno le persone dell’uno odell’altro sesso dedite alla prostituzione: trattasi pertanto di reato pro-prio 117.
Si tratta di una contravvenzione specificatamente dolosa che si con-suma, con riferimento alla prima ipotesi, nel momento della percezione, daparte dell’interessato, della modalità scandalosa o molesta dell’invito; nelsecondo caso, allorquando una o più persone siano inseguite per la pubblicavia e siano a loro rivolti gli inviti al libertinaggio 118.
114 MELOTTI, Prostituzione: dalla legge Merlin alle recenti proposte de iure condendo, Tesi didottorato di ricerca in Diritto Penale, Facoltà di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Parma,XX° Ciclo, Coordinatore Prof. A. Cadoppi, 70.
115 PIOLETTI, voce « Prostituzione », cit., 293; sulla nozione di “comune sentimento del pudore”quale elemento normativo extragiuridico della fattispecie penale si vd. FIANDACA-MUSCO, Diritto Penale,parte generale, Bologna, Zanichelli, 1995, III ed., 71.
116 PIOLETTI, op. loc. citt. Si vd. inoltre Cass. pen., 7.7.1959, in Giust. pen. 1960, II, 439, secondo cuinon costituisce reato la profferta di relazione carnale fatta in modo non scandaloso né molesto, anche sein una pubblica via; nonché Cass. pen., 29.11.1962, in CED Cass., n. 98927 secondo cui « per scandalosi deve intendere una manifestazione impudente percepibile da terzi, sì che nessuno scandalo puòravvisarsi nella riservata contrattazione tra una prostituta ed il cliente ».
117 LA CUTE, voce « Prostituzione (dir. vig.) », cit., 474 il quale rileva che la circostanza secondocui il reato potrà essere commesso soltanto da persone dedite alla prostituzione troverebbe il suofondamento sia nella disciplina delle conseguenze, anche amministrative, previste nella norma in esameper le persone che si prostituiscono, sia nel rapporto di specialità che è dato riscontrare tra la norma inquestione e la fattispecie contravvenzionale prevista dall’art. 660 cod. pen. (molestia o disturbo allepersone) relativamente alla quale è prevista una pena più elevata.
118 BONTEMPI, sub art. 3 l. 20 febbraio 1958, n. 75, cit., 5260.
IV, 5Prostituzione e diritto penale
31
17. Misure di sicurezza.
A norma dell’art. 538 cod. pen.: « Alla condanna per il delitto preve-duto dall’art. 531 può essere aggiunta una misura di sicurezza detentiva. Lamisura di sicurezza detentiva è sempre aggiunta nei casi preveduti dagliarticoli 532, 533, 534, 535 e 536 ».
Si ritiene che la disposizione in esame, in quanto fatta salva dall’abro-gazione effettuata dall’art. 3 della legge Merlin, sia ancora in vigore.
Ne deriva pertanto che alla consumazione di una delle ipotesi delittuosecontemplate ai nn. da 1 a 8 dell’art. 3 della l. n. 75/1958 dovrà conseguire exlege l’applicazione della misura di sicurezza detentiva; viceversa siffattamisura non sarà applicabile in caso di condanna per delitto tentato 119.
Relativamente alla costituzionalità della norma in questione sono statesollevate due questioni di legittimità entrambe respinte: così anzitutto laprima questione di legittimità costituzionale dell’art. 538 cod. pen. inrelazione all’art. 25 della Costituzione è stata dichiarata manifestamenteinfondata dal momento che si è ritenuto che la sopravvivenza della misuradi sicurezza in esame non contrasta con alcun precetto costituzionale ciò inquanto è materia riservata al legislatore la determinazione e la disciplinadelle pene e delle misure di sicurezza da applicare 120.
La seconda questione di legittimità costituzionale sollevata con riferi-mento all’obbligatorietà dell’applicazione della misura ed al suo presuntocontrasto con gli artt. 27, 25 e 3 della Costituzione è stata anch’essa rispeditaal mittente alla luce dell’intervenuta abrogazione dell’art. 204 del cod. pen.che ha avuto la conseguenza di abrogare la c.d. presunzione di pericolositàe di ritenere pertanto che le misure di sicurezza detentive possano essereapplicate solo allorquando venga in concreto accertato che il soggetto attivoè persona socialmente pericolosa 121.
18. Pene accessorie.
L’art. 6 della l. n. 75/1958 prevede la pena accessoria dell’interdizionedai pubblici uffici (art. 28 cod. pen.) per un periodo variante da un minimodi due anni ad un massimo di venti a partire dal giorno in cui avrannoespiato la pena, nei confronti dei soggetti che siano ritenuti colpevoli di
119 Cass. pen., 2.4.1984, n. 6218, in Giust. pen., 1985, II, 328.120 Cass. pen., 2.10.1984, in Monitore dei pretori , 1984, 166.900.121 Cass. pen., 15.5.1987, n. 7618, in Monitore dei pretori , 1984, 176.220.
IV, 5 La disposizione del corpo
32
taluno dei delitti, siano essi consumati o tentati, previsti dalla legge mede-sima.
La norma in esame, stabilendo che l’interdizione temporanea daipubblici uffici consegue ad ogni condanna in materia di prostituzione, anchese a livello di tentativo, costituisce una deroga ai principi contenuti nell’art.29 cod. pen. a norma del quale, viceversa, l’interdizione perpetua daipubblici uffici consegue alle condanne per un tempo non inferiore a cinqueanni, mentre l’interdizione temporanea ai casi di condanna per un periodonon inferiore a tre anni.
Essa attribuisce inoltre un’ampia discrezionalità al Giudice nella deter-minazione della durata della pena accessoria (da due a vent’anni) con ciòderogando altresì alle disposizioni contenute nell’art. 37 cod. pen. a normadel quale, quando la durata della pena accessoria non è espressamentestabilita dalla legge, essa avrà durata identica a quella della pena principaleinflitta.
Numerose sono inoltre le perplessità sollevate dalla dottrina al ri-guardo:
così anzitutto se ne è affermata la superfluità rispetto all’interdizionedai pubblici uffici e dall’esercizio della tutela e curatela già espressamentepreviste dall’art. 28 cod. pen.; in secondo luogo, si è osservato come lanorma stabilisca un trattamento sanzionatorio molto meno severo per icondannati per i delitti in materia di prostituzione non potendosi applicarenei loro confronti, in caso di condanna non inferiore a cinque anni,l’interdizione perpetua prevista dall’art. 29 cod. pen. 122.
Infine, si è criticata la mancata previsione, da parte della norma, dellaperdita della potestà dei genitori sui figli e della perdita del diritto aglialimenti e dei diritti successori verso le persone offese che viceversa eranocontemplati nell’art. 541 (abrogato) del Codice Rocco 123.
Bibliografia
F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, parte speciale, I, Milano, Giuffrè, 2002, XIV ed.(?) Bontempi, sub art. 3 l. 20 febbraio 1958, n. 75, in Codice penale commentato, parte speciale, a cura
di E. DOLCINI-G. MARINUCCI, Milano, Ipsoa, 1999.
122 BONTEMPI, sub art. 3 l. 20 febbraio 1958, n. 75, cit., 5261.123 Dottrina e giurisprudenza prevalenti hanno tuttavia ritenuto applicabile l’art. 541 cod. pen.
(ora abrogato a seguito dell’entrata in vigore della l. 15 febbraio 1996, n. 66 in tema di reati sessuali)anche ai delitti in tema di prostituzione: cfr. LA CUTE, voce « Prostituzione (dir. vig.) », cit., 476; PIOLETTI,voce « Prostituzione », cit., 295.
IV, 5Prostituzione e diritto penale
33
A. CADOPPI, sub art. 3 l. 15 febbraio 1996 n. 66, in ID. (a cura di), Commentari delle norme contro laviolenza sessuale e della legge contro la pedofilia, Padova, Cedam, 2002, III ed.
A.A. CALVI, Sfruttamento della prostituzione, Padova, Cedam, 1970.G. FIANDACA, voce « Violenza sessuale », in Enc. dir., Agg. IV, Milano, Giuffrè, 2000.G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale, parte generale, Bologna, Zanichelli, 1995, III ed.G. LA CUTE, voce « Prostituzione (dir. vig.) », in Enc. dir., XXXVII, Milano, Giuffrè, 1989.F. LEONE, Delitti di prossenetismo ed adescamento, Milano, Giuffrè, 1964.F. MANTOVANI, La nuova disciplina penale della lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui, in
Riv. it. dir. proc. pen., 1959, 459.S. MARANI-P. FRANCESCHETTI, I reati in materia sessuale, in Fatto&Diritto, collana a cura di P. CENDON,
Milano, Giuffrè, 2006.S. MELOTTI, Prostituzione: dalla legge Merlin alle recenti proposte de iure condendo, Tesi di dottorato di
ricerca in Diritto Penale, Facoltà di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Parma, XX°Ciclo, Coordinatore Prof. A. Cadoppi.
L. PAVONCELLO SABATINI, voce « Prostituzione (disposizioni penali in materia di) », in Enc. giur. Treccani,XXV, Roma, Ed. Enc. it., 1991.
G. PIOLETTI, voce « Prostituzione », in Digesto IV ed., Disc. pen., X, Torino, Utet, 1995.D. POTETTI, La casa di prostituzione e l’esercizio in comune del meretricio, in Cass. pen., 2001, 640.E. PROTETTI-A. SODANO, Offesa all’onore e al pudore sessuale nella giurisprudenza, Padova, Cedam, 1972.A. SANTORO, voce « Prostituzione (diritto vigente) », in Noviss. Digesto it., XIV, Torino, Utet, 1967.G. VASSALLI , Le norme penali a più fattispecie e l’interpretazione della legge Merlin, in Studi in onore di
Francesco Antolisei , III, Milano, Giuffrè, 1960 -5.S. VINCIGUERRA, Principi di criminologia, Padova, Cedam, 2005, II ed.
IV, 5 La disposizione del corpo
34