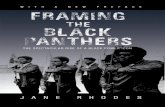Promoting mammography: Framing effect and salience of information
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
6 -
download
0
Transcript of Promoting mammography: Framing effect and salience of information
PSICOLOGIA SOCIALE n. 2, maggio-agosto 2006 355
Promuovere l’adesione alla mammografia: effetti di frame e salienza delle informazioni Lorella Lotto, Alessandra Tasso, Andrea Carnaghi e Rino Rumiati
Nonostante la mammografia sia attualmente con-siderata la tecnica più efficace per l’individuazione precoce del carcinoma mammario, il suo utilizzo rimane ancora sottostimato. Al fine di promuovere l’adesione a questo metodo di indagine, il presente studio ha confrontato l’efficacia persuasiva di due differenti messaggi in un campione di donne tra i 38 e i 69 anni di età. È stata studiata la relazio-ne tra frame (messaggi di guadagno vs. messaggi di perdita) e salienza delle informazioni, in fun-zione della rilevanza personale. I risultati relativi all’atteggiamento e all’intenzione comportamen-tale hanno mostrato che i messaggi formulati con frame di perdita sono più efficaci nella condizione di alta salienza, mentre i messaggi formulati con frame di guadagno sono più efficaci nella condizio-ne di bassa salienza. La rilevanza personale non ha mostrato alcun effetto significativo.
Il presente lavoro intende fornire un contributo allo studio della co-municazione persuasiva di messaggi che promuovono comportamenti di prevenzione della salute personale, e in particolare della prevenzione del tumore al seno. Le ragioni che hanno guidato il presente lavoro di ricerca sono di due tipi, una prati-co-applicativa e una più puramente teorica.
L’importanza del primo aspetto, quello pratico-applicativo, non può essere trascurato se si considera che le attuali conoscenze sull’eziologia del carcinoma mammario non con-sentono di mettere in atto interventi di prevenzione primaria: i fattori di
rischio conosciuti spiegano infatti meno del 30% delle differenze di incidenza che si riscontrano nelle varie popolazioni, mentre è stata dimostrata l’efficacia della preven-zione secondaria, quale lo screening mammografico.
La mammografia è l’indagine strumentale più indicata nello screening dei tumori al seno perché permette al medico di diagnosticare neoplasie della mammella anche in fase molto precoce, quando il loro trattamento consente la guarigione o, se non altro, permette di ridurre l’aggressività delle cure e degli eventuali interventi chirurgici, ridu-
Per la corrispondenza: Lorella Lotto, DPSS, Università di Padova, via Venezia 8, 35131 [email protected]
356 Lorella Lotto, Alessandra Tasso, Andrea Carnaghi e Rino Rumiati
cendo, in ogni caso, la mortalità. Per questo motivo è considerato l’esame elettivo per il controllo delle donne di oltre i 40 anni di età, in cui il rischio di ammalarsi aumenta in modo significativo.
Da un punto di vista applicativo, è perciò necessario rafforzare la prevenzione se-condaria incrementando il numero di donne che si sottopongono a tale indagine stru-mentale. Il primo studio che ha testato l’efficacia della mammografia (Health Insurance Plan) ha infatti dimostrato, dopo diciotto anni di follow up, una riduzione della mor-talità per tumore mammario di oltre il 20% nel gruppo sperimentale (invitato ad effet-tuare una mammografia annualmente, per quattro anni consecutivi) rispetto a quello di controllo (sottoposto ad esame clinico), con percentuali più elevate nelle donne di età superiore ai 50 anni.
L’obiettivo di intervenire in fase precoce è attuabile principalmente tramite la rea-lizzazione di campagne di informazione per la sensibilizzazione attiva di larghe fasce della popolazione femminile. A tal fine, acquista particolare rilevanza lo studio dell’ef-ficacia persuasiva dei messaggi volti a promuovere tali pratiche preventive e di diagnosi precoce. La progettazione di tale campagne, tuttavia, non è affatto semplice. Non è suf-ficiente, infatti, far conoscere alle persone i rischi cui vanno incontro se adottano (o non adottano) un certo comportamento, come è evidente da numerose situazioni della vita quotidiana. Ad esempio, gli individui sono consapevoli dei rischi associati al fumo, ma continuano a fumare; inoltre molti sanno che per evitare il contagio di malattie sessual-mente trasmissibili è sufficiente utilizzare il preservativo e, tuttavia, in molti continuano a non usarlo (Albarracìn, Johnson, Fishbein e Muellerleile, 2001; Carnaghi, Cadinu, Castelli, Kiesner e Brigantini, in stampa).
Da un punto di vista teorico, il presente studio intende analizzare l’efficacia dei messaggi che promuovono comportamenti di prevenzione all’interno della più estesa letteratura sulla teoria del prospetto, focalizzandosi su due costrutti distinti: l’atteggia-mento nei confronti della mammografia e l’intenzione comportamentale nei riguardi di tale strumento diagnostico. La scelta di tali costrutti si giustifica con l’importanza che l’atteggiamento e l’intenzione comportamentale ricoprono nella determinazione del comportamento (Ajzen e Fishbein, 1977 e 1980; Fishbein, 1980).
1. Impatto persuasivo di messaggi che promuovono comportamenti di salute
Una delle modalità utilizzate per favorire la forza persuasiva di un messaggio consiste nel manipolare la formulazione linguistica del messaggio stesso. L’effetto più noto è l’«effetto framing», inizialmente studiato da Tversky e Kahneman (1981) a partire dalla teoria del prospetto (Kahneman e Tversky, 1979). Tversky e Kahneman (1981), nel classico studio noto con il nome di «malattia asiatica», presentavano ai partecipanti uno scenario in cui veniva dichiarato che un’epidemia avrebbe potuto causare la morte di 600 persone. I partecipanti dovevano scegliere tra due diversi trattamenti per far
Promuovere l’adesione alla mammografia 357
fronte all’epidemia. Tali trattamenti erano però presentati in associazione a due formati distinti: un formato che sottolineava il numero di vite salvate e un altro che sottolineava il numero di vite perse. Quando le opzioni erano presentate in termini di vite salvate, la maggioranza dei partecipanti sceglieva di salvare per certo 200 persone e solo una piccola percentuale di persone sceglieva l’opzione alternativa, che prevedeva la possibi-lità di salvare 600 persone con 1/3 di probabilità, ma di non salvare nessuno con 2/3 di probabilità. Per contro, quando le opzioni erano presentate in termini di vite perdute, la maggioranza dei partecipanti sceglieva l’opzione rischiosa, per la quale c’era 1/3 di probabilità che nessuno morisse e 2/3 di probabilità che tutte le 600 persone morissero, al posto dell’opzione certa in cui si prevedeva la morte certa di 400 persone. La tenden-za è, quindi, di evitare scelte rischiose quando le opzioni sono presentate in termini di guadagno e sono enfatizzati i possibili benefici mentre, al contrario, si è maggiormente propensi a compiere scelte rischiose quando le opzioni sono incorniciate (framed) in termini di potenziali perdite. In altre parole, le persone manifestano un’avversione al rischio quando le opzioni sono presentate in termini di guadagno, mentre manifestano una propensione al rischio quando le stesse opzioni sono presentate in termini di per-dita.
Il fenomeno del framing è stato indagato in numerosi ambiti. In un contesto sa-nitario, ad esempio, Meyerovitz e Chaiken (1987) hanno esaminato l’influenza della formulazione dei messaggi sui comportamenti di prevenzione della salute personale. Le autrici hanno testato l’efficacia di un volantino che promuoveva l’auto-esame del seno, raccomandato da oncologi e medici come pratica utile a diagnosticare precocemente eventuali alterazioni al seno. I risultati hanno mostrato che le donne che avevano rice-vuto il messaggio formulato in termini di perdita non solo esprimevano maggiore inten-zione ad eseguire la pratica consigliata ma, ad un follow-up di 4 mesi, dichiaravano di aver aderito a tale pratica in misura maggiore rispetto alle donne che avevano ricevuto il messaggio formulato in termini di guadagno. Studi successivi hanno confermato l’ef-ficacia del frame di perdita nel promuovere l’uso della mammografia (Banks, Salovey, Greener, Rothman, Moyer, Beauvais e Eppel, 1995; Schneider, Salovey, Apanovitch, Pizarro, McCarthy e Zullo, 2001; Abood, Coster, Mullis e Black, 2002). L’efficacia di messaggi formulati in termini negativi è stata osservata anche in altri ambiti, ad esempio nella promozione dell’amniocentesi (Marteau, 1989), del test per l’HIV (Kalichman e Coley, 1995) e nell’ambito della prevenzione del melanoma (Block e Keller, 1995).
Nonostante i numerosi lavori che hanno documentato l’importanza del frame di perdita nel promuovere l’adesione al comportamento richiesto, altri studi hanno rileva-to una maggior efficacia del frame di guadagno. Tale efficacia è stata mostrata, ad esem-pio, da Christophersen e Gyulay (1981) nell’utilizzo in auto degli specifici seggiolini per bambini, da Linville, Fisher e Fischhoff (1993) nel promuovere l’uso del preservativo e da Detweiler e coll. (1999) nell’uso di creme solari a protezione della pelle. Una prima spiegazione a tale apparente contraddizione nei risultati degli studi che si sono occupati dell’effetto framing è stata proposta da Rothman e Salovey (1997), secondo i quali l’in-tegrazione della teoria del prospetto nell’ambito delle raccomandazioni di pratiche me-
358 Lorella Lotto, Alessandra Tasso, Andrea Carnaghi e Rino Rumiati
diche è di difficile operazionalizzazione. Infatti, contrariamente al paradigma originale di Tversky e Kahneman (1981), in cui si richiede ai partecipanti di scegliere tra un’op-zione certa e una rischiosa, le preferenze e i comportamenti nell’ambito della salute consistono nel decidere se aderire o meno ad una certa pratica medica. Gli stessi autori, hanno perciò suggerito che la diversa efficacia dei due tipi di frame possa essere messa in relazione al tipo di pratica medica promossa, e hanno rianalizzato la letteratura nei termini della distinzione tra comportamenti di prevenzione (prevention) e comporta-menti di individuazione (detection). I comportamenti di prevenzione hanno lo scopo di mantenere lo stato di salute: ad esempio, l’uso di creme protettive durante l’esposizione al sole serve a prevenire il tumore alla pelle, e tale uso non comporta alcun rischio. I comportamenti di individuazione hanno invece lo scopo di controllare lo stato di salute: l’esame mammografico può essere considerato un comportamento rischioso, in quanto una donna che mette in atto questo comportamento può scoprire di essere malata. In questo contesto, dunque, un comportamento rischioso non si riferisce ad un compor-tamento che può costituire un danno per la salute, ma descrive un comportamento che implica la possibilità di rilevare un’eventuale alterazione patologica e la perdita della convinzione di essere sane.
Da tale rianalisi della letteratura Rothman e Salovey (1997) hanno messo in luce che i comportamenti di prevenzione sono maggiormente promossi dal frame di guada-gno, mentre i comportamenti di individuazione sono favoriti dal frame di perdita. Tale distinzione è in linea con la teoria del prospetto (Kahneman e Tversky, 1979): se un messaggio sottolinea le conseguenze negative del non mettere in atto un certo compor-tamento le persone sono più propense a cercare di evitare tali conseguenze e, quindi, ad aderire al comportamento promosso. Se, invece, un messaggio sottolinea i vantaggi del mettere in atto lo stesso comportamento, i costi derivanti dalla mancata aderenza alle indicazioni restano impliciti e le persone sono meno propense ad aderire al comporta-mento promosso.
Letti in questi termini, i risultati presentati nella rassegna di Rothman e Salovey (1997) sembrano dunque dimostrare che il frame di perdita ha un maggior impatto persuasivo nel promuovere i comportamenti che implicano un certo livello di rischio. Meyerowitz, Wilson e Cjaiken (1991) hanno infatti sottolineato che il frame di perdita induceva una maggiore aderenza al comportamento promosso (l’autoesame al seno) solo nelle donne che riferivano di percepirlo come un comportamento rischioso.
Le campagne di promozione allo screening mammografico dovrebbero perciò pun-tare ad enfatizzare tale dimensione, se vogliono far presa su quella percentuale di donne che non si sottopone regolarmente a tale pratica.
2. I fattori di modulazione dell’effetto frame
Precedenti ricerche hanno messo in luce la dimensione del coinvolgimento personale come fattore in grado di influenzare il modo in cui sono elaborate le informazioni pre-
Promuovere l’adesione alla mammografia 359
senti nel messaggio (Greenwald e Leavitt, 1984; Kardes, 1988). In particolare, Mahe-swaran e Meyers-Levy (1990) hanno manipolato il tipo di frame (di guadagno vs. di perdita) e il grado di coinvolgimento (alto vs. basso) in un gruppo di studenti universi-tari. I partecipanti assegnati alla condizione di alto coinvolgimento apprendevano che i risultati di uno studio condotto presso la Harward Medical School mostravano che «anche le persone sotto i 25 anni di età sono a rischio di patologie cardiache» e inoltre che «la suscettibilità alle patologie cardiache nella tarda età si definisce di fatto nei primi vent’anni e che quindi il rischio di essere vittima di un attacco cardiaco aumenta dai 25 anni di età». I partecipanti assegnati alla condizione di basso coinvolgimento appren-devano, dalla medesima fonte, che «le persone anziane sono ad alto rischio per quanto riguarda le patologie cardiache», perché «il rischio di patologie cardiache aumenta in modo proporzionale all’età e che quindi il rischio di essere vittima di un attacco cardia-co aumenta in particolare dai 65 anni di età». A tutti i partecipanti veniva descritto il ruolo del livello di colesterolo nello sviluppo delle patologie cardiache e l’importanza di misurarlo attraverso un test. I risultati che misuravano l’atteggiamento e l’intenzione comportamentale ad effettuare il test hanno messo in luce un’interazione tra frame e coinvolgimento: il frame di perdita si è mostrato più efficace nel gruppo ad alto coinvol-gimento, mentre nel gruppo a basso coinvolgimento si è rivelato più efficace il frame di guadagno. La manipolazione sperimentale consisteva dunque nel far sì che gli studenti nella condizione di alto coinvolgimento si percepissero come una categoria a rischio (al termine dell’esperimento ai partecipanti venivano fornite spiegazioni sugli scopi effet-tivi della ricerca).
Un limite dello studio ora descritto potrebbe derivare dalla possibile sovrapposizio-ne, all’interno del fattore coinvolgimento, di due variabili diverse: la salienza contingen-te e la rilevanza personale del messaggio. Il termine salienza contingente di uno stimolo fa riferimento a una variabile situazionale che rende saliente tale stimolo nell’acquisizio-ne e nell’elaborazione delle informazioni contestuali (Kunda e Spencer, 2003). In parti-colare, nel contesto della ricerca descritta, ai partecipanti sono fornite informazioni che riguardano il rischio associato a una certa patologia e che rendono tale rischio saliente. Il termine rilevanza personale fa invece riferimento al rischio stimato per una popolazio-ne che, in una condizione di alta rilevanza personale, è associato al proprio gruppo e, in una condizione di bassa rilevanza, è associato ad un gruppo estraneo. Nell’esperimento di Maheswaran e Meyers-Levy (1990) il livello di alta rilevanza personale corrisponde alla condizione di alto coinvolgimento («Anche le persone sotto i 25 anni di età sono a rischio di patologie cardiache»), mentre il livello di bassa rilevanza corrisponde alla condizione di basso coinvolgimento («Il rischio di essere vittima di un attacco cardiaco aumenta in particolare dai 65 anni di età»).
Sulla base di questa distinzione diventa difficile distinguere quale delle due dimen-sioni del coinvolgimento interagisca con il frame. In altre parole, l’effetto del messaggio sull’intenzione comportamentale è moderato dalla rilevanza personale del messaggio o dalla salienza contingente del rischio? Lo stesso problema è altresì evidente nello studio condotto da Meyerowitz e Chaiken (1987), nel quale l’informazione relativa al rischio di
360 Lorella Lotto, Alessandra Tasso, Andrea Carnaghi e Rino Rumiati
carcinoma mammario veniva fornita a tutte le partecipanti, studentesse universitarie di età inferiore ai trentaquattro anni («Il carcinoma al seno è la principale causa di morte nelle donne tra i 15 e i 34 anni»). Anche in questo caso la salienza contingente di svi-luppare un carcinoma si sovrappone all’alta rilevanza personale del messaggio. In con-clusione, a nostro parere, il coinvolgimento personale riguarda due diverse dimensioni associate al rischio: la salienza si riferisce all’informazione sul rischio che può essere o meno presente, mentre la rilevanza personale si riferisce al diverso rischio associato a diversi gruppi di età.
3. Presentazione dello studio e ipotesi
Il presente studio intende scindere la salienza contingente del rischio dalla rilevanza personale del messaggio. A tale scopo, a metà delle donne incluse nel presente studio è stata fornita la percentuale di incidenza di rischio del tumore al seno (alta salienza), mentre alla restante metà tale informazione non è stata presentata (bassa salienza). Inol-tre, il fattore rilevanza personale è stato manipolato fornendo percentuali di incidenza della malattia diverse in funzione di diverse fasce d’età. Nella condizione di alta salienza alle partecipanti veniva comunicato che ogni anno la percentuale di nuovi casi di tumo-re è pari al 22% per le donne al di sotto dei 50 anni e pari al 45 % per le donne di età compresa fra i 50 e i 69 anni1.
Ipotizziamo che nella condizione di frame di perdita le partecipanti riportino un atteggiamento più favorevole nei confronti della mammografia ed esprimano una più alta intenzione a sottoporsi a tale esame quando l’informazione rispetto all’incidenza è presente (alta salienza) rispetto alla condizione in cui tale informazione è assente (bassa salienza). Al contrario, nella condizione di frame di guadagno, prevediamo che le par-tecipanti riportino un atteggiamento più favorevole nei confronti della mammografia ed esprimano una più alta intenzione a sottoporsi a tale esame quando l’informazione rispetto all’incidenza è assente (bassa salienza) rispetto alla condizione in cui tale infor-mazione è presente (alta salienza).
Inoltre, intendiamo testare se la relazione tra il tipo di frame (guadagno vs. perdita) e la salienza del rischio (alta vs. bassa) possa essere moderata dalla rilevanza personale, ossia dall’età delle partecipanti. Se la rilevanza personale avesse un effetto, nella con-dizione di frame di perdita e alta salienza dovremmo ottenere punteggi relativi all’at-teggiamento e all’intenzione comportamentale più alti da parte delle donne tra i 50 e i 69 anni di età rispetto alle più giovani, perché in questa condizione il rischio sarebbe saliente per entrambe, ma molto più rilevante per le partecipanti più anziane rispetto a quelle giovani.
1 In Italia si stima che si ammalino oltre 30.000 donne ogni anno e che, analogamente a quanto si riscontra in tutti i paesi occidentali, l’incidenza aumenti esponenzialmente con l’età fino alla meno-pausa, quando si riscontra un rallentamento; in seguito la crescita riprende ma con velocità minore (fonte: www.unipd.it/regtumve/).
Promuovere l’adesione alla mammografia 361
4. Metodo
4.1. Partecipanti
Alla ricerca hanno partecipato 80 donne di età compresa tra i 38 e i 69 anni (M = 50.8; Md = 49.5). In particolare, una sperimentatrice ha contattato 161 donne chiedendo se fossero interessate a prendere parte ad una ricerca condotta dall’Università di Padova e se si fossero mai sottoposte ad una mammografia. Poiché il 50% delle donne contattate aveva già eseguito almeno una volta la mammografia, il campione sperimentale finale è costituito da N = 80 partecipanti che hanno accettato di partecipare alla ricerca e che non avevano mai effettuato un esame mammografico.
4.2. Procedura, materiale e variabili indipendenti
La sperimentatrice ha raggiunto le partecipanti individualmente a casa e, dopo aver descritto la ricerca come uno studio sui comportamenti volti alla salute, ha chiesto loro di rispondere ad alcune domande focalizzate in particolare sulla mammografia. L’anoni-mato è stato garantito dalla legge italiana sulla privacy (D.L. 675/1996).
Le partecipanti sono state assegnate secondo una procedura casuale ad una delle quattro condizioni derivanti dal disegno fattoriale completo: 2 (frame: guadagno vs. perdita) x 2 (salienza: alta vs. bassa), con entrambi i fattori manipolati tra i gruppi.
Prima della manipolazione sperimentale alle partecipanti è stato chiesto di rispon-dere ad alcune domande sulla mammografia utilizzando scale dicotomiche o tipo Likert a 7 punti (conoscenza della mammografia come tecnica di diagnosi; percezione di effi-cacia della mammografia; grado di informazioni possedute).
Le partecipanti venivano quindi invitate a leggere un opuscolo in cui venivano for-nite le seguenti informazioni sul carcinoma al seno e sulla mammografia, identiche per tutte le partecipanti:
Il carcinoma della mammella è il tumore femminile più frequente in tutti i paesi più sviluppa-ti. La mammografia è un esame in grado di diagnosticare carcinomi ancora in fase preclinica. I medici sono concordi nell’affermare l’efficacia della mammografia come esame diagnostico.
Le informazioni seguenti, invece, variavano in base alla condizione sperimentale. Nella prima condizione (guadagno) erano descritte le conseguenze positive della mam-mografia, nella seconda condizione (perdita) erano descritte le conseguenze negative del mancato esame, espresse come negazioni esplicite (tra parentesi):
(non) effettuando regolarmente, ogni due anni, una mammografia (non) si può controllare la salute del seno, e (non) si ha la possibilità di individuare eventuali anomalie in fase precoce. Inoltre (non) effettuando regolarmente la mammografia, (non) si può individuare il nodulo quando è ancora di dimensioni ridotte e la successiva terapia (non) sarà di tipo conservativo
362 Lorella Lotto, Alessandra Tasso, Andrea Carnaghi e Rino Rumiati
Il pieghevole continuava fornendo la seguente informazione, identica per tutte le partecipanti:
Si stima che in Italia si ammalino oltre 30.000 donne ogni anno. In Veneto ogni anno i nuovi casi sono circa 3.100 e i decessi circa 1.000.
A metà delle partecipanti era in seguito fornita l’informazione relativa alla percen-tuale di incidenza del tumore al seno per fasce d’età (alta salienza):
Il 22% di questi casi interessa donne di età inferiore ai 50 anni, il 45% riguarda donne di età compresa fra i 50 e i 69 anni.
All’altra metà delle partecipanti tale informazione non veniva fornita (bassa salienza).In seguito alla lettura del pieghevole le partecipanti rispondevano ad alcune do-
mande sulla conoscenza ed efficacia della mammografia, sull’atteggiamento compor-tamentale e sull’intenzione comportamentale, utilizzando scale di tipo Likert a 7 punti.
Il disegno sperimentale prevede dunque la manipolazione sperimentale di due va-riabili: il frame e la salienza. La rilevanza personale coincide nel presente studio con l’età: ci aspettiamo che le informazioni abbiano una diversa rilevanza personale e siano elaborate in modo differente in funzione delle diverse fasce d’età.
4.3. Misure socio demografiche
Le partecipanti indicavano i seguenti dati: età, residenza, occupazione, titolo di studio, stato civile, numero di figli.
4.4. Variabili dipendenti
Pap testPrima di rispondere alle domande focalizzate sulla mammografia, le partecipanti
rispondevano ad una domanda relativa al pap test («Ha mai effettuato il pap test?») e il cui format di risposta era discreto: si vs. no.
Conoscenza, informazione ed efficaciaPer quanto riguarda le domande focalizzate in particolare sulla mammografia, una
domanda intendeva indagare se le partecipanti fossero a conoscenza della mammografia come tecnica diagnostica («È a conoscenza dell’uso della mammografia come tecnica di diagnosi di eventuali noduli al seno?»). A questa domanda, le partecipanti rispondeva-no tramite un formato discreto: si vs. no.
Sia prima che dopo la manipolazione sperimentale è stato valutato il grado di in-formazione che le partecipanti ritenevano di avere («Quanto ritiene di essere informata sulla mammografia?»: 1 = per nulla informata, 7 = molto informata).
Promuovere l’adesione alla mammografia 363
Infine, una misura del grado di efficacia è stata rilevata sia prima che dopo la ma-nipolazione sperimentale («In che misura ritiene che la mammografia sia un’efficace tecnica di diagnosi del tumore al seno?»: 1 = per nulla efficace, 7 = molto efficace).
AtteggiamentoLa seguente domanda intendeva indagare l’atteggiamento nei confronti della mam-
mografia: «È bene fare una mammografia ogni due anni anche se non si hanno avuto casi di tumore al seno in famiglia»; 1 = per nulla d’accordo; 7 = molto d’accordo.
IntenzioneIn seguito alla manipolazione sperimentale, una domanda specifica intendeva misu-
rare il grado di intenzionalità ad effettuare una mammografia: «Ho intenzione di effettua-re una mammografia entro un anno»; 1 = per nulla intenzionata; 7 = molto intenzionata.
FamiliaritàLe partecipanti rispondevano ad una domanda relativa alla familiarità: «Sue fami-
liari o persone a lei care si sono ammalate di cancro al seno?» e il cui formato di risposta era discreto: si vs. no.
5. Risultati
5.1. Misure socio-demografiche
L’età media del campione è pari a 50.8 anni. In particolare, l’età media delle partecipanti nella condizione «alta salienza» è pari a 51.3 anni (ds = 11.8) , mentre nella condizione «bassa salienza» è pari a 50.3 anni (ds = 9.9).
Il campione è costituito prevalentemente da casalinghe (49%), la restante parte del campione è così ripartita: 19% impiegate, 7.5 % artigiane, 6.3% pensionate, 3.8% insegnanti, 1.3% commercianti, 1.30% libere professioniste, 11.8 % non specificato. Se si considera il titolo di studio, il 62% si divide equamente tra chi possiede la licenza elementare e chi il diploma di scuola media inferiore, mentre solo il 29.2% ha il diploma di scuola superiore, il 7,5% ha una laurea e l’1,30 % ha effettuato studi universitari. Per quanto riguarda lo stato civile, l’85% delle partecipanti è sposata o convive; circa un terzo ha 1 figlio e il 36% ha 2 figli.
5.2. Pap test
In considerazione del fatto che il campione da noi reclutato non si era mai sottoposto a mammografia, eravamo interessati a sapere in che misura le partecipanti si fossero inve-ce sottoposte ad un pap test, in quanto esame diagnostico specifico per la popolazione
364 Lorella Lotto, Alessandra Tasso, Andrea Carnaghi e Rino Rumiati
femminile, e consigliato alle donne a partire dalla giovane età. Pur non avendo mai fatto una mammografia, l’87% delle partecipanti dichiara di aver effettuato il pap test. Congiuntamente, questi dati indicano che il non essersi sottoposte a mammografia non dipende da una generale resistenza ad effettuare esami diagnostici.
5.3. Conoscenza, informazione ed efficacia
Il 100% delle donne afferma di essere a conoscenza dell’uso della mammografia come tecnica di diagnosi di eventuali noduli al seno. Questo indica che non è per mancanza di informazioni che le partecipanti non hanno mai effettuato tale esame.
Al fine di indagare se le variabili indipendenti avessero modificato il grado di in-formazione e l’efficacia percepita circa l’esame mammografico, abbiamo calcolato il punteggio di differenza tra le risposte delle partecipanti all’item informazione e all’item efficacia fornite prima e dopo la lettura del volantino. Tali score di informazione e di ef-ficacia sono stati utilizzati come criterio in due analisi di regressione separate, mentre il frame (guadagno: -1; perdita: +1), la salienza (bassa: -1; alta: +1), l’età delle partecipanti (punteggi z) e le loro combinazioni lineari sono state considerate come predittori2.
Nessun predittore è risultato significativamente legato né alla variabile informazio-ne, né alla variabile efficacia.
Tali risultati dimostrano che la manipolazione del frame linguistico e dell’infor-mazione relativa all’incidenza non hanno influenzato né la quantità di informazione posseduta dalle partecipanti, né l’efficacia percepita della mammografia come esame diagnostico. Inoltre, l’assenza di un effetto significativo dell’età ci permette di assumere che il campione è, indipendentemente dall’anzianità delle partecipanti, equamente in-formato circa l’esame mammografico e la sua efficacia diagnostica.
5.4. Atteggiamento
Al fine di indagare se le variabili indipendenti avessero un effetto sull’atteggiamento relativo all’esame mammografico, la variabile atteggiamento è stata utilizzata come cri-terio in un’analisi di regressione, mentre il frame (guadagno: -1; perdita: +1), la salienza (bassa: -1; alta: +1), l’età delle partecipanti (punteggi z) e le loro combinazioni lineari sono stati utilizzati come predittori. Il modello complessivo mostra un effetto tenden-zialmente significativo, F (7,72) = 1.40, p = .22, R = .35, e l’analisi dei predittori indica un’interazione significativa tra frame e salienza b = .23; t(72) = 2.12; p = .038.
2 Come test statistico è stata eseguita un’analisi di regressione perché l’età delle partecipanti è stata considerata una variabile continua. Trattare invece l’età come una variabile categoriale sarebbe non solo una forzatura metodologica, ma anche concettuale. Infatti, relativamente all’informazione sul grado di incidenza del tumore nella popolazione (inferiore ai 50 anni vs. tra i 50 e i 69 anni), le donne di 49 anni apparterrebbero allo stesso gruppo delle donne di 40 pur essendo in realtà «più vicine» alle donne di 51 anni.
Promuovere l’adesione alla mammografia 365
I risultati, mostrati in figura 1, confermano in parte la nostra ipotesi: come previsto, con frame di perdita l’atteggiamento nei confronti della mammografia è più favorevole quando l’informazione sull’incidenza è presente rispetto alla condizione in cui è assente t(38) = 1.9; p = .06. Con frame di guadagno l’atteggiamento delle partecipanti non varia significativamente in relazione alla presenza o assenza dell’informazione t(38) = .23; ns., ma è possibile evidenziare comunque una tendenza congruente con le ipotesi: i punteggi sono infatti più elevati quando l’informazione sull’incidenza è assente rispetto a quando è presente. Non è emerso nessun altro effetto significativo.
5.5. Intenzione
Per indagare se le variabili indipendenti avessero un effetto sull’intenzione comporta-mentale, la variabile intenzione è stata utilizzata come criterio in un’analisi di regres-sione, mentre il frame (guadagno: -1; perdita: +1), la salienza (bassa: -1; alta: +1), l’età delle partecipanti (punteggio z) e le loro combinazioni lineari sono state utilizzate come predittori. Il modello generale è significativo F(7,72) = 2.40, p < .03, R = .44, ed è inoltre significativa l’interazione tra frame e salienza b = .38; t(72) = 3.6; p = .001.
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
alta salienza bassa salienza
guadagnoperdita
Fig. 1. Interazione tra frame e salienza relativa alla variabile atteggiamento.
366 Lorella Lotto, Alessandra Tasso, Andrea Carnaghi e Rino Rumiati
In conformità alle ipotesi, come si può vedere in figura 2, con frame di perdita le partecipanti esprimono una maggiore intenzione a sottoporsi ad una mammografia quando l’informazione sull’incidenza è presente rispetto a quando è assente t(38) = 2.3; p = .03, mentre con frame di guadagno le partecipanti indicano una maggiore intenzio-ne quando l’informazione sull’incidenza è assente rispetto a quando è presente t(38) = 3.01; p = .005. Non è emerso nessun altro effetto significativo.
5.6. Familiarità
Il 29% delle 80 partecipanti ha risposto di aver avuto una conoscente o una parente affetta da tumore al seno. Nell’analisi di regressione sono stati utilizzati il frame (guada-gno: -1; perdita: +1), la salienza (alta: -1; bassa: +1), l’età (punteggi zeta), la familiarità (familiari: -1; no familiari: +1) e le loro combinazioni lineari come predittori, mentre la variabile intenzione è stata utilizzata come criterio. Il modello generale è significativo F(15, 64) = 1.84, p < .05, R = .55.
La variabile familiarità non predice l’intenzione comportamentale nei confronti della mammografia b = -.02; t(64) = .15; ns., ma emerge un’interazione significativa tra frame e salienza b = .30; t(64) = 2.4; p = .021, che conferma il pattern osservato in precedenza (cfr. figura 2) relativo ai punteggi di intenzione comportamentale. Tale inte-razione è qualificata da un’interazione di secondo ordine frame x salienza x familiarità b = .26; t(64) = 2.1; p = .040. Come si può osservare in figura 3, solo le partecipanti che non hanno avuto familiari ammalate mostrano un effetto del frame e della salienza del tutto simile a quello emerso dal modello semplice, cioè il modello che non include la familiarità come predittore.
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
alta salienza bassa salienza
guadagnoperdita
Fig. 2. Interazione tra frame e salienza relativa all’intenzione comportamentale.
Promuovere l’adesione alla mammografia 367
Al contrario, come si può vedere in figura 4, le partecipanti che hanno avuto per-sone care ammalate mostrano un quadro molto diverso, in cui né il frame né la salienza predicono significativamente l’intenzione comportamentale.
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
alta salienza bassa salienza
guadagnoperdita
Fig. 3. Punteggi relativi all’intenzione comportamentale per le partecipanti che non hanno avuto familiari malate.
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
alta salienza bassa salienza
guadagnoperdita
Fig. 4. Punteggi relativi all’intenzione comportamentale per le partecipanti che hanno avuto familiari malate.
368 Lorella Lotto, Alessandra Tasso, Andrea Carnaghi e Rino Rumiati
6. Discussione
I processi di pensiero e le credenze che gli individui hanno nei riguardi della propria salute si riflettono sulle scelte comportamentali. La conoscenza di tali aspetti è quindi determinante per pianificare interventi di comunicazione efficace. Un’analisi psico-so-ciale dei comportamenti di salute, tuttavia, non può trascurare altri fattori, altrettanto importanti nelle scelte comportamentali, quali il tipo di pubblico cui il messaggio per-suasivo è rivolto, il modo con cui l’informazione viene presentata, e il tipo di informa-zione che viene fornita.
Il presente studio ha focalizzato l’attenzione sul ruolo di tali fattori investigando l’efficacia persuasiva di un messaggio volto a promuovere l’aderenza allo screening mammografico in una popolazione di donne tra i 38 e i 69 anni di età che non si erano mai sottopose a tale esame.
Relativamente al tipo di pubblico cui il messaggio persuasivo viene rivolto, non è stata effettuata alcuna manipolazione sperimentale allo scopo di privilegiare la dimen-sione ecologica della ricerca. Le donne che hanno partecipato alla ricerca sono state, in-fatti, reclutate all’interno di una popolazione cui tale indagine strumentale è consigliata da medici ed oncologi in considerazione dell’incidenza della malattia nella popolazione, che aumenta in modo significativo a partire dai 40 anni di età.
La modalità con cui l’informazione viene presentata e il tipo di informazione for-nita sono invece stati oggetto di manipolazione sperimentale. La modalità di presen-tazione ha riguardato la «cornice» linguistica con cui i messaggi sono stati formulati (frame). Nel frame di guadagno erano descritte le conseguenze positive derivanti dal fatto di eseguire la mammografia, mentre nel frame di perdita erano descritte le conse-guenze negative del mancato esame. Il secondo aspetto è stato investigato assumendo che la presenza o l’assenza dell’informazione relativa all’incidenza della malattia nella popolazione (salienza dell’informazione) potesse modulare l’effetto dovuto al frame. Inoltre, questo studio ha cercato di investigare in maniera distinta gli effetti legati alla salienza del rischio da quelli relativi alla rilevanza personale del rischio, legati cioè al fatto di appartenere – per età, nel presente studio – a un gruppo maggiormente a rischio.
I risultati riguardanti la conoscenza, l’informazione e l’efficacia della mammografia dimostrano che né il frame né l’incidenza influenzano la quantità di informazione che le partecipanti pensano di avere sulla mammografia e l’efficacia percepita della mam-mografia come tecnica diagnostica. Questi dati suggeriscono che la manipolazione del frame linguistico non differisce tanto in termini di quantità di informazione fornita o in termini di efficacia percepita, quanto, piuttosto, nella modalità di strutturazione cogni-tiva del messaggio che si riflette sull’atteggiamento e sull’intenzione. Inoltre, l’assenza di un effetto principale dell’informazione circa l’incidenza ci fa assumere che la salienza del rischio percepito non alteri le conoscenze possedute dalle partecipanti circa l’esame mammografico. Entrambi questi risultati ci assicurano che le variabili indipendenti del disegno non alterano le conoscenze delle partecipanti. Inoltre, l’assenza di un effetto
Promuovere l’adesione alla mammografia 369
significativo dell’età ci fa supporre che il campione sia equamente informato circa lo screening e la sua efficacia diagnostica.
I risultati relativi all’atteggiamento e all’intenzione comportamentale sono nel com-plesso tra loro sovrapponibili e congruenti con le ricerche che hanno evidenziato un’alta correlazione tra attitudine e intenzione. Infatti, come previsto dalla teoria dell’«azione ragionata» (Ajzen e Fishbein, 1977), l’atteggiamento nei confronti di un potenziale comportamento è altamente correlato con l’intenzione a comportarsi coerentemente con tale atteggiamento. I nostri risultati confermano tale previsione, l’atteggiamento nei confronti della mammografia è significativamente correlato all’intenzione di sottoporsi ad un esame mammografico r(80) = .49, p < . 001. Da un punto di vista applicativo, poi-ché l’intenzione comportamentale è il miglior predittore del comportamento manifesto (Ajzen e Fishbein, 1977), questi risultati indicano il rafforzamento dell’atteggiamento positivo verso la mammografia come la strategia migliore per incrementare il numero di donne che si sottopongono allo screening mammografico.
Infatti, conformemente alle nostre ipotesi, i risultati indicano che con frame di perdita le partecipanti esprimono una maggiore intenzione a sottoporsi ad una mam-mografia quando l’informazione sull’incidenza è presente (alta salienza), mentre con frame di guadagno le partecipanti indicano una maggiore intenzione quando l’infor-mazione sull’incidenza è assente (bassa salienza). In altre parole, l’alta salienza del ri-schio ha amplificato gli effetti del frame di perdita e ridotto invece l’impatto del frame di guadagno.
È inoltre estremamente importante evidenziare che la rilevanza personale, qui scis-sa dal processo di salienza del rischio, non ha determinato alcun effetto semplice né di interazione sulle variabili di atteggiamento e di intenzione comportamentale. Sebbene nelle campagne di comunicazione sulla salute le due variabili siano naturalmente con-fuse, da un punto di vista teorico è importante sottolineare che la rilevanza personale non sembra essere una variabile moderatrice dell’effetto di frame. Il presente studio sottolinea, almeno in contesti ecologici, l’importanza della salienza del rischio piutto-sto che della rilevanza personale. L’assenza di tale effetto potrebbe però essere dovuta alla specificità del campione qui preso in esame. Mentre nell’esperimento di Maheswa-ran e Mayers-Levy (1990) i partecipanti erano sottoposti ad una chiara dicotomia tra un gruppo a rischio e un gruppo non a rischio, le partecipanti che avevano ricevuto l’informazione sull’incidenza erano consapevoli di essere, sebbene differentemente in funzione dell’età, soggette, attualmente o nel futuro, ad un possibile rischio. È perciò plausibile che fattori quali il destino comune o la formazione di una categoria sovraordi-nata (Gaertne, Mann, Dovidio, Murrell e Pomare, 1990) abbiano ridotto la distinzione tra le partecipanti in funzione dell’età e, pertanto, diminuito la distinzione che la mani-polazione sperimentale voleva sollecitare.
Infine, un effetto interessante riguarda la familiarità. Solo nel gruppo di donne che non hanno avuto esperienza diretta con casi di tumore al seno si riscontra un effetto di frame in interazione con l’informazione sull’incidenza della malattia, mentre nessun effetto emerge per le donne che hanno avuto parenti o conoscenti ammalate. Altri studi
370 Lorella Lotto, Alessandra Tasso, Andrea Carnaghi e Rino Rumiati
hanno messo in luce che la propensione a sottoporsi allo screening mammografico è positivamente correlata, oltre che con la suscettibilità percepita nei confronti del fatto di potersi ammalare di cancro al seno, con la presenza di un tumore al seno nella storia familiare (McCaul, Branstetter e Schroeder, 1996; Finney e Iannotti, 2002). Possiamo quindi pensare che l’importanza di tale fattore sia maggiore di quella di altri fattori contestuali, relativi al modo e al tipo di informazione ricevuta e strettamente attinenti al messaggio persuasivo.
Infine, un’ultima considerazione in merito ai risultati del follow up. A scopo esplo-rativo, 57 delle 80 partecipanti (71.25%) sono state ricontattate a distanza di 6 mesi dall’esperimento, per sapere quante di queste si fossero effettivamente sottoposte ad una mammografia. Il confronto tra questi dati e quelli che si riferiscono all’intenzione comportamentale mette in luce un interessante cambiamento nel pattern di risultati in funzione del frame: delle donne che, a sei mesi di distanza, si sono sottoposte a mam-mografia, la maggior parte sono quelle che hanno letto il volantino con frame di perdita, rispetto alle partecipanti che hanno letto il volantino con frame di guadagno (44% vs. 17%; χ2 = 5.24; p = .022). Anche se i dati relativi al follow up non riguardano la totalità del campione, è interessante notare come il frame di perdita, ma non il frame di gua-dagno, risulti avere un impatto persuasivo a lungo termine. Una possibile spiegazione può essere ascritta al modello di Petty e Cacioppo (1986), secondo cui le informazioni negative, elaborate in modo sistematico attraverso quella che gli autori chiamano «via centrale», inducono cambiamenti negli atteggiamenti più duraturi rispetto alle informa-zioni positive, elaborate in modo superficiale attraverso la «via periferica». Rispetto a tale considerazione, ulteriori ricerche saranno necessarie per determinare il ruolo che i diversi fattori esaminati – frame, salienza e rilevanza personale – possono avere nell’in-fluenzare gli atteggiamenti e le intenzioni comportamentali da una parte, e il comporta-mento effettivo dall’altra.
La presente ricerca ha dunque permesso, da un punto di vista teorico, di appro-fondire la comprensione dell’efficacia dei messaggi persuasivi all’interno del modello del frame, indicando alcuni possibili moderatori dell’effetto; da un punto di vista ap-plicativo, invece, ha fornito utili indicazioni alla costruzione di messaggi che promuo-vono comportamenti di salute ed ha, esplorativamente, identificato due popolazioni che potrebbero richiedere approcci distinti: coloro che hanno familiarità con un certo argomento (ad esempio, una malattia) e coloro che non possiedono tale familiarità.
Riferimenti bibliografici
Abood D.A., Coster D.C., Mullis A.K. e Black D.R. (2002). Evaluation of a «loss-framed» minimal intervention to increase mammography utilization among medically un- and under-insured women. Cancer detection and Prevention, 26, 394-400.
Ajzen I. e Fishbein M. (1977). Attitude-behavior relations: A theoretical analysis and review of empirical research. Psychological-Bulletin, 84, 888-918.
Promuovere l’adesione alla mammografia 371
Ajzen I. e Fishbein M. (1980). Understanding attitudes and predicting social behavior: Attitudes, intentions, and perceived behavioral control. Englewood Cliffs (NJ): Prentice Hall.
Albarracìn D., Johnson B.T., Fishbein M. e Muellerleile P.A. (2001). Theories of reaso-ned action and planned behavior as models of condom use: A meta-analysis. Psychological-Bulletin, 127, 142-161.
Banks S.M., Salovey P., Greener S., Rothman A.J., Moyer A., Beauvais J. e Eppel E. (1995). The effects of message framing on mammography utilization. Health Psychology, 14, 178-184.
Block L.G. e Keller P.A. (1995). When to accentuate the negative: The effects of per-ceived efficacy and message framing on intentions to perform a health-related behaviour. Journal of Marketing Research, 32, 192-203.
Carnaghi A., Cadinu M., Castelli L., Kiesner J. e Bragantini C. (in stampa). The best way to tell you to use a condom: The interplay between message format and individuals‚ level of need for cognition. AIds-Care.
Christophersen E.R. e Gyulay J.E. (1981). Parental compliance with car seat usage: A positive approach with long-term follow-up. Journal of Pediatric Psychology, 6, 301-312.
Detweiler J.B., Bedell B.T., Salovey P., Pronin E. e Rothman A.J. (1999). Message fra-ming and sunscreen use: Gain-framed messages motivate beach-goers. Health Psychology, 18, 189-196.
Finney L.J. e Iannotti R.J. (2002). Message framing and mammography screening: A theory-Driven Intervention. Behavioral Medicine, 28, 5-14.
Fishbein M. (1980). A theory of reasoned action: Some applications and implications. In H.E. Howe Jr. e M.M. Page (a cura di), Nebraska symposium on Motivation. Lincoln: University of Nebraska Press, vol. 27, pp. 65-116.
Gaertner S.L., Mann J., Dovidio J.F., Murrell A. e Pomare M. (1990). How does coo-peration reduce intergroup bias? Journal of Personality and social Psychology, 59, 692-704.
Greenwald A.G. e Leavitt C. (1984). Audience involvement in advertising: Four levels. Journal of Consumer Research, 11, 581-592.
Kahneman D. e Tversky A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. Econometrica, 47, 263-291.
Kalichman S.C. e Coley B. (1995). Context framing to enhance HIV-antibody-testing messages targeted to African American women. Health Psychology, 14, 247-254.
Kardes F.R. (1988). Spontaneous inference processes in advertising: The effects of conclusion omission and involvement on persuasion. Journal of Consumer Re-search, 15, 225-233.
Kunda Z. e Spencer S.J. (2003). When do stereotypes come to mind and when do they colour judgment? A goal-based theoretical framework for stereotype activation and application. Psychological Bullettin, 129, 522-544.
372 Lorella Lotto, Alessandra Tasso, Andrea Carnaghi e Rino Rumiati
Linville P.W., Fischer G.W. e Fischhoff B. (1993). AIDS risk perceptions and decision biases. In J.B. Pryor e G.D. Reeder (a cura di), The social psychology of HIV infection. Hillsdale (NJ): Lawrence Erlbaum, pp. 5-38.
Maheswaran D. e Mayers-Levy J. (1990). The influence of message framing and issue involvement. Journal of Marketing Research, 27, 361-367.
Marteau T.M. (1989). Framing of information: Its influence upon decisions of doctors and patients. British Journal of social Psychology, 28, 89-94.
McCaul K.D., Branstetter A.D. e Schroeder D.M. (1996). What is the relationship between breast cancer risk and mammography screening? A meta-analytic re-view. Health Psychology, 15, 423-429.
Meyerowitz B.E. e Chaiken S. (1987). The effect of message framing on breast self-exa-mination attitudes, intentions, and behaviour. Journal of Personality and social Psychology, 52, 500-510.
Meyerowitz B.E., Wilson D.K. e Chaiken S. (1991). Loss-framed messages increase breast self-examination for women who perceive risk. Paper presented at the annual convention of the American Psychological Society, Washington, DC.
Petty R.E. e Cacioppo J.T. (1986). The elaboration likelihood model of persuasion. In L. Berkowitz (a cura di), Advances in experimental social psychology. New York: Academic Press, vol. 19, pp. 123-205.
Rothman A.J. e Salovey P. (1997). Shaping perceptions to motivate healthy behaviour: The role of message framing. Psychological Bullettin, 121, 3-19.
Rothman A.J. Salovey P. Antone C. Keough K. e Martin C. (1993). The influence of message framing on intentions to perform health behaviours. Journal of Experi-mental social Psychology, 29, 408-433.
Schneider T.R., Salovey P., Apanovitch A.M., Pizarro J., McCarthy D. e Zullo J. (2001). The effects of message framing and ethnic targeting on mammography use among low-income women. Health Psychology, 20, 256-266.
Tversky A. e Kahneman D. (1981). The framing of decisions and the psychology of choice. science, 211, 453-458.